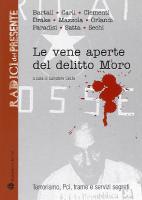Le vene aperte del delitto Moro. Terrorismo, PCI, trame e servizi segreti 8856400146, 9788856400144
Le vene aperte del delitto Moro sono le ombre del sistema politico dell'Italia repubblicana. Perciò continuano a in
464 62 3MB
Italian Pages 360 [362] [362] Year 2009
Polecaj historie
Citation preview
collana diretta da Salvatore Sechi
1
Roberto Bartali • Luigi Carli • Marco Clementi Richard Drake • Franco Mazzola • Fernando Orlandi Gabriele Paradisi • Vladimiro Satta • Salvatore Sechi
Le vene aperte del delitto Moro Terrorismo, Pci, trame e servizi segreti a cura di Salvatore Sechi
www.mauropagliai.it
© 2009 EDIZIONI POLISTAMPA Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze Tel. 055 737871 (15 linee) [email protected] - www.polistampa.com ISBN 978-88-564-0014-4
SOMMARIO
Salvatore Sechi, Introduzione
pag.
7
Richard Drake, Il delitto Moro trent’anni dopo Marco Clementi, La memoria difensiva di Aldo Moro Luigi Carli, La colonna genovese delle Brigate rosse Roberto Bartali, Il Pci e le Brigate rosse Fernando Orlandi, A Praga, a Praga! Gabriele Paradisi, Quegli «… ottusi servitorelli…» Franco Mazzola, Il caso Moro visto dal Palazzo Vladimiro Satta, La risposta dello Stato ai terrorismi Salvatore Sechi, Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
» » » » » » » » »
19 31 51 77 121 161 189 203 245
Appendice
»
315
» »
345 347
(comunicato n. 2 delle Br, note di R. Rota, due lettere di B. Craxi)
Bio-bibliografia degli autori Indice dei nomi
INTRODUZIONE Salvatore Sechi
Tutti condannati, ormai quasi nessuno in ceppi, grazie ad una legislazione premiale tanto generosa verso i carnefici quanto malthusiana verso le vittime. Il delitto Moro, il maggiore omicidio politico dell’Italia repubblicana, è in questi scarni dati sulle condizioni delle carceri. L’estinzione delle pene da parte dei colpevoli rende melanconico il ricordo della tragica vicenda che le ha giustificate. Contro chi ha a lungo evocato il carattere repressivo dello Stato (accusato di essere complice o fomentatore della “strategia della tensione”), la liberazione di tutti gli imputati condannati testimonia il carattere assai blando della legislazione di emergenza varata in Italia dai governi negli anni Settanta. È quanto mostrano, comparativamente, gli studi di Marica Tolomelli sulla Germania occidentale. Se dal capitolo dei delitti e delle pene si passa all’analisi di ciò che hanno significato i 55 giorni trascorsi tra il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, si può parlare di vene aperte. Domande ancora appese, quasi conficcate, ai punti interrogativi, smarrimento delle interpretazioni, particolari grandi e piccoli che, ognuno animato da una logica interna quasi sempre assoluta, si infoltiscono sulla filiera. Randagi o malinconicamente muti. I saggi qui raccolti sono figli dell’occasione (il primo convegno nazionale sul delitto Moro organizzato dal Comune di Cento, il 15-16 marzo 2008) in cui si sono dipanati i disagi delle versioni ufficiali, il calore vivo di inesauste polemiche che le ha investite. Studiosi o affabulatori di dietrologie hanno preso di petto sentenze dei tribunali o verdetti politici brandendo come un’arma i risultati di studi o solo lo squadernamento di fascinose congetture. A Cento, era la prima volta che i sostenitori di punti di vista diversi ed opposti si confrontavano a fianco delle tele dolenti del corpulento Guercino. Dopo un anno sono rimasti i grumi di tenaci contrapposi7
SALVATORE SECHI
zioni, anche se la postura delle divergenze ha meno spigoli e sembra scemata l’euforia e il gusto, di ascendenza politica, per la rissa continua. Avviene sempre così, allorché la storiografia (una non-scienza e sempre umbratile) cede il passo, e lo spazio, alla dietrologia, e la storia viene piegata oltremodo alla suggestione e alla congettura. Dopo il convegno nella cittadina emiliana1 alcuni interrogativi e dilemmi credo siano cambiati o non sono riformulabili nei termini del passato. Il rapimento e l’assassinio di Moro, ritenuto il massimo rappresentante politico della borghesia e del segmento italiano del sistema imperialistico delle multinazionali, fu un’impresa di mano proletaria, una sorta di vendetta di classe? Secondo il pubblico ministero che si occupò della colonna genovese delle Brigate rosse2, e le fece condannare, Luigi Carli, i suoi componenti non superarono mai le 60 unità, ed erano figli della piccola e media borghesia, per lo più studenti e docenti universitari. Ci fu anche un manipolo di operai, di sindacalisti, di militanti delle associazioni cattoliche, di dipendenti dell’azienda municipale trasporti. La componente operaia arrivò al massimo a 12 presso la brigata Italsider, ma mai a più di due o tre nelle brigate del Porto, dell’Ansaldo ecc. Fu proprio questa separatezza dalla classe operaia a segnare la fine del brigatismo genovese. Ebbe luogo dopo l’assassinio di Guido Rossa, quando il Pci decise di scatenare una risposta massiccia contro le Br, ponendo fine ad ogni residua complicità o solo comprensione (lo slogan «Né con le Br né con lo Stato!»). La testimonianza del giudice ligure fotografa la situazione delle grandi fabbriche genovesi del 1979-1983. Con l’irruzione in via Frac1
Al Convegno nazionale “Il delitto Moro. Golpe internazionale e/o terrorismo italiano?”, organizzato dal Comune di Cento e sponsorizzato dall’Università di Ferrara, dal Dipartimento di Studi Politici della Luiss di Roma, dalla rivista «Nuova Storia Contemporanea» e dal Centro Studi sulla Storia dell’Europa Orientale di Levico Terme, hanno preso parte Roberto Bartali, Giovanni Bianconi, Nicola Biondo, Francesco Biscione, Luigi Carli, Gianni Cipriani, Marco Clementi, Andrea Colombo, Giuseppe De Lutiis, Aldo Giannuli, Paolo Mastrolilli, Franco Mazzola, Fernando Orlandi, Francesco Perfetti, Rosario Priore, Sandro Provvisionato, Vladimiro Satta, Salvatore Sechi (ideatore e organizzatore del Convegno). 2 Per una prima ricostruzione cfr. Chiara DOGLIOTTI, La colonna genovese delle Brigate Rosse, «Studi storici», n. 4 (2004), pp. 1151-1177.
8
Introduzione
chia, il 28 marzo 1980, di un reparto dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, le Br vennero smantellate. Questa analisi, frutto di una precisa esperienza personale del dott. Carli (proveniente dal Campasso, un quartiere operaio di Sampierdarena, da studente universitario vicino alla sinistra, amico del dirigente del Pci Roberto Speciale) contrasta con quella di uno storico romano dell’Urss, Marco Clementi. Nei suoi studi ha sottolineato l’estrazione dei brigatisti dal bacino del proletariato di fabbrica. Essi alimentarono un fenomeno settentrionale, con le radici negli agglomerati urbani e nelle grandi fabbriche del triangolo industriale. I primi nuclei e la stessa prima colonna delle Br nacquero all’inizio degli anni Settanta, in Lombardia, nelle file del lavoro manuale dipendente (e in misura minore degli impiegati e degli studenti), presso la Pirelli e la Sit-Siemens. Dunque, molto diversa è la situazione che Clementi descrive rispetto a quella di Genova. Quali furono i rapporti tra i brigatisti e il Pci? Essendo quelle terroristiche delle organizzazioni che avevano scelto la strada della lotta armata, il primo problema riguardò il rinvenimento e il successivo approvvigionamento delle armi. Da un ex partigiano comunista i brigatisti genovesi ebbero solo ferraglia. Vennero riforniti, invece, da Action Directe e dal terrorismo palestinese di al-Fatah, attraverso i valichi per la Francia e la colonna veneta. Circolarono voci anche sulla Cecoslovacchia, che il giudice Carli si limita a registrare, ma acquisteranno un peso rilevante, come emerge da diversi saggi di questo stesso volume. Roberto Bartali delinea il processo di definizione dell’atteggiamento dei comunisti nei confronti del terrorismo, che avevano replicato i modelli organizzativi delle bande partigiane (i Gap e le Sap). Dalla linea di comprensione degli anni Sessanta nei confronti del movimento studentesco («Nessun nemico a sinistra») si passa all’ambiguità fino alla svolta che coincise col sequestro, nel dicembre 1973, di Ettore Amerio. Come ha ricordato Alberto Franceschini, «a Reggio Emilia sapevano che io e gli altri eravamo nelle Br anche se nessuno lo ammetteva ufficialmente. Così io potevo tornarmene nella mia città per la Festa dell’Unità e mangiare tranquillamente ai tavoli con i compagni di pochi anni prima». La svolta si tradusse, come ricorda Bartali, in una stretta collaborazione tra l’attività di intelligence svolta dal Pci, con infiltrazioni di 9
SALVATORE SECHI
propri elementi in seno ai gruppi estremistici, e quella della polizia e dei carabinieri. Il partito si faceva Stato. Non si trattava solo di dare una prova indiscutibile e massiccia di identificazione con lo Stato di diritto, giustificata dalla politica di assunzione di responsabilità di governo. C’era, pure, l’ingombro del passato. Bisognava stornare da sé la memoria (diventata terribilmente negativa) dei corsi di addestramento alla lotta armata di gruppi di militanti. Non perché il Pci abbia mai optato per il terrorismo, ma per quel che aveva comportato, la lealtà, se non la disciplina, al Comintern, al Cominform, e i rapporti fraterni col Pcus e con un paese dedito all’espansionismo come quello sovietico. I rapporti con la Cecoslovacchia divennero centrali. Continuano ad esserlo anche oggi animando un dibattito, cioè opinioni divergenti, tra gli stessi collaboratori di questo volume (Roberto Bartali, Franco Mazzola, Fernando Orlandi, chi scrive ecc.). Dai sospetti che l’ambasciata di Praga a Roma fosse stata una stazione di passaggio del calvario di Moro, Berlinguer scivola nella paura. La scoperta di frequentazioni di elementi delle Br e dei gruppi estremistici nei campi militari cechi, sovietici e mediorientali costituivano tracce, spie che potevano portare a identificare chi erano stati i loro predecessori, cioè i comunisti? Proprio questo album di famiglia è il rovello che scuote Enrico Berlinguer, Giorgio Amendola, Gianni Cervetti, Arturo Colombi, Emanuele Macaluso, Ugo Pecchioli, Salvatore Cacciapuoti ecc. Ad avvertirlo, e denunciarlo, fu prima Margherita Boniver e successivamente, nell’anno 1993, Bettino Craxi in due lettere, inviate a Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini rispettivamente presidenti della Camera dei deputati e del Senato. In esse si rilevava il ruolo classicamente comunista (cioè per un verso a difesa della democrazia e per l’altro di complicità col più dispotico e criminale potere del mondo, quello del comunismo sovietico) svolto da Ugo Pecchioli, chiedendone le dimissioni da presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti3. Chi, per conto del Pci, aveva inviato a Mosca gruppi di radio-trasmettitori, per essere addestrati dal Kgb a creare strutture illegali e spiare le attività militari, politiche ecc. del nostro paese, non 3
Si veda Maurizio CAPRARA, Craxi: Pecchioli deve dimettersi, «Corriere della Sera», 28 ottobre 1993, p. 7; Una lettera di Craxi sul “caso Pecchioli”, ivi, 29 ottobre 1993, p. 13.
10
Introduzione
poteva assolvere quell’incarico. Pertanto queste lettere, che pubblico in Appendice, rimasero carta straccia. Come accade a quelle dei riformisti italiani, che siano anche coerentemente anti-comunisti, sostarono senza risposta. Di fronte alle accuse di complotto e di sedizione mosse a Praga Fernando Orlandi deplora l’uso parziale, selettivo o, peggio, l’omissione della documentazione archivistica (a cominciare da quella della Repubblica ceca, accessibile da molti anni). Sulla base di essa, e di alcuni riscontri su fonti italiane, può affermare che per città come Dobrˇ ichovice sarebbe un’invenzione bella e buona sia la proclamata esistenza di campi di addestramento militare alla guerriglia, al sabotaggio e alle armi automatiche sia che a frequentarli possano essere stati i comunisti prima e i brigatisti successivamente. Orlandi non esclude che tanto in Cecoslovacchia quanto in Urss (qui sicuramente fino al 1981) quadri selezionati del Pci possano essere stati istruiti, sotto l’occhio vigile del Kgb, a tecniche di spionaggio, mimetizzazione per pratiche illegali, uso di radio-ricetrasmittenti, azioni specifiche di addestramento. È quanto sostengono Ministero dell’Interno, degli Esteri, servizi segreti e carabinieri. Di qui l’esigenza di un esame comparativo delle fonti italiane, ceche e russe che Orlandi opportunamente avanza. L’ex-sottosegretario al Ministero della Difesa e alla Presidenza del Consiglio, Franco Mazzola, non ha dubbi nel dare testimonianza del fatto che le voci sulla pista ceco-sovietica e quella mediorientale, per spiegare il terrorismo, erano quelle prevalenti al Viminale. Ma la presenza di Luciano Ferrari Bravo (e del gruppo legato a Toni Negri, che del comunismo dell’Europa orientale non subì mai il fascino), Augusto Viel, Fabrizio Pelli, Alberto Franceschini, Renato Curcio ecc. è smentita dalle ricerche tanto di Nicola Biondo, consulente della Commissione Mitrokhin, quanto di Orlandi e dal libro di Giuseppe Fiori. Mazzola chiama in causa la politica estera del doppio binario, da “marca occidentale”, con una faccia volta alle Alpi (cioè all’Occidente e all’atlantismo), e una faccia volta al Mediterraneo (cioè filo-arabopalestinese) che proprio Moro aveva contribuito a irrobustire. Una volta sotto schiaffo, poteva farcela lo Stato italiano a reggere questo equilibrio? I 55 giorni del calvario di Moro celebrarono l’inefficienza storica degli apparati statali di prevenzione e repressione. Gli italiani, non solo quelli vicini agli stereotipi della sinistra comunista, si sono spesso chiesti se lo Stato non sia stato complice, se 11
SALVATORE SECHI
non fomentatore, della strategia della tensione di cui l’assassinio del presidente della Dc sarebbe il massimo esempio. Vladimiro Satta, abituato da sempre a scombinare la quiete dei conformismi, smonta questa tesi in nome del principio del distingue frequenter. Non possono essere confusi tre periodi: il quinquennio (1970-1974) dell’inerzia legislativa, dell’arretratezza normativa e della impreparazione degli apparati; il quinquennio (1974-1978) di una politica ondivaga anche contraddittoria; e il dopo-Moro. Allora il Nucleo speciale anti-terrorismo dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’Ispettorato generale per l’azione contro il terrorismo (poi Sds) del questore Emilio Santillo, insieme alla legislazione che incoraggiò il “pentitismo”, consentirono allo Stato di riportare sulla criminalità politica organizzata una vittoria piena. Alla fine, il terrorismo rosso e lo spontaneismo armato nero sono stati sconfitti. Ed è un grande successo della democrazia italiana non aver pagato un prezzo che non era scontato potesse esserle risparmiato: quello di vedere diminuire la libertà di espressione, di voto e il pluralismo politico. Satta onestamente confessa che il paese ha, invece, dovuto soccombere di fronte allo stragismo. I suoi protagonisti l’hanno potuta fare franca, in quanto lo «stragismo, obiettivamente, era più sfuggente, perché rinunciando a rivendicare gli attentati e a coltivare un radicamento sociale si rendeva meno esposto del terrorismo rosso; inoltre la destra eversiva usufruì di qualche protezione, attestata da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente». C’è da chiedersi se prevenire (è quanto lo Stato italiano non sa fare), non sia più oneroso (anche in termini di godimento delle libertà) che reagire. I dubbi sulla dinamica dei fatti nell’agguato di via Fani e in generale la differenza tra la verità processuale e quella realmente accertata avanzati dall’onorevole Franco Mazzola si sommano a quelli sull’attribuzione dei comunicati dei brigatisti. Gabriele Paradisi ha il sospetto che non si sia andati a fondo, quanto era necessario, lasciando così semplicemente accantonata, e quindi senza risposta, la preoccupazione che venne avanzata da un diplomatico che era stato in servizio all’ambasciata italiana a Mosca, il consigliere Renzo Rota. Non c’era una ridondanza della lingua russa, anzi del lessico leninista, nella terminologia con cui si esprimevano i brigatisti almeno nei 12
Introduzione
primi due comunicati del 18 e 25 marzo 1978? Il timore che essi non fossero italiani può dare la stura ad un tormentone, alimentando il ritorno della fenice, cioè della vecchia cara dietrologia. Insieme a quella che accusa l’Urss e il suo servizio segreto (il Kgb), ne è cresciuta un’altra di segno diametralmente opposto. In termini storiografici è stata battezzata come «teoria dell’eversione atlantica». Secondo il Pci che per primo la inaugurò, a suonare la musica sarebbero stati la Cia degli Stati Uniti, il Mossad di Israele, l’MI6 della Gran Bretagna, la nostra intelligence dai nomi stagionalmente cangianti. Nelle pagine che seguono me ne occupo ampiamente (e ne chiedo scusa ai lettori) avviando una discussione con l’esponente più avveduto e sensibile, Giuseppe De Lutiis, di questo genere di studi. Proprio per la sua volontà, e non solo desiderio, di non restare prigioniero di vecchi schemi, di modificarli e anche rinunciarvi, se necessario, mi pare si possa dire che De Lutiis, a differenza di altri suoi “scolari”, sia diventato abbastanza postumo alla formulazione identitaria che ho voluto qui discutere. La storiografia del caso Moro si è sempre trattenuta, se non rifiutata, dal guardare sino in fondo su come erano veramente scritti i comunicati Br. Con questa omissione ha evitato di vedere rifrangersi “lo specchio orrendo” delle tare ereditarie dell’album di famiglia. Perciò Gabriele Paradisi ripercorre con pudore, come se fosse una colpa, l’âme d’ancêtre di quei giorni. Ma essa acquista una coloritura dietrologico-complottistica negli scritti di chi, per la verità, sembra rivendicarla senza remore, quasi con orgoglio. Anche nella cura assai ritrosa per la completezza bibliografica, e per la segnatura delle fonti, A. Giannuli è in tutto e per tutto uomo della contro-informazione4. Da P. Cucchiarelli, G. De Lutiis, i ferri vengono fatti cigolare al collo e ai piedi di vecchi satrapi onnipresenti della politica italiana, cioè Giulio Andreotti, i servizi segreti, in combutta con la camorra e la malavita di Francis Turatello. Di questo Anello della Repubblica offre un quadro Stefania Limiti per Chiarelettere. È 4
A questo aspetto importante della realtà italiana ha dedicato di recente una ricerca (A. GIANNULI, Bombe a inchiostro, Bur, Milano 2008), in cui si contrappongono oscurità come «le cosiddette fonti ufficiali dell’informazione e i molti rivoli della militanza democratica», e si coltiva una doppia illusione (per un liberal-democratico), cioè che il sigillo di «una democrazia integrale» sia «lo svelamento dei rapporti di potere». Dilemmi da storiografia da Centri sociali.
13
SALVATORE SECHI
un mondo umbratile, di intelligence sopravvissuta al fascismo (il “Noto Servizio” in attività con la Nato come “Anello”), padri francescani, cappellani delle carceri, terroristi di ogni specie. Brigano per soldi, per carità cristiana, ma anche per interesse primario alle carte di Moro. Insieme alla preservazione del sistema politico e della stessa Nato, fu questo anche il caso del funzionario che il Dipartimento di Stato americano, per appagare le richieste di aiuto del ministro dell’Interno Francesco Cossiga, invia a Roma, Steve Pieczenik? Clementi nega che dietro le Br ci fosse la Cia o “poteri occulti” come pensava, al pari di Giannuli, uno storico come Pietro Scoppola. Né si associa al sospetto che l’ex segretario di Stato Henry Kissinger (che amava Moro quanto Olaf Palme e Willy Brandt) fosse l’occulto ispiratore dell’assassinio del leader democristiano. Quasi tutti i collaboratori di questo volume concordano con questa impostazione. Resta, però, oscuro il comportamento di Pieczenik durante il suo soggiorno come membro di uno dei Comitati di crisi creati da Cossiga. Dopo aver sostenuto il contrario (prendendo la decisione di rientrare a Washington), egli si auto-assegna un ruolo di primo piano in seno al Comitato di crisi di cui fece parte. E arriva a dichiarare di avere concordato con Cossiga sia l’operazione del lago della Duchessa (col falso comunicato delle Br sulla morte, inventata di sana pianta, di Moro) sia la scelta per cui il presidente della Dc sarebbe stato più utile da morto che da vivo. In questa condizione non avrebbe potuto divulgare i segreti militari della Nato di cui poteva essere a conoscenza né attaccare Giulio Andreotti. Pieczenik non ha mai confessato se questa linea di condotta fosse una sua iniziativa personale o l’avesse concordata col Dipartimento di Stato. C’è anche da tenere conto che altre testimonianze (da quelle di Cossiga a quelle di Stefano Silvestri, del sottosegretario onorevole Mazzola, dei magistrati Claudio Vitalone e Luciano Infelisi ecc.) lo smentiscono. Vladimiro Satta ha mostrato quanto il consulente degli Stati Uniti sia inaffidabile5, ma qualcuno lo incorona come un esperto nella guerra psicologica di cui Cossiga sarebbe stato l’ennesima vittima. 5
Si veda il saggio di V. SATTA, Il sequestro e l’omicidio Moro (in corso di pubblicazione negli atti del convegno su Moro organizzato, il 5 dicembre 2008, dalla Luiss e dall’Università di Bari).
14
Introduzione
Forse quando si scrive che Pieczenik fu un vero e proprio dominus di tutta la vicenda, il suo nome è citato come una metafora della Casa Bianca? Uno dei maggiori storici nordamericani dell’Italia contemporanea ci viene incontro riabilitando l’onda lunga e la cultura da cui viene il terrorismo italiano6. Dopo nove anni di studi, Richard Drake è arrivato alla conclusione che le ragioni della morte di Moro vanno ricercate nelle idee di chi ne è stato il killer: «Mi resi conto infatti di quanto le Brigate rosse appartenessero ad una tradizione rivoluzionaria che affondava le proprie radici nella più classica critica marxista del capitalismo». Esse non avevano la ragion di Stato come non l’ebbe mai Moro che credeva nei conflitti tra i popoli, e nel dovere di dare pari dignità anche a chi non aveva la forma dell’istituzione come i terroristi: «La ragione di rivoluzione è la più radicale delle ragioni di Stato: e le implacabili Br non risposero all’atto solenne con cui Paolo VI cercò di coinvolgerle nel dialogo da esse cercato con le istituzioni mediante l’appello diretto ai brigatisti di salvare Aldo Moro “senza condizioni”, cioè senza trattativa delle Br con lo Stato. Le Br non consideravano la Chiesa come potere, volevano il riconoscimento del potere reale: quello dello Stato italiano che non ebbero»7. Le ideologie secolari del mondo moderno non sono mitridatizzate contro il fanatismo dal quale restano influenzati anche i gruppi terroristici. Pertanto, rileva Drake in polemica con le teorie complottistiche, nonostante «i goffi tentativi […] solo attraverso una soppressione sistematica dell’uso della logica e delle prove si potrebbero sostituire, nel ruolo di autori del crimine, le Brigate rosse con la Cia, il Mossad o il Kgb». A spuntarla è, ancora una volta, il nostro saggio amico oltremontano, Alexis de Tocqueville. S.S. 6
Alla ricerca delle ragioni che hanno spinto una banda di rivoluzionari al sequestro e all’assassinio di Moro è dedicato anche l’ultimo saggio (che fa seguito a Il caso Aldo Moro, Marco Tropea editore, Milano 1996) di questo appassionato professore di storia nell’Università del Montana, R. DRAKE, Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Le Lettere, Firenze 2008. 7 Si veda Gianni BAGET BOZZO, Moro, la Dc e il dialogo sconfitto, «La Stampa», 3 dicembre 2008 e in generale l’ampia riflessione dello stesso Gianni BAGET BOZZO e Giovanni TASSANI, Aldo Moro: il politico nella crisi, 1962-1973, Sansoni, Firenze 1983.
15
SALVATORE SECHI
Ringraziamenti Questo libro non avrebbe visto la luce anzitutto senza il Convegno nazionale sul delitto Moro che il Comune di Cento, per la liberalità del sindaco Flavio Tuzet e dell’assessore alla Cultura Daniele Biancardi, ha reso possibile il 15-16 marzo 2008, in occasione del trentennale della morte del leader democristiano. In secondo luogo, era destinato a soccombere se non avesse potuto contare sulla collaborazione editoriale efficace e sui precisi commenti critici di Gabriele Paradisi e di Alberto (il nostro amico innominabile). 16
SIGLE E ABBREVIAZIONI
Amt Anpi Anppia
Azienda municipale trasporti di Genova Associazione nazionale partigiani italiani Associazione unitaria dei perseguitati politici antifascisti italiani Apci Archivio del partito comunista italiano Br Brigate rosse Cc Comitato centrale Cesis Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza Cia Central Intelligence Agency Cs Centro situazione (struttura del Sid) Cs Controspionaggio Digos Direzione investigazioni generali e operazioni speciali (organo di polizia di stato) Far Fasci di azione rivoluzionaria Fig Fondazione Istituto Gramsci Fplp Fronte popolare per la liberazione della Palestina Gap Gruppi di azione patriottica g.i. giudice istruttore Gis Gruppo Intervento Speciale Carabinieri Kgb Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitato per la sicurezza statale) Kominform Informacionnoe bjuro kommunisticeskich i rabocich partij (Ufficio informativo dei partiti comunisti e operai) Komintern Kommunisticeskij internacional (Internazionale comunista) Mar Movimento di azione rivoluzionaria 17
SIGLE E ABBREVIAZIONI
MI6 Nar Msi Mossad Nato Nsc Olp Oss P2 Pcf Pci Pcus Polfer Raf Ros Sap Sds Sdece Sid Sifar Sigsi Sim Sim Sios Sisde Sismi Stasi Stb Sùa Ucigos Urad
Servizio segreto inglese Nuclei armati rivoluzionari Movimento sociale italiano Servizio segreto israeliano North Atlantic Treaty Organization National Security Council Organizzazione per la liberazione della Palestina Office of Strategic Services Loggia massonica segreta appartenente al Grande Oriente d’Italia Partito comunista francese Partito comunista italiano Partito comunista dell’Unione sovietica Polizia ferroviaria Rote Armee Fraktion Reparto operativo speciale dei Carabinieri Squadre di azione patriottica Servizio di sicurezza per la lotta contro il terrorismo Servizio segreto francese Servizio Informazioni Difesa Servizio Informazioni forze armate Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna Stato imperialista delle multinazionali Servizio Informazioni militari Servizio Informazioni e operazioni e segrete Servizio per l’informazione e la sicurezza democratica Servizio informazioni e sicurezza militari Servizio segreto della Repubblica democratica tedesca Servizio segreto cecoslovacco Archivio statale di Praga Ufficio centrale investigazioni generali e operazioni speciali, Ministero dell’Interno Servizio civile ceco di intelligence per l’estero
18
IL DELITTO MORO TRENT’ANNI DOPO L’EREDITÀ DEL 1978 NELLA POLITICA E NELLA CULTURA ITALIANE
Richard Drake*
Ho vissuto a Roma dal giugno 1972 all’agosto 1973, in parte grazie ai fondi della borsa di studio Aldo Moro per gli studenti stranieri: un supporto che si rivelò essenziale per aiutarmi a completare le ricerche per la mia tesi di dottorato sull’emersione di una cultura secolare di destra in Italia. Quando, parecchi anni più tardi, quella dissertazione divenne un libro1, credevo ancora che avrei dedicato la mia carriera di studioso alla storia culturale e politica italiana del XIX secolo. Invece, proprio mentre a Los Angeles lavoravo al suo completamento, seppi del rapimento e della morte di Aldo Moro. Nonostante non avessi mai avuto rapporti personali con il presidente, sentii il bisogno – proprio per aver svolto le mie ricerche in quel ruolo – di dedicarmi allo studio delle ragioni per le quali era stato assassinato dalle Brigate rosse. Mi furono necessari nove anni per produrre un rapporto preliminare sui motivi dell’assassinio2. Nello scrivere quel testo, mi convincevo sempre più della nota tesi sostenuta da Eric Hoffer3 che cioè, per avere una guida ideologica e politica, gli uomini di azione dipendono da quelli di idee. Mi resi conto infatti di quanto le Brigate rosse ap* Professore di Storia moderna europea e Direttore del Dipartimento di Storia dell’Università del Montana, Usa. Il saggio è stato pubblicato originariamente su Federalismi.it: Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato (giugno 2008), che ringraziamo per averne autorizzato la riproduzione. 1 R. DRAKE, Byzantium for Rome. The Politics of Nostalgia in Umbertian Italy, 1878-1900, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1980. 2 Lo pubblicai con il titolo di The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1989. 3 E. HOFFER, The True Believer. Thoughts on the Nature of Mass Movements, Harper, New York 1951.
19
RICHARD DRAKE
partenessero ad una tradizione rivoluzionaria che affondava le proprie radici nella più classica critica marxista del capitalismo. Lo evidenziava del resto anche Mario Moretti, uno dei loro leader, il quale insisteva sul fatto che le Brigate rosse avevano sempre pensato a sé come a comunisti rivoluzionari, per quanto disordinatamente le loro azioni potessero essere ricollegate alla teoria marxista-leninista. D’altra parte, lo stesso Lenin era notoriamente disordinato nell’applicazione dei principi marxisti alle azioni e alle politiche dei bolscevichi: in un senso, dunque, i marxisti-leninisti avevano già dato vari esempi di saper agire in modo innovativo, se ciò era richiesto dalle specifiche circostanze di un particolare capitalismo. In The Revolutionary Mystique, analizzavo il modo in cui Raniero Panzieri e Toni Negri avevano adattato la cultura storica del marxismo alle esigenze dei rivoluzionari dell’Italia contemporanea. Enormi divergenze di opinioni dividevano l’estrema sinistra in piccolissimi e medi compartimenti tattici ed ideologici, che raramente concordavano sui modi di promuovere la rivoluzione. La fede nella sua imminenza e necessità pervadeva l’intero movimento della cosiddetta «sinistra extraparlamentare», come veniva comunemente definito questo arcipelago di gruppi dissenzienti. Molti fra pensatori, gruppi e riviste extraparlamentari guadagnarono una certa notorietà. Ma furono Panzieri e Negri a giocare i ruoli chiave nel processo di auto-definizione della sinistra rivoluzionaria italiana alla vigilia dei violenti anni Settanta4. Nei «Quaderni rossi», Panzieri e i suoi seguaci, fra i quali anche Negri, si appassionavano a sostenere la perdurante necessità della rivoluzione. In effetti, la causa rivoluzionaria aveva sofferto, qualche anno prima, un monumentale disastro: quando infatti, nel 1956, Nikita Kruscev aveva rivelato la natura di Iosif Stalin – a lungo percepito in Italia quale la quintessenza dell’uomo comunista – alla pari di un mostro assetato di sangue, per reazione molti settori della sinistra, incluse parti dello stesso Partito comunista, invocarono l’avvento di un socialismo democratico, avviando così la lunga marcia della sinistra 4
R. DRAKE, Vivere la rivoluzione. Raniero Panzieri, “Quaderni rossi” e la sinistra extraparlamentare, «Nuova storia contemporanea», VII, n. 6 (novembre-dicembre 2003), pp. 33 sgg.; R. DRAKE, Il seme della violenza. Toni Negri apostolo della rivoluzione nella stagione del terrorismo, «Nuova storia contemporanea», VIII, n. 6 (novembre-dicembre 2004), pp. 57 sgg.
20
Il delitto Moro trent’anni dopo
verso il centro (o, almeno, verso posizioni ideologiche che Marx e Lenin avrebbero considerato come tradimenti della causa della rivoluzione). Proprio in quegli anni, Panzieri si faceva così la fama del più aperto oppositore alla resa della sinistra al riformismo, affermando che l’Italia aveva ora più che mai bisogno di una rivoluzione, e che questo richiedeva l’abbattimento violento del capitalismo nella stessa maniera descritta da Marx e messa in pratica da Lenin. Nonostante Negri abbia scritto su «Quaderni rossi», insieme a Panzieri si scontrarono su quello che era sempre stato il maggior punto di attrito nella sinistra marxista: se cioè il suo compito fosse quello di avviare la rivoluzione vera e propria o, più semplicemente, quello di limitarsi a prepararla. Negri – che, dopo la morte prematura di Panzieri nel 1964, divenne il più noto rivoluzionario marxista in Italia – spingeva più fortemente dell’altro per l’azione rivoluzionaria immediata. Brillante e carismatico professore all’Università di Padova, egli sosteneva infatti come la sola speranza per un’umanità ormai stretta nella morsa del capitalismo potesse venire dalla capacità del marxismo-leninismo di rispondere agli oppressori del mondo: insomma, un vero potere operaio, dunque – per richiamare il titolo di una delle sue riviste – avrebbe potuto essere ottenuto solo attraverso le vie descritte da Lenin in Stato e Rivoluzione. Fu proprio riprendendo quella prospettiva apertamente rivoluzionaria che per dieci anni era stata resa familiare dalla lunga fila di portavoce e riviste della sinistra extra-parlamentare, che Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini presentarono il loro programma nel fondare le Brigate rosse. Della sinistra extra-parlamentare, i comunicati delle Brigate rosse riflettevano le classiche questioni dello sfruttamento del proletariato e della necessità di una rivoluzione comunista contro lo status quo capitalista. Nel dichiarare guerra all’egemonia delle società internazionali che avevano fatto dell’Italia un avamposto dell’impero economico statunitense, essi davano una dimostrazione pratica di cosa significasse vivere la rivoluzione: le loro rapine, i loro rapimenti, le loro gambizzazioni e i loro omicidi generavano una sorta di regno del terrore per i sostenitori della democrazia italiana. Nelle situazioni rivoluzionarie, nessun limite morale può essere posto alla violenza del proletariato contro la classe dei suoi tormentato21
RICHARD DRAKE
ri. Era sulla base di questa regola d’oro marxista-leninista che l’organizzazione lanciò la sua sanguinosa campagna di liberazione, guadagnandosi al principio vari gradi di approvazione (o almeno di comprensione) in una vasta platea di sostenitori nella sinistra extraparlamentare. Di questa campagna delle Brigate rosse contro lo Stato, il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro segnarono lo zenith. L’enorme impatto di questa operazione sulla psiche italiana ha dato adito a “teorie della cospirazione” che andavano dal teoricamente possibile al platealmente assurdo. Ma nei 30 anni di scavi giornalistici ed accademici per la ricerca della verità sull’orribile destino di Moro, nessuna prova a sostegno di alcuna di esse è stata rinvenuta. La mancanza di prove, comunque, non è riuscita ad evitare la loro crescita lussureggiante nella società italiana. Ho passato lunghi anni negli archivi giudiziari di Roma a svolgere ricerche per il mio libro del 19955, e non sono riuscito a trovare nulla che minasse le conclusioni giudiziarie secondo le quali la morte di Moro è da imputare esclusivamente alle azioni del movimento rivoluzionario detto Brigate rosse. Del resto, essendo la figura politica più importante del paese, Moro era un obiettivo logico per le Brigate rosse. E i resoconti giudiziari mostrano come queste ultime abbiano colpito proprio nel momento della massima debolezza e confusione per lo Stato, il quale infatti, nel corso delle indagini, compì vari e ben documentati errori. Nonostante i goffi tentativi, dunque, solo attraverso una soppressione sistematica dell’uso della logica e delle prove si potrebbero sostituire, nel ruolo di autori del crimine, le Brigate rosse con la Cia, il Mossad o il Kgb. Investigando fra le carte dei processi e delle inchieste parlamentari sul caso Moro, devo dire che mi sono sentito come se mi fossi imbattuto nel sancta sanctorum di una comunità di fede. Negli Stati Uniti, ove la religione conserva un potere enorme rispetto alle esperienze culturali di altri paesi avanzati, abbiamo ampia
5
R. DRAKE, The Aldo Moro Murder Case, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1995 (tr. it. Il caso Aldo Moro. Una tragedia italiana vista da uno storico americano, Tropea, Milano 1996). Si veda anche R. DRAKE, Cultura della rivoluzione e delitto Moro. Le teorie della cospirazione contro la verità che fa male, «Nuova storia contemporanea», V, n. 6 (novembre-dicembre 2001), pp. 19 sgg.
22
Il delitto Moro trent’anni dopo
opportunità di osservare la fede in azione, anche e soprattutto ai più alti livelli del governo di Washington. In proposito, Tocqueville – che non fu né il primo né l’ultimo osservatore ad essere colpito dalla straordinaria influenza delle credenze religiose nella vita americana, ma ne rimane comunque il più brillante studioso – ha osservato, con grande acume, quanto vicine al fanatismo religioso del tipo più estremo possano giungere le ideologie secolari nel mondo moderno. I terroristi che testimoniarono nei processi Moro diedero per lo più poche informazioni utili sui dettagli del rapimento e dell’omicidio, dando così ulteriore corpo al processo di produzione di massa di “teorie della cospirazione”. Molti di loro, in compenso, resero testimonianza – come si usa dire in taluni circoli religiosi americani – della fede che li animava per Marx, per Lenin, e per un gruppo di divinità minori nel pantheon della rivoluzione. Marx e Lenin, in particolare, venivano riveriti come quella patristica le cui idee costituivano i valori essenziali della crociata che le Brigate rosse avevano lanciato contro i mali mostruosi del capitalismo italiano e dei suoi servitori – primi fra tutti i crudeli democristiani e i più sottilmente depravati comunisti. Nei licei, nelle università, nelle fabbriche e nei quartieri d’Italia, assemblee e gruppi di discussione marxisti-leninisti avevano così catechizzato una generazione di giovani sugli abomini del capitalismo e sulle virtù del comunismo come via, verità e vita per tutta l’umanità: l’adesione alle Brigate rosse richiedeva evidentemente un lungo condizionamento preparatorio nella fede e nei testi sacri del comunismo. Nel mio libro del 20036 ho tentato di analizzare il significato e le dinamiche storiche del marxismo italiano, evidenziando in particolare come, sin dal suo approdo nel paese con la traduzione e i commentari di Carlo Cafiero negli anni Settanta dell’Ottocento, la tradizione marxista italiana abbia sofferto di una fondamentale scissione fra rivoluzionari e riformisti. In questo senso, il famigerato appello di Cafiero perché il proletariato uccidesse Andrea Costa, colpevole di apostasia riformista dagli
6
R. DRAKE, Apostles and Agitators. Italy’s marxist Revolutionary Tradition, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2003 (tr. it. Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Le Lettere, Firenze 2008).
23
RICHARD DRAKE
ideali della rivoluzione, sembra aver predisposto una sorta di schema ricorrente nella vita della sinistra italiana. Anche Antonio Labriola, filosofo marxista assai originale (in un certo senso, il Toni Negri dei suoi giorni), sottolineava l’importanza vitale della violenza per l’avanzamento della causa della liberazione del proletariato dalla schiavitù universale imposta dal capitalismo. In questo modo, egli si opponeva a Filippo Turati, la maggior figura nei primi anni della storia del Partito socialista italiano: il programma di Turati per una riconciliazione fra pratiche della democrazia e idealismo socialista veniva infatti guardato da Labriola come nulla più che un salvacondotto per il mantenimento della dittatura capitalista sull’umanità. Egli non giungeva a chiedere l’assassinio di Turati, il cui riformismo pure lo irritava e imbestialiva, ma pensava comunque che il comunismo sarebbe potuto venire al mondo solo se i sostenitori del capitalismo fossero stati spediti prematuramente alle loro tombe. In effetti, fu un’intera generazione di rivoluzionari italiani a demonizzare Turati. Arturo Labriola – che non era parente di Antonio, nonostante la comune provenienza partenopea – concepì il sindacalismo rivoluzionario proprio come antitesi morale e politica al turatismo. Per non parlare del principale simbolo della passione rivoluzionaria nell’Italia dell’ante-guerra, Benito Mussolini, il quale semplicemente associava l’ottica di Turati con il campo nemico del capitalismo. Anche i giovani socialisti Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti guardavano tutti all’intransigente Mussolini per una guida fuori dal caos politico creato dal flirt di Turati con Giovanni Giolitti e il suo tentativo di trasformare il socialismo in un supporto per lo status quo. A seguito dell’arresto di Gramsci nel 1926, Togliatti divenne il dominatore incontrastato del Pci e tale rimase per i successivi quarant’anni. Fu un’ironia della sorte che proprio un uomo che nel 1921 aveva lasciato il Partito socialista per via della svolta riformista, dovesse divenire nei suoi ultimi anni, per la nascente sinistra extra-parlamentare, il volto del più stanco e trito conformismo comunista. Così, Adriano Sofri, allora astro nascente della sinistra extra-parlamentare, lo criticava di fronte a un uditorio dell’Università di Pisa per aver abbandonato il principio basilare che dava a un individuo il diritto di chiamarsi comunista: una completa ed inequivoca dedizione alla causa della rivoluzione. 24
Il delitto Moro trent’anni dopo
Enrico Berlinguer, uno dei successori di Togliatti come segretario del Pci, ricevette lo stesso tipo di critiche dalle Brigate rosse. Nei loro comunicati siglati dalla stella a cinque punte, denunciarono lui e il suo partito come l’ultima incarnazione del “revisionismo”. Nella loro prospettiva rivoluzionaria, affermavano che Giolitti avrebbe tratto diletto dal compromesso storico degli anni Settanta fra comunisti e democristiani, poiché, nella loro lettura, ad inizio secolo egli e Turati avevano tentato anch’essi di giocare un simile tiro alla classe operaia. Il brigatismo rosso nacque, dunque, come una setta marxista-leninista intenta a ravvivare ed attuare l’antica religione della rivoluzione. In questo senso, esso ha fallito completamente: né avrebbe potuto essere altrimenti, date le circostanze storiche generali del tempo. Nonostante infatti, inizialmente, avessero il sostegno di molti elementi della sinistra extraparlamentare, il resto del sistema politico stava, nella sua interezza, schierato contro le Brigate rosse, a cominciare dai comunisti. Soprattutto, il sole stava ormai tramontando sull’intero mondo marxista-leninista. Poco più di un decennio dopo l’assassinio di Moro, la Guerra Fredda cessò, e con essa si spense lo slancio e la sostanza del comunismo ovunque in Europa. In questo senso, è istruttivo visitare il magazzino di servizio dove l’Istituto Gramsci a Roma tiene la sua collezione di riviste marxiste. Vi sono mostrati i resti terreni di una cultura che un tempo fu orgogliosa, potente e fiduciosa. Uno ad uno, quei giornali cessarono di esistere nel corso degli anni Novanta, il decennio nel quale lo stesso Partito comunista subì uno smantellamento interno. La santa madre chiesa del comunismo italiano si dissolse così in un assortimento di nuovi autoproclamati democratici e, minoritariamente, di epigoni comunisti di varia foggia che offrivano differenti visioni dell’autentico Marx. La dissoluzione del comunismo negli anni Novanta non impedì però alle Brigate rosse di mettere in scena un proprio ritorno verso la fine del decennio. Sconfitti dallo Stato negli anni successivi all’omicidio Moro, i brigatisti si erano da allora rifugiati in un’esistenza da fuggitivi. Poi, nel 1999, una loro nuova generazione, sostenendo di continuare la battaglia anti-capitalista dei predecessori, uccise Massimo D’Antona; e, tre anni più tardi, inflisse la medesima sorte a Marco Biagi. 25
RICHARD DRAKE
Entrambe le vittime appartenevano alla sinistra moderata. Tutti e due, come economisti, erano stati funzionali all’avanzamento dell’integrazione dell’Italia nell’economia globalizzata. In questo modo, le nuove Brigate rosse denunciavano la globalizzazione come l’ennesimo capitolo dell’eterno tentativo capitalista di organizzare le masse per il loro sfruttamento. Una sequela di arresti mise comunque rapida fine a questa recrudescenza del brigatismo rosso, anche se, data la lunga storia di attivismo rivoluzionario del paese (protrattasi praticamente fino ad oggi), può essere prematuro pensare che sia l’ultima volta che sentiamo parlare di uomini e donne pronti ad uccidere ed essere uccisi per la causa comunista. L’eredità degli anni Settanta resta una parte assai importante della cultura e della politica italiane di oggi, in una maniera che colpisce come inusuale un osservatore statunitense. Gli Usa hanno avuto la loro versione di un simile decennio nelle azioni terroristiche del Weather Underground. Per quanto infatti esistano certamente differenze importanti fra il Weather Underground e le Brigate rosse, entrambi questi gruppi vedevano l’impero americano come la causa principale della povertà e dello sfruttamento inflitti al mondo: il Weather Underground lo attaccava direttamente attraverso attentati terroristici contro le strutture politiche e militari degli Usa; le Brigate rosse si concentravano invece sulla distruzione dell’anello italiano della tela del capitalismo internazionale ordita da Washington, ma rappresentavano comunque i democristiani e perfino i comunisti come pilastri dell’ordine imperiale americano in Italia. Il Weather Underground riuscì a mettere a segno un record di pressoché totale inutilità, e scivolò ben presto verso l’insignificanza, il che segna un aspro contrasto con la sfida prolungata posta dalle Brigate rosse. La sospensione del Selective Service nell’aprile 1973 segnò di fatto la fine per il Weather Underground come forza significativa nei campus universitari. Senza più la leva, la minaccia del Vietnam perse la sua immediatezza per gli studenti universitari, esattamente come accade per la guerra in Iraq oggi. Ben presto, il radicalismo del Weather Underground abbandonò perfino la pretesa di aver un qualunque seguito nella società. Le ragioni dell’inefficacia e del carattere effimero del Weather Underground gettano una luce contrastante sulla presenza vigorosa del26
Il delitto Moro trent’anni dopo
le Brigate rosse nella vita italiana durante gli anni Settanta e, come memoria storica vivente, ancora oggi. Christopher Lasch7 ha osservato che due gruppi predominano nella politica statunitense: i conservatori religiosi e le élites universitarie liberal. Nessuno dei due ha alcuna affinità con la rivoluzione. Dunque, nel senso serio del termine, la rivoluzione non ha praticamente alcuna chance di successo negli Usa: a meno che non prenda la forma di Padri Fondatori dedicati alla preservazione di istituzioni quali la chattel slavery, i rivoluzionari americani si trovano di fronte un’opposizione pressoché compatta da parte dell’intero spettro della cultura e della politica del paese. Arturo Labriola, che trascorse molti anni negli Stati Uniti e li conosceva a fondo, giunse ad una conclusione simile ottanta anni fa quando affermava che la più notevole caratteristica degli americani era la loro invincibile fiducia nel loro sistema economico e politico. Nonostante spaventosi problemi sociali, la vita del paese scivolava via tranquilla, mentre la vasta maggioranza della popolazione aspettava fiduciosa di diventare ricca. L’America diede l’opportunità di divenire milionari. E fintanto che quella fiducia fosse durata – prevedeva Labriola – il socialismo non avrebbe contato nulla. Perfino un test così duro come quello posto dalla depressione degli anni Trenta avrebbe mancato di produrre un’efficace sfida socialista allo status quo americano. Le distorsioni e le tensioni prodotte nella società americana dalla tragica guerra del Vietnam avevano creato la momentanea illusione di una possibilità rivoluzionaria per il Weather Underground: i rivoluzionari americani cercarono così di far attecchire, nella tradizione radicale della Nazione, uno stelo assai leggero. Ma con la fine del Vietnam e il ritorno alle normali condizioni di vita, l’intero peso della cultura si mosse contro di loro, esattamente come descritto da Lasch e precedentemente, in Italia, da Labriola. Sconfitti e decimati, il Weather Underground scomparve così senza lasciare alcuna traccia politica, eccetto che per la reazione negativa prodotta nella società, e in particolare nel processo che contribuì poi al revival repubblicano dell’era Reagan. 7
CH. LASCH, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton, New York 1978 (tr. it. La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano 1981).
27
RICHARD DRAKE
In Italia, le cose sono andate diversamente. Qui le Brigate rosse possedevano i vantaggi combinati di una cultura rivoluzionaria vitale e diffusa e di una serie di perduranti problemi sociali, economici e politici: tutti aspetti che, di norma, facilitano il progresso dei gruppi radicali. Il caos nel sistema universitario, la crisi dell’occupazione, lo stallo di un sistema politico diffusamente percepito come corrotto e senza speranza fornirono all’organizzazione un pubblico ammirato ed un ampio gruppo di reclute per il loro assalto rivoluzionario all’establishment dello Stato. Fu dunque una generazione intera che, con vari gradi di veemenza, partecipò al movimento rivoluzionario italiano: questo è quel che intendevano Curcio e Moretti quando, nei tardi anni Ottanta, scrissero che le Brigate rosse appartenevano a un tempo e ad una cultura caratterizzate dalla rivoluzione in migliaia di forme. In quella fase, molti personaggi della sinistra stavano tentando di relegare l’organizzazione in una sorta di storia separata: ma gli onesti e quelli di buona memoria sapevano bene che, in realtà, essa condivideva il suo pedigree ideologico con l’intero movimento. Per tutti i componenti, la rivoluzione era stata l’unica cosa buona in una sordida vita capitalista: ed era questa convinzione che li aveva guidati nei loro destini separati, conducendoli chi alla prigione o alla morte, chi ad alte posizioni nella politica, nella finanza, o nel giornalismo. Queste contiguità rendono oggi difficile mettere le Brigate rosse al sicuro nel passato dei libri di storia: quel passato dove ora giace, indisturbato e indisturbante, il Weather Underground. La tesi di Curcio e Moretti secondo cui i brigatisti appartenevano alla (ed agivano in nome della) intera generazione del ’68 significa infatti coinvolgere nell’esperienza dell’organizzazione un segmento di peso della società italiana. Moretti in particolare reiterava l’accusa nelle sue memorie8 sostenendo come fossero in molti a stimare le Brigate rosse e ad aiutarle: del resto, si chiedeva, come avrebbero fatto altrimenti a sopravvivere tutti quegli anni senza l’assistenza di un ampio giro di persone?
8
Brigate rosse. Una storia italiana, intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Anabasi, Milano 1994.
28
Il delitto Moro trent’anni dopo
I processi Moro forniscono abbondanti prove per sostenere la tesi di Moretti che, in aggiunta ai 300 membri attivi, qualcosa come 5000 fiancheggiatori potevano essere richiesti di fornire case sicure, aiuto medico, soldi, automobili, ecc. Molte altre migliaia, poi, guardavano da lontano alle Brigate rosse ammirandole e riconoscendo in esse la realizzazione della promessa della lungamente attesa e desiderata rivoluzione. Negli anni Settanta, insomma, la tradizione rivoluzionaria italiana ha avuto il suo rendez-vous con la storia. Di quella tradizione, le Brigate rosse erano interpreti sostanzialmente equi ed onesti: esse fornivano argomenti ben ragionati basati sui principi marxisti sul perché il capitalismo, con l’America in testa, fosse destinato ad assestare una sconfitta finale all’umanità; temporeggiare ora avrebbe significato la vittoria totale per la società dei consumi che essi odiavano. Quante volte, dai tempi di Carlo Cafiero, gli italiani avevano ascoltato simili chiamate alle armi rivoluzionarie dei marxisti? In questo senso, il destino storico dell’Italia è stato quello di trovarsi, fra tutte le nazioni occidentali, nei primi ranghi della battaglia ingaggiata da Marx per la defenestrazione dell’uomo “acquisitivo”. Il virtuale collasso del comunismo ha lasciato un vuoto enorme nella vita politica e culturale italiana. Per adottare termini gramsciani, il comunismo ha giocato un ruolo centrale contro-egemonico rispetto all’ordine democratico-cristiano appoggiato dagli Stati Uniti. In quest’ottica, la disintegrazione della Dc ha avuto un impatto minore di quella del suo storico nemico: l’ordine successivo a quella si è infatti prodotto senza strappi, e la presenza militare, economica e culturale statunitense rimane come segnale delle continuità strutturali con il passato (né sembra vi sia alcunché in termini di forza reale con cui si possa contestare quella presenza). Nell’ordine naturale delle cose, queste situazioni tendono a mettere in moto le dinamiche della hubris con le connesse tragedie per tutti coloro che ne sono interessati. L’assenza di una forza in grado di limitare l’egemonia americana in Italia non ci dovrebbe comunque far sentire alcuna nostalgia per i giorni gloriosi del Partito comunista. A quanto pare, Turati fece una previsione azzeccata quando, nel 1921, mise in guardia contro i disastri che la storia avrebbe avuto in serbo per i socialisti d’ogni parte del mondo a causa della vittoria del bolscevismo. 29
RICHARD DRAKE
Il comunismo italiano aveva il bolscevismo come sua ragion d’essere, e i due avrebbero condiviso il medesimo destino. Tuttavia Turati sperava che, nel giorno del giudizio del bolscevismo, reso inevitabile dalle enormità compiute da Lenin e dei suoi scagnozzi, il socialismo non sarebbe perito con esso. Poiché se questo fosse accaduto, non sarebbe rimasto più nulla ad arginare la strada di un capitalismo che, spinto dalle proprie ineluttabili forze a condurre verso la fine della storia, avrebbe perpetuato per sempre l’attuale sistema politico ed economico, costruito allo scopo di mantenere i nove decimi dell’umanità nel ruolo di falegnami e portatori d’acqua per il restante, singolo, decimo.
30
LA MEMORIA DIFENSIVA DI ALDO MORO Marco Clementi
Un libro uscito di recente dedicato alle lettere di Moro dalla prigionia scritto da Miguel Gotor ha riaperto la discussione intorno all’originalità degli scritti del presidente democristiano durante i giorni in cui egli si trovò nelle mani delle Brigate rosse. La tesi di Gotor è che ci furono forti interventi da parte dei brigatisti, i quali leggevano gli scritti di Moro, quindi li emendavano e costringevano l’ostaggio a inserire le loro glosse. Ecco come Gotor ricostruisce la genesi delle lettere: la base di partenza era un manoscritto di Moro che veniva rapidamente battuto a macchina: da un lato per motivi di sicurezza affinché potesse circolare dattiloscritto non firmato e, dall’altro, allo scopo di essere più agevolmente leggibile dai suoi occhiuti supervisori rispetto a un originale manoscritto o a una sua fotocopia […]. I documenti di Moro hanno subìto una raffinata opera di manipolazione. Un lavorio che, con tutta la buona volontà, si ha difficoltà ad attribuire allo sforzo autonomo di uomini come Germano Maccari, Prospero Gallinari e Mario Moretti. Si tratta, infatti, di un esercizio che richiede l’occhio perfetto e allenato di un filologo o, semmai, l’orecchio assoluto di un compositore. In un caso come nell’altro, una diuturna abitudine alla visione di testi e codici, all’ascolto di note e partiture altrimenti dissonanti, da ricomporre in una nuova armonia prestabilita. Del resto certi mestieri – il filologo e il musicista – sono prima di tutto delle vocazioni1.
Secondo Gotor ogni singola missiva era costruita attraverso un meccanismo che avrebbe prodotto centinaia di fogli
1
M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, Einaudi, Torino 2008, pp. 298-300.
31
MARCO CLEMENTI
questi sì […] distrutti dai brigatisti via via che la lettera assumeva la forma definitiva. Solo a questo punto, se si riteneva che la missiva dovesse essere oggetto di una valutazione esterna al nucleo operativo romano, veniva dattiloscritta a partire dall’originale. In questo formato poteva uscire dalla prigione e poi, una volta discussa, se era approvata ma bisognava approntare dei cambiamenti, veniva riscritta da Moro, altrimenti si inoltrava nella versione originaria. Nel caso in cui il comitato esecutivo avesse deciso di non distribuirla, la lettera era accantonata2.
Nel sostenere questa sua tesi, Gotor rinuncia a porsi il problema logistico derivante da una simile e complessa procedura. Per i meccanismi di funzionamento delle Br, ogni testo uscito dalla prigione avrebbe dovuto essere portato da Mario Moretti di persona a Firenze, dove si riuniva l’Esecutivo dell’organizzazione, letto, emendato, ricondotto a Roma e fatto riscrivere a Moro. Non sono in grado di ipotizzare una media dei viaggi rispetto a quella delle pagine uscite dalla prigione (lettere e cosiddetto memoriale), ma non tenendo conto dei primi 13 giorni di sequestro nei quali Moro tacque e dunque sottraendoli dai 55, ne restano una quarantina (togliamone i due finali) nel corso dei quali Moretti avrebbe dovuto fare la tratta ferroviaria Roma-Firenze almeno una ventina di volte, ossia un giorno sì e uno no. A prescindere dalla difficoltà e dal rischio di un simile comportamento, che in quella temperie rasenta l’assurdo, se così fosse, si dovrebbe dire che il sequestro Moro fu solo ed esclusivamente incentrato sulle lettere e sugli altri scritti dell’ostaggio e che le Br rinunciarono, dopo 13 giorni, a giocare un qualsiasi ruolo diretto, nascondendosi dietro l’ombra delle parole del presidente democristiano. Ciò, però, è contraddetto dallo stesso Gotor, secondo il quale Moro scelse di comunicare sia perché minacciato, sia perché in tal modo nell’ipotesi peggiore avrebbe rinviato la propria morte, nella migliore avrebbe lasciato la possibilità alle forze di sicurezza di individuare la prigione e alle forze politiche di sviluppare la trattativa. Nel frattempo, egli avrebbe potuto capire meglio le esigenze e le debolezze di chi aveva davanti e approfittare della incontinenza comunicativa dei brigatisti per provare a stabilire un contatto con l’esterno, così da far filtrare messaggi e riferimenti che provassero ad aggirare la loro censura3. 2 3
Ivi, p. 301. Ivi, p. 203.
32
La memoria difensiva di Aldo Moro
Accanto a questo, ma soprattutto alle difficoltà logistiche di cui si è detto, esiste un altro problema che deve essere affrontato quando si parla di questi presunti emendamenti. La dimostrazione di quanto sostenuto da Gotor, infatti, non si basa su un’analisi filologica dei testi, ed è lo stesso autore a sostenerlo: Chi scrive ha troppo rispetto per il lavoro dei filologi ed è ben consapevole di non avere realizzato un’edizione critica di quei testi, ma piuttosto un paziente esercizio di trascrizione di documenti che hanno statuti e momenti di trasmissione guizzanti nel tempo, scivolosi come anguille4.
Purtroppo, questo approccio conduce Gotor ad immaginare una serie di congetture, che in alcune parti del libro diventano convinzioni, sia riguardanti la storia del sequestro, sia la sua esegesi da parte degli storici. Intanto, per restare alle lettere di Moro, afferma che il valore «ermeneutico» delle lettere dipende «soprattutto dai meccanismi censori messi in atto dai brigatisti e dalla loro strategia di recapito, che fu parte integrante – troppo spesso sottovalutata – della loro azione terroristica»5. È giusto chiedersi se sia stata davvero sottovalutata. È stato ripetutamente scritto che i brigatisti, logicamente, recapitarono le lettere che ritenevano congrue alla propria strategia e che, dunque, lo stesso Moro non poteva essere certo che il suo di-
4
Ivi, p. XVIII. Ivi, p. XXI. Non mi voglio dilungare in questa sede nella divisione, a mio giudizio arbitraria, che Gotor opera tra quelli che chiama «i dietrologi» e «gli spiegazionisti a oltranza» (p. XVII). Mi sembra un approccio troppo liquidatorio; del resto, curiosamente – almeno a mio giudizio – egli afferma che «sarebbe sbagliato pensare che sposare una tesi precostituita sin dal titolo […] o scrivere a ridosso degli avvenimenti animati da ragioni politiche o affettive siano di per sé elementi che inficiano il rigore dell’analisi storica: anzi, la volontà di difendere a oltranza i propri assunti di partenza obbliga a notevoli sforzi euristici e documentari e, dal confronto dalle opposte tendenze, ciò che resiste alla furia demolitoria di entrambi i fronti, l’un contro l’altro armati, si può trasformare in un prezioso elemento di valutazione per lo studioso di storia» (ivi, p. XIV). Per quanto mi riguarda, credo proprio che sia vero l’esatto contrario, ossia che il fare storia non dovrebbe significare lottare per affermare una tesi precostituita, ma, semmai, la sua ricerca. 5
33
MARCO CLEMENTI
scorso con il mondo libero non fosse mediato6. La censura, dunque, ci fu certamente nella consegna, ma ciò non significa che essa fu applicata al contenuto delle lettere o del memoriale (la memoria difensiva di Moro), al punto da modificarli. Ma c’è dell’altro. Gotor afferma con sicurezza che i brigatisti minacciarono di morte i familiari di Moro: Come vedremo […] è altamente probabile che la scelta di Moro di interloquire con i sequestratori fosse stata condizionata da reiterate minacce di morte rivolte contro la sua persona e contro i familiari, dal momento che i brigatisti avevano bisogno della sua parola per realizzare il loro piano terroristico7.
Si tratta di un’ipotesi ardita. Le Br, certamente quelle cosiddette morettiane8, non minacciarono mai alcun familiare di una loro vittima, né è possibile dimostrare che lo fecero con quelli di Moro perché non disponiamo d’alcun riferimento diretto o indiretto, scaturito da dichiarazioni o da indagini, per il quale i familiari di Moro fossero controllati dai brigatisti (cosa necessaria per portare a termine una minaccia). Non conosciamo neanche il nome dell’eventuale vittima, né esiste alcun riferimento di Moro nelle sue lettere ad una tale circostanza. Il libro di Gotor tenta di inquadrare storicamente il fenomeno del brigatismo, e lo fa citando il cinema. È però difficile capire quanto il cinema ci possa venire in aiuto per ricostruire la storia delle Br e, in particolare, quanto possa fare in questo senso il regista Marco Bellocchio, di cui si citano due film lontani nel tempo, sebbene simili per ambientazione: I pugni in tasca del 1965 e il recente Buongiorno, notte. In base a quale motivo la generazione della lotta armata sia dovuta nascere «dall’impotente e rabbiosa claustrofobia familiare dei Pugni in tasca», resta un mistero, visto che la lotta armata fu condotta principalmente da proletari, mentre i protagonisti del film appartengono
6
La bibliografia in proposito è molto vasta e non starò qui a citarla. Per estrema semplicità rimando alla bibliografia pubblicata in calce alla terza edizione del mio volume La pazzia di Aldo Moro, Bur, Milano 2008. Nell’ultimo anno sono stati pubblicati nuovi, interessanti e in qualche caso innovativi contributi, per i quali invito il lettore a consultare i siti www.vuotoaperdere.org e www.brigaterosse.org. 7 M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., pp. 202-203. 8 Per la storia delle Br si veda anche M. CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse, Odradek, Roma 2007.
34
La memoria difensiva di Aldo Moro
a una famiglia dell’alta borghesia italiana (e lo ripeto, siamo nel 1965)9. Il problema, però, è proprio sull’interpretazione del ruolo dei brigatisti, prima, durante e dopo il sequestro Moro, perché qui sorgono nuove rigidità. Gotor, per esempio, sostiene che «pensare di ricostruire» la storia del rapimento «utilizzando esclusivamente [sda] le testimonianze successive» dei brigatisti «è un’illusione che rischia di essere fuorviante», cosa che, però, non mi pare sia stata sostenuta in passato da qualcuno. Aggiunge anche che «nel caso specifico si tratta prevalentemente di fonti giudiziarie in cui gli imputati hanno la facoltà di scegliere il silenzio o addirittura di mentire pur di non danneggiare il proprio diritto alla difesa»10. A chi si riferisce Gotor, a un imputato in generale, oppure ai brigatisti? E, se vuole indicare i brigatisti, chi di questi, in particolare? I pentiti, i dissociati o i cosiddetti “irriducibili”? In un simile contesto sarebbe stato non di secondo piano ricordare che le Br rinunciarono, come organizzazione, a difendersi. I militanti catturati rivendicarono le proprie azioni, anche durante i processi, e si dichiararono praticamente corresponsabili di ogni attentato, confessando dunque delle responsabilità collettive. Su questa base furono condannati in moltissimi, ché se si fossero difesi individualmente (e in un caso è accaduto), la storia giudiziaria del brigatismo italiano sarebbe andata in modo ben diverso. In secondo luogo, le confessioni dei pentiti e quelle dei dissociati sono state qualitativamente differenti: i pentiti hanno offerto riscontri importanti per le indagini in corso, permettendo l’arresto di moltissimi brigatisti. I dissociati hanno raccontato la propria verità personale, quella riguardante la propria esperienza di militanza, e lo hanno fatto ex post, a volte molti anni dopo la conclusione del primo processo. Usufruen-
9
M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. XV. Per quanto riguarda l’origine sociale dei brigatisti, compresi quella della colonna meno “ortodossa” da questo punto di vista, ossia la genovese, si consiglia la lettura di La mappa perduta, II, a cura di Maria Pia Prette, Sensibili alle foglie, Roma 2006, e, sempre per la cura della Prette, Gli sguardi ritrovati, Sensibili alle foglie, Roma 1995. Poco conosciuto, ma utile, è il saggio di Giuseppe NICOLO, Le Br nel Biellese. Gli anni di piombo nella testimonianza di un dirigente comunista, «L’Impegno», XI, 1 (1991). Cfr. anche il volume di Giovanni BIANCONI, Mi dichiaro prigioniero politico. Storie delle Brigate Rosse, Einaudi, Torino 2003. 10 M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. XXII.
35
MARCO CLEMENTI
do delle leggi ad hoc, si sono visti ridurre la pena, ma non hanno certo cambiato con le proprie confessioni la percezione che si aveva del brigatismo. È chiaro, però, che muovendosi su questo terreno ci si possa spingere molto oltre, come ha fatto ancora Gotor il 9 maggio del 2008 in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi11. Nell’appassionato articolo scritto per l’occasione, egli chiede sostanzialmente agli ex Br di smetterla di esternare le proprie passioni e di entrare in una «dimensione privata della riflessione che esuli da un nuovo protagonismo pubblico, tanto ricercato e così esibito», perché «bisogna saper distinguere la reintegrazione dal pulpito». A quanto risulta a chi scrive, i pochi ex-Br che hanno partecipato in modo attivo alla memorialistica appartengono nella propria maggioranza alla schiera dei cosiddetti pentiti o dei dissociati. Come già detto, con le loro rivelazioni hanno aiutato in modo sostanziale gli inquirenti prima, i giudici poi, e per questo lo Stato italiano ha riconosciuto loro degli sconti di pena. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, quelle rare volte, come nel caso di Mario Moretti, sono accusati di essere reticenti su varie questioni, come ha fatto lo stesso Gotor!12. Tornando al volume di Gotor, in esso si suppongono altre cose riguardanti i 55 giorni, come l’esistenza di un canale di ritorno e la possibilità che Moro abbia fornito ai brigatisti del materiale riservato proveniente dal proprio archivio attraverso questo canale, ma anche qui ci troviamo di fronte a congetture. Nel fare ciò, si ipotizza un grave reato, che avrebbe compiuto Moro: […] non è inverosimile che Moro, dopo i primi giorni di prigionia, ripresosi dallo shock, possa aver proposto ai brigatisti una trattativa privata, offrendo in cambio della sua liberazione alcuni documenti riservati che avrebbe potuto accumulare nel corso della sua lunga carriera istituzionale e conservare in luoghi solo a lui conosciuti13.
11
«La Stampa», 9 maggio 2008. Gotor scrive a proposito di Moretti e Gallinari, che «come ad esempio fece Moretti davanti al giudice il 30 ottobre 1990, hanno scelto la strada di un’arrogante reticenza, suscitando la perplessità e i sospetti degli stessi compagni d’avventura di un tempo»; M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. 253. 13 Ivi, p. 218. 12
36
La memoria difensiva di Aldo Moro
Ebbene, è lecito appropriarsi di documenti riservati e conservarli in luoghi segreti, anche in presenza di una lunga carriera istituzionale alle spalle? Ovviamente, non lo sarebbe, a prescindere dalla lunghezza dell’impegno personale nello Stato (e crediamo che Moro non l’abbia fatto); questo particolare, però, non è messo nella giusta evidenza, così come si cita in modo non del tutto proprio Pier Paolo Pasolini (e sarebbe ora che questo luogo comune venisse superato), il quale scrisse certamente che Moro era il «meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 a oggi»14, ma lo fece in un contesto per nulla edificante per il leader democristiano. La frase esatta, infatti, è la seguente: Nella fase di transizione gli uomini di potere democristiani hanno quasi bruscamente cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio completamente nuovo (del resto incomprensibile come il latino): specialmente Aldo Moro: cioè (per una enigmatica correlazione) colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 ad oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di conservare comunque il potere15.
Con lungimiranza, Gotor pone nel suo libro una questione non secondaria, come quella delle fonti e del loro uso, e ultimamente lo stesso autore è tornato sulla questione con un articolo intitolato Il paese delle carte segrete16, dove si lamenta della loro mancanza, sostenendo che per quanto concerne lo studio di temi come il terrorismo e lo stragismo o di personalità come Moro, la strada per i ricercatori si trasforma spesso in un percorso a ostacoli, ricoperto da uno stratificato pulviscolo di diffidenza, ostruzionismo e opacità dei comportamenti, che rende il loro cammino ancora più arduo.
Come ricorda Gotor, presso l’Archivio centrale dello Stato è conservato l’archivio personale di Moro dal 1953 al 1978, ma «per un motivo insondabile questi documenti non sono trattati come gli altri e, ad 14
Ivi, p. 205. P.P. PASOLINI, Il vuoto del potere in Italia, «Corriere della Sera», 1º febbraio 1975 (ristampato in P.P. PASOLINI, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975, p. 163). 16 «La Stampa», 17 novembre 2008. 15
37
MARCO CLEMENTI
esempio, non si trova[no] nella sala di studio ove dovrebbe[ro] essere». Ricorda altresì Gotor, che le carte di Moro sono state digitalizzate e rese disponibili on-line, ma secondo lui «ciò ha prodotto un imprevisto effetto distorcente giacché gli studiosi non possono lavorare sugli originali, ma si devono accontentare dello schermo di un computer». La rimostranza non è molto condivisibile. Da tempo, infatti, l’intero archivio di Moro è consultabile on-line e se un archivio è disponibile online, è assolutamente normale che non venga dato in consultazione cartacea17. Per ciò che, invece, concerne i documenti delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, conservati presso l’Archivio storico del Senato, anche questi sono disponibili on-line, a parte alcuni faldoni ancora riservati. Se questa è la realtà, ossia che la maggior parte delle carte è consultabile, perché «una simile situazione induce gli studiosi a nutrire aspettative immotivate e contribuisce ad alimentare la dietrologia e il qualunquismo»? Polemiche simili instillano il sospetto proprio in un tema, quello delle stragi e delle carte di Moro, dove il lavoro di validissimi archivisti (il riferimento è per esempio a quelli del Senato), ha dato risultati notevoli. Certo, la situazione degli archivi italiani non è più rosea di quella di altri paesi, come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, ma non è possibile affermare che il nostro paese si trovi molto indietro. Sarebbe, certamente, auspicabile avere a disposizione l’archivio dell’Arma dei Carabinieri, o maggiore possibilità di consultare quello dello Stato Maggiore dell’Esercito, purtroppo condizionato dalla mancanza di personale, ma questo è davvero un altro discorso. Quello che allora lo storico si chiede, è come mai ci si trovi di fronte a tutta questa serie di interventi, i quali, invece di chiarire, rischiano di contribuire a reiterare un velo di Maya su quella che è una vicenda in Italia tra le più studiate, indagate e lette, per la quale sono stati svolti sei processi, arrestati o comunque individuati con certezza tutti i protagonisti e che ha goduto anche del lavoro di due Commissioni parlamentari, una delle quali rinnovata per alcune legislature. Ma, viste le polemiche alle quali non si è sottratto neanche l’autore di questo articolo, è lecito chiedersi che senso abbia parlare oggi 17
Riguardo alle carte di Moro conservare presso l’Archivio centrale dello Stato si veda anche A. CUSTODERO, Aldo Moro. Gli archivi segreti del ministro, «la Repubblica», 9 agosto 2008.
38
La memoria difensiva di Aldo Moro
ancora della vicenda del sequestro di Aldo Moro e della sua uccisione, rischiando con ciò di reiterare – e questo è un punto messo bene in rilievo da Gotor – l’oblio nel quale sembra essere stata posta la figura di Moro politico? Perché, e qui Gotor ha ragione da vendere, manca uno studio monografico su Aldo Moro, anche se qualche tentativo, sebbene parziale, sia stato fatto anche da chi si è occupato principalmente del sequestro. Spiace non vederlo citato. Per ora, si possono segnalare almeno un paio di libri come quelli di Corrado Guerzoni e Giovanni Galloni, dedicati proprio alla figura del leader democristiano18. Siamo ancora lontani dal saggio di uno storico, ma qualcosa si sta muovendo, come testimoniano alcuni convegni svoltisi in anni sia recenti, sia più remoti, in alcune università italiane (La Luiss di Roma e la Statale del Salento, per esempio), nel corso dei quali si è cercato di ricostruire il pensiero politico e la figura di statista di Aldo Moro19. Per rispondere positivamente alla domanda che ci si è appena posti, ossia se sia ancora utile studiare il sequestro Moro, si può affermare che alcuni momenti di quei giorni appaiono ancora compresi parzialmente. Tra questi, a parere di chi scrive, si trovano tutti quegli scritti dell’ostaggio che furono composti su sollecitazione dei brigatisti e che hanno assunto il nome improprio di memoriale. Più giusto, come ho già avuto modo di scrivere in passato, sarebbe stato chiamarli, tutti insieme, memoria difensiva, perché proprio di questo si tratta. Moro era in un «carcere del popolo» ed era «sottoposto a un processo proletario». Aveva la facoltà di difendersi, e lo fece con quegli scritti. Il memoriale, infatti, è proprio uno scritto che ha uno scopo preciso, ossia difendere un imputato dalle accuse di un “pubblico ministero” e si tratta, dunque, non di un memoriale sulla storia italiana o sull’operato di Moro in generale, ma di una lunga memoria difensiva che contiene, se letto in modo dialettico, le risposte alle accuse briga-
18
C. GUERZONI, Aldo Moro, Sellerio, Palermo 2008; G. GALLONI, 30 anni con Moro, Editori Riuniti, Roma 2008. 19 Si tratta del Convegno organizzato dall’Università del Salento “Aldo Moro e le relazioni internazionali dell’Italia”, 12-13 giugno 2008, nell’ambito degli studi “Aldo Moro nell’Italia Contemporanea”, conclusisi alla Luiss di Roma il 4-5 dicembre 2008. Si vedano anche gli eventi organizzati dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, reperibili in http://www.accademiaaldomoro.org/bollettino/pdf/Nota1995-2000.pdf.
39
MARCO CLEMENTI
tiste, basate sui punti principali di quella che era la loro visione del mondo. Una buona parte delle domande che le Br fecero a Moro, infatti, riguardò lo Stato imperialista delle multinazionali (Sim, una sorta di ristrutturazione capitalistica guidata a livello globale da una cupola di stati imperialisti), così com’era stato immaginato dalle Br sulla base delle proprie analisi. Moro, che mal si adattava a questa teoria, pur seguendo la traccia delle domande di Moretti sul Sim, se ne allontanò costantemente, in quanto doveva giustificare un trentennio di scelte politiche, dando necessariamente un’interpretazione differente di quegli elementi che i brigatisti leggevano come i chiari sintomi della presenza del Sim nella penisola. Ai brigatisti interessava poco la polemica spiccia del palazzo. Essi credevano che Moro fosse uno dei referenti principali del Sim in Italia e volevano ricevere tutte le informazioni in grado di giustificare la teoria e, in particolare: chi finanziasse e come la Dc, quali fossero i rapporti del partito con gli Stati Uniti, quale fosse il ruolo della grande stampa nel progetto di ristrutturazione capitalista, quello del Fondo monetario internazionale, l’apporto di singole personalità democristiane come Giulio Andreotti, Amintore Fanfani e Francesco Cossiga, quello del grande capitale e in particolare della famiglia Agnelli. Volevano anche sapere se esisteva un coordinamento antiguerriglia della Nato e, in caso positivo, da chi era diretto e quali paesi coinvolgeva. Per quanto riguardava il finanziamento dei partiti (che poi avrebbe svolto un ruolo così importante per la storia italiana più recente) le Br ritenevano assodato che il governo statunitense finanziasse direttamente la ristrutturazione in Italia, e dunque la Dc, che di questa politica doveva essere l’interprete principale. Di tutto questo era chiamato a rispondere Moro, ed è su questo che Moro impostò la propria difesa. Nella quale, però, parlò ovviamente solo di ciò che conosceva, e dunque non del Sim. Quello offerto da Moro nelle sue risposte fu un quadro abbastanza deprimente della politica italiana, che venne in parte scoperto solo all’inizio degli anni Novanta durante l’inchiesta “Mani pulite” e che le Br avevano già rivelato, in sintesi e con il loro linguaggio rigido, attraverso il comunicato numero 6: Certo, l’interrogatorio ad Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime, […] ha messo a nudo gli intrighi di potere, […] ha indicato l’intreccio degli interessi personali, delle corruzioni, delle clientele
40
La memoria difensiva di Aldo Moro
che lega in modo indissolubile i vari personaggi della putrida cosca democristiana e questi, […] agli altri dei partiti loro complici20.
Se la teoria del Sim serviva a spiegare la ristrutturazione capitalistica a livello mondiale, per quanto riguardava l’Italia le Br pensavano che fosse funzionale al progetto di trasformare il paese in una repubblica presidenziale per rafforzare l’esecutivo e svuotare contestualmente il parlamento delle proprie funzioni. Era il progetto neogollista, di cui si era cominciato a parlare ai tempi del rapimento del magistrato Mario Sossi, nel 1974. Moro, però, contraddisse questa ipotesi: Posso dire intanto quello che non vedo accadere: la fine del bicameralismo, il sistema dei partiti, le regioni, le province e i comuni. Vedo i sindacati accrescere enormemente il loro peso e prendere quota, con una nuova presenza dei lavoratori, al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro. Le regioni, come mostra la legge sulla riconversione, entreranno sempre più nella gestione dell’economia con particolare riguardo all’occupazione. Ed infine, per quanto qualche anno fa se ne sia molto parlato, non vedo trasformarsi l’elezione del Presidente della Repubblica in elezione popolare e con l’acquisizione dei poteri che sono propri del sistema presidenziale americano o anche francese21.
Secondo Moro, non esisteva alcun piano di trasformazione della Repubblica italiana, ma si trattava, casomai, di semplice evoluzione politica, lenta e non sempre prevedibile. Anzi, per quanto concerneva le istituzioni, Moro affermò non esserci proprio alcun progetto di 20
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (d’ora in avanti CpM), vol. XXX (1988), pp. 733-734; per un’edizione a stampa si veda Dossier Brigate rosse 1976-1978, a cura di L. Ruggiero, Kaos, Milano 2007, pp. 315-316. 21 Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (d’ora in avanti CpS), X Legislatura, doc. XXIII, n. 26 (1991), Relazione sulla documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990, in via Monte Nevoso, a Milano, II, memoriale, numerazione tematica 9, pp. 165-167. Per l’edizione a stampa del memoriale si veda Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano, a cura di F.M. Biscione, Coletti, Roma 1993; un’altra edizione si trova in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Brigate rosse, Kaos, Milano 1997, pp. 205-328.
41
MARCO CLEMENTI
riforma «ma, almeno per ora, […] di rinnovamento di classe dirigente. Su questo si mette l’accento ed è anche in questo senso, io credo, il consiglio straniero». La direttiva, insisteva l’ostaggio, era di «mettere fuori uomini vecchi e inutili, anche se possono avere delle benemerenze, e mandare avanti uomini nuovi. Circa due terzi dei gruppi parlamentari della Dc sono stati rinnovati»22. Per quanto riguarda la fin troppo enfatizzata, e presunta rivelazione su Stay Behind, o Gladio, contenuta nella memoria difensiva, si può affermare che il documento sia al proposito tutt’altro che chiaro, anche perché la domanda dei brigatisti riguardava una cosa differente. A loro, infatti, non interessava sapere se la Nato avesse potuto o meno resistere a un’invasione straniera (la funzione di Stay Behind era questa), ma se a livello intergovernativo fosse stata predisposta una struttura antiguerriglia europea in grado di combattere la lotta armata. Su questo punto Moro rispose negativamente, ma affermò che esisteva un piano di guerriglia contro eventuali forze avversarie occupanti23. Le Br, probabilmente, avevano cominciato a pensare con una certa insistenza a una possibile azione antiguerriglia coordinata dalla Nato dopo che nel 1977 la Rote Armee Fraktion aveva rapito il capo degli industriali tedeschi Hanns-Martin Schleyer, che sarebbe poi stato ucciso. I reparti speciali tedeschi, agendo in accordo con quelli inglesi, avevano dato l’assalto a Mogadiscio a un commando palestinese che aveva dirottato un aereo della Lufthansa con la speranza di liberare i militanti della Raf in carcere, in coordinamento con il sequestro di Schleyer. Un’azione antiguerriglia operata in un paese terzo da tedeschi e inglesi insieme poteva ben far supporre l’esistenza di una struttura intergovernativa. Diventano più credibili le parole di Moretti, quando afferma di non essersi reso conto dell’importanza di certe argomentazioni di Moro, proprio perché stava cercando qualcosa di diverso da Gladio: un’organizzazione europea antiguerriglia in grado di coordinare su scala internazionale la lotta alle Br e agli altri gruppi della lotta armata, e non un protocollo per la guerriglia partigiana contro l’invasore. Il 27 gennaio 1978, inoltre, era stata firmata a Strasburgo una Convenzione europea per la prevenzione del terrorismo che andava ad affiancare, modernizzandola, la Convenzione per
22 23
CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 10, pp. 297-303. CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 14, pp. 161-164.
42
La memoria difensiva di Aldo Moro
la prevenzione e la repressione del terrorismo adottata a Ginevra dalla Società delle Nazioni il 16 novembre 1937. Fatto caratterizzante la Convenzione del 1978 era la derubricazione di un reato politico a reato comune, se tale fosse stato particolarmente grave (pirateria, attentato alla vita, all’incolumità o alla libertà dei diplomatici, uso di razzi, esplosivi contro persone) al fine di aprire la strada all’istituto dell’estradizione, fino ad allora particolarmente difficile. Si deve però aggiungere che la stessa Convenzione non fu firmata da Irlanda e Malta, non fu ratificata da Belgio, Francia e Grecia, mentre nove dei paesi firmatari (Cipro, Danimarca, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Svizzera), avrebbero posto la riserva cosiddetta dell’ex art. 13, per il quale uno Stato contraente poteva rifiutare l’estradizione anche in casi obbligatori, qualora avesse stimato per politici i reati per i quali la si chiedeva24. Sempre nel contesto del supposto progetto neogollista, le Br chiesero informazioni sulla stampa che, a dire di Moro, costituiva «un enorme problema sia per quanto riguarda il suo ordinamento e sviluppo, sia per quanto riguarda la sua indipendenza». Difatti, la «gestione giornalistica è talmente costosa da essere proibitiva», al punto che la Dc, in quella de «Il Mattino» e de «Il Gazzettino Veneto», doveva fare ricorso all’aiuto di un «abile giocatore» che «dominerà fino al limite del possibile» (l’editore Rizzoli). Pochi erano secondo Moro i giornali «seri», come si deduce dalla seguente riflessione, con riferimento alla vicenda del suo sequestro: Questi giorni hanno dimostrato come sia facile chiudere il mercato delle opinioni. Non solo non troverai opinioni, ma neppure notizie. Forse è questo un aspetto particolare di una crisi economica, che non può non essere anche una crisi editoriale. Infatti su 20-25 giornali seri è difficile bloccare; su 5 o 6 sì.
Moro parlò delle proprietà dei giornali come di normali operazioni finanziare in un ambito strettamente locale, mentre mancano riferimenti a interventi esterni in grado di regolare la proprietà editoriale25.
24
Cfr. M.R. MARCHETTI, Istituzioni europee e lotta al terrorismo, Cedam, Padova 1986. 25 CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 16, pp. 154-155.
43
MARCO CLEMENTI
Nemmeno le parole di Moro sul sistema bancario potevano soddisfare le attese dei brigatisti. L’ostaggio descrisse un settore caotico e lottizzato dai partiti, nel contesto del quale il Pci aveva chiesto «una discussione parlamentare in comitato ristretto», che Moro riteneva sensata. Si tratta di un settore che rientrava nella spartizione del potere, la quale avveniva «non sempre tra i partiti, spesso nell’ambito dello stesso partito». L’unica banca ad avere importanti contatti internazionali era la Banca d’Italia, che operava «al massimo delle sue possibilità, con uno scrupolo e con un’obiettività che sono da tutti riconosciuti. È chiaro, però, che essa fa solo quello che può fare»26. Insomma, anche qui emergeva nuova corruzione, ma non c’era nessun riferimento al Sim e al suo corollario neogollista italiano. Le risposte inerenti il Fondo monetario internazionale, del resto, costituivano una nuova conferma delle falle della teoria brigatista della ristrutturazione, evidentemente troppo meccanicistica e semplicistica per un mondo che cominciava allora a strutturarsi in modo più complesso rispetto al passato. Il prestito di cui aveva beneficiato il governo italiano nel 1977 e che, osserva Moro, aveva ovviamente ragioni politiche, infatti, era stato negoziato con gli Stati Uniti nel contesto della nuova politica italiana, nella quale sarebbe mutato il ruolo dei comunisti. Per questo gli uomini di governo democristiani attribuivano un grande significato morale a quel prestito. Gli statunitensi cedettero durante la visita di Andreotti a Washington nel dicembre 1976; i comunisti potevano collaborare al governo e contribuire alla cura del paese, ma senza assumere dirette responsabilità; concedendo il prestito «in sostanza si dava un avallo a quello che c’era già, ma implicitamente si chiedeva la garanzia che non si andasse in là verso la collaborazione di governo»27. Per quanto riguarda gli ambasciatori statunitensi conosciuti da Moro, Graham Martin, John Volpe e Richard Gardner, le parole dell’ostaggio, invece, qualcosa produssero. Confermarono che, secondo quelle che erano le convinzioni dei brigatisti, gli statunitensi, dalla gestione di Henry Kissinger in poi, pur appoggiando la Dc ne auspicavano il rinnovamento affinché divenisse un partito più giovane, moderno e tecnicamente in 26
CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 13, pp. 141-145. CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 5, pp. 396-397. La versione di Moro concorda sostanzialmente con quanto raccontato da Andreotti, all’epoca del prestito presidente del Consiglio, in G. ANDREOTTI, Governare con la crisi. Dal 1944 a oggi, Rizzoli, Milano 1991, pp. 236-238. 27
44
La memoria difensiva di Aldo Moro
corsa con i tempi. Per iniziativa del Dipartimento di Stato americano, affermò Moro, si era registrato un cambiamento di rapporto che «prefigurava un’Italia tecnocratica, che tra l’altro parla l’inglese, più omogenea ad un mondo più sofisticato e, per così dire, più internazionale che si era andato profilando»28. Si tratta dei primi passi del fenomeno che oggi chiamiamo globalizzazione, colto all’epoca tanto dalle Br, quanto dallo stesso Moro, che a differenza dei suoi rapitori ne aveva ben chiara la prospettiva, come ribadì in un successivo passo della memoria difensiva: Di fronte a molteplici richieste circa gli assetti economico sociali dell’Europa di domani, ed in essa dell’Italia, devo dire onestamente che quello che si ha di mira è il rinvigorimento, su base tecnocratica, del modo di produzione capitalistico, ovviamente temperato dalle moderne tecniche razionalizzatrici e con l’opportuna coesistenza di piccole e medie imprese e di botteghe artigianali29.
In tale contesto, l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger è indicato quale l’uomo più ostile all’idea di un rafforzamento dell’unità europea. Moro conferma che in talune occasioni l’Europa si dovette adeguare ai desiderata statunitensi, al punto che un progetto di Carta europea adatto ad avviare una certa politica di autonomia fu dapprima ritirato, quindi sostituito da una nuova Carta atlantica, sancita ad Ottawa. «Cadde così», commenta lo statista, «l’unico tentativo che fu fatto con un certo impegno da parte europea, per rivendicare la propria identità ed autonomia […]». D’altro canto, proseguiva, l’Europa sarebbe stata sempre fortemente legata agli Usa, a prescindere dai governi correnti, che potevano essere laburisti o conservatori in Gran Bretagna, socialdemocratici o democristiani in Germania; anzi, aggiunse, a volte le sinistre si sarebbero dimostrate più pronte nell’accogliere un’ideologia produttivistica e tecnocratica, che Moro sintetizzò con l’espressione mitteleuropea. Tale indirizzo politico, concluse, sarebbe stato coltivato da organizzazioni paragovernative, come la Trilateral, famigerata per le Br e tante volte citata nei loro documenti, che Moro, però, precisò di non aver mai frequentato30. Egli spiegò anche i
28
CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 8, pp. 289-293. CpM, vol. II (1983), memoriale, pp. 135, 137-141; CpS, II, memoriale, cit., pp. 210-233. 30 CpS, II, memoriale, cit., pp. 210-233. 29
45
MARCO CLEMENTI
motivi dell’ostilità che Kissinger gli dimostrò nel 1974 durante una visita negli Stati Uniti (visita spesso citata dagli studiosi alla ricerca di un qualche coinvolgimento statunitense nel suo sequestro), riferendosi alla quarta guerra arabo-israeliana dell’ottobre 1973 e alla posizione assunta in quel momento dall’Italia: Ma il punto, serio, di conflitto con gli americani e con il sig. Kissinger era la vincolabilità della crisi con i moduli politico militari della Nato e l’uso dei nostri punti di approdo di atterraggio per rifornimenti americani alla parte israeliana.
L’Italia non giudicò il conflitto tra israeliani e siriani come qualcosa che riguardasse la Nato e rifiutò di dare il proprio consenso all’uso delle basi aeree. Per questo e per la politica italiana di dialogo con i paesi arabi, Kissinger coltivò un’animosità per la parte italiana e per la mia persona, che venne qualificata, come mi fu chiarito in sede obiettiva e come risultò da episodi certamente opinabili, come protesa ad una intesa indiscriminata con il Pci, mentre la mia, com’è noto, è una meditata e misurata valutazione politica […]31.
Si tratta di un passaggio importante, in quanto a dire di Moro, la posizione ostile di Kissinger era stata dettata in prima misura dal rifiuto italiano di concedere agli israeliani l’uso delle basi militari Nato; l’apertura verso il Pci, invece, appare come un elemento secondario dello scontro. Il nome del maggiore capitalista italiano, Gianni Agnelli, era entrato diverse volte nei volantini brigatisti; essi chiesero a Moro notizie sulle strategie politiche dell’avvocato, degli altri membri della famiglia torinese e più in generale della Confindustria. Moro spiegò con ordi31
CpM, memoriale, pp. 166-168; CpS, II, memoriale, cit., pp. 238-243. La lettura del secondo volume di memorie di Henry KISSINGER, Years of Upheaval, LittleBrown, Boston 1982 (tr. it. Anni di crisi, SugarCo, Milano 1982) non offre spunti tali da confermare i ripetuti sospetti verso il Premio Nobel per la pace del 1973; in passato, infatti, qualcuno lo ha ritenuto l’occulto ispiratore del delitto Moro. La politica estera statunitense verso l’Europa, però, appare molto più complessa di quanto lascerebbe pensare l’idea di un complotto così didascalico, come appare chiaro anche dalla lettura del lungo volume.
46
La memoria difensiva di Aldo Moro
ne le posizioni di Gianni Agnelli, dapprima vicino ai repubblicani, della sorella Susanna, entrata nel gruppo parlamentare di quel partito, e del fratello Umberto, divenuto senatore democristiano, sebbene non tutto il partito fosse unito intorno a quella candidatura. Gli Agnelli, come la Confindustria, premevano per un rinnovamento politico nel senso dell’europeismo, dell’efficientismo, del laicismo, della tecnocrazia. Anche questi sono elementi che entreranno nella futura globalizzazione; le Br li avevano dunque individuati, ma inseriti in un contesto non del tutto aderente alla realtà italiana32. Tre argomenti trattati nella memoria difensiva rivestono una certa importanza per la storia della penisola negli anni del secondo dopoguerra e riguardano il cosiddetto Piano Solo, la strategia della tensione e lo scandalo Lockheed, sul quale, però, l’ostaggio praticamente glissò, ribadendo tesi già esposte pubblicamente prima del rapimento. Per quanto riguarda il tentativo di colpo di Stato del 1964 (il cosiddetto Piano Solo) Moro offrì una ricostruzione particolareggiata, tirandosi fuori dalle responsabilità, che attribuì in particolare all’allora presidente della Repubblica, Antonio Segni, contrario alla politica di apertura ai socialisti condotta da Moro. Il piano, che prevedeva, in caso di emergenza, la deportazione in Sardegna di circa 700 persone di diverse aree politiche e l’instaurazione di un sistema più autoritario, sarebbe stato predisposto «su disposizione del Capo dello Stato», mentre la figura di Giovanni De Lorenzo, «un servitore dello Stato», fu rivalutata dal presidente democristiano. Il generale, infatti, era stato molto utile con alcune intercettazioni telefoniche fattegli pervenire quando egli era segretario della Dc, ma senza incarichi di governo, che contribuirono alle dimissioni di Fernando Tambroni da presidente del Consiglio. Qui si intrecciano, dunque, due vicende, quella del 1964 e una del 1960, quando si parlò di un altro tentativo di golpe. Il 20 giugno del 1960 il giornalista de «La Stampa» Vittorio Gorresio aveva attribuito proprio a Tambroni un progetto di colpo di Stato, rivelando anche il regime di sorveglianza a cui sarebbe stato sottoposto l’allora presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Il progetto eversivo fu divulgato con il nome di Operazione Ippocampo e prevedeva una serie di attacchi di piazza contro i manifestanti allo scopo di mutare la natura del regime italiano, da democratico ad autoritario. Si trattava di una strategia della tensione ante litteram, meno sofisticata dei suc32
CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 11, pp. 304-307.
47
MARCO CLEMENTI
cessivi sviluppi, e che presentava anche alcuni elementi di somiglianza con il Piano Solo. Il governo Tambroni rappresentò un rischio di involuzione autoritaria e fu latore di gravi provocazioni nei confronti delle forze progressiste ma, come affermò Moro, venne combattuto dall’interno della maggioranza attraverso delle intercettazioni e altri elementi informativi ottenuti in vario modo. Con questa dichiarazione, è evidente, Moro tese a mostrarsi come uno di coloro che avevano agito in passato nel senso della conservazione del regime democratico in Italia33. Per quanto riguarda la strategia della tensione più propriamente detta, essa costituì una delle principali accuse rivolte contro il prigioniero, ma anche in questo caso Moro usò la stessa tattica del punto precedente, tendendo a minimizzare il proprio ruolo e la propria capacità di approfondire la questione: Non si tratta purtroppo, come ho detto, di una verità secca e precisa, anche per le ragioni che mi appresto a sviluppare brevemente e che dimostrano inconfutabilmente come in quel periodo, ben lungi dal godere la fiducia e il rispetto di tutti, ero costantemente in polemica con il Partito. In realtà la mia immagine di Capo incontrastato della Dc è stata costruita dalla stampa con la ben nota faciloneria (per non dire altro) ed ha solo un’apparenza di verità […]34.
Rivendicò, come nel caso del governo Tambroni, un ruolo positivo da ministro degli Esteri, quando assieme al Sid, che a suo giudizio si comportò bene, furono mantenuti proficui contatti con diversi movimenti di 33
Tambroni aveva formato un governo monocolore democristiano nella primavera del 1960. La fiducia era stata accordata dal Parlamento grazie al voto determinante di 24 missini e 4 indipendenti di destra, cosa che per la prima volta reinseriva i missini nell’ambito della cosiddetta area costituzionale. Dopo mesi di proteste e di sanguinosi scontri di piazza tra manifestanti antifascisti e forze dell’ordine, che provocarono tra l’altro i cinque morti di Reggio Emilia (7 luglio), il 19 luglio Tambroni presentò le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. A dire di Aldo Moro, però, alla base della decisione ci sarebbero state le intercettazioni in possesso dello stesso Moro, fornitegli da De Lorenzo. Per quanto riguarda De Lorenzo, egli fu promosso generale di corpo d’armata il 2 febbraio 1961; nel 1968, lasciata la carriera militare, venne eletto deputato nelle file del Partito democratico italiano di unità monarchica. 34 CpS, II, memoriale, cit., pp. 329-346.
48
La memoria difensiva di Aldo Moro
liberazione nazionale (il riferimento era ai palestinesi), cosa che poteva essere positivamente giudicata dalle Br. Moro affermò che la strategia della tensione «ebbe la finalità, anche se fortunatamente non conseguì il suo obiettivo, di rimettere l’Italia nei binari della normalità dopo le vicende del ’68 ed il cosiddetto autunno caldo». Parlò di «significative presenze» di due paesi che all’epoca ospitavano dei fascisti italiani, Grecia e Spagna, e indica tra i fautori di mutamenti involutivi coloro che nella nostra storia si trovano periodicamente, e cioè ad ogni buona occasione che si presenti, dalla parte di [chi] respinge le novità scomode e vorrebbe tornare all’antico. […] E così ora non soli, ma certo con altri, lamentavano l’insostenibilità economica dell’autunno caldo, la necessità di arretrare nella via delle riforme e magari di dare un giro di vite anche sul terreno politico35.
Il prigioniero affermò di non aver mai creduto «nemmeno per un minuto» alla pista rossa per quanto riguardava Piazza Fontana (che era, anzi, «vistosamente nera») e lamentò il fatto che il processo di Catanzaro sulla vicenda non avesse «compiutamente definito […] il ruolo (preminente) del Sid e quello (pure esistente) delle forze di polizia. Ma che questa implicazione ci sia non c’è dubbio». «È doveroso alla fine rilevare», concludeva Moro, «che quello della strategia della tensione fu un periodo di autentica ed alta pericolosità, con il rischio di una deviazione costituzionale che la vigilanza delle masse popolari fortunatamente non permise». Secondo Moro, poi, «l’interesse e l’intervento» furono «più esteri che nazionali», mentre c’era chi «intendeva usare il Sid in senso politico e in una certa direzione politica»36. Moro, difendendosi, ricorda il suo isolamento nel partito alla fine degli anni Sessanta e all’inizio degli anni Settanta, il fatto che fosse stato definito «antipartito» per aver criticato la strategia dell’allora segretario, Forlani, latore di una politica che sarebbe stata realizzata in seguito, quella di un pentapartito che escludesse i comunisti e avesse come elemento centrale dell’equilibrio politico un forte partito socialista. Concluse, quindi, di non essere depositario di segreti particolari, né di essere mai stato il capo incontrastato della Dc:
35 36
CpS, II, memoriale, cit., numerazione tematica 2. pp. 384-391. Ivi, pp. 258-269.
49
MARCO CLEMENTI
si può dire solo che in essa sono stato presente ed ho fatto il mio gioco, vincendo o perdendo, anzi più perdendo che vincendo, per evitare una involuzione moderata della Dc e mantenere aperto il suo raccordo con le grandi masse popolari. La sincerità dei miei intendimenti e delle mie intuizioni politiche, in ogni sede sinceramente confermate […] potrebbero indurre ad un giudizio generoso nei miei confronti37.
Come si può apprezzare leggendo quanto scritto durante il sequestro, Moro continuò a discolparsi con una certa decisione e in questo senso la memoria difensiva appare come un materiale vincolato alle lettere, le quali a loro volta costituiscono il tentativo di difendere le proprie tesi inerenti la proposta di scambio di prigionieri e di una tregua nei confronti del mondo esterno. In ciò Moro fu davvero un uomo solo, perché rimase inascoltato tanto fuori dalle forze politiche, quanto dentro dai suoi sequestratori, che ne divennero poi gli assassini, perché la sua lunga memoria difensiva non riuscì a mutare la loro attitudine. Si comprende meglio, a questo punto, per quale motivo le Br incontrarono delle difficoltà nella diffusione del materiale. In effetti non ci si trova di fronte a delle ammissioni chiare, a delle rivelazioni dirette, ma a una serie di risposte che Moro usò per difendersi dalle accuse che gli furono poste nel corso di quello che, non lo si deve mai sottovalutare, per le Br, e dunque per Moro, fu un vero processo. Un processo “non giusto”, però, perché l’esito non dipese dalle “prove a carico” o a “discolpa” di Moro, ma dalla risposta della politica italiana alle richieste dei brigatisti.
37
CpM, memoriale, pp. 130-134; CpS, II, memoriale, cit., pp. 329-346.
50
LA COLONNA GENOVESE DELLE BRIGATE ROSSE Luigi Carli
Dott. Carli, come nacque la sua attività investigativa sul terrorismo delle Brigate rosse a Genova? Carli - Per quanto riguarda le Br, come magistrato del pubblico ministero in servizio a Genova, fui incaricato di occuparmene dall’allora procuratore della Repubblica, piuttosto tardi, cioè, dal 1979. E me ne interessai fino al 1983, allorché la “colonna” genovese delle Brigate rosse fu totalmente smantellata ed i componenti della medesima tutti condannati a pesanti pene in vari processi. La mia investitura avvenne quasi per caso, dopo la clamorosa sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Assise di Genova presieduta dall’oggi defunto collega Giuseppe Quaglia. Gli imputati, accusati di essere brigatisti, furono infatti tutti prosciolti e tale assoluzione venne fortemente criticata dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che usò in proposito la formula: «L’ingiustizia che assolve». Erano o non erano brigatisti, ci faccia capire? Carli - In realtà, come accertai in seguito con le mie indagini, solo alcuni degli imputati erano o erano stati dei brigatisti, mentre altri appartenevano semplicemente all’area eversiva della sinistra extraparlamentare. Con le Brigate rosse vere e proprie, non avevano avuto nulla a che fare.
L’intervista al dott. Luigi Carli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari, è stata raccolta da R. Bartali e S. Sechi, e curata da Leonardo Raito. 51
LUIGI CARLI
Inoltre, nei confronti di tutti erano state raccolte solo prove indiziarie. Le sole allora possibili. Non ho mai saputo perché, quando dopo tale decisione i colleghi che fino ad allora si erano occupati delle indagini sul fenomeno eversivo chiesero ed ottennero di essere sollevati dall’incarico, la scelta del procuratore cadde su di me. Forse, perché ero tra i pochi che non posero pregiudiziali. Forse, perché essendo allora uno dei più giovani sostituti non ebbi il coraggio di rifiutare. Forse, perché, essendomi in precedenza già occupato, come pubblico ministero, di taluni fatti eversivi minori, come l’attentato incendiario ai danni della Lufthansa, avevo maturato una certa esperienza in questo settore. Anzi, come dirò in seguito, questa piccola esperienza e la raggiunta conoscenza di taluno degli imputati di quel fatto, fu davvero preziosa per il mio lavoro futuro. Non escludo, però, che una delle concause della mia scelta possa essere stata anche la circostanza che, provenendo dai quartieri operai di Sampierdarena, come il Campasso, ed avendo militato – soprattutto da studente universitario – nei movimenti della sinistra studentesca, non solo ne conoscevo quasi tutti gli esponenti ma, soprattutto, ero in grado di parlare e comprendere il “politichese”. Dimostrando, così, di saper decifrare il criptico linguaggio dei documenti delle Br. Che erano davvero scritti in una lingua aliena. Come riuscì a ricostruire la storia della colonna genovese delle Br? Carli - Direi anche per una serie di circostanze favorevoli. È, però, vero che di esse me ne ero occupato professionalmente solo dopo l’omicidio di Guido Rossa e l’irruzione dei Carabinieri in via Fracchia1. Fu molto utile un’indagine che si fondò, in sostanza, sull’essenziale apporto collaborativo dei “pentiti”. Mi riferisco alle confessioni che riuscii a raccogliere, tra brigatisti genovesi e non. Furono più di un centinaio. Ma riuscii a identificare tutti gli appartenenti, prima noti
1
Il 28 marzo 1978 i Carabinieri del generale Dalla Chiesa effettuarono un blitz nel “covo” di via Fracchia, a Genova, indicato dal pentito Patrizio Peci. Nell’operazione restarono uccisi quattro brigatisti rossi: Annamaria Ludman e Riccardo Dura, genovesi, Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli appartenenti ad altre “colonne” e rifugiatisi a Genova.
52
La colonna genovese delle Brigate rosse
solo per il loro cosiddetto “nome di battaglia”. Accertai a quali “azioni di fuoco” essi avevano partecipato. Sequestrai materiale propagandistico e militare di grande rilievo. Individuai i “covi” e, alla fine, ottenni la loro condanna in giudizio. Quale tipo di presenza ebbero le Br a Genova? Carli - Da quanto venni a sapere, almeno fino alla seconda metà degli anni Settanta non si può parlare di una effettiva presenza, con radicamenti locali, delle Br nella città di Genova. Le azioni più clamorose che sono state fatte prima del 1975, cioè il rapimento del pubblico ministero Mario Sossi e l’omicidio del procuratore generale Coco, erano state portate a termine, infatti, soprattutto da persone venute da fuori. L’apporto dei genovesi – come appresi poi – si limitò al massimo, in tali occasioni, nel fornire basisti ed informatori. Solo successivamente intervenne una vera e propria “colonna” genovese, via via rafforzatasi nel tempo, fino a raggiungere un organico complessivo, a vario livello di partecipazione, di una sessantina di persone. A questa “colonna” vanno imputati l’omicidio di Guido Rossa, il sequestro dell’armatore Costa, eseguito per autofinanziare l’organizzazione, le uccisioni del vice-questore Esposito, nonché dei Carabinieri di Albaro e di Sampierdarena, oltre a numerosissime “gambizzazioni” di esponenti politici della Dc e del Pci e di sindacalisti, nonché azioni di propaganda di vario genere, quali azioni minatorie ed incendi di auto. Ma chi erano i brigatisti genovesi? Carli - La realtà delle Br genovesi era del tutto particolare. Da quel che emerse dalle mie indagini, i movimenti eversivi di sinistra, che furono il vero brodo di cultura delle Brigate rosse a Genova, si collocavano quasi totalmente nell’ambiente studentesco ed accademico. Soprattutto universitario. In particolare presso le facoltà di Lettere, Architettura e Medicina. Attorno a questo ambiente piuttosto elitario, fatto in prevalenza di giovani e giovanissimi di estrazione borghese, ma in cui spiccavano anche docenti come G. Faina, E. Fenzi, L. Grasso, Ortolani, ruotavano infatti gli appartenenti ai gruppuscoli di varia matrice eversiva. 53
LUIGI CARLI
Esclude che ne facessero parte militanti delle vecchie organizzazioni operaie? Carli - Nella “colonna” genovese delle Br militarono, in verità, anche soggetti provenienti dai sindacati, dalle grandi fabbriche come l’Italsider e l’Ansaldo, dai circoli della Amt (l’azienda municipale trasporti), dall’organizzazione portuale, e pure da alcune associazioni cattoliche. Ma restarono sempre una minoranza rispetto all’apporto accademico-studentesco. Com’è noto, nell’ambito dell’organizzazione genovese (la “Ditta”, come veniva chiamata dagli affiliati) vi erano, come altrove, diversi ruoli. I quali partivano dai semplici “contatti”, ossia dai meri simpatizzanti, passavano attraverso gli “irregolari”, che erano coloro che, pur facendo parte delle Br ed avendo un nome di battaglia, conservavano le proprie abitudini sociali e di lavoro, e giungevano ai “regolari” (o “clandestini”). Cioè a coloro che erano i vertici politico-militari apicali della “colonna”. Vivevano in clandestinità, erano sempre armati e partecipavano istituzionalmente alle azioni di fuoco più importanti, quali gli “annientamenti” (omicidi) dei nemici del popolo. Vi erano anche diversi “prestanome” che avevano il compito di intestarsi e gestire le “basi logistiche” (i “covi”). Altra caratteristica dell’ambiente eversivo genovese, oltre alla giovinezza degli adepti (riscontrai la presenza di un solo, ormai attempato, sedicente “staffetta partigiana”), era la reciproca comune conoscenza. Cosicché, siano o no poi divenuti appartenenti alle Br, alla faccia del cosiddetto “principio di compartimentazione”, tutti si conoscevano e sapevano tutto (o molto) di tutti. E, questo fu una fortuna per le mie indagini. Rispetto ai gruppuscoli quale fu la differenza? Carli - Guardi che le Br furono un’altra cosa rispetto ai gruppuscoli iniziali, del tipo di quelli del Faina. Essi erano sostanzialmente dei velleitari, ma da questi gruppi transitarono i vari componenti della futura “colonna”. In realtà, nonostante il fortissimo dibattito politico in atto ed i proclami eversivi, il terrorismo vero e proprio – come ebbi ragione di constatare con le indagini – al di fuori delle Br aveva scarsamente attecchito nella società genovese e, soprattutto, sulla base operaia. Neppure vi fu un incisivo apporto in tal senso delle forze politiche. 54
La colonna genovese delle Brigate rosse
Il partito, infatti, che al movimento eversivo forse fu più idealmente vicino, come potei constatare, organizzando in ispecie manifestazioni pubbliche di protesta ed architettando campagne di stampa contro le istituzioni pubbliche, quali la magistratura, definite repressive, fu il Psi. Imitato da quello Radicale. Ci furono singoli personaggi che possono dirsi vicini alle Br? Carli - Ricordo in particolare – ma ne parlerò meglio in seguito – il prof. Enrico Fenzi, stimatissimo petrarchista. Ricordo, inoltre, Roberto Garigliano, un brillante studente della facoltà di Lettere che aveva compiuto l’attentato alla Lufthansa di cui ho in precedenza parlato. Garigliano, che conosceva vita, morte e miracoli del movimento eversivo e dei suoi componenti, comprese le Br e, pertanto, mi fu utilissimo per le indagini. Aveva da sempre cercato di entrare nell’organizzazione, ma ne era stato sempre respinto perché le Br non gli perdonavano certi suoi trascorsi da tossicodipendente. Ricordo anche Gianluigi Cristiani, uno dei pochi Br genovesi di sicura origine proletaria, e Carlo Bozzo, borghese e figlio di borghesi, divenuto capo del Fronte Logistico di “colonna” e custode delle armi e dei materiali in dotazione alla medesima. Ma c’erano pure gli “irregolari”: Gianni Cocconi, operaio dell’Italsider; Angela Scozzafava – figlia di un commesso di palazzo di giustizia – la quale lavorava presso le istituzioni portuali e Fulvia Miglietta, cattolica fervente, divenuta rivoluzionaria a causa delle delusioni patite nell’ambiente da cui proveniva. Né posso tralasciare la ultrasettantenne Caterina Picasso, prestanome di quella base logistica di fondamentale importanza per la “colonna genovese”, che fu quella di via Zella, a Rivarolo; affiliatasi alle Br per protesta contro una vita di indicibili stenti e sofferenze. Essa mi si affezionò sinceramente, nonostante fossi un pubblico ministero, solo perché ero stato tra i pochi che la sapevano ascoltare. Ma dovrei ricordarne anche tanti altri, con i quali riuscii a comunicare, perché – come ho detto – sapevo parlare “politichese” e venivo dal Campasso, ma anche perché, come magistrato, non ero affatto il “cane da guardia della borghesia” che si aspettavano. Mi percepirono come un essere umano, alla fin fine come loro. E, soprattutto, un garantista. 55
LUIGI CARLI
Cosa che li sorprese molto. Impararono a fidarsi di me quando cominciai a prospettare i vantaggi che la legge prevedeva per chi collaborasse. Che ruolo ebbe il suicidio dell’avvocato Arnaldi? Carli - Fu un fattore decisivo per la sconfitta politico-giudiziaria non solo delle Brigate rosse genovesi. L’avvocato Arnaldi, come accertammo, era infatti inserito a pieno titolo – quale “irregolare” – nell’organizzazione delle Br. Formalmente, con il compito di assicurare la difesa tecnica ai brigatisti detenuti ma, in realtà, con il compito di garantire un costante contatto tra l’organizzazione esterna delle Brigate rosse ed i suoi appartenenti incarcerati. Cosicché, all’uopo sfruttando le prerogative del difensore che, per legge, può in ogni momento incontrare in carcere i propri assistiti, recava loro non solo le istruzioni del Comitato esecutivo e del direttivo di “colonna”, ma poteva controllarne il comportamento. Assicurandosi che non vi fossero cedimenti o ripensamenti. I quali sarebbero stati comunque repressi con sanzioni che potevano giungere fino all’uccisione dei presunti traditori. Va aggiunto che, ideologicamente, ai brigatisti rossi la difesa tecnica nel processo non interessava in alcun modo. Non solo la rifiutavano, ma “gambizzavano” o “annientavano” – nella guerra contro lo Stato che avevano dichiarato – i difensori d’ufficio loro nominati per legge (si veda, per tutti, l’omicidio dell’avvocato Croce, a Torino). Era molto più rilevante nella loro ottica bellicistica che l’organizzazione restasse compatta sia all’esterno sia all’interno del carcere. Può spiegare meglio in che modo l’avvocato Arnaldi ha potuto provvedere a questo scopo? Carli - Direi che proprio grazie a lui l’organizzazione delle Br riuscì – per un certo periodo – a vivere e prosperare anche all’interno delle strutture carcerarie. Applicandovi ferocemente le proprie leggi, difendendosi dagli attacchi che riteneva di subire e punendo esemplarmente i presunti traditori. Ma, altresì, programmando varie azioni di fuoco contro il personale carcerario, che l’organizzazione esterna non esitò poi a realizzare. In conseguenza della collaborazione di Patrizio Peci con la magistratura torinese, non solo venne individuato a Genova il “covo” di via 56
La colonna genovese delle Brigate rosse
Fracchia, ma compiutamente accertato anche il ruolo dell’avvocato Arnaldi. Quando i Carabinieri si recarono dall’avvocato per arrestarlo questi, con una scusa, riuscì a chiudersi nel bagno, sparandosi un colpo in testa con una pistola lì occultata. È quanto accertò la Squadra mobile di Genova fatta intervenire dal magistrato di turno allo scopo che non vi fossero dubbi sull’estraneità degli stessi Carabinieri al fatto. Si interruppe, in tal modo, il cordone ombelicale che legava l’organizzazione delle Br al mondo interno delle carceri. E ciò fu davvero devastante per la strategia delle stesse Br, tanto è vero che i brigatisti detenuti a Genova, privi ormai di contatti e di istruzioni della “casa madre” e messi di fronte alle loro responsabilità, non solo accettarono la difesa tecnica ma, dopo le prime resistenze intese a verificare la lealtà degli inquirenti, iniziarono a collaborare con loro. Va aggiunto che l’avvocato Arnaldi aveva un figlio, Edoardo, studente universitario, pure lui inserito nell’organizzazione delle Br in qualità di “irregolare”. Probabilmente, tale suo inquadramento – avvenuto non senza contrasti nel direttivo di “colonna”, a quanto mi dissero i “pentiti” – fu determinato dalla volontà del padre e, forse, più della madre, accesa rivoluzionaria, ma non inquadrata nell’organizzazione. Non fu, tuttavia, una scelta felice per le Br perché il giovane, accusato non senza fondamento di leggerezza nell’osservarne il codice di comportamento, si rivelò un anello debole soprattutto nei confronti della “compartimentazione”. Si tratta dell’obbligo di cautela e discrezione derivanti dalla limitatezza delle conoscenze personali che ciascun brigatista doveva istituzionalmente mantenere allo scopo di non pregiudicare la struttura segreta dell’organizzazione, anche se fosse stato catturato dalle forze dell’ordine. Fu proprio grazie a Edoardo Arnaldi ed ai suoi invece ostentati contatti personali – tutti riconducibili all’ambiente eversivo di cui ho parlato all’inizio – che fu possibile individuare, tra gli altri, brigatisti come Gianluigi Cristiani e Carlo Bozzo e talune militanti della organizzazione. Nonché aspiranti brigatisti, come Roberto Garigliano. Mi pare si possa dire che allora venne fuori l’intera storia delle Brigate rosse genovesi. Carli - È vero. Come ho sopra accennato, a Genova le Brigate rosse erano formate quasi esclusivamente da studenti, soprattutto universitari. Provenienti, in ispecie, dalle facoltà di Lettere, Architettura e Medicina. 57
LUIGI CARLI
La componente operaistica ed impiegatizia – pur presente – era di scarsa consistenza. Ed anche taluni sedicenti operai erano, in realtà, studenti che avevano scelto la fabbrica per ragioni, per così dire, ideologico-sentimentali. Non militavano nelle Br genovesi né ex partigiani, né iscritti ai partiti cosiddetti “costituzionali”. Inoltre, una “colonna” genovese in senso stretto fu costituita – a quanto mi consta – solo dopo lo scontro di via Fracchia. Ne è dimostrazione il fatto che, a parte alcuni “irregolari” individuati successivamente, nel “direttivo” scoperto in via Fracchia vi erano solo due genovesi: Riccardo Dura e la “prestanome” dell’alloggio, Annamaria Ludman. Gli altri due brigatisti che vi restarono uccisi, provenivano dalle “colonne” di Torino e Milano. A parte ciò, i connotati ideologici dei Br genovesi erano, come ho già detto, abbastanza peculiari. Assai inconsistente la componente “operaistica”, prevaleva invece l’impostazione militaristico-intellettuale. Nella “colonna” genovese dove militarono in successione una sessantina di elementi – trovai, infatti, due o al massimo tre operai dell’Ansaldo, i quali costituivano la corrispondente “brigata”. Si riferisce, ci pare, alla “brigata” Italsider e quindi al rapporto delle Br con la classe operaia… Carli - Nei momenti di massimo splendore, essa non superò mai le dodici unità. La “brigata” Porto constava in tutto di due componenti e, forse, di qualche “contatto. Anche il resto delle “brigate” era costituito da studenti o “quasi-studenti”. Un paio appartenevano alla cosiddetta “brigata” Amt (Azienda municipalizzata trasporti), qualcuno alla “brigata” Ospedali, mentre la “brigata” Enti locali esisteva solo sulla carta. Ed anche della “brigata imperiese”, che svolgeva soprattutto compiti logistici sfruttando la vicinanza di Imperia alla Francia, facevano parte ex studenti e qualche persona che lavorava nel campo dello spettacolo e della ristorazione. Si trattava, peraltro, di una “brigata” anomala, perché i suoi componenti mantenevano rapporti con la malavita locale. Cosa che le Brigate rosse avevano sempre rifiutato fermamente fino a che, per ragioni contingenti, non furono costrette a ricredersi sul punto, soprattutto nel Veneto o nell’area napoletana. E fu, peraltro, una delle ragioni della loro fine. 58
La colonna genovese delle Brigate rosse
La sostanziale separatezza dei militanti genovesi delle Br dalla realtà delle grandi fabbriche e, in genere, dalla classe operaia spiega – a mio avviso – anche il loro successivo fallimento a Genova. In effetti, anche se all’inizio vi era stata una certa simpatia ideologica, in realtà questa non andò mai oltre la posizione espressa con lo slogan «né con lo Stato, né con le Brigate rosse». Dopo l’uccisione di Guido Rossa – come vedremo meglio in seguito – allorché il Pci assunse una posizione di netto rifiuto del terrorismo e fece terra bruciata nei confronti delle Br, queste si rivelarono, almeno a Genova, un vero e proprio corpo estraneo rispetto alla classe che pretendevano di guidare alla conquista del potere. Dalle testimonianze raccolte risulta che dal rapimento Sossi in poi rapporti del genere invece ci furono, magari a livello non ufficiale. Ad esempio il generale Bozzo iniziò a collaborare col segretario della federazione provinciale del Pci Lovrano Bisso, avviando uno scambio di informazioni. Carli - Non escludo che, all’inizio, dalle fabbriche genovesi siano partite informazioni di ogni genere dirette alle Brigate rosse. Il sequestro di un’imponente messe di documenti nel “covo” di via Fracchia, starebbe a dimostrarlo. Non so, invece, di preesistenti rapporti di collaborazione, anche informativa, tra la base operaia, il Pci e le forze dell’ordine. Segnatamente, i Carabinieri. Non solo non ho accertato nulla in proposito, ma nessuna informazione mi pervenne da tali fonti allorché mi occupai personalmente della “colonna” genovese e della “brigata” Italsider in particolare, come dirò meglio in seguito. D’altra parte, come ho detto, ho iniziato ad indagare sul terrorismo brigatista solo a partire dal 1979. E, per lo stesso motivo, neppure sono al corrente di asseriti rapporti – intercorsi prima di tale data – tra le Br genovesi ed i vecchi partigiani. L’unica cosa che posso riferire in merito è che Carlo Bozzo, capo del “fronte logistico di colonna”, a suo dire tentò (evidentemente non per sua sola iniziativa) di contattare taluni ex militanti della Resistenza al fine di reperire materiale bellico da utilizzarsi nelle “azioni di fuoco”. Ma, a quanto mi disse, riuscì a recuperare solo “ferrivecchi”, tanto da costringere i membri della “colonna” a farsi rifornire di armi lunghe da altre colonne ed a procedere in proprio ad “espropri”, come 59
LUIGI CARLI
nel caso delle mitragliette sottratte ai Carabinieri uccisi a Sampierdarena. Armi da guerra ed esplosivi giunsero comunque a Genova dal Veneto e dalla Francia. In particolare, mitra Sten forniti dalla “colonna” veneta che asseriva di averli avuti da al-Fatah. Armi, queste, rivelatesi subito inappropriate alla guerriglia urbana, tanto da essere immediatamente “imboscate” nei magazzini delle varie basi logistiche. Esplosivi furono invece forniti ai genovesi da Action Directe e giunsero in Liguria attraverso sentieri montani ubicati alle spalle di Ventimiglia ed indicatici da Fulvia Miglietta. Le armi normalmente utilizzate per le “gambizzazioni” e gli “annientamenti” erano, dunque, pistole di vario calibro già in dotazione della “colonna” oppure fornite dall’organizzazione centrale, che le faceva ruotare fra le varie “colonne”, come appurammo anche in seguito alla scoperta della “base logistica” di Cervo Vecchia, a due passi da Imperia. Qui reperimmo pure mitra di fabbricazione tedesca e italiana, ma risalenti alla seconda guerra mondiale ed ormai del tutto inutilizzabili. Furono dunque rinvenute anche vecchie armi, che provenivano dalla guerra partigiana? Carli - Proprio grazie alla collaborazione dei “pentiti” della “brigata” imperiese (anch’essa composta in prevalenza da studenti o ex studenti) giungemmo alla base logistica delle Br ubicata tra gli uliveti di Cervo Vecchia. Qui reperimmo, come ho detto, in un anfratto nascosto tra le “fasce” (ossia i terrazzamenti), mitra di fabbricazione tedesca (Schmeisser) ed italiana (Mab), di cui ho parlato, ed anche esplosivi. I primi, erano proprio i “ferrivecchi” di cui parlava Carlo Bozzo, gli esplosivi erano, invece, di recente fabbricazione e di chiara provenienza francese. Si rivelò, inoltre, particolarmente interessante l’altro materiale reperito nell’anfratto: apparecchi per la falsificazione delle targhe automobilistiche, ciclostili ed apparecchiature elettroniche per inserirsi nelle trasmissioni della Rai, nonché un’abbondante documentazione cartacea di ogni tipo. Non solo di carattere eversivo (scoprimmo, tra l’altro, che il “giornale” delle Br era stampato ad Imperia), ma anche moltissimi documenti falsi, di sicura origine delittuosa, nonché refurtiva varia, tra cui perfino oggetti sacri. Avemmo così oggettiva conferma che i brigatisti locali, come ho detto, erano abbastanza anomali rispetto agli altri componenti della “colonna” genovese ed alle Brigate rosse in genere. 60
La colonna genovese delle Brigate rosse
Può riprendere il discorso sulle armi delle Br, per favore? Carli - Le armi sono sempre state considerate indispensabili alla rivoluzione che le Br dicevano di perseguire attraverso la lotta armata. In tale prospettiva privilegiavano al momento quelle più idonee agli obbiettivi che si poneva la cosiddetta “propaganda armata”. Cioè, terrorizzare e demoralizzare il “nemico di classe” con “invalidazioni” ed “annientamenti”, ed in tal modo aprire la via alla cosiddetta “guerra civile dispiegata” in cui le Br, fatto ormai “il salto a partito” e conquistato il potere, avrebbero instaurato la dittatura del proletariato. Solo in questa fase successiva sarebbe stato necessario dotarsi di materiale più propriamente bellico, a dire delle Br sottratto all’esercito o fornito spontaneamente dai “proletari in divisa”. Ma anche proveniente da “forze amiche” (sentii, a questo proposito parlare di Cecoslovacchia e Bulgaria, ma nulla constatai direttamente, anche perché la “guerra civile dispiegata” non vi fu). Nel frattempo, come ho detto, erano considerate utili e ricercate solo le armi idonee alla guerriglia urbana. In particolare, secondo i dettami di Carlos Marighella, armi corte, mitragliette, bombe a mano ed esplosivi che in effetti reperimmo non solo a Cervo Vecchia, ma anche nel “covo” di via Zella, a Genova-Rivarolo ed in vari “imboschi” sulle alture genovesi. Sta di fatto che i brigatisti nostrani – particolarmente vocati al militarismo e dalle soluzioni armate invece che al proselitismo ideologico privilegiato altrove – accantonati i vecchi mitra di provenienza bellica (grossi, antiquati e scarsamente efficienti), si erano dotati di moderne mitragliette (Skorpion e M12), pistole automatiche, calibro 9 o 7,65, esplosivi vari e bombe a mano. Taluni “espropriati”, come ho detto, altri, provenienti dall’organizzazione centrale, che li aveva reperiti in vario modo, anche comprandoli dalla malavita. Che vi fosse una rotazione, tra le varie “colonne”, di pistole e mitragliette è dimostrato, ad esempio, dal fatto che bossoli esplosi dalla stessa arma furono reperiti in varie città d’Italia dove si erano avute azioni di fuoco poi regolarmente rivendicate dalle Br. Franceschini ha detto che le Br di Genova, quando egli era ancora in libertà, erano composte dai Ciruzzi, Lazagna, Adamoli, tutti vicini al Pci e tutti con contatti con i paesi dell’Est. A Lei risulta nulla del genere? 61
LUIGI CARLI
Carli - Ho precisato più volte che mi occupai delle Br genovesi solo a partire dal 1979, allorché si era costituita a Genova la “colonna” Br vera e propria su base locale. In precedenza, a quanto mi risulta, pur esistendo una realtà politico-militare operativa, questa non può essere minimamente paragonata a quella formatasi dopo la vicenda di via Fracchia. In precedenza, infatti, la presenza stabile delle Br a Genova era stata esigua essendo, quella genovese, appendice di altre “colonne”. Torinesi e milanesi in particolare. Tutto fu particolarmente chiaro quando intervenne l’azione di via Fracchia e, in base alle indicazioni di Patrizio Peci, fu individuata anche una “base logistica” a Recco. Non mi risulta neppure che a livello, diciamo “istituzionale”, esistessero rapporti tra questa sia pur precaria realtà iniziale, i paesi dell’Est e il Pci. Seppi solo da vari “pentiti” che, però, riferivano quanto appreso da altri, che Adamoli, ormai latitante da tempo, aveva contatti personali con elementi rivoluzionari francesi e spagnoli. Da quello che accennò poi sia pur sommariamente (non fu mai chiara in proposito) Fulvia Miglietta, e da quanto reperito a Cervo Vecchia ed in via Zella di Genova-Rivarolo, la “colonna” che riuscii poi a smantellare, intratteneva rapporti soprattutto con ambienti eversivi francesi ed Action Directe, in particolare. I collaboratori di giustizia mi riferirono altresì – come ho detto – che la “colonna” aveva ricevuto, tramite la “colonna” veneta e non per contatti propri, armi provenienti da al-Fatah. Dalle stesse fonti appresi pure che le Br – ma solo a livello nazionale – avevano avuto contatti e, forse, anche aiuti non meglio specificati, dal Mossad, il servizio segreto di Israele. La cosa mi stupì molto, poiché non riuscivo a capire cosa potessero entrarci gli israeliani con il terrorismo italiano. Mi fu detto che, ad Israele tutto ciò interessava invece molto, aspirando a divenire – al posto dell’Italia – il principale referente Usa nel Mediterraneo. In effetti, un’Italia resa debole ed inaffidabile a causa del terrorismo interno, sarebbe stata poco credibile. Ma, poiché la cosa non aveva risvolti processuali sulle vicende genovesi di cui mi stavo occupando, al di là dell’ovvia curiosità, non approfondii tale discorso. Franceschini, Paroli, Bertolazzi, Bonavita: tutti o quasi i primi brigatisti parlano di una forte contiguità con i vecchi partigiani, dicono 62
La colonna genovese delle Brigate rosse
che questi li portavano a sparare, ad addestrarsi. Parlano proprio di contiguità fisica. Può confermarci se ciò avvenne anche a Genova? Carli - Da quanto ho constatato, i militanti della “colonna” genovese si addestravano regolarmente all’uso delle armi. Dovevano farlo d’obbligo tutti, “regolari” ed “irregolari”. Fu costretto a farlo pure Enrico Fenzi, che era un intellettuale puro ed odiava le armi. Ma, avendo qualità di “irregolare”, dovette comunque partecipare armato alla “gambizzazione” di Carlo Castellano. E lo fecero anche gli altri brigatisti della “colonna”, maschi e femmine. L’addestramento alle armi avveniva in genere sulle alture di Genova, a cura del Fronte Logistico e sotto la sorveglianza di taluni “irregolari” e, forse, anche di qualche “clandestino”. Che, però, pur essendo presente per vigilare sull’efficienza dell’addestramento militare, nel rispetto della “compartimentazione” evitava di farsi vedere ed avere contatti con coloro che non vi erano autorizzati. D’altra parte, chi aveva aderito alle Br e desiderava salire nel “cursus honorum”, passando da “contatto” a “irregolare”, e da “irregolare” a “clandestino”, oltre all’indottrinamento politico, doveva necessariamente saper maneggiare le armi. A prescindere dal fatto che poi, secondo le opzioni personali e l’approvazione dell’Esecutivo, restasse un “irregolare” o “passasse in clandestinità”. Nel primo caso, pur avendo un nome di battaglia ed essendo a pieno titolo inquadrato nell’organizzazione delle Br, tanto da svolgere attività informativa e poter partecipare a “invalidazioni” nonché ad azioni minori, conservava la propria identità ed il proprio lavoro, e viveva la vita di tutti i giorni. Da “irregolare”, anche se taluno fu immediatamente ammesso alla “clandestinità”, dopo un severo esame attitudinale a cura dei vertici dell’organizzazione, si poteva ascendere a “regolare”. Abbandonando qualsiasi contatto familiare e personale e vivendo appieno e nel segreto l’attività rivoluzionaria. A tale scopo, il “clandestino” portava sempre con sé un’arma, addestrandosi ad usarla senza esitazione ove per qualsiasi motivo venisse in contatto con le forze dell’ordine. Era peraltro istituzionalmente il “clandestino” a partecipare fisicamente all’“annientamento” dei “nemici del popolo” e ad uccidere. All’“irregolare” competevano, invece, come ho accennato, il lavoro di preparazione (ignorandolo, però) degli “annientamenti” e delle “invalidazioni” (“gambizzazioni”) e, solo eccezionalmente e per necessità, veniva impiegato nei primi. 63
LUIGI CARLI
Non mi risulta in alcun modo, tuttavia, che “regolari” o “irregolari” siano stati addestrati all’uso delle armi da ex partigiani. Anzi, l’unico sedicente partigiano con cui ebbi a che fare nelle mie indagini e che venne arrestato dai Carabinieri, era stato – a suo dire – una semplice “staffetta partigiana”. Siccome collaborò fin da subito, gli chiesi se, oltre a lui, vi erano altri ex partigiani nell’organizzazione, ricevendo una risposta negativa. Né le indagini in proposito compiute lo smentirono. Le tecniche di lotta sono quelle dei piccoli gruppi durante la guerra di liberazione, cioè delle Sap e dei Gap? Chi insegnò loro a colpire un obbiettivo? Carli - Chiesi ai “pentiti”, anche per qualificare giuridicamente le azioni come reati di lesioni volontarie, tentato omicidio, omicidio e simili, quali erano state le modalità esecutive degli “annientamenti” e delle “invalidazioni”, visto che erano sicuramente tutti premeditati e preventivamente studiati in tutti i particolari prima di essere compiuti. Mi fu risposto che erano rigorosamente applicati i testi sacri della guerriglia urbana, che conoscevano tutti a memoria e, inoltre, che si osservavano, nell’occasione, anche i principi tattici stabiliti in concreto dall’organizzazione. L’autore più citato e comunque conosciuto a proposito di guerriglia urbana era Carlos Marighella, ma non mancavano altri “maestri” di provenienza sudamericana. Sul piano concreto, ribadisco che ogni azione – qualunque fosse – prevedeva un attento esame dei luoghi e delle abitudini dell’eventuale vittima, preventivamente ed accuratamente scelta dall’organizzazione in ragione del suo “valore politico”. Essa veniva pedinata a lungo dagli “irregolari” e, talvolta, anche da “contatti”, onde controllarne gli spostamenti e le abitudini. I risultati di tale azione informativa venivano poi trasmessi al “direttivo di colonna” che, a sua volta, li riferiva all’Esecutivo Nazionale. Il quale approvava o no, sia l’azione che la scelta della vittima, dando il via all’operazione. Venivano quindi attentamente preparate e studiate le modalità tattiche di questa, valutandone i rischi ed i riflessi politici. La “propaganda armata” non tollerava, infatti, né sconfitte, né sbagli. Neanche per pallottole vaganti ed errori di obbiettivo come il ferimento di estranei (si doveva evitare in ogni modo, tra l’altro, di invalidare terze persone e coinvolgere soggetti particolari, come i preti. Né si ammetteva l’eccessiva esposizione dei “compagni” che parteci64
La colonna genovese delle Brigate rosse
pavano alle azioni. I quali – per ovvi motivi – dovevano evitare in tutti i modi di essere riconosciuti o, peggio, catturati. Con queste premesse, come si spiega l’omicidio Rossa? Carli - A quanto mi fu detto, fu un’azione del tutto anomala, almeno come risultati finali e conseguenze politiche controproducenti. Fu discusso a lungo, innanzi tutto, a livello di Comitato esecutivo Centrale oltre che di Direttivo di quella che era allora la “colonna” genovese, quale fosse l’azione più idonea ed esemplare per punire Guido Rossa. Infatti, le Br volevano in tal modo dare un esempio memorabile alla classe operaia, idoneo a dissuadere per sempre coloro che avessero avuto idea di imitarlo, “tradendola”. Fu dapprima ipotizzato e poi escluso, anche per la difficoltà pratica di attuarlo, un sequestro di persona. Si passò quindi a considerare, in alternativa, “l’invalidazione” o “l’annientamento”. Da quanto mi riferirono i “pentiti” che, però, riportavano quanto appreso “de relato” in quanto all’epoca non erano ancora militanti delle Br, fu privilegiata “l’invalidazione”. Da rivendicare con un cartello appeso al collo di Rossa e riportante la scritta: “traditore della classe operaia”. Le cose, però, andarono diversamente dal previsto. Se è ormai pacifico, infatti, che a sparare sia stato Riccardo Dura, ex militante di Lotta continua ed ex operaio dell’Italsider, all’epoca in clandestinità e capo della “colonna” genovese, sull’effettivo svolgersi dell’azione mi furono fornite due diverse versioni. Secondo la prima, giudicata dagli stessi referenti meno attendibile, Rossa sarebbe stato ucciso a causa dei suoi movimenti scomposti allorché si tentava solo di “gambizzarlo”. Secondo l’altra versione – ritenuta da tutti più attendibile – fu proprio Dura ad ucciderlo deliberatamente. Egli spesso mal si adattava ad eseguire le determinazioni del Comitato esecutivo centrale ed agiva di testa propria e, per questo, era molto criticato dai “compagni”. L’uccisione di Rossa fu una violazione degli ordini ricevuti. E, per tale motivo, a quanto ancora mi dissero i “pentiti”, lo stesso Dura fu sottoposto ad un processo politico e fu un bene per lui – sempre a loro dire – che restasse successivamente ucciso in via Fracchia, altrimenti avrebbe dovuto subire esemplari sanzioni da parte dell’Esecutivo. 65
LUIGI CARLI
In effetti, l’uccisione di Guido Rossa fu un errore politico e strategico imperdonabile per le Brigate rosse che, come vedremo, si alienarono per sempre le simpatie della classe operaia. Si è detto da taluno, inoltre, che all’azione contro Rossa partecipò anche Gianluigi Cristiani. Ma tale affermazione mi lascia alquanto perplesso. Cristiani – che collaborò totalmente e lealmente alle indagini, assumendosi in pieno le proprie responsabilità – non ne parlò mai. Inoltre, Cristiani sarebbe stato all’epoca poco più che adolescente, e le Br, come sappiamo, per le azioni di fuoco sceglievano sempre le persone più esperte. Inoltre, come constatai personalmente, Cristiani soffriva di attacchi d’asma e di crisi epilettiche. Mi pare improbabile, dunque, che venisse impiegato in un’azione di fuoco di tale rilievo politico, ancorché all’inizio potesse essere solo una “gambizzazione”, un soggetto così fragile. Col rischio che un attacco d’asma o una crisi epilettica la facesse fallire. Rossa cercò di spezzare un tentativo di infiltrazione all’Italsider? Carli - Non lo so, anche se in base alle indagini da me compiute lo escluderei. Come ho detto, nell’Italsider la posizione inizialmente assunta dalla base operaia nei confronti del terrorismo fu quella dell’indifferenza: «né con lo Stato, né con le Brigate rosse». La scelta di testimoniare in giudizio assunta da Guido Rossa, a mio avviso, ha invece i connotati di un’opzione autonoma e soggettiva, tipica della generosità e dell’impegno civile dell’uomo Rossa, anche se questa scelta non poteva essere certamente né ignota né disapprovata dal Pci e dal sindacato di cui egli faceva parte. Non posso dunque dire se, l’implicito o esplicito assenso con cui questa determinazione venne accolta, riveli una precisa presa di posizione e, fin d’allora, del Pci e dei sindacati contro il terrorismo. Non lo escluderei, tuttavia. Sta di fatto, però, che le indagini da me compiute e corroborate da plurimi riscontri e dalla piena confessione degli appartenenti all’ala “operaistica” della “colonna” genovese, evidenziarono come la presenza delle Br all’Italsider fosse sempre stata percentualmente assai modesta. Non più di dodici persone in tutto, a fronte di migliaia di operai al lavoro. Né i componenti della stessa “brigata Italsider”, appena identificati, si rivelarono persone di elevato livello rivoluzionario e di grande carisma. Anzi, essi costituivano, con la loro ideologia “operaistica” e 66
La colonna genovese delle Brigate rosse
sostanzialmente meno violenta, una presenza in grande parte decorativa ed anomala in una “colonna” – come quella genovese – che privilegiava invece senza esitazione il militarismo e la lotta armata. In proposito illuminanti appaiono le dichiarazioni a verbale di Gianni Cocconi, che di tale “brigata” fu il responsabile fino all’arresto e che, quale operaio vero e sindacalista, ben conosceva l’ambiente di fabbrica. Il quale escluse ruoli interdettivi di Rossa o di qualche altro. La vicenda di via Fracchia ci aiuta a delineare alcune caratteristiche ideologiche delle Br genovesi. Carli - Lo scontro a fuoco di via Fracchia con la morte di quattro brigatisti, due genovesi (Dura e Ludman) e due provenienti da altre “colonne” (Betassa e Panciarelli), non indebolì né compromise incisivamente la “colonna” genovese che, come ho detto, era all’epoca ancora in formazione. Essa si costituì, infatti, come realtà soprattutto militare, subito dopo l’azione di via Fracchia e come reazione ad essa. L’organico che la costituiva, tra “regolari”, “irregolari”, “contatti” e “prestanome” non superò la sessantina di persone, ed essa operò con azioni di fuoco fin verso la fine del 1981, quando venne integralmente smantellata a seguito dell’inchiesta giudiziaria. Ripeto, la “colonna” genovese aveva una fisionomia sua propria. Assai diversa da quella delle altre “colonne” che conoscevo. Era la provenienza prevalentemente studentesca ed universitaria dei componenti a caratterizzarla. Inoltre, a differenza di molte altre, oltre ad essere fortemente ideologicizzata, era quella che aveva sposato senza riserve la lotta armata, tanto è vero che – nello stesso ambito delle Br – era conosciuta come quella più “militarista”. Ne avemmo conferma giudiziaria sia per il materiale bellico recuperato nei vari “covi” (via Zella, a Genova-Rivarolo; Cervo Vecchia e via Fracchia), sia per la “biblioteca” messa a disposizione dei “compagni”. I brigatisti genovesi, oltre a leggere i testi classici di Marx e Lenin, si indottrinavano soprattutto con le opere di Rosa Luxemburg (L’accumulazione del capitale; La rivoluzione sovietica in particolare, ma anche con scritti minori della medesima). Di conseguenza, erano strenui sostenitori dello “spontaneismo armato”, rifiutando invece il centralismo di Lenin, privilegiato dall’organizzazione centrale. 67
LUIGI CARLI
Altri testi amati dai genovesi erano quelli che teorizzavano la guerriglia urbana, come Carlos Marighella. E, pur adeguandosi ai principi operativi dettati dal Comitato esecutivo centrale nelle varie “risoluzioni strategiche” ed attuando le varie “campagne” che realizzavano la “propaganda armata”, i brigatisti genovesi privilegiarono senza esitazione le azioni di fuoco. Furono, dunque, portati a termine numerosissime “invalidazioni” e diversi “annientamenti”, intimidendo e “gambizzando” gli esponenti della Dc locale, i “berlingueriani” del Pci ed i quadri di fabbrica ed uccidendo senza pietà i poliziotti dell’antiterrorismo ed i Carabinieri, che consideravano in particolare responsabili del “massacro” di via Fracchia. Furono compiuti in tal senso, dopo l’efferata uccisione del vice-questore Antonio Esposito su un autobus che lo portava in ufficio, gli eccidi dei Carabinieri di Sampierdarena e di Albaro. Senza contare che la “colonna” genovese e taluni che aspiravano ad entrarvi, come Garigliano, stavano preparando attentati dinamitardi contro diverse caserme dell’Arma. Né va trascurato che, prima del loro definitivo smantellamento, le Br genovesi si stavano apprestando ad uccidere l’industriale del petrolio Riccardo Garrone con un attentato dinamitardo. Una domanda specifica. Avete mai avuto notizie del servizio di intelligence – chiamiamolo così – che iniziò a svolgere il Pci contro il terrorismo? A quanto pare Rossa era un elemento di questo apparato, lo racconta2 la figlia nel libro e lo conferma Lovrano Bisso. Carli - Innanzitutto, su un compito del genere svolto da Guido Rossa, personalmente – come ho detto – non so nulla. Né mai me ne parlarono i miei “pentiti” che, peraltro, entrarono a far parte delle Br solo dopo la sua uccisione. Né fatti del genere emersero dalle mie indagini. So solo, invece, per averlo constatato dagli atti e parlando con qualcuno degli inquirenti, che esisteva una rete informativa al servizio dell’Arma e del generale Dalla Chiesa in particolare, composta da “sorveglianti” in servizio nelle grandi fabbriche genovesi i quali, peraltro, erano in gran parte proprio ex appartenenti proprio all’Arma dei Carabinieri. Incontrai, fra questi, ad esempio, il maresciallo Mu2
Si tratta del libro-intervista Guido Rossa, mio padre di Giovanni Fasanella e Sabina Rossa, BUR, Milano 2006.
68
La colonna genovese delle Brigate rosse
molo che, dimessosi in un primo tempo dall’Arma per fare il sorvegliante – mi pare all’Italsider – rientrò poi in servizio. E mi sembra di ricordare che pure altri sorveglianti abbiano fatto come lui. Non mi risulta, invece, che tale struttura e questi asseriti “interscambi” informativi abbiano prodotto grandi risultati, almeno sotto l’aspetto delle indagini. Ne è dimostrazione il fatto che, quando avvenne l’eccidio di Albaro, si attendeva con ansia che il colonnello dell’Esercito, Ramundo, rimasto per fortuna solo ferito, potesse fornire informazioni sugli attentatori, essendo gli inquirenti completamente all’oscuro su movente, attentatori e modalità dell’eccidio. E, quando furono uccisi e disarmati a Sampierdarena i componenti di una pattuglia – ancora di Carabinieri – non si riuscì a chiarire nulla in proposito, fin quando non intervennero le confessioni dei “pentiti” e, in ispecie, di Caterina Picasso – prestanome del “covo” di via Zella a Genova-Rivarolo – in cui, subito dopo il fatto, si rifugiarono gli autori dell’omicidio, recando con sé le armi sottratte agli uccisi. Mi pare significativo in proposito, inoltre, che i vari componenti della “brigata” Italsider – tutti arrestati e, poi, tutti “pentiti” – furono identificati proprio da me e dalla Digos genovese, sulla base esclusiva delle indicazioni forniteci dagli altri componenti della “colonna” genovese, allorché decisero di collaborare. Non ho mai ricevuto, almeno per quanto mi riguarda, informazioni provenienti da presunte intelligence, interne od esterne alla fabbrica. Di esse non ho mai appurato, almeno giudizialmente, neppure l’esistenza. Si ebbero in giudizio, per amor del vero, testimonianze provenienti da operai delle grandi fabbriche genovesi. Ma queste furono acquisite solo “ex post”, alla fine delle indagini e dopo lo smantellamento della “brigata” Italsider. Il giornalista Giovanni Fasanella afferma che quando lavorava per «l’Unità», a Torino, poteva disporre di una vasta schedatura di persone fatta dal Pci. Carli - Presumo sia vero. Sono stato compagno d’università ed amico di Roberto Speciale, da sempre membro del Pci genovese, e da lui appresi che il partito aveva effettivamente compiuto un’estesa indagine sulla situazione del terrorismo nelle fabbriche. Ma, per quanto riguarda le vicende dell’uccisione di Guido Rossa e di una sua presunta attività di 69
LUIGI CARLI
informatore non posso dire nulla più di quanto ho già più volte precisato. D’altronde, ho già detto e ripetuto che cominciai ad occuparmi delle Brigate rosse solo dal 1979 e, quanto avvenuto prima, in realtà non interessava le indagini che stavo conducendo. Si trattò, come tutti sanno, di indagini fortunate, che portarono allo smantellamento delle Brigate rosse genovesi, all’individuazione di tutti i componenti della “colonna” e alla loro condanna. Ma si trattava, alla fin fine, solo di indagini, e non di una ricerca storica. Né può trascurarsi che i fatti antecedenti al 1979 erano già stati oggetto di procedimento e, da noi, vige il principio del ne bis in idem, per cui non si può essere inquisiti due volte per gli stessi fatti. Comunque sia, l’inchiesta che condussi fu agevolata da diversi fattori positivi. In antecedenza impensabili. In primo luogo, non può nascondersi che la vicenda di via Fracchia ebbe un impatto psicologico formidabile sul sostrato eversivo presente in questa città, vocato, come ho detto, soprattutto all’intellettualismo ed al militarismo. Nonostante la conclamata volontà di rivincita che, effettivamente per un breve periodo animò la “colonna” genovese, i risultati dello scontro di via Fracchia furono sempre ed inevitabilmente interpretati dalle Br come una grave sconfitta militare. Con la sconsolante sensazione di aver perso in tal modo quell’aura di imbattibilità che fino ad allora credevano aleggiasse su di esse. Inoltre, i “militaristi” che preparavano fin nei minimi dettagli le cosiddetta “azioni di fuoco” giocando soprattutto sulla sorpresa, preoccupandosi solo di come “invalidare” o “annientare” le vittime, si resero finalmente conto che – nella lotta armata – i caduti potevano esserci da entrambe le parti e che anche i cosiddetti “combattenti del popolo”, oltre che finire in prigione, potevano morire. E ciò li fece riflettere. Il secondo fattore fu quello dell’impossibilità di qualsiasi contatto tra chi si trovava in carcere e l’organizzazione esterna, a seguito della scomparsa dell’avvocato Arnaldi. Chi era finito in carcere, prima o poi si accorgeva, infatti, di essere rimasto solo e con in più la prospettiva di subire pesanti condanne ed una lunga detenzione. L’unica via d’uscita per gente che, peraltro, era per lo più molto giovane fu, a questo punto, quella di appigliarsi alla cosiddetta “legge sui pentiti” che assicurava forti sconti di pena per chi collaborasse con gli inquirenti. Altro fattore, insieme psicologico e di valore giudiziario, fu l’isolamento morale in cui caddero le Brigate rosse in seguito all’uccisione 70
La colonna genovese delle Brigate rosse
di Guido Rossa. Dopo la netta posizione di rifiuto del terrorismo assunta dal Pci cessò di colpo, infatti, ogni simpatia per la lotta armata ed i suoi adepti, e la classe operaia si schierò apertamente e recisamente contro le Brigate rosse. Cosicché esse si trovarono inaspettatamente contro lo stesso elemento per cui asserivano di “lavorare”. Lo sconforto ed il senso di frustrazione che ne seguirono furono totali, soprattutto per chi si trovava in carcere. Tanto da indurlo a “rifluire nel privato” ed a pensare al proprio “particolare”, accogliendo la mano che gli veniva tesa dalla “legge dei pentiti”. L’accettarono quasi tutti, perseguendo i vantaggi che questa offriva ove avessero collaborato con gli inquirenti. Ma vi furono anche pentimenti, oltre che sinceri, totalmente disinteressati, come ad esempio, quello di Fulvia Miglietta. Già “regolare” e “clandestina”, coinvolta in prima persona nelle più rilevanti azioni della “colonna” genovese (e non solo), si rese conto di quanto male aveva fatto e di quanto sangue aveva contribuito a versare. E si pentì davvero. Fu così che, soprattutto grazie ai “pentiti”, ma anche ad un’abile condotta investigativa, non solo vennero identificati ed arrestati quasi tutti i componenti della “colonna” genovese (sfuggì alla cattura solo qualche “clandestino”), ma fu possibile il recupero di tutto il materiale bellico in dotazione di quel Fronte logistico. Sotto l’aspetto giudiziario, fu conseguentemente possibile procedere alla ricostruzione di tutti gli episodi criminosi ed all’individuazione dei vari colpevoli. Anche di azioni passate. Mi piace altresì ricordare che, proprio grazie ai “pentiti” ed all’abilità degli inquirenti genovesi fu possibile scoprire anche il “covo” della “colonna” romana gestito, sul litorale laziale, da certa Ave Maria Petricola. Con questo fatto si posero le basi anche per l’identificazione e la cattura di molti brigatisti romani. Grazie ai “pentiti” genovesi fu possibile, inoltre, sventare un feroce attentato che i (pochi) superstiti della “colonna”, precariamente ancora in libertà, intendevano perpetrare ai danni dell’industriale genovese Riccardo Garrone. Attentato dapprima pensato da svolgere in modo analogo a quello ai danni di Carrero Blanco3, ed abbandonato solo perché la zona do3
Carrero Blanco era un militare ed un politico spagnolo, tra i principali collaboratori di Francisco Franco. Il 20 dicembre 1973 subì un attentato ad opera dell’Eta. L’auto su cui viaggiava venne fatta saltare in aria da un ordigno collocato in un tombino sotto la sede stradale. Blanco morì in seguito alle ferite riportate.
71
LUIGI CARLI
ve abitava la vittima designata non aveva tombini idonei a celare esplosivo. Successivamente, secondo le intenzioni, l’azione avrebbe dovuto attuarsi facendo sparare migliaia di biglie di acciaio contro l’auto di cui l’industriale si serviva, da un rudimentale cannone occultato su un motocarro e comandato a distanza. Per sua e nostra fortuna, l’arresto di chi doveva compiere tale efferata azione ed il sequestro, in via Zella, delle biglie e dei pezzi del cannone, impedirono ad altri di attuare il crimine. L’ultima azione imputabile alla “colonna” genovese, ormai costituita solo da un paio di “irregolari” e da una “clandestina” proveniente da Roma, cioè di Barbara Balzerani (tutti catturati poco dopo), fu la tentata “gambizzazione” di un sindacalista, mi pare dell’Italsider. Fortunatamente, “Sara” non era una grande tiratrice ed il sindacalista riuscì a salvarsi rinchiudendosi in un garage, dopo che le pallottole sparategli contro gli avevano portato via solo il tacco di una scarpa. Roberto della Rocca, nell’intervista resa da Sabina Rossa a Giovanni Fasanella, afferma: «le Br al porto erano così forti che si era addirittura formata una squadra di calcio composta da brigatisti e simpatizzanti». A Lei quindi non risulta… Carli - Direi di no. In tutta la sua storia, la “brigata Porto”, tra “irregolari” e “contatti” (non fece parte del suo organico, a quanto mi risulta, un “regolare”) non superò mai il numero di quattro persone, così come mi disse Angela Scozzafava, che ne era a capo. Né posso dubitare della lealtà e della sincerità della ragazza, che era peraltro figlia di un ex commesso, ben conosciuto, del palazzo di giustizia di Genova e che, dopo aver saldato il proprio debito con la giustizia, convolò felicemente a nozze con un maresciallo dei Carabinieri di cui si era innamorata proprio durante le indagini. A quanto ne so, fu un episodio isolato tra le ex-brigatiste. Quanto alle evasioni ludico-sportive dei componenti della “colonna” genovese, non sono al corrente di squadre di calcio. Mi venne detto, però, da vari ex componenti della medesima come, alla faccia dei principi di compartimentazione, quasi tutti si ritrovavano sovente – riconoscendosi – a ballare presso il circolo Soms di Genova-Quarto. E, d’estate, l’organizzazione affittava pure vari appartamenti al mare, in particolare a Recco, Chiavari e Varazze. 72
La colonna genovese delle Brigate Rosse
In essi si riunivano per ristorarsi, oltre a qualcuno degli “irregolari” e, ovviamente, al “prestanome”, soprattutto i “clandestini”. Tutto ciò fece molto irritare Caterina Picasso. Essendo una donna d’età ed abituata a benaltro, riteneva tali svaghi inutili frivolezze. Fu proprio lei ad indicarmi quali erano stati due degli alloggi utilizzati all’uopo dalle Br, e che – grazie ancora a lei – riuscimmo ad individuare perfettamente. Quindi il fatto che la colonna di Genova fosse imprendibile, fortissima ecc. sono tutte cose non vere? Carli - Era sicuramente fortissima ed imprendibile soprattutto all’inizio, quando non si sapeva a Genova cosa fossero le Br e neppure come affrontarle. Eppure, esse uccidevano, “gambizzavano” ed incendiavano impunemente. Nessuno di noi magistrati, ma anche le forze dell’ordine a quanto constatai, aveva all’origine grandi idee su come individuarne i componenti e perseguirli, in ispecie sul piano giudiziario. Il principio di “compartimentazione”, allora, applicato severamente, faceva il resto. Calando un velo di assoluta impenetrabilità sull’organizzazione, le azioni poste in essere ed i partecipi alle medesime. Le Br erano, all’inizio – bisogna riconoscerlo – una realtà criminale inattaccabile dall’esterno. E, per di più, con i mezzi ed i sistemi giudiziari. D’altra parte, era difficile immaginare, e soprattutto provare in giudizio, che un ragazzo o una ragazza, i quali conducevano una vita apparentemente normale ed alla luce del sole fossero, in realtà, degli “irregolari” delle Brigate rosse. Dei “regolari”, che vivevano in clandestinità e dovevano restare nell’anonimato finché non fossero venuti a contatto con le forze dell’ordine, nel qual caso dovevano usare le armi e dileguarsi, non sapevamo assolutamente niente al di là dell’eventuale nome di battaglia. L’impreparazione di tutti sfociava – almeno fino al rapimento dell’onorevole Moro – anche nel difetto di una qualsiasi protezione fisica nei confronti dei magistrati che si occupavano di terrorismo. Tanto è vero che taluni di noi – me compreso – dopo il raccapricciante attentato al collega Giacumbi, che era stato ucciso dai brigatisti sotto gli occhi della moglie e dopo che gli attentatori avevano avuto modo di riattivare più volte le armi inceppatesi, pensammo di difenderci da soli. 73
LUIGI CARLI
Comprando, a fini di protezione personale, pistole a rotazione. Ossia, pistole che non s’inceppano mai. Successivamente comunque, quando fummo finalmente protetti ed imparammo – lavorando nel modo accennato – a trattare i brigatisti, le cose andarono assai diversamente. Fu davvero una sorpresa constatare che tre quarti dei componenti della “colonna” genovese era costituita non da operai “incazzati” come pensavamo, ma da giovani studenti e da rampolli della borghesia “albarina”4. E taluno, come Fulvia Miglietta, addirittura proveniente da circoli cattolici. Si trattava, comunque – come constatai personalmente – di soggetti in genere assai fragili dal punto di vista psicologico. Facili ad entusiasmarsi e ad illudersi quando erano sulla cresta dell’onda ma, altrettanto inclini a deprimersi quando finirono in carcere, percependo la sconfitta. Rendendosi così conto che l’utopia, per quanto affascinante e purtroppo macchiata di sangue, quando faceva i conti con la realtà, era destinata inevitabilmente a soccombere. La vicenda della Miglietta ci permette di tornare su alcune caratteristiche delle Br. Vuole chiarirci il ruolo, all’interno della colonna genovese, degli irregolari e dei regolari? Carli - Gli “irregolari” ed i “regolari” erano, ripeto, la struttura portante della “colonna” genovese come di tutta l’organizzazione delle Brigate rosse. I primi, vivendo una vita pubblica ed apparentemente normale, assicuravano all’organizzazione una sorta di osmosi con la realtà esterna. Il loro compito era analogo, sotto l’aspetto operativo, a quello dei “sottufficiali” di qualsiasi organizzazione militare. Si occupavano, infatti, dei “contatti”, ossia dei simpatizzanti, provenienti dagli ambienti vicini all’eversione, rivelandosi loro come brigatisti solo quando li ritenevano ormai – dopo attenta e prolungata valutazione – pronti ed idonei ad entrare in “Ditta”. Essi costituivano il nucleo delle varie “brigate” in cui si articolava la “colonna” e, dopo aver dato buona prova di sé nelle azioni di fuoco, potevano anche ascendere al ruolo di dirigenti delle medesime e dei “fronti” in cui si raggruppavano le “brigate”. 4
Albaro è, notoriamente, il quartiere “bene” di Genova.
74
La colonna genovese delle Brigate rosse
Tenga conto che, se lo volevano e venivano giudicati idonei dal Comitato Esecutivo Centrale, potevano pure passare in clandestinità, divenendo dei “regolari”. Può essere più preciso su questi ultimi? Carli - I “regolari” erano coloro che avevano accettato di dedicarsi pienamente alla lotta armata, prestato una sorta di voto rivoluzionario che implicava la “rinuncia al mondo”, all’identità personale ed agli affetti di ogni genere. Come gli “irregolari” avevano un nome di battaglia (o di copertura) ma, a differenza dei primi, dovevano girare sempre armati ed essere pronti in ogni momento ad affrontare azioni di fuoco. Essi rappresentavo, inoltre, l’élite dell’organizzazione delle Br e solo loro potevano ascendere ai vertici nazionali. Inoltre, nei loro confronti non valeva la “compartimentazione”. Non solo conoscevano il nome di tutti gli adepti dell’organizzazione e potevano liberamente contattarli, ma erano sempre al corrente di come fosse strutturata l’organizzazione stessa, tanto rispetto alle singole “colonne” locali quanto al centro. Quali vertici di “colonna” (a loro ne competeva la direzione) e componenti del Comitato esecutivo centrale, elaboravano ed attuavano poi i piani operativi della “campagna” predisposta e “lanciata” dall’Esecutivo o dalla Direzione strategica, di cui facevano pure parte. Nello specifico, essi approvavano e selezionavano in base a criteri politico-militare gli obbiettivi da colpire e gli uomini che dovevano farlo, partecipando di persona agli “annientamenti”, mentre le semplici “invalidazioni” potevano essere anche totalmente affidate agli “irregolari”. Essendo fortemente indottrinati ed addestrati alla lotta armata, i “regolari” finiti in carcere furono gli ultimi ad accettare di collaborare alle indagini. Ma lo fecero alla fine anche loro. E così accadde, ad esempio per Fulvia Miglietta, che era passata in clandestinità fin quasi dall’inizio della propria militanza nelle Br ed aveva partecipato e diretto molteplici azioni. Essa fu arrestata dalla Polfer di Sestri Levante perché, individuata dai poliziotti in base alle indicazioni somatiche fornite dalla “nonna delle Br”, che la conosceva benissimo e non l’amava, non reagì sparando, come avrebbe dovuto. Prevalse in lei, infatti, l’educazione cattolica in cui era cresciuta e che, successivamente all’abbandono della lotta armata, la portò in convento ed alla manifestazione di quel sincero pentimento di cui ho già detto. 75
IL PCI E LE BRIGATE ROSSE Roberto Bartali
Al centro di questo saggio è la reazione del Pci, ed in modo specifico dell’allora segretario Enrico Berlinguer, di fronte alla comparsa del terrorismo ‘di sinistra’, con particolare riferimento alla principale formazione per numero e livello delle azioni criminose poste in essere nel corso dei cosiddetti “anni di piombo”: le Brigate rosse. Il lavoro si è reso necessario in quanto la saggistica sul tema giunge (come si avrà modo di argomentare) a conclusioni parziali e non del tutto rispettose dei fatti. Da essa emerge, infatti, come la leadership di via delle Botteghe Oscure iniziò a combattere con fermezza il terrorismo, e più in generale il fenomeno eversivo, a partire dalla seconda metà degli anni ’70 allorché, come ha scritto Ermanno Taviani, «all’interno del partito era andata affermandosi una linea volta ad una netta e rigorosa presa di distanza da tutte le forme di “estremismo” che si ponevano alla sinistra del partito»1. Inoltre il tema non è mai stato affrontato in modo esaustivo poiché, nella maggior parte dei casi, ci si è limitati allo studio dei quotidiani del tempo o delle dichiarazioni ufficiali del Pci2.
1
E. TAVIANI, Pci, estremismo di sinistra e terrorismo, in L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, a cura di G. De Rosa e G. Monina, vol. IV, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 235-275. La tesi è stata successivamente ripresa anche in M. TOLOMELLI, Italia anni ’70: nemico di Stato vs Stato nemico, «Storicamente», 1 (2005), http://www.storicamente.org/1Tolomelli.htm. 2 Si veda tra gli altri: G. GALLI, Storia del partito armato 1968-1982, Rizzoli, Milano 1986; A. BALDONI e S. PROVVISIONATO, La notte più lunga della Repubblica. Sinistra e destra, ideologie, estremismi, lotta armata, 1968-1989, Ed. Serarcangeli, Roma 1989; R. LUMLEY, Dal ’68 agli anni di piombo, Giunti, Firenze 1998; S. ZAVOLI, La notte della Repubblica, Mondadori, Milano 1995.
77
ROBERTO BARTALI
Nel campo delle pubblicazioni, felici eccezioni sono – a mio avviso – il lavoro scritto da Giovanni Fasanella di concerto con Alberto Franceschini3, e quello pubblicato dal giornalista Paolo Pergolizzi sull’origine delle Br reggiane4. Al contrario dei precedenti, con essi si è per la prima volta cercato di andare realmente in profondità sull’argomento, aprendo in un certo senso la strada, lo confesso, a questo saggio. A tutto ciò va aggiunta una doverosa premessa che è in parte un tentativo di spiegazione per i risultati cui sono pervenuti finora gli studi storici sul terrorismo. Se corrisponde al vero il fatto che non è mai facile conoscere e capire fino in fondo i singoli partiti politici, ebbene questo è ancora più arduo e tortuoso nel caso del Pci. Si potrebbe perfino parlare della necessità di uno studio di semiotica-comunista, tanto era complesso, astruso, il linguaggio dei comunisti nostrani. Il modo di comunicare adottato dai dirigenti verso l’esterno del partito, verso il proprio interno, verso i propri militanti e perfino nei confronti della cosiddetta nomenklatura, era spesso segnato da assenze, da semplici ma significativi silenzi, da note a prima vista trascurabili che emergevano in articoli o trafiletti nella stampa di partito magari a distanza di mesi, o addirittura anni, rispetto alla decisione presa dalla leadership. In alcuni casi una “svolta” si poteva palesare perfino con la banale assenza di un dirigente ad un congresso o nel mancato ricorso ad un argomento in un discorso di chiusura del segretario generale. In più, a differenza del partito comunista francese, tanto per portare un esempio vicino (almeno geograficamente), esistevano differenze anche nella comunicazione tra e verso le singole federazioni. Ecco perché capire con precisione il momento di una svolta, o l’esatta datazione dell’inizio di un processo (anche importante come la “risposta” alla sfida delle Brigate rosse) risulta realmente complicato. Ecco perché studiare unicamente le pubblicazioni del Pci – «l’Unità», «Rinascita» o «Vie Nuove», tanto per citare le più note – può talvolta trarre in inganno. Ed ecco, infine, perché trattando l’argomento terrorismo si potrebbe essere facilmente depistati se ci si affidasse unicamente alla lettura degli articoli di giornale per ricercare il momento esatto in cui la 3
G. FASANELLA e A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le Br. Le radici, la nascita, la storia, il presente, BUR, Milano 2004. 4 P. PERGOLIZZI, L’appartamento. Br: dal Pci alla lotta armata, Aliberti, Reggio Emilia 2006.
78
Il Pci e le Brigate rosse
dirigenza del Pci, e specificamente il suo segretario generale Enrico Berlinguer, iniziò a combatterlo con tutto l’impegno ed i mezzi di cui disponeva, e soprattutto a considerarlo per quello che era realmente, soprattutto in quel momento storico: terrorismo “di sinistra”, diretta emanazione di una seppur assai minoritaria area culturale del partito, inquadrabile in quello che Rossana Rossanda definì successivamente come l’album di famiglia5. È storicamente vero che la stragrande maggioranza dei militanti del Partito comunista attribuì al terrorismo brigatista un ruolo del tutto funzionale rispetto a determinati interessi reazionari operanti all’interno del paese e alla cosiddetta strategia della tensione. Non mi pare, tuttavia, si possa negare che i vertici del Pci avevano parallelamente maturato convinzioni sensibilmente differenti. Specialmente nel periodo successivo alla comparsa del fenomeno, agirono in questa direzione, anche se in modo “riservato”. L’accesso alla documentazione delle commissioni parlamentari d’inchiesta “Stragi” e “Mitrokhin” (purtroppo decisamente centellinato) e dell’archivio della Fondazione Gramsci, ha permesso di studiare più precisamente la reazione del Pci, ed in modo specifico l’azione di contrasto posta in essere – in modo serio ma discreto – da Enrico Berlinguer, di fronte allo sviluppo del brigatismo rosso. Ma è stato soprattutto l’ausilio di alcune importanti testimonianze dirette ad aver permesso una sorta di salto di qualità alla ricostruzione storiografica6.
5
Il riferimento è all’articolo apparso su «il manifesto» del 2 aprile 1978. Come avrò modo di esporre, la novità fondamentale è rappresentata da un rapporto di collaborazione, sorto sul finire del 1973 nella forma di un vero e proprio gentleman agreement tra il generale dell’Arma dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa ed il segretario del Pci Enrico Berlinguer, con il fondamentale tramite di Ugo Pecchioli. Di tale unità di intenti non è rimasta traccia documentale in forma scritta perché l’intesa fu conclusa verbalmente ed in modo assolutamente riservato. Fortunatamente è sopravvissuta nei ricordi di chi con essi ebbe stretti rapporti di lavoro, ma non solo. Si vedano a questo riguardo, oltre alle testimonianze raccolte dall’autore, anche: U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità. Storia di una democrazia incompiuta, a cura di G. Cipriani, Baldini & Castoldi, Milano 1995 e M. RUGGIERO, Nei secoli fedele allo Stato. L’Arma, i piduisti, i golpisti, i brigatisti, le coperture eccellenti, gli anni di piombo nel racconto del generale Nicolò Bozzo, Fratelli Frilli Editori, Genova 2006. 6
79
ROBERTO BARTALI
Il lettore si accorgerà come, partendo dallo studio del problema che dà il titolo al saggio, il quadro venga man mano a dilatarsi ad altre questioni. Pur non essendo ad esso strettamente connesse, si sono rivelate meritevoli di una specifica trattazione. Ma è però attraverso una lettura “dall’alto” dell’insieme, del singolo argomento e del “tutto”, che si può ottenere una prospettiva storiografica sufficientemente persuasiva. Dalla lettura dei documenti, e dal confronto di questi con le testimonianze, emerge chiaramente come l’allora segretario comunista Berlinguer, subito dopo il suo ritorno in Italia dalla Bulgaria (dove, nel 1973, era stato con ogni probabilità vittima di un attentato) perse evidentemente ogni dubbio sull’origine ed il significato di certi avvenimenti accaduti a partire dal 1969. Il giudizio maturato su che cosa si nascondesse realmente dietro le Br, lo indussero quindi a prendere una serie di “contromosse” volte a contrastarle su vari piani e livelli. È così che nel giro di pochi mesi, ed a partire proprio dalla fine del 1973, si riscontrano numerosi provvedimenti, da parte del Pci, nei confronti del nascente fenomeno brigatista. Si tratta di una novità importante anche da un punto di vista metodologico: a livello “ufficiale”, infatti, la posizione di via delle Botteghe Oscure nei confronti delle Br venne delineata fin dalla loro apparizione in modo chiarissimo ed inequivocabile: «non esistono avversari a sinistra»7. È vero che tale principio si era affermato durante e dopo il Sessantotto, ma il tiro fu soltanto leggermente spostato dopo il sequestro di Bruno Labate (12 febbraio 1973), segretario provinciale della Cisnal di Torino, quando l’azione terrorista venne presentata dell’organo ufficiale del Pci come una «Grave provocazione nel quadro della strategia della tensione»8.
Secondo il giornale, risultava … evidente il tentativo di gettare discredito sulle lotte dei lavoratori. I volantini di tipo programmatico lasciati intorno all’incatenato Bruno La7
R. MAZZETTI, Genesi e sviluppo del terrorismo in Italia: il maggio troppo lungo, Ed. Armando, Roma 1979, p. 133. 8 «l’Unità», 13 febbraio 1973.
80
Il Pci e le Brigate rosse
bate sembrano messi apposta per far pubblicità al sindacato fascista, al quale vengono addirittura attribuiti dodicimila aderenti alla sola FIAT 9.
Le Brigate rosse, in poche parole, erano “nere”, ed erano parte integrante di quella strategia della tensione che era stata posta in essere da forze oscure ed antidemocratiche a partire dal dicembre 1969. Nei loro confronti, però, il comportamento fu inizialmente piuttosto ambiguo, o per lo meno, non perfettamente definito. Come ha affermato Alberto Franceschini: Pubblicamente, su l’Unità e sui giornali amici, ci faceva bollare come provocatori legati ai servizi segreti, venivamo chiamate le “fantomatiche Brigate Rosse, rosse di nome e nere di fatto”. Il Partito comunista sapeva però bene chi eravamo, sapeva che la maggioranza di noi proveniva dalle sue file e che alcuni, con la tessera in tasca, frequentavano ancora le sezioni. Era informato ma non collaborava con la polizia e carabinieri, si limitava a dar di noi un’immagine misteriosa e torbida per allontanare da noi la gente e gli operai […] Era sufficiente crearci il vuoto intorno […] a Reggio Emilia sapevano che io e gli altri eravamo nelle Br anche se nessuno lo ammetteva ufficialmente. Così io potevo tornarmene nella mia città per la Festa dell’Unità e mangiare tranquillamente ai tavoli con i compagni di pochi anni prima…10.
Dopo il sequestro di Ettore Amerio (dicembre 1973), che venne salutato da «l’Unità» come una ennesima «provocazione nel pieno della lotta contrattuale dei metalmeccanici»11, la situazione cominciò invece a mutare sensibilmente. A partire da questo momento l’atteggiamento del Pci nei confronti delle Br inizierà a tradursi nell’adozione di provvedimenti, anche se in modo ufficioso e solamente dal punto di vista “pratico”. Sui giornali, invece, almeno fino al sequestro Sossi, le Brigate rosse continuarono ad essere bollate come “nere”12. 9
Ibidem. A. FRANCESCHINI, Mara, Renato e io, Mondadori, Milano 1988, p. 80. 11 «l’Unità», 11 dicembre 1973. 12 Dopo la liberazione del magistrato genovese, avvenuta il 23 maggio 1974, non fu però più possibile sostenere presso il grande pubblico la tesi della “provocazione fascista”, ed il Pci si vide costretto a prendere atto, ufficialmente, di avere un “nemico” praticamente in casa, scegliendo una posizione di assoluta intransigenza nei loro confronti. 10
81
ROBERTO BARTALI
Perfino lo stesso Franceschini notò che «improvvisamente», e da un preciso punto in avanti, il Pci mutò linea di condotta nei loro confronti. Non tanto sui media, quanto piuttosto a livello che potremmo definire “riservato”. Come ha raccontato nel suo primo libro di memorie: «Il partito comunista ci cercò dopo il sequestro di Ettore Amerio»13. Fu lì, in quel preciso momento, che ebbe inizio il cambiamento di rotta. L’Apparato comunista contro le Br Il partito di Berlinguer usò dapprima quelle che possono essere definite come buone maniere: i giovani brigatisti nati e cresciuti all’interno delle organizzazioni giovanili del Pci furono contattati ed invitati ad abbandonare le Br con il tramite di persone “vicine” e di fidati compagni, quali il senatore Alberto Malagugini (noto penalista e «uomo dell’apparato segreto del partito», come lo definisce Valerio Riva)14 ed il giudice istruttore di Milano, Ciro De Vincenzo. Di notevole importanza a questo proposito sono di nuovo le parole di Franceschini, il quale entra maggiormente nel dettaglio: Franceschini - Si mosse l’avvocato Alberto Malagugini, allora responsabile nazionale del settore “problemi dello Stato” del Pci, e che si diceva fosse molto legato all’Urss… Il suocero di Berio? Franceschini - Sì. Contattò me e Piero Morlacchi, che venivamo entrambi dal Pci, e ci fece questo discorso: guardate che per voi si stanno preparando tempi duri, se vi consegnate al giudice istruttore milanese Ciro De Vincenzo, che è un nostro amico, vi garantisco che ne uscirete puliti e ve ne tornerete a casa15. 13
A. FRANCESCHINI, Mara, Renato e io, cit., p. 78. V. RIVA, Oro da Mosca, Mondadori, Milano 1999, p. 228. 15 Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (d’ora in avanti CpS), audizione di Alberto Franceschini, 17 marzo 1999, XIII Legislatura, 50º resoconto stenografico. I resoconti stenografici delle sedute della “Commissione Stragi” (1988-2001), qui citati, si possono consultare nel sito internet del Senato della Repubblica: http://www. archivioinchieste. senato.it/ html/ consultazione.htm. Una 14
82
Il Pci e le Brigate rosse
Che Malagugini tenesse sotto controllo le attività delle nascenti Br è stato poi confermato anche dal dottor Antonino Allegra, che in quel periodo era a capo dell’Ufficio politico della questura di Milano, durante la sua audizione di fronte alla “Commissione Stragi” allora presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino: Allegra - L’onorevole Malagugini, quando succedeva qualcosa, non so se lo facesse a titolo personale o fosse il partito ad incaricarlo, veniva a prendere contatti con noi, anche se va detto che Malagugini era quello sempre in giro16. Dunque, stando alla testimonianza di Franceschini ed alla indiretta conferma di Allegra, il primo contatto, realizzato tramite un importante intermediario, tra vertice del Pci ed i brigatisti cresciuti all’interno del partito avvenne nel 1973, ed aveva un senso, un “sapore” (se così mi è consentito definirlo) che era ai limiti del paternalistico. Quel messaggio recapitato era infatti di questo tenore: «fermatevi subito, prima di commettere reati più seri ed efferati, ed il partito penserà a trovare una via di uscita il più possibile indolore per voi, altrimenti saranno guai seri». L’obiettivo era duplice. Per un verso di recuperare quei giovani che erano fuoriusciti dal partito, e per l’altro di non far emergere neanche lontanamente l’idea di un collegamento tra comunisti e terroristi. Il pericolo maggiore per il Pci in quel momento era probabilmente legato al fatto che – anche a livello di opinione pubblica – si potessero associare i giovani terroristi con il partito, mandando così all’aria l’immagine di difensore della democrazia, di vero “paladino della costituzione”, che Botteghe Oscure nel corso dei decenni precedenti aveva faticosamente cercato di costruire. Alberto Franceschini è perfino più specifico, e soprattutto si spinge fino a rivelare un particolare molto significativo: De Vincenzo era, come si diceva allora, un simpatizzante, un compagno. Ed eravamo convinti che ci stesse proteggendo, che si limitasse a fare contro di noi il minimo indispensabile per far salvare la faccia […] con De Vincenzo avevamo stabilito un rapporto particolare […] a lui piaceva versione in formato htm degli stenografici della XIII Legislatura (1996-2001) si può consultare nel sito del Parlamento italiano: http://www.parlamento.it/bicam/terror/home.htm. 16 CpS, audizione di Antonino Allegra, 5 luglio 2000, XIII Legislatura, 73º resoconto stenografico.
83
ROBERTO BARTALI
andare in barca e, nell’estate 1973, invitò me e Renato [Curcio, nda] nel sud Italia17.
Un giudice istruttore, in poche parole, invitò due giovani terroristi (già nell’elenco dei ricercati per fatti gravi come il sequestro di Idalgo Macchiarini) a fare una gita nella propria imbarcazione. Il fatto, che di per sé è di inaudita gravità a livello giudiziario, conferma però la linea di condotta intrapresa dal Pci per cercare in qualche modo di recuperare dalle Br i propri “figli degeneri” prima che si macchiassero di reati più gravi. Nell’ambiente dei carabinieri, però, sospetti sul fatto che Ciro De Vincenzo fosse una sorta di quinta colonna dei terroristi all’interno della magistratura circolavano da tempo. È di nuovo Allegra a parlarne in modo sprezzante durante la sua audizione, tanto da giungere ad affermare che certe scelte fatte dal magistrato durante le indagini sulle Br sembrarono decisamente fuori luogo: … una disinformazione colpevole, stupida e talvolta non so se anche per mala fede o per ignoranza. Tutto ciò ha avuto la sua influenza […] anche la stasi che si è verificata, secondo me, è stata gravissima dal punto di vista degli effetti che ha prodotto18.
Altre testimonianze, anche indirette, confermano questo canale preferenziale tra le Br e De Vincenzo. Ecco ad esempio le parole di Silvano Girotto, alias “Frate mitra” – l’infiltrato per conto dei Carabinieri che nel 1974 riuscì a far arrestare il duo Franceschini-Curcio a Pinerolo – durante la sua audizione di fronte alla “Commissione Stragi”: È vero che Lazagna19 le confida che il partito armato ha parecchi amici anche fra i magistrati e le parla di Ciro De Vincenzo, che era allora il giudice istruttore di Milano che seguiva le indagini sulle Brigate rosse? 17
G. FASANELLA e A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le Br, cit., pp. 89-117. CpS, audizione di Antonino Allegra, 5 luglio 2000, cit. 19 L’avvocato Giovanbattista Lazagna nacque a Genova il 5 dicembre 1923, iscritto al Pci nel 1942 ne uscì nel 1972. Comandante partigiano, decorato medaglia d’argento al valor militare per meriti durante la Resistenza, venne arrestato la prima volta il 22 marzo 1972 nell’ambito delle indagini sulla morte di Feltrinelli e quindi coinvolto nel 1974 nell’inchiesta che scaturì dall’arresto a Pinerolo (8 settembre 1974) di Renato Curcio e di Alberto Franceschini. 18
84
Il Pci e le Brigate rosse
Girotto - … Il nome di quel magistrato viene fuori da Levati, il quale dice: è un compagno20. In un appunto trasmesso all’Ufficio D del Sid datato 26 maggio 1974 ed inerente le indagini sul rapimento del giudice Sossi si andava anche oltre, affermando che: … nei 25 giorni [del rapimento, nda] Lazagna è andato frequentemente da De Vincenzo e si è interessato alle indagini […] De Vincenzo, da parte sua, sta “camminando sul filo del rasoio” relativamente alle indagini di sua competenza sulle Brigate Rosse. Indubbiamente ha fatto delle indagini, ma molte altre non le ha fatte e tante prove le ha fatte sparire21.
Di questa particolare attività del giudice Ciro De Vincenzo si era comunque reso conto anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale, il 17 marzo 1975 presentò uno specifico esposto-denuncia alla Procura generale di Torino. De Vincenzo venne sottoposto ad una inchiesta da parte del Csm, ma il caso venne successivamente archiviato. Come ha confermato il generale Nicolò Bozzo: «Dalla Chiesa su De Vincenzo aveva dei bruttissimi pensieri…»22. Ad ogni modo la vicenda giudiziaria che coinvolse Dalla Chiesa e De Vincenzo si chiuse con le dimissioni del magistrato. Il “compagno” magistrato inquirente, in accordo con il senatore Malagugini svolgeva dunque un ruolo fondamentale in questa manovra di riassorbimento posta in essere dal partito. In un bilancio della vicenda, si deve registrare in tutta evidenza che, tramite canali diversi, il gruppo dirigente comunista inviò chiari segnali ai suoi vecchi iscritti arruolatisi come giovani estremisti. Una volta ricevuta la risposta negativa di Franceschini e compagni, al partito non rimase altra soluzione che intraprendere – pur con le solite cautele – la via più corretta dal punto di vista legalitario: fronteggiare le Br con tutta la forza del proprio apparato.
20
CpS, audizione di Silvano Girotto, 10 febbraio 2000, XIII Legislatura, 62º resoconto stenografico. 21 Citata in G. CIPRIANI, Lo stato invisibile, Sperling&Kupfer, Milano 2002, p. 33. 22 Testimonianza del generale Nicolò Bozzo raccolta dall’autore e da Salvatore Sechi il 23 febbraio 2007.
85
ROBERTO BARTALI
La “controffensiva” berlingueriana investì da quel momento anche molti altri fronti, in pratica tutti gli ambiti esterni ed interni al Pci che erano – secondo le informazioni in possesso del leader sardo – coinvolti nell’emergente fenomeno terroristico. È lo stesso Ugo Pecchioli a fare una sincera analisi delle prime Br e del comportamento tenuto dal suo partito, un’analisi che in pratica conferma quanto sostenuto in precedenza: … quando il brigatismo venne alla luce, noi ci rendemmo conto della sua pericolosità e della necessità di combatterlo con grande severità. Parlo dell’eversione di sinistra. Ce ne rendemmo però conto con un certo ritardo. All’inizio eravamo un po’ incerti. Tra noi si alternavano giudizi diversi: i terroristi o venivano considerati cechi strumenti di provocazione che lavoravano per conto di centri reazionari anche internazionali, oppure si dava di loro un giudizio meno drastico, considerandoli, nonostante compissero azioni sempre più violente, come degli irresponsabili. Questa altalena durò per un breve periodo. … ne uscimmo agli inizi degli Anni Settanta, quando si costituirono le prime vere Brigate Rosse, quando fu sequestrato Amerio e poi Sossi […] poi le Brigate Rosse, dopo il ’74, diventarono una cosa diversa…23.
L’affermazione di Pecchioli collima con quanto sostenuto, in tempi non sospetti, dall’ex generale del Sid Gianadelio Maletti in una nota intervista rilasciata al settimanale «Tempo» del giugno 1976, e con quel filone storiografico che vede nel biennio ’74/’75, ovvero con l’avvento ai vertici del gruppo di Mario Moretti, il passaggio a delle “nuove Br”24. Un ragionamento complessivo su quel periodo e sui rapporti con il Pci lo ha fatto anche lo stesso Franceschini durante l’audizione di fronte alla “Commissione Stragi”: … a Reggio Emilia […] una parte dei compagni che era d’accordo con le nostre posizioni sulla lotta armata rimasero (nella FGCI o nel partito). Alcuni di essi, nel 1972 fecero alcune rapine con compagni nostri di quella zona. Erano ancora iscritti alle sezioni, al partito. Fino al 1974 nessuno disse loro niente; poi, all’inizio del 1974 vennero chiamati dal segretario 23
U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità, cit., p. 101. Alla mutazione nella storia delle Br accennò anche il colonnello Umberto Bonaventura nella sua audizione alla Commissione Stragi: «… era la teoria del “lasciare i rami verdi”: quando si doveva intervenire lo si faceva più o meno ampiamente, però si lasciava sempre un ramo che sul momento poteva non essere importante, ma tuttavia poteva continuare a farci lavorare». 24
86
Il Pci e le Brigate rosse
della sezione: “Guarda, noi sappiamo che hai fatto questa rapina, questo e quest’altro: non ti denunciamo alla polizia, però ridacci la tessera e per il resto sono affari tuoi”. Pertanto era chiaro che anche da questo punto di vista c’era una svolta che passava dal vertice probabilmente e arrivava fino alla base del partito cioè, se fino a quel momento vi era stata dal punto di vista della struttura del partito comunista una non belligeranza nei nostri confronti, da un certo momento in poi vi è un rapporto organico […] con Dalla Chiesa e certe strutture dello Stato25.
E ancora: … il Pci sapeva tutto di noi perché noi venivamo tutti da lì. Per alcuni anni non collaborò con la polizia. Ci teneva sotto controllo, come era attività del Pci: con la vigilanza, i loro archivi e le informazioni per capire dove potevamo andare. Poiché io sono convinto che tra il ’73 e il ’74, ci fu un accordo tra il Pci, o comunque la parte berlingueriana, e settori della Dc e dello Stato, che fu poi anche parte di un processo che portò al compromesso storico26.
Sempre per quanto riguarda le Br, le contromosse di Berlinguer presero corpo in altre due iniziative, che risalgono all’inizio del 1974. Anzitutto con l’avvio di una fattiva collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che proprio a partire dal dicembre del 1973 aveva costituito i “nuclei speciali” agli ordini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La collaborazione con i Carabinieri Si trattava, come vedremo, di un’attività che prevedeva un reciproco scambio di informazioni, e che durante le indagini relative al rapimento del giudice Sossi arrivò ad essere, per ovvi motivi, davvero rilevante. È la testimonianza dell’ex ministro Paolo Emilio Taviani ad illuminare bene la vicenda: … durante la vicenda Sossi – e questo è importante – il Partito comunista ufficiale […] collaborò attivamente con me e con il Ministero dell’interno per le investigazioni e la ricerca dei responsabili. L’onorevole Galluzzi, a diretto contatto con Berlinguer, aveva frequenti incontri con me anche nella sede del Ministero dell’interno27.
25
CpS, audizione di Alberto Franceschini, 17 marzo 1999, cit. Citato in P. PERGOLIZZI, L’appartamento, cit., p. 103. 27 CpS, audizione del senatore Paolo Emilio Taviani, 1º luglio 1997, XIII Legislatura, 24º resoconto stenografico. 26
87
ROBERTO BARTALI
Ma è ancora Alberto Franceschini – stranamente, ma pur sempre in modo corrispondente al vero – ad entrare nello specifico, raccontando i primi passi della collaborazione del Pci con il generale Dalla Chiesa: … il generale Dalla Chiesa stava costituendo i nuclei antiterrorismo proprio con l’appoggio del Pci […] una notizia che avevamo avuto nel 1973-1974 sempre dal canale israeliano. Diceva che si era svolta una riunione a Torino, ai primi del 1974, cui avevano partecipato Pecchioli, Pajetta, Dalla Chiesa e Reviglio Della Veneria che era il procuratore generale [di Torino, ndr], nella quale di fatto si era decisa la costruzione dei “nuclei speciali”, che formalmente vennero realizzati alcuni mesi dopo, durante il sequestro Sossi. Noi trovammo conferma che l’operazione di Dalla Chiesa aveva l’appoggio del Partito Comunista da alcune cose che succedevano in quel periodo […] Pertanto era chiaro che anche da questo punto di vista c’era una svolta che passava dal vertice probabilmente e arrivava fino alla base del partito, cioè se fino a quel momento vi era stata dal punto di vista della struttura del partito comunista una non belligeranza nei nostri confronti, da un certo momento in poi vi è un rapporto organico […] con Dalla Chiesa e certe strutture dello Stato28.
A prescindere dalla singolarità del fatto che il Mossad, servizio segreto di Israele, abbia fornito questo tipo di informazione, così riservata, ad un gruppo terrorista italiano, il racconto di Franceschini giunge a delle conclusioni del tutto condivisibili. Il 1974, dal punto di vista del Pci, fu un anno di radicale svolta. Per avere ulteriori conferme dell’entente cordiale stabilitasi col capo dell’anti-terrorismo, forse nessuno meglio dei suoi più stretti collaboratori può offrire una testimonianza convincente, se non decisiva. Tra gli assistenti maggiormente conosciuti ed apprezzati c’è senza dubbio il generale Nicolò Bozzo: Bozzo - Quelli con il Pci erano rapporti che lui [il generale Dalla Chiesa, nda] manteneva segretamente, riservatamente… Da quando inizia la collaborazione dei carabinieri con i vertici del Pci?
28
CpS, audizione di Alberto Franceschini, 17 marzo 1999, cit.
88
Il Pci e le Brigate rosse
Bozzo - Dunque… Dalla Chiesa assume il comando, perché lui proveniva dalla legione di Palermo, e si presenta alla Divisione Pastrengo di Milano, che era comandata da Giovan Battista Palumbo se non mi sbaglio nell’ottobre 1973… a metà ottobre, ed assume il comando della Brigata Carabinieri di Torino… che aveva competenza sul Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma dipendeva dalla Pastrengo […] A me risulta che avesse un ottimo rapporto con Pecchioli. E infatti me lo ha presentato lui, ed ho partecipato ad alcuni incontri con Pecchioli. Io a Genova avevo dei buoni rapporti con il Pci, con Lovrano Bisso… Quando iniziarono in modo specifico i suoi rapporti con il Pci di Genova? Bozzo - Io iniziai ad avere rapporti e ad interessarmene direttamente nel 1974, con il rapimento Sossi, che se non sbaglio è del 18 aprile. Dalla Chiesa inizia ad interessarsi di terrorismo, di Brigate Rosse, in quel periodo, e lui propone la costituzione di un reparto speciale, che sia svincolato dalla gerarchia territoriale […]. Che tipo di rapporti c’erano con il Pci e con Pecchioli? come funzionava questa collaborazione? Bozzo - La collaborazione del Pci fu totale. È soprattutto uno scambio di informazioni. Dal partito comunista ci arrivava una richiesta “guardate, non abbiamo questo nome, che secondo noi potrebbe essere almeno un fiancheggiatore delle Br…”. Allora noi facevamo degli accertamenti che poi si riferivano… era una cosa utilissima, di grandissima importanza… Per quanto riguarda Torino si era parlato a lungo di elenchi contenenti centinaia di nomi di presunti brigatisti… si dice 300… passati dal partito comunista all’Arma… Bozzo - L’elenco di cui io sono a conoscenza riguardava la Fiat. Ed il generale Dalla Chiesa interessò il dottor Callieri della Fiat. Siamo intorno al 1976 o ’77. Ed anche in quella occasione l’aiuto del partito comunista fu enorme29. 29
Testimonianza del generale Nicolò Bozzo raccolta dall’autore e da Salvatore Sechi il 22 febbraio 2007.
89
ROBERTO BARTALI
Riassumendo appare, dunque, chiaro come a partire dalla fine del 1973 il Pci, dopo aver in un primo momento cercato di far restare la questione Br in un ambito “di partito”, affrontando il problema attraverso canali personali, cambiò radicalmente strategia. Il momento di questa svolta è databile nel periodo che va tra l’ottobre 1973 e l’aprile 1974, esattamente cioè tra il ritorno da Sofia di Enrico Berlinguer dopo “l’incidente” di cui fu vittima (di cui avremo modo di riferire) ed il rapimento del giudice genovese Mario Sossi. È in quel frangente che il Pci prese contatti con Dalla Chiesa, con il quale realizzerà un accordo formale che darà luogo ad una lunga e – come vedremo – assai prolifera collaborazione. Da quel momento, inoltre, il Pci orientò contro il terrorismo tutta la forza del proprio “Apparato di Vigilanza”, utilizzandolo di fatto come un vero e proprio apparato di intelligence. Giovanni Fasanella, saggista e giornalista del settimanale «Panorama», negli anni ’70 lavorava nella redazione torinese dell’Unità. Qui poté accertare, facendone oggetto di racconti, alcuni interessanti particolari di questa nuova e imprevedibile funzione svolta dal suo partito. Nella sua attività di giovane cronista “di nera”, infatti, ogni qual volta accadeva un fatto criminoso di origine terroristica egli si recava all’ultimo piano della federazione del Pci. Qui era stato allestito un vero e proprio ufficio informazioni con archivi, schedari e tutto ciò che potesse essere utile nella lotta contro le Br. Il partito, in questo scontro con i terroristi, giunse perfino a far condurre ai propri militanti delle perizie calligrafiche notturne sulle scritte inneggianti alle Br che comparivano sui muri delle città. Grazie ad esse gli esperti del Pci riuscivano a risalire al simpatizzante brigatista che le aveva fatte. La cosa è stata confermata anche da Rino Serri, allora dirigente del partito comunista di Reggio Emilia: Sì, c’erano due persone di nostra piena fiducia che nel partito facevano anche questo lavoro di intelligence. Ma sì, chiamiamolo così31.
Ed una ulteriore duplice conferma in questo senso è venuta anche dal lavoro svolto da Sabina Rossa, figlia del sindacalista della Cgil ucciso 30
Cfr. Introduzione al volume G. FASANELLA e S. ROSSA, Guido Rossa mio padre, BUR, Milano 2006, p. 11. 31 Testimonianza di Rino Serri, in P. PERGOLIZZI, L’appartamento, cit., p. 104.
90
Il Pci e le Brigate rosse
dalle Br nel 1979. Suo padre Guido – come ella ha scoperto solo di recente – era, infatti, un elemento di fiducia dell’Apparato di Vigilanza del Pci di Genova. Così fidato da meritare la totale stima dell’allora segretario provinciale del partito, Lovrano Bisso, il quale lo incaricò di svolgere alcuni lavori “d’intelligence” piuttosto rischiosi proprio contro le Br. Guido Rossa usava tenere dei quaderni con i frutti della propria attività investigativa fatta all’interno dello stabilimento Italsider di Genova per conto del Pci, appunti molto dettagliati vergati su dei block notes e contenenti fatti, nomi, date, circostanze. Ebbene quei particolareggiati taccuini egli cominciò a redigerli proprio a partire dal 1974, anno di inizio della sua attività informativa32. Interessante quanto esplicativa è, sempre su questo punto, la testimonianza di Roberto Speciale, per anni ai vertici del partito comunista di Genova e già membro di quella «sezione problemi dello Stato» interna al Pci che si occupò di contrastare il terrorismo reperendo informazioni e collaborando con i Carabinieri e la magistratura: Il momento di inizio della collaborazione [con i Carabinieri, nda] per quello che so io è il rapimento Sossi […] Qui a Genova c’è stato prima delle Br il gruppo XXII Ottobre, ma era un gruppo un po’ anomalo, occasionale… diciamo strano… però c’è un’altra cosa da notare… proprio per le caratteristiche del Pci di Genova, senza ovviamente mitizzare nulla, c’è un senso di appartenenza, un fiuto politico… e quando compaiono questi qui, dalla Banda XXII Ottobre [il Pci, nda] capisce subito che c’è qualcosa che non va… che non funziona… chi sono questi balordi che vogliono parlare a nome dei lavoratori, della sinistra, ecc?… per chi lo fanno? Tant’è che quando c’è il rapimento Sossi il sindacato proclama uno sciopero… credo che sia il primo in Italia… tra l’altro per un magistrato che era sempre stato di destra, o di estrema destra, che aveva fatto processi contro i picchetti degli operai, contro i blocchi stradali… quindi poteva anche non suscitare simpatia. Nonostante questo si fa uno sciopero […] In un periodo precedente il rapimento Sossi c’era quindi già un allarme, tant’è che quando rapiscono Sossi come ho detto c’è uno sciopero immediato, che voleva dire che già c’era una tensione…33.
Il funzionamento di questo accordo, che prevedeva un vicendevole scambio di informazioni tra i vertici del partito di Berlinguer e il 32
Cfr. G. FASANELLA e S. ROSSA, Guido Rossa mio padre, cit. Testimonianza di Roberto Speciale raccolta dall’autore e Salvatore Sechi il 22 febbraio 2007. 33
91
ROBERTO BARTALI
nucleo speciale di Dalla Chiesa, è spiegato con dovizia di particolari da Gianni Nobile. Si tratta di un ex funzionario della federazione comunista di Genova e – negli anni del terrorismo – anch’egli fu membro della Commissione «Problemi dello Stato» che a livello nazionale faceva capo a Ugo Pecchioli: … fra i miei compiti c’era quello di raccogliere documenti, soprattutto materiali dei movimenti e dell’eversione… all’inizio consideravamo i brigatisti rossi dei provocatori fascisti, mentre molti di loro erano cresciuti con il mito della Resistenza. … noi non volevamo trasformarci in poliziotti, non eravamo per una azione di polizia di massa. Le indicazioni ai nostri compagni non erano: indagate e denunciate […] Il nostro compito, invece, era quello di capire la consistenza delle Brigate Rosse all’interno delle fabbriche attraverso una valutazione della loro ascendenza sui lavoratori e delle loro possibilità di reclutamento… le nostre informazioni, quelle che arrivavano dalla fabbriche, le passavamo alla Direzione centrale del partito. Poi spettava a loro intervenire, attivando dei canali di informazione per far giungere la notizia a chi di dovere. Avevamo rapporti con i carabinieri del nucleo antiterrorismo e con il Ministero dell’Interno. E c’erano dei nostri compagni nella polizia…34.
Questa attività con il tempo andò perfezionandosi giungendo a livelli qualitativi e quantitativi davvero notevoli. È lo stesso Ugo Pecchioli, nel libro-intervista che scrisse poco prima della sua scomparsa, a sottolineare i rapporti del Pci, e suoi in particolar modo, con il generale Dalla Chiesa: … ci scambiavamo opinioni sullo stato della sicurezza, lui mi dava qualche informazione sulle attività in corso e io lo mettevo al corrente delle nostre iniziative e talvolta di segnalazioni che ci erano pervenute35.
Roberto Speciale entra ancora più a fondo nel merito del lavoro svolto dal Pci contro le Br: Il lavoro d’intelligence era intelligence politico-culturale e poi anche intelligence organizzativa…, perché bisognava capire quale cultura politica, quale ideologia e che obiettivi avevano, andava fatta un’analisi precisa
34 35
G. FASANELLA e S. ROSSA, Guido Rossa mio padre, cit., pp. 151-152. U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità, cit., pp. 143-145.
92
Il Pci e le Brigate rosse
sulla base dei documenti che lasciavano in giro… ne lasciavano una tale quantità che era quasi più facile trovare i loro che quelli del sindacato in giro… in questo caso era perfino superfluo avere rapporti con la polizia perché si trovavano normalmente questi documenti… volantini… risoluzioni strategiche ecc. Poi facemmo un’analisi per capire l’humus nel quale potevano attecchire e per capire se c’erano e chi erano i fiancheggiatori… quindi si sono costituiti in ogni azienda, in ogni posto di lavoro, nelle scuole, nelle università… dei punti di riferimento che stessero attenti a quello che succedeva […] C’è un’analisi politico-culturale del terrorismo fatta nel “caldo degli eventi”, poi c’è un’analisi degli avvenimenti e delle contraddizioni di questi avvenimenti… c’è infine un’analisi di certi nomi di personaggi che venivano da fuori e che oggettivamente facevano riflettere. Oltre a combattere, diciamo così, a difendere la democrazia, che era una cosa di per sé già giusta, c’era la voglia di dimostrare l’estraneità politica, personale ed umana del Pci… creare anche culturalmente una distanza con il terrorismo […] Dunque si raccoglievano informazioni, si coordinavano informazioni… Se queste risultavano essere di un certo livello si comunicavano al Nucleo dei Carabinieri che se ne occupava, e all’altra parte si richiedevano verifiche… c’era dunque un rapporto del tutto evidente di collaborazione36.
Siamo in presenza, evidentemente, di una collaborazione di notevole livello basata su di uno scambio reciproco di informazioni e anche di nomi di terroristi o fiancheggiatori da seguire con attenzione. Il tutto, giova ripeterlo, era il frutto del vero e rischioso lavoro d’intelligence che il partito comunista portava avanti con tutta la forza di cui poteva disporre il suo apparato. Un’altra testimonianza molto chiara è quella dello stesso Lovrano Bisso: … non c’è dubbio, noi iniziammo a “drizzare le orecchie” contro le Br proprio con il rapimento di Sossi. Anzi, per essere più precisi ricordo che la prima riunione, alla quale parteciparono anche i carabinieri ed il questore di Genova De Longis, si tenne immediatamente dopo l’irruzione delle forze dell’ordine nel carcere di Alessandria. Lì ci venne la richiesta di collaborare ed inizia la nostra attività informativa nelle fabbriche, ad esempio […] così diciamo a certi nostri compagni di guardare, di conoscere il più possibile, di raccogliere informazioni… però il nostro lavoro informativo seguiva un preciso percorso: chi notava 36
Testimonianza di Roberto Speciale raccolta dall’autore e Salvatore Sechi il 22 febbraio 2007.
93
ROBERTO BARTALI
qualcosa di credibile, serio, la doveva riferire solo al centro, al partito, il quale a sua volta attivava i propri canali…37.
Anche dalle carte presenti nell’archivio della Fondazione Istituto Gramsci emerge con chiarezza come dal 1973-1974 il Pci iniziò una vera schedatura, fabbrica per fabbrica, della presenza, della composizione e dell’influenza dei diversi gruppi estremistici, suddivisi per quadri e attivisti. Uno studio di notevole livello statistico affidato – era il caso di Milano e delle sue fabbriche – a Claudio Petruccioli tramite interviste a campione, ma svolto anche all’interno di quattro istituti bancari e nelle scuole38. Gli esperti del Pci portarono a termine successivamente anche delle specifiche analisi della struttura dei vari gruppi terroristici, dei modi di finanziamento, di come colpivano e con quali armamenti, dei diversi sistemi usati dai terroristi in tutto il mondo, di come si sostentassero, delle pianificazioni operative. Si curò anche l’analisi dell’effetto psicologico di bombe, rapimenti, rapine ed ostaggi, del fatto che l’atto terroristico e l’omicidio siano accettati perché funzionali alla rivoluzione ma che alla lunga i terroristi scivolano verso il nichilismo. Si fecero inoltre degli studi psicologici e psicopatologici del terrorismo39. La struttura che faceva capo al Pci, dunque, nulla ebbe a che fare col terrorismo. Anzi, secondo quanto si legge in un breve appunto riservato del Sisde, risalente al 1980, si può dire di più: l’Apparato segue il fenomeno del terrorismo a livello di informazioni. Collabora anche al rintraccio di qualche terrorista e sviluppa delazioni articolate dirette a terminare situazioni particolari a carico di questo o quel personaggio40. 37
Testimonianza di Lovrano Bisso raccolta dall’autore e Salvatore Sechi il 26 marzo 2007. 38 Archivio storico del Partito comunista, Istituto Fondazione Gramsci (d’ora in avanti IG APC), Fondo Bertini, busta 3804 UA 25. Singolare appare il fatto che dopo aver analizzato la diffusione della stampa legata ai gruppi extraparlamentare si riportava poi con una certa enfasi il fatto che nel corpo insegnante, a metà maggio 1974, i gruppi avevano raccolto il 30% degli iscritti, percentuale molto più alta delle altre medie prese in esame. 39 Su questo tema si consideri ad esempio lo studio intitolato “L’interazione di aspetti psicopatologici e di aspetti socio-politici del terrorismo italiano”; IG APC, Fondo Bertini, UA 36. 40 Appunto dal titolo: «Partito Comunista Italiano. Apparato della Vigilanza», Raggruppamento “Centri C.S.”, 3 febbraio 1980. Sta in Senato della Repubblica,
94
Il Pci e le Brigate rosse
Gli stessi servizi segreti italiani, dunque, riconoscevano che l’Apparato di Vigilanza democratica del Pci, nel corso degli anni duri dell’eversione brigatista, era schierato dalla parte dello Stato. Ma non è tutto. Sergio Segio in un suo recente volume, ha sottolineato che Ugo Pecchioli ha omesso fino all’ultimo di raccontare come in realtà l’attività da vero e proprio servizio segreto fatta dall’apparato del Pci si spinse fino all’infiltrazione all’interno dei gruppi clandestini. Militanti “coperti” del Pci, vennero appositamente inseriti in ambienti dell’Autonomia Operaia e della sinistra extraparlamentare, su iniziativa della struttura di vigilanza del partito e della direzione. Nel quadro di questa attività e della stabile collaborazione con il generale Dalla Chiesa vi furono anche operazioni speciali e coperte. Penso a quella chiamata in codice “Olocausto”, che consistette nell’infiltrazione di un militante del Pci nei gruppi armati già all’epoca del caso Moro. Dopo l’infiltrazione del gruppo clandestino, il militante riferiva ogni informazione di cui entrava in possesso al proprio partito e, direttamente, al generale e ai responsabili del suo reparto dei carabinieri41. Ma le contromosse di Berlinguer nella guerra “sotterranea” contro le Br non si esaurirono qui. Sempre in quel periodo (1975) ci fu il primo dei viaggi di Salvatore Cacciapuoti a Praga di cui avremo modo di riferire in dettaglio42. Singolare l’appunto che Franceschini, nel suo libro-intervista, fa al proprio interlocutore:
Archivio della Commissione Mitrokhin (d’ora in avanti ACM), Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Richiesta di archiviazione nel procedimento penale 8393/92 B “Ionta-De Ficchy”. 41 S. SEGIO, Una vita in Prima Linea, Rizzoli, Milano 2006, p. 145. Si veda anche: V. TESSANDORI e E. BOFFANO, Il procuratore. Gian Carlo Caselli, un giudice fra mafia e terrorismo, Baldini&Castoldi, Milano 1995, pp. 299-300. 42 Si veda a questo proposito il report n. 143 del “dossier Mitrokhin”. Per l’edizione a stampa si veda Dossier Kgb, rapporto Mitrokhin. Tutti i documenti dello spionaggio in Italia, a cura di A. Ruggieri, Sapere 2000 edizioni multimediali, Roma 1999. Il “dossier Mitrokhin” (o “rapporto Impedian”), è costituito dall’insieme delle 261 schede che il Sis (Secret Intelligence Service) inviò, tra il marzo 1995 e il maggio 1999, al Sismi, l’allora servizio segreto militare italiano. Fu reso pubblico dall’Ufficio di Presidenza della Commissione Stragi l’11 ottobre 1999. Si può consultare anche al sito Internet http://www.unknown.it/materiale/mitrokhin.html.
95
ROBERTO BARTALI
[…] in quello stesso periodo, tra l’altro, Salvatore Cacciapuoti, allora presidente della Commissione centrale di Controllo del Pci, va a Praga, dai comunisti cecoslovacchi, e dice: sappiamo che voi proteggete i brigatisti, smettetela43.
In sintesi, una volta appurato con sicurezza, da parte del Pci, che i giovani delle Br venivano addestrati in terra ceca anche con il fine di destabilizzare la politica “revisionista” posta in essere da Berlinguer, egli si mosse in modo ufficiale nei confronti dei ‘compagni’ cechi per far terminare questa pratica. Il fine, logicamente, era di fare completamente “terra bruciata” intorno al gruppo fondato da Renato Curcio, colpendo tutte quelle componenti che avevano, o avevano avuto, un ruolo nella sua nascita. D’altronde, come appare evidente anche dalla lettura di alcune note riservate inviate all’attenzione del Ministero degli Interni anche in periodi successivi, le notizie di cui erano in possesso i vertici del suo partito lasciavano poco spazio all’immaginazione: le prime Br erano «finanziate e manovrate» dai servizi segreti sovietici, e questi se ne servivano per contrastare il “riformismo” dei compagni italiani44. In conclusione, siamo dunque in grado di affermare con una accettabile dose di sicurezza, frutto di una sufficiente base documentale, che il partito comunista italiano, nel periodo della segreteria di Enrico Berlinguer, posto di fronte alla vera e propria sfida lanciatagli dalle nascenti Brigate rosse, intraprese una linea di resistenza e di contrasto fin dai primi anni ’70. Si può forse parlare di una sorta di crescendo wagneriano che corrisponde, ed è in una precisa simmetria, da un lato all’innalzarsi del livello delle azioni brigatiste, e dall’altro alla presa di coscienza da parte dello stesso leader di quale fossero il retroterra socio-politico e gli interessi, anche di carattere internazionale, che si nascondevano dietro il gruppo di Curcio e Franceschini facendo un uso strumentale della sincera fede rivoluzionaria della grande maggioranza dei suoi componenti. 43
G. FASANELLA e A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le Br, cit., p. 131. ACM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Richiesta di Archiviazione nel procedimento Penale 8393/92 B, “Ionta-De Ficchy”, appunto del 5 marzo 1982. La fonte del Viminale riferì quanto esposto a livello confidenziale dall’onorevole Mario Bartolini, secondo il quale il Pci era in possesso di «prove certe» per dimostrare il legame tra l’Urss ed il gruppo di Curcio e Franceschini, ed in modo specifico che le Br fossero «finanziate e manovrate» dai sovietici. 44
96
Il Pci e le Brigate rosse
Dalla nascita delle Br (1970) e fino ai mesi che stanno tra il rapimento di Ettore Amerio a Torino e quello di Mario Sossi a Genova, il Pci cercò prima di tutto di capire con precisione cosa si nascondesse dietro quella sigla e quelle azioni, prodigandosi poi in un’operazione volta al “recupero” di quella componente brigatista che proveniva dal proprio interno, dalle organizzazioni giovanili. Questa prima fase ebbe poi un momento di radicale svolta tra l’autunno 1973 e l’aprile 1974, quando dopo il rifiuto dei brigatisti contattati di “deporre le armi” ed il successivo verificarsi di alcuni accadimenti particolari (l’incidente di cui lo stesso Berlinguer fu vittima a Sofia ed il rapimento a Genova del giudice Mario Sossi) spinse il partito comunista ad iniziare, in modo riservato, una fattiva collaborazione con la magistratura e le forze di polizia, nello specifico del generale Dalla Chiesa e dei più alti ufficiali del suo Nucleo Speciale. Appare evidente come già a partire dalla fine del 1973 – e non più tardi – prese il via lo scambio vicendevole di informazioni tra carabinieri e partito comunista, il quale, forte di un apparato vasto quanto radicato nelle principali realtà produttive ed industriali del paese, ed anche grazie alla forte presenza del sindacato ad esso vicino (la Cgil), giunse fino ad impiegare il proprio “Apparato di Vigilanza Democratica” come un vero e proprio servizio di intelligence. Lo stesso Paolo Emilio Taviani, tra l’altro, fornì una conferma in merito a quanto sostenuto in questo lavoro: «La tesi che il Partito comunista si sia convertito solo dopo l’assassinio di Moro è destituita di fondamento»45. Si trattò di una scelta che, come sappiamo, porterà a grandiosi risultati nella lotta contro il terrorismo e, allo stesso tempo, a tragedie umane come quella di Guido Rossa, sindacalista genovese ed esponente della “Vigilanza” del Pci trucidato dalle Br proprio per aver collaborato con i carabinieri denunciando un fiancheggiatore del gruppo46.
45
CpS, audizione del senatore Paolo Emilio Taviani, 1º luglio 1997, cit. Su questo punto si veda, oltre al già citato volume scritto dalla figlia di Guido Rossa, Sabina, anche E. FENZI, Armi e bagagli, un diario delle Br, Costa & Nolan, Genova 1987. Sulle reali motivazioni che portarono al delitto di Rossa, e non “solamente” al suo ferimento, permangono inalterati – è doveroso sottolinearlo – dubbi e perplessità, acuiti anche dalla lodevole, e più volte citata, ricostruzione realizzata da Sabina Rossa in collaborazione con Giovanni Fasanella. 46
97
ROBERTO BARTALI
I rapporti col Mossad Dall’analisi della documentazione e delle testimonianze emergono però altri due accadimenti perlomeno singolari su cui è doverosa qualche chiosa: il contatto tra le Brigate rosse ed il Mossad, ed il viaggio di Salvatore Cacciapuoti a Praga. Per quanto riguarda il primo punto si tratta a ben vedere di un contatto ormai noto e di cui parlano senza reticenze praticamente tutti gli appartenenti al Nucleo Storico delle Br; in questo contesto non va però dimenticato che il Mossad era, ed è tutt’oggi, il servizio segreto di un paese, Israele, che vive in una situazione di perenne stato di belligeranza, e che dunque – per ovvi motivi – necessitava (ed in effetti poteva vantare sul campo) di una particolare efficienza47. È ormai accertato che in due diverse occasioni le “barbe finte” israeliane riuscirono a contattare le Br, ed in specifico il cosiddetto Nucleo Storico, per proporre una sorta di patto: armi in cambio di una escalation di violenza sul territorio italiano da parte dei terroristi. La circostanza, che venne riferita una prima volta dal pentito Patrizio Peci al magistrato torinese Gian Carlo Caselli, è stata successivamente confermata praticamente dalla totalità dei brigatisti. Si tratta in effetti di una di quelle notizie che sono state letteralmente tramandate di generazione in generazione all’interno del gruppo, anche se i particolari erano noti solamente al livello più alto: come ebbe a riferire Bonavita, infatti, si veniva resi edotti su certe questioni solamente nel momento in cui (dopo essere stati militanti “regolari”) si entrava a far parte del cosiddetto Comitato Esecutivo48. Alberto Franceschini – che in qualità di dirigente delle Br in quel periodo trattò in prima persona la questione – in proposito ha riferito che: Fu un compagno di “Controinformazione” a dirci, non senza imbarazzo, che si erano messi in contatto con lui degli uomini dei servizi segreti di Tel Aviv, dicendogli che avevano una proposta da fare a noi delle Br. Come prova della loro affidabilità ci avevano dato l’indirizzo di Friburgo 47 Si
vedano a questo proposito: B. MORRIS e I. BLACK, Le guerre segrete di Israele, Rizzoli, Milano 2003 e A. MUSCI e M. MINICANGELI, Breve storia del Mossad, Datanews, Roma 2001. 48 Testimonianza di Alfredo Bonavita (o Buonavita), Corte d’Assise di Roma: processo Moro, udienza del 14 ottobre 1982, in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, vol. LXXVIII (1993), pp. 629-711.
98
Il Pci e le Brigate rosse
dove si era nascosto Pisetta dopo le sue soffiate e i nomi di alcuni operai della Fiat che, per conto dei servizi italiani, stavano cercando di infiltrarsi al nostro interno. Volevano fornirci armi e munizioni moderne senza chiedere una lira in cambio: avremmo solo dovuto continuare a fare quello che stavamo facendo, a loro interessava che i paesi mediterranei come l’Italia, non in pessimi rapporti con i Palestinesi, continuassero a vivere una situazione di instabilità al loro interno. Non fu necessaria una lunga discussione tra noi, eravamo tutti d’accordo: niente armi dagli israeliani anche se le notizie che ci avevano fornito erano assolutamente esatte e ci furono utili. Stavamo per fare entrare nella brigata Fiat un falso compagno pagato dai carabinieri49.
Lo stesso Franceschini ha ripetuto più o meno le stesse cose, ma aggiungendo altri particolari, durante l’audizione in “Commissione Stragi”: … la proposta che ci veniva fatta era questa: noi non vogliamo dirvi le cose che voi dovete fare. Cioè, a noi ci va benissimo quello che voi fate. Ci interessa che voi esistiate. Il fatto stesso che voi esistiate, qualunque cosa facciate a noi va benissimo. E spiegarono anche le motivazioni politiche di questa loro posizione. Dissero che siccome vi era ovviamente un problema di area mediterranea e di paesi leader, dal un punto di vista dei rapporti degli americani, nel controllo dell’area nella misura in cui l’Italia era destabilizzata, più l’Italia era destabilizzata più era inaffidabile, più Israele diventava paese affidabile per tutte le politiche mediterranee50.
A ben vedere, dunque, le cose offerte dal Mossad alle Brigate rosse in cambio della loro “collaborazione” non si limitavano alle sole «armi e munizioni moderne», come racconta Franceschini, ma comprendevano anche delle informazioni di un certo valore. Per conquistare la loro fiducia e convincerli ad accettare una qualsiasi forma di sodalizio, il Mossad pose sul piatto della bilancia anche qualcosa di utile per le Br almeno quanto lo erano le armi: informazioni. La prima di esse riguardava il luogo dove si era rifugiato il primo confidente delle forze di polizia infiltratosi nel gruppo, cioè quel Marco Pisetta nei confronti del quale i brigatisti avevano forti desideri di vendetta. Pisetta si era nascosto in Germania occidentale dopo le sue confessioni. Ebbene, il servizio segreto israeliano, in qualche modo, era venuto a conoscenza della esatta localizzazione del suo rifugio e la fornì ai brigatisti, tant’è che gli 49 50
A. FRANCESCHINI, Mara, Renato e io, cit., p. 74. CpS, audizione di Alberto Franceschini, 17 marzo 1999, cit.
99
ROBERTO BARTALI
stessi brigatisti fecero “buon uso” delle informazioni che gli erano state fornite, ed inviarono prontamente in Germania un nucleo composto da due elementi con il preciso fine di uccidere Pisetta. Fu solo a seguito di alcune fortuite coincidenze che il progetto di uccidere l’ex imbianchino di Trento non venne poi portato a termine51. Ma non è tutto, perché il Mossad rivelò alle Br altre informazioni decisamente interessanti. A renderle note è di nuovo Franceschini: … una informazione, una notizia che avevamo avuto nel 1973-1974 sempre dal canale israeliano diceva che si era svolta una riunione a Torino, ai primi del 1974, cui avevano partecipato Pecchioli, Pajetta, Dalla Chiesa e Reviglio della Veneria che era il procuratore generale, nella quale di fatto si era decisa la costruzione dei “nuclei speciali”, che formalmente vennero realizzati alcuni mesi dopo, durante il sequestro Sossi. Noi trovammo conferma che l’operazione di Dalla Chiesa aveva l’appoggio del Partito Comunista da alcune cose che succedevano in quel periodo52.
Le notizie fornite dai servizi segreti con la stella di Davide erano dunque estremamente precise e circostanziate e, soprattutto, riguardavano riunioni riservate di cui in pochi avrebbero dovuto essere a conoscenza. Infine, come ricorda sempre Franceschini: … ci diedero i nominativi di due operai della Fiat (uno della Fiat Rivalta), che dicevano che erano infiltrati in mezzo a noi. Infatti noi andammo a verificare questi due operai, che esistevano ed erano anche due del giro delle Brigate di fabbrica53.
Un servizio segreto, dunque, di rara efficienza, e soprattutto che poteva contare su propri informatori anche all’interno della Questura meneghina. Ricapitolando l’offerta israeliana, dobbiamo sottolineare come, al fine di conquistare la fiducia del gruppo capeggiato da Curcio e Franceschini e, come ha raccontato quest’ultimo, fargli innalzare il livello di attività terroristica, i servizi israeliani non si fecero scrupolo di of51
Cfr. Testimonianza di Alfredo Bonavita, 14 ottobre 1982, cit. Ibidem. 53 CpS, audizione di Alberto Franceschini, 17 marzo 1999, cit. Si noti come tutte le informazioni vennero successivamente verificate dalle Brigate rosse, ed i riscontri ebbero esito positivo. 52
100
Il Pci e le Brigate rosse
frire come contropartita armi di prima qualità ed una quantità notevole di informazioni. Interessante fare il punto anche su queste: il luogo in Germania (Friburgo) dove si era rifugiato il delatore Marco Pisetta; il nome di due confidenti della Questura milanese che si stavano infiltrando nel gruppo a loro insaputa; il resoconto di una riunione (tenutasi sotto il più stretto riserbo) in cui alcuni dirigenti nazionali del Pci incontravano magistrati e membri delle forze dell’ordine per concordare azioni di contrasto verso le stesse Br. Il Mossad mostrò, in poche parole, di essere un servizio segreto realmente efficiente, potendo fornire ai propri interlocutori informazioni di prima mano e nei settori più disparati. Ma la cosa che più colpisce è il fatto che gli israeliani non avevano solamente tenuto sotto osservazione il gruppo di Curcio e Franceschini, ma erano entrati in possesso di notizie dettagliate e precise inerenti ambiti diversi e, come nel caso della riunione tra Dalla Chiesa ed i vertici del Pci, anche su riunioni veramente riservate. La prova dei contatti avuti con il servizio d’intelligence israeliano dimostra chiaramente come le prime Br disponevano di una preparazione militare alla lotta clandestina piuttosto relativa; in poche parole erano decisamente permeabili. Per una forza di polizia ben organizzata, o un servizio di intelligence degno di tale nome, non era difficile individuarne i militanti, seguirne le mosse e infiltrare propri confidenti nel gruppo54. 54
È da tenere presente che oltre al caso Pisetta ed al contatto con il Mossad le “prime Br” subirono in altre occasioni delle infiltrazioni di confidenti o veri e propri infiltrati. Tra i più noti ci sono quello di Silvano Girotto, alias “Frate Mitra” (che giunse a far arrestare i suoi leader Renato Curcio e Alberto Franceschini), di Francesco Marra (di cui si è saputo solo dopo la pubblicazione del volume dei fratelli Antonio e Gianni CIPRIANI, Sovranità limitata. Storia dell’eversione atlantica in Italia, Ed. associate, Roma 1991). Aggiungerei il nome di Roberto Dotti, elemento di spicco dell’organizzazione – i Comitati di Resistenza Democratica – messa in piedi da Edgardo Sogno. Grazie ai suoi trascorsi di ex partigiano comunista rifugiatosi per alcuni anni in Cecoslovacchia, Dotti poteva vantare – allo stesso tempo – la piena fiducia di Mara Cagol, dalla quale si era fatto consegnare delle schede con i nominativi del primissimo nucleo di futuri brigatisti, allora ancora parte del Collettivo politico metropolitano-Sinistra Proletaria. A questo proposito si vedano: E. SOGNO e A. CAZZULLO, Testamento di un anti-comunista, Mondadori, Milano 2000 p. 101; G. FASANELLA e A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le Br, cit., pp. 147-149; A. CIPRIANI e G. CIPRIANI, Sovranità limitata, cit.; S. FLAMIGNI, Convergenze parallele, Kaos, Milano 1998; AA.VV., Il sequestro di verità, Kaos, Milano 2008.
101
ROBERTO BARTALI
Come ha scritto correttamente l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, a livello storiografico non conta però che le Br abbiano accettato o meno l’aiuto del Mossad, ma conta il fatto stesso – di non poca importanza – che una formazione terroristica, per altri versi già in contatto con elementi dell’estremismo palestinese, fosse stata sostenuta anche dagli avversari storici dei palestinesi55. Ci troviamo dunque in un momento in cui al riemergere in Italia delle mai sopite tensioni sorte sul finire del secondo conflitto mondiale tra fascisti ed anti-fascisti ed al costante confronto tra le due super-potenze mondiali, Stati Uniti ed Unione Sovietica nel contesto della Guerra fredda, si unì l’allargamento allo scacchiere mediterraneo dello scontro tra israeliani e palestinesi. La realtà storica nella quale nacquero le Brigate rosse era, in buona sostanza, non solo complessa ma anche enormemente superiore al loro livello di preparazione. Ad una specifica domanda rivolta a Franceschini se come gruppo dirigente delle Br avessero avuto qualche forma di timore in merito a questo contatto, se cioè in quel momento ebbero o meno la percezione di trovarsi in un “gioco” più grande di loro, la sua risposta è stata la seguente: … in quel momento il tuo ragionamento è che quella è la realtà e tu ti devi muovere in mezzo a sta’ realtà… così noi al Mossad gli diciamo “andate a quel paese!”… però io ripeto che se ci avesse contattato direttamente il servizio segreto cubano io avrei accettato di fare l’agente dei cubani […] per cui quando Feltrinelli ci diceva di essere in contatto con i servizi di Cuba io ero entusiasta… tant’è che noi cadiamo nella trappola di Frate Girotto perché ci disse di avere le garanzie dei cubani… noi cercavamo i cubani…56.
Sempre Alberto Franceschini ha raccontato un altro curioso episodio risalente al 1973: il rapimento-lampo di un dirigente dell’Alfa Romeo, Michele Mincuzzi portato a termine, a nome e per conto delle Br, dal discusso Mario Moretti. L’azione, che ebbe anche un certo risalto sui media, vide Moretti dirigere e partecipare in prima persona: egli prelevò l’ostaggio, lo fece salire su di un furgone, lo fotografò con l’ormai rituale cartello al collo, scattando una fotografia che ven55
F. IMPOSIMATO, Democrazia, Terrorismo e servizi segreti, in Forme di organizzazione criminali e terrorismo, a cura di F. Ferracuti, Ed. Giuffrè, Milano 1988, p. 184. 56 Testimonianza di Alberto Franceschini raccolta dall’autore il 31 marzo 2006.
102
Il Pci e le Brigate rosse
ne pubblicata il giorno successivo dai principali quotidiani, quindi lo rilasciò. La stranezza – ben visibile perfino ad un osservatore distratto – risiede nel fatto che sul cartello la stella a cinque punte, l’ormai tristemente celebre simbolo delle Br, era stata disegnata “a sei punte”, proprio come quella presente nella bandiera di Israele. Gli stessi giornali del tempo si accorsero dell’evidente anomalia. Interrogato dagli stessi brigatisti, Moretti si giustificò dicendo di essersi sbagliato. Lo sbaglio, anche a distanza di anni, appare però troppo grossolano per essere il frutto di un semplice errore dovuto alla fretta, tanto più che il simbolo che ne venne fuori, cioè la stella di Davide, era (ed è) così noto da far ritenere improbabile che Moretti non si fosse reso conto di cosa avesse “inconsapevolmente” disegnato; la scusa di Moretti appare dunque poco credibile. È per questa ragione che Franceschini si pone una domanda: «[Mario Moretti] aveva voluto mandare un messaggio a qualcuno?»57. E aggiunge: «Molti anni dopo, un ufficiale dei Carabinieri che ha speso la vita a indagare sul terrorismo, mi ha detto “Moretti voleva mandare un messaggio agli Israeliani: guardate che cosa sono in grado di fare, comando io”»58. L’avvenimento, nella sua particolarità, appare davvero singolare ma altrettanto verosimile, soprattutto se si considera che da lì a pochi mesi lo stesso Mario Moretti diventerà il leader indiscusso delle Br e lo resterà per quasi un decennio. È a questo punto opportuno cercare di trovare le motivazioni che possono aver spinto il Mossad ad entrare in contatto con un gruppo terrorista italiano di matrice marxista-leninista e proporgli un supporto logistico ed informativo di un ottimo livello qualitativo. La motivazione ufficiale, che venne addotta dagli agenti israeliani, può essere riassunta come «sviluppare il caos in Italia al fine di continuare ad essere l’alleato più fedele degli Usa». Per quanto verosimile, alla luce della situazione internazionale potrebbe, infatti, essere stata solo una copertura ad altre motivazioni che non potevano essere rivelate ai brigatisti. È nuovamente l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, che per quantità e qualità di inchieste in questo settore si è guadagnato sul campo una meritata qualifica di “specialista”, a fornire una prima spiegazione:
57 58
G. FASANELLA e A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le Br, cit., p. 123. Ibidem.
103
ROBERTO BARTALI
[le motivazioni] erano due. In primo luogo, i servizi segreti israeliani tentavano di stabilire in Italia una situazione di guerra civile e di conflitto armato per costringere gli americani a non fare affidamento solo sull’Italia come base sicura nel mediterraneo […] nonché per indurli a diffidare della lealtà politica dell’Italia59.
Un’altra spiegazione plausibile è quella che è stata proposta a suo tempo da Giorgio Galli. A suo avviso il Mossad attraverso i contatti con le Brigate rosse sperava di arrivare a intercettare un contatto, o comunque una rete di contatti, attraverso il quale giungere a colpire il suo nemico storico: i gruppi estremistici palestinesi con i quali, com’è noto, i terroristi nostrani intrattenevano rapporti da lungo tempo60. Interessante mi è parso anche quanto sostiene Alberto Franceschini: … il ’72 con la strage alle Olimpiadi di Monaco per Israele è una vera svolta. Loro capiscono che il fatto che i palestinesi abbiano dei rapporti con i gruppi della sinistra estrema europea ha un’importanza fondamentale, e quindi loro devono in qualche modo reagire. Così mettono su questi gruppi speciali che girano per l’Europa… ed in varie maniere entrano in contatto con la Raf, con le Br…61.
Il recente emergere di importanti testimonianze ha permesso di sommare a queste due interpretazioni anche una terza, che è stata solo sfiorata dal ragionamento fatto da Imposimato. Leggendo nelle carte, e soprattutto confrontando le date, ci si accorge infatti di alcune particolari concomitanze, di avvenimenti verificatisi in una tempistica tale da fornire, a mio avviso, una chiave di lettura alternativa o, quantomeno, un aiuto per spiegare il comportamento degli israeliani: una sorta di “risposta”, quando non addirittura una vera e propria ritorsione, a certi accadimenti. Prima di entrare nel dettaglio è bene tenere a mente che il primo contatto tra le Br ed il Mossad, avvenuto tramite un intermediario, si verificò durante il sequestro di Ettore Amerio, realizzato il 10 dicem-
59
«Il Tempo», 1º marzo 1999. L’articolo in questione aveva un titolo decisamente esplicativo: Le Br erano in contatto con i servizi israeliani. 60 Cfr. G. GALLI, Storia del partito armato 1968-1982, cit., p. 114. 61 Testimonianza di Alberto Franceschini raccolta dall’autore il 31 marzo 2006.
104
Il Pci e le Brigate rosse
bre 197362. A questo va aggiunto un altro particolare. Sempre nello stesso anno, e sempre nel nostro paese, si era verificato un altro avvenimento che aveva visto la presenza del servizio segreto israeliano, avvenimento di cui anni dopo si occupò il giudice Carlo Mastelloni: l’incidente dell’“Argo 16”. “Argo 16” era il nome di un aereo militare, un Fokker bimotore, impiegato dai servizi segreti italiani per le operazioni riservate e con il quale venivano trasportati in Sardegna i “gladiatori” della sezione italiana di Stay Behind per seguire corsi di addestramento63. L’inchiesta di Mastelloni non prese il via successivamente all’incidente che coinvolse il velivolo il 23 novembre 1973, quando precipitò nei pressi di Porto Marghera causando la morte dei membri dell’equipaggio, quattro militari del Sismi. La tragedia, infatti, venne inizialmente attribuita ad un guasto e sulla vicenda calò il più totale silenzio, probabilmente anche in considerazione del fatto che l’“Argo 16” apparteneva ad una struttura allora segreta quale era Gladio nel 197364. Diversi anni dopo l’incidente, nel 1987, il generale del Sismi Ambrogio Viviani, fece una importante rivelazione in una intervista rilasciata al settimanale «Panorama». Egli sostenne che quello dell’“Argo 16” non era affatto stato un incidente quanto piuttosto un avvertimento del Mossad, un consiglio un po’ cruento per dirci di smetterla […] col terrorismo arabo-palestinese65.
62
Lunedì 10 dicembre alle 7,30 un gruppo di brigatisti armati e travestiti con tute della Sip prelevò il cavalier Ettore Amerio nei pressi della sua abitazione portandolo in un “carcere del popolo”. Durante il rapimento vennero distribuiti comunicati in molte fabbriche del Nord: alla Fiat, all’Ansaldo Nucleare (Sampierdarena), alla Sit-Siemens (Milano), alla Breda (Porto Marghera), alla Breda (Sesto San Giovanni), all’Alfa (Arese), e poi a Piacenza, a Modena e sulla linea ferroviaria Milano-Luino. Cfr. Brigate rosse: che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto, a cura del Soccorso rosso, Feltrinelli, Milano 1976. 63 Proprio l’indagine di Mastelloni fece scoprire l’esistenza della “storica” base di addestramento dei reparti di Gladio a Capo Marrargiu in Sardegna. Fu per questo motivo che all’indagine venne opposto il “segreto di stato”. 64 Cfr. G. DE LUTIIS, Storia dei servizi segreti italiani, Ed. Riuniti, Roma 1984, p. 314. 65 «Panorama», 13 maggio 1987. Proprio a seguito di questa intervista il giudice istruttore veneziano Carlo Mastelloni (competente per territorio dato che l’aereo era precipitato a Marghera) aprì una indagine con la quale furono incriminati per stra-
105
ROBERTO BARTALI
Secondo la ricostruzione di Viviani (cui si oppose subito quella del generale Serravalle, già comandante di Gladio, che addebitava la tragedia a personale italiano), era stato proprio con quell’aereo che, pochissimi mesi prima della sua caduta, erano stati portati in Libia alcuni terroristi arabi accusati di progettare un attentato all’aeroporto di Fiumicino contro la compagnia di bandiera israeliana, la El Al. Dei cinque terroristi, arrestati a Ostia il 5 settembre 1973, due vennero subito rilasciati (l’11 novembre) e gli altri tre poco dopo, sebbene dietro cauzione. Tutti e cinque invece di restare in prigione vennero trasportati via Malta in Libia a cura degli agenti del Sid, per mezzo dell’“Argo 16” – C47 Douglas66. Cinque pericolosi terroristi, fermati dalle forze di polizia italiane, erano stati rilasciati e trasportati a Tripoli, e questo, secondo il generale, era avvenuto in ottemperanza ad un accordo segreto esistente tra l’Italia ed alcuni gruppi vicini all’Olp. Sempre secondo Viviani, il Mossad sabotò l’“Argo 16” come atto di ritorsione per l’impunità concessa ai terroristi arabi. La cosa è stata per altro confermata dall’ex presidente Francesco Cossiga: … un altro degli episodi legati all’accordo è la distruzione da parte dei servizi israeliani dell’aereo militare Argo 16, in dotazione al Sismi, come ritorsione alla “esfiltrazione” di cinque terroristi palestinesi arrestati in quanto avevano tentato di abbattere con missili terra-aria un aereo civile israeliano in partenza da Fiumicino […] l’esfiltrazione o fuga agevolata venne operata da agenti del nostro servizio, naturalmente d’accordo con la magistratura che giustamente talvolta fa eccezioni al principio dell’esercizio dell’azione penale 67. ge il capo del Mossad del 1973 (Zevi Zamir), il plenipotenziario del Mossad in Italia (Aba Essan) e cinque ufficiali del Sid accusati di aver coperto le vere ragioni dell’incidente aereo. L’inchiesta, iniziata nel 1988 da Mastelloni, si rivelò lunghissima ed oltremodo complessa, ma non portò alla condanna degli imputati. Sarebbe stato d’altronde strano il contrario, trattandosi di una operazione d’intelligence, dunque posta in essere con il massimo della cura onde evitare di lasciare tracce. 66 Su questo punto si veda il racconto fatto da Viviani in A. VIVIANI, Servizi segreti italiani, 1815-1985, Adnkronos libri, Roma 1986, p. 355. 67 ACM, Tratto dalla lettera inviata dal senatore a vita Francesco Cossiga al capogruppo di An in commissione Mitrokhin, Enzo Fragalà, in seguito dell’acquisizione agli atti, da parte dell’organismo parlamentare, di alcuni documenti relativi al periodo che precedette la strage alla stazione di Bologna.
106
Il Pci e le Brigate rosse
Per comprendere entrambi gli avvenimenti si deve tener presente una circostanza che solo da poco tempo è stata confermata. Nella seconda metà del 1973 il Governo italiano aveva fatto un accordo decisamente particolare con i gruppi del nazionalismo palestinesi, un accordo non esattamente vantaggioso per gli interessi israeliani. Si tratta di un patto, non scritto, che per quasi un decennio ha però inciso profondamente sulla nostra storia nazionale, tant’è che lo stesso Aldo Moro (che del patto fu uno dei realizzatori) lo rammenterà in diverse lettere durante la sua prigionia nella cosiddetta Prigione del Popolo delle Brigate rosse68. Sui campi di addestramento militare in Cecoslovacchia L’altro punto su cui vale la pena soffermarsi è, come già accennato, il viaggio di Salvatore Cacciapuoti a Praga. La circostanza, che per molti anni è rimasta sconosciuta al di fuori dell’ex partito comunista, venne confermata dalla stessa figlia di Cacciapuoti: 68 Aldo Moro descrive chiaramente le motivazioni che lo spinsero alla realizzazione del “patto” in una lettera recapitata a Renato Dell’Andro il 29 aprile 1978 durante il suo rapimento, precisamente quando affermò: «Lo Stato italiano, in vari modi, dispose la liberazione di detenuti, allo scopo di stornare grave danno minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata», ed ancora in una missiva inviata alla Democrazia Cristiana il 28 aprile 1978: «… per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. E, si noti, si trattava di minacce serie, temibili […] La necessità di fare uno strappo alla regola della legalità formale (in cambio c’era l’esilio) era stata riconosciuta». Si veda a questo proposito: A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2008, pp. 111, 141-142; un’edizione precedente delle lettere di Moro era stata pubblicata in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Brigate rosse, Kaos, Milano 1997. A dire il vero degli accenni a questo accordo segreto si erano avuti già nel 1978, quando il giornalista Carmine Pecorelli detto “Mino”, dalle pagine del suo informatissimo periodico «Op – Osservatore politico internazionale», il 10 ottobre 1978 aveva commentato una lettera che Aldo Moro aveva scritto a Flaminio Piccoli – recapitata il 29 aprile 1978 – dalla Prigione del popolo delle Br (si veda ora la raccolta curata da S. FLAMIGNI, Le idi di marzo. Il delitto Moro secondo Mino Pecorelli, Kaos, Milano 2006, pp. 364-365). Un’altra conferma dell’esistenza di questo patto venne successivamente fornita dall’ex capo del Sid Vito Miceli, nel 1981, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale «L’Espresso»: «Sulla base di precise direttive di Governo di cui erano al corrente tutti i ministri, prendemmo contatti con i palestinesi dei vari gruppi e ci accordammo per evitare attentati che coinvolgessero l’Italia. E le nostre trattative hanno reso buoni servizi al paese…». Cfr. «L’Espresso», intervista di Mario Scialoja, 10 marzo 1981.
107
ROBERTO BARTALI
… mio padre era stato incaricato da Enrico Berlinguer di denunciare al Governo cecoslovacco l’appoggio del suo Servizio segreto alle Brigate Rosse. Non dire chiaramente quale fosse il ruolo di mio padre allora all’interno del Comitato centrale di controllo del Partito Comunista Italiano di cui era vice presidente, quello di difesa del Pci di Berlinguer dagli attacchi di chi voleva sconfiggerne la linea politica, mi sembra veramente fare torto alla memoria di un uomo che ha passato nove anni della sua gioventù nelle carceri fasciste…69.
Quanto scritto dalla figlia di Salvatore Cacciapuoti, pur considerando l’enfasi emotiva con cui una figlia difende la memoria del defunto padre, assume rilievo per un duplice motivo: viene in primo luogo confermato, anche se indirettamente, che l’allora segretario del Pci Berlinguer era perfettamente a conoscenza dei rapporti tra Br e servizi del “campo socialista”70. In secondo luogo era ritenuto perfettamente possibile – oltre ad essere considerato corrispondente al vero – che questi rapporti avessero un fine ben preciso: quello di contrastare la politica riformista intrapresa dallo stesso Berlinguer71. Venendo nel merito dei viaggi di Cacciapuoti a Praga, la notizia venne alla luce una prima volta dalla lettura del testo di un verbale (proveniente dagli archivi del servizio segreto cecoslovacco StB e giunto all’attenzione della “Commissione Stragi” nell’autunno 1999) che era stato stilato nell’ottobre del 1975 da Antonin Vavrus, alto fun69
Alba Libera Cacciapuoti, figlia di Salvatore Cacciapuoti, Lettera all’onorevole D’Alema, vedi Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il “dossier Mitrokhin” e l’attività d’intelligence italiana, audizione dell’onorevole Massimo D’Alema, 3 febbraio 2004, resoconto stenografico della 51ª seduta, p. 17. 70 A distanza di anni lo stesso Leonardo Sciascia, in qualità di membro della Commissione Moro, si stupì del fatto che sebbene i riferimenti e le informative dei servizi segreti italiani parlassero chiaramente e con una certa sicurezza dell’addestramento militare di estremisti italiani in terra ceca a livello politico la cosa non avesse prodotto né causato reazioni del nostro paese. Anche per questo motivo, non condividendo la relazione “di maggioranza”, in modo particolare proprio sul punto relativo ai rapporti fra Br e paesi dell’Est, Sciascia decise di presentare autonomamente un proprio elaborato di minoranza. Si veda a tale proposito: L. SCIASCIA, L’affaire Moro. Con aggiunta la Relazione Parlamentare, Sellerio, Palermo 1983 (3ª ed. 1989); pp. 147-183; altra ed. Adelphi, Milano 1994 (10ª ed. 2007), pp. 159-196. 71 Sulla presenza di brigatisti in campi di addestramento paramilitare in Cecoslovacchia è importante sottolineare come in effetti i servizi di sicurezza italiani
108
Il Pci e le Brigate rosse
zionario del partito comunista cecoslovacco. Nel verbale – scritto da Vavrus il giorno successivo ad un incontro avuto con l’allora vicepresidente della “Commissione di controllo” del Pci Salvatore Cacciapuoti giunto a Praga in veste ufficiale – si legge che questi era stato inviato oltre cortina su preciso mandato del segretario Berlinguer con il preciso compito di chiedere alle autorità ceche di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con le italiane Brigate rosse. Vista l’importanza del documento è opportuno riportarlo con precisione, almeno nei suoi tratti salienti: Il compagno Cacciapuoti ha dichiarato che il vertice del Partito lo aveva incaricato di informare il Partito Comunista Cecoslovacco per quanto riguardava la gravità del problema delle cosiddette Brigate Rosse. Ha inoltre detto che gli organi di Stato italiani possedevano delle prove che questi gruppi avevano una delle sue basi sul territorio della Repubblica Socialista Cecoslovacca. Sono stati trovati documenti [dalle forze di polizia italiane, nda] che permetterebbero il movimento libero [dei terroristi] nella Repubblica Socialista Cecoslovacca. Il cittadino italiano a nome Franceschini al quale è stata fatta inaspettatamente la perquisizione dell’abitazione, possedeva il passaporto con il visto cecoslovacco appena rilasciato. Durante l’interrogatorio ha detto che stava per essere adescato per la collaborazione con i servizi d’informazione cecoslovacchi, rifiutando però l’offerta. Nella Repubblica Socialista Cecoslovacca vive Fabrizio Pelli e anche Curcio e Setti e probabilmente gli altri membri delle Br frequentavano la Repubblica Socialista Cecoslovacca. Il compagno Cacciapuoti ha inoltre dichiarato che gli organi cecoslovacchi
erano in possesso di riscontri oggettivi che lo provavano. Tra le tante trovo corretto porre l’accento soprattutto sulla testimonianza del generale Giovanni Romeo, già capo dell’Ufficio D del Sid e poi Direttore della prima divisione del Sismi, il quale di fronte alla “Commissione Stragi” ebbe a riferire che: «Sappiamo che uomini delle Br, e anche di Prima Linea, sono stati addestrati in Cecoslovacchia» (CpS, X Legislatura, audizione del generale Giovanni Romeo, 22 novembre 1990, 68º resoconto stenografico). A questa rivelazione, di per sé importante, se ne deve aggiungere un’altra di pari valore pronunciata nella stessa audizione, in seduta inizialmente segreta: «Quando tutti parlavano di dover affrontare il terrorismo mediante infiltrazioni, il reparto D lo aveva già fatto; ed è per questo che è pervenuto a quei risultati. Se questa informazione verrà fuori, molti uomini potranno correre pericoli». La desecretazione dell’audizione è avvenuta nel 1991 all’interno del volume scritto dai fratelli Cipriani: A. CIPRIANI e G. CIPRIANI, Sovranità limitata, cit., pp. 213-214.
109
ROBERTO BARTALI
dovevano essere informati di questa faccenda e aveva chiesto di cessare la collaborazione con questi elementi né tantomeno di dare loro sostegno […] Il vertice del Pci consiglia, nel caso nostri organi d’informazione usassero queste persone di dubbia reputazione, di troncare tutti i rapporti con esse. L’amico del Pci che ha trattenuto i documenti non può garantire di non essere obbligato a passarli e impedire di renderli pubblici. Il vertice del Pci si rende conto che la direzione principale della campagna nemica si rivolterà contro la Repubblica Socialista Cecoslovacca. Sarebbe però coinvolto anche il Pci, anche se indirettamente. Per questo i compagni [del Pci] hanno interesse di non far scoppiare questo affare72.
Dalla lettura del documento emergono diverse notizie interessanti. Anzi tutto emerge come nel 1975 ai vertici del partito comunista italiano fossero giunte da una fonte ritenuta attendibile notizie circa un collegamento tra la Cecoslovacchia socialista e le italiane Brigate rosse. Le informazioni provenivano da una fonte ritenuta estremamente affidabile, tanto da convincere l’allora segretario, Enrico Berlinguer a fare un “passo ufficiale” rilevante come l’invio di un alto dirigente di partito (e stimato ex partigiano) quale Salvatore Cacciapuoti. L’altro elemento interessante è che viene tirato in ballo il nome di Alberto Franceschini, co-fondatore delle Br con Mara Cagol e Renato Curcio, ed in oltre è indicato in modo specifico il contenuto dell’interrogatorio cui lo stesso Franceschini venne sottoposto dal magistrato torinese Gian Carlo Caselli nei giorni successivi al suo arresto, avvenuto l’8 settembre 1974. Il dattiloscritto dell’interrogatorio di Fraceschini, a quanto pare, era stato intercettato da un “amico del Pci”, che doveva quindi essere o un elemento dell’Arma dei carabinieri (che com’è noto portò brillantemente a termine l’arresto del duo Curcio-Franceschini) o, più probabilmente, una persona che lavorava nell’ambito della magistratura inquirente. Quale che fosse l’origine dell’informazione, la cosa su cui porre l’accento è che Berlinguer la ritenne comunque degna di considerazione, anche se per giungere ad inviare una persona di fiducia in visita ufficiale a Praga le conferme di cui disponeva devono essere state certamente più di una e, ovviamente, concordi.
72
Testo consultabile (sia in versione originale sia nella traduzione in italiano fatta dal Sismi) in: ACS, fasc. “Ever. sinistra” [eversione di sinistra] 9/3a, p. 13.
110
Il Pci e le Brigate rosse
Ad ulteriore conferma della validità del documento rinvenuto negli archivi della ex repubblica socialista ceca va considerato che, praticamente, le stesse notizie sono successivamente apparse, e con buona qualità descrittiva, nel report n. 143 del “dossier Mitrokhin” che ha per oggetto: «Brigate Rosse italiane: contatti tra i partiti comunisti di Cecoslovacchia e Italia: 1975 e 1978». Nel report, che dato l’interesse mi permetto nuovamente di citare integralmente, si legge: 1. Nel dicembre del 1975 Yuriy Andropov notificò quanto segue al Comitato Centrale del Pcus. Il Ministro degli Affari Interni Cecoslovacco, Obzina, aveva informato il rappresentante del Kgb sovietico a Praga di un incontro avvenuto il 16 settembre 1975. L’incontro era stato tra Antonin Vavrus, Capo del Dipartimento Internazionale del Comitato centrale del Partito Comunista Cecoslovacco e Salvatore Cacciapuoti, vice presidente della Commissione Centrale di Controllo del Partito Comunista Italiano (Pci). Cacciapuoti affermò di essere stato autorizzato dalla dirigenza del Pci a informare il Comitato centrale del Partito Comunista Cecoslovacco che le agenzie ufficiali italiane erano in possesso di alcuni documenti. Tali documenti confermavano che una delle basi dell’organizzazione terroristica italiana “Brigate Rosse” era ubicata in Cecoslovacchia e che le agenzie di sicurezza cecoslovacche stavano cooperando con essa. Questo fatto poteva essere usato contro il Pci. Vavrus aveva garantito a Cacciapuoti che il Ministero degli Affari Interni Cecoslovacco non aveva alcun contatto con i terroristi italiani. 2. Durante la sua visita a Mosca, Obzina disse al Kgb che il Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco aveva dato una calma ma decisa risposta al Comitato Centrale del Pci. 3. Le “Brigate Rosse” erano un’organizzazione di estrema sinistra fondata da Renato Curcio nel 1970. Operava su base di illegalità. 4. Il 4 maggio 1978, durante una conversazione con Vladimir Koucky Ambasciatore cecoslovacco in Italia, Giorgio Amendola membro del Presidium del Comitato Centrale del Pci, lo invitò ad essere prudente riguardo alle “Brigate Rosse”. Amendola disse che i contatti delle “Brigate Rosse” con la Cecoslovacchia e la loro presenza nel paese avrebbero potuto venir fuori durante un successivo processo a loro carico. 5. Anche Arturo Colombi, Presidente della Commissione di Controllo del Pci, aveva messo in guardia l’Ambasciatore cecoslovacco sulle “Brigate Rosse”. Egli aveva criticato il Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco perché non aveva dato risposta a specifiche domande in merito alle “Brigate Rosse”. Tali domande erano state poste da Cacciapuoti durante i colloqui di Praga. Il Comitato centrale del Pci non fu soddisfatto del categorico rifiuto sull’esistenza di alcun contatto tra la Cecoslovacchia e le “Brigate Rosse”.
111
ROBERTO BARTALI
6. Koucky era stato particolarmente turbato dal comportamento di Nikita Ryzhov, Ambasciatore sovietico in Italia. Questi rammentava ripetutamente a Koucky che aveva messo in guardia i rappresentanti cecoslovacchi in merito ai contatti con le “Brigate Rosse”, ma questi non gli avevano dato ascolto. Ryzhov era convinto che all’interno dell’Ambasciata cecoslovacca ci fosse qualcuno che, alle spalle di Koucky, era in contatto con le “Brigate Rosse”. Ryzhov aveva accusato Koucky di recare più danni che benefici associandosi con le “Brigate Rosse”73.
Dunque, secondo i servizi segreti sovietici, in tre diverse occasioni alcune personalità di livello, quali erano Amendola, l’ambasciatore sovietico a Roma Ryzhov ed il già citato Salvatore Cacciapuoti, accusarono senza mezzi termini, giri di parole né tema di smentita, i rappresentanti del governo di Praga di addestrare sul proprio territorio nazionale alcuni elementi delle Brigate rosse. Altro elemento di rilievo è il fatto che, a proposito delle parole pronunciate da Cacciapuoti, nel resoconto sovietico si parli di «agenzie ufficiali italiane», in altre parole dei servizi segreti, per indicare chi, all’interno dello Stato italiano, era in possesso di notizie sul collegamento tra Br e servizi cechi. Come sottolinea il report, lo stesso Ryzhov aveva rimproverato Koucky accusandolo di «recare più danni che benefici associandosi con le Brigate Rosse». In buona sostanza, anche l’ambasciatore sovietico era certo che questi rapporti esistessero. Tra l’altro di questi incontri (ma nel caso di Amendola potremmo parlare di “scontri”) venne informato anche l’allora ministro degli Interni Francesco Cossiga, segno evidente che sul tema della lotta al terrorismo la collaborazione tra Pci ed apparati dello Stato era già in corso. Cossiga testimoniò quanto accaduto durante la sua lunga audizione di fronte alla “Commissione Mitrokhin”:
73
Report n. 143 del “dossier Mitrokhin” (si veda Dossier Kgb, rapporto Mitrokhin, cit., pp. 118-119) e anche CH. ANDREW e V. MITROKHIN, The Mitrokhin Archive. The Kgb in Europe and the West, London, Allen Lane, The Penguin Press 1999, p. 389 (ed. it. parziale L’Archivio Mitrokhin. Le attività segrete del Kgb in Occidente. Con un’appendice sui documenti dell’Archivio Mitrokhin in Italia Milano, Rizzoli, Milano 1999, p. 373; rist. BUR, Milano 2007).
112
Il Pci e le Brigate rosse
Cossiga - Quello che invece so, perché ne fui informato dal Partito comunista italiano, è che ci furono due passi violenti, fra cui soprattutto quello di Amendola, il quale, poiché era accertato che alcuni delle Br erano stati addestrati in Cecoslovacchia, intervenne con l’ambasciata sovietica perché intervenissero con i cecoslovacchi dicendo di smetterla. Di questo fui informato dal ministro dell’interno ombra, Ugo Pecchioli. Presidente - È un episodio noto. Poi c’era stato anche l’invio di Cacciapuoti in un altro momento per la stessa identica ragione. Cossiga - Esatto, perché ogni tanto l’StB cecoslovacco si dava arie di indipendenza e allora l’ambasciata sovietica lo richiamava all’ordine74. Secondo il settimanale «Panorama», che per primo giunse ad avere accesso a certi documenti di provenienza cecoslovacca, la prima visita a Praga di Cacciapuoti è del settembre 1974. Ciò si desume dai documenti reperiti dal giornalista Fausto Biloslavo presso l’Ufficio d’investigazione e documentazione sui crimini del comunismo di Praga consegnategli dal dirigente di quell’amministrazione, Jan Frolik. Tra i documenti che Biloslavo sostiene aver acquisito ve ne è anche un altro di un qualche interesse. Si tratta di una nota inviata dal Ministero degli Affari Esteri ceco all’ambasciata di Roma con data 2 giugno 1976 in cui si afferma che: […] la delegazione del Comitato centrale del Pci guidata da Cacciapuoti ha riferito che il cittadino cecoslovacco Dagmar Hampl avrebbe visitato nel 1968 a Reggio Emilia il cittadino italiano Setti. Secondo Cacciapuoti Setti era allora iscritto al Pci e ora sarebbe attivo nell’ambito delle cosiddette Br. Tutte queste notizie sono state ricevute da un informatore del Pci attivo nell’ambito della polizia italiana75.
In buona sostanza Cacciapuoti, nel suo viaggio ufficiale a Praga, accusò i “compagni” cechi non solo di aver dato ospitalità a due giovani brigatisti, Pelli e Franceschini, il secondo dei quali era stato da poco tratto in arresto, ma anche di intrattenere rapporti con un altro
74
CpM, audizione del presidente emerito Francesco Cossiga, 24 febbraio 2004, resoconto stenografico della 53ª seduta, p. 18. 75 «Panorama», 28 ottobre 1999.
113
ROBERTO BARTALI
soggetto di nazionalità italiana, tale Setti, anch’egli proveniente dalla zona di Reggio Emilia ed «attivo nelle Br». La cosa, ovviamente, dovette colpire molto la Direzione nazionale delle Botteghe Oscure. Si noti come in merito ai viaggi di Salvatore Cacciapuoti a Praga le versioni fornite dal presidente emerito Cossiga e dall’ex deputato del Pci Gianni Cervetti convergono praticamente su tutto. Il primo, audito dalla “Commissione Mitrokhin”, fece una sorta di riassunto sullo stato della preparazione militare dei brigatisti in Cecoslovacchia, ed ebbe a riferire che: … I cecoslovacchi addestravano nei loro campi di addestramento terroristi di ogni genere […] Che non erano ancora Brigate Rosse. Alcuni di quelli entrarono nelle Brigate Rosse dopo essere stati addestrati. Non erano Brigate Rosse […] Addestravano chiunque si dichiarasse dei movimenti di liberazione. La cosa venne appresa perché […] vi era una folta rappresentanza di comunisti italiani a Praga, alcuni dei quali erano stati mandati dal Partito comunista per gestire Radio Praga, mentre altri erano quelli che Togliatti aveva fatto espatriare per i fatti successivi a Porzius, al triangolo della morte. Quando furono da questi informati che vi erano italiani nei campi e ne fui informato anche io dal Ministro dell’interno, Cacciapuoti fu mandato a Praga e Amendola prese di petto l’ambasciatore sovietico, a cui suggerì di dire ai compagni cecoslovacchi che erano matti, che il giorno in cui si sarebbe scoperto un fatto del genere avrebbero detto che c’erano loro dietro le Brigate Rosse. L’unico tra i Servizi coordinati dal Kgb che si prendeva qualche libertà era l’StB cecoslovacco76.
76
CpM, audizione del presidente emerito Francesco Cossiga, 26 febbraio 2004, resoconto stenografico della 54ª seduta, pp. 30-31. Di notevole interesse anche quanto testimoniato da Cossiga in riferimento ad una esplicita domanda dell’autore: «… tu sai che un agente del Kgb era il fratello di De Mauro… l’italianista, il linguista… la loro era una rete efficientissima… me lo raccontò un ex agente sovietico… che mi raccontò dell’opera di intossicazione che loro riuscirono a fare con Eugenio Scalfari e Jannuzzi per il golpe De Lorenzo… poi erano riusciti a intossicare il povero Zaccagnini mettendogli alle costole un agente, così che lui aveva creduto che dietro il rapimento Moro c’era la CIA… Loro erano bravissimi in quelle che chiamavano operazioni di Disinformatjia… di disinformazione… e c’è da chiedersi se anche l’operazione P2 non fosse un’altra opera di intossicazione, di disinformazione…». Testimonianza del presidente della Repubblica emerito Francesco Cossiga raccolta dall’autore e da Salvatore Sechi il 6 novembre 2006.
114
Il Pci e le Brigate rosse
Nelle dichiarazioni rese il 26 novembre 1999 alla Digos, Cervetti riferì che il partito di Berlinguer decise di inviare in Cecoslovacchia Cacciapuoti poiché Ugo Pecchioli «… era venuto in possesso di documentazione che sembrava provare rapporti tra le Brigate Rosse e le autorità cecoslovacche»77. D’altronde appare perfettamente logico quanto sostenuto dallo stesso Alberto Franceschini, nonostante che da parte sua continuino a giungere decise smentite circa un proprio addestramento cecoslovacco: Questa è un’altra cosa che vorrei spiegarmi: cioè non è possibile che questo [Cacciapuoti, nda] vada a Praga senza una documentazione adeguata…78.
Ai documenti e alle testimonianze va ancora aggiunto un ulteriore elemento: il fatto che Cacciapuoti prima, ed Amendola e Colombi poi, si siano recati dai “compagni” cecoslovacchi e durante degli incontri “ufficiali” abbiano fatto presente in modo ripetuto le ragioni del Pci, sta ad indicare che la direzione del partito fosse in possesso di elementi che provavano senza possibilità di errore l’addestramento delle Br nei campi siti in quel paese. L’elemento assume ulteriore conferma se si pensa che una personalità del calibro di Amendola, notoriamente pacata e riflessiva, non si sarebbe mai spinto a tanto, ossia non avrebbe mai compiuto un passo di tale rilevanza nei riguardi dell’ambasciatore cecoslovacco senza essere assolutamente certo di quanto andava a “rimproverare”. Un’altra spiegazione possibile, ma per nulla considerata da studiosi e consulenti, è che le notizie sull’addestramento dei brigatisti nei campi situati nei pressi di Praga siano pervenute al Pci direttamente dalla Cecoslovacchia, e più precisamente dagli ambienti del circolo Democrazia Popolare, da quella che era stata “Radio Oggi in Italia”, o comunque dagli esuli politici comunisti rifugiati in quel paese, persone che, evidentemente, avevano mantenuto contatti con i vertici di via delle Botteghe Oscure anche nel periodo successivo all’invasione sovietica del 196879. 77
Il verbale in questione venne pubblicato sul quotidiano «Libero» del 26 ottobre 2004. 78 Testimonianza di Alberto Franceschini raccolta dall’autore il 31 marzo 2006. 79 Cfr. R. TURI, Gladio Rossa. Una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra al caso Moro, Marsilio, Venezia 2004.
115
ROBERTO BARTALI
Si trattava, evidentemente, di “compagni” che conoscevano quegli ambiti nei quali si era storicamente svolta la preparazione politica e paramilitare, alla guerriglia ed al sabotaggio, e che dunque possono aver riferito notizie decisamente precise e circostanziate circa la nuova leva di giovani rivoluzionari che erano giunti oltrecortina. Per ovvie ragioni di sicurezza, o meglio, per non rivelare l’effettiva fonte, sia Cacciapuoti sia Colombi ed Amendola, nei rispettivi colloqui avuti con i rappresentanti cechi non si spinsero oltre l’affermazione di essere in possesso di notizie certe. L’addestramento dei comunisti italiani A tale riguardo è assolutamente degna di rilievo la Nota del centro C.S. [controspionaggio] di Bologna datata 30 settembre 1974 e citata interamente all’interno della richiesta di archiviazione del procedimento penale “Gladio Rossa”. In essa si legge infatti: Il recente arresto dei due esponenti delle Brigate Rosse Curcio Renato e Franceschini Alberto ha reso attuale nel Partito comunista il problema, già registrato negli anni ’60, relativo alla raccolta di notizie e documenti riguardanti la posizione dei comunisti italiani della così detta vecchia guardia (stalinisti) legati al partito comunista cecoslovacco. Il Partito comunista Italiano è venuto a conoscenza di questa situazione attraverso alcuni iscritti che recentemente sarebbero stati avvicinati da uomini legati al PC Cecoslovacco ed invitati ad entrare nella loro organizzazione […] I soggetti incaricati della operazione sarebbero ex funzionari aderenti all’Anpi e all’Anppia emarginati dal Pci dopo la destalinizzazione e che dopo la liberazione hanno soggiornato per lungo tempo in Cecoslovacchia per sottrarsi alla giustizia Italiana. […] Si tratta di uomini fedeli fino all’ultimo al Senatore Pietro Secchia e alla sua opposizione silenziosa ma ferma all’interno del partito. È convinzione del Pci che anche parecchi giovani appartenenti alla sinistra extraparlamentare facevano parte, in qualche modo, dell’Organizzazione. Non si spiegherebbe altrimenti il perché della ospitalità, libertà di movimento e copertura offerta dalla Cecoslovacchia a membri delle Brigate Rosse come Franceschini e Pelli […] I dirigenti del Pci sono persuasi che i cecoslovacchi non agiscano di propria iniziativa ma siano al servizio dei sovietici, per cui la situazione è ritenuta molto preoccupante 80.
80
ACM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Richiesta di archiviazione nel procedimento penale 8393/92 B “Ionta-De Ficchy”.
116
Il Pci e le Brigate rosse
Com’è facile notare l’appunto dei servizi segreti contiene una lunga serie di notizie di un certo rilievo, e tra l’altro perfettamente in linea con quanto sostenuto da Cacciapuoti nei colloqui di Praga: prima tra tutte la conferma che alcuni brigatisti fossero effettivamente stati in Cecoslovacchia. In secondo luogo si portava l’attenzione sulla notevole attività che l’StB ceco avrebbe svolto in Italia, ed in modo specifico nei confronti della vecchia guardia stalinista, composta da uomini vicini a Pietro Secchia ed al tempo stesso in contatto con gli ambienti italiani di Praga. Da ognuno di questi casi si evince la medesima considerazione, cioè che il vero bersaglio perseguito dai cechi, e quindi dai sovietici, non fosse altro che il Pci e la sua politica di lenta ma costante emancipazione dalla casa madre del comunismo internazionale. Proprio per questa ragione la situazione veniva ritenuta «molto preoccupante» dai vertici di Botteghe Oscure. Un ulteriore elemento su cui merita porre attenzione riguarda il fatto che una presentazione storica del tutto simile alla presente compaia anche nelle carte provenienti dall’archivio Cia-FoIA. In un documento del 1982, veniva effettuata una ricostruzione delle Brigate rosse al fine di far comprendere il carattere clamoroso del rapimento del generale americano James Lee Dozier. In esso si dava come acquisito che la repubblica comunista della Cecoslovacchia avesse storicamente fornito assistenza al gruppo e che numerosi tra i “founding fathers” brigatisti si erano recati nei campi di addestramento nei pressi di Praga fin dai primissimi anni ’70. Tale collaborazione si era mantenuta costante nel corso degli anni, ma – faceva notare il documento – aveva radici ben piantante nella storia, precisamente nei primi anni ’40, quando il paese iniziò a dare rifugio ed ospitalità ad estremisti comunisti provenienti dall’Italia81.
81
Archivio Cia-FoIA, doc. ID: 28693, pp. 13-14. Si noti come anche l’ex presidente israeliano Benjamin Netanyahu confermi questa ricostruzione aggiungendo altre notizie molto interessanti. A suo avviso, infatti, Pietro Secchia e Giangiacomo Feltrinelli sarebbero stati elementi di una stessa “rete” controllata dal primo e posta in essere dai servizi segreti sovietici; B. NETANYAHU, Fighting Terrorism: How democracies can defeat domestic and international terrorists, Farrar, New York 1995, pp. 54-55.
117
ROBERTO BARTALI
A tutto ciò deve essere aggiunta la circostanza che dal 1967, anno del colpo di stato dei “colonnelli” in Grecia, la Direzione del Pci, sotto preciso input di Luigi Longo, aveva organizzato (sempre con la collaborazione “tecnica” dei sovietici) un nuovo apparato. Conosciuto con il nome di Vigilanza Democratica, fu messo a punto proprio per non far trovare il partito impreparato di fronte ad un eventuale golpe anche in Italia, visto che l’apparato “secchiano” era stato disarmato82. A tale fine alcune decine di militanti comunisti erano stati inviati oltre cortina per apprendere tecniche e direttive utili a far sopravvivere il partito una volta che esso si fosse trovato in una condizione di clandestinità proprio a seguito di un colpo di stato “reazionario”83. La differenza che immediatamente dovette risaltare agli occhi di Enrico
82
A proposito della cosiddetta “Vigilanza Rivoluzionaria” del Pci, o “apparato secchiano”, si vedano: S. SECHI, L’esercito rosso. Il dipartimento di Stato e l’apparato militare del Pci, «Nuova Storia Contemporanea», n. 4 (maggio-giugno 2000), pp. 41 e sgg; G. P. PELIZZARO, La Gladio Rossa: dossier sulla più potente banda armata esistita in Italia, Settimo sigillo, Roma 1997; R. TURI, Gladio Rossa, cit.; V. ZASLAVSKY, L’apparato paramilitare comunista nell’Italia del dopoguerra (’45-’55), Relazione per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi; G. DONNO, La Gladio Rossa del Pci (1945-1967), Rubbettino, Soveria Mannelli 2001; S. SECHI, Compagno cittadino. Il Pci tra azione parlamentare e lotta armata, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. È corretto dire che a partire dalla metà degli anni ’50, più precisamente nel periodo compreso tra la morte di Stalin, la destituzione di Pietro Secchia dall’ufficio organizzazione del Pci e la nascita del “Patto di Varsavia” (dunque con la stabilizzazione della guerra fredda a livello internazionale), la struttura paramilitare legata al partito comunista subì una profonda ristrutturazione – che giunse ai limiti del completo smantellamento – perdendo nel giro di pochi anni le sue caratteristiche di apparato “di massa” e, soprattutto, l’iniziale ruolo legato all’idea di quello che della struttura fu un po’ il padre fondatore e che fino alla morte (avvenuta nel 1973) restò il leader indiscusso dell’ala insurrezionalista del Pci: Pietro Secchia. Stando ai documenti fino ad oggi rinvenuti, ciò che sopravvisse della struttura furono piccole cellule, «ma composte da elementi fanatici e pronti a tutto», collegate in modo diretto con i servizi sovietici, tra i cui fini c’erano lo spionaggio militare ed industriale a favore di Mosca. Cfr. V. ZASLAVSKY, Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo. 1945-1991, Mondadori, Milano 2004, p. 114. 83 I fatti, e soprattutto alcune testimonianze, hanno dimostrato come in realtà i timori di un colpo di stato in Italia non erano frutto della fantasia dei leader co-
118
Il Pci e le Brigate rosse
Berlinguer risiedeva nel fatto che mentre era noto ed accettato che il partito comunista avesse inviato (e continuasse per ragioni differenti ad inviare) propri elementi a seguire corsi di politica e di addestramento di vario tipo, in Cecoslovacchia come in Unione Sovietica, fin dai primi anni del dopoguerra, nel caso delle Br i “compagni” cechi stavano addestrando non dei semplici militanti comunisti arrivati dall’Italia con il benestare del Pci, ma dei veri e propri terroristi, persone che una volta rientrate in Italia sarebbero entrate in clandestinità finendo per costituire un pericolo reale ed immediato (e non solo “potenziale”) per lo Stato italiano. Su questo punto decisamente interessante è stata la testimonianza del generale dell’Arma dei carabinieri Gian Paolo Sechi, già membro del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria che dal 1974 al 1975 venne messo in piedi e diretto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: Sechi - … Con Praga le Br avevano come un cordone ombelicale… avevano i soldi, facevano i master di addestramento… però quelli non dettavano la strategia al gruppo. Numericamente quanti sono stati? Sechi - Noi calcolammo che in Cecoslovacchia erano state in totale circa 900 persone… loro non erano moltissimi, e non tutti di questi diventarono terroristi… munisti ma si basavano su informazioni “reali”. Mi sia consentito di ricordare quanto l’ex segretario della Dc Arnaldo Forlani ebbe a dire l’8 novembre 1972 proprio a questo proposito: «Vi era stato un tentativo, forse il più pericoloso che la destra reazionaria abbia portato dalla Liberazione ad oggi, con una trama che aveva radici organizzative e finanziarie consistenti, che ha trovato solidarietà non soltanto di ordine interno ma anche di ordine internazionale. Questo tentativo disgregante non è finito, noi sappiamo in modo documentato, e sul terreno della nostra responsabilità, che questo tentativo è ancora in corso…». Si vedano a tale proposito anche: E. SOGNO e A. CAZZULLO, Testamento di un anticomunista. Dalla Resistenza al «golpe bianco», Mondadori, Milano 2000; P. CUCCHIARELLI e A. GIANNULI, Lo Stato parallelo. L’Italia “oscura” nei documenti e nelle relazioni della Commissione Stragi, Ed. Gamberetti, Roma 1997 e Tribunale Civile e Penale di Milano, Sentenza-Ordinanza del Giudice Istruttore di Milano, Guido Salvini nei confronti di Rognoni Giancarlo e altri, 3 febbraio 1998.
119
ROBERTO BARTALI
A che periodo si riferisce? Fine anni ’60 o anche prima? Sechi - Anche prima, diverse generazioni, diciamo in tutto 900 persone… all’inizio anche in Jugoslavia e non solo in Cecoslovacchia o a Mosca. […] Però non ci turbava più di tanto… quando parliamo di clandestini parliamo di gente che si dà una copertura per fare il terrorista, non che va a fare addestramento… se fosse stato solo quello non avremmo avuto una grandissima preoccupazione… o meglio, ci sarebbe stata preoccupazione per l’arma territoriale, ma quando le Br diventano clandestine lo fanno per portare l’attacco al cuore dello Stato, per ammazzare, per gambizzare… il discorso è diverso. Fino al ’70 che queste cose avvenissero non avevamo dubbi… il compito di stilare un elenco era dei servizi e delle forze di polizia… era importante sapere cosa facevano, dove si addestravano, che armi avevano… però fino al ’70 il pericolo c’era, era stato ben definito, ben contrastato… ma era un pericolo di eserciti contro eserciti con uno stile di guerra. Qui parliamo di terrorismo, è una nuova strategia, differente, che non ha a che fare con i fucili mitragliatori, con i carri armati, con le bombe anti-carro… il terrorismo ha un’altra strategia…84. Il quesito che sorge spontaneo è però un altro: quali ulteriori elementi erano in possesso di Enrico Berlinguer per fargli ritenere con estrema sicurezza che dietro le Brigate rosse si nascondesse [anche] l’attività – e l’interesse – dei servizi dell’Est?
84
Testimonianza del generale Gian Paolo Sechi raccolta dall’autore il 21 aprile 2007.
120
A PRAGA, A PRAGA! STORIA, LEGGENDE E MALCOSTUME DI UNA VICENDA ITALIANA
Fernando Orlandi
Nel nostro paese si è radicata ed è cresciuta una scuola di pensiero ricca di adepti, che indaga le vicende del passato attraverso il prisma dei misteri e dei complotti, comunemente indicata come “dietrologia”1. Le vicende del terrorismo italiano e in particolare l’affaire Moro sono state oggetto di numerose rivisitazioni che, a seconda dell’autore, puntano l’indice verso un composito panorama di burattinai, dai servizi segreti nostrani più o meno deviati, a quelli di Mosca e Washington, senza dimenticare un piccolo ruolo per Israele. I misteri affascinano il pubblico e pertanto queste pubblicazioni godono di successo editoriale, che purtroppo non viaggia in parallelo alla ricerca della verità. Soprattutto, l’affannosa caccia di qualche nuovo mistero fa dimenticare le origini indigene del fenomeno brigatista e più in generale del terrorismo italiano. La certezza del complotto occultato ha poi alimentato un metodo di raccolta dei materiali basato sull’uso parziale e selettivo delle fonti, evitando la consultazione e il riscontro con i documenti oramai da molti anni accessibili nei diversi archivi come, ad esempio, quelli della Repubblica ceca. Nei casi più gravi di uso scorretto della documentazione proveniente dagli archivi di polizia o dei servizi di intelligence, il materiale viene utilizzato senza neppure tenere conto delle avvertenze degli estensori. Inoltre, in modo francamente discutibile si utilizzano informative dei servizi segreti o provenienti da fonti di polizia, senza il minimo tentativo di riscontro con le altre fonti archivistiche, scambiando così la confidenza o la voce riferita in un appunto, ovvero una segnalazione da verificare, in qualcosa di già acclarato. Molto correttamente
1
Al riguardo si vedano le osservazioni in S. SECHI, Il delitto Moro: un esempio di “eversione atlantica”? Una discussione con Giuseppe De Lutiis, Centro studi sulla storia dell’Europa orientale, Levico Terme 2008 (Csseo Working Paper n. 133).
121
FERNANDO ORLANDI
l’ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del Sismi, nel corso della sua audizione alla Commissione stragi precisò, riferendosi proprio all’utilizzo di questo genere di carte di archivio dei servizi: Un’informativa di un centro Cs [Controspionaggio] non rappresenta assolutamente niente perché deve essere almeno confermata da altre due fonti, altrimenti è un pezzo di carta di nessun valore. […] Le carte che non sono confermate, che non diventano notizia ma sono la soffiata di un tizio qualsiasi, non rappresentano niente nella vita di un Servizio. Questo è un aspetto da tenere presente2.
Nel caso della Cecoslovacchia, paese e partito (Kscˇ) con il quale i comunisti italiani (Pci) hanno avuto un rapporto decisamente particolare (correttamente, è stato affermato che Praga era la «città privilegiata» dei comunisti italiani3), i dietrologi nostrani non si curano di consultare la documentazione disponibile per verificare le notizie sulle scuole di addestramento militare degli anni Cinquanta di cui a lungo si è parlato e che per alcuni di loro hanno costituito il retroterra di un addestramento di terroristi negli anni Settanta. Chi scrive, negli anni 1990-1994, ha anche avuto la possibilità di incontrare dopo non poche peripezie e molte ritrosie alcuni comunisti italiani che, dopo aver trovato riparo in quel paese, lì hanno poi ricostruito una propria esistenza, una seconda vita dietro il nome cospirativo assunto (e in qualche caso una nuova famiglia, a dispetto di quella lasciata in Italia). Per la maggior parte di queste persone le condizioni materiali di esistenza non sono state particolarmente fortunate, avendo condiviso, specialmente negli anni Cinquanta, la misera esistenza dei cechi, nelle campagne o in fabbrica, dispersi nel paese, lontano da Praga, in condizioni anche vicine all’indigenza, con una alimentazione, a volte, pressoché priva di frutta e verdura. Comunità prettamente maschili, con problemi relazionali e di integrazione, dovuti anche alla non conoscenza della lingua del paese ospitante. In condizioni non dissimili si trovavano altri rifugiati, ad esempio quelli provenienti dalla Grecia. Le persone con cui mi trovai a discutere al2
Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (CpS), 54º Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 6 ottobre 1999, p. 354. 3 K. BARTOŠEK, Zpráva o putování v komunistických archivech, Paseka, PrahaLitomyšl 2000, p. 117.
122
A Praga, a Praga!
l’inizio degli anni Novanta chiesero la garanzia dell’anonimato, e quindi non le ricorderò, sebbene mi siano servite per comprendere in modo più approfondito quelle vicende. Oggi disponiamo invece all’Archivio statale di Praga (Súa) l’accesso alle carte che concernono i rifugiati italiani e le loro attività, compresa la scuola di partito e l’emittente radiofonica «Oggi in Italia». I materiali si trovano soprattutto nel Fondo 100/3 (Kscˇ mezinárodní odde˘leni) e nel Fondo 19/7. Nella documentazione, gli italiani sono indicati con i nomi cospirativi assunti, ma in molti casi, grazie alla ricchezza delle carte, è possibile scioglierli in quelli reali. Fra i materiali si trovano anche molti file personali, rapporti, statistiche e anche materiale fotografico. Paradossalmente, ma forse ancora più significativamente, nessuno dei dietrologi nostrani si è peritato di andare a consultare queste carte4. Non si tratta solo di questioni linguistiche, che comunque andrebbero in ogni caso risolte, se si applicasse il rigoroso metodo scientifico che impone il riscontro di tutte le fonti accessibili, perché parte significativa di questi documenti è in italiano (alcuni sono redatti in francese e la restante parte in ceco). Mentre mi trovavo a Praga assieme ad alcuni membri del Centro studi sulla storia dell’Europa orientale nell’ambito di altra ricerca, nell’aprile 2006 ho potuto discutere con funzionari dello stato e dell’Úrˇad dokumentace a vyšetrˇování zlocˇinu˚ komunismu (Údvzk) della questione Brigate rosse (Br)-Cecoslovacchia. Nel corso di uno di questi incontri mi è stata offerta la possibilità di compulsare i faldoni contenenti tutta la documentazione disponibile e non ancora declassificata. Per quanto ho potuto vedere, posso affermare che non esiste un solo file re4
Ad oggi queste carte sono state utilizzate soltanto dallo storico Philip Cooke che ha pubblicato i seguenti lavori: From Partisan to Party Cadre: The Education of Italian Political Emigrants in Czechoslovakia, «Italian Studies», vol. 61, n. 1 (Spring 2006), 64-84; Da partigiano a quadro di partito: l’educazione degli emigrati politici italiani in Cecoslovacchia, «Ricerche storiche», a. 40, n. 101 (aprile 2006), pp. 9-38; Oggi in Italia: The Voice of Truth and Peace in Cold War Italy, «Modern Italy», vol. 12, n. 2 (giugno 2007), pp. 251-265; Oggi in Italia: La voce della verità e della pace nell'Italia della guerra fredda, «L’Impegno», a. 27, n. 1 (giugno 2007), pp. 39-54; e L’emigrazione politica in Cecoslovacchia e Italian Political Emigration to Czechoslovakia, entrambi in G. RANDO e J. HAGAN, a cura di, La diaspora italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. The Italian Diaspora after the Second World War, International AM Edizioni, Bivongi 2007, pp. 49-59 e 273-284.
123
FERNANDO ORLANDI
lativo ai primi anni Settanta (o ai Sessanta), quando invece un nutrito gruppo di italiani, secondo una vulgata prevalente, sarebbe stato addestrato in quel paese. Non solo, i file successivi sono stati aperti soprattutto su input provenienti dall’estero. Debbo anche confessare che quando ho goduto dell’opportunità di consultare i fascicoli sul terrorismo italiano non pensavo affatto a scrivere un contributo su questa vicenda, ero mosso maggiormente dalla curiosità, da quel desiderio di conoscenza che aleggia in tutti coloro che si occupano di storia. La scuola di Dobrˇ ichovice I legami politici e organizzativi fra i comunisti italiani e il partito fratello della Cecoslovacchia negli anni Cinquanta sono stati particolarmente stretti, molto più importanti di quelli, ad esempio, con i comunisti bulgari o polacchi, e si sono articolati su diversi piani. In aggiunta ai normali rapporti fra partiti fratelli, dopo la rottura tra Stalin e Tito, la Cecoslovacchia è divenuta una sorta di retrovia del comunismo italiano. Proprio come prima era particolarmente agevole il passaggio illegale in Jugoslavia, allo stesso modo lo era il trasferimento in Cecoslovacchia, controllando, fino al 1955, le truppe dell’Armata Rossa sovietica la parte orientale dell’Austria e fornendo il Partito comunista austriaco tutto il suo sostegno. La Cecoslovacchia subentrò così alla Jugoslavia quale territorio di rifugio, ospitando non solo comunisti italiani, ma anche greci e di altre nazionalità, che dovevano sottrarsi alla giustizia dei propri paesi. Per quanto riguarda lo specifico della Cecoslovacchia, abbiamo una iniziale emigrazione di italiani prima del “colpo di Praga” del febbraio 1948; una emigrazione di tipo economico, nel contesto di un accordo stipulato da Giuseppe Di Vittorio, che permetteva a un limitato numero di operai di trovare una nuova occupazione in quel paese5. Seguì l’emigrazione, ben più significativa, di coloro che ripararono illegalmente in Cecoslovacchia per sfuggire alla magistratura italiana, perseguiti per crimini commessi dopo la fine della guerra, ad esempio gli omicidi della Volante rossa o i molti assassinii perpetrati nel cosiddetto “triangolo della morte” emiliano. Si tratta di un consistente numero di militanti comunisti, spesso con un basso livello di educazione politica e culturale, con anche alcuni casi di analfabetismo. Riparati in 5
P. COOKE, L’emigrazione politica in Cecoslovacchia, cit., p. 49.
124
A Praga, a Praga!
Cecoslovacchia, vennero distribuiti in varie zone del paese: assunsero nomi di copertura, rispettarono le regole cospirative e lavorarono, spesso in pessime condizioni, in fattorie agricole, in fabbriche e anche nelle miniere. Delle procedure cospirative utilizzate del Pci troviamo indicazione anche in una testimonianza «fornita da un connazionale già espatriato clandestinamente in Cecoslovacchia e rientrato nel 1952» di cui riferisce un rapporto del novembre 1954 del maggiore Aldo Cappelli del Centro Cs di Bologna: gli apparati del Pci predisponevano con cura itinerari e accompagnatori, curando anche «l’invio alle rappresentanze del Pci in Cecoslovacchia di una biografia dell’espatriando con tutte le informazioni atte a ben lumeggiare la figura sotto ogni profilo»6. Attorno a questa emigrazione sono sorte diverse leggende, la principale delle quali racconta che almeno una parte di questi uomini seguì particolari corsi di addestramento militare alla guerriglia e al sabotaggio. Numerose sono le informative provenienti da Questure e Carabinieri come pure dai Centri Cs, dove si legge di «corsi per il perfezionamento di sabotatori», di «corsi di addestramento alla guerriglia, al sabotaggio, all’uso di armi automatiche», e di di «corsi di istruzione sulla guerriglia e sulla lotta partigiana». Nelle carte depositate negli archivi italiani si rinvengono fitti scambi fra il Ministero degli esteri, il Ministero dell’interno (in particolare la Divisione affari riservati), e il diplomatico Raniero Vanni d’Archirafi. Quest’ultimo, ad esempio, con una nota del 12 settembre 1950, comunica alla Farnesina che da una fonte della «massima attendibilità» ha appreso che a Dobrˇichovice (qualche decina di km da Praga, a mezza strada fra la capitale e il castello di Karlštejn), era stata istituita una «scuola di sabotaggio e attentati», gestita congiuntamente da cechi e sovietici. Quattrordici italiani avrebbero preso parte ai corsi7. 6
Sifar, Centro Cs di Bologna all’ufficio D di Roma, 29 novembre 1954, in Archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l’attività d’intelligence italiana (ACM), Raccolta dei materiali per il procedimento penale «Gladio Rossa». 7 Ministero degli affari esteri, Telespresso n. 16/18772 a Ministero dell’interno, 13 settembre 1950. Oggetto: Scuola di sabotaggio in Cecoslovacchia. L’ambasciata si premura di segnalare: «Questa Legazione non ha il mezzo per compiere altri accertamenti». Vedi anche Ministero degli affari esteri, Telespresso n. 16/20767 a Ministero dell’interno, 31 ottobre 1950. Oggetto: Italiani alla scuola di sabotaggio
125
FERNANDO ORLANDI
Con una certa regolarità negli anni successivi continuano a pervenire da informatori notizie su scuole di addestramento8. Un rapporto del Sifar indica fra gli «insegnanti» di una di queste «scuole per terroristi e propagandisti» Francesco Moranino9. Viene altresì ripetutamente segnalata la presenza di Giulio Paggio, alias Tenente Alvaro, alias Antonio Boffi, il capo della Volante rossa10. Di tanto in tanto, queste notizie affiorano anche sulle pagine dei giornali11. di Dobrˇichovice; Ministero degli affari esteri, Telespresso n. 219/[illeggibile] a Ministero dell’interno, 22 novembre 1950. Oggetto: Italiani alla scuola di sabotaggio di Dobrˇichovice, tutti riprodotti in G. DONNO, La Gladio rossa del Pci (19451967), Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, pp. 357-360. 8 Ad esempio Ufficio affari riservati, Documento 224/I-123, 19 maggio 1952. Oggetto: Scuole di sabotaggio in Cecoslovacchia, riprodotto in Idem, p. 360. 9 Sifar, Appunto [per la Presidenza del consiglio], 11 giugno 1952. Oggetto: Relazioni fra Pci e Cecoslovacchia, riprodotto in Idem, pp. 361-362. Moranino, condannato dal Tribunale speciale e comandante partigiano, nel 1946 fu eletto deputato alla Costituente. Sottosegretario alla Difesa con delega per l’esercito nel terzo governo De Gasperi, fu rieletto deputato nel 1948. Nel 1951 riparò in Cecoslovacchia. Rieletto parlamentare nel 1953, poté rientrare in Italia, ma fuggì nuovamente in Cecoslovacchia dopo che la Camera votò l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Nel 1953 Moranino fu nominato rappresentante del Pci nella Segreteria del Cominform e nella redazione della rivista «Per una pace stabile, per una democrazia popolare!». Segreteria del Pci a Ufficio di informazione dei partiti comunisti e operai, 23 marzo 1953, Fondazione Istituto Gramsci (FiG), Archivio del Partito comunista italiano (Apci), fondo M, mf 245-246. Processato in contumacia nell’aprile 1956, la Corte di assise di Firenze lo condannò all’ergastolo. La sua vicenda giudiziaria terminò nel 1964, con la grazia concessagli dall’allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Rientrato in Italia, nel 1968 Moranino fu eletto senatore. Sulla sua vicenda giudiziaria, si veda R. GREMMO, Il processo Moranino, Edizioni Storia ribelle, Biella 2005. A Praga Moranino era conosciuto come Franco Moretti. 10 Ad esempio Questura di Milano a Ministro dell’interno e Direzione generale di P.S., 17 ottobre 1952. Archivio del Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari riservati, fascicolo Z-20/E. Sulla Volante rossa vedi C. BERMANI, La Volante rossa (estate 1945-febbraio 1949), «Primo maggio», n. 9-10, inverno 1977-1978, pp. 81-106; C. BERMANI, Storia e mito della Volante rossa, Nuove Edizioni Internazionali, Milano, 1996; C. GUERRIERO e F. RONDINELLI, La Volante rossa, Datanews, Roma 1996; e M. RECCHIONI, Ultimi fuochi di resistenza: Storia di un combattente della Volante rossa, DeriveApprodi, Roma 2009. 11 Ad esempio A. VALCINI, Dove si insegna agli italiani come sabotare la democrazia, «Corriere della Sera», 9 luglio 1955.
126
A Praga, a Praga!
Le informative depositate negli archivi italiani fanno riferimento a varie scuole e corsi di addestramento militare, indicando sovente la già citata località di Dobrˇichovice. Sono notizie che, con il passare del tempo, tendono a moltiplicarsi12. Arriverà persino l’informazione che gli allievi italiani colà addestrati si apprestano a rientrare in patria per tentare una sorta di golpe. Leggiamo, infatti, in un Telespresso: L’informatore avrebbe saputo dalla moglie di uno di questi italiani, recentemente giunti nella scuola di sabotaggio, che in essa vi sarebbero molti istruttori russi e che i cosiddetti allievi dovrebbero rientrare in Italia verso il prossimo mese di febbraio [1951] – per tentare – si dice una specie di ‘putsch’ nel nostro paese.
Il documento conclude, avvertendo: «Quanto sopra riferisco, naturalmente, con ogni riserva, non avendo per ora possibilità di controllo»13. Come tutti ben sappiamo non si tentò nessuna «specie di ‘putsch’» nel nostro paese. Quella riferita, peraltro con le dovute cautele del caso, era una semplice voce raccolta. Questa «notizia», un documento che per serietà non andrebbe neppure citato, a meno che non si voglia discutere dei boatos che necessariamente gli apparati dello Stato si trovano a dovere recepire, viene accreditata in un recente volume di Rocco Turi14. E poiché nulla accadde in quel febbraio 1951, in modo altrettanto disinvolto l’autore conclude, senza ovviamente indicare una fonte a sostegno dell’affermazione: Il putsch programmato per il febbraio 1951 venne cancellato o rinviato a causa della scoperta, da parte dei vertici comunisti, della fuga di informazioni, ma sia l’attività informativa, da parte italiana, che quella eversiva, da parte cecoslovacca, continuarono per anni15.
12
R. TURI, Gladio rossa. Una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra al caso Moro, Marsilio, Venezia 2004, pp. 127-128 e i documenti citati. 13 Ambasciata italiana di Praga, Telespresso n. 2376/1438 a Ministero degli affari esteri, 31 ottobre 1950; e Ministero degli affari esteri, Telespresso n. 16/20767 a Ministero dell’interno, 31 ottobre 1950. Oggetto: Italiani alla scuola di sabotaggio di Dobrˇichovice, riprodotto in G. DONNO, La Gladio rossa, cit., p. 358. 14 R. TURI, Gladio rossa, cit., p. 125. 15 Ivi, p. 127.
127
FERNANDO ORLANDI
Il tentativo di confermare una tesi fa sì che invece di ricostruire la concreta vicenda dei comunisti italiani in Cecoslovacchia prevalgano le congetture. Quello che il rigore metodologico imporrebbe è riscontrare le informative dei nostri archivi con il database delle informazioni pubbliche e le accessibili carte della sezione internazionale del Kscˇ che riguardano gli italiani. Per quanto riguarda date e tempi, è pacifico che la scuola di addestramento a sabotaggi e attentati di Dobrˇichovice sia la stessa di cui parlano in dettaglio le carte di archivio di Praga. Ma la storia che questi documenti ci raccontano con dovizia di particolari è ben diversa da quella riferita nelle non riscontrate informative già citate16. La proposta di istituire una scuola politica per gli italiani venne avanzata dal partito fratello nel 194917. Trovò sede in una villetta di Dobrˇichovice, e fu attiva per tre anni, dal 1950 al 1952. Le carte d’archivio bene documentano la selezione degli allievi, a partire dalle dettagliate «caratteristiche», ovvero le biografie. È interessante osservare come le note fossero critiche, esprimendo riserve sui candidati, specie per quanto riguardava la «mentalità partigiana» e settaria18. Verso la fine di novembre 1949 Pietro Secchia scrive a Bedrˇich Geminder, capo della Sezione internazionale della Segreteria del Kscˇ: l’obiettivo della scuola è formare dei quadri in grado di svolgere un adeguato lavoro politico fra gli esuli italiani. Il primo corso durerà un anno, i selezionati saranno cinquanta e il corso sarà modulato sulla base di quelli organizzati in Italia dalla scuola centrale del Pci (quella delle Frattocchie, l’Istituto di studi comunisti, inizialmente intitolato a Andrei Zhdanov e successivamente a Palmiro Togliatti)19. L’organizzazione del corso viene affidata a Silvio Bertona (alias Secondo Villa),
16
I documenti sono stati studiati da Philip Cooke che ne ha dato conto in From Partisan to Party Cadre, cit.; e Da partigiano a quadro di partito, cit. 17 Roberto Dotti alla dirigenza del Pci e del Kscˇ, Súa, Kscˇ, fond 100/3, sv. 56, a.j. 265, pp. 33-39. 18 Questo aspetto è stato opportunamente messo in evidenza da Philip Cooke nei due lavori già citati. Vedi anche le osservazioni di AraldoTolomelli in L. TESTA, «La vita è lotta». Storia di un comunista emiliano, Diabasis, Reggio Emilia 2007, pp. 192-193. 19 Pietro Secchia a Bedrˇich Geminder, 21 novembre 1949, Súa, Kscˇ, fond 100/3, sv. 56, a.j. 265, p. 41.
128
A Praga, a Praga!
già insegnante alla Frattocchie20. I corsi si tengono in italiano e a parte viene insegnata un po’ di lingua ceca. Alcune lezioni sono tenute da insegnanti cechi e russi, ma comunque in lingua italiana. Lo scopo della scuola, scrive nel gennaio 1951 Domenico Ciufoli (alias Paolo Belli), all’epoca suo direttore, responsabile dei fuoriusciti italiani e membro del Comitato centrale (Cc) del Pci, a Bedrˇich Geminder, è fornire «ai nostri compagni partigiani la preparazione ideologica che non hanno avuto o il tempo di avere in montagna»21. La scuola di Dobrˇichovice, insomma, altro non era che una sorte di clone di quella delle Frattocchie e dal piano di studi, intenso e identico a quello romano, non si evince alcuna attività militare o paramilitare. Certo, non si può escludere che vi siano stati casi di selezionati quadri del partito avviati ad un addestramento militare o alle tecniche dello spionaggio. Ma questo non è stato il caso di Dobrˇichovice. Va inoltre osservato che di queste attività, come conosciamo dalla documentazione disponibile, si occupava direttamente il Kgb (Comitato per la sicurezza di stato) e gli addestramenti speciali per stranieri venivano generalmente effettuati in Unione sovietica. Dei corsi Vystrel di addestramento al combattimento e al sabotaggio e di quelli dove venivano insegnate le tecniche dello spionaggio, ci informa, ad esempio, un report originato da Vasilii Mitrokhin. Si tenevano a Solnechnogorsk, una cittadina nell’Oblast’ di Mosca, a circa 65 km dalla capitale22. Per quanto riguarda la Cecoslovacchia, sono circolate voci, ma senza particolari elementi di riscontro, in relazione ad addestramenti per le radiotrasmissioni in cifra ad alta frequenza e a procedure dello spionaggio, corsi che si sarebbero tenuti in una struttura alle dipendenze del Ministero dell’interno a Zastávka u Brna, località a poco più di 20 km a nord-ovest di Brno23. Di Zastávka u Brna troviamo 20 La sua relazione del 25 gennaio 1950 fornisce dettagli sull’organizzazione della scuola. Súa, Kscˇ, fond 19/7, sv. 198, pp. 9-11. 21 Domenico Ciufoli a Bedrˇ ich Geminder, 31 gennaio 1951, Súa, Ksc ˇ, fond 100/3, sv. 56, a.j. 265, p. 90. 22 Impedian Report n. 118, 6 ottobre 1995: Use of Illegals for Sabotage Operations, paragrafi 72 e 73. 23 Conversazione con un funzionario dell’Údvzk, 20 aprile 2006. Vedi anche polizia della Repubblica ceca, Ufficio investigativo della Repubblica ceca, Verbale di deposizione del testimone Jan Frolík, Praga 29 luglio 1998, p. 13, all. 1 a Procura della Repubblica di Roma a Commissione stragi, 6 aprile 1999, Archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (ACS), fascicolo «Eversione di sinistra», 9/3, p. 13.
129
FERNANDO ORLANDI
menzione anche in alcuni documenti redatti dal Sisde nel 1990: in un appunto del luglio si legge che in quella località si trovava uno dei campi di addestramento anche per terroristi italiani organizzati dal Kgb in territorio ceco24, e da una successiva nota dell’agosto 1990, si apprende che lì esisteva un centro di addestramento per terroristi provenienti dal Medio oriente25. Per quanto riguarda il Pci, gli addestramenti speciali di quadri effettuati in Unione sovietica dal Kgb continuano ancora negli anni Settanta. Ad esempio, nella seduta del Politbyuro del Partito comunista dell’Unione sovietica (Pcus) del 5 maggio 1974 si approva l’invio a Mosca di un gruppo di diciannove italiani affinché siano addestrati nelle scuole speciali del Kgb alle tecniche dell’organizzazione illegale e delle trasmissioni in cifra. Si approva pure la fornitura di 550 passaporti italiani falsi e altri 50 documenti d’identità svizzeri e francesi stampati nei laboratori del Kgb. Sempre su richiesta del Pci, Mosca elabora programmi di comunicazione cifrata per consentire trasmissioni «coperte» di messaggi all’interno di una rete di centri regionali26. Un contemporaneo messaggio viene inviato al residente del Kgb a Roma per comunicare a Armando Cossutta la deliberazione adottata27. Il 30 gennaio 1976 Boris Ponomarev informa il Politbyuro che Ugo Pecchioli, «su incarico della direzione del Pci» chiede che sette italiani effettuino un «corso di preparazione speciale» in Unione sovietica. Pecchioli chiede altresì cento documenti italiani falsi28. Pochi giorni dopo la richiesta è accolta29. Uno dei sette, che per essere ad24
Sisde, Appunto, 10 luglio 1990, p. 1, all. 5 a Idem. Sisde a Segreteria speciale del Gabinetto del Ministero dell’interno, 21 agosto 1990, cit. in R. BARTALI, L’ombra di Yalta sugli anni di piombo: Le origini del fenomeno brigatista nel contesto italiano ed internazionale, tesi di dottorato, Università degli studi di Siena, Scuola di dottorato in scienze giuridiche, storiche e sociali, XX ciclo, 2008, p. 277. 26 Estratto dal verbale n. 136 della seduta del Politbyuro del Cc del 5 maggio 1974: Assistenza speciale al Pci, trad. in V. RIVA, Oro da Mosca, Mondadori, Milano 1999, p. 742; anche V. BUKOVSKIJ, Gli archivi segreti di Mosca, Spirali, Milano 1999, pp. 47-48. 27 Allegato al punto 53 del verb. n. 136: Al residente del Kgb a Roma, 5 maggio 1974, trad. in V. RIVA, Oro da Mosca, cit., p. 743. 28 Al Cc del Pcus: Assistenza speciale al Pci, 30 gennaio 1976, trad. in Idem, pp. 752-753. 29 Estratto dal verbale n. 203 della seduta del Politbyuro del Cc del 5 febbraio 1976: Assistenza speciale al Pci, trad. in Idem, p. 753. 25
130
A Praga, a Praga!
destrato arriva in Unione sovietica via Bulgaria, è Domenico Dardi30. Nel gennaio 1979 altri quindici comunisti vanno in Unione sovietica “per un corso di addestramento speciale di tre mesi per ciascuno”31. Queste attività illegali proseguono almeno “fino al 1981”32. Alla fine del 1969 un “centro di trasmissione per i collegamenti radio clandestini del Pci”, gestito dal Kgb, era stato allestito a Sofia33. Ma dopo l’attentato a Papa Giovanni Paolo II (13 maggio 1981) il Pci si preoccupa e per il tramite di Franco Raparelli, fidato collaboratore di Pecchioli, comunica al Kgb la decisione “di smantellare e distruggere per ragioni di sicurezza tre stazioni radio ricetrasmittenti” clandestine che si trovano in Italia34. È assai probabile che lo smantellamento delle radio sia stato deciso, come ha osservato Francesco Bigazzi, per il timore che venisse scoperto il collegamento con Sofia35. “Oggi in Italia” A Praga, per timori e motivi di sicurezza, il Pci negli anni Cinquanta trasferisce il suo archivio. A tale fine, il 22 gennaio 1952 Palmiro Togliatti scrive a Klement Gottwald, e poi, per definire i dettagli invia nella capitale cecoslovacca Luigi Amadesi, il suo segretario personale, che il 30 gennaio, accompagnato da Matteo Secchia, incontra Anna Baramová, responsabile del Dipartimento internazionale del Kscˇ. Il giorno successivo Amadesi si incontra anche con Antonín Novotný, segretario del Cc e Bruno Köhler, capo della Sezione quadri del Kscˇ. L’accordo è subito raggiunto: gli archivi del Pci saranno trasferiti nell’edificio del Cc del Kscˇ 36. Di lì a poco inizia il trasferimento, di cui si occupa Giulio Seniga, stretto collaboratore di Secchia nella potente e cruciale Commis30
Alla Sezione amministrativa del Cc de Pcus, 5 maggio 1977, trad. in Idem, p. 763. Estratto dal verbale n. 143 § 8gs della Segreteria del Cc, 17 gennaio 1979; e Delibera della Segreteria del Cc del Pcus sulla richiesta della Direzione del Pci, 17 gennaio 1979; entrambi trad. in S. BERTELLI e F. BIGAZZI, Pci: la storia dimenticata, Mondadori, Milano 2001, pp. 372-373. 32 F. BIGAZZI, Baffi finti e passaporti falsi, in Idem, p. 371. 33 Al Cc del Pcus, trad. in Idem, pp. 366-367. 34 V. A. Kryuchkov a B. N. Ponomarev, 22 giugno 1981, trad. in Idem, p. 371. 35 F. BIGAZZI, Baffi finti e passaporti falsi, cit., p. 371. 36 Colloquio, Anna Baranová con Luigi Amadesi e Matteo Secchia, 30 gennaio 1952; e Colloquio, Antonín Novotný e Bruno Köhler con Luigi Amadesi, 31 gennaio 1952, entrambi in Súa, Kscˇ, f. 100/24, sv. 71, a.j. 1117. Vedi anche K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., p. 117. 31
131
FERNANDO ORLANDI
sione d’organizzazione e viceresponsabile dell’altrettanto importante Commissione nazionale di vigilanza, assieme alla sua compagna, Anita Galliussi37. Da Praga, poco dopo, gli archivi saranno trasferiti a Mosca, sotto la supervisione di Rita Montagnana. Praga è importante anche per gli aiuti finanziari al Pci, che non arrivano solo da Mosca e solo con trasferimenti diretti di denaro in divise convertibili38, ma anche con percentuali sugli accordi commerciali39. È questo un capitolo della storia del Pci ancora da scrivere. L’attività sembra avere preso il via all’inizio del 1948, quando Matteo Secchia suggerì all’ambasciatore sovietico a Roma Mikhail Kostylev di collegare agli accordi commerciali, che imprenditori e società italiane stipulavano con l’Unione sovietica, dei finanziamenti al Pci. La stessa pratica viene poi introdotta in tutti i paesi del blocco sovietico40. Per quanto concerne la Cecoslovacchia, nel giugno 1950 Eugenio Reale e Durdo41, discutono e si lamentano con la Segreteria del Kscˇ delle società commerciali che rappresentano la Cecoslovacchia in Italia. Sostengono che sono nelle mani di «elementi ostili» (neprˇátelských elementu˚) e per questo vanno rimpiazzate da altre, «molto più democratiche» (daleko demokraticˇtejší), vale a dire che aiutino economicamente il Pci. Subito dopo, il 16 giugno Reale si incontra con una nutrita delegazione guidata dal vice ministro per il commercio estero Rudolf Margolius. Firmano un lungo accordo, il testo redatto in francese, con il quale il Pci ottiene tutto ciò che desiderava42. Attorno a questi traffici commerciali si sus37
Archivio Pietro Secchia, «Annali» [Fondazione Giangiacomo Feltrinelli], a. 19 (1978), Feltrinelli, Milano 1979, p. 437. 38 G. CERVETTI, L’oro di Mosca, Baldini & Castoldi, Milano 1993; V. ZASLAVSKY, I finanziamenti sovietici alle forze politiche italiane di sinistra, «Nuova storia contemporanea», a. 3, n. 6 (novembre-dicembre 1999), pp. 29-54; M. TORTORELLA e F. BIGAZZI, Oro da Mosca: l’ultimo capitolo, in S. BERTELLI e F. BIGAZZI, Pci: la storia dimenticata, cit., pp. 383-391; e soprattutto V. RIVA, Oro da Mosca, cit. 39 Vedi Colloquio, Mikhail A. Kostylev con Matteo Secchia, 6 marzo 1948, Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Federatsii (AvpRf), fond 09, opis’ 31, delo 14, papka 179, pp. 170-171, cit. in E. AGA-ROSSI e V. ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin, Il Mulino, Bologna 1997, p. 253. 40 K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., p. 123. 41 Non sono stato in grado di identificarlo. 42 Procès-verbal concernant les pourparlers sur les modifications de l’organisation de représentation en Italie, 16 giugno 1952, Súa, Kscˇ, f. Rudolf Margolius, Z 18 4628, III. cást. Vedi anche, per dettagli e società coinvolte, K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., pp. 123-125.
132
A Praga, a Praga!
seguono gli incontri fra dirigenti del Pci e del Kscˇ. Il 16-20 luglio 1951 è la volta di Giangiacomo Feltrinelli. Si presenta con una lettera di Pietro Secchia, dove si assicura che gode della piena fiducia del Pci e viene per sistemare un affare di cui ha già informato Reale43. Poi ci sono i finanziamenti diretti. Ad esempio, il 2 agosto 1949 Eugenio Reale trasmette a Bedrˇ ich Geminder una «richiesta di Togliatti» (prˇ ání s. Togliattiho) di 150.000 dollari. Ne otterrà immediatamente 75.00044. Sempre nella capitale cecoslovacca un piccolo numero di italiani lavora in due emittenti radiofoniche: alcuni alle trasmissioni in lingua italiana della statale «Radio Praga», altri in modo cospirativo all’emittente «Oggi in Italia». È il Partito comunista francese, alla riunione della Segreteria del Cominform dell’aprile 1950, a sollevare la questione delle trasmissioni radiofoniche per Francia, Italia e Belgio. Su proposta del Kscˇ e del Partito operaio rumeno si decide di predisporre speciali apparecchi trasmittenti in onde medie e corte. Italiani e francesi avrebbero dovuto fornire il personale. Alla riunione di novembre della Segreteria si fa il punto della situazione. Per il Pci, Luigi Amadesi prepara una nota in cui informa dell’accordo raggiunto con il Kscˇ in base al quale da Praga verranno effettuate speciali trasmissioni, in aggiunta a quelle ufficiali di «Radio Praga» in italiano. Una redazione di cinque persone è pronta ad operare45. Amadesi aggiunge che sarebbe opportuno effettuare anche delle trasmissioni da Budapest. Gli italiani invieranno materiali per via aerea o a mezzo del telefono46. Il mese successivo 43 Súa, Ksc ˇ, f. 100/3, sv. 14, a.j. 49b. Vedi anche K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., p. 125. 44 La richiesta è riassunta in una nota di Bedrˇich Geminder a Rudolf Slánský, 12 agosto 1949, Súa, Kscˇ, fond 100/3, sv. 48, a.j. 221. Vedi anche K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., pp. 121-122. 45 Tutti riparati in Cecoslovacchia per sottrarsi alla giustizia: Francesco Moranino (Franco Moretti), AraldoTolomelli (Aldo Tognotti), Francesco Nulchis (Francesco Orsini), Bruno Montanari (Cesare Zerbini) e Vincenzo Guarisco (Guido Marinoni). Súa, Kscˇ, fond 100/3, sv. 53, a.j. 261, p. 21. 46 Nota informativa di Amadesi sull’organizzazione di trasmissioni radiofoniche per l’Italia dai paesi di democrazia popolare, novembre 1950, in F. GORI e S. PONS, a cura di, Dagli archivi di Mosca, Carocci, Roma 1998, pp. 415-416. Vedi anche n. 128, p. 438.
133
FERNANDO ORLANDI
prendono il via le trasmissioni di «Oggi in Italia»47, che risponde a un ufficio di coordinamento del Pci, a Roma48. Le trasmissioni, inizialmente molto brevi, sembravano provenire dall’Italia. Con il corso degli anni le emissioni si moltiplicarono. Ad esempio, nel 1954 le trasmissioni erano otto al giorno, ognuna di trenta minuti, parte in onde corte, parte in onde medie49, suscitando anche alcune proteste diplomatiche dell’Italia. A metà degli anni Sessanta la contesa che oppone Mosca e Pechino si riverbera in tutto il movimento comunista internazionale, dove si serrano i ranghi. Al Kscˇ alcune delle posizioni assunte dal Pci suonano eterodosse, non in linea con quelle di Mosca, e «Oggi in Italia», proprio perché aveva sede a Praga e seguiva la linea politica dettata da Botteghe Oscure, alla fine del 1964 inizia a trovarsi in difficoltà, rischiando di divenire vittima indiretta della contesa ideologica. Alla fine di quell’anno, infatti, la dirigenza del Kscˇ valuta se chiudere la radio, trasferirla in un altro paese o unificare le trasmissioni con il servizio in lingua italiana di «Radio Praga». A Roma sono bene al corrente di quanto sta accadendo, e se ne preoccupano50. Viene così inviata in Cecoslovacchia una delegazione guidata da Arturo Colombi, presidente della Commissione centrale di controllo. Gli italiani si incontrano con Vladimír Koucký (anni dopo lo ritroveremo ambasciatore a Roma), Oldrich Kaderka e altri esponenti del Kscˇ. L’accordo raggiunto prevede l’ulteriore correzione dei toni polemici delle trasmissioni, ma soprattutto: 47
La vicenda di «Oggi in Italia» è assai poco studiata. Si vedano, di Philip Cooke, Oggi in Italia: The Voice of Truth and Peace in Cold War Italy, cit.; e Oggi in Italia: La voce della verità e della pace nell'Italia della guerra fredda, cit. AraldoTolomelli, che per molti anni diresse i programmi della radio, nel 1966 rientrò in Italia, dove venne eletto senatore. Recentemente è stata pubblicata una sua biografia in forma di intervista, L. TESTA, «La vita è lotta», cit. 48 G. GOZZINI e R. MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. 7, Einaudi, Torino 1998, p. 153; e K. BARTOŠEK, Zpráva o putování, cit., p. 120. A svolgere il ruolo di coordinatori a Roma si succederanno Carlo Farini, Mario Benocci e Alessandro Pecorari. Conversazione con Luciano Antonetti, 16 febbraio 2009. 49 «l’Unità» pubblicava con risalto frequenze e orari dei programmi. 50 Conversazione con Araldo Tolomelli, 16 febbraio 2009; e A. PECORARI, Promemoria sulle questioni di «Oggi in Italia», 11 novembre 1965, FiG, Apci, 0527, 1972-1974.
134
A Praga, a Praga!
Fare in modo che nei programmi di «Oggi in Italia» non vengano riprese notizie, o servizi, sui problemi del movimento operaio internazionale, che possano essere in qualche modo in contrasto con l’atteggiamento che, verso di essi, viene osservato dal Partito cecoslovacco51.
Si dovrà anche cercare di coordinare i programmi con il servizio italiano di «Radio Praga», al fine di evitare «una differenziazione tra le posizioni del nostro Partito e quello cecoslovacco». Questi sforzi, tuttavia, «non hanno portato a risultati soddisfacenti e non sempre per colpa nostra»52. Così i problemi rimangono e alla fine del 1965 sembra «sia stata genericamente formulata anche la richiesta di una specie di fusione fra ‘Oggi in Italia’» e il servizio italiano di «Radio Praga»53. La prospettiva era preoccupante anche da un altro punto di vista, perché Josef Skála, che grosso modo dal 1960 al 1968 diresse il servizio italiano di «Radio Praga» aveva fama di essere strettamente legato alla sicurezza di Stato ceca. I rapporti cambiano decisamente con l’ascesa al potere di Alexander Dubcˇek e il deciso sostegno degli italiani alla Primavera di Praga. Alla fine di marzo, il segretario del Pci Luigi Longo afferma che quanto avviene in Cecoslovacchia fornisce anche un modello di rinnovamento dei regimi socialisti54. L’invasione e la successiva «normalizzazione» segnano il declino e la fine della radio. Creata in modo cospirativo, l’ubicazione dell’emittente era nota a pochi, e la villetta da cui trasmetteva mascherava bene il suo reale utilizzo (si trovava nella zona di Nusle, in Nad Nuslemi). Quando i sovietici, subito dopo l’invasione, presero il controllo degli studi e degli impianti di trasmissione della radio e della televisione statale cecoslovacca, proprio le strutture di «Oggi in Italia», di cui non erano a conoscenza, assieme ad altri impianti di trasmissione55, vennero utilizzate per nove giorni per mettere in onda programmi dei dubcˇekiani. Fra l’altro vennero trasmessi anche i lavori del Quattordicesimo congresso straordinario del Kscˇ, tenuto clandestinamente all’interno di una grande fabbrica di
51
Idem, 0527, 1973. Ivi. 53 Idem, 0527, 1974. 54 L. LONGO, È ora di cambiare, «l’Unità», 28 marzo 1968. 55 J. PELIKÁN, Il fuoco di Praga, Feltrinelli, Milano 1978, p. 201. 52
135
FERNANDO ORLANDI
Vysocˇany56, L’emittente venne scoperta solo dopo l’arrivo a Praga di speciali apparecchiature e di tecnici del Kgb57. Compromessi agli occhi della nuova dirigenza che aveva preso il potere per essersi schierati e avere collaborato anche dopo l’invasione con i dubcˇekiani (in questo riflettendo la posizione del Pci, che aveva manifestato pubblicamente il «grave dissenso» per l’intervento militare), per i redattori di «Oggi in Italia» fu l’inizio della fine. Le trasmissioni dell’emittente, infatti, cessarono dopo qualche mese, nella primavera del 1969, con lo smantellamento della redazione. Alcuni dei dipendenti andarono a lavorare al servizio in lingua italiana di «Radio Praga», altri rientrarono in Italia e i restanti intrapresero attività commerciali58. Nell’estate del 1969, a dispetto dei tentativi di farlo reintegrare, venne licenziato Ignazio Salemi (andrà a lavorare per conto del partito fra gli emigrati italiani in Australia), mentre i rapporti fra Pci e Kscˇ diventarono sempre più tesi, fino alla pressoché totale interruzione del 197459. Nel marzo 1976 si chiuse definitivamente la vicenda, quando i cecoslovacchi licenziarono gli ultimi otto italiani (redattori e tecnici) per non aver rispettato un ordine del Kscˇ che imponeva a tutto il personale dell’ente radiotelevisivo di Stato di segnalare con relazioni in triplice copia ogni contatto con cittadini stranieri, dalle conversazioni telefoniche a ogni genere di corrispondenza. Il Pci sosterrà i licenziati, scegliendo anche di rendere pubbli56
Conversazione con Jirˇí Pelikán, 29 aprile 1988. Idem. Il Kgb, in una lunga relazione dell’ottobre sulle attività dell’underground «controrivoluzionario», dedicherà spazio anche alle radio che hanno trasmesso dopo l’invasione. Zapiska predsedatelya Kgb Yu. V. Andropova v TsK KPSS o podgotovlennoi po pros’be «nemetskikh i pol’skikh druzei» informatsii o deyatel’nosti kontrrevolyutsionnogo podpol’ya v ChSSR, 13 ottobre 1968, Rossiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Noveishei Istorii (Rgani), fond 89, opis’ 61, delo 5, pp 160, riprodotto in S. KARNER, N. TOMILINA e A. TSCHUBARJAN, a cura di, Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968. Dokumente, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2008, pp. 1004-1053. 58 Conversazione con Luciano Antonetti, 16 febbraio 2009. 59 Al 1974 data l’interruzione «ufficiale» dei rapporti fra i due partiti. In realtà i rapporti non si troncarono definitivamente, perché delegazioni ufficiali del Kscˇ continuarono ad arrivare in Italia, mentre italiani continuarono a recarsi a Praga in veste non ufficiale, quali «osservatori», oppure per missioni particolari, quali quelle riservate effettuate da Salvatore Cacciapuoti di cui si riferisce nelle pagine che seguono. 57
136
A Praga, a Praga!
co l’accaduto60. Alcune di queste persone faranno rientro in Italia; Natale Burato, non avendo ancora risolto la posizione giudiziaria forse andrà in Jugoslavia prima di poterlo fare; Giulio Paggio, invece, resterà a Praga, assunto come funzionario nella redazione della rivista internazionale «Problemi della pace e del socialismo»61. Nel suo libro Turi attribuisce in modo bizzarro il loro licenziamento «agli esiti delle sessioni del 13 e 14 maggio 1976 del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo del Pci», in ragione della posizione assunta da Enrico Berlinguer «sulla partecipazione del Pci al governo e sulle relazioni internazionali dell’Italia»62. In realtà, quando si svolse quell’assise del Pci, gli otto erano già stati licenziati da oltre due mesi. Turi sostiene inoltre, senza indicare una sola fonte, che all’epoca Berlinguer «venne definito ‘traditore senza appello’»63. Legami con il terrorismo? Non era più tollerabile nella Praga che stava imboccando il cammino della «normalizzazione» la presenza di una radio diretta da un partito che si era schierato con Dubcˇek e aveva preso le distanze dall’«intervento fraterno» delle truppe del Patto di Varsavia64. La «colpa» dei redattori di «Oggi in Italia», insomma, era anche quella di essersi schierati dalla parte del «nuovo corso», del «comunismo dal volto umano»65. Stupiscono, quindi, soprattutto per il livello di sconoscenza dei fatti e delle dinamiche politiche, le affermazioni di una certa letteratura che descrive la redazione di «Oggi in Italia» come un semplice covo di stalinisti66. 60
«l’Unità», 12 marzo 1976. Conversazione con Luciano Antonetti, 16 febbraio 2009. 62 R. TURI, Gladio rossa, cit., n. 9, p. 172. 63 Idem, p. 153. 64 A. HÖBEL, Il Pci, il ’68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus, «Studi storici», vol. 42, n. 4 (2001), pp. 1145-1172; M. BRACKE, Which Socialism? Whose Detente? West European Communism and the Czechoslovak Crisis of 1968, Central European University Press, Budapest 2007; A. HÖBEL, Il contrasto tra Pci e Pcus sull’intervento sovietico in Cecoslovacchia. Nuove acquisizioni, «Studi storici», vol. 48, n. 2 (2007), pp. 523-550; e soprattutto V. ZASLAVSKY, La Primavera di Praga: resistenza e resa dei comunisti italiani, «Ventunesimo secolo», a. 7, n. 16 (giugno 2008), pp. 123-141. 65 V. RIVA, Oro da Mosca, cit., p. 385. 66 Con questo non si vuole certo escludere che singole persone fossero ancora animate da «sentimenti ortodossi». Ma era questione di singoli e non della struttura, che era diretta dal Pci. Conversazione con Luciano Antonetti, 16 febbraio 2009. 61
137
FERNANDO ORLANDI
È una tesi che, ad esempio, troviamo nel libro appena citato, come pure nel recente dottorato di Roberto Bartali, che scrive: In questo contesto Praga, e gli ambienti contigui alla radio italiana, finirono per diventare al tempo stesso una sorta di ufficio raccolta per la struttura ed una enclave stalinista. Fu proprio in questo ambito che sul finire degli anni Sessanta inizierà ad arrivare (con fini di istruzione politica e militare) una nuova leva di comunisti rivoluzionari, la stessa che formerà la spina dorsale delle future Br67.
Turi a sua volta sostiene che «molti giovani ‘extraparlamentari’, attraverso la presentazione e la garanzia prestate dai vecchi ‘Padri partigiani’, poterono recarsi in Cecoslovacchia per corsi di formazione rivoluzionaria»68. E ancora, senza indicare alcuna fonte a supporto dell’affermazione: Per molti studiosi non esistono collegamenti operativi diretti fra XXII Ottobre, i Gap e le Br. In realtà le tre strutture erano logicamente cementate [corsivo aggiunto] dai «grandi vecchi»: molti ex partigiani liguri, piemontesi, emiliani e lombardi più radicali, delusi e stanchi del nuovo Pci. Fra loro spiccavano i fuoriusciti ritornati a seguito della grazia presidenziale o dell’amnistia o dell’indulto ricevuto, che rimasero legati direttamente o indirettamente ai servizi segreti di Praga69.
Mario Moretti, addirittura, sarebbe stato «una pedina della politica sovietica in Italia e sempre del tutto in mano alla ‘Direzione strategica’ eterodiretta da Praga»70. La vicenda Moro avrebbe conosciuto una solida e precisa «regia cecoslovacco-sovietica»71. Un rapporto del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (Cesis), probabilmente redatto dopo il settembre 1979, afferma che «dai rilevamenti effettuati da varie fonti si calcola che almeno 2000 cittadini italiani dal 1948 ad oggi abbiano frequentato corsi riservati ad attivisti estremisti in Cecoslovacchia ed in altri paesi. Di questi sono noti al Sismi circa 600 nominativi». Riguardo alla Cecoslovacchia, lo stesso documento precisa: 67
R. BARTALI, L’ombra di Yalta, cit., p. 132. R. TURI, Gladio rossa, cit., p. 154. 69 Idem, p. 159. 70 Idem, p. 167. 71 Idem, p. 183. 68
138
A Praga, a Praga!
In particolare a Milano e a Roma risiedono elementi italiani del servizio segreto cecoslovacco di contatto con i vari gruppi terroristici. Essi provvedono alla raccolta di un’accurata documentazione sui candidati (tutti volontari), che trasmettono all’ambasciata cecoslovacca, che la inoltra successivamente a Praga. A questo punto gli elementi ritenuti di maggior spicco per fanatismo, aggressività e attitudine militare vengono avviati a veri e propri corsi paramilitari, in Cecoslovacchia o in altro paese, muniti di passaporti falsificati nelle nazioni ospiti. Una volta superato il ciclo addestrativo, i terroristi fanno ritorno in Italia con un bagaglio notevole di nozioni teoriche e pratiche sulla guerriglia che possono, a loro volta, riversare sugli altri elementi delle organizzazioni di appartenenza72.
In relazione a questo rapporto del Cesis, è opportuno ricordare che il senatore Mario Valiante, presidente della Commissione Moro, attorno al febbraio 1982 chiese al Sismi se le affermazioni, «all’indicativo presente» di quel documento erano ancora valide. La risposta del Sismi è particolarmente interessante, anche per la serietà metodologica che emerge. Dopo aver ricordato che «indizi formulati in modo identico», «provenienti da fonte estera», erano stati raccolti il 20 luglio 1977, prosegue: – nel contesto delle pressanti esigenze conoscitive insorte al momento della strage di via Fani e per quanto non si fosse riusciti – anche con l’aiuto di Servizi Collegati – a dar corpo ai citati indizi mediante il reperimento di elementi probanti e non univoci, il 3 aprile 1978 l’esistenza degli stessi indizi (e con le opportune cautele in ordine alla loro affidabilità) fu partecipata informalmente sia al Ministro della Difesa e sia al Gabinetto della Presidenza del Consiglio, mediante la consegna di semplici appunti; – il 14 maggio 1979, in relazione al riaffacciarsi di notizie sul presunto sostegno al terrorismo italiano da parte di paesi dell’Est ed in particolare della Cecoslovacchia, il Cesis chiese ed ottenne dal Sismi tutta la documentazione raccolta nel tempo sull’argomento (ivi compresa copia dell’atto concernente gli indizi in argomento, nella loro originaria e mai provata formulazione). Nella circostanza, peraltro, venne ribadito che, anche da ulteriori verifiche svolte sia direttamente e sia con la
72
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cesis, Studio del terrorismo in Italia, in connessione con i punti di crisi e la situazione economica nella società nazionale, s.d., pp. 73-74, riprodotto in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVIII (1988), pp. 663-664.
139
FERNANDO ORLANDI
collaborazione dei Servizi Collegati, non erano emerse prove sulla presenza di connazionali in campi di addestramento al terrorismo e alla guerriglia […]. Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter conclusivamente affermare che dalla strage di via Fani ad oggi il Sismi non ha raccolto elementi concordanti ed inconfutabili che possano confermare l’attuale validità delle notizie citate dall’On. Presidente73.
Che i cecoslovacchi avessero a che fare con le Br era convinzione condivisa in molti ambienti governativi. Lo stesso Aldo Moro, pur non avendone le prove, riteneva che il terrorismo italiano fosse sostenuto da alcuni stati del blocco sovietico, «con ogni probabilità attraverso la Cecoslovacchia», come ebbe a dire all’ambasciatore statunitense Richard N. Gardner il 5 novembre 197774. Anche Enrico Berlinguer, a discapito della sua nota riservatezza, parlando con Leonardo Sciascia e Renato Guttuso il 6 maggio 1977, alla domanda del primo che gli chiedeva se il paese cui aveva fatto riferimento nella dichiarazione trasmessa dal telegiornale la sera prima era la Cecoslovacchia, rispose affermativamente75. Sciascia ebbe poi a riferirne il 23 maggio 1980 in una riunione della Commissione Moro, ottenendo smentite (la smentita di Guttuso, fatta per dovere di partito, portò anche alla rottura personale fra i due76). Berlinguer «temeva che quell’accenno, se confermato, avrebbe avuto conseguenze per il Pci in Italia e all’estero»77, e a dispetto del consiglio opposto di Emanuele Macaluso querelò lo scrittore siciliano. Recentemente Ferdinando Imposimato che, come giudice istruttore ha istruito alcuni tra i più importanti casi di terrorismo tra cui il processo Moro e l’attentato al Papa, ha osservato a proposito della «pista cecoslovacca»: 73
Sisde a Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, 15 marzo 1982, all. 1, riprodotto in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. CVI (1995), pp. 114-115. 74 R. N. GARDNER, Mission: Italy, Mondadori, Milano 2004, p. 169. 75 Intervista di Leonardo Sciascia a «Il mattino», 28 maggio 1980, ripresa in «Notizie radicali», 28 maggio 1980. 76 B. CARUSO, Le giornate romane di Leonardo Sciascia, La Vita felice, Milano 1997; e V. VECELLIO, Saremo perduti senza la verità, La Vita felice, Milano 2003. 77 E. MACALUSO, 50 anni nel PCI, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 170.
140
A Praga, a Praga!
Nel corso del tempo queste notizie hanno trovato oggettivi elementi di riscontro nel ritrovamento sul territorio nazionale di tre pistole Skorpion collaudate tra il 1970 e il 1979 al banco di prova di Praga; nonché di altre cinque pistole Skorpion di fabbricazione cecoslovacca con matricola abrasa. Tra queste c’era anche quella usata per l’assassinio di Aldo Moro78.
Francamente, se la smoking gun è questa, è davvero pochino: soltanto alcune armi di fabbricazione cecoslovacca. Se per caso fossero state delle Tokarev avrebbero forse confortato una «pista sovietica» o delle Browning una «pista americana»? Davvero poco se si pensa a tutte le armi del terrorismo e degli infiniti modi con cui le organizzazioni terroriste hanno cercato di costruire i loro arsenali. È opportuno anche ricordare che la questione della provenienza delle armi è stata ripetutamente sollevata e che già nella Relazione di maggioranza della Commissione Moro, si osservava: Si è tentato di trarre prove di eventuali collegamenti internazionali dall’esame delle armi rinvenute nei covi scoperti. Non è risultato possibile – come hanno riconosciuto i responsabili dei nostri servizi di sicurezza – considerare significativa la provenienza di un’arma da uno Stato come indice della responsabilità di quello Stato o dei suoi servizi, giacché bisogna tener conto degli strani giri che queste armi finiscono per fare79.
La questione, insomma, è quella dei rapporti fra il terrorismo italiano, le Br in particolare, e i paesi socialisti, la Cecoslovacchia nello specifico. Renzo Rossellini, all’epoca direttore di una nota emittente romana vicina all’estrema sinistra, Radio Città futura, rilasciò nell’ottobre 1978 a un quotidiano francese una intervista che suscitò notevole scalpore. Rossellini infatti sostenne che un «partito sovietico» si muoveva per de78
S. PROVVISIONATO e F. IMPOSIMATO, Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il giudice dell’inchiesta racconta, Chiarelettere, Milano 2008, p. 235. 79 Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Doc. XXIII, n. 5, vol. I (1983), p. 139. Vedi ugualmente Sisde, Appunto, «Caso Moro»: i collegamenti internazionali del terrorismo italiano, p. 12, riprodotto in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVIII (1988), p. 26.
141
FERNANDO ORLANDI
stabilizzare l’Italia e tenere il Pci «segregato all’opposizione». Richiestogli quali fossero le prove dei legami fra Unione sovietica e Br, Rossellini fornì una risposta che non regge al riscontro storico: Tutto è cominciato durante l’ultima guerra, quanto una frazione importante della Resistenza italiana passò sotto il controllo dell’Armata Rossa. Questa frazione dopo la guerra conservò le armi e divenne una base logistica della strategia dei Servizi sovietici nel nostro paese. Il nucleo fu poi rivitalizzato alla fine degli anni Sessanta, quando in esso confluirono tutti gli elementi pro-cubani legati alla Tricontinentale. Fu così che questo fenomeno attraversò tutta la sinistra e l’estrema sinistra: a partire dal Pci, in cui sussiste una forte minoranza pro-sovietica, fino all’Autonomia, terreno di grande infiltrazione. È chiaro, io schematizzo, ma è questa in sintesi l’origine delle Br. Esse oggi hanno alle spalle l’apparato militare dei paesi dell’Est, di cui sono una delle emanazioni80.
Rossellini ha peraltro smentito queste dichiarazioni81. Convocato dalla Commissione Moro disse che le sue dichiarazioni erano state avventate e che non possedeva prove o elementi di fatto e che quanto sostenuto sull’Unione sovietica altro non era che la trasposizione in Italia di conoscenze maturate nel Terzo mondo82. Non era la prima volta che nel nostro paese si parlava di una «pista sovietica» per il terrorismo italiano. Mario Sossi, il pubblico ministero nel processo alla XXII Ottobre, sequestrato dalle Br a Genova il 18 aprile 1974, ha sostenuto: È però un fatto, in base ai dati in mio possesso, che le Br siano strettamente collegate con i servizi dell’Est. Questa considerazione non è
80
«Il y a en Italie un véritable parti soviétique» nous déclare Renzo Rossellini, «Le Matin», 4 ottobre 1978; l’intervista è stata subito tradotta in italiano come È stato il partito sovietico in Italia a rapire Moro, «Lotta Continua», 5 ottobre 1978. 81 Sismi, Rapporto per l’inchiesta parlamentare sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, s.d., pp. 74-75, riprodotto in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. CVI (1995), pp. 78-79; e G. ZUPO e V. MARINI RECCHIA, Operazione Moro, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 56-64. 82 Audizione di Renzo Rossellini, 23 giugno 1981, in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. VIII (1985), p. 459.
142
A Praga, a Praga!
frutto di divagazioni più o meno dilettantesche di politica estera, ma si basa su documenti precisi, su fatti e circostanze sui quali mi è toccato di indagare per ragioni del mio ufficio.
I fatti cui si riferisce Sossi sarebbero: che Augusto Viel, della XXII Ottobre, subito dopo la rapina di Genova del 26 marzo 1971, alla quale aveva preso parte con Mario Rossi e nel corso della quale venne assassinato Alessandro Floris, trovò rifugio a Milano dove poi venne catturato il 15 aprile 1972 assieme a Giuseppe Saba, uomo di fiducia di Giangiacomo Feltrinelli, dei Gruppi d’azione partigiana (Gap). Interrogato dal sostituto procuratore Guido Viola, Viel aveva dichiarato di essere stato mandato da Feltrinelli a Praga. Il secondo elemento addotto da Sossi viene dal fatto che in quel periodo, a «Radio Praga» lavorava Fabrizio Pelli, ricercato in Italia per la sua partecipazione alle Br83. Interrogato da Viola, Viel dichiarò: Dopo la rapina a Genova mi nascosi in casa per quattro o cinque giorni. Quindi alcuni elementi di cui non conosco i nomi e che non conoscevo prima, dopo avermi fornito documenti falsi mi condussero in Cecoslovacchia, a Praga, in una strada che non conosco, in un villino, presso persone che non conosco. Ivi sono rimasto dall’aprile al dicembre 1971… A dicembre un signore [Feltrinelli] mi ha riportato in macchina in Italia.
Viel non aggiunge altro: «Non intendo dire nulla perché voglio essere leale verso i miei compagni»84. Ritroviamo l’episodio nella sentenza del processo «Gap-FeltrinelliBr»: La stessa scelta di Praga non appare in tal senso casuale, ma l’inserimento in un circuito ben determinato di preparazione ideologica e pratica per la rivoluzione. Si è pertanto discusso sul significato della permanenza di Viel proprio a Praga e non in Austria, in Francia, o in Belgio, o in Svizzera o in Germania, paesi dove Feltrinelli aveva tutte le possibilità per far rifugiare un latitante.
83 84
M. SOSSI, Nella prigione delle Br, Editoriale Nuova, Milano 1979, pp. 59-60. G. BENSI, La pista sovietica, SugarCo, Milano 1983, pp. 37-38.
143
FERNANDO ORLANDI
Si osserva, inoltre: In tutte le discussioni e ipotesi fatte ci si è dimenticati di valutare una circostanza di fatto fondamentale. In tutti i paesi europei come quelli citati, alle diverse polizie i rifugiati possono anche sfuggire o, se identificati, venire sopportati. In un paese come la Cecoslovacchia, invece, non esiste clandestinità, specialmente del cittadino straniero, la cui permanenza non può sfuggire alla polizia. Se un Feltrinelli ve lo introduce e ve lo fa permanere per tempi non brevi, significa che Feltrinelli si è servito di canali facenti capo alla stessa polizia, a cominciare da quella di frontiera e che qualcuno dell’apparato statale aveva dato il consenso85.
Se la memoria non trae in inganno chi scrive, l’unico riscontro alla lunga permanenza di Viel a Praga (in una villetta con altre persone, straniere, ma che parlavano italiano) viene da una cartolina imbucata nella capitale cecoslovacca e indirizzata alla madre. Insomma, un espediente per rassicurare il genitore, oppure per depistare: potrebbe averlo fatto chiunque, per primo lo stesso Feltrinelli, che a Praga si recò varie volte. Nella biografia del padre scritta da Carlo Feltrinelli si avanza il dubbio86. E allora, proprio come ha fatto il figlio, ho parlato con Augusto Viel. Questi mi ha detto che prima del suo arresto fu latitante, ma non a Praga né in Cecoslovacchia, bensì in Italia, e che quello della cartolina fu un escamotage per allentare le ricerche della polizia. Escamotage che peraltro si rivelò utilissimo anche dopo l’arresto, perché gli permise di evitare interrogatori sulla sua latitanza italiana87. Certo, si tratta di dichiarazioni dell’interessato, a loro volta prive di riscontri. Ma una certa plausibilità l’hanno. Una plausibilità che trova conforto nelle carte che nell’aprile 2006, assieme ad alcuni membri del Centro studi sulla storia dell’Europa orientale, potei compulsare in modo fiduciario a Praga. Fra queste c’era anche il dossier intestato a Viel. Lo scarno fascicolo che lo riguarda si apre con una richiesta di informazioni indirizzata alle autorità 85
ACS, Sentenza della Corte di assise di appello di Milano nel procedimento penale «Gap-Feltrinelli-Br», 9 aprile 1981. 86 C. FELTRINELLI, Senior Service, Feltrinelli, Milano 1999, p. 403. 87 Conversazione con Augusto Viel, 5 febbraio 2007. Viel mi informò dell’intenzione di pubblicare un libro, una sorta di autobiografia, in cui avrebbe scritto in dettaglio anche di questa vicenda. Ad oggi non mi risulta sia stato pubblicato.
144
A Praga, a Praga!
ceche dalla locale Ambasciata d’Italia, attivata dagli organi giudiziari e di polizia dopo il suo arresto. Gli italiani, trasmettono anche una sua fotografia, assai utile nel caso fosse entrato nel paese sotto falso nome, perché all’epoca si dovevano compilare delle richieste di visto, su moduli a soffietto, su cui si doveva applicare anche la propria fotografia. Questi moduli venivano conservati dai servizi di sicurezza. Nel caso, poi, di una lunga permanenza, il visto andava regolarmente rinnovato presso un apposito ufficio della Sicurezza pubblica sito in un luogo disagevole, lontano dal centro della capitale. Ma ai cechi nulla risulta riguardo una sua permanenza a Praga. Le informazioni su Viel provengono dall’Ambasciata d’Italia o sono state successivamente raccolte in note che riassumono articoli della stampa italiana. Anche le voci ripetutamente circolate su un impiego di Fabrizio Pelli a «Radio Praga» e addirittura al quotidiano del Cc del Kscˇ, il «Rudé právo», non hanno riscontri. A quanto pare, a certi informatori piace attribuire questo genere di occupazione ai terroristi italiani. Un posto di lavoro, «nelle vesti di giornalista», a «Radio Praga» non sarebbe stato negato neppure a Mario Moretti. Da un appunto del Sisde infatti si apprende che i servizi italiani, «in un quadro di reciproca collaborazione» avrebbero chiesto agli omologhi della Cecoslovacchia postcomunista il riscontro a questa informazione88. Tornando a Fabrizio Pelli, le prime informazioni sulla sua permanenza in Cecoslovacchia le ritroviamo in appunti dell’Ufficio D del Sid, secondo cui Pelli, «durante la sua permanenza in territorio cecoslovacco (dall’aprile 1973 al maggio 1974) avrebbe prestato la propria opera nelle redazioni del giornale ‘Rudé právo’ e di ‘Radio Praga’»89. Un successivo rapporto del Centro Cs del Sid di Bologna del 30 settembre 1974 riferisce dell’ospitalità offerta dalla Cecoslovacchia a membri delle Br e riguardo a Pelli, annota: «quest’ultimo ancora a Praga»90. Nel giro di poco tempo la notizia finisce sui giornali, che scriveranno del «latitante Fabrizio Pelli impiegato a ‘Radio Praga’»91. 88
Sisde a Sismi e Ministero dell’interno, Appunto, 31 maggio 1990, cit., p. 1. A. MANTICA e V. FRAGALÀ, La dimensione sovranazionale del fenomeno eversivo in Italia, in CpS, Elaborati presentati dai commissari, Doc. XXIII, n. 64, vol. I, Tomo V, Parte seconda, Tipografia del Senato, Roma 2001, p. 38. 90 Appunto, 30 settembre 1974, riprodotto in R. BARTALI, L’ombra di Yalta, cit., p. 274. 91 «Il Tempo», 5 giugno 1975, cit. in Idem, p. 271. 89
145
FERNANDO ORLANDI
Per quanto riguarda Pelli, abbiamo una ulteriore testimonianza, successiva, in apparenza più che autorevole: quella del generale Jan Šejna, che defeziona all’inizio del 196892. Secondo quando dichiara Šejna in una intervista, Pelli era stato istruito a Doupov, una base di addestramento dell’aviazione militare cecoslovacca, nel biennio 19666793. La rivelazione di Šejna viene poi ripresa in un rapporto del Sismi del marzo 198294. A questo punto ci troviamo dinanzi a un banale problema anagrafico, che non sembra essere stato colto da chi si è occupato di queste vicende. Fabrizio Pelli è nato a Reggio Emilia l’11 luglio 1952. Nel 1966 aveva 14 anni e 15 nel 1967. Dalle indagini degli organi di polizia, dalle inchieste delle magistratura e dalla pubblicistica disponibile conosciamo molte cose della sua biografia. È forse il più giovane dei componenti del nucleo reggiano che poi darà vita alle Br. Precario, studente-lavoratore (di sera nei ristoranti), proprio per la sua condizione personale fe-
92
Per problemi di spazio, non ci si occupa qui del generale Jan Šejna (al quale, chi scrive, ha intenzione di dedicare un articolo), della sua biografia, delle vicende che portarono alla sua defezione (ma forse sarebbe meglio dire «fuga-defezione», perché riparò in Occidente per evitare un arresto per crimini comuni), e della triste parabola della sua vita quando, non più in grado di dare informazioni, per non perdere un ruolo da prima donna, iniziò ad inventarsele, da quelle sui prigionieri di guerra sottoposti a esperimenti medici, alla rivelazione del grande complotto moscovita per annichilire l’Occidente sommergendolo di stupefacenti raccontato in J. D. DOUGLASS, JR., Red Cocaine. The Drugging of America, Clarion House, Atlanta 1990 (Šejna la fonte principale). Anche le sue «rivelazioni» sull’addestramento di terroristi italiani in Cecoslovacchia, appartengono a questo filone fantasioso. Invece di interrogarsi su perché i cecoslovacchi, ad esempio, avessero dovuto addestrare un quattordicenne (Fabrizio Pelli), c’è chi ha collegato la mancata pubblicazione da parte dell’«Espresso» di una intervista al generale che raccontava fesserie (in effetti, una questione di buon senso, anche per la congerie di persone messe assieme) a motivi assai meno nobili: «La cosa non deve però sorprendere troppo, visto quanto riporta il Dossier Mitrokhin nei report n. 5 e n. 35: cospicui fondi al settimanale furono forniti, anche per la sua fondazione, proprio dall’Unione sovietica». R. BARTALI, L’ombra di Yalta, cit., n. 45, p. 289. 93 Intervista al generale Jan Šejna, ACS, fascicolo «Eversione di sinistra», 9/7; parzialmente ripubblicata in A. MANTICA e V. FRAGALÀ, La dimensione sovranazionale, cit., pp. 34-36. 94 Sismi, La Cecoslovacchia e il terrorismo internazionale, 30 marzo 1982; ripubblicato in A. MANTICA e V. FRAGALÀ, La dimensione sovranazionale, cit., pp. 36-38.
146
A Praga, a Praga!
ce rapidamente la scelta della clandestinità95. Nel periodo in cui si asseriva la sua presenza a Praga è sempre stato in Italia, nelle grandi città del nord, da Milano al Triveneto, in particolare a Marghera. Peraltro, non conosceva nessuna lingua straniera96. Presto latitante, il 17 giugno del 1974 è tra i brigatisti che irrompono nella sede padovana del Msi di via Zabarella e uccidono i due attivisti presenti, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola: sono i primi omicidi delle Br. Arrestato a Pavia il 24 dicembre 1974, muore per leucemia l’8 agosto 1979. Per scrupolo, sulla eventuale presenza di Pelli o di altri brigatisti ho interpellato varie persone che tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta hanno lavorato a «Radio Praga» e al «Rudé právo». Tutti l’hanno categoricamente escluso, e fra questi Zdeneˇk Horˇení, già membro della Segreteria del Kscˇ e direttore del quotidiano del Cc del partito97. Un falso e l’apprensione del Pci Alla «questione cecoslovacca» era indirizzata l’attenzione già attorno alla metà degli anni Settanta, dopo che nel settembre del 1974 il capitano dei carabinieri Gustavo Pignero del nucleo antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva appena arrestato a Pinerolo i brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini, «rivelava» nel corso di una conferenza stampa che «Franceschini era arrivato qualche giorno prima da Praga». Non era vero, serviva a proteggere l’infiltrato Silvano Girotto (ovvero «Frate Mitra»). Non solo, «per ‘coprirlo’ viene inviato alla magistratura un falso rapporto con la ricostruzione dei movimenti di Franceschini negli ultimi mesi», che «si sarebbe spostato con disinvoltura oltre che attraverso l’Italia, anche in un ‘paese europeo’», vale a dire la Cecoslovacchia98. La falsa indiscrezione messa in circolazione iniziò a vivere di vita propria, trovando «riscontri» in confidenti di evidente dubbio valore
95
A partire dal maggio 1972, militanti delle Brigate rosse entrarono in clandestinità per scelta dell’organizzazione e non per sfuggire a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. SOCCORSO ROSSO, Brigate rosse, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 124-125. 96 Conversazione con Tonino Paroli, 18 febbraio 2009. Sul gruppo dei reggiani si veda soprattutto P. PERGOLIZZI, L’appartamento, Aliberti, Reggio Emilia 2006. 97 Conversazione con Zdene ˇk Horˇení, 6 maggio 1998. 98 V. TESSANDORI, Br. Imputazione: banda armata, Garzanti, Milano 1977, p. 211.
147
FERNANDO ORLANDI
e traducendosi in vari appunti del Sid, come quello già citato del Centro Cs di Bologna del 30 settembre 1974 o quello dell’Ufficio D del marzo 1975, secondo cui Franceschini aveva soggiornato in Cecoslovacchia dal giugno 1973 al giugno 1974 lavorando nel campo di Lidice99. Tutto questo non poteva non preoccupare la dirigenza del Pci, che aveva raccolto con attenzione e preoccupazione le voci iniziali. Anzi, fin da prima dell’arresto di Curcio e Franceschini a Botteghe Oscure erano state collazionate tutte le informazioni possibili. Già nel maggio del 1973, nel corso di un battibecco al Senato fra Paolo Bufalini e l’allora presidente del consiglio Giulio Andreotti, quest’ultimo aveva fatto un cenno alla Cecoslovacchia100. Nel periodo successivo, quello che va dal 1973 al 1974, il Pci, per il tramite di Giancarlo Pajetta, si fa segretamente promotore di una iniziativa verso i brigatisti che provenivano dalle sue fila, promettendo «l’impunità, o almeno una forte indulgenza se si fossero costituiti al giudice ‘amico’ Ciro Di Vincenzo»101. Il Pci, peraltro non era affatto all’oscuro di quanto era accaduto. Per chi doveva sapere, le Br non erano affatto «sedicenti». A Reggio Emilia il partito era bene informato, afferma Antonio Bernardi, ex parlamentare e segretario provinciale dal 1973 al 1978: «Certo che conoscevamo queste cose, altrimenti perché avremmo dovuto cacciarli dal partito?»102. Conferma Peppino Catellani, uno dei due responsabili reggiani della Vigilanza del Pci: «Sì, eravamo a conoscenza delle armi e delle rapine che facevano questi giovani»103. Le voci che iniziano a circolare sulla Cecoslovacchia generano una certa apprensione. All’epoca le relazioni ufficiali fra Pci e Ksˆc erano pressoché congelate e i rapporti particolarmente difficili, segnati da
99
A. MANTICA e V. FRAGALÀ, La dimensione sovranazionale, cit., p. 38. Senato della Repubblica, VI legislatura. 156ª seduta pubblica. Resoconto stenografico. Venerdì 15 maggio 1973, Tipografia del Senato, p. 7642. 101 G. FASANELLA e C. SESTIERI, con G. PELLEGRINO, Segreto di Stato, Einaudi, Torino 2000, p. 129; P. PERGOLIZZI, L’appartamento, cit., pp. 100, 103 e 120; e l’audizione di Alberto Franceschini, CpS, stenografico 50ª seduta. Mercoledì 17 marzo 1999,http://www.parlamento.it/bicam/terror/stenografici/steno50a.htm#50a. Di Vincenzo nel 1975 fu denunciato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con l’accusa di collusione con le Br, ma un anno dopo venne prosciolto. 102 Antonio Bernardi cit. in P. PERGOLIZZI, L’appartamento, cit., p. 59. 103 Peppino Catellani, cit. in Idem, p. 83. 100
148
A Praga, a Praga!
persistenti schermaglie104. Nel settembre 1971 «Giorni-Vie Nuove» pubblica una intervista a Josef Smrkovský105 alla quale replica il 25 settembre «Rudé právo», accusandolo di «essere entrato al servizio di interessi stranieri, al servizio dell’anticomunismo»106. Nel gennaio 1972 viene arrestato Valerio Ochetto107; il mese successivo vede l’espulsione di Ferdinando Zidar, già corrispondente dell’«Unità» e segretario dell’Organizzazione internazionale dei giornalisti, accusato di avere avuto contatti con i sostenitori della Primavera di Praga108. I numerosi arresti (tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972109) e i processi del luglio 1972 a trentadue esponenti del comunismo riformatore, accusati di «attività di sovversione della Repubblica» aggravano la tensione fra i due partiti110, anche perché fra i condannati vi è Milan Hübl, che mantiene rapporti stretti con il Pci, inviando materiali alla sua dirigenza (Zidar, emerge al processo, è uno dei corrieri)111. Nel dicembre 1973 viene respinto all’aeroporto di Praga un altro giornalista dell’«Unità», Silvano Goruppi, pur munito di regolare visto. Il 4 maggio 1974 «Práce» aveva attaccato personalmente Davide Lajolo, col104
Nel corso degli anni lo scontro pubblico fra Kscˇ e Pci viene seguito con attenzione da una parte della dissidenza e dall’emigrazione ceca. Vedi, ad esempio, «Listy» Comments on Feud Between «L’Unità» and «Rude Pravo», in «Translations on Eastern Europe. Political, Sociological, and Military Affairs», n. 1344 (Jprs, 25 gennaio 1977), pp. 32-35 (trad. da «Listy», n. 5, ottobre 1976, pp. 8-9). 105 Smrkovsky ci parla del socialismo in Cecoslovacchia e invita alla pacificazione, «Giorni-Vie Nuove», 22 settembre 1971. Vedi anche K. DEVLIN, Italian Communist’s Tribute to Smrkovsky, «Rfe Research», 16 gennaio 1974, pp. 1-4. 106 K. DEVLIN, The Czechoslovak Trials and CPCS Relations with Western Communist Parties, «Rfe Research», 14 settembre 1972, p. 15. 107 V. OCHETTO, No, signor referente, Sei, Torino 1972. 108 Dello stesso periodo sono alcuni altri episodi che vedono coinvolti giornalisti italiani. Demetrio Volcic, corrispondente da Praga della radiotelevisione italiana, mentre si reca a Vienna con la moglie, viene a perquisito e subisce la confisca di giornali, articoli e libri; mentre a tre dirigenti della Federazione nazionale della stampa italiana, Luigi Barzini, Alessandro Curzi e Antonino Fava, viene rifiutato il visto di ingresso in Cecoslovacchia. «Corriere della Sera», 10 febbraio 1972. 109 F. S. LARRABEE, a cura di, Survey of East European Developments: April-June 1972, «Rfe Research», 7 luglio 1972, p. 12. 110 K. DEVLIN, The Czechoslovak Trials and CPCS Relations, cit., pp. 6 e 8-9. 111 R. W. Dean, Czechoslovak Trials: The Expanding Limits of Normalization, «Rfe Research», 10 agosto 1972, pp. 6 e 11.
149
FERNANDO ORLANDI
pevole di avere pubblicato su «Giorni-Vie Nuove», il settimanale che dirigeva, la lettera di Alexander Dubcˇek alla vedova di Josef Smrkovský (deceduto il 15 gennaio). In questo contesto, la direzione del Pci decide di inviare a Praga una delegazione composta da Emanuele Macaluso, Gianni Cervetti e Salvatore Cacciapuoti112. Dall’1 al 5 luglio hanno luogo «numerosi e penosi» incontri113 con Vasil Biľak e altri suoi colleghi, ma l’obiettivo della missione, quello di ottenere la riammissione nel Kscˇ dei comunisti epurati dopo la «normalizzazione» seguita all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia e ripristinare i rapporti fra i due partiti, non viene raggiunto114. A margine di questi incontri ufficiali ve n’è anche uno informale e riservato di Cacciapuoti (vicepresidente della Commissione centrale di controllo del Pci), che solleva con i cecoslovacchi la questione delle Br115. Subito dopo la conferenza stampa in cui i Carabinieri tirano in ballo la Cecoslovacchia, Cacciapuoti viene nuovamente inviato in missione segreta a Praga. Il 27 settembre 1974 ha un incontro con dirigenti del Kscˇ, nel corso del quale chiede che i cechi interrompano i rapporti con le Br. È una accusa che il Kscˇ trova inaccettabile. In una bozza di lettera da inviare al Pci conservata negli archivi di Praga, Vasil Biľak, all’epoca segretario del Cc del Kscˇ per gli affari internazionali, ricorda che già nel settembre è stato formalmente assicurato al rappresentante del Pci che mai gli organi della sicurezza di Stato della Cecoslovacchia, e quantomeno il Kscˇ, hanno avuto contatti con le Br116. Un qualche esponente del governo o dei servizi di sicurezza italiani, o forse degli Affari riservati117, o magari invece un collaboratore se112
K. DEVLIN, «Confrontation of Opinions» Between PCI Delegation and Czechoslovak Leaders, «Rfe Research», 9 luglio 1974, p. 5. 113 E. MACALUSO, 50 anni, cit., p. 169. 114 G. CERVETTI, Il valore universale della democrazia e le relazioni internazionali, 25 marzo 2004, http://www.dsonline.it/aree/form_politica/documenti/dettaglio.asp?id_doc=16983. 115 Conversazione con Gianni Cervetti, 3 febbraio 2007. Macaluso non ha memoria di questo incontro di Cacciapuoti: «non posso confermare né smentire». Conversazione con Emanuele Macaluso, 15 febbraio 2007. 116 V. Biľak, Návrh dopisu ústrˇednímu výboru Italské komunistické strany, s.d./ma subito dopo il 15 ottobre 1975, in all. 4 a Procura della Repubblica di Roma a Commissione stragi, 6 aprile 1999, ACS, fascicolo «Eversione di sinistra», 9/3. 117 Emanuele Macaluso indica il Viminale quale fonte. E. MACALUSO, 50 anni, cit., p. 169.
150
A Praga, a Praga!
greto del Pci ad alto livello al Viminale, fornisce a Pecchioli informazioni su alcuni documenti: forse riferisce proprio sulle informative del Sid cui si è fatto cenno, forse vengono fatte vedere fotocopie di «parti di passaporti», come ricorda Gianni Cervetti118. L’esistenza di questi documenti aumenta la preoccupazione al vertice del Pci, e il timore di un coinvolgimento di Praga sarà persistente nel corso degli anni. Ad esempio, nella riunione della Direzione del 22 dicembre 1976 Pecchioli afferma che «sono circolate notizie sulla Cecoslovacchia per l’ospitalità data a brigatisti rossi: i fatti sono veri e il fatto è stato sollevato anche nella riunione tra i segretari dei partiti con Andreotti»119. Dinanzi alle voci che si accumulano e soprattutto ai documenti consegnati o forse solo fatti visionare a Pecchioli, la direzione del Pci decide di inviare nuovamente in missione segreta Cacciapuoti a Praga. Il 15 ottobre 1975 questi si incontra con Antonín Vavruš, capo del Dipartimento internazionale del Kscˇ. Dal verbale della riunione si comprende quanto duri siano stati i toni impiegati da entrambi. Cacciapuoti, sulla base delle informazioni fornite a Pecchioli, parla di una base delle Br in Cecoslovacchia e del fatto che hanno frequentato o vissuto nel paese Renato Curcio, Alberto Franceschini, Fabrizio Pelli e tale Setti120, e che gli organi di Stato italiani possiedono delle «prove documentali» (doklady). Per il Pci si tratta di una «faccenda estremamente seria» (velmi važnou záležitost), e per questo si chiede al Kscˇ di provvedere «affinché 118
T. MONTESANO, Gli 007 cecoslovacchi dietro le Br. E il Pci sapeva, «Libero», 26 ottobre 2004; e Conversazione con Gianni Cervetti, 3 febbraio 2007. 119 Riunione della Direzione del 22 dicembre 1976. Seduta antimeridiana, FiG, Apci, Direzione, Verbali, mf 0280, 300. 120 Da informazioni ottenute, sembra trattarsi di Giuseppe Setti, rifugiato a Ostrava (dove aveva assunto il nome di Marco Zotti) dal 1949 al 1955. Militante del Pci, a Reggiolo, la città natale, è stato segretario della Camera del Lavoro, della sezione del Pci «Dante Freddi» e ha anche ricoperto incarichi nella giunta comunale. Titolare di una ditta di import-export, in seguito si è sovente recato in Cecoslovacchia per motivi di affari. Sembra essere stato in contatto con alcuni funzionari del Primo direttorato del Ministero dell’Interno, fra cui gli illegali che hanno operato nell’ambasciata di Roma Josef Cˇermák (ufficialmente Console) e Jaroslav Forst (ufficialmente funzionario dell’Ufficio visti). Conversazione con un funzionario del Ministerstvo vnitra, 20 aprile 2006; Conversazione con un funzionario dell’Údvzk, 21 aprile 2006; e conversazione con Gianni Riccò, 19 febbraio 2009.
151
FERNANDO ORLANDI
non si prosegua nella cooperazione con tali elementi, né si presti loro alcun aiuto» (aby nebylo pokracˇováno ve spolupráci s teˇmito živly, ani jim poskytována žádná podpora). Vavruš respinge seccamente gli addebiti e a sua volta accusa gli italiani di «leggerezza», per il modo in cui hanno costruito il loro ragionamento, non suffragato da alcun elemento di prova. Infatti, richiesto di consegnare della documentazione, l’inviato del Pci ammette «di non averne». Nonostante ciò, Vavruš impegna gli organi della sicurezza di Stato ad effettuare le verifiche del caso121. Su questo incontro, Vasilii Mitrokhin ha raccolto delle informazioni che poi sono state riversate in un report Impedian, cioè uno dei file basati sulle carte dell’ex archivista del Kgb che l’intelligence britannica inviò agli omologhi italiani. Per un evidente errore122, l’incontro Cacciapuoti-Vavruš viene datato 16 settembre 1975. Nel rapporto 143 si legge che il ministro degli interni cecoslovacco Jaromír Obzina ha informato dell’incontro il rappresentante del Kgb a Praga, che pertanto trasmette un rapporto a Mosca. In ragione di ciò, nel dicembre 1975 Yurii Andropov riferisce al Cc del Pcus che Cacciapuoti, su incarico della dirigenza del Pci, aveva informato i cechi che imprecisate agenzie italiane erano in possesso di alcuni documenti da cui si evinceva che in Cecoslovacchia era ubicata una delle basi delle Br e che le agenzie di sicurezza cecoslovacche fornivano loro cooperazione. Questo fatto avrebbe potuto essere utilizzato contro il Pci. Vavruš aveva assicurato che il suo ministero non aveva contatti di nessun genere con i terroristi italiani. Nel corso di una successiva visita a Mosca, Obzina riferì che i cecoslovacchi avevano fornito una calma ma decisa risposta al Pci123. Da questa documentazione si evince come i cecoslovacchi prendano in seria considerazione quanto esposto dall’emissario del Pci, pur non avendo fornito alcuna prova: fanno effettuare una seconda verifica dagli organi della sicurezza di Stato (dopo quella effettuata a seguito della prima visita di Cacciapuoti) e ricontrollare i visti di ingresso rilasciati; istruiscono l’ambasciata di Roma affinché segua 121
Záznam, 15 ottobre 1975, pp. 1-2, in all. 4 a Procura della Repubblica di Roma a Commissione stragi, 6 aprile 1999, ACS, fascicolo «Eversione di sinistra», 9/3. 122 Conversazione con un dirigente dell’Údvzk, 21 aprile 2006. 123 Impedian Report n. 143, 20 ottobre 1995: Italian ‘Red Brigade’ Contacts between the Communist Parties of Czechoslovakia and Italy: 1975 and 1978. Vedi anche C. ANDREW, V. MITROKHIN, The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the Kgb, Basic Books, New York 1999, pp. 298-299.
152
A Praga, a Praga!
con attenzione la questione124, e soprattutto informano Mosca al più alto livello, il capo del Kgb Andropov che a sua volta riferisce al Politbyuro e al segretario generale Leonid Brezhnev. Va anche ricordato che Vavruš si trova a Mosca alla fine di novembre 1975, quale membro di una delegazione ad altissimo livello del Kscˇ125. Ma a Botteghe Oscure la diffidenza verso i cechi non viene meno e le smentite dei dirigenti del Kscˇ non sono risolutive, non riescono a convincere. Per questo Cacciapuoti viene inviato almeno un’altra volta in missione riservata a Praga sulla questione delle Br, dove effettua un altro incontro il 29 marzo 1976126. Le sdegnate smentite e le rassicurazioni provenienti da Praga non sono sufficienti. Ancora due anni dopo, il 4 maggio 1978 Giorgio Amendola, nel corso di una conversazione con l’ambasciatore di Praga in Italia Vladimír Koucký, invita i cecoslovacchi ad essere prudenti riguardo alle Br. Un avvertimento simile era venuto anche da Arturo Colombi, presidente della Commissione di controllo del Pci, che aveva pure criticato la dirigenza del Kscˇ per non aver dato risposta a specifiche domande in merito alle Br, insoddisfatto del categorico rifiuto dell’esistenza di qualsivoglia contatto127. Un atteggiamento non dissimile sembra averlo avuto anche l’ambasciatore sovietico a Roma Nikita Ryzhov128. Ugo Pecchioli rimarrà convinto che a Praga qualcosa avessero combinato, visto che Fabrizio Pelli è «stato ospite in Cecoslovacchia»129. 124
Záznam, 15 ottobre 1975, cit., p. 2. Oltre a Vavruš, del gruppo facevano parte: segretario generale del Kscˇ e presidente della repubblica Gustáv Husák, il primo ministro federale Lubomír Štrougal; il segretario del Cc per gli affari internazionali Vasil Biľak, il primo segretario del Partito comunista Slovacco Jozef Lenárt, il primo ministro ceco Josef Korcˇák, il vice primo ministro federale e presidente della Commissione statale di pianificazione Václav Hu˚la e il membro del Cc del Kscˇ e ambasciatore a Mosca Jan Havelka. Vedi HAJEK, NIZNANSKY, Top-Level Delegation in Moscow, «Rfe, Rad/Czechoslovak Unit», 1 dicembre 1975, F-78. 126 K. PACNER, Praha se nepodílela na vraždc ˇ Alda Mora, «Mf Dnes», 8 aprile 2000 (questo articolo è stato ispirato da una agenzia della sicurezza di stato ceca); conversazione con un funzionario dell’Údvzk, 21 aprile 2006; e documentazione cui l’autore ha avuto accesso a Praga. 127 Impedian Report n. 143, cit. 128 Idem. 129 U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità, Baldini & Castoldi, Milano 1995, p. 80. 125
153
FERNANDO ORLANDI
Questa vicenda forse ci dice di più a proposito di un tentativo di intossicazione del Pci messo in atto da qualche funzionario o apparato dello Stato. Ma sarebbe un capitolo ancora da scrivere, e manca un riscontro documentario (le voci da sole non sono certamente sufficienti). E se non è stata una «polpetta avvelenata», allora probabilmente si tratta di un informatore del Pci, vuoi nei servizi, vuoi al Viminale, che aveva accesso e aveva minuziosamente riferito delle informazioni raccolte e degli appunti fatti circolare dai servizi sulla presenza dei brigatisti in Cecoslovacchia. Resta infine una terza ipotesi: che la dirigenza del Pci non fosse del tutto certa che i vecchi apparati militari fossero effettivamente stati smantellati del tutto e sostituiti dalla Vigilanza. Ma, per chi scrive, sembra la pista davvero più labile130. Quel che è invece certo, è che la «pista cecoslovacca» nasce nel settembre 1974 per le false dichiarazioni alla stampa e il falso rapporto inviato all’autorità giudiziaria dal capitano dei carabinieri Gustavo Pignero. Questa sorgente avvelenata è ben nota, sebbene pochi l’abbiano presa nella dovuta considerazione. In qualche modo ha avvelenato gli stessi servizi di informazione: messa in circolazione la notizia dalla stampa, è rientrata nelle «conferme» di alcuni «informatori». E così ha iniziato a vivere di vita propria, in un meccanismo perverso di autoriproduzione. Per questo, ancora negli anni Ottanta i nostri servizi di sicurezza continuano a puntare il dito verso Praga. L’attenzione verso la Cecoslovacchia era tale che nei giorni del rapimento di Aldo Moro si è giunti a valutare seriamente qualcosa che dovrebbe essere, tutto sommato, inconcepibile: l’allora commissario Antonio Frattasio, audito dalla Commissione Stragi dichiarò che alla Questura di Roma si era arrivati a pensare a un assalto militare dell’ambasciata cecoslovacca, e poco ci mancò che la sede diplomatica venisse presa d’assalto131. Insomma, una dichiarazione di guerra a un paese del Patto di 130
Per quanto riguarda lo scioglimento di particolari apparati di sicurezza del Pci, debbo comunque ricordare che Renato Risaliti, per lunghi anni militante comunista, ha sostenuto che “la vera e completa liquidazione istituzionale della Gladio rossa ci fu solo quando Enrico Berlinguer cominciò la politica della solidarietà nazionale. Ossia negli anni compresi fra il 1972 e il 1975”. R. CANTORE, V. SCUTTI, L’armata nascosta, «L’Europeo», 22 maggio 1991. 131 Audizione di Antonio Frattasio, CpS, 38ª seduta. Mercoledì 15 luglio 1998, http://www.parlamento.it/bicam/terror/stenografici/steno38b.htm#2; la notizia era stata anticipata da «Adn-Kronos», 17 giugno 1998.
154
A Praga, a Praga!
Varsavia. In quei giorni convulsi, anche l’allora ministro dell’interno Francesco Cossiga fu «sollecitato da ambienti vicino alla famiglia Moro a mettere sotto controllo l’ambasciata della Cecoslovacchia» («il che era una grande stupidaggine»)132. Le considerazioni fatte per le informative e gli appunti sulle persone valgono anche per le notizie raccolte sui campi di addestramento. Karlovy Vary, nei Sudeti, la Karsbad che conobbe grandi splendori, diviene la località su cui si focalizza l’attenzione degli apparati di intelligence. Una relazione dei servizi segreti italiani databile marzomaggio del 1976 e che ha per oggetto le «attività eversive sviluppate dalla sinistra extraparlamentare, unitamente alle connessioni che essa appare avere con il comunismo internazionale e con altri servizi informativi stranieri nell’area comunista» punta il dito verso «Karlos Vivary» [sic, Karlovy Vary], dove «si ritiene che le Br e probabilmente anche i Nap, abbiano la centrale operativa», una centrale che «manovra non solo il terrorismo italiano, ma anche quello che opera in altri paesi europei». Dalla Cecoslovacchia questi gruppi riceverebbero «istruzione, direttive e finanziamenti», ma non avrebbero alcun contatto «con il personale dell’ambasciata ceca a Roma». Invece, «il coordinamento per il collegamento delle attività eversive in Italia, attuato dalle Br e dai Nap, verrebbe predisposto da Mosca tramite l’ambasciata di Cuba a Roma, con il supporto delle altre rappresentanze dei paesi oltre cortina in Italia, ivi compresa la Cecoslovacchia. Le ambasciate, però, non mantengono nessun collegamento con i citati movimenti estremisti». Infine, «tra le organizzazioni terroristiche italiane, militerebbero anche alcuni agenti russi»133. Karlovy Vary ritorna nel corso degli anni in diversi appunti e informativa. Ad esempio, in un appunto del Comando generale dei Carabinieri si legge che A Karlovy Vary, nei pressi del fiume Ohrˇe, esisterebbe un campo di addestramento di terroristi internazionali di «grosso calibro», mentre altri campi militari, dove si addestrerebbero terroristi provenienti da vari paesi, compresa l’Italia, sarebbero ubicati: nei pressi di Plzenˇ, in
132
Audizione di Francesco Cossiga, CpS, 27ª seduta. Giovedì 6 novembre 1997, http://www.parlamento.it/bicam/terror/stenografici/steno27b.htm. 133 ACM, Relazione dei servizi segreti del maggio 1976, all. alla relazione presentata da G. Donno a chiusura dei lavori della Commissione Mitrokhin, doc. 184.
155
FERNANDO ORLANDI
una gola tra i fiumi Urlava [sic, Úhlava] e Úslava; nei pressi della frontiera russa [sic, sovietica, oggi Ucraina], nella grande pianura di Michalovce [oggi in Slovacchia] tra i fiumi Ondava e Loborec134.
Gli italiani cercarono, vanamente, riscontri. L’ammiraglio Fulvio Martini, audito dalla Commissione stragi, ha infatti raccontato come, nella sua qualità di capo delle operazioni estere del Sid fece «un tentativo per accertare se nella zona di Karlovy Vary ci fossero campi di addestramento delle Br, ma l’operazione fu un insuccesso»135. Anni prima il Sisde osservava: «Per quanto attiene alla ventilata esistenza di centri di addestramento per terroristi a Karlovy Vary e a Doupov, non si hanno obiettivi elementi di riscontro»136. La collaborazione dei nuovi servizi Con la caduta dei regimi comunisti dell’Europa centro-orientale, la situazione muta. Paesi e strutture statali che fino a quel momento ci erano ostili cambiano radicalmente. Gli apparati della sicurezza di Stato vengono epurati e ristrutturati e i nuovi governi fin da subito iniziano a manifestare la loro aspirazione ad accedere alle istituzioni comunitarie e a quelle transatlantiche. Vogliono rientrare a far parte di quell’Europa da cui sono stati rapiti, sequestrati, per usare le parole di Milan Kundera, con la sovietizzazione del dopoguerra. È cambiato tutto e così mutano i rapporti fra gli apparati di sicurezza. Laddove c’era ostilità ora si aprono nuovi canali di collaborazione. Gli italiani si attivano e iniziano a chiedere informazioni sullo spionaggio messo in atto nel passato e, nel caso della Cecoslovacchia, anche sugli eventuali legami intrattenuti con organizzazioni terroristiche del nostro paese. Da un appunto del Sisde del 31 maggio 1990 si apprende che, «in un quadro di reciproca collaborazione» i nostri servizi hanno chiesto 134
Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, II reparto – SM – Ufficio Operazioni, 12 maggio 1981, ACM, cit. in R. BARTALI, L’ombra di Yalta, cit., p. 298. 135 CpS, 54º Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 6 ottobre 1999, p. 342. 136 Sisde, Appunto, «Caso Moro»: i collegamenti internazionali del terrorismo italiano, p. 12, riprodotto in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. XXVIII (1988), p. 26.
156
A Praga, a Praga!
agli omologhi della Cecoslovacchia postcomunista informazioni e riscontri137. Forse è proprio a questa iniziativa (e magari ad altre, ulteriori richieste) che si riferisce l’ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del Sismi, nella citata audizione alla Commissione stragi: Quando divenni capo del servizio, alla caduta del muro, uno dei primi rapporti che avemmo con i servizi minori di oltrecortina fu con il servizio cecoslovacco da cui derivò poi il caso Orfei138. In quella occasione sparsi la voce a Praga che ero disposto a pagare eventuali documenti che portassero all’individuazione dei veri rapporti tra il servizio cecoslovacco e le Br, ma la risposta fu di non sapere niente delle Br, ma di quello che faceva la stazione cecoslovacca a Roma e da lì nacque il caso Orfei139.
Il Sismi ha certamente in più di una occasione cercato di avere dai nuovi servizi dell’Europa centro-orientale informazioni e documentazione riguardanti i collegamenti fra gli apparati della sicurezza di Stato dei precedenti regimi comunisti e le organizzazioni del terrorismo italiano, in particolare le Br. Il paese a cui si è a lungo riferito per i presunti rapporti con le Br, ovvero la Cecoslovacchia, rispose prontamente. Infatti, l’Úrˇad pro zahranirˇní styky a informace (Úzsi), il servizio civile di intelligence per l’estero, manifestando totale collaborazione, inviò ai colleghi italiani 137
Sisde a Sismi e Ministero dell’interno, Appunto, 31 maggio 1990, cit., p. 1. Accusato di essere stato reclutato dal servizio segreto cecoslovacco, il politologo Ruggero Orfei, consigliere diplomatico di Ciriaco De Mita negli anni Ottanta quando era presidente del consiglio, nel novembre 1991 venne scagionato dal pubblico ministero Michele Coiro. 139 CpS, 54º Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 6 ottobre 1999, p. 342. È opportuno ricordare che, audito in Commissione Moro, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dichiarò: «Collegamenti internazionali. Sono portato ancora oggi a pensare che se possono sussistere ipotesi destabilizzanti nei confronti del nostro paese, non sono suffragate da elementi di fatto, non esistono dati di fatto». Audizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 luglio 1980, in CpM, Allegato alla relazione. Documenti, Doc. XXIII, n. 5, vol. IV (1984), p. 299. Allo stesso modo, la Relazione di maggioranza della Commissione Moro concludeva: «Poiché invece nessun rapporto è emerso per quanto riguarda le Br e Prima Linea, non trova riscontro l’ipotesi secondo la quale la Cecoslovacchia abbia mantenuto […] rapporti con elementi del terrorismo italiano». Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, cit., p. 140. 138
157
FERNANDO ORLANDI
relazioni e vasta documentazione140. Materiale il cui contenuto è rimasto pressoché segreto nel nostro paese, al punto che quasi nessuno ne è a conoscenza, mentre prosegue la circolazione, sulla stampa e nei libri, di notizie che non trovano alcun conforto. Questa situazione ha infastidito non poco i praghesi, che dopo la consegna della documentazione si aspettavano un qualche riscontro pubblico nel nostro paese141. Così, diversi mesi dopo la trasmissione delle carte, in qualche modo indispettiti, si attivarono affinché uno dei quotidiani più diffusi pubblicasse un lungo articolo, lanciato sulla prima pagina e che proseguiva per una intera pagina all’interno, che grosso modo riassumeva pubblicamente la parte principale delle notizie fatte arrivare a Roma142. Queste carte sono state successivamente inviate alla Commissione Mitrokhin ma attualmente non sono aperte alla consultazione pubblica. In passato sono state nella disponibilità dei commissari e dei consulenti della stessa commissione. L’autore di questo articolo ha vanamente cercato di ottenerne copia, e allo stesso modo non è stato possibile visionare una, a quanto pare assai interessante e corposa, relazione del Reparto operativo speciale (Ros) dei Carabinieri, inviata alla Procura della Repubblica di Roma il 15 luglio 2000. Non sono pertanto in grado di confrontare i materiali cui ho avuto l’accesso con la documentazione trasmessa al Sismi e con il rapporto del Ros, e me ne rammarico. Poiché mi venne riferito a Praga da un funzionario dell’Údvzk che si trattava degli stessi documenti, cercherò di riferire sulle cose maggiormente rilevanti che ebbi l’occasione di vedere. Si tratta di documentazione proveniente dal Primo direttorato del Ministero dell’interno143. La prima osservazione riguarda il fatto che il materiale è raccolto a partire da certa data, ovvero che prima della
140
Conversazione con un funzionario governativo ceco, 20 aprile 2006. Conversazione con un funzionario dell’Údvzk, 21 aprile 2006. 142 K. PACNER, Praha se nepodílela na vražde ˇ Alda Mora, «MF Dnes», 8 aprile 2000. 143 Un diagramma della complicata struttura organizzativa del Ministero degli interni in F. KOUDELKA e J. SUK, a cura di, Ministerstvo vnitra a bezpecˇnostní aparát v období Pražkého jara (leden-srpen 1968), Prameny k deˇjinám cˇeskoslovenské krize 1967-1970, vol. 7/1, Úsd-Doplnek, Praha-Brno 1996, p. 321. Per una introduzione agli apparati della sicurezza di stato della Cecoslovacchia, si veda M. CHURÁNˇ A KOLEKTIV, Encyclopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpecˇnosti, Libri, Praha 2000; e P. BLAŽEK e P. ŽÁCˇ EK, Czechoslovakia, in K. PERSAK e Ł. KA141
158
A Praga, a Praga!
metà degli anni Settanta, grosso modo la fine del 1974, non era stato aperto alcun file. E i primi dossier raccolgono richieste provenienti dall’Ambasciata d’Italia, che reagiva a indicazioni dell’autorità giudiziaria via Ministero di grazia e giustizia, ad esempio riguardo Augusto Viel (di cui veniva fornita anche la fotografia, per meglio identificarlo). Altri collazionano informazioni generaliste, provenienti da fonti aperte e da strutture dei servizi cechi, compresi gli agenti a Roma. Il materiale e la sua datazione collimano con quanto si legge nel verbale del già citato incontro del 15 ottobre 1975 fra Salvatore Cacciapuoti e Antonín Vavruš144 e nella bozza di lettera da inviare al Pci a firma di Vasil Biľak145. Infatti, i cechi a seguito delle sollecitazioni provenienti dal Pci effettuano un controllo su tutti i visti di ingresso rilasciati agli stranieri ed effettivamente trovano riscontro per alcuni dei nomi indicati da Cacciapuoti, e quindi aprono dei fascicoli su di loro. Contemporaneamente segnalano che i loro apparati della sicurezza non hanno alcun rapporto con Curcio, Franceschini e Pelli, ed è proprio questo che Vavruš ribadisce a Cacciapuoti. Nella dirigenza del Kscˇ la questione viene affrontata con la massima serietà e ciò è anche testimoniato dalla comunicazione rapidamente inoltrata a Mosca al capo del Kgb Andropov, e di cui troviamo traccia nel report Impedian n. 143. A Praga ho potuto visionare il fascicolo intestato a Renato Curcio, aperto sulla base di un visto di transito in Cecoslovacchia. Ma l’omonimo Renato Curcio era un avvocato calabrese, nato un decennio prima, nel 1931. Vengono registrati anche i visti di ingresso di un commerciante toscano, tale Sergio (e non Alberto) Franceschini che a partire dalla fine degli anni Sessanta si recò più volte in Cecoslovacchia, soggiornando nella località di Karlovy Vary (la stessa nota località termale dei ripetutamente segnalati campi di addestramento)146.
a cura di, A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944-1989, Institute of National Remembrance, Warsaw 2005, pp. 87-161. 144 Záznam, 15 ottobre 1975, cit., pp. 1-2. 145 V. Biľak, Návrh dopisu ústrˇednímu výboru Italské komunistické strany, cit., pp. 1-2. 146 Vedi anche P. DI NICOLA, Br addestrati in Cecoslovacchia? Erano solo omonimi, «L’espresso», 27 maggio 2005. L’articolo si basa sulla relazione di Nicola Biondo per la Commissione Mitrokhin, che purtroppo non ho avuto modo di consultare. La relazione di Biondo è comunque ampiamente citata in R. BARTALI, L’ombra di Yalta, cit. MINSKI,
159
FERNANDO ORLANDI
Nel corso degli anni ritornano alcune relazioni interne, in cui si precisa che non esiste alcun rapporto con le Br, né con gli agenti a Roma né con il Primo direttorato (e in particolare la 42ª sezione, «Europa Nato»). Altra documentazione riguarda le «campagne anti-cecoslovacche» messe in atto dalla stampa italiana. Si tratta di fascicoli aperti nella seconda metà degli anni Settanta a partire dalla pubblicazione di articoli, ad esempio del «Settimanale», di cui si fornisce la traduzione, cui seguono commenti degli agenti a Roma e informative che giungeranno fino alla dirigenza del Kscˇ. Per completezza, debbo infine riferire l’informazione sulla distruzione negli anni Ottanta di alcuni fascicoli riguardanti le Br e il terrorismo. Sembra, mi è stato parimenti detto, che non si trattasse di materiale operativo, bensì di documentazione di natura informativa e analitica e che la loro distruzione sia avvenuta nel quadro dell’ordinaria eliminazione di dossier privi di alcun valore. La documentazione presente negli archivi cechi, le risultanze degli accertamenti degli organi di sicurezza del nostro paese, le acquisizioni dell’autorità giudiziaria, nonché le stesse testimonianze degli interessati147 e più in generale dei militanti delle Br interrogati dopo il loro arresto, univoche a prescindere dalle posizioni processualmente assunte (collaboratore di giustizia, dissociato o irriducibile), concordano nell’escludere che la Cecoslovacchia abbia fornito ospitalità e addestramento alle Br. Per questo il Kscˇ non poteva che rispondere sdegnato alle accuse mosse dal Pci. Le autorità della Repubblica ceca hanno collaborato pienamente con quelle italiane, fornendo documentazione che dovrebbe avere aiutato a chiarire la questione dell’eventuale sostegno della Cecoslovacchia al terrorismo del nostro paese. Oggi sappiamo che l’accusa si basava su notizie false e mai sottoposte a verifica. Come una fenice, continua invece a risorgere la «pista cecoslovacca». Nel nostro paese, forse, quando non si trova conforto alla propria interpretazione, o ci si lascia andare al sensazionalismo oppure ci si aggrappa all’inquietante teorema per cui se non si è trovato nulla, allora il mistero (o che altro) è davvero grande. Ma un atteggiamento del genere non fa onore allo storico.
147
Alberto Franceschini, ad esempio ha ripetutamente smentito. Audizione di Alberto Franceschini, cit.
160
QUEGLI «… OTTUSI SERVITORELLI…» CHI HA SCRITTO I COMUNICATI DELLE BRIGATE ROSSE DURANTE IL SEQUESTRO MORO? RIFLESSIONI SUL “DOSSIER” DIMENTICATO DI RENZO ROTA*
Gabriele Paradisi
Introduzione: una sorprendente lacuna storiografica Negli oltre trent’anni che ci separano ormai dalla strage di via Fani, dal sequestro e dall’omicidio di Aldo Moro (16 marzo-9 maggio 1978), un’enorme quantità di carte si è accumulata intorno a quella tragica vicenda. Basti pensare agli atti giudiziari dei sei processi, alle oltre centomila pagine raccolte negli atti della Commissione Moro, al filone di inchiesta sugli sviluppi dello stesso caso Moro della Commissione Stragi, alle migliaia di articoli apparsi su quotidiani e settimanali, alla copiosa produzione saggistica recentemente arricchitasi nello scorso anno in occasione della ricorrenza del trentennale di quei luttuosi eventi. Eppure si cercherebbe invano nella vasta storiografia derivata da quell’oceano di carte uno studio, degno di questo nome, riguardante i comunicati delle Brigate rosse fatti ritrovare tra il 18 marzo e il 5 maggio 1978. È bene ricordare, infatti, per quanto sia ovvio e banale sottolinearlo, che due sono state, sono e saranno anche nel futuro, le fonti principali per lo studio del caso Moro: vale a dire le lettere e il cosiddetto memoriale di Aldo Moro1, da una parte, e i comunicati delle Brigate rosse dall’altro. * Questo breve saggio è una rielaborazione sintetica di uno scritto apparso in tre parti nel sito internet www.cielilimpidi.com. 1
Soltanto per le lettere di Aldo Moro disponiamo finalmente di una esemplare edizione: A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2008, pp. 1-181. Il testo delle lettere, riccamente annotato, è seguito da un lungo approfondito saggio dello stesso curatore, Le possibilità dell’uso del discorso nel cuore del terrore: della scrittura come agonia, pp. 183-389; per la prima edizione a stampa del memoriale, rinvenuto in due momenti, nell’ottobre 1978 e nell’ottobre 1990, si veda Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano, a cura di F.M. Biscione, Coletti, Roma 1993; le lettere e il memoriale di Moro sono
161
GABRIELE PARADISI
Sfortunatamente i comunicati delle Brigate rosse, per quanto siano stati pubblicati, citati, commentati e chiosati in molti volumi, non hanno ancora trovato una adeguata trattazione2. Questa sorprendente lacuna storiografica è ancora più difficile da spiegare dal momento che, da più di 25 anni a questa parte, è stato reso pubblico un importante “dossier” consegnato alla Commissione Moro dal consigliere diplomatico Renzo Rota. Eppure anche il “dossier Rota”, come lo si può chiamare, ha incontrato una particolare “sfortuna” tra le varie scuole storiografiche che si sono scontrate e continuano a scontrarsi intorno agli enigmi o ai cosiddetti “misteri” del più importante delitto politico della storia dell’Italia repubblicana. Quasi tutti gli studiosi del caso Moro non citano neppure il nome di Renzo Rota: questo è il modo più semplice ed efficace per eludere le clamorose conclusioni alle quali portava l’analisi svolta dal diplomatico italiano. Chi accenna al suo nome, il più
pubblicati in un unico volume in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Br, Kaos, Milano 1997, pp. 55-203 (le lettere), pp. 211-328 (il memoriale). 2 I nove comunicati delle Brigate rosse, ritenuti autentici, furono fatti rinvenire il 18, 25 e 29 marzo, il 4, 10, 15, 20 e 24 aprile e il 5 maggio 1978; altri due comunicati, ritenuti falsi, furono rinvenuti il 18 aprile 1978 – si tratta del famoso comunicato n. 7 che annunciava che il cadavere di Moro si trovava nel lago della Duchessa – e il 20 maggio 1978, un comunicato, in parte in codice, molto meno noto, a volte indicato come comunicato n. 10. Ricordiamo alcune edizioni a stampa dei comunicati brigatisti in libri recenti dedicati al caso Moro o alla storia delle Brigate rosse: M. CLEMENTI, La pazzia di Aldo Moro, 2ª edizione, Rizzoli, Milano 2006, Appendice A, pp. 351-368 (senza i due falsi comunicati); Dossier Brigate rosse 19761978, a cura di L. Ruggiero, Kaos, Milano 2007, pp. 293-326 e 332-338; P. CASAMASSIMA, Il libro nero delle Brigate Rosse, Newton Compton, Roma 2007, pp. 203-218 (senza il comunicato in codice); M. CASTRONUOVO, Vuoto a perdere. Le Brigate Rosse, il rapimento, il processo e l’uccisione di Aldo Moro, edizione riveduta e ampliata, Besa, Nardò 2008, pp. 477-510. Per i testi originali si veda il sito internet del Senato della Repubblica: http://www.archivioinchieste.senato.it/html/consultazione.htm. Per i contenuti dei comunicati brigatisti si veda S. FLAMIGNI, La tela del ragno. Il delitto Moro, 5ª edizione aggiornata, Kaos, Milano 2003, pp. 239-250, 256-266, 287299 e 313-316.
162
Quegli «… ottusi servitorelli…»
delle volte si limita a rimandare al giudizio liquidatorio, e non argomentato, avanzato dalla Relazione di maggioranza della Commissione Moro3. Un comune lettore avrebbe dovuto aspettare fino al 2003 – ossia 20 anni dopo che il “dossier Rota” era stato reso pubblico – per trovare un rimando bibliografico preciso che lo mettesse in grado di identificare, ed eventualmente consultare, quella documentazione4. Il “dossier” del consigliere diplomatico si configura pertanto come un vero e proprio “buco nero”, per usare la metafora che troviamo nel sottotitolo di un libro pubblicato nel marzo 20085. Esso fa parte, a sua volta, come si diceva sopra, di una più estesa lacuna storiografica, ossia la mancanza di uno studio monografico, sistematico, dei comunicati delle Brigate rosse fatti ritrovare durante i 55 giorni più terribili dell’Italia repubblicana. Sono queste alcune delle ragioni che ci hanno spinto a “riesumare” dall’oblio, nel quale è stato fino ad ora tenuto, il lavoro di Renzo Rota. La prima parte di questo scritto intende essere solo un guida espositiva ai poco noti scritti di Rota. Li giudichiamo importanti e degni di essere conosciuti, indipendentemente dalla valutazione sull’attendibilità delle conclusione avanzate dal diplomatico italiano. La seconda parte esemplifica le modalità della particolare “sfortuna” incontrata nell’ultimo quarto di secolo dal “dossier Rota” negli sporadici episodi nei quali è emerso in superficie per essere poi sempre di nuovo riprecipitato nell’oblio.
3
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, comunicata alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983, Roma 1983, p. 127; costituisce il vol. I degli atti della stessa Commissione, Doc. XXIII, n. 5; questa relazione è stata ristampata in Dossier delitto Moro, a cura di S. Flamigni, Kaos, Milano 2007, pp. 57313, il passo al quale ci riferiamo è a p. 225. 4 Vale a dire fino alla pubblicazione del volume di V. SATTA, Odissea nel caso Moro. Viaggio controcorrente attraverso la documentazione della Commissione Stragi, Roma, Edup 2003, p. 210 e p. 254 nota 605. 5 AA.VV., Il sequestro di verità. I buchi neri del delitto Moro, con saggi di R. BARTALI, G. DE LUTIIS, S. FLAMIGNI, I. MORONI e L. RUGGIERO, Kaos, Milano 2008; il volume non si occupa però dei comunicati brigatisti.
163
GABRIELE PARADISI
Nel mirino del Kgb? La pericolosa “expertise” di “filologia politica” del diplomatico Renzo Rota sui comunicati delle Brigate rosse durante il sequestro Moro Il 17 marzo 1981 il diplomatico Renzo Rota inviava al senatore Dante Schietroma, allora presidente della Commissione parlamentare Moro6 e a tutti i componenti della stessa commissione, un corposo “dossier” di oltre 150 pagine. Il voluminoso incartamento era costituito da quattro allegati riguardanti l’analisi dei comunicati fatti ritrovare dalle Brigate rosse durante il sequestro Moro7. Fin dalle prime righe della lettera di accompagnamento, allegata a quel voluminoso “dossier”, Rota riassumeva il clamoroso e sorprendente contenuto di quegli “allegati”:
6
La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (d’ora in poi CpM) fu istituita con la Legge 23 novembre 1979, n. 597; ha chiuso i suoi lavori nel giugno 1983 con la presentazione della relazione di maggioranza e di cinque relazioni di minoranza. È stata presieduta dal deputato Oddo Biasini (8 gennaio-5 marzo 1980), dal senatore Dante Schietroma (16 aprile 1980-28 giugno 1981) e infine dal senatore Mario Valiante (dal 31 luglio 1981 fino al termine dei lavori). Tutti gli atti della Commissione, 130 volumi e 2 di indici, sono stati pubblicati tra il 1983 e il 1996, VIII Legislatura, Doc. XXIII, n. 5. A partire dal maggio 2008 tutta la documentazione è accessibile dal sito Internet del Senato della Repubblica: http://www.archivioinchieste.senato.it/html/consultazione.htm. 7 CpM, vol. CXXI (1995): Analisi dei messaggi delle Brigate rosse inviata alla Commissione dal dottor Renzo Rota, pp. 219-376, così articolata: Allegato n. 1, Dal 2º messaggio delle Br (in realtà senza titolo; indicato qui di seguito come Relazione breve), pp. 224-232; pubblicato per la prima volta in CpM, vol. II (1983), Relazione di minoranza del deputato Franco Franchi e del senatore Michele Marchio (Gruppo parlamentare del MSI-DN), allegato n. 7, pp. 221-229; è stato pubblicato anche in un volume, quasi sconosciuto, che raccoglie le lettere di A. MORO, Lettere dal patibolo, a cura di S. Bellamio, I Quaderni [supplemento di] Critica Sociale, Milano 1995 e ristampato sul periodico «Critica sociale», n. 1/2 (2008), pp. 41-46. Allegato n. 2, Stereotipi del linguaggio comunista sovietico (indicato qui di seguito come Relazione lunga), pp. 233-368; pubblicato per la prima volta nella sopracitata Relazione di minoranza, vol. II (1983), pp. 231-366, che sviluppa ed esemplifica la precedente Relazione breve. Allegato n. 3, Esame del messaggio n. 2 nel quadro dei successivi messaggi, pp. 369-373. Allegato n. 4, Dei sovietici hanno ucciso Moro, pp. 374-376.
164
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Invio a Lei, come a tutti i componenti la Commissione Moro, i documenti allegati. Essi mostrano che la parte centrale – quella ideologica – del primo messaggio delle Br (la parte iniziale e quella finale sono a carattere puramente descrittivo) e tutto il secondo messaggio, sono stati scritti da un comunista sovietico, e più precisamente, da un “ideologo” del Partito Comunista sovietico8.
Il primo e il secondo «messaggio delle Br», ai quali si riferiva Rota, erano naturalmente i primi due comunicati delle Brigate rosse del 18 e il 25 marzo 19789. Non meno sconvolgente e notevolmente drammatico è quanto Rota scriveva nella parte manoscritta di quella stessa lettera: È possibile che nonostante il segreto istruttorio, e in perfetta buona fede, la notizia di questa mia “expertise” trapeli non pubblicamente. Per rendere più difficile una rappresaglia del Kgb ai danni non tanto miei, quanto soprattutto di mia moglie, prego Lei e l’On. Commissione che Ella presiede, perché venga emesso un comunicato in cui la Commissione, senza naturalmente pronunciarsi sul merito, renda per intanto pubblica la notizia che le è pervenuto uno studio tendente a dimostrare che la parte centrale del 1º comunicato e tutto il 2º comunicato delle Br per Moro sono stati scritti da un sovietico. È necessario che il comunicato-stampa della Commissione renda anche pubblico il mio nome. Ciò potrebbe rendere più difficile una rappresaglia del Kgb. Non posso dare io stesso il comunicato alla stampa. Se lo facessi, dovrei accusare direttamente – come è vero – il Kgb del crimine. E, come funzionario dello Stato, non lo posso fare se non è già intervenuta al riguardo una dichiarazione ufficiale10. 8 CpM, vol. CXXI (1995), Lettera inviata dal dottor Rota al Presidente della Commissione [Dante Schietroma] il 17 marzo 1981, pp. 221-223 (versione integrale del testo dattiloscritto e manoscritto); pubblicata parzialmente, limitatamente al solo testo dattiloscritto, anche in CpM, vol. II (1983), cit., pp. 219-220. Un’altra edizione parziale è apparsa sul periodico «Critica sociale», n. 1/2 (2008), p. 38. La lettera di Rota è scritta su carta intestata del Ministero degli Affari Esteri. 9 CpM, vol. XXXVII (1988), pp. 546-547 (primo comunicato), pp. 635-636 (secondo comunicato); per un’edizione a stampa si veda ad esempio Dossier Brigate rosse 1976-1978, cit., pp. 293-297 (primo comunicato), dove però è omessa l’ultima riga: «I comunicati verranno battuti tutti con la stessa macchina: questa» e pp. 298-302 (secondo comunicato). 10 CpM, vol. CXXI (1995), cit., pp. 222-223.
165
GABRIELE PARADISI
Ma chi era Renzo Rota? Conosciamo poche notizie biografiche che lo riguardano, se non quanto lui stesso riferisce nella lettera sopra citata, ossia che era un diplomatico, ministro plenipotenziario, già primo consigliere dell’ambasciata italiana a Mosca dal 1965 al 1972, con l’incarico di seguire la politica interna sovietica. Ma sono soprattutto le sue sottili, raffinate doti ermeneutiche che si riscontrano nel suo “dossier” a “parlare” per lui. Poiché i quattro «documenti allegati», insieme alla lettera di accompagnamento, giacciono indisturbati da un quarto di secolo a questa parte nei volumi degli atti della Commissione Moro, e sono di fatto quasi sconosciuti, è opportuno esporre qui di seguito il loro contenuto. La Relazione breve di Rota del 27-29 marzo 1978 Riteniamo utile fare un passo indietro e ritornare ai primi giorni della primavera insanguinata del 1978 e ripercorrere, in ordine cronologico, il lavoro intrapreso da Rota. Il 25 marzo 1978 le Brigate rosse fanno ritrovare il loro comunicato n. 2. Il giorno seguente tutti i giornali italiani riportano il testo integrale di quel comunicato. Quel testo fu letto, più o meno attentamente, forse da milioni di persone. A Roma però c’era un lettore molto particolare, dotato di una mente “preparata”, atta a cogliere ciò che quasi tutti non riuscivano a “vedere”, anche se stava davanti ai loro occhi. Era appunto il diplomatico Renzo Rota. Come sappiamo dalla lettera del 17 marzo 1981, Rota si mise subito al lavoro e nei tre giorni successivi (27-29 marzo) elaborò quella che chiamiamo qui per semplicità Relazione breve. Quel testo (di 9 pagine), elaborato in condizioni di impellente urgenza e che non porta alcun titolo, è strutturato nel modo seguente: è diviso in tre colonne, nella prima (sopratitolata «Dal 2. messaggio delle Br») sono trascritti stralci tratti dal comunicato n. 2 delle Brigate rosse; nella seconda (sopratitolata «Testo russo»), grazie ad una ardita intuizione ermeneutica, Rota propone una «retroversione letterale» in russo del testo italiano che figura nella prima colonna; infine nella terza colonna (sopratitolata «Osservazioni») sono riportati i commenti e le annotazioni dello stesso Rota. Nella sua analisi, Rota segue questo metodo: isola 27 parole, o espressioni o intere frasi, che numera (da 1 a 27) nel corpo del testo 166
Quegli «… ottusi servitorelli…»
della prima colonna (ossia nel testo del comunicato n. 2) che ritiene tra le più significative e “sintomatiche”. Poi, grazie alla «retroversione letterale» in russo di quelle stesse parole, Rota mostra, nel commento della terza colonna, che l’ipotetico estensore sovietico (che non dominava completamente, come un madrelingua, l’italiano), ha proposto delle «espressioni in italiano» che tradiscono appunto una derivazione dal russo. Come gli sconcertanti «servitorelli» che figurano significativamente al n. 1 nella sua lista e che abbiamo scelto come titolo di questo scritto. Chi si incammina in quel labirinto linguistico con la guida sapiente di Rota vi troverà inattese e sorprendenti annotazioni, che crediamo mai avrebbe immaginato di trovare in quel secondo comunicato, spesso definito (ma troppo frettolosamente, come tanti altri) «delirante». Tra queste espressioni, una ci pare particolarmente “illuminante”. È la coppia di termini «appendici militari» (nella quinta pagina della relazione) dal significato più che enigmatico in italiano (anche nell’italiano delle Brigate rosse che, peculiare fin che si vuole, sempre italiano dovrebbe essere). Tra l’altro questa “strana coppia” di termini compare in un paragrafo del comunicato n. 2 dove troviamo un non meno sconcertante verbo («trainare»), in connessione proprio con le strane «appendici militari», che rende quella frase particolarmente ardua da intendere. Che significato ha, infatti, preso alla lettera, il passo seguente, che dovrebbe stare “in piedi” anche senza gli altri due verbi che si trovano dentro la parentesi quadra?: Sono i paesi più forti della catena e che hanno già collaudato le tecniche più av[a]nzate della controrivoluzione ad assumersi il compito di trainare […] le appendici militari […]?11
Ha un significato altamente problematico, per non dire che non ha, in realtà, alcun significato. Se si legge la frase completa con i verbi «istruire» e «dirigere» (che seguono «trainare») si intuisce che cosa l’estensore intendesse esprimere. Ma quell’estensore dovrebbe essere un “nativo” italiano, chiunque esso sia, brigatista patentato, o dell’area
11
CpM, vol. XXXVII (1988), cit., p. 636, corsivi aggiunti.
167
GABRIELE PARADISI
intellettuale dell’estrema sinistra12. Ma Rota fa notare, nelle sue osservazioni, che la parola russa per «appendice» ha anche il significato di «reparto». L’estensore del comunicato ha “semplicemente” scelto il significato sbagliato. È possibile che un italiano abbia scritto “quella” frase (e tante altre similmente “strane”)? Sono domande che riteniamo del tutto legittime. Sono le risposte che fino ad ora sono mancate (e sono trascorsi ormai più di 30 anni). Ma che destino fu riservato, nel 1978, all’analisi di Rota? Dalla lettera del 17 marzo 1981 sappiamo soltanto che questa Relazione breve fu «subito recapitata a chi di dovere»13. Dato il velo di riserbo, comprensibile per la carica che Rota ricopriva, alzato dal diplomatico italiano, non conosciamo l’eventuale iter, o l’utilizzo, ammesso che ce ne sia stato uno, che allora fu riservato a quello scritto redatto in modo così tempestivo. Ricordiamo che non erano trascorse neppure due settimane dall’eccidio di via Fani e dal sequestro di Aldo Moro. La Relazione lunga di Rota (primavera 1978 – primavera 1981) In un periodo imprecisato, tra la primavera del 1978 e quella del 1981, o forse dopo l’istituzione della Commissione parlamentare sul caso Moro (alla fine di novembre 1979), probabilmente proprio per mettere a disposizione della stessa Commissione le sue competenze, Rota rimise mano alla sua analisi dei comunicati delle Brigate rosse. Nel corso di una sola settimana predispose un nuovo rapporto ben più voluminoso (ben 136 pagine) rispetto alle 9 pagine del marzo 1978. È l’allegato n. 2, che Rota intitolò Stereotipi del linguaggio comunista sovietico, e che qui, per semplicità, abbiamo chiamato la Relazione lunga14. Il contenuto di questo scritto è riassunto da Rota stesso nella lettera del 17 marzo 1981:
12
Nel libro di M. MORETTI, Brigate rosse: una storia italiana. Intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Anabasi, Milano 1994 (rist. Baldini & Castoldi, Milano 1998 e 2002; Oscar Mondadori, Milano 2007), l’intervistato si è assunto la paternità, insieme alla cosiddetta Direzione strategica delle Brigate rosse, della stesura dei comunicati brigatisti. 13 CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 221. 14 CpM, vol. CXXI (1995), cit., pp. 233-368.
168
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Esso contiene degli esempi, tratti dalla letteratura sovietica, comprovanti che frasi e parole impiegate nel 2.ndo messaggio delle Br sono espressioni cl[a]ssiche dello stile “ufficiale” degli ideologi del partito comunista sovietico15.
Il testo vero e proprio di questa Relazione lunga è preceduto da una breve Prefazione (di tre pagine) che mostra compiutamente il metodo di lavoro di Rota, la sua competenza e la sua profonda conoscenza, non solo del linguaggio ideologico sovietico, ma di quell’intero mondo concettuale scaturito dalla Rivoluzione d’ottobre. Un paragrafo della seconda pagina della Prefazione esemplifica bene, con una efficace metafora, la sostanza dell’interpretazione avanzata da Rota: A parte le inesattezze di italiano proprie ad una persona di lingua russa, i molteplici stereotipi – caratteristici del linguaggio comunista sovietico – impiegati nel messaggio costituiscono come le impronte digitali dell’estensore: le impronte che egli ha lasciato sul luogo del delitto16.
A nostro avviso, gli sconcertanti «ottusi servitorelli», rappresentano una gigantesca “impronta digitale”, talmente enorme che si finisce quasi per non vederla. Nell’ultima sezione della Prefazione, Rota elenca le tre pubblicazioni di cui si è servito per documentare l’analisi delle 27 espressioni già individuate e numerate nella precedente Relazione breve. Si tratta della Pravda, organo ufficiale del defunto Pcus (annate 1976-1979), di Kommunist, la rivista teorica dello stesso Pcus (annate 1967, 1970-1972, 1975, 1977) e di Politicescoe Samobrasovanie (Autodidattica politica), un’altra rivista comunista sovietica (annata 1977)17. Con questo materiale a disposizione Rota procede poi a configurare, in una nuova versione, le 27 espressioni già individuate in precedenza. L’esempio dell’espressione n. 1, ossia gli «ottusi servitorelli», servirà come campione per illustrare tutto il resto della struttura di que-
15
CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 221. CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 235. 17 Ivi, p. 236. 16
169
GABRIELE PARADISI
sta Relazione lunga. Nella parte superiore della pagina, a fianco della dicitura “Testo Br”, Rota trascrive alcune righe del testo italiano del comunicato n. 2 delle Brigate rosse che comprendono l’espressione numerata in oggetto, e che viene sottolineata. In questo caso il testo è il seguente: «… gli strateghi della controrivoluzione e i loro ottusi servitorelli…», che fa parte a sua volta di uno dei più significativi paragrafi della seconda parte (quella ideologica) di quel comunicato brigatista e che è opportuno trascrivere integralmente: Non dubitino gli strateghi della controrivoluzione e i loro ottusi servitorelli revisionisti vecchi e nuovi, che contro l’internazionale del terrore imperialista sapremo costruire l’unità strategica delle forze comuniste18.
Sotto al testo italiano, a fianco della dicitura «lingua sovietica», Rota riporta la «retroversione letterale» (come lui stesso la chiama) in russo del testo italiano. Il testo in russo è manoscritto. Sotto a questa doppia intestazione, Rota procede con i suoi commenti. In questo caso scrive: Il termine (prislusniki) non ha una traduzione letterale in italiano. Fondamentalmente vuol dire “servo”, ma in un significato molto più dispregiativo: è un servo sciocco, e che inoltre striscia, adula, vuol compiacere il padrone. Il vocabolario classico della lingua russa, il Dahl, stampato a Pietroburgo nel 1882 e riprodotto in fotocopia a Mosca nel 1935, riporta a tale riguardo la frase di Griboiedov: “potrei servire come uno schiavo, ma mi fa schifo di essere un «prislusnik»”. La frase “la controrivoluzione (o la reazione, la borghesia oppure l’imperialismo: i termini sono intercambiabili nella fraseologia sovietica) e i suoi ‘prislusniki’” è un classico del linguaggio comunista sovietico19.
Rota prosegue poi raccogliendo una lunga antologia di citazioni in russo dalle tre testate sopra citate, riprodotte in fotocopia, e seguite dalla traduzione italiana. Viene costruito in tal modo un paziente, certosino collage di frammenti testuali che esemplificano, espressione per espressione, tutte le 27 frasi isolate e numerate da Rota. 18 19
CpM, vol. XXXVII (1988), cit., p. 636. CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 237.
170
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Nel caso degli «ottusi servitorelli» le citazioni proseguono per cinque pagine. Riportiamo qui di seguito solo due degli esempi, tratti dalla «Pravda» e da «Kommunist». al IX Congresso del Partito comunista tedesco, il membro del Politburo sovietico, Suslov, dice (Pravda, 20.5.76) “Nello sforzo di impedire la diffusione dell’idea marxista-comunista, gli imperialisti e i loro ‘prislusniki’”. Sul Kommunist (giugno 1971, n. 9, pag. 57) si legge “i politici borghesi e i loro ‘prislusniki’ ideologici…”20
Continuiamo riportando ancora qualche ulteriore interessante osservazione di Rota: l’estensore del messaggio delle Br ha tradotto l’espressione: l’imperialismo (o la controrivoluzione) e i suoi ‘prislusniki’, con la perifrasi non certo felice in italiano: ottusi servitorelli. Il linguaggio propagandistico sovietico ha – ad un livello di stile più basso di quello di Kommunist o della Pravda – un sinonimo di ‘prislusniki’: ed è ‘lakiei’ che deriva dal francese “laquais” ma che in sovietico ha un significato molto più dispregiativo che nella lingua originale ed è l’esatto corrispettivo ‘prislusnik’. Però ‘lacchè’, in italiano, poteva suonare troppo prezioso, e l’estensore si è ribattuto su un ‘servitorelli’ che, secondo lui, conteneva l’idea dello schifo, del disprezzo. Poi ha voluto mettere anche l’altra sfumatura della imbecillità, della stupidità, e ha scritto ‘ottusi servitorelli’. Ora ‘ottuso’, per dire ‘stupido’, non è molto usato in italiano, ma è la traduzione letterale dell’aggettivo comunemente adoperato in russo ‘tupoi’. Nel suo significato originario ‘tupoi’ si applica ad un coltello che ha perso il filo, esattamente come in italiano ‘fesso’ deriva dall’idea di un vaso che si è incrinato21.
Gli ultimi due allegati del “dossier Rota” Nell’allegato n. 3 (Esame del messaggio n. 2 nel quadro dei successivi messaggi), di cinque pagine, Rota esamina le relazioni tra i primi due comunicati delle Brigate rosse e i restanti sette. I due paragrafi iniziali di questo scritto ne riassumono con efficacia il contenuto: 20 21
Ibidem. Ivi, pp. 239-240.
171
GABRIELE PARADISI
Come si è detto, i primi due messaggi delle Br dopo il rapimento di Moro sono stati scritti da un sovietico; anzi nel primo messaggio, solo la parte centrale: quella ideologica, è stata scritta da un sovietico, mentre la parte iniziale e quella finale, a carattere descrittivo, sono di mano italiana. Gli ultimi sette messaggi, dei nove complessivi, non solo sono stati scritti da un italiano, ma cercano anche di rimediare, di camuffare – riprendendoli e rielaborandoli – le improprietà linguistiche o i ‘sovietismi’ sfuggiti al redattore dei primi due messaggi22.
L’allegato n. 4 (Dei sovietici hanno ucciso Moro), di tre pagine, chiude infine il “dossier Rota”. In un passo di questo breve scritto, di tipo più speculativo, Rota scrive: I primi due messaggi delle Brigate Rosse furono buttati giù perciò da un sovietico e trasmessi con ponte radio in Italia a quell’uomo, l’unico uomo che deve esistere e che fa da anello di congiunzione tra i servizi sovietici e le ignare Brigate Rosse italiane23.
Per concludere un’ultima citazione di natura linguistica tratta dal paragrafo successivo a quello sopra citato: I primi due messaggi delle Brigate Rosse non sono stati scritti infatti da un italiano, ma da uno che pensava in russo, anzi, in sovietico. Perché c’è una differenza profonda tra la lingua russa e la lingua sovietica: una diversità di intonazione, di uso di aggettivi, di impiego di parole, di ricorrente uso di frasi stereotipate24.
La punta emersa dell’iceberg: una discussione dei testi riguardanti il “dossier Rota” Che fine hanno fatto i quattro «documenti allegati», citati nella lettera di Rota del 17 marzo 1981? Quali discussioni hanno suscitato i clamorosi contenuti già delineati in questa lettera nella sterminata letteratura sul caso Moro che si è andata accumulando nel quarto di secolo trascorso da allora? 22
CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 369. CpM, vol. CXXI (1995), cit., p. 375. 24 Ivi, pp. 375-376. 23
172
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Per rispondere a questa domanda, qui di seguito sono presi in considerazione, in ordine cronologico, i testi che siamo riusciti ad individuare riguardanti le tematiche legate al “dossier Rota” nei pochi episodi in cui questo “iceberg” è fugacemente apparso da sotto la cortina dell’oblio. I testi provengono principalmente dagli atti della Commissione Moro, da sei audizioni della Commissione Stragi e da alcuni volumi dedicati al caso Moro. La Relazione di maggioranza della Commissione Moro cita Rota in tre righe scarse del paragrafo 4 (L’ipotesi di connivenze di organismi esteri) del capitolo IX (I collegamenti internazionali). Dopo aver esposto brevemente il contenuto dello studio fatto pervenire alla Commissione stessa nel marzo 1981, i commissari di maggioranza formulano questo lapidario giudizio liquidatorio: Per la verità molte delle “espressioni russe” individuate dal dottor Rota erano da tempo entrate nel lessico della sinistra extraparlamentare italiana25.
Data la rilevanza che queste poche righe hanno avuto sulla particolare “sfortuna” incontrata dall’interpretazione di Rota nello scorso quarto di secolo, è utile dedicare qualche riflessione a proposito di questo giudizio critico. Questa valutazione, formulata dai commissari di maggioranza, dello studio di Rota (che, ricordiamolo, occupa oltre 150 pagine), sembrerebbe costituire l’esito finale, ultrasintetizzato, di una qualche relazione dedicata alle analisi del diplomatico italiano. Si cercherebbe tuttavia invano una tale relazione in tutti i restanti 129 volumi degli atti della stessa Commissione Moro. Non si capisce quindi quali siano le argomentazioni che stanno alla base della frettolosa demolizione delle interpretazioni di Rota. Tra l’altro, i commissari di maggioranza non scrivono che tutte le «espressioni russe» individuate da Rota facevano parte del lessico della sinistra extraparlamentare italiana, ma solo «molte». Il che implica che una parte, ossia poche «espressioni», non rientravano in questo «lessico». Ma, ammessa anche la plausibilità della valutazione avanzata dai 25
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, cit., p. 127, corrispondente alla p. 225 del volume Dossier delitto Moro, cit.
173
GABRIELE PARADISI
commissari di maggioranza, sono proprio alcune delle parole e frasi evidenziate da Rota che rappresentano degli sconcertanti reperti, i quali a guisa di enigmatici “fossili linguistici” sfidano la “paleontologia linguistico-politica” apparentemente sostenuta dai commissari di maggioranza (ci sia permessa l’inusuale e un po’ fantasiosa terminologia). Le incredibili coppie linguistiche degli «ottusi servitorelli» o delle «appendici militari», e lo sconcertante uso dei verbi «trainare» o «attivizzare», per limitarsi solo ad alcune delle più “incredibili” parole che popolano il comunicato n. 2 delle Brigate rosse (del 25 marzo 1978), rappresentano una sfida molto impegnativa che i critici di Rota non avrebbero dovuto sottovalutare e liquidare in modo così sbrigativo. I commissari di maggioranza avrebbero dovuto seguire umilmente lo stesso metodo di Rota, ed usarlo come strumento critico contro le interpretazioni avanzate dallo stesso Rota. Avrebbero dovuto costruire, analogamente a quanto aveva fatto il diplomatico italiano, la loro contro-antologia di esempi riguardanti soprattutto la terminologia più “anomala”, cercando di rintracciarla prima di tutto nella vasta “letteratura brigatista” prodotta tra il 1970, anno delle prime azioni della allora Brigata rossa (al singolare) fino almeno alla lunga Risoluzione della Direzione strategica del febbraio 197826 (per limitarsi al periodo precedente il sequestro Moro). I commissari di maggioranza avrebbero potuto scandagliare anche pubblicazioni nell’area contigua alle Brigate rosse, come ad esempio il periodico Controinformazione o, nell’ambito «della sinistra extraparlamentare», citata proprio dagli stessi commissari di maggioranza, l’area dell’Autonomia operaia, o di Potere operaio. Ma niente di tutto ciò, a quanto ci risulta, è stato fatto, allora e nel quarto di secolo seguente. Oggi abbiamo a disposizione un voluminoso corpus di “letteratura brigatista” che non attende altro che di essere attentamente scandagliato27. Un altro elemento che probabilmente ha contribuito a mantenere nell’oblio le analisi di Rota, anche se in modo indiretto, è stata proprio la pubblicazione della Relazione breve e della Relazione lunga in una 26
Questo lungo documento fu diffuso dalle Brigate rosse il 4 aprile 1978 insieme al comunicato n. 4, CpM, vol. CXXIX (1996), pp. 185-217; pubblicato anche in Dossier Brigate rosse 1976-1978, cit., pp. 220-288. 27 Nel 2007 le edizioni Kaos hanno pubblicato due utilissime antologie di scritti delle Br che coprono il decennio 1969-1978: Dossier Brigate rosse 19691975 e Dossier Brigate rosse 1976-1978, cit., entrambe a cura di L. Ruggiero.
174
Quegli «… ottusi servitorelli…»
delle Relazioni di minoranza della Commissione Moro, quella redatta dai commissari dell’allora Movimento sociale italiano-Destra nazionale Franco Franchi e Michele Marchio. Forse la diffusa diffidenza nei confronti dei rappresentanti politici degli eredi della Repubblica sociale italiana ha finito per avere la prevalenza sui contenuti e sulle argomentazioni avanzate dal diplomatico italiano. Nella nota in coda all’indice della loro Relazione, Franchi e Marchio scrivevano: Riteniamo opportuno pubblicare questi due ultimi documenti (7 e 8) per l’importanza che riveste lo studio del diplomatico Rota, uno dei più illustri sovietologi, particolarmente esperto nel linguaggio del partito comunista sovietico. Poiché la Commissione, assurdamente, ha respinto le nostre reiterate richieste di ascoltare il dottor Renzo Rota, pubblichiamo il suo studio trasmesso a tutti i membri della Commissione. Oggi lo studio di Rota sulle responsabilità del Kgb nel sequestro Moro trova una insospettata conferma nel Rapporto dei Servizi di sicurezza italiani. Questi due documenti hanno la potenzialità di far riaprire tutte le analisi e le conclusioni sul caso Moro28.
Gli scritti di Rota forse avrebbero avuto un destino diverso se fossero stati pubblicati, ad esempio, da Leonardo Sciascia, anch’egli membro della Commissione Moro, per il gruppo parlamentare radicale. Ma Sciascia mostra chiaramente di non avere dubbi sull’italianità dei documenti brigatisti: E che l’italiano maneggiato dalle Brigate Rosse sia di traduzione da altra o da altre lingue è questione da lasciar cadere. L’italiano delle Brigate Rosse è semplicemente, lapalissianamente, l’italiano delle Brigate Rosse29. 28 CpM, vol. II, Relazione di minoranza del deputato Franco Franchi e del senatore Michele Marchio (Gruppo parlamentare del MSI-DN), cit., p. 66. I documenti 7 e 8 sono gli ultimi due allegati della loro relazione, ossia La via del Kgb La denuncia del diplomatico dottor Renzo Rota, Ministro plenipotenziario, pp. 121-366 e La via del Kgb Il rapporto dei Servizi di sicurezza, pp. 367-396, quest’ultimo è un rapporto del Cesis, classificato «riservatissimo», del 31 marzo 1983, intitolato Implicazioni internazionali del terrorismo. 29 CpM, vol. II (1983), Relazione di minoranza del deputato Leonardo Sciascia (Gruppo parlamentare radicale), p. 410, la relazione completa occupa le pp. 397413; è stata ripubblicata anche in L. SCIASCIA, L’affaire Moro. Con aggiunta la Relazione Parlamentare, Sellerio, Palermo 1983 (3ª ed. 1989), pp. 147-183 (altra ed., Adelphi, Milano 1994, 10ª ed. 2007, pp. 159-196).
175
GABRIELE PARADISI
Sciascia, attento lettore dei giornali dei 55 giorni del sequestro Moro, sembra riferirsi ad articoli di stampa apparsi nell’ultima decade di marzo 1978 e forse anche alle analisi di Rota; il nome del diplomatico, tuttavia, non compare nel suo scritto. Anche Sciascia, pur così acuto e raffinato nelle sue analisi del caso Moro, al quale aveva dedicato uno dei primissimi studi sull’argomento, apparso già nell’ottobre 197830, si limita pertanto a proporre una banale tautologia e non un giudizio critico. Sarebbe stato molto interessante se Sciascia si fosse inoltrato nel labirinto linguistico additato da Rota. È stata, purtroppo, un’occasione mancata. Nel 1995 un piccolo spiraglio sullo studio di Rota si apre in un libro che raccoglieva le lettere di Aldo Moro dalla prigionia brigatista31. In quel volume è trascritto il testo italiano della Relazione breve. Quel libro deve aver avuto però una limitatissima circolazione e si può considerare un libro “clandestino”32. Un ulteriore elemento che non ha giovato a far conoscere i testi di Rota è stato l’uso occulto, e poco accurato, che ne ha fatto il generale dei carabinieri Francesco Delfino in un suo libro autobiografico33. Delfino, che dichiara esplicitamente nel suo libro di non essersi mai occupato del caso Moro, dedica poco meno di tre pagine34 al tentativo di rispondere alla domanda: «C’è o non c’è un Grande Vecchio, in grado di muovere a suo piacimento i fili del burattino Italia?»35. Per rispondere, Delfino utilizza un espediente narrativo, una sorta di versione modernizzata del ritrovamento di un antico manoscritto, qui sostituito dalla casuale apertura di quattro file occultati in un computer. Nel primo file compare Henry Kissinger, il “grande fratello” atlantico, che potrebbe essersi frapposto ai tentativi di salvare Moro. Nel secondo file si delinea il “grande fratello” sovietico, che attraverso il Kgb avrebbe partecipato alla stesura dei primi due comunicati brigatisti. 30
L. SCIASCIA, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978. A. MORO, Lettere dal patibolo, cit., si veda anche «Critica Sociale», n. 1/2 (2008) alla prima pagina dell’indice. 32 Non è citato neppure nella pur accurata recente edizione dell’epistolario di A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura da M. Gotor, cit. 33 F. DELFINO, La verità di un generale scomodo. Dal banditismo sardo al caso Soffiantini, Industria Edit. Telematica, Verona 1998. 34 Ivi, pp. 65-67. 35 Ivi, p. 65. 31
176
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Nel terzo file entra in gioco il “fratello maggiore” israeliano che avrebbe ordito l’attentato alla questura di Milano del 17 maggio 1973, attraverso Gianfranco Bertoli. Infine nel quarto file compare un ipotizzato connubio tra l’eversione di sinistra, rappresentata da Giangiacomo Feltrinelli dilaniato da una carica esplosiva che si apprestava a piazzare in un traliccio di Segrate il 14 marzo 1972, e l’eversione di destra, rappresentata da Carlo Fumagalli, che possedeva un covo proprio a 300 metri dal luogo dell’attentato. Il secondo file è quello che qui ci interessa direttamente e dal quale citiamo alcuni dei passi più significativi: Secondo file: un vocabolario russo-italiano. Stralcio dai primi due comunicati delle Brigate Rosse alcune frasi: “La congrega più bieca di ogni manovra giudiziaria… sulle cui gambe cammina il progetto delle multinazionali…”, “Le maggiori potenze che stanno alla testa della camera gerarchica…”, “Il compito di trainare le appendici militari…” […] Se un traduttore russo, che conosce poco bene l’italiano, avesse dovuto ricorrere al vocabolario per accertarsi del significato di parole che nei discorsi quotidiani non erano mai entrate… traino… cinghia… camera gerarchica… congrega bieca… progetto delle multinazionali…?»36.
Sebbene Delfino non citi mai Rota, la figura del diplomatico italiano si può intravedere abbastanza chiaramente, ad esempio dal richiamo al «vocabolario russo-italiano» che compare subito all’inizio della citazione37. Ma i panni del filologo mal si addicono al generale dei carabinieri. Cerchiamo pertanto di districare la matassa delle citazioni dai primi due comunicati brigatisti che Delfino ha parecchio ingarbugliato: I «La congrega più bieca di ogni manovra giudiziaria…» corrisponde in realtà alla frase del comunicato n. 1 «la congrega più bieca di ogni manovra reazionaria»38; II «sulle cui gambe cammina il progetto delle multinazionali…» è una citazione corretta, ma il testo si trova nel comunicato n. 239; 36
Ivi, p. 66. Nella Relazione breve, Rota utilizza parecchie volte, per le sue analisi, il vocabolario russo-italiano edito nel 1972 dall’Enciclopedia sovietica, si veda CpM, vol. CXXI (1995), cit., pp. 225, 227, 230 e 232. 38 CpM, vol. XXXVII (1988), cit., p. 547, corsivi aggiunti. 39 CpM, vol. XXXVII, cit., p. 636. 37
177
GABRIELE PARADISI
III «Le maggiori potenze che stanno alla testa della camera gerarchica» corrisponde in realtà alla frase del comunicato n. 1 «le maggiori potenze che stanno alla testa della catena gerarchica»40; IV «Il compito di trainare le appendici militari» è inserita nel contesto di questa frase del comunicato n. 2: «Sono i paesi più forti della catena e che hanno già collaudato le tecniche più av[a]nzate della controrivoluzione ad assumersi il compito di trainare, istruire, dirigere le appendici militari nei paesi più “deboli” che non hanno ancora raggiunto i loro livelli di macabra efficienza»41. Le precedenti puntualizzazioni sono doverose perché le citazioni alquanto maldestre di Delfino sono evocate in alcune audizioni della Commissione Stragi che esaminiamo più sotto. In un altro passo di questo immaginario secondo file, Delfino forniva invece delle autentiche novità, provenienti da informazioni estremamente riservate, quasi sicuramente provenienti dai servizi segreti. Scrive Delfino: E se, tra il secondo e il terzo comunicato, il traduttore del Kgb in Italia fosse stato richiamato in patria, come si suol dire in termini diplomatici, “per consultazioni”, e fosse stato sostituito con un altro più ferrato nella lingua italiana, capace di tradurre anche i più desueti termini dell’Urss in lingua moderna…? Non sembrano forse scritti in Unione Sovietica i primi due comunicati?42.
Qui Delfino sembra delineare la figura di Sergeij Sokolov – all’epoca del tutto ignoto, ma fin dal 1977 ben conosciuto dai servizi segreti italiani – il presunto “borsista” sovietico che frequentava le lezioni di Moro nell’inverno del 197843.
40
CpM, vol. XXXVII, cit., p. 547, corsivi aggiunti. CpM, vol. XXXVII, cit., p. 636. 42 F. DELFINO, La verità di un generale scomodo, cit., p. 66. 43 Sulla vicenda Sokolov si veda: Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l’attività d’intelligence italiana (istituita con Legge 7 maggio 2002, n. 90; prorogata con Legge 11 agosto 2003, n. 232), Documento conclusivo sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta, presentato dal presidente senatore Paolo Guzzanti, 15 marzo 2006, doc. n. 374, pp. 213-219; Documento conclusivo sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta, presentato dai commissari del centrosinistra, 23 marzo 2006, doc. n. 377, pp. 164-169. Entrambe queste relazioni si possono consultare nel sito del Parlamento italiano all’indirizzo internet 41
178
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Nelle sei audizioni della Commissione Stragi tenutesi durante la XIII Legislatura (1996-2001), sotto la presidenza di Giovanni Pellegrino, riguardanti l’“Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro”, il deputato Enzo Fragalà (indirettamente attraverso il testo di Delfino) e Vincenzo Manca, vicepresidente della stessa Commissione (direttamente attingendo ai testi di Rota), sollevano la questione delle anomalie linguistiche dei primi due comunicati delle Brigate rosse. Il presidente Giovanni Pellegrino avanza invece molte osservazioni critiche, non sempre ben mirate in realtà, nei confronti delle tematiche linguistiche proposte durante le discussioni. Durante l’audizione del senatore Luciano Barca, tenutasi il 17 febbraio 199944, Fragalà, pur non citando direttamente Rota, insiste in particolare sull’espressione «camera gerarchica», evocata nel libro autobiografico di Delfino45 e nella recensione di Giorgio Bocca a quel libro46. Fragalà però, prendendo per buona la citazione tratta da Delfino, incorre in un equivoco terminologico poiché l’espressione che si trova nel comunicato n. 1 delle Brigate rosse (del 18 marzo 1978) non è «camera gerarchica» bensì «catena gerarchica», come si è detto in precedenza. La discussione si arena perciò rapidamente. L’audizione di Giovanni Moro, figlio del leader assassinato, si tiene il 9 marzo 199947. Fragalà, che parte sempre col piede sbagliato, chiede un parere sulle ipotesi «di tipo sintattico e terminologico» che si trovano nel libro di Delfino, sopra menzionato. Giovanni Moro replica che è meglio lasciar perdere le precarie competenze linguistiche di Delfino http://www.parlamento.it/Bicamerali/mitrokhin/sommariobicamerali.htm. Per ulteriori considerazioni si veda anche più sotto. 44 Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (d’ora in poi CpS). La versione cartacea dei resoconti stenografici delle sedute della XIII Legislatura (1996-2001) si può consultare al sito internet del Senato della Repubblica: http://www.archivioinchieste.senato.it/html/consultazione.htm. Una versione in formato htm si può consultare nel sito del Parlamento italiano: http://www.parlamento.it/bicam/terror/home.htm. Per l’audizione di Barca si veda il 47º resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 febbraio 1999, pp. 2086-2088. 45 F. DELFINO, La verità di un generale scomodo, cit., p. 66. 46 G. BOCCA, I misteri del generale. La verità di Francesco Delfino sulle Br, il “grande vecchio”, la cattura di Riina, «la Repubblica», 4 febbraio 1999, p. 13. 47 CpS, 48º resoconto stenografico della seduta di martedì 9 marzo 1999, p. 2120.
179
GABRIELE PARADISI
e che è preferibile guardare con più attenzione alle sue conoscenze nell’ambito dei servizi segreti. La discussione si esaurisce così ancor prima di iniziare. Anche con Alberto Franceschini48, sentito il 17 marzo 199949, Fragalà ripropone ancora lo stesso tema dell’audizione del 17 febbraio, sopra ricordata; anche in questa circostanza non è richiamato Rota. Questa volta Fragalà cita direttamente dal libro di Delfino50, anche qui compare di nuovo l’errata espressione «camera gerarchica». Franceschini, pur ritenendo «interessante» il tema sollevato da Fragalà, non si sofferma più di tanto sul problema strettamente linguistico, che considera solo un «pretesto». La discussione specifica, che pure aveva registrato un qualche consenso, si disperde rapidamente nella più vasta questione delle possibili interferenze dei servizi segreti orientali (Kgb) e occidentali (Cia e Mossad) nel caso Moro. Durante la discussione il presidente Giovanni Pellegrino accenna al linguista Tullio De Mauro che, ancor prima di Rota, aveva scritto due articoli con alcune riflessioni “filologiche” sul primo comunicato brigatista (quello del 18 marzo 1978)51. Nell’audizione del magistrato Rosario Priore, tenutasi il 10 novembre 199952, riaffiorano in modo esplicito le analisi di Rota. Per comprendere il contesto nel quale riemerge il “dossier Rota” è necessario dilungarsi un po’ sull’argomento principale affrontato in quella giornata, ossia il caso Sokolov.
48 Fondatore con Renato Curcio e Margherita Cagol delle Brigate rosse, arrestato insieme a Curcio l’8 settembre 1974 a Pinerolo. 49 CpS, 50º resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 marzo 1999, pp. 2265-2266. 50 F. DELFINO, La verità di un generale scomodo, cit., p. 66. 51 T. DE MAURO, Tentativo di lettura filologica del messaggio Br. Non è come gli altri: sembra tradotto dal francese, «Paese Sera», 19 marzo 1978; T. DE MAURO, Sembra scritto da un francese, «La città futura», 22 marzo 1978. Pellegrino però scambia l’ipotesi avanzata da De Mauro con quella proposta da A. LEVI, L’analisi del volantino dei “brigatisti„ trovato a Roma. C’è un’ipotesi latino-americana, «La Stampa», 21 marzo 1978, p. 3. Levi, a quel tempo direttore del quotidiano torinese, riprendeva, commentandolo, proprio l’articolo di De Mauro di due giorni prima su «Paese Sera». 52 CpS, 56º resoconto stenografico della seduta di mercoledì 10 novembre 1999, pp. 2524-2527.
180
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Rosario Priore fu giudice istruttore, fin dal 13 maggio 1978, nei processi dal Moro-1 al Moro-4 (fino al 1990). Nel corso della delicata audizione (Priore era propenso a tenerla infatti in seduta segreta, poi si decise per la seduta pubblica), il magistrato legge stralci di una lettera inviatagli il 5 novembre 1999 da Francesco Tritto (1950-2005), assistente e poi successore sulla cattedra universitaria che era stata di Moro53. L’argomento riguarda l’assidua frequentazione delle lezioni di Moro, fino al 15 marzo 1978, del “borsista” sovietico Sergeij Sokolov (allora venticinquenne, essendo nato nel 1953). La scheda n. 83 del “Rapporto Impedian”, meglio noto come “dossier Mitrokhin”, lo qualifica come «ufficiale del V Dipartimento del Primo Direttorato Principale del Kgb che lavorava sull’Italia. Sokolov fu in Italia negli anni 1981-1982 sotto la copertura di corrispondente della Tass»54. Era stata proprio la clamorosa, e del tutto inusuale pubblicazione del “dossier Mitrokhin”, decisa dall’Ufficio di presidenza della stessa Commissione Stragi, l’11 ottobre 1999, a risvegliare i ricordi di Tritto. L’assistente di Moro rammentò così l’assidua presenza di Sokolov alle lezioni di Moro e le sue domande sugli uomini della scorta, che tanto lo avevano inquietato. Lo stesso giorno del sequestro di Moro, il 16 marzo 1978, Tritto si era recato dal sottosegretario agli Interni, Nicola Lettieri, per segnalargli la presenza di Sokolov alle lezioni di Moro. In seguito Tritto fu rassicurato da un ufficiale dei servizi segreti italiani che Sokolov era sorvegliato fin dal suo arrivo in Italia sul finire del 197755. Fu solo la pubblicazione del “dossier Mitrokhin” a far 53
Su Tritto si veda D. BARBARA e R. MARINO, La lezione. Aula XI, Armando Curcio, Roma 2008. 54 Per “Rapporto Impedian”, o “dossier Mitrokhin”, si intende l’insieme delle 261 schede che il Sis (Secret Intelligence Service) inviò, tra il marzo 1995 e il maggio 1999, al Sismi, l’allora servizio segreto militare italiano. È consultabile al sito Internet http://www.unknown.it/materiale/mitrokhin.html. Per l’edizione a stampa si veda Dossier Kgb, rapporto Mitrokhin. Tutti i documenti dello spionaggio in Italia, a cura di A. Ruggieri, sapere 2000 edizioni multimediali, Roma 1999. Questo volume riporta impropriamente il nome di V. Mitrokhin come autore del rapporto, compilato in realtà dal Sis sulla base della documentazione, conservata negli archivi del Kgb, trascritta dallo stesso Mitrokhin tra il 1972 e il 1984 e trasferita poi in Gran Bretagna nel 1992. 55 V. SATTA, Odissea nel caso Moro, cit., p. 39.
181
GABRIELE PARADISI
emergere dal “sommerso della Repubblica” la vicenda di Sokolov, grazie ai ricordi di Tritto56. È in questo ambito che il vice presidente della Commissione Stragi, Vincenzo Manca, legge, quasi integralmente, la parte dattiloscritta della lettera del 17 marzo 1981 inviata da Rota alla Commissione Moro, sollevando il caso delle possibili “presenze” sovietiche nel caso Moro. Sulle tematiche sollevate da Manca, Priore (che pure conosceva le analisi di Rota) manifesta prudenza e preferisce una sorta di sospensione del giudizio. Fortemente critico è invece l’atteggiamento assunto dal presidente Pellegrino che, quasi infastidito dalle questioni avanzate da Manca, qualifica come «una grossa sciocchezza»57 l’analisi di Rota. Pellegrino obietta inoltre che «una analisi testuale dovrebbe dimostrare quali e quante frasi del primo o del secondo comunicato delle Brigate Rosse non appartengono al linguaggio delle stesse. Non si specificano le frasi»58. Rota (all’opposto di quanto sembra ritenere Pellegrino) aveva fatto proprio un elenco di 27 parole o espressioni, appositamente numerate, che a suo parere derivavano direttamente dal linguaggio ideo56
Va ricordato, infatti, che nulla si dice di Sokolov in CH. ANDREW e V. MIThe Mitrokhin Archive. The Kgb in Europe and the West, Allen Lane, The Penguin Press, London 1999 (ed. it. L’Archivio Mitrokhin. Le attività segrete del Kgb in Occidente Con un’appendice sui documenti dell’Archivio Mitrokhin in Italia Milano, Rizzoli, Milano 1999. Va tenuto presente che l’edizione italiana di questo volume è parziale – manca l’intero capitolo 28 dell’edizione originale – e censurata – sono state soppresse 438 note e i testi che a quelle note rimandavano – rispetto all’edizione inglese; ristampata dallo stesso editore nel 2007, con una Introduzione di G. D’Avanzo, pp. I-XIII. Per una ricostruzione del ruolo di Sokolov in relazione al caso Moro, rimandiamo alla estesa trattazione dell’argomento svolta nel volume di F. IMPOSIMATO e S. PROVVISIONATO, Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il giudice dell’inchiesta racconta, Chiarelettere, Milano 2008, pp. 217-234 e, per una divergente valutazione, ai volumi di V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 33-42 e G. DE LUTIIS, Il golpe di via Fani. Protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro, Sperling & Kupfer, Milano 2007, pp. 207-209. Questi ultimi due autori, pur da impostazioni storiografiche diverse, propendono per una sostanziale estraneità di Sokolov nel caso Moro. 57 CpS, 56º resoconto stenografico, cit., p. 2527. 58 Ibidem. TROKHIN,
182
Quegli «… ottusi servitorelli…»
logico sovietico. Pellegrino ritiene inoltre «una piccola forzatura» dire che l’espressione «smascheramento del nemico imperialista» è una frase che «Moretti non poteva scrivere»59. Ma «smascheramento del nemico imperialista» non figura affatto né tra le 27 espressioni numerate, né tra le altre non numerate, analizzate da Rota nelle sue due relazioni. Quella citata da Pellegrino è semplicemente una frase che Rota ha trascritto nel frontespizio della sua Relazione lunga, cioè negli Stereotipi del linguaggio comunista sovietico. La citazione completa è la seguente: «Nello smascheramento del nemico imperialista, … noi adoperiamo un linguaggio grigio e piatto, stereotipato sul piano emotivo…»60. In questo caso non c’erano di mezzo i comunicati brigatisti, ma solo gli «stereotipi» del linguaggio sovietico, esplicitamente menzionati in una rivista politica appartenente a quell’universo ideologico. Anche in questo caso la discussione si esaurisce rapidamente e prende altre strade. Nella continuazione dell’audizione di Priore, nella seduta dell’11 novembre 199961, il presidente Pellegrino si scusava col senatore e vicepresidente Manca per il brusco intervento del giorno precedente, a proposito dei comunicati delle Brigate rosse, e coglieva l’occasione per fare alcune precisazioni. Secondo Pellegrino sui documenti delle Brigate rosse hanno tenuto il campo due errori contrapposti. Da un lato quello di gran parte dell’intellettualità italiana che ha quasi sempre qualificato i documenti brigatisti come «farneticanti» (o «deliranti»); dall’altro quello di coloro che hanno proposto una lettura «linguistica» di quei comunicati. Lettura alla quale Pellegrino non ha mai creduto, dal momento che a suo parere «quei comunicati le Brigate Rosse se li scrivevano da soli»62 dando quindi per risolto un enigma che a noi pare tuttora aperto. Pellegrino contrapponeva alle valutazioni linguistiche l’analisi di tipo contenutistico svolta dalla stessa Commissione Stragi sul documento di rivendicazione dell’omicidio di Massimo D’Antona. Non ci sembra tuttavia che le analisi di tipo linguistico 59
Ibidem. CpM, vol. CXXI (1995), p. 233, la citazione è tratta dalla rivista comunista sovietica «Politicescoe Samobrasovanie» (Autodidattica politica) del luglio 1977, p. 45. 61 CpS, 57º resoconto stenografico della seduta di giovedì 11 novembre 1999, pp. 2576-2577. 62 Ivi, p. 2577. 60
183
GABRIELE PARADISI
formulate da Rota siano necessariamente in conflitto con quelle di taglio contenutistico, ci paiono anzi complementari63. Lo stesso 11 novembre 1999 Gianluigi da Rold pubblicava sul «Giornale» un articolo che illustrava favorevolmente le analisi di Rota e nel quale è riprodotto l’originale della prima pagina della Relazione breve del 197864. L’autore rimandava, seppure in modo generico, alle relazioni di minoranza della Commissione Moro del 1983. Questa è probabilmente l’unica emersione delle analisi di Rota sulla stampa quotidiana, 16 anni dopo che erano state rese disponibili. L’articolo di Da Rold suscitò però scarso interesse tanto che non è neppure riportato nella rassegna stampa della Camera65 dei deputati. Le analisi di Rota fanno una nuova e ancor più fugace apparizione nell’audizione, tenutasi il 24 novembre 199966, del magistrato Ferdinando Imposimato, giudice istruttore nei processi Moro-1 e Moro-2 (fino al 1984). È ancora il vice presidente Vincenzo Manca a sollevare il caso delle analisi di Rota; ma in questa audizione la discussione è brevissima e cade rapidamente. Anche Imposimato però non sembra avere una conoscenza di prima mano delle analisi di Rota, il quale ha proposto una interpretazione, controversa fin che si vuole, ma che difficilmente si può etichettare, secondo Imposimato, come una «deduzione logica»67. 63
A proposito dell’omicidio di Massimo D’Antona, avvenuto a Roma il 20 maggio 1999 e di quello di Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002 (entrambi docenti universitari e consulenti del ministro del Lavoro), Amedeo Benedetti ha proposto una approfondita analisi comparata dei lunghi documenti di rivendicazione dei due delitti eseguiti dalle Brigate rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente: A. BENEDETTI, Il linguaggio delle nuove Brigate rosse. Frasario, scelte stilistiche e analisi comparativa delle rivendicazioni dei delitti D’Antona e Biagi, Erga, Genova 2002. Al termine di un’analisi estremamente accurata, nella quale metteva a confronto le ricorrenze di oltre una novantina di forme linguistiche, Benedetti giungeva alla rilevante conclusione (p. 122) che la mano che aveva redatto la rivendicazione del delitto D’Antona era la stessa che aveva stilato la rivendicazione dell’assassinio di Biagi. 64 G. DA ROLD, Quei comunicati delle Br copiati dal cirillico, «il Giornale», 11 novembre 1999, p. 8. 65 http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/rassegnaQuotidianaFrame.asp. 66 CpS, 58º resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 novembre 1999, pp. 2605-2606. 67 Ivi, p. 2606.
184
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Vladimiro Satta ha lavorato, dal 1989 al 2001, come archivista della Commissione Stragi, e si è trovato pertanto in una posizione privilegiata per conoscere la sterminata documentazione accumulata sia da questa Commissione (qualcosa come un milione e mezzo di pagine), sia dalla precedente Commissione Moro, e anche di altre Commissioni parlamentari. Anche se non si condividono le conclusioni che l’autore trae nel libro Odissea nel caso Moro68 occorre riconoscere che gli scritti di Satta sono ricchissimi di puntuali rinvii alla documentazione di base su quasi tutte le questioni controverse del caso Moro. L’Odissea, un vero e proprio trattato enciclopedico, è un importante contributo pubblicato nel 25º anniversario del sequestro del presidente della Dc, e continua ad essere tra i volumi più dibattuti negli ultimi anni. Satta, pur aderendo alle conclusioni della Relazione di maggioranza della Commissione Moro (si veda sopra), ha avuto il merito non indifferente, dopo un assordante silenzio durato 20 anni nella storiografia del caso Moro, di segnalare, finalmente, dove si poteva reperire lo studio integrale formulato da Renzo Rota69. Va comunque notato che neppure questo studioso del caso Moro ha prodotto una qualche analisi critica degli scritti di Rota. Si è limitato infatti a sottoscrivere quanto si trova enunciato nella Relazione di maggioranza della Commissione Moro, più sopra richiamata e criticata, senza aggiungere un suo contributo originale. Naturalmente ciò è legittimo, ma lascia il problema irrisolto ed esattamente allo stesso punto nel quale si trovava 20 anni prima. Rocco Turi, sociologo e giornalista, nella prima parte del libro Gladio Rossa70 sviluppa una originale ricerca storica basata in gran parte su documenti inediti degli archivi diplomatici italiani. Questa parte del libro si occupa principalmente degli ex partigiani comunisti rifugiatisi in Cecoslovacchia nell’immediato dopoguerra, della formazione dell’apparato di propaganda riunito intorno a Radio Oggi in Italia (una sezione clandestina di Radio Praga), e delle scuole di sabotaggio e terrorismo. La
68
V. SATTA, Odissea nel caso Moro, cit. e nel successivo Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit. 69 V. SATTA, Odissea nel caso Moro, cit., p. 210 e p. 254, nota 605. 70 ROCCO TURI, Gladio Rossa. Una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra al caso Moro, Marsilio, Venezia 2004: Ex partigiani in azione.
185
GABRIELE PARADISI
seconda parte del volume (Ipotesi intorno all’eredità brigatista) è di natura più “speculativa” e riguarda una possibile ricostruzione del sequestro Moro in relazione con la “pista cecoslovacca”. È proprio nella sezione intitolata La «pista cecoslovacca», che viene evocata l’analisi di Rota: Nonostante i dubbi che l’onorevole Franco Franchi e il senatore Michele Marchio tentarono di seminare fra i colleghi della Commissione parlamentare [Moro, 1979-1983], la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione apparve riduttiva e superficiale. Franchi e Marchio, ad esempio, stigmatizzarono la mancata audizione del diplomatico Rota, illustre sovietologo, esperto nel linguaggio del Pcus71.
Turi è l’unico autore, tra coloro che si sono occupati del caso Moro, che esprime un giudizio positivo sulle analisi di Rota. La ricorrenza, lo scorso anno, del trentennale del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro ha visto una copiosa produzione di saggi sull’argomento. Giuseppe De Lutiis, anticipando i tempi, ha pubblicato un saggio nel settembre 200772. L’autore è uno studioso dei servizi segreti e dei poteri occulti. Nella sezione finale del capitolo 1173, l’autore prende in considerazione alcune tesi proposte nel libro di Francesco Delfino, sopra discusso74. De Lutiis sembra cautamente approvare lo scenario delineato da Delfino. A farne le spese però è ancora una volta Renzo Rota. Infatti, il rimando bibliografico della nota 58, dove viene citato Rota, manda in corto circuito il testo di pagina 224 e il «secondo file» immaginato da Delfino, in quanto De Lutiis si richiama esclusivamente alla qui più volte citata pagina 127 della Relazione di maggioranza della Commissione Moro (1983), che esprime un giudizio del tutto negativo sul contributo di Rota. Inoltre, con quel solo rimando bibliografico si preclude al lettore, ancora una volta, la possibilità di consultare quanto Rota ha effettivamente scritto.
71
Ivi, p. 220. G. DE LUTIIS, Il golpe di via Fani, cit. 73 I legami con l’Europa orientale: l’ombra di Jalta, capitolo dedicato ad una discussione della “pista orientale” in relazione al caso Moro. 74 F. DELFINO, La verità di un generale scomodo, cit. 72
186
Quegli «… ottusi servitorelli…»
Stefano Grassi, un giornalista che ha scritto per «la Repubblica», «Il Foglio» e «Il Giorno», ha pubblicato un voluminoso tomo enciclopedico (di oltre 800 pagine), ordinato alfabeticamente, sul caso Moro75. Il diplomatico Renzo Rota è citato in due voci. Alla voce omonima si legge: Rappresentante diplomatico italiano in Unione Sovietica. Propone alla Commissione Stragi una rilettura dei comunicati redatti dalle Brigate rosse durante il sequestro Moro, come strettamente derivanti dalla lingua russa e dal lessico burocratico del Pcus. La commissione formula, però, un giudizio negativo sul valore del contributo analitico76.
Alla voce Franchi, Franco, troviamo scritto: Parlamentare del Movimento sociale italiano. Membro della Commissione Moro. Autore, con Michele Marchio, di una relazione di minoranza cui è allegato uno studio di Renzo Rota, primo consigliere dell’ambasciata italiana a Mosca, che tenta di dimostrare la derivazione del linguaggio dei comunicati brigatisti dalla corrente pubblicistica politica sovietica77.
Data la considerevole mole del volume di Grassi, è comprensibile che l’autore non sia riuscito a tenere sotto controllo tutti i numerosissimi rimandi incrociati che si intrecciano nella sua opera. Così, nella prima voce, si fa approdare Rota alla Commissione Stragi ma, come si è visto, Rota inviò il suo “dossier” alla Commissione Moro nel marzo 1981, sette anni prima che fosse istituita la Commissione Stragi. Nella seconda voce, invece, il contributo di Rota è segnalato correttamente come allegato alla Relazione di minoranza di Franchi e Marchio (1983) della Commissione Moro. Inoltre, va ricordato che Rota ipotizzò che solo i primi due comunicati delle Brigate rosse (del 18 e 25 marzo 1978) fossero stati scritti, almeno in parte, da un «ideologo» del Partito comunista sovietico.
75
S. GRASSI, Il caso Moro. Un dizionario italiano, Mondadori, Milano 2008. Ivi, pp. 619-620. 77 Ivi, p. 286. 76
187
GABRIELE PARADISI
Conclusione: un auspicio per il futuro Al termine di questa rassegna ci sentiamo di formulare un auspicio: speriamo che nei prossimi anni venga finalmente colmata, da parte di qualche volonteroso studioso che sappia superare l’istintiva repulsione che gli scritti brigatisti hanno suscitato nel passato, la sorprendente lacuna che abbiamo messo in evidenza nell’introduzione. Per quanto il suggerimento possa sembrare strano, a nostro avviso i testi dattiloscritti e diffusi come ciclostilati dalle Brigate rosse nella primavera del 1978 dovrebbero essere studiati come se fossero delle antiche pergamene medievali o dei papiri rimasti sepolti nel deserto egiziano. Andrebbero attentamente analizzati gli originali, ammesso che siano ancora conservati in un qualche tribunale della Repubblica; bisognerebbe fornire di quei testi una vera e propria edizione critica, come per i classici dell’antichità. Infatti, le molte edizioni a stampa dei documenti brigatisti, che inevitabilmente normalizzano le forme grammaticali errate che si riscontrano nei testi originali (ad esempio è quasi sistematicamente errato l’uso degli accenti nella terza persona singolare del verbo essere), finiscono per occultare, anche se del tutto involontariamente, “indizi” che potrebbero rivelarsi preziosi per identificare il redattore dei comunicati brigatisti o almeno il dattilografo. Quello che suggeriamo non è un mero e stravagante esercizio di filologia fine a se stesso, ma la preparazione di un insieme di tessere che alla fine potrebbero ricomporsi e portare a capire chi ha scritto veramente quei comunicati, individuo singolo o “entità collettiva” che sia. In questo ambito di ricerche un indispensabile capitolo dovrebbe essere inevitabilmente riservato ad una valutazione critica del “dossier Rota” che da troppo tempo è rimasto a giacere come uno spettro tra i volumi della Commissione Moro, ma che potrebbe riacquistare oggi nuova vita grazie alla facilità di consultazione messa a disposizione da Internet. C’è ancora del lavoro da fare sui comunicati e su gli altri scritti delle Brigate rosse riguardanti il caso Moro, reperti linguistici “fossili” di un’era della storia dell’Italia repubblicana sempre più lontana, che dovrebbero essere collocati nell’ambito dell’indagine storica e studiati con tutti gli strumenti concettuali che la ricerca storica mette a disposizione.
188
IL CASO MORO VISTO DALL’INTERNO DEL PALAZZO Franco Mazzola
Collocazione geografica e peculiarità della politica estera italiana Anche per chi – come me – l’ha vissuto da una responsabilità di governo, il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, per poter essere valutati in tutti i loro aspetti e risvolti, devono essere collocati nel quadro della situazione interna ed internazionale di cui sono parte integrante. Il rischio della banalità che c’è in un’affermazione del genere viene meno se si tiene conto degli aspetti assolutamente peculiari della vicenda. Su di essi, non a caso, non solo non si è ancora fatta compiutamente chiarezza, ma, anzi, sono stati visti e valutati diversamente a secondo dell’angolatura dalla quale venivano guardati. Del tutto particolare, infatti era la situazione dell’Italia negli anni Sessanta sotto il profilo geo-politico: un paese al confine della “marca occidentale”, proiettato al centro del Mediterraneo, incrocio di culture, storie ed interessi diversi e per molti versi contrastanti. Ospitava il più forte partito comunista del mondo, esclusi quelli del blocco sovietico. È vero che stava maturando al proprio interno un processo di autonomia dall’Urss, ma ciò lo rendeva molto diverso e peculiare rispetto ad altri partiti comunisti dell’Occidente e non particolarmente gradito alla dirigenza sovietica e degli altri paesi del Patto di Varsavia. Si tenga conto che, pur nella fedeltà all’alleanza atlantica, l’Italia aveva sviluppato una propria politica estera segnata dalla grande attenzione ai problemi dell’area mediterranea, soprattutto di quella medio-orientale. Tutti questi aspetti rivestono un’importanza rilevante e da essi non si può prescindere se si vuole esaminare la vicenda Moro con gli occhiali della storia e non solo con quelli della cronaca giudiziaria. Ma con questo approccio le cose si complicano. Infatti, com’è noto, la verità storica, è molto più complessa di quella processuale. 189
FRANCO MAZZOLA
Sul caso Moro una verità processuale è stata accertata, ma non ha potuto rispondere a molti interrogativi che sono tuttora aperti ed ai quali, in verità, non spetta tanto ai giudici quanto agli storici rispondere. La ricerca della risposta a questi interrogativi si presenta difficile. Forse è destinata a non approdare a conclusioni definitive perché i grandi delitti della storia lasciano sempre dietro di sé una scia di interrogativi irrisolti, come la tragica fine di John e Robert Kennedy ci ha dimostrato. Nella vicenda Moro dobbiamo quindi cercare, al di là della verità processuale, le ragioni storico-politiche che possono essere state alla radice dei fatti. Occorre, pertanto, sviluppare un ragionamento non solo di natura giudiziaria, ma anche politico. Senza di esso, infatti, pensare di potersi avvicinare alla “verità reale” è assolutamente impossibile. Abbiamo accennato prima ad un aspetto peculiare della politica estera italiana, rappresentato da una particolare attenzione ai problemi dei paesi mediterranei e soprattutto a quelli del Medio Oriente. Si trattava di un’impostazione che veniva da lontano e affermava l’esigenza di considerare le ragioni non solo dei paesi che si erano affrancati dal colonialismo attraverso dure lotte di liberazione, come l’Algeria, ma anche e soprattutto le ragioni dei palestinesi. Essi aspiravano ad avere una loro patria, e questa rivendicazione doveva essere conciliata con quelle degli israeliani i quali, a loro volta, non volevano perdere lo spazio geografico che erano riusciti a riavere soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Questa politica aveva avuto negli anni Settanta un risvolto “segreto” nato dall’esigenza di risparmiare all’Italia l’esperienza degli attentati di matrice palestinese che insanguinavano in quel periodo altri paesi. Ciò fu possibile in cambio di una sorta di “status” di combattenti riconosciuto di fatto ai terroristi palestinesi. Aldo Moro, come ministro degli Esteri prima e come presidente del Consiglio poi, era stato il principale artefice di questa politica che quindi conosceva benissimo. Ciò spiega le lettere sullo “scambio di prigionieri” recapitate durante il suo sequestro al partito della Democrazia cristiana (28 aprile 1978), a Flaminio Piccoli, Erminio Pennacchini, Renato Dell’Andro (29 aprile 1978)1. 1
A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2008, pp. 140-144, 103-105, 107-108, 111-112; un’edizione precedente delle lettere di Moro era stata pubblicata in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Brigate rosse, Kaos, Milano 1997. Un’importante con-
190
Il caso Moro visto dal Palazzo
In quelle lettere si fa esplicito riferimento anche al colonnello Stefano Giovannone, uomo del Sismi a Beirut, che aveva collaborato con Moro per arrivare all’accordo “segreto” con i palestinesi. C’era dunque, e ci fu in tutta la vicenda Moro, un ruolo dei palestinesi giocato nel tentativo di arrivare alla liberazione dell’ostaggio. Si deve peraltro osservare come il ragionamento di Moro sullo “scambio dei prigionieri” fatto in riferimento alla vicenda dell’accordo con i palestinesi, non era applicabile alle richieste di scambio avanzate dalle Brigate rosse. Il terrorismo palestinese, infatti, era un terrorismo che si prefiggeva un fine “nazionale”: quello di arrivare alla nascita di uno Stato palestinese. Il terrorismo delle Br invece si prefiggeva un fine “eversivo” rappresentato dall’abbattimento dello Stato democratico e pertanto nei loro confronti non era ipotizzabile un riconoscimento dello “status di combattenti” del tipo di quello riconosciuto, di fatto, ai gruppi terroristici palestinesi. Questo discorso, però, porta alla necessità di affrontare un argomento di fondo rappresentato dal tema dei collegamenti fra le Br e le altre realtà internazionali del terrorismo stesso. Le Br furono solo un fenomeno italiano? Numerosi storici, commentatori e uomini politici hanno sostenuto e sostengono la tesi dell’assoluta “italianità” del fenomeno delle Br. Si tratterebbe, secondo questi osservatori, di un fenomeno del tutto “autoctono”, nato e cresciuto in Italia, per ragioni sociali e politiche tutte interne alla storia del nostro paese e pertanto privo di collegamenti con il resto dei movimenti analoghi presenti all’epoca in molti altri stati europei e dell’area mediterranea. A mio parere si tratta di una tesi molto poco credibile, se non del tutto infondata sia da un punto di vista logico sia in relazione alla realtà di un periodo storico nel quale il terrorismo ha rappresentato
ferma di parte palestinese a riguardo dei patti “segreti” stipulati con le autorità italiane è venuta da Bassam Abu Sharif, tra i più importanti dirigenti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) negli anni Settanta, nell’intervista al «Corriere della Sera» del 14 agosto 2008.
191
FRANCO MAZZOLA
una componente non solo presente in molti paesi ma connotata da tratti ideologici che, sia pure con sfumature a volte molto diverse, erano riconducibili ad una comune matrice politica marxista-stalinista e ad una comune matrice storica rappresentata dall’evoluzione in senso terroristico di parte dei movimenti nati all’indomani del fenomeno del Sessantotto. Le Br, ancorché nate in Italia come evoluzione del Collettivo politico metropolitano fondato da Renato Curcio, subirono successivamente un processo di mutazione profonda quando a Curcio successe Mario Moretti nella guida del movimento dando ad esso una struttura militare ed una organizzazione logistica molto diversa da quella delle origini. In quella fase di trasformazione appare logico ritenere che le Br siano entrate in contatto con altre realtà del terrorismo internazionale, come la banda Baader-Meinhof tedesca, Action Directe francese e vari gruppi palestinesi. D’altra parte sui collegamenti delle Br a livello internazionale si hanno dei riscontri obbiettivi. Già dall’inizio degli anni Settanta rapporti informativi del Sid, e poi del Sismi, avevano indicato nella Cecoslovacchia un punto di riferimento importante per l’addestramento di elementi terroristici, come confermato poi dal generale Šejna, capo dei servizi segreti di quel paese, fuggito negli Stati Uniti all’inizio del 1968. È provato, ma non ammesso da tutti, che oltre a Giangiacomo Feltrinelli ed a Luciano Ferrari Bravo, aderente ai Gap fondati dall’editore milanese, Augusto Viel, Alberto Franceschini e Fabrizio Pelli (che parteciparono in prima linea alla nascita ed alla fase iniziale della storia delle Br) erano stati in Cecoslovacchia. Dagli archivi della Stasi (i servizi segreti della ex Ddr) risultano comprovati i rapporti strettissimi con la banda Baader-Meinhof che, a sua volta, ebbe numerosi contatti con le Br. È altresì comprovato che dietro le attività dei servizi della Cecoslovacchia e della Germania dell’Est stava l’azione del I Direttorato del Kgb, struttura alla quale erano demandati i compiti di disinformazione, sabotaggio all’estero e destabilizzazione. L’Italia rappresentava all’epoca un punto cruciale dell’Alleanza atlantica non solo per la sua posizione geografica ai confini dell’alleanza stessa, ma per la presenza al suo interno di un forte partito comunista che fin dalle esperienze dell’“eurocomunismo” ma soprattutto dopo il colpo di Stato in Cile del 1973 che aveva portato Enrico Ber192
Il caso Moro visto dal Palazzo
linguer a prospettare la strategia del “compromesso storico”, era andato assumendo posizioni sempre meno ortodosse rispetto alla politica dell’Unione Sovietica. In questa situazione mi pare di poter affermare che sia una utopica ingenuità ritenere che da questo intreccio fra i servizi segreti dell’Est e le formazioni terroristiche operanti in Europa, l’Italia sia rimasta fuori. Si pone a questo punto l’interrogativo se le Br siano state in qualche modo infiltrate e manipolate in modo consapevole o meno. Ho sempre creduto, e continuo a credere, che Mario Moretti sia l’unica persona in grado di dire la verità su questo aspetto fondamentale della storia delle Br. Mario Moretti però, fino ad oggi, non ha mai voluto parlare. Le preoccupazioni Washington La situazione geopolitica dell’Italia degli anni Sessanta non poteva non destare preoccupazioni da parte dell’Alleanza atlantica e soprattutto degli Stati Uniti d’America. Innanzitutto sotto l’aspetto militare che vedeva dispiegate nel nostro paese basi aeree e navali importanti, se non decisive, per il sistema difensivo della Nato. In secondo luogo sotto l’aspetto politico per le ragioni sulle quali ci siamo già soffermati. Le preoccupazioni degli Usa per la strategia morotea dei passi lungo la strada di un avvicinamento al Pci di Berlinguer sono note. Per gli Usa non era facile capire esattamente la strategia di Moro che molti osservatori americani confondevano con quella berlingueriana del “compromesso storico” anche se, in effetti, si trattava di due strategie molto diverse. Per Moro il dialogo con il Pci doveva portare ad un tratto di strada da percorrere insieme e non ad un patto di governo di lungo periodo. Quel tratto di strada, per Moro, era essenziale per poter sconfiggere il terrorismo e bloccare il processo di inflazione che flagellava l’economia italiana; terminato quel tratto di strada si sarebbe aperta, secondo Moro, una fase nuova: la fase della democrazia dell’alternanza nella quale la Dc e il Pci sarebbero ritornati ad essere in competizione per la guida dell’Italia. Questa distinzione non era facile da cogliere per uomini come Henry Kissinger abituati da sempre ad un’alternanza fra democratici 193
FRANCO MAZZOLA
e repubblicani che non chiamava mai in causa un rischio per la democrazia americana. Inoltre la divisione del mondo in due portava gli Usa a ritenere prevalenti i pericoli derivanti dalla politica imperialista dell’Urss non solo dal punto di vista militare ma anche sotto il profilo ideologico. Per questi motivi ritenevano comunque rischioso qualsiasi avvicinamento del Pci all’area di governo in un paese dell’Alleanza atlantica. Pertanto è necessario tenere conto di questo aspetto se si vuole avere una visione completa di tutte le posizioni che, a livello internazionale, erano in campo nel momento in cui si verificò il sequestro di Aldo Moro. Verità processuale e verità storica Come ho già avuto modo di accennare, sulla tragica vicenda di via Fani e dei 55 giorni della detenzione di Moro nella “prigione del popolo” esiste una “verità processuale” acclarata da sentenza passata in giudicato. Ma la verità processuale è, spesso, cosa diversa dalla verità reale. Nel caso del sequestro Moro questa affermazione appare molto credibile data la numerosa serie di interrogativi ai quali le sentenze non sono state in grado di dare risposte concrete e convincenti. Innanzitutto permangono interrogativi sulla stessa dinamica dei fatti accaduti in via Fani la mattina del 16 marzo 1978. Il 22 ottobre 2007 l’ex presidente della Commissione Stragi senatore Giovanni Pellegrino affermava: «non si sa ancora quanti e chi fossero i brigatisti che parteciparono all’agguato: di certo non i 7 o i 9 di cui hanno parlato sempre i brigatisti. Basti pensare che per un sequestro come quello assai più facile del giudice Mario Sossi nel 1974, è stato accertato che vi parteciparono 19 brigatisti. C’è da supporre che in via Fani siano stati almeno 20 o 30, e ancora non si conosce la loro identità, salvo rendersi conto – dopo le perizie balistiche – che l’eliminazione della scorta di Moro è stata compiuta da due soltanto, capaci per la loro abilità militare di sparare una gragnuola di colpi in modo da uccidere i cinque uomini della scorta con matematica precisione senza torcere un capello al presidente che era a pochi centimetri da loro». Queste affermazioni bastano da sole per rimarcare quanto siamo ancora lontani da una verità reale sui fatti verificatesi quella mattina in via Fani. 194
Il caso Moro visto dal Palazzo
Esse, inoltre, pongono in evidenza la particolare abilità militare dimostrata in quell’occasione dai brigatisti; una abilità che, peraltro, non ritroviamo in nessuno degli altri numerosi attentati compiuti dalle Br. Questa circostanza può, indubbiamente, far pensare che per l’operazione in via Fani le Br possano essere state supportate da altri elementi. D’altronde un testimone dell’agguato ha affermato di avere sentito un membro del commando brigatista urlare alcune parole in lingua straniera, probabilmente tedesco. Il numero dei partecipanti all’azione brigatista e la tecnica militare dimostrata nel prepararla ed eseguirla non trovano nella sentenza una risposta sufficiente a fare ritenere la verità processuale aderente alla verità reale. Si potrebbe continuare su questo piano con la presa in considerazione di una serie di altre circostanze relative all’agguato ed ai successivi 55 giorni nei quali si è dipanata la vicenda fino al suo tragico epilogo. Non è tuttavia necessario farlo dato che esiste una vastissima bibliografia che ha esaminato e valutato con attenzione tutte queste circostanze più volte definite come i buchi neri o i misteri del caso Moro. Ma su alcune di quelle circostanze può essere utile fare qualche considerazione al fine di capire se, ed in quale misura, si può arrivare ad avvicinare la verità reale. Il ruolo di Markevitch Un personaggio del quale molto si è parlato negli anni successivi al sequestro Moro è Igor Markevitch, direttore d’orchestra di fama internazionale, marito della principessa Topazia Caetani. Davanti al palazzo della quale venne fatta trovare dalle Br la Renault con il cadavere di Moro. A questo personaggio nelle lunghe e molteplici istruttorie giudiziarie relative ai fatti di via Fani e successivi, non è mai stata data una particolare attenzione. Eppure Francesco Cossiga in una intervista al «Corriere della Sera» del 14 novembre 2007 afferma che «Igor Markevitch ospitò probabilmente nella sua casa di Firenze la riunione in cui fu decisa la morte di Moro». Aggiunge poi che «la casa di sua moglie in via Caetani rappresentò per i brigatisti solo un punto di riferimento, un luogo conosciuto dove lasciare la Renault rossa, fra Botteghe Oscure e Piazza del Gesù.» 195
FRANCO MAZZOLA
Questa seconda affermazione appare molto riduttiva rispetto alla prima che attribuisce a Markevitch un ruolo rilevante se non decisivo nella vicenda e soprattutto nella sua tragica conclusione. Sembra a me che il ritrovamento della Renault rossa in via Caetani non possa essere considerata solo una coincidenza simbolica per la collocazione di quel luogo fra le sedi del Pci e della Dc. La mattina del 9 maggio 1978 Roma, come durante tutti i giorni del lungo sequestro, era una città sottoposta ad una attenta sorveglianza da parte delle forze dell’ordine. Ciò significa che diventa estremamente difficile credere che la Renault rossa con a bordo il cadavere di Moro possa avere attraversato mezza città per raggiungere da via Montalcini via Caetani, senza incappare in nessun controllo da parte dei numerosi posti di blocco sparsi per tutta Roma. A meno di non pensare che l’ultima prigione di Moro non fosse in via Montalcini e che il trasporto sia avvenuto da un luogo molto vicino a quello del ritrovamento. Per inciso occorre ricordare che Igor Markevitch non era solo un famoso musicista e direttore d’orchestra. Negli anni della seconda guerra mondiale era stato agente dell’Intelligence Service inglese operante in Italia ed aveva quindi familiarità con il mondo dei servizi segreti. Ma, al di là di questa annotazione, resta il fatto che il ritrovamento della Renault rossa in via Caetani, al di là del più volte richiamato simbolismo di quel luogo, apre la strada ad altri interrogativi non risolti dalle istruttorie giudiziarie. Moro è rimasto 55 giorni nel covo di via Montalcini senza essere mai spostato? Le varie sentenze hanno fatto propria questa ipotesi sempre sostenuta dai brigatisti, ma diversi fatti e circostanze non la fanno apparire così sicura e provata. II riferimento alla difficoltà di credere all’ipotesi del trasporto da via Montalcini a via Caetani in una Roma blindata dalle forze di polizia non è l’unico aspetto che solleva dubbi certamente fondati. Ma, anche a voler credere che ciò sia stato possibile, resta aperto l’interrogativo se quella di via Montalcini sia stata l’unica prigione di Moro nei 55 giorni del sequestro. Risulta dagli esami fatti sul corpo di Moro che lo stesso non presentava le caratteristiche di decadimento fisico che avrebbero dovuto contrassegnare il corpo di una persona rimasta 55 giorni praticamente immobile in uno stanzino di due metri per tre. 196
Il caso Moro visto dal Palazzo
Inoltre sotto le scarpe di Moro furono trovate tracce di terriccio e frammenti di erba incompatibili con quelle condizioni di detenzione: tracce di sabbia furono ritrovate anche nel risvolto dei pantaloni indossati da Moro. È pur vero che i brigatisti hanno poi parlato di tracce apposte da loro ai fini di un depistaggio delle indagini. Tali affermazioni non sembrano credibili alla luce delle condizioni del corpo che, comunque, non corrispondevano alla tesi di una quasi totale immobilità, nel cubicolo di via Montalcini, che sarebbe durata per circa due mesi. Vi erano quindi, e vi sono, elementi circostanziati, oltre che “ragionevoli dubbi”, per ritenere che via Montalcini non sia stata l’unica “prigione del popolo” utilizzata dalle Br nel corso del sequestro. Se ciò è vero occorre cercare di capire quando possa essere avvenuto il trasferimento di Moro da una prigione all’altra. Questo momento, secondo me, può essere individuato nel giorno della scoperta del covo di via Gradoli e della contestuale uscita del comunicato noto come quello del lago della Duchessa. I due fatti, a mio giudizio, devono essere visti insieme se si vuole dare un minimo di logica agli accadimenti. Tutte le indagini, invece non l’hanno fatto considerandoli separatamente e dando così ad essi un significato assai poco credibile. Gradoli, una pista mobile La mattina del 18 aprile 1978 le Br celebrarono, a loro modo, il trentesimo anniversario del voto che aveva visto la vittoria della Dc sul Fronte Popolare facendo trovare il comunicato n. 7 nel quale si annunciava il «suicidio» di Moro con un esplicito riferimento al suicidio dei capi della banda Baader-Meinhof verificatosi nel carcere tedesco di Stammheim mesi prima. Nel comunicato si indicava nel lago della Duchessa il luogo nel quale era stato gettato il corpo dello statista. Nel corso della stessa mattinata la polizia trovava in via Gradoli un covo “freddo”, cioè abbandonato dalle Br. Come è noto il covo venne scoperto in circostanze tali da far ritenere che i brigatisti avessero voluto farlo ritrovare. Per tutta la giornata le forze dell’ordine scandagliarono le acque del lago della Duchessa (che, tra l’altro, era ghiacciato!) senza trovare nulla. Sulla questione del comunicato n. 7 molto si è detto e scritto. Fin dall’inizio apparvero anomali alcuni particolari quali la presenza di 197
FRANCO MAZZOLA
uno strano geroglifico sulla lettera A della scritta Brigate rosse e sulla stella a cinque punte che si presentava in parte diversa da quella dei comunicati precedenti. Peraltro il comunicato al momento fu considerato autentico dai periti dei carabinieri, della polizia e della Procura della Repubblica, come ribadito ancora da Cossiga nella già citata intervista del 14 novembre 2007 al «Corriere della Sera». Due giorni dopo, le Br negarono la paternità del documento che, in seguito, venne attribuito a Toni Chichiarelli, un falsario legato alla banda della Magliana. Steve Pieczenik, il consulente inviato dal Dipartimento di Stato per dare consigli ed aiuto nelle operazioni di ricerca di Moro, in una recente intervista2 sostiene che il comunicato n. 7 era stato un tranello elaborato dai servizi segreti italiani per preparare l’opinione pubblica al peggio (cioè alla morte di Moro) e contemporaneamente shoccare i brigatisti. Sempre secondo Pieczenik questa mossa indusse le Br, stordite e deluse, alla decisione di uccidere Moro. Tornerò più avanti sull’argomento; per intanto mi preme fare notare come, in ogni caso, il comunicato ottenne l’effetto di impegnare per un’intera giornata le forze dell’ordine a setacciare il lago della Duchessa mentre contestualmente la scoperta del covo di via Gradoli e l’esame del materiale in esso ritrovato impegnavano polizia e carabinieri della capitale. Quale migliore occasione per poter spostare Moro da una “prigione del popolo” ad un’altra? Sono dell’opinione che i due accadimenti del 18 aprile siano stati due abili diversivi posti in atto dai brigatisti per poter effettuare un trasferimento. La successiva affermazione delle Br, che rinnegarono la paternità del comunicato e le stesse anomalie grafiche e letterali del comunicato stesso non solo non contraddicono la tesi del diversivo ma la confermano. Il comunicato n. 7, infatti, proprio per le sue anomalie, innescò a posteriori una ridda di ipotesi destinate, nel disegno brigatista, a gettare scompiglio e perpetrare nel tempo gli effetti di quel depistaggio. 2
Rilasciata ad Emmanuel AMARA, autore del libro Nous avons tué Aldo Moro, Patrick Robin, 2006 (tr. it. Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un protagonista esce dall’ombra, a cura di N. Biondo, Cooper, Roma 2008).
198
Il caso Moro visto dal Palazzo
Le affermazioni di Steve Pieczenik sul comunicato n. 7 sono, a mio parere, non veritiere per almeno due ragioni. Innanzitutto non vi è stata nessuna continuità temporale fra il comunicato n. 7 (18 aprile) e l’uccisione di Moro avvenuta il 9 maggio, cioè tre settimane dopo. Nell’intervista ad Amara, riportata in ampi stralci dal quotidiano «La Stampa» di domenica 9 marzo 2008, Pieczenik dichiara di non avere partecipato direttamente alla messa in atto del comunicato che definisce testualmente «un’iniziativa brutale, una decisione cinica, un colpo a sangue freddo: un uomo doveva essere freddamente sacrificato per la sopravvivenza dello Stato». Secondo quanto sostenuto da Pieczenik, il comunicato n. 7 determinò nelle Br la decisione di sopprimere Aldo Moro. Ma il tempo passato fra il 18 aprile e il 9 maggio è piuttosto lungo e Pieczenik non dà alcuna spiegazione a questo intervallo. Una spiegazione più credibile è contenuta nella citata intervista di Cossiga al «Corriere della Sera». Cossiga afferma che la lettura data da Pieczenik al comunicato n. 7 era sbagliata perché – cito testualmente – «si trattava di una mossa per salvare Moro». Infatti, spiega Cossiga, «da quel momento crebbero la confusione e la paura per la sua sorte. Le Br lo uccisero senza accorgersi che avevano vinto. Alla Direzione in cui Fanfani avrebbe chiesto di riunire il Consiglio nazionale per aprire la trattativa, io – afferma Cossiga – andai con la lettera di dimissioni: il Ministro dell’intransigenza non poteva essere il Ministro della trattativa. Già da giorni la D.C. aveva cominciato a cedere». Il comunicato del lago della Duchessa è del 18 aprile. Quattro giorni prima, in una riunione al Viminale alla quale ero presente, Pieczenik sostenne con dovizia di argomenti la tesi della necessità di sviluppare un canale indipendente, scelto dal Governo, per trattare con le Br. In quella stessa riunione Cossiga precisò che il negoziatore non poteva essere riconducibile in modo diretto o indiretto al Governo. Doveva trattarsi di un negoziatore autonomo o scelto dalla famiglia Moro, d’accordo col Governo e da questo controllato. Tale negoziatore, secondo Cossiga, doveva entrare in scena solo nel momento in cui le Br avessero rinunziato alla tesi dello scambio di prigionieri per accedere a quella del negoziato. Quella di Pieczenik era, pertanto, la tesi del negoziato e nelle tre settimane che seguirono, in effetti, l’idea della trattativa andò prendendo sempre più piede. 199
FRANCO MAZZOLA
Trattare o no con le Br Siamo arrivati, a questo punto, al cuore del problema di fronte al quale si trovarono tutti durante i 55 giorni del sequestro: trattare con le Br o no. Sarebbe profondamente sbagliato pensare che quel problema si ponesse in modo così secco. Molteplici, infatti, erano le sue sfumature. In effetti quello che lo Stato non poteva accettare era il riconoscimento delle Br come partito comunista combattente, riconoscimento implicito nella richiesta dei brigatisti di arrivare al uno “scambio di prigionieri”. Ciò, infatti, avrebbe comportato la nascita di un partito armato con conseguenze di tipo “libanese” sulla situazione politica italiana che avrebbero portato ad una diffusione del fenomeno di proporzioni assolutamente incalcolabili. Tuttavia con il passare dei giorni si erano andate profilando altre ipotesi. Penso a quella di Bettino Craxi sul cosiddetto «atto di clemenza unilaterale da parte dello Stato» o quella della Chiesa cattolica, disposta a versare una ingente somma di danaro per salvare la vita di Moro. In definitiva mentre la linea della fermezza era tenuta ferma dal Governo altri soggetti si muovevano alla ricerca di soluzioni alternative. Il 5 maggio le Br, con il comunicato n. 9, rendono noto che stavano «eseguendo» la sentenza emessa contro Aldo Moro. Ma passano ancora quattro giorni prima del ritrovamento del corpo di Moro nella Renault rossa parcheggiata in via Caetani. In quelle ore si sviluppa l’iniziativa di Amintore Fanfani che porta alla convocazione della Direzione Dc per la mattina del 9 maggio. La notizia della riunione era stata data ai giornali e si sapeva che in quella seduta della Direzione Fanfani avrebbe chiesto la convocazione del Consiglio nazionale della Dc, rispondendo così ad una esplicita richiesta fatta dai brigatisti in una lettera fatta pervenire all’onorevole Riccardo Misasi. Quando la Direzione della Dc stava per iniziare arrivò a Piazza del Gesù la notizia del ritrovamento del cadavere di Moro. Ma oltre all’iniziativa politica di Fanfani c’erano in corso in quelle ore altre iniziative.
200
Il caso Moro visto dal Palazzo
Come si è poi saputo, la più importante era quella del Vaticano che aveva trovato un canale di comunicazione con i brigatisti ai quali aveva offerto una ingente somma di danaro in cambio del rilascio di Moro. Inoltre il presidente della Repubblica Giovanni Leone aveva fatto sapere di essere pronto a firmare la grazia per un brigatista detenuto, non compreso nella lista dei 13 la cui liberazione era stata richiesta dalle Br, che non si era macchiato di reati di sangue e si trovava in cattive condizioni di salute. Tra l’altro questo detenuto venne poi graziato. Di tutte queste iniziative erano ben a conoscenza i carcerieri di Moro. Essi avevano sostanzialmente accettato l’idea di un riconoscimento politico da parte della Dc, come esplicitamente richiesto nell’ultima telefonata fatta alla famiglia Moro nella quale si chiedeva «un intervento urgente e diretto dell’onorevole Zaccagnini». La convocazione della Direzione Dc indetta per la mattina del 9 maggio, era il segnale che le Br attendevano. A questo punto è lecito chiedersi perché le Br non attesero le decisioni della Direzione democristiana, ma anzi l’anticiparono uccidendo Moro all’alba del 9 maggio, parecchie ore prima che la riunione della Direzione stessa avesse inizio. A questo interrogativo non è mai stata data una risposta da parte delle Br. Neanche le istruttorie giudiziarie successive sono riuscite a gettare luce sui motivi che hanno portato alla tragica conclusione della vicenda proprio nel momento in cui si stava aprendo la porta verso quella “soluzione politica” che le Br avevano ripetutamente indicata come la via per salvare la vita di Aldo Moro. Perché, dunque, le Br uccisero Aldo Moro proprio quando, in pratica, stavano vincendo la loro battaglia? Francesco Cossiga ha spesso sostenuto che le Br non si accorsero che stavano vincendo. Ma ciò non basta a dare una risposta, soprattutto se si tiene conto del fatto che la dirigenza brigatista aveva dato prova di una notevole “intelligenza politica” nel corso di quei lunghi due mesi precedenti. Davanti a questo irrisolto interrogativo non rimangono molte alternative da esplorare; una, tuttavia, c’è ed appare, come in effetti è, molto inquietante.
201
FRANCO MAZZOLA
L’uccisione di Moro: un intervento esterno? È l’ipotesi di un intervento esterno che fece precipitare la situazione, portando alla tragica decisione di porre fine alla vita di Moro. Da questa considerazione discende la convinzione di coloro che, come me, pensano che la vera gestione dell’intera vicenda possa essere stata condizionata. Fu sostanzialmente eterodiretta, almeno nella sua fase finale. Da chi? A questa domanda non c’e risposta nelle carte processuali. Probabilmente per trovarne una si può solo fare ricorso alle considerazioni, più volte ripetute, sulla situazione geo-politica degli anni ’70-’80, sulla peculiarità della politica italiana di quel periodo e sulle preoccupazioni che la strategia di Aldo Moro, insieme a quella di Enrico Berlinguer, aveva destato ad Oriente come in Occidente. È la logica del “cui prodest” alla quale si può fare ricorso. Sfortunatamente, in questo caso, neppure essa porta ad una conclusione univoca, dati gli interessi in gioco in ambedue gli schieramenti nei quali era diviso all’epoca lo scacchiere mondiale. Non si tratta di una ipotesi “fantapolitica”, come molti ritengono, ma di una ipotesi “logica”. Mi pare l’unica possibile alla luce di tutto lo svolgimento della vicenda e soprattutto delle circostanze che hanno accompagnato la sua tragica conclusione.
202
LA RISPOSTA DELLO STATO AI TERRORISMI GLI APPARATI E LA LEGISLAZIONE Vladimiro Satta
Dalla fine degli anni Sessanta fin verso la conclusione degli Ottanta l’Italia fu scossa da una fitta serie di eventi terroristici di vario tipo e di diverso segno. Migliaia furono gli attacchi, centinaia i morti e i feriti1. La stagione dei cosiddetti “anni di piombo” fu aperta dallo stragismo, che mirava a un’involuzione autoritaria ed agiva mediante attentati esplosivi in luoghi affollati da cittadini comuni. Esso fece le sue prime vittime nel dicembre 1969 a Milano, in Piazza Fontana. Nel 1970 prese le mosse la lotta armata condotta dalle Brigate rosse e da altri gruppi di estrema sinistra, cominciata con azioni di modesta portata ma poi cresciuta vertiginosamente e protrattasi fino all’uccisione del senatore Roberto Ruffilli nel 1988. Tra la seconda metà degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo, si aggiunse un terrorismo nero di nuova generazione – si pensi ai Nar – per certi aspetti speculare a quello rosso piuttosto che indirizzato verso prospettive di golpe come invece era stata l’eversione di destra in precedenza. Contemporaneamente si registravano altri frequenti episodi di violenza politica che, pur non potendosi definire terroristici, concorrevano a mettere a dura prova gli apparati statali e le Forze di polizia in particolar modo2. 1
Il principale riferimento bibliografico per cronologia, dati e statistiche in materia è la ricerca Isodarco (International school on disarmament and research on conflicts; Italian Pugwash group): AA.VV., Vent’anni di violenza politica in Italia. 1969-1988. Cronologia ed analisi statistica, Università degli studi di Roma, Centro stampa d’Ateneo, Roma 1992. 2 Il magistrato Guido Viola ci ha lasciato una vivida descrizione della Milano di quei tempi: «Nelle strade, il sabato pomeriggio, cominciava la guerriglia. Ovunque, cavalli di frisia e postazioni della polizia e dei carabinieri. Quando ero di turno prendevo subito contatti con gli ospedali per organizzare il ricovero dei feriti.». Cfr. V. MORELLI, Anni di piombo, SEI, Torino 1988, p. 7.
203
VLADIMIRO SATTA
Oltre che dei fenomeni autoctoni, negli stessi anni il paese fu teatro di azioni di terrorismo internazionale, specie mediorientale, nonché di un attentato a papa Giovanni Paolo II. Non si dimentichi, poi, il misterioso disastro aereo nei cieli di Ustica, dove nel giugno 1980 perirono 81 persone per cause in merito alle quali l’unica certezza, finora, è che non si trattò di un guasto né di un cedimento strutturale3. Dunque in Italia l’offensiva eversiva, per ampiezza e articolazione, fu decisamente superiore agli analoghi fenomeni riscontrabili in altri paesi democratici (escludendo i terrorismi di matrice etnica e/o nazionalistica che colpirono altri Stati europei occidentali, con i quali i confronti sarebbero impropri). Prima ancora di analizzare le modalità con le quali lo Stato fronteggiò tali molteplici aggressioni, allora, occorre domandarsi se ed in quale misura sia stato il sistema politico-istituzionale italiano, con le sue caratteristiche, a creare premesse favorevoli alle insorgenze terroristiche. Caratteristiche del sistema politico-istituzionale italiano ed insorgenza dei terrorismi Le libertà civili e politiche L’alto livello di libertà civili e politiche sussistente nel paese offre una prima, importante risposta negativa al quesito. In Italia c’era – e non venne mai meno – la più larga facoltà di esercitare i diritti politici in maniera democratica. Le libertà di manifestazione del pensiero erano parimenti garantite. Si tenevano alla luce del sole congressi di forze politiche nei quali l’argomento all’ordine del giorno era la rivoluzione, e sui giornali comparivano appelli firmati ad armare le masse e a «combattere un giorno con le armi in pugno contro lo Stato».
Manifestazioni e cortei bellicosi avevano luogo anche a Roma ed in altre città. Altre forme di violenza si distribuivano in tutti i giorni della settimana, con azioni non sempre preventivate che talvolta colpivano persone inermi ed obbiettivi indifesi. 3 Dopo l’assoluzione in Cassazione, nel gennaio 2007, degli alti ufficiali dell’Aeronautica militare che erano stati accusati di avere depistato le indagini, le inchieste giudiziarie su Ustica sembravano essersi definitivamente arenate. Nel giugno 2008, però, la Procura della Repubblica di Roma ha riaperto il fascicolo Ustica, prendendo spunto da dichiarazioni dell’ex-presidente della Repubblica Francesco Cossiga alla stampa.
204
La risposta dello Stato ai terrorismi
L’editoria e la stampa, prevalentemente in mano ai privati, davano vita ad un sistema pluralista, nel quale anche i più estremisti avevano pienamente modo di farsi sentire. E non soltanto attraverso le innumerevoli manifestazioni di piazza e la miriade di piccoli giornali e riviste il cui grande impeto rivoluzionario, invero, era frenato dalla modestia dei mezzi a disposizione. Uno dei maggiori gruppi editoriali nazionali, infatti, era capeggiato da Giangiacomo Feltrinelli, a buona ragione, detto l’“editoreguerrigliero”4. Verso la metà degli anni Settanta il pluralismo prese piede pure nel settore radiotelevisivo, che fino a quel momento era stato solo pubblico. La Corte Costituzionale, con una serie di pronunciamenti, sentenziò la fine del monopolio Rai. Al che, rapidamente, proliferarono le cosiddette radio libere, spesso politicamente impegnate. Queste emittenti, frequentemente gestite da redattori giovani, diedero voce innanzi tutto alle nuove generazioni. La legge di riforma della Rai, approvata nel 1975 trasferì il controllo della televisione di Stato dal Governo al Parlamento – allargando così il ventaglio delle forze politiche che vi concorrevano – e previde l’attivazione di una terza rete pubblica, entrata in funzione verso la fine del decennio. Inoltre, c’era tolleranza riguardo ai fenomeni di protesta sociale, fino al permissivismo verso forme di lotta che si spingevano ai limiti della legalità e non di rado li oltrepassavano5. Forse, anzi, se gli apparati dello Stato si fossero fatti carico di tracciare più nettamente la linea di demarcazione tra espressioni accettabili ed espressioni inaccettabili della contestazione – distinzione di cui nel nostro paese i movimenti in gran parte giovanili avevano coscienza scarsa o nulla – lo scivolamento verso la violenza ed il terrorismo sarebbe risultato più circoscritto. Pare impossibile, comunque, sostenere che la violenza po4
Feltrinelli morì il 14 marzo 1972, maneggiando incautamente un congegno esplosivo mentre si accingeva a compiere un attentato. Tra i titoli pubblicati dalla sua casa editrice: La guerriglia in Italia, a cura di P. Secchia, Feltrinelli, Milano 1969. 5 Ad esempio, le occupazioni delle università da parte degli studenti contestatori duravano talvolta settimane, senza che le autorità intervenissero. La sociologa Donatella Della Porta ha parlato perciò di «un uso moderato delle forze di polizia», che a suo parere rappresentò «una rottura rispetto ai due decenni precedenti». Cfr. D. DELLA PORTA, Il terrorismo, in Storia d’Italia, Annali, vol. 12, Einaudi, Torino 1997, p. 378.
205
VLADIMIRO SATTA
litica – specie organizzata – fosse una fisiologica reazione a costrizioni imposte da poteri pubblici oppressivi. b) un sistema bloccato? Le sfide terroristiche lanciate alle istituzioni italiane agli albori degli anni Settanta non possono neppure essere considerate risposte patologiche ad un cosiddetto blocco di sistema, ovvero ad una palese situazione di paralisi della politica, tale da rendere impossibile l’attuazione delle riforme divenute necessarie ed il ricambio all’interno della classe dirigente6. L’importazione in Italia del suddetto schema interpretativo – originariamente concepito in riferimento ad altri contesti nazionali – è doppiamente incongrua. Soggettivamente, perché né i terroristi neri né quelli rossi pensavano di essere di fronte ad un sistema bloccato. La loro produzione teorica mostra chiaramente che gli uni e gli altri, invece, ritenevano di essere in una fase di trasformazione, della quale ovviamente davano antitetici giudizi di valore: secondo i neri, era in atto una deriva verso sinistra, politica e sociale, che andava fermata; secondo i rossi, si era creata una situazione pre-rivoluzionaria, che andava sfruttata7. Casomai, i più allarmati fra i rossi (ad esempio, Feltrinelli) immaginavano di essere ad un bivio tra rivoluzione e reazione. Di qui anche gli scontri fisici diretti tra le due opposte fazioni, che costellarono gli anni Settanta (con prevalenza di aggressioni da parte della destra nella prima metà del decennio, e da parte della sinistra nella seconda metà). Oggettivamente, quali che fossero le analisi dei contemporanei, il quadro politico italiano conobbe numerosi cambiamenti tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, vale a dire il periodo in cui il terrorismo fu più intenso; viceversa, la coalizione di governo rimase sempre la stessa dal 1979 alla fine degli Ottanta, quando al contrario i terrorismi andarono scemando. 6
Questi i parametri indicati da Gianfranco PASQUINO, autore del saggio Sistema politico bloccato e insorgenza del terrorismo: ipotesi e prime verifiche, pubblicato nel volume di autori vari intitolato La prova delle armi, Il Mulino, Bologna 1984. Adottare parametri adeguati è indispensabile, se si vuole dare concretezza al concetto di blocco di sistema e avere la possibilità di verificarne la sussistenza. 7 Non lascia spazio a dubbi la ricognizione testuale effettuata da Gianfranco PASQUINO, nel citato saggio Sistema politico bloccato e insorgenza del terrorismo: ipotesi e prime verifiche.
206
La risposta dello Stato ai terrorismi
Una sintetica carrellata permette di cogliere ad occhio nudo il carattere di accentuato movimento proprio della situazione italiana nel decennio 1969-1979. Nel 1969 il governo era di centro-sinistra, con i comunisti all’opposizione. Il centrosinistra appariva in crisi, vuoi perché gran parte dei progetti riformatori sbandierati alla sua nascita si erano perduti per strada, vuoi per il calo di consensi elettorali della sua componente socialista (nel 1968 le liste comuni di socialisti e socialdemocratici raccolsero molti meno voti di quelli ottenuti separatamente nel 1963); nella società, il 1968 aveva segnato l’inizio della vivace contestazione giovanile, e il 1969 era stato l’anno dell’“autunno caldo”. Il peggioramento della situazione economica, che negli anni Settanta fu difficile a causa di fattori interni ed internazionali, fece il resto. Gli equilibri politici e sociali di fine anni Sessanta, insomma, sembravano avere vita breve, e così fu. Non a caso dopo il 1968, anno in cui la legislatura era giunta a scadenza naturale, si ebbe una lunga serie di elezioni anticipate. Il primo mutamento a livello di coalizione governativa ci fu nel 1972. Si trattò di un ritorno al centrismo, con la formazione di un esecutivo Andreotti nel quale un ruolo di rilievo fu rivestito dal liberale Malagodi; tuttavia, neppure questa soluzione si dimostrò duratura. La successiva variazione fu la creazione di un nuovo ma debole centrosinistra che, progressivamente, si aprì alla collaborazione con il Pci il cui segretario Berlinguer, nell’autunno 1973, aveva lanciato una proposta di “compromesso storico” ai tradizionali rivali democristiani la quale, potenzialmente, era tale da cambiare in profondità gli assetti della vita pubblica italiana. Pochi mesi più tardi il referendum sul divorzio, al quale il leader democristiano Fanfani aveva voluto dare grande valenza politica, segnò una pesante sconfitta per il partito di maggioranza relativa. La novità del 1975 furono le “giunte rosse”, formatesi a seguito della tornata di elezioni locali svoltasi nel giugno, in occasione della quale il Pci fece un balzo in avanti. La Dc fu perciò relegata all’opposizione, spesso per la prima volta, nelle nuove amministrazioni locali di comuni grandi e piccoli governate da alleanze di partiti di sinistra. Alle elezioni politiche del 1976, anch’esse anticipate e alle quali per la prima volta poterono votare i diciottenni, i vincitori furono due: la Dc, in quanto essa fece il pieno dell’elettorato spaventato dalla crescita comunista e si confermò partito di maggioranza relativa; e il Pci, che replicò abbondantemente il successo delle precedenti amministrative, ottenendo la più ampia rappresentanza parlamentare della sua storia. 207
VLADIMIRO SATTA
Se dunque gli elettori, intorno alla metà degli anni Settanta, avevano in parte modificato i loro orientamenti e aperto nuovi sbocchi, premiando soprattutto il Pci, i dirigenti dei partiti non furono da meno. Si è già accennato alla svolta di Berlinguer in direzione di un accordo con la Dc anziché di un’alternativa ad essa, e si possono aggiungere le oscillazioni del Psi, che ai tempi del centrosinistra aveva scelto di governare insieme alla Dc a costo di laceranti polemiche con i comunisti, mentre in occasione delle elezioni del 1976 annunciò la propria indisponibilità a far parte di maggioranze chiuse al Pci ma nel 1979, in nome della governabilità, si prestò nuovamente ad escludere i comunisti. Tornando al 1976, dopo la consultazione elettorale si costituì il governo della “non sfiducia”, una formula senza precedenti che consentì ai comunisti di passare dall’opposizione all’astensione e, di fatto, di partecipare alle decisioni della maggioranza in una misura significativamente superiore al passato. Nella primavera 1978, il Pci fece ingresso nella maggioranza, e i liberali ne uscirono. Nel 1979 il partito di Berlinguer si defilò dalla maggioranza e, dopo le elezioni anticipate da esso provocate e nettamene perse, tornò all’opposizione. Nel panorama sociale degli anni Settanta, l’Italia divenne più laica, la condizione della donna fece sensibili progressi, si affermarono nuovi soggetti ed altri già esistenti, quali i sindacati, crebbero e divennero protagonisti. La presunta assenza di riforme incisive, infine, è smentita dallo “statuto dei lavoratori” (1970), dall’istituzione delle regioni, dalle leggi sul divorzio e sull’aborto, dalla riforma sanitaria e da altre ancora, quali che siano i giudizi di valore su ciascuna di esse. Solamente collocandosi in una prospettiva ciecamente massimalista si potrebbero considerare irrilevanti tutti i suddetti cambiamenti effettivamente avvenuti, nonché quelli che magari non si realizzarono, ma sembrarono a portata di mano. Infine, è stato correttamente ritenuto da vari studiosi che il restringimento dei canali di protesta sociale e politica a sinistra verificatosi tra il 1976 e il 1979, in conseguenza dell’abbandono di una linea di opposizione da parte del Pci e degli insuccessi elettorali dell’estrema sinistra, giocò un ruolo nell’ingrossamento delle fila di un terrorismo che, però, si era impiantato da molto prima. Poiché, in scala ridotta, le suddette dinamiche del triennio 1976-1979 a prima vista assomigliano al modello teorico del blocco di sistema quale concausa dell’insorgenza terroristica, è opportuno enucleare il periodo in questione. Ad uno sguardo più approfondito, invero, le somiglianze risultano superficiali. 208
La risposta dello Stato ai terrorismi
La prima discrepanza, in relazione al Pci, è che gli adepti della lotta armata nel 1976-1979, sicuramente scontenti della strategia del “compromesso storico” (peraltro risalente al 1973) e verosimilmente delusi da Berlinguer, comunque non erano militanti o simpatizzanti del partito, bensì venivano da gruppi e movimenti collocati al suo esterno8. In altri termini, la posizione abbandonata dai dirigenti del Pci non era la loro, pur essendo certo meno distante di quella del “compromesso storico”. La seconda riserva discende dall’esiguità dell’area di ultrasinistra nella quale si verificarono gli sbandamenti. Nel 1976 il cartello elettorale denominato Democrazia Proletaria, con l’1,5% dei voti, portò alla Camera sei deputati. Pochi sistemi elettorali al mondo consentivano (e consentono) di partecipare al riparto dei seggi con percentuali di voto così basse. Nel 1979, Democrazia Proletaria scese allo 0,8% e non ottenne seggi; stavolta, però, a sinistra del Pci – intanto tornato all’opposizione – si presentò con liste autonome il Pdup, che ebbe l’1,4%, tradottosi in sei deputati9. Si può intuire la frustrazione di chi, abituato a riempire le piazze, scoprì di non essere capace di riempire le urne. Resta fermo che il fallimento della prova elettorale dipese dalla scarsa rappresentatività dell’ultrasinistra nel paese – molto lontana da certe rappresentazioni ed auto-rappresentazioni correnti all’epoca – e non da straordinarie difficoltà di accesso poste dal sistema politico. c) uno Stato stragista? In riferimento stavolta alla sola eversione di sinistra, una tesi ricorrente ne attribuisce lo scatenamento ad una sindrome auto-difensiva provocata dalla strage di Piazza Fontana e dall’incapacità dello Stato di fare giustizia sulla vicenda. 8
Donatella DELLA PORTA, Il terrorismo di sinistra, Il Mulino, Bologna 1990, ha calcolato che appena il 2,8% dei soggetti coinvolti provenisse dal Pci, il 6,5% dai sindacati, mentre il 38% avesse trascorsi nella Nuova Sinistra e, più in generale, addirittura l’84% dei militanti nelle organizzazioni clandestine di sinistra fossero stati attivi nei circoli e nei gruppi autonomi emersi alla metà degli anni Settanta (ivi, p. 155). Le elaborazioni di Della Porta si riferiscono agli “anni di piombo” nel loro complesso. 9 Nel 1983 Democrazia Proletaria, alla Camera, risalì all’1,5%, risultato che fruttò sette deputati.
209
VLADIMIRO SATTA
A parte il fatto che molti terroristi rossi seguirono percorsi differenti, lo schema di cui sopra richiede quanto meno una precisazione. L’offensiva proveniente da sinistra, infatti, andrebbe collegata non con il precedente evento stragista in sé ma con una sua lettura – diffusa in un’area assai più vasta di quella della lotta armata – che impropriamente riteneva lo Stato artefice del massacro10. Il problema, pertanto, sta nei meccanismi ideologici e psicologici che condussero in primo luogo ad un’interpretazione della vicenda di Piazza Fontana alquanto arbitraria, ed in secondo luogo alle contromosse più aberranti. L’oscurità dell’attentato, razionalmente, avrebbe dovuto suggerire cautela nelle interpretazioni, invece della precipitosa affermazione che la strage era di Stato, riecheggiata dal titolo di un volume pubblicato il 13 giugno 1970 dagli editori Samonà e Savelli, che vendette centinaia di migliaia di copie e diventò un breviario della cosiddetta controinformazione in quegli anni11. L’ultimo verdetto giudiziario su Piazza Fontana (Cassazione, maggio 2005), che ha confermato l’assoluzione di Maggi, Rognoni e Zorzi decisa nel 2004 dalla Corte d’assise d’appello di Milano, ribadisce bensì che l’eccidio fu comunque perpetrato dall’estrema destra e recepisce le divergenze dei giudici del capoluogo lom-
10 La tesi che i mandanti della strage fossero le istituzioni è stata criticata in maniera penetrante da G. SABBATUCCI nel saggio Il golpe in agguato e il doppio Stato, in AA.VV., Miti e storia dell’Italia unita, Il Mulino, Bologna 1999. Di recente, interessanti riflessioni su come la vicenda di Piazza Fontana fu vista dai movimenti di estrema sinistra nonché da significativi settori del giornalismo e della cultura sono state sviluppate da L. MANCONI nel suo libro Terroristi italiani, Rizzoli, Milano 2008, capitolo 2. 11 Quanto agli anonimi autori e alle fonti dello scottante libro La strage di Stato – un ordine di questioni non privo di rilevanza penale – ultimamente lo studioso Aldo Giannuli ha parlato di un nucleo composto dall’avvocato Edoardo Di Giovanni, da Marco Ligini e da altre due persone (sui nomi delle quali egli avanza alcune ipotesi), intorno al quale gravitavano molti altri militanti di estrema sinistra in forma più o meno coordinata, impegnati a rastrellare le notizie poi elaborate dai primi quattro. Insomma, «era la struttura di un servizio segreto sui generis», chiosa Giannuli, il quale così conclude: «l’ipotesi più ragionevole è che il libro sia stato la risultante di varie fonti, da quelle aperte (stampa ecc.) a quelle della raccolta militante, alle voci degli ambienti giornalistici e forensi. A tutto ciò si aggiunsero le notizie ricavate dai rapporti personali di alcuni autori in ambienti diversi» (A. GIANNULI, Bombe a inchiostro, BUR, Milano 2008, pp. 52-60).
210
La risposta dello Stato ai terrorismi
bardo rispetto alle sentenze ormai definitive che negli anni Ottanta avevano assolto altri neofascisti, ma non si pronuncia circa la questione, per noi cruciale, del coinvolgimento o meno dello Stato (ed in quale grado, eventualmente)12. L’idea che la bomba del 12 dicembre 1969 fosse opera delle istituzioni e preparasse la strada ad un golpe, da scongiurare prendendo le armi in anticipo, fu un abbaglio, ancorché comune a molti militanti dell’estrema sinistra. La responsabilità del grosso errore di valutazione pesa individualmente su ciascuno dei singoli che lo commisero, pur con l’attenuante della suggestione collettiva. A maggior ragione, ricade su ciascun singolo l’ulteriore sciagurata scelta di reagire violentemente, dalla quale si astenne buona parte di coloro che condividevano l’analisi sbagliata di partenza. Dello Stato, al massimo, si può dire che se avesse avuto la capacità di fare piena luce e giustizia su Piazza Fontana esso, con ciò, avrebbe anche tolto ai suoi nemici armati uno dei loro pretesti. Per quanto riguarda la lunghissima e purtroppo fallimentare vicenda giudiziaria conseguente all’attentato, la brevità del tempo intercorso tra lo scoppio della bomba e le prime manifestazioni di terrorismo rosso sta
Il giornalista Francesco Grignetti, dal canto suo, ha ventilato l’ipotesi che taluni contributi al pamphlet si debbano a Giorgio Conforto, per decenni uomo dei servizi segreti sovietici (F. GRIGNETTI, Professione spia, Marsilio, Venezia 2002). Sorprende che tanto Grignetti quanto Giannuli – il quale si dichiara possibilista sul ruolo di Conforto – presumano che l’agente filosovietico possa essere stato mosso da intenti anticlericali (nell’anonimo volume c’erano pure attacchi contro il Vaticano e il vescovo Marcinkus) e non che si trattasse di un’operazione calunniosa ai danni dello Stato italiano, compiuta nell’interesse dell’Urss. 12 Non fa distinzione tra matrice di destra e matrice di Stato, invece, Aldo GIANNULI (Bombe a inchiostro, cit.). Secondo lui, la controinformazione di estrema sinistra aveva ragione di sostenere che «in Piazza Fontana si era consumata una strage di Stato», la quale «era parte di una “strategia della tensione”. Questa è l’interpretazione che ha retto meglio al tempo, ricevendo conferme sia nelle inchieste parlamentari sia in quelle giudiziarie» (ivi, p. 469). «Sul piano storico», prosegue Giannuli «sembra ormai difficile contestare: a) che le stragi siano state opera dell’estrema destra; b) che settori rilevanti dei servizi segreti – nazionali e americani – fossero al corrente di quanto si preparava e non siano intervenuti a impedirlo; c) che i fascisti abbiano poi goduto di costanti depistaggi a loro favore, da parte di polizia, carabinieri e servizi segreti; d) che tutto questo si sia inserito in una strategia di parte dei gruppi dirigenti
211
VLADIMIRO SATTA
a significare che il germe della violenza era in incubazione da prima che fosse possibile tirare conclusioni meditate sulla condotta degli inquirenti e dei tribunali. La pista anarchica, la prima ad essere battuta, si rivelò fallace, ma non può essere liquidata alla stregua di un semplice sviamento delle indagini. Originariamente era suffragata da una testimonianza oculare – sia pure successivamente invalidata perché raccolta con modalità che nel 1972 furono dichiarate irregolari – e il rinvio a giudizio di Pietro Valpreda fu chiesto da un giudice, Vittorio Occorsio, al di sopra di qualsiasi sospetto di connivenza con l’eversione nera: prova ne sia che proprio Occorsio sostenne l’accusa nel procedimento conclusosi nel 1973 con la condanna in primo grado degli appartenenti al Movimento Politico Ordine Nuovo e, tragica riprova, la sua uccisione il 10 luglio 1976 ad opera del neofascista Pierluigi Concutelli, per ritorsione. La colpevolezza degli anarchici era affermata pure dalla “controinchiesta” su Piazza Fontana segretamente svolta dalle Brigate rosse: materialmente l’ordigno era stato posto nella banca da Valpreda, con la collaborazione di tutto il gruppo anarchico del Ponte della Ghisolfa […] doveva esplodere quando i locali della banca erano rimasti deseroccidentali tendente a ostacolare la politica di distensione fra i due blocchi» (ivi, p. 470). Per Giannuli, quindi, lo Stato è sinonimo di estrema destra, citata alla lettera «a)». L’accusa di complice inerzia elevata contro i «settori rilevanti dei servizi segreti» di cui alla lettera «b)» è molto pesante, ma per niente dimostrata nel volume. Bombe a inchiostro, piuttosto, non menziona la testimonianza di Paolo Emilio Taviani secondo cui un avvocato romano di nome Fusco, che «aveva frequenti legami con i dirigenti del Sid», il 12 dicembre 1969 si accingeva a partire per Milano allo scopo di prevenire la strage (notizia confermata da Anna Maria Fusco, figlia dell’avvocato, scomparso negli anni Ottanta). Cfr., per il tutto, P.E. TAVIANI, Politica a memoria d’uomo, Il Mulino, Bologna 2002, p. 382. Inoltre, dopo l’attentato ci furono depistaggi, ma non furono «costanti». Dal 1974 in poi, viceversa, costante fu l’impegno nel fare pulizia, coronato da successo tale da indurre lo stesso Giannuli a ritenere che le passate collusioni tra destra eversiva e poteri pubblici in realtà fossero state poca cosa (Bombe ad inchiostro, cit., pp. 44-45). È un’opinione di Giannuli, infine, il collegamento politico fra la strage compiuta da un pugno di eversori di destra e una strategia di politica internazionale condotta da «parte dei gruppi dirigenti occidentali» intenzionati ad ostacolare la distensione tra Est e Ovest. Più frastagliato il quadro tracciato da Mimmo FRANZINELLI, La sottile linea nera (Rizzoli, Milano 2008), il quale comunque tende anch’egli ad accomunare estrema destra e apparati dello Stato. Tra le due parti sarebbe intercorsa una «alleanza conflit-
212
La risposta dello Stato ai terrorismi
ti […] l’esplosivo ed i timer furono forniti per l’attentato dal gruppo veneto di Freda e Ventura […] il cervello dell’operazione era stato Delle Chiaie che era riuscito a gestire il gruppo di anarchici grazie all’inserimento in esso di Merlino, che era un suo uomo […] gli esiti dell’inchiesta non furono pubblicizzati anche perché, dalla medesima, risultava che Pinelli si era suicidato perché realmente coinvolto. […] Emerse dalla nostra inchiesta anche un particolare ruolo di Giannettini nel progetto svolto da Delle Chiaie13.
Qui, ovviamente, interessa poco il grado di credibilità della versione brigatista; interessa piuttosto confrontarla con le costruzioni accusatorie vagliate dai tribunali della Repubblica. L’intreccio tra anarchici e neofascisti tratteggiato dalla “controinchiesta” presenta somiglianze vistose con le ipotesi elaborate dagli apparati statali. Valpreda fu portato alla sbarra insieme ai neofascisti, questi ultimi formalmente indiziati e arrestati nel 1971. Nella ricostruzione brigatista, infine, il ruolo del giornalista e segreto informatore del Sid Guido Giannettini appare poco chiaro, seppure di certo inferiore a quello di anarchici e neofascisti. L’accenno a Giannettini non è sufficiente tuale» (ivi, p. 11). Franzinelli, che si occupa non soltanto di Piazza Fontana ma di tutto lo stragismo 1969-1974, taccia di «scarsa lealtà democratica» soprattutto l’Arma dei Carabinieri i cui comandanti, insieme a quelli di Sid e Forze armate, si sarebbero spinti «sino all’estremo limite del complotto contro le istituzioni democratiche che avrebbero dovuto presidiare» (p. 10). Il primo argomento addotto da Franzinelli, invero, non riguarda Piazza Fontana bensì la percezione dei carabinieri «come cobelligeranti» avuta da due «alfieri del terrorismo come Carlo Fumagalli e Giancarlo Esposti». Sta di fatto che Fumagalli fu condannato dallo Stato italiano ad una pena di 18 anni, regolarmente scontata, mentre Esposti fu ucciso in un conflitto a fuoco proprio dai Carabinieri che avrebbero dovuto essere suoi cobelligeranti. Spostandoci al capitolo su Piazza Fontana, neppure qui emergono evidenze di coinvolgimento degli apparati dello Stato nella progettazione o nell’esecuzione dell’attentato. Piuttosto, nella ricostruzione di Franzinelli spicca, a p. 70, una lettera pervenuta nel gennaio 1971 al ministro dell’Interno Silvio Gava, nella quale gli si chiedeva di aiutare l’indagato Giovanni Ventura: la missiva fu scritta da Tina Anselmi. A posteriori la Anselmi se ne pentì, e sarebbe ingiusto infierire su di lei per quella che è da considerarsi un’ingenuità, ancorché grossa. 13 Dichiarazioni rese nel 1991 da Michele Galati al giudice istruttore Carlo Mastelloni, riportate in A. CIPRIANI e G. CIPRIANI, Sovranità limitata, Edizioni Associate, Roma 1991, pp. 124-125.
213
VLADIMIRO SATTA
nemmeno per stabilire se nella visione delle Br dietro di lui ci fosse lo Stato, oppure segmenti più o meno rilevanti dei servizi segreti, oppure ancora nessun altro. Le indagini giudiziarie esplorarono le ipotesi peggiori sul conto di Giannettini, che fu imputato di strage prima di essere prosciolto. Chi parla di persecuzione nei confronti degli anarchici, dovrebbe ricordare che gli unici condannati nei procedimenti connessi a Piazza Fontana, alla fine, non furono loro bensì due appartenenti ai servizi segreti, Labruna e Maletti, per favoreggiamento nei riguardi di Giannettini. Il Sid, che nel 1973 negò alla magistratura le informazioni su Giannettini da essa richieste, travalicò le comprensibili esigenze di copertura del suo collaboratore, i cui legami con il Servizio furono poi resi noti dal ministro della Difesa Andreotti nel 1974. Resta incerto se nel 1973 il Sid avesse deciso in autonomia di essere reticente, o lo avesse fatto con l’avallo dell’autorità politica14. D’altro lato, è acclarato che Giannettini fosse amico di Freda e frequentasse gli ordinovisti veneti15. Tali rapporti, sommati all’operato di Labruna e di Maletti, all’aiuto ad espatriare che venne fornito al ricercato Pozzan nonché ad altri minori ma pur sempre censurabili comportamenti del Sid in vari momenti dell’inchiesta, sono rivelatori di collusioni tra spezzoni degli apparati di sicurezza e destra eversiva. Tutto questo, però, non significa che il servizio segreto fosse il mandante o l’esecutore della strage di Piazza Fontana e, quindi, non consente di definirla “strage di Stato”. 14
In sede storiografica, alcuni ritengono che ci siano elementi sufficienti per sciogliere il dubbio. Così Giuseppe De Lutiis, secondo il quale il Sid ebbe l’assenso del livello politico. De Lutiis aggiunge che nel 1973 politici e Sid protessero Giannettini perché erano «consapevoli» che «nell’attuazione dell’eccidio [di Piazza Fontana] era in qualche modo coinvolto un settore istituzionale dello Stato e dunque un possibile esecutore o intermediario non poteva essere abbandonato, rischiandosi in tal caso il disvelamento dell’intera catena di comando della strage» (G. DE LUTIIS, L’omicidio politico e la sua protezione, in Storia d’Italia, Annali, vol. 12, Einaudi, Torino 1997, pp. 505-507). Se così fosse, però, non si capirebbe perché nel 1974 Andreotti abbia rovesciato la decisione di un anno prima. Sarebbe più ragionevole supporre che, sia pure tardivamente, l’opportunità di collaborare alle indagini su un fatto gravissimo quale la bomba di Piazza Fontana abbia fatto premio sulla tutela di una fonte del Servizio. 15 Cfr. M. FRANZINELLI, La sottile linea nera, cit., p. 72.
214
La risposta dello Stato ai terrorismi
Personaggi di primo piano dei movimenti extraparlamentari di sinistra di allora, come il leader di Lotta continua Adriano Sofri – condannato in relazione all’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi – ed ex-terroristi quali il brigatista Valerio Morucci hanno schiettamente riconosciuto che l’aggressività sarebbe divampata anche se la strage di Piazza Fontana non fosse mai avvenuta16. Alle soglie degli anni Settanta: a) gli apparati L’eterogeneo ma consistente terrorismo era alquanto nuovo per l’Italia repubblicana. In precedenza si erano verificati attentati in Alto Adige ad opera di secessionisti locali di lingua tedesca, ma si era trattato di un fenomeno geograficamente circoscritto e tutto sommato di impatto non comparabile con gli accadimenti degli anni 1969-1988. Alle soglie degli anni Settanta, gli apparati statali destinati a combattere il montante terrorismo – vale a dire Carabinieri, polizia e servizi segreti – erano strutturati piuttosto in funzione di controllo dell’ordine pubblico. La magistratura, dal canto suo, era anch’essa inesperta di terrorismo, e la legislazione che si trovava ad applicare era inadeguata. Sul piano operativo, le Forze di polizia avevano esperienza di moti di piazza e non di lotta ad organizzazioni clandestine. Gran parte del personale era poco qualificata e poco addestrata, i mezzi in dotazione erano sovente carenti o vetusti17. Per di più, i vari organismi statali era-
16
Intervista di Roberto Delera ad Adriano Sofri, «Corriere della Sera», 2 aprile 2004. Attenzione a non lasciarsi fuorviare dal titolo: Tutto partì da Piazza Fontana. Poi lanciammo la prima pietra. Nel testo, infatti, Sofri afferma il contrario: «Mi chiedo: senza la strage di Piazza Fontana avrei tirato la prima pietra o no? Secondo me sì. Anzi forse l’avevamo già tirata. […] Noi non abbiamo cominciato a credere non solo nella necessità della violenza, ma addirittura nella virtù della violenza, dopo il 12 dicembre. Noi ce ne riempivamo la bocca da molto tempo prima». Di Valerio MORUCCI, si veda l’autobiografico volume La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004, a p. 252. Egli, tempo prima di entrare nelle Br, era stato militante di Potere Operaio. 17 Due riferimenti bibliografici; il primo, d’epoca, è R. CANOSA, La polizia in Italia dal 1945 ad oggi, Il Mulino, Bologna 1976; il secondo, recente, è il volume di D. DELLA PORTA e H. REITER, Polizia e protesta. L’ordine pubblico dalla Liberazione ai “no global”, Il Mulino, Bologna 2003.
215
VLADIMIRO SATTA
no anche mal coordinati tra loro. Non esistevano reparti specializzati nell’antiterrorismo e neppure squadre di intervento per eventuali blitz in condizioni estreme. Sul piano dell’intelligence, le strutture erano due: il servizio segreto di origine militare (Sid), ed il Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna (Sigsi), nuovo nome assunto dalla Divisione Affari Riservati del Ministero dell’Interno creata nel 1948, i cui terminali sul territorio erano gli Uffici Politici delle Questure. Tradizionalmente, gli Affari Riservati svolgevano funzioni di osservazione e informazione, con orientamenti a volte discutibili e con metodi che si rivelarono poco adatti a scopi prettamente investigativi. Il livello di istruzione dell’analista medio dell’intelligence italiana non era eccelso, e non si usava ricorrere a consulenze esterne. Le cosiddette “fonti aperte” – tra cui la pubblicistica di ambienti che, soprattutto a sinistra, si erano incamminati sulla strada della violenza o non facevano mistero di accettarla quale metodo di lotta, diventando fatalmente bacino di reclutamento per i gruppi armati – non erano studiate con l’accuratezza che avrebbero meritato18. Non va tralasciato che nel Sid, specie tra gli anziani del servizio, albergava uno spirito anticomunista, con due conseguenze: troppe simpatie nei confronti degli estremisti di destra in quanto anticomunisti anch’essi, e scarsa capacità di distinguere tra la sinistra legalitaria e la sinistra sovversiva. Solo a partire dal 1974 l’autorità politica fece intendere chiaramente a tutti che i valori supremi erano quelli costituzionali e non l’anticomunismo19. Oltre ai difetti osservati, inerenti specificamente al modo di affrontare i pericoli eversivi, bisogna tenere nel massimo conto le vicissitudini di altra natura che sballottavano gli apparati di intelligence, in primis il Sid. Il Sid ebbe una storia tormentata fin dalla sua nascita, nel 1966, avendo raccolto dal suo predecessore Sifar un’eredità segnata da scandali e polemiche. Negli anni Sessanta, infatti, il Sifar si era prestato a 18
Sul bagaglio culturale degli appartenenti ai servizi e sui loro metodi di lavoro, confrontati con quelli della “controinformazione” di estrema sinistra, cfr. A. GIANNULI, Bombe a inchiostro, cit., pp. 82-101. 19 Maletti, alla delegazione della Commissione Stragi che lo interrogò nel marzo 1997, disse che fino al 1974 era mancata «una guida politica che dicesse di fare una cosa piuttosto che un’altra, che c’era una Costituzione da rispettare e un’eversione da combattere».
216
La risposta dello Stato ai terrorismi
farsi strumento di interessi di partito, di corrente o individuali che con la difesa delle istituzioni non avevano alcun nesso, o aveva avuto la tendenza a trasformarsi in centro di potere autonomo. Queste attività, che andavano dalla distrazione di fondi alle schedature illegali (le quali più tardi recidivarono all’interno del Sid20) venendo a galla furono oggetto di clamorose inchieste e di polemiche che misero in difficoltà l’intero servizio. In particolare, nel 1964 fu sollevata in Parlamento la questione dell’esistenza presso il Sifar di una copiosa messe di fascicoli informativi a carico di autorità e personalità della vita pubblica italiana; la notizia trovò conferma e la questione fu aggravata, nel 1966, dalla scoperta che alcuni dei suddetti fascicoli erano spariti dagli uffici, essendo stati prelevati il 18 marzo dal Capo del servizio, generale Allavena, il quale dichiarava di averli distrutti ma senza apposita regolare verbalizzazione. Di conseguenza, i vertici del Sifar furono rimossi ed il servizio fu sciolto e sostituito dal Sid21. La commissione amministrativa istituita nel 1967 (commissione Beolchini) in pochi mesi accertò che la formazione dei circa 160.000 incartamenti era stata illegittima ed incontrollata, e concluse che in seno al Sifar si era creato un gruppo fuori controllo. Intanto cadde in disgrazia pure un altro ex-capo del Sifar, il generale De Lorenzo, protagonista degli eventi dell’estate 1964 dei quali si occuparono una commissione ministeriale (commissione Lombardi) ed una commissione parlamentare d’inchiesta (commissione Alessi). Il Sid, composto da cordate di elementi non di rado fedeli a questo o a quel dirigente più che al servizio, fu lacerato da dualismi e rivalità interne. La più eclatante di esse, nella prima metà dei Settanta, fu la contrapposizione tra il capo del servizio, Vito Miceli, ed il capo dell’Ufficio D del servizio stesso, Gianadelio Maletti. Entrambi, a turno, furono coinvolti in procedimenti giudiziari e dovettero rispondere di gravi accuse, tra cui quella di complicità con l’eversione di destra (Miceli sarà assolto e di20
Lo stesso Maletti dichiarò alla Commissione Stragi che «il Servizio non era un vero servizio informazioni all’epoca [1971-1972]: era un servizio di pettegolezzi». 21 La questione dei fascicoli illegali non si chiuse qui, peraltro, poiché la loro distruzione, ordinata dal Parlamento, fu eseguita con anni di ritardo, il che lasciò uno strascico di sospetti su cosa potesse essere avvenuto nel frattempo. Sull’intera vicenda dei fascicoli, si può consultare A. VIVIANI, Storia dei servizi segreti italiani 1815-1985, Adnkronos, Milano 1985.
217
VLADIMIRO SATTA
verrà parlamentare del Msi, mentre Maletti riporterà condanne e assoluzioni22). Anche il massimo dirigente degli Affari Riservati, D’Amato, conobbe le sue traversie giudiziarie, secondo alcuni alimentate dal Sid, che non lo amava23. D’Amato fu accusato di intendersela con i sovietici, fu implicato nelle indagini sul golpe Borghese e poi in uno scandalo relativo ad intercettazioni telefoniche. Ne venne fuori bene, ma lentamente e faticosamente. Alle soglie degli anni Settanta: b) il quadro normativo La normativa era ancorata a categorie soggettive ormai antiquate, non contemplando la nuova realtà delle associazioni aventi finalità terroristiche e, in conseguenza di un’insufficiente cultura sul fenomeno emergente, il legislatore stentava a concepire contromisure opportunamente modellate, in luogo di generiche disposizioni contro la criminalità. L’arretratezza culturale, del resto, era solo uno dei nodi da sciogliere. Contemporaneamente era in atto nell’ambito della legislazione penale italiana, all’incirca dal 1968, una fase di espansione dei diritti e delle garanzie individuali che raggiunse in quel periodo i suoi massimi livelli24. La legge 5 dicembre 1968, n. 932, vietava agli organi di polizia di sottoporre a sommario interrogatorio le persone arrestate o fermate. Nel 1969, il legislatore ritoccò le norme sull’arresto in fla22
Maletti è stato condannato due volte: una, come già ricordato, insieme con Antonio Labruna, per favoreggiamento nei confronti di Giannettini in relazione alle indagini sull’attentato di Piazza Fontana; l’altra per la vicenda del dossier Mi.Fo.Biali. Si sottrasse alla carcerazione fuggendo in Sudafrica. Nel 2000, imputato nel processo per la bomba gettata nel 1973 alla Questura di Milano da Gianfranco Bertoli, Maletti fu condannato in primo grado, ma assolto nei successivi. 23 Questa l’interpretazione di A. GIANNULI, Bombe a inchiostro, cit., pp. 281-282. Secondo Giannuli, il Sid e la Cia non perdonavano a D’Amato l’impulso che fra il 1968 e il 1969 egli diede alla formazione di un coordinamento internazionale di servizi di polizia – il club di Berna – al di fuori della Nato. 24 Si conviene con il giudizio di Vittorio GREVI, in testa al suo saggio intitolato Sistema penale e leggi dell’emergenza: la risposta legislativa al terrorismo, in AA.VV., La prova delle armi, Il Mulino, Bologna 1984. Il parere di Grevi è indirettamente confermato da tutti quei garantisti che parlano delle modifiche subite più tardi dalla legislazione in termini di smantellamento delle «conquiste» precedenti.
218
La risposta dello Stato ai terrorismi
granza e sul fermo di indiziati. Per avere un’idea degli effetti pratici della normativa vigente in quel periodo, si pensi alla vicenda del pittore Enrico Castellani; nel 1971, a pochi giorni dall’attentato incendiario compiuto dalle Br contro gli stabilimenti Pirelli a Lainate il 25 gennaio, egli fu sospettato dalla questura di Milano di essere uno dei responsabili, e la perquisizione della sua abitazione ne diede oggettivi riscontri, poiché vi furono rinvenuti documentazione brigatista, inneschi a miccia identici a quelli usati a Lainate ed un timer. Per legge, tuttavia, ciò non era sufficiente all’arresto immediato e così, intanto che la magistratura emetteva l’ordine di cattura, l’artista si rese latitante25. Una delle prime risposte normative allo stragismo, paradossalmente, fu un ampliamento delle garanzie per gli imputati: la cosiddetta “legge Valpreda” del 15 dicembre 1972, n. 773. Essa, trasparentemente legata alla vicenda di uno degli accusati dell’attentato di Piazza Fontana, conferì al giudice la facoltà di concedere la libertà provvisoria anche in relazione ai reati per i quali la cattura fosse obbligatoria. Ancora in occasione del sequestro Sossi (1974), tra il fatto in senso stretto ed il fatto in senso giuridico c’era un abisso: mentre il primo comunicato diramato dalle Brigate rosse annunciava l’ingresso «in una fase nuova della guerra di classe, fase in cui il compito principale delle forze rivoluzionarie è quello di rompere l’accerchiamento delle lotte operaie estendendo la resistenza e l’iniziativa armata ai centri vitali dello stato», per il codice penale il reato più grave configuratosi era la lesione di un paio di costole del rapito durante la fase del prelevamento26. Le carenze della magistratura in fatto di conoscenze sui terrorismi erano addirittura più profonde di quelle di cui soffrivano i corpi di polizia, anche perché prima dell’approvazione del nuovo codice di procedura penale (1989) l’attività di polizia e l’attività giurisdizionale erano più separate di adesso, e le questioni di sicurezza e ordine pubblico competevano essenzialmente alla polizia. Il vecchio codice legittimava la polizia giudiziaria a decidere autonomamente quali elementi fossero da riferire all’autorità giudiziaria perché ritenuti rilevanti rispetto al procedimento penale e quali no (potere di valuta25
M. CLEMENTI, Storia delle Brigate rosse, Odradek, Roma 2007, p. 28. La surreale dissonanza è stata ricordata dall’attuale procuratore della Repubblica di Torino, dottor Gian Carlo Caselli, alla sessione 8-9 maggio 2008 del convegno Protesta sociale e violenza politica in Italia e nella Germania federale negli anni ’60 e ’70 del Novecento, organizzato a Trento dalla Fondazione Bruno Kessler. 26
219
VLADIMIRO SATTA
zione che oggi è rimesso al pubblico ministero, cui perciò viene riferito automaticamente tutto)27. Un altro inconveniente strutturale, destinato a perdurare fino ai giorni nostri, era la frammentazione delle indagini tra le varie procure sparse sul territorio, derivante dal principio della competenza esclusiva di ciascuna per i fatti avvenuti nella propria area geografica. Un parziale rimedio consisterà nell’organizzazione di riunioni periodiche, soprattutto dal 1978 in poi, tra i magistrati delle procure maggiormente impegnate nell’antiterrorismo28. In sostanza, inizialmente apparati repressivi e potere giudiziario erano largamente impreparati ad affrontare i terrorismi. Del resto, lo erano anche altre istituzioni e settori della società, purtroppo. E anche in seguito e per lungo tempo, come ammisero gli stessi responsabili tecnici e politici della sicurezza, le forze di polizia e i servizi segreti palesarono gravi insufficienze, fatte salve le debite eccezioni. Dal 1974 alla soglie della vicenda Moro Autorevoli osservatori hanno imputato tali lacune degli apparati repressivi alle politiche che, almeno fino al 1977, avrebbero erroneamente privilegiato il profilo ordinamentale, cioè il varo di una legislazione di emergenza incentrata sul restringimento degli spazi di libertà. In altre parole, una seria politica degli apparati sarebbe stata inopportunamente surrogata e ritardata dall’inasprimento dei codici simboleggiato innanzi tutto dalla cosiddetta «legge Reale» (n. 152 del 22 maggio 1975)29. Al riguardo – premesso che la risposta ordinamentale era relativamente facile, rapida e a costo zero, mentre riorganizzare e ammodernare corpi composti da decine di migliaia di uomini si prospettava 27
In proposito, vedasi A. ANDREASSI, Dalla polizia politica alla polizia di sicurezza: un’evoluzione complessa (relazione al convegno Terrorismo e violenza politica nel XXI secolo, organizzato da Università di Roma «La Sapienza» e Centro Studi «Gino Germani», novembre 1999. Gli atti del convegno sono stati pubblicati nei «Quaderni del Centro Gino Germani», a. 10, n. 2/3. 28 Si vedano le testimonianze dei magistrati Ferdinando Pomarici e Rosario Priore a p. 145 del volume di G. ARMENI intitolato La strategia vincente del generale Dalla Chiesa contro le Brigate rosse… e contro la mafia, Edizioni Associate, Roma 2004. 29 S. RODOTÀ, La risposta dello Stato al terrorismo: gli apparati, in AA.VV., La prova delle armi, Il Mulino, Bologna 1984.
220
La risposta dello Stato ai terrorismi
operazione ben più lenta e faticosa, tale da non consentire di farsi illusioni sui risultati ottenibili a breve scadenza – non corrisponde al vero che nell’ambito degli apparati non si fosse fatto «nulla, o quasi». In questo campo, l’opera fu avviata nella primavera 1974, ossia un anno prima della «legge Reale». Il 1° giugno 1974 nasce l’Ispettorato Generale per l’azione contro il terrorismo (più tardi rinominato Sds), diretto dal dinamico questore Emilio Santillo, in sostituzione degli exAffari Riservati guidati dal navigato prefetto Federico Umberto D’Amato. Nelle stesse settimane del 1974, a Torino, viene istituito un Nucleo speciale antiterrorismo, capeggiato dal generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel luglio 1975 darà origine alle Sezioni Speciali Anticrimine; nello stesso 1975, in seno alla polizia, si formò un Nucleo Anticommando, che venne inquadrato nello Sds di Santillo e fu il capostipite delle squadre di pronto intervento in Italia. Le disposizioni del 1974-1975 furono seguite da altre non meno rilevanti nel 1977-1978, in risposta ad un impressionante aumento dei crimini terroristici: nel maggio 1977, il preoccupante fenomeno delle evasioni fu arginato affidando ai Carabinieri – nella persona di Dalla Chiesa – il coordinamento della sicurezza esterna dei penitenziari30, che in luglio fu integrato dall’attivazione di carceri speciali; nell’ottobre 1977, fu la volta di una radicale riforma dei servizi segreti; sempre in ottobre, una direttiva ministeriale promosse la creazione dei Nocs polizia, accompagnata da quella del corrispondente Gruppo Intervento Speciale (Gis) Carabinieri; e ancora, nel gennaio 1978, istituzione dell’Ucigos, con la quale il ministro dell’Interno Francesco Cossiga intese compensare la sparizione dello Sds di Santillo, dovuta alla legge di riforma dei servizi segreti. L’Italia, inoltre, si muoveva pure a livello continentale, essendo partecipe di iniziative sopranazionali di collaborazione antiterrorismo31. Il 27 gennaio 1977, a Strasburgo, fu firmata una Convenzione europea per la prevenzione e la repressione del terrorismo la quale facilitò le procedure di estradizione, 30
Decreto ministeriale 4 maggio 1977, firmato dal ministro per la Grazia e Giustizia Bonifacio, dal ministro per la Difesa Lattanzio e dal ministro per l’Interno Cossiga. Tra le evasioni, si ricordano quella di Curcio (dal penitenziario di Casale Monferrato, febbraio 1975) e di Gallinari ed altri (da quello di Treviso, gennaio 1977). 31 Il primo organismo internazionale ad iscrivere la questione del terrorismo all’ordine del giorno fu l’Onu, a ridosso dei fatti che avevano funestato le Olimpiadi di Monaco del 1972. Malgrado l’impegno personale del segretario generale Waldheim,
221
VLADIMIRO SATTA
mediante la derubricazione dei reati politici a reati comuni in una serie di casi32. La Convenzione di Strasburgo, la quale andava controcorrente rispetto ad una tendenza che dopo la seconda guerra mondiale inclinava piuttosto in favore del diritto d’asilo, sancì un principio foriero di progressi verso la costruzione di uno spazio giuridico europeo33. Era inevitabile, comunque, che i benefici di alcune tra le iniziative avviate tra la metà del 1974 e i primi del 1978 divenissero tangibili soltanto a distanza di tempo. Se tra il 1974 ed il 1977 l’organismo diretto da Santillo inferse duri colpi all’eversione di destra e ai Nuclei Armati Proletari, invece per il battesimo del fuoco dei Gis Carabinieri e dei Nocs polizia si dovette attendere rispettivamente il 1980 e il 1982. Inoltre, la riforma dei servizi segreti segnò addirittura un momentaneo regresso di capacità operative, pur essendo necessaria in ragione delle disfunzioni e deviazioni che avevano caratterizzato il Sid. La transizione dal vecchio assetto unitario al nuovo, sdoppiato, migliorò però, in seno alle Nazioni Unite si palesarono divisioni, che paralizzarono l’organismo. Il Vecchio Continente, nella circostanza, si dimostrò più pronto; il Consiglio d’Europa riconobbe la necessità di un’azione coordinata dei paesi membri e, stante l’inerzia delle Nazioni Unite, intraprese un percorso che avrebbe portato alla Convenzione di Strasburgo del 1977. 32 Non tutti i paesi europei, però, adottarono le regole di Strasburgo. Irlanda e Malta non firmarono l’accordo, e altri Stati non lo ratificarono. Tra questi la Francia, il paese nel quale si sarebbe rifugiata la maggioranza dei terroristi italiani in rotta fuggiti all’estero. All’Assemblea di Strasburgo, i rappresentanti italiani si divisero: i comunisti votarono contro il testo in esame. Per maggiori ragguagli sulla Convenzione di Strasburgo, cfr. il Quaderno di documentazione Estradizione e reti politiche, curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (Roma 1981), oppure la monografia di M.R. MARCHETTI, Istituzioni europee e lotta al terrorismo, Cedam, Padova 1986. 33 Ne furono consapevoli sia i fautori, sia gli avversari. Tra i primi, si annovera il presidente della Repubblica francese Giscard d’Estaing, che il 14 dicembre 1977 fece una dichiarazione radiotelevisiva in materia (riassunta da S. SENESE, Implicazioni giuridiche e politiche della Convenzione europea contro il terrorismo, in L’Europa tra integrazione economica ed egemonia politica, Franco Angeli, Milano 1979. Senese, all’opposto di Giscard d’Estaing, riteneva che la Convenzione, espressione di una «curvatura autoritaria dello Stato tardo-capitalistico», fosse «ragione d’inquietudine e di allarme non soltanto per la nuova sinistra ma – soprattutto fuori d’Italia – per fasce non trascurabili di opinione pubblica democratica»).
222
La risposta dello Stato ai terrorismi
infatti il controllo istituzionale sui servizi segreti ma comportò un loro temporaneo calo di efficienza. Dei due rami spuntati dal tronco del Sid, cioè il Servizio Informazioni Sicurezza Miliare (detto Sismi) e il Servizio Informazioni Sicurezza Democratica (detto Sisde), proprio il secondo – competente in materia di antiterrorismo – nell’inverno 1978 versava in condizioni estremamente precarie, terribilmente a corto di uomini e mezzi34. Non essendosi proceduto a duplicare gli archivi del morente Sid, il patrimonio informativo accumulato dal servizio segreto vecchio divenne oggetto di contese tra i due nuovi. La stessa cosa avvenne su altri fronti. Nella spartizione, spesso ebbe la meglio il Sismi, ma a prescindere da chi dei due prevalesse, a perderci sistematicamente era il paese. Va considerato pure che la ristrutturazione degli organici, in un’epoca pre-informatica o quasi, fatalmente menomava la memoria storica umana collettiva, poiché smembrava unità di lavoro nelle quali, prima, chi non aveva diretta esperienza su una materia sapeva, in compenso, a quale collega rivolgersi35. Lo scioglimento dello Sds – in parte confluito nel Sisde, in altra parte rimpiazzato dall’Ucigos, mentre Santillo fu nominato vicecapo della polizia – va inquadrato nell’ambito della riforma dei servizi di sicurezza e sopravvenne dopo che esso aveva compiuto le missioni cui si era principalmente dedicato. È improbabile che l’Sds, qualora fosse stato ancora in funzione all’epoca del rapimento Moro, potesse fornire contributi decisivi, poiché era scarsamente ferrato sulle Brigate rosse36. Mentre il sistema degli apparati, insomma, in realtà cambiò parecchio, in relazione alla legislazione sarebbe parziale considerare soltanto i giri di vite e non anche gli allentamenti. 34
Per una ricognizione dettagliata, cfr. A.L., Cronaca di storia recente. I primi anni del Sisde, «Per aspera ad veritatem» [rivista a cura del Sisde], fasc. di settembredicembre 1995. 35 Questo aspetto è stato colto da L. STORTONI, autore del saggio La repressione del terrorismo in Italia: alcune ipotesi sulle difficoltà, «Storia e problemi contemporanei», anno 1993, fascicolo 11. 36 Al punto che Santillo ammise umilmente, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta, che fino alla primavera 1978 egli e il suo Ispettorato non sapevano neppure chi fosse Mario Moretti.
223
VLADIMIRO SATTA
Le modifiche ordinamentali apportate tra il 1974 ed il 1977, infatti, furono fin troppo altalenanti, come già all’epoca constatavano qualificati osservatori37. Coesistevano, con difficoltà, due orientamenti divergenti; l’uno proseguiva nella direzione garantista imboccata tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, mentre l’altro, di fronte ad un incremento degli indici di delinquenza (non soltanto terroristica) registratosi nella prima metà del nuovo decennio, tendeva ad un irrigidimento. Andavano in direzione garantista i principi e criteri che, ai sensi della legge 3 aprile 1974, n. 108, avrebbero dovuto informare il futuro codice di procedura penale, e altrettanto dicasi per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (legge 8 aprile 1974, n. 98) e per la riforma dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), caratterizzata quest’ultima dalla previsione di misure alternative alla detenzione delle quali, in taluni casi, i terroristi approfittarono per rendersi irreperibili. I primi segnali di mutamento di rotta si ebbero invece con un decreto legge dell’aprile 1974 poi convertito in legge il 7 giugno seguente; il provvedimento allungava la carcerazione preventiva (onde prevenire una serie di scarcerazioni che altrimenti sarebbero scattate il 1º maggio 1974, alla scadenza dei termini fissati da un decreto legge antecedente) ed ampliava la sfera di utilizzabilità del rito direttissimo. Quest’ultima disposizione precorse la legge 14 ottobre 1974, n. 497, che impose il rito direttissimo per i reati concernenti armi ed esplosivi, nonché ulteriori passi nella medesima direzione negli anni a seguire. Sempre nel 1974, fu restituito agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di interrogare le persone arrestate o fermate, che era stato tolto loro nel 1969, purché ciò avvenisse alla presenza del difensore. Il più impegnativo intervento del legislatore contro la criminalità sia terroristica, sia comune, fu la legge n. 152 del maggio 1975, che prese il nome dal Guardasigilli Oronzo Reale (appartenente al Partito repubblicano italiano). Essa, proprio perché dava l’impressione di una svolta, fu emanata «dopo un travagliato dibattito parlamentare e dopo non poche polemiche nell’ambito politico»38. Tra i punti salienti della 37
I magistrati Pier Luigi Vigna e Giovanni Bellagamba, coautori di un instant book di commento alla legge Reale del 22 maggio 1975, nella Premessa scrivevano: «il legislatore attuale mostra spesso una certa mutevolezza di indirizzi, forse adeguandosi alla mutevolezza dei tempi». Cfr. P.L. VIGNA e G. BELLAGAMBA, La legge sull’ordine pubblico, Giuffrè, Milano 1975. 38 Ibidem.
224
La risposta dello Stato ai terrorismi
composita «legge Reale»: una sensibile restrizione della discrezionalità che la “legge Valpreda” aveva conferito al giudice in materia di concessione della libertà provvisoria; l’accrescimento dei poteri delle forze dell’ordine e delle garanzie relative allo svolgimento del loro servizio, mediante nuove norme in tema di fermo, perquisizione, uso delle armi e la particolare procedura in caso di imputazioni a carico di ufficiali ed agenti; l’estensione del ricorso al giudizio direttissimo. Sul versante di destra la «legge Reale» ritoccava la «legge Scelba», allargando e precisando l’ambito di applicazione della norma in modo da rendere punibili i gruppi neofascisti composti da un minimo di cinque persone. La «legge Reale», che era tecnicamente discutibile in alcuni passaggi, fu aspramente criticata dai garantisti un po’ per queste ragioni e, ancor più, per motivi di principio. Si è già detto, a proposito degli apparati repressivi, che molti mal sopportavano le soluzioni dichiaratamente eccezionali. In campo giuridico, la contrarietà da parte degli addetti ai lavori era ancora più forte. Agli occhi dei giuristi garantisti, i profili preventivi e i giudizi con rito direttissimo rappresentavano una sorta di sottosistema penale a parte che, in quanto tale, era lesivo del fondamentale principio dell’eguaglianza di fronte alla legge. I sostenitori della legislazione speciale antiterroristica, dal canto loro, tacciavano i garantisti di formalismo e teorizzavano la necessità che il diritto stabilisse una gerarchia tra i valori in gioco, la quale recepisse la novità dell’aggressione terroristica39. Nel 1978, la parola passò agli elettori: fu indetto un referendum popolare abrogativo, promosso dal Partito radicale e da svariati comitati, in esito al quale la «legge Reale» fu confermata a grande maggioranza (76,5%). Infine, tra il 1974 e il 1978, si resero necessari provvedimenti atti a garantire la regolare celebrazione dei processi. Le Br, infatti, tentarono con tutti i mezzi di impedire lo svolgimento di un importante processo a Torino contro la loro organizzazione, giungendo ad uccidere il presidente del locale ordine degli avvocati, Fulvio Croce, nell’aprile 1977. Nel clima di intimidazione venutosi a creare, era diventato difficile persino reperire la mezza dozzina di giurati popolari che la pro39
Un’ampia illustrazione delle argomentazioni dei garantisti si trova in L. FERDiritto e ragione, Laterza, Roma-Bari 2004 (1ª ed., 1989), pp. 844-877 e relative note. Contra, N. LIPARI, Terrorismo e valori nella cultura giuridica (relazione svolta presso l’Università di Padova il 3 dicembre 1982, trascritta in «Democrazia e diritto», a. 1983, fasc. 2). RAJOLI,
225
VLADIMIRO SATTA
cedura penale richiedeva, e si profilava il rischio che i termini di legge scadessero. Pertanto, il decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, interruppe il decorso dei termini di carcerazione preventiva fintanto che il dibattito processuale fosse in sospeso o rinviato per cause di forza maggiore, e il successivo decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, agevolò la costituzione e l’eventuale integrazione delle giurie popolari. Il processo di Torino poté dunque iniziare e questo fatto, in sé, rappresentò un successo per le istituzioni. Retrospettivamente, l’efficacia delle misure introdotte tra il 1974 ed il 1977 appare scarsa, specie se comparata con quelle di epoca successiva. Tuttavia la reazione legislativa antiterroristica di quel quadriennio, sebbene alquanto approssimativa, era pur sempre meglio di niente e comunque, ai fini della sicurezza, risultava più utile (o meno controproducente, se si preferisce) delle aperture libertarie le quali, mirando ad obiettivi sociali non aventi nulla a che fare con problemi di quel genere, li ignoravano o, addirittura, oggettivamente ne allontanavano la soluzione. Il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro La Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro scrisse che «la punta più alta dell’attacco terroristico» – segnata dall’eccidio di via Fani e dal sequestro e omicidio del presidente della Dc – coincise «con la punta più bassa del funzionamento dei servizi di informazione e sicurezza». L’impreparazione degli apparati statali, e dei servizi segreti in particolar modo, non era rimediabile dalla mattina alla sera. Consapevoli di questo, le autorità tentarono di supplire con la quantità alle carenze di qualità. Le ricerche dello statista impegnarono più di 12.000 uomini al giorno, uno sforzo senza eguali, le cui dimensioni erano l’unica speranza in una situazione in cui si andava alla cieca. Il meticoloso vaglio del lavoro di questa massa di persone, ovviamente non tutte infallibili, in realtà non ha evidenziato errori determinanti, né tanto meno dolosi40.
40
Per un’analisi dettagliata al riguardo, mi permetto di rimandare ai miei: V. SATOdissea nel caso Moro, Edup, Roma 2003, e Il caso Moro e i suoi falsi misteri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. In aggiunta, merita un cenno l’episodio rivelato dal brigatista Bruno Seghetti al giornalista Giovanni BIANCONI, narrato in un capitolo del
TA,
226
La risposta dello Stato ai terrorismi
Il rilievo va esteso anche a coloro che nel 1981 risultarono iscritti alla loggia massonica segreta, e pertanto illegale, di Licio Gelli, la P2, la cui presenza negli apparati pubblici è stata ingigantita da chi ha imperniato su di essa teorie cospirative41. Inoltre, il sequestro Moro si distinse da altre vicende di terrorismo o di criminalità perché fu l’unico caso in cui vennero istituiti appositi comitati di crisi. Il primo e più importante di essi si formò il giorno stesso dell’agguato di via Fani. Era un comitato politico-tecnico-operativo, dapprima presieduto dal ministro dell’Interno Cossiga, poi dal sottosegretario Lettieri, composto da esponenti dell’esecutivo e vertici di forze di polizia, servizi segreti e forze armate. Qualche malumore fu causato dal fatto che la componente politica fosse governativa e non parlamentare, a differenza di quanto era accaduto in Germania al tempo del sequestro di Hanns-Martin Schleyer. In Italia, peraltro, il governo in carica aveva l’appoggio di una larghissima maggioranza parlamentare, sicché l’esclusione delle sparute opposizioni era una questione di principio, ma priva di effetti pratici sui lavori del comitato. Il vero problema del comitato Lettieri era la carenza di buone piste da seguire. A fine marzo, l’insoddisfazione dei partecipanti venne fuori, e le riunioni quotidiane cessarono.
volume Mi dichiaro prigioniero politico, Einaudi, Torino 2003. Il nominativo di Seghetti, nel 1978 noto alla polizia solo quale militante dell’ultrasinistra romana, fu per questo compreso negli accertamenti disposti il 3 aprile su centinaia di soggetti di quell’area. Avendo appreso che lo avevano cercato in sua assenza, Seghetti ripulì il proprio appartamento e, allo scopo di prevenire l’attivazione di una sorveglianza sul suo conto, subito dopo si presentò spontaneamente in commissariato, pensando che a quel punto ciò fosse il pericolo minore per le Br. Sul posto, Seghetti constatò che la polizia non aveva nessun concreto elemento contro di lui. Gli inesperti agenti di turno non intuirono chi egli fosse realmente e lo lasciarono andare. 41 La perniciosità del fenomeno P2 non è sufficiente per incolpare la cricca di Gelli di ogni sventura nazionale e, segnatamente, anche del caso Moro e di complicità con le Br. È doveroso rammentare che negli anni Settanta due appartenenti alla P2, Massimo De Carolis e Publio Fiori, furono feriti dalle Br a colpi di arma da fuoco. Tempo dopo, i Carabinieri scoprirono pure che le Br intendevano assassinare il generale Grassini, piduista, direttore del Sisde.
227
VLADIMIRO SATTA
Intanto, erano stati messi in piedi anche altri organismi, persino improbabili, quale il gruppo di intellettuali attorno al professor Vincenzo Cappelletti, il cui apporto fu assolutamente nullo. Furono chiamati a Roma pure il generale Dalla Chiesa ed alcuni ufficiali delle disciolte Sezioni Speciali Anticrimine dei Carabinieri, ma né l’uno né gli altri furono in condizioni di contribuire granché alle indagini42. Resta il fatto che la mobilitazione delle forze di polizia purtroppo fu vana e le Br uccisero l’ostaggio. Neanche la magistratura fu all’altezza della situazione. Le note dolenti attengono soprattutto alle burocratiche deficienze organizzative. Il titolare delle indagini, Luciano Infelisi, fu costretto ad operare con le risorse ordinarie, vale a dire senza adeguati rinforzi. Egli, anzi, fu addirittura costretto a sciupare parte del suo tempo per presenziare ad udienze di altre vicende, come la procedura imponeva. Ha poco senso, invece, rimproverare alla magistratura di non avere esercitato un ruolo di guida rispetto alle indagini, dal momento che si andava a tentoni e le attività di controllo, puntando sulla quantità, erano così numerose ed urgenti da non lasciare alle forze di pubblica sicurezza il tempo di riferire preventivamente all’autorità giudiziaria. Il 24 aprile Infelisi, ormai prossimo alla scadenza di 40 giorni prevista dal codice per l’istruttoria sommaria, preparò una serie di ordini di cattura, la cui emissione fu rallentata di qualche giorno dal procuratore De Matteo nel timore che la mossa fosse inopportuna (le Br avevano appena offerto il rilascio dell’ostaggio in cambio della scarcerazione di loro militanti detenuti). In Commissione Moro il procuratore generale Pascalino, a domanda, rispose chiaramente che quei mandati di cattura erano campati in aria. A parte il fatto che la maggioranza dei personaggi ricercati era estranea al sequestro Moro, un ordine di cattura non è affatto sinonimo né garanzia di cattura. Nel 1978, su Mario Moretti e Prospero Gallinari già pendevano ordini di cattura ormai da anni, senza che ciò avesse in alcun modo avvicinato il loro arresto o impedito loro di prelevare e tenere segregato 42
Si vedano il resoconto dell’audizione 8 luglio 1980 del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro e quello dell’audizione 23 maggio 2000 dell’ufficiale Umberto Bonaventura in Commissione Stragi, nonché p. 132 del volume Nei secoli fedele allo Stato, Fratelli Frilli Editori, Genova 2006, un libro-intervista di Michele RUGGIERO al generale Nicolò Bozzo.
228
La risposta dello Stato ai terrorismi
Aldo Moro. Il differimento di pochi giorni nell’emissione di quella serie di ordini di cattura basati sul nulla, logicamente, fu irrilevante per la sorte dell’ostaggio. Non si ha motivo di ritenere che se ci fosse stato un altro al posto di Infelisi la sostanza potesse mutare radicalmente. Basti ricordare che uno dei magistrati subentrati dopo la fine dell’istruttoria sommaria, Ferdinando Imposimato, versava in una «totale ignoranza della galassia brigatista» e il 19 maggio, al momento in cui il tipografo Enrico Triaca, arrestato, gli fece il nome di Moretti, pensò «che si trattasse di un nome inventato di sana pianta»43. Fu sicuramente più valida la risposta legislativa, sebbene da sola non sufficiente. Essa scattò in meno di una settimana dall’agguato di via Fani. Il 21 marzo 1978, infatti, entrò in vigore un decreto-legge, n. 59, poi convertito con modificazioni in legge 18 maggio 1978, n. 191. Innanzi tutto, la norma inserì nel codice penale un nuovo articolo (n. 289-bis) che prevedeva la figura delittuosa di «sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione». Così, da un lato si manifestava finalmente chiara coscienza della lotta armata di cui il sequestro era parte e, da un altro, si prometteva una diminuzione di pena al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si fosse adoperato per rimettere in libertà il sequestrato. Nessun brigatista colse tale opportunità, purtroppo, ma si trattò in ogni caso di uno spunto di natura premiale che anticipò una successi43
Lo ammette IMPOSIMATO stesso, a p. 265 di Doveva morire, volume del quale è autore insieme al giornalista Sandro PROVVISIONATO (Chiarelettere, Milano 2008). La circostanza è doppiamente sconcertante in quanto Moretti era tra i ricercati della prima ora, i cui nomi e volti erano stati diffusi da televisione e giornali subito dopo l’eccidio di via Fani. In altre parole Imposimato, a distanza di appena due mesi, se ne era scordato completamente e, assumendo la titolarità dell’indagine, si comportò come se non si fosse curato di conoscere almeno l’essenziale di ciò che era stato fatto. Nel corso degli anni, Imposimato è divenuto un assertore di piste internazionali alle quali, come è noto, i tribunali non hanno creduto. Nell’aprile 2008, le agenzie di stampa hanno informato altresì che la procura di Roma, dopo quattro anni, ha archiviato l’inchiesta riaperta a seguito della presentazione di un fascicolo da parte dell’avvocato Marazzita, preparato con l’aiuto di Imposimato. Giornali, televisioni e radio, spesso prodighi di dettagli insignificanti sulla vicenda Moro, hanno ignorato l’importante decisione della procura.
229
VLADIMIRO SATTA
va strategia, destinata a contribuire efficacemente alla disfatta dei terrorismi. Sempre in funzione del contingente sequestro Moro, il decreto-legge dettava un nuovo articolo di codice di procedura penale, il 165-ter, che autorizzava il ministro dell’Interno a richiedere all’autorità giudiziaria informazioni e copie di atti processuali. In tal modo, facendo un’eccezione al vincolo del segreto istruttorio, il 165-ter aveva il pregio di consentire una più stretta collaborazione tra ministro e magistrato, ma sotto il profilo dei rapporti tra poteri dello Stato la prerogativa assegnata al Viminale appariva essere uno sconfinamento; nel tempo, comunque, le apprensioni e le polemiche furono smorzate grazie ad un uso moderato del nuovo strumento44. Infine, il decreto-legge n. 59 introdusse l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle locazioni di immobili e delle generalità di chi ne entrava in possesso. Una disposizione apparentemente secondaria e che fu accolta con scetticismo, la quale però si attagliava ai covi dei terroristi e creò difficoltà non lievi ai gruppi armati. Dopo Moro Dopo la perdita di Moro – una sconfitta militare che apparve a molti italiani assai più pesante e ingiustificabile di quanto apparve ai tedeschi il sequestro e l’omicidio di Hanns-Martin Schleyer – le istituzioni seppero risalire la china. Nella seconda metà del 1978 e durante il 1979 la lotta alle Br divenne molto più incisiva e a partire dall’inverno 1980 lo Stato prese il sopravvento.
44
Questa la conclusione del giurista Vittorio GREVI, Sistema penale e leggi dell’emergenza, cit., p. 36. È positiva la valutazione del 165-ter di Virginio ROGNONI, che se ne avvalse. Si veda Intervista sul terrorismo, p. 71. Si tratta di un volume realizzato da Rognoni con la collaborazione del giornalista Giuseppe De Carli, edito da Laterza, Roma-Bari 1989. È durissimo, invece, il giudizio dell’ex-magistrato Ferdinando IMPOSIMATO il quale, alle pp. 329-330 del libro Doveva morire, afferma che il 165-ter servì ad «emargina[re] la Procura di Roma dalle indagini» e a permettere al ministro di «conoscere in ogni dettaglio le mosse dei magistrati e controllarne le iniziative. A quale scopo? Il pretesto fu che le indagini potevano mettere in pericolo la vita di Moro. In realtà era vero il contrario: quelle iniziative avrebbero potuto salvare la vita di Moro». Il corsivo è mio. In Doveva morire, tuttavia, non si ravvisa l’asserita criminosa ingerenza del ministro nell’attività della magistratura.
230
La risposta dello Stato ai terrorismi
Dallo stesso 1980 in poi, fu debellato anche il terrorismo di destra, passato in secondo piano rispetto a quello di sinistra e nondimeno autore nella seconda metà degli anni Settanta di una lunga catena di omicidi, attentati e rapine. Dal 1975 al 1980 si attribuiscono ai neri 115 morti, di cui 85 nella strage di Bologna, e circa 3000 attentati contro persone e cose45. Un rinnovato slancio nelle inchieste sui neofa45
Bilancio fatto dal magistrato Rosario Minna nel saggio Il terrorismo di destra, in Terrorismi in Italia, a cura di D. Della Porta, Il Mulino, Bologna 1984. Com’è noto, per la strage di Bologna sono stati giudicati colpevoli con sentenza definitiva i neofascisti Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Tuttavia, esiste una corrente che ritiene Fioravanti e Mambro estranei alla strage e, pertanto, il dibattito pubblico è tuttora aperto. Nella saggistica, ad esempio, nel 2007 sono usciti due libri di orientamento diametralmente opposto: innocentista quello di A. COLOMBO, Storia nera, Cairo editore, Milano 2007; colpevolista, il di poco successivo R. BOCCA, Tutta un’altra strage, BUR, Milano 2007. Sulla strage di Bologna, si segnala altresì uno studio compiuto da due consulenti della ex-Commissione parlamentare d’inchiesta sul dossier Mitrokhin, Lorenzo Matassa e Gian Paolo Pelizzaro, che delineano invece una pista mediorientale. Secondo Matassa e Pelizzaro, il cui lavoro è stato divulgato da due parlamentari di An, Filippo Berselli (a quel tempo sottosegretario alla Difesa) ed Enzo Raisi, il terrorismo arabo avrebbe colpito l’Italia per punire il sequestro di materiale bellico avvenuto nel 1979 ad Ortona e il connesso arresto del giordano Abu Anzeh Saleh. La parte italiana, in tal modo, avrebbe violato un accordo sotterraneo in base al quale le nostre autorità lasciavano indisturbati i guerriglieri mediorientali e i loro traffici in cambio dell’astensione da attacchi contro il nostro paese. L’ipotesi di Matassa e Pelizzaro, a mio avviso, non esclude un coinvolgimento del terrorismo di destra nostrano nell’attentato di Bologna. Potrebbe essersi trattato di concorso in un’iniziativa partita da altri. I dirigenti mediorientali che in Europa tessevano una rete di collegamenti con svariati gruppi armati del continente non avevano preclusioni nei confronti della destra. Per l’Italia, se è vero che la causa palestinese riscuoteva consensi nell’estrema sinistra, è altrettanto vero che gli arabi avevano in comune con l’estrema destra l’antisemitismo. Ad esempio, un notorio nemico di Israele era Franco Freda, e un altro personaggio a lui vicino, Claudio Mutti, teorizzava affinità tra il nazismo e l’Islam. In atti giudiziari compaiono persino tracce di addestramenti di neofascisti italiani presso campi paramilitari mediorientali. L’individuazione di un movente internazionale plausibile per la strage di Bologna, quindi, sanerebbe una delle due debolezze della sentenza giudiziaria, vale a dire l’improbabilità che nel contesto politico, sociale e ideologico dell’agosto 1980 i neofascisti italiani pensassero di ritentare la carta giocata nel 1969 in Piazza Fontana (l’altra debolezza, a mio parere, è la scarsa attendibilità del testimone Massimo Sparti, ma ciò riguarda la personale posizione di Fioravanti e Mambro e non l’intera area dell’eversione nera).
231
VLADIMIRO SATTA
scisti giunse a seguito di due delitti, in particolare: l’assassinio del dottor Mario Amato, sostituto procuratore in Roma (23 giugno 1980), e la strage di Bologna (2 agosto 1980)46. Nel giro di pochi mesi gli inquirenti ampliarono grandemente le loro cognizioni e nel febbraio 1981 si registrò il primo importante arresto, quello di Valerio (detto Giusva) Fioravanti. Verso la fine del 1982, grazie al lavoro di magistratura, polizia e carabinieri, lo spontaneismo armato di destra poteva considerarsi stroncato47. I nuclei dei Carabinieri del generale Dalla Chiesa Il primo Nucleo speciale antiterrorismo dei Carabinieri nacque nel maggio 1974, all’indomani della conclusione del sequestro brigatista ai danni del magistrato Mario Sossi, prelevato il 18 aprile a Genova. Il progetto maturò nel corso di una serie di incontri tra Dalla Chiesa ed il ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani. La vicenda Sossi, chiusasi con un rilascio deciso unilateralmente dai rapitori, aveva messo in luce l’accresciuta pericolosità delle Brigate rosse e, al tempo stesso, l’inefficienza delle forze di polizia48. Dalla Chiesa all’epoca comandava la Prima Brigata Carabinieri con giurisdizione su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ed era convinto che la tradizionale struttura territoriale dell’Arma fosse inadatta a fronteggiare la nuova minaccia e della necessità di allestire un apposito gruppo ristretto, dalle caratteristiche peculiari, di eccellenza, non proponibili per la totalità delle forze di polizia. Egli trovò in Taviani un interlocutore ben disposto, che gli permise di superare resistenze sia da parte di settori della società e della politica contrari a misure eccezionali, sia interne alle alte sfere dei Carabinieri stessi, che si sentivano scavalcate. Il nucleo era composto da una quarantina di elementi. La specializzazione, la selezione di personale motivato, capace di straordinaria 46
Amato all’epoca indagava proprio sui neofascisti. Poche settimane prima dell’omicidio era stata accolta la sua insistente richiesta di essere affiancato da un paio di colleghi. La sua memoria è stata onorata da Elisabetta CESQUI nell’articolo Come eravamo, «Questione Giustizia», fasc. n. 4/2007. 47 Cfr. F. FERRARESI, Minacce alla democrazia, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 340-341. 48 Nei secoli fedele allo Stato cit., p. 105.
232
La risposta dello Stato ai terrorismi
dedizione, e l’affrancamento almeno tendenziale da dispersivi oneri burocratici produssero presto notevoli risultati, primo fra tutti la cattura nel settembre dei capi storici brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini. Altri arresti e scoperte di covi si susseguirono per mesi. Nell’estate 1975 il nucleo unico originario fu sostituito da tre Sezioni Speciali Anticrimine, con sedi a Milano, Roma e Napoli. Sotto un certo profilo, si trattava di una propagazione dell’esperienza avviata nel 1974, ma sotto un altro profilo fu un inizio di rientro negli schemi organizzativi su base territoriale anziché funzionale propri dell’Arma dei Carabinieri49. Dalla Chiesa si separò dalle nuove Sezioni Speciali, le quali comunque furono attivate e colsero pure risultati non disprezzabili. Nel novembre 1977, la tendenza al riassorbimento prevalse fino in fondo, comportando l’inglobamento dei reparti speciali all’interno dei rispettivi comandi provinciali. Stando ai ricordi di politici e di ufficiali dell’epoca, si era affievolita la sensazione che il brigatismo rosso andasse combattuto con strumenti di emergenza e, parallelamente, aveva influito un mai sopito desiderio di normalizzazione, presente soprattutto presso i comandi dell’Arma50.
49
Bozzo, alle domande dei commissari della Commissione Stragi, rispose che la decisione di riorganizzare l’originario nucleo antiterrorismo fu una questione interna all’Arma, cui la politica rimase estranea (audizione 1998). 50 Nel volume Nei secoli fedele allo Stato, a p. 109, Bozzo afferma che alla base della decisione «vi era il superamento della fase di emergenza (che nessuno amava, non dimentichiamolo) e una valutazione (da più parti) del fenomeno rivelatasi poi ingannevole, ma non un abbassamento della guardia nella lotta al terrorismo, perché lo Stato mise in piedi altre iniziative di contrasto». Dissente dai prevalenti giudizi di inopportunità delle modifiche apportate strada facendo alle Sezioni speciali anticrimine, ivi comprese quelle del novembre 1977, il direttore della polizia di prevenzione, prefetto Ansoino Andreassi: a suo parere, essendovi «l’esigenza di un coordinamento delle Sezioni, si pensò in un primo momento di risolvere il problema affidando tale compito ad appositi comandi istituiti presso le Divisioni di Milano, Roma e Napoli. Ma questa triplice direzione non si mostrò adeguata e le Sezioni furono inglobate nei Nuclei Investigativi (poi ribattezzati Reparti Operativi) esistenti in ogni Gruppo Carabinieri (vale a dire in ogni provincia)». Si veda A. ANDREASSI, Dalla polizia politica alla polizia di sicurezza: un’evoluzione complessa, cit.
233
VLADIMIRO SATTA
La scelta si rivelò improvvida, in quanto due fattori stavano giocando in favore dei terroristi. Il primo fu una sorta di “eruzione sociale” all’indomani delle elezioni politiche del 1976 e lungo il 1977. Tra i suoi effetti meno vistosi ma più importanti ci fu quello di determinare il passaggio alla lotta armata di elementi dell’ultrasinistra delusi dal risultato elettorale e dalle prospettive di accordi tra la classe dirigente, il maggior partito della sinistra e i sindacati. Il secondo fattore fu l’innegabile abilità dei brigatisti che subentrarono ai capi imprigionati o morti. Fu sottovalutato non tanto il terrorismo nel suo complesso, quanto la vitalità posseduta dalla sua specifica componente brigatista51. La deficitaria prestazione delle strutture operative in occasione della vicenda Moro pose allo Stato l’imperativa esigenza di attrezzarsi meglio. La più importante innovazione in questo senso fu appunto il conferimento a Dalla Chiesa di un nuovo incarico speciale per la lotta contro il terrorismo. Il decreto istitutivo, messo a punto nell’agosto 1978, assegnava al generale il coordinamento degli «operatori di polizia appositamente prescelti in relazione ad appropriate esperienze e speciali capacità evidenziate», per la durata di un anno a decorrere dal 10 settembre. Questa volta Dalla Chiesa poté avvalersi di circa 230 elementi, di cui 180 provenienti dai Carabinieri e 50 dalla Pubblica Sicurezza. I comandi territoriali dei Carabinieri, le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza e la Guardia di Finanza erano tenuti ad assicurare ogni necessaria collaborazione. Il generale avrebbe riferito «direttamente al Ministro dell’Interno». Il provvedimento governativo ripristinava insomma, in versione potenziata, il modello che era stato creato nel 1974. La novità del di-
51
In audizione davanti alla Commissione Stragi (1º luglio 1997), Taviani dichiarò: «Una volta catturato Curcio si credette che le Brigate rosse fossero finite. L’assassinio del giudice Coco e della sua scorta si pensò fosse l’ultimo colpo di coda di uomini pronti a rifugiarsi in Paraguay. Invece rimaneva Moretti che sul piano caratteriale valeva assai più di Curcio. Ormai ero fuori dal Governo. Del temperamento di Moretti mi resi conto soltanto in seguito. Dell’ignoranza – diciamo in questo modo – dell’importanza di quest’uomo rispetto all’altro, ossia Curcio, ancora oggi mi creo degli scrupoli – per quanto evidentemente non era compito mio – però nessuno mai mi aveva parlato».
234
La risposta dello Stato ai terrorismi
retto rapporto con il ministro – un’anomalia, sul piano formale, che fu criticata dai più garantisti52 – costituì un elemento di forza, mentre qualche problema derivò dalla congenita dipendenza dalla collaborazione di altri apparati, che non sempre furono solleciti in tal senso o entusiasti di lavorare per un personaggio il cui comportamento, ai loro occhi, aveva forti venature di protagonismo. Dalla Chiesa fece nuovamente leva sulle qualità e sull’abnegazione dei suoi uomini e si dotò di strumenti tecnologici avanzati, tra cui: il computer, il fax, il telefono cellulare53, che la creatività dell’elemento umano seppe sfruttare nel migliore dei modi. Inoltre, avendo intuito l’opportunità di concepire i crimini terroristici non come singoli episodi bensì come manifestazioni di un fenomeno – l’eversione – che non si fermava al loro compimento, i Carabinieri di Dalla Chiesa svilupparono tecniche di indagine volte a sapere tutto il possibile sulle caratteristiche del nemico, basandosi sulla raccolta di dati computerizzata54. Per converso, fu curata attentamente la mimetizzazione, intesa come insieme di accorgimenti tecnici, procedurali e logistici che im-
52 Le perplessità si manifestarono anche nei dibattiti parlamentari. Sul punto, si vedano le pp. 46-47 del libro realizzato dall’allora ministro dell’Interno Virginio Rognoni insieme al giornalista Giuseppe DE CARLI, Intervista sul terrorismo, Laterza, Roma-Bari 1989. L’argomento è toccato pure da MORELLI, Anni di piombo, cit., pp. 24-26. Morelli, inoltre, scrive che «anche i responsabili del Sisde e del Sismi manifestarono poco entusiasmo e lo stesso accadde in seno al Comando dell’Arma dei Carabinieri», i quali non erano stati preventivamente informati e furono colti di sorpresa. 53 Me ne ha parlato il generale Nicolò Bozzo, il quale mi ha concesso un colloquio il 24 aprile 2008, a Genova. Il computer, ricorda Bozzo, permetteva una raccolta e una rielaborazione di dati che prima era impossibile; il fax, la trasmissione in tempo reale di documenti cartacei da ogni parte d’Italia, surclassando in fatto di velocità ogni altra forma di recapito; il telefono cellulare consentiva di chiamare da dovunque ci si trovasse e per di più era difficile da intercettare, a differenza delle comunicazioni radio o da telefono fisso, sulle quali Dalla Chiesa e i suoi uomini temevano di essere vulnerabili. Dalla Chiesa, intorno alla metà degli anni Settanta, aveva ricevuto in regalo un computer dall’industriale De Benedetti. 54 Cfr. ARMENI, La strategia vincente del generale dalla Chiesa, cit. Sui metodi di lavoro di Dalla Chiesa e dei suoi uomini si veda anche P. SAPEGNO e M. VENTURA, Generale. Carlo Alberto dalla Chiesa, un caso aperto, Limina, Arezzo 1997.
235
VLADIMIRO SATTA
pedissero ai brigatisti di riconoscere i loro avversari55. Le risorse finanziarie, che valsero anche a procurarsi confidenti a pagamento, si mantennero tra i 10 e i 20 milioni al mese, una cifra davvero modesta56. I reparti di Dalla Chiesa agivano senza vincoli territoriali sul territorio nazionale, sottoponendosi a veri tour de force, ove necessario. Già il 1º ottobre 1978, a conclusione di una pregevole indagine nata dal ritrovamento di un borsello smarrito su un autobus, furono arrestati numerosi brigatisti – anche di alto livello – e furono espugnati tre loro covi a Milano. In uno di essi, quello di via Monte Nevoso, fu pure trovata (in copia) parte delle lettere e del memoriale scritti da Moro durante il sequestro. Il blitz di Milano accrebbe la popolarità di Dalla Chiesa ma, al tempo stesso, generò forte tensione tra i suoi reparti da un lato, e dal lato opposto la struttura portante dell’Arma, il cui ruolo di supporto era rimasto in ombra57. 55 Dalla Chiesa, audizione in Commissione Moro, 8 ottobre 1980, pp. 244-246. Per motivi di riservatezza, appunto, gli uomini di Dalla Chiesa venivano sostituiti da altri Carabinieri nella firma di atti relativi alle operazioni da loro compiute, di modo da non dover poi comparire in tribunale quando venivano celebrati i corrispondenti processi. E ancora: «I nostri reparti dovevano vivere la stessa vita clandestina delle Brigate rosse. Nessun uomo fece mai capo alle caserme: vennero affittati in modo poco ortodosso gli appartamenti di cui avevamo bisogno, usammo auto con targhe false, telefoni intestati a utenti fantasma, settori logistici ed operativi distanti tra loro. I nostri successi costarono allo Stato meno di 10 milioni al mese» (parole dello stesso Dalla Chiesa, riportate da sito Web Arma dei Carabinieri). 56 E addirittura irrisoria, se paragonata alla spesa per le Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica recate dalla legge 24 dicembre 1979, n. 651: l’articolo 2 di quest’ultima stanziava 85 miliardi per l’anno finanziario 1979 e altri 140 miliardi per l’anno 1980. 57 Si arrivò all’apertura di un’azione disciplinare da parte della Legione Carabinieri di Milano nei confronti del gruppo di Dalla Chiesa. Cfr. N. Bozzo, colloquio con l’autore, e Nei secoli fedele allo Stato cit., p. 141 e pp. 146-148). A proposito del clima di quei giorni, il generale Morelli (cfr. Anni di piombo, cit., p. 107), narra un illuminante aneddoto, databile 10 ottobre 1978 o giorni immediatamente seguenti: «il generale Corsini aveva ricevuto dall’interno dell’Arma alcune pressioni per far cessare le esagerazioni della campagna giornalistica in favore del generale Dalla Chiesa, in cambio di una maggiore esaltazione dell’Arma in generale. Ma non diede ascolto a queste pressioni, anche perché ritenne che la campagna così come combinata, in fin dei conti, aveva ugualmente riflessi psicologici e pro-
236
La risposta dello Stato ai terrorismi
Per non dare esca ad ulteriori contrasti con i comandi locali58, gli uomini di Dalla Chiesa abbandonarono frettolosamente via Monte Nevoso, e fu così che non si accorsero che all’interno di una parete era rimasta occultata una seconda parte di scritti di Moro, poi rinvenuta nell’ottobre 1990 durante una ristrutturazione edilizia. La questione dei rapporti tra Dalla Chiesa e il resto dell’Arma, invero, si trascinò irrisolta fino alla fine, ma fortunatamente senza arrivare a compromettere la vittoria sul terrorismo. Nell’ottobre 1978, comunque, l’operazione milanese rappresentò un’iniezione di fiducia, componente psicologica alla quale Dalla Chiesa annetteva fondamentale importanza. Da allora, i suoi uomini inanellarono altri successi, che non si possono qui menzionare tutti59. In sintesi, si può dire che i progressi degli anni 1978-1979 preannunciarono la vittoria dello Stato, fattasi chiara e definitiva negli anni Ottanta. L’incarico speciale a Dalla Chiesa fu prorogato di un trimestre rispetto alla scadenza prefissata, dopo di che a dicembre del 1979, il generale andò a comandare la Divisione Pastrengo60, come era nei suoi voti61. La decisione di sciogliere il nucleo speciale fu concordata tra Dalla Chiesa e l’autorità governativa, alla quale egli garantì che la lotta contro l’eversione non ne avrebbe risentito62. In effetti, sotto il pagandistici molto positivi per i Carabinieri e quindi si traduceva già in un indubbio vantaggio per l’Istituzione. Anzi, nel corso della colazione, che concluse la sua visita ai reparti di Milano, il generale Corsini accolse con gradimento l’affermazione di Dalla Chiesa che, al levare delle coppe per il brindisi augurale, sostenne che tanta pubblicità sui carabinieri e sul suo nome – alla quale si dichiarava completamente estraneo – serviva come incentivo all’arruolamento dei giovani nell’Arma». 58 Nei secoli fedele allo Stato, cit., p. 141 e pp. 146-148. 59 Si rimanda alle relazioni periodiche stilate da Dalla Chiesa, negli atti della Commissione Moro. 60 Sulla Pastrengo al momento in cui Dalla Chiesa ne assunse il comando, si veda il dossier All’Arma!, «la Repubblica», 22 dicembre 1979. 61 Cfr. l’autobiografia di Carlo Alberto DALLA CHIESA curata da suo figlio Nando, In nome del popolo italiano, Rizzoli, Milano 1997. 62 Sia ROGNONI, Intervista sul terrorismo, cit., p. 73, che Dalla Chiesa (audizione 1980) attestano che l’autorità governativa era più incline del generale a continuare sulla linea tracciata nell’estate 1978, e sciolse il coordinamento solo dietro garanzia, fornita dal comandante, che la lotta al terrorismo potesse andare avanti con altrettanta se non maggiore efficacia.
237
VLADIMIRO SATTA
suo comando la potente Divisione Pastrengo, non soggetta alle difficoltà di rapporti esterni sofferte dal nucleo speciale, si dimostrò capace di incalzare le Brigate rosse come prima e più di prima, con i veterani di Dalla Chiesa spesso in prima linea. Nel frattempo le Br erano entrate irreversibilmente in crisi e quando Dalla Chiesa lasciò la Pastrengo diventando vice-comandante dell’Arma, a fine 1981, ormai il più era fatto. La legislazione dei primi anni Ottanta Il legislatore, dalla seconda metà del 1978 al 1982, mise da parte le precedenti incertezze e considerò decisamente prioritaria la questione della sicurezza. In ambito parlamentare, tale scelta di fondo fu consolidata dal contributo del Pci, maggior partito della sinistra nonché seconda forza parlamentare del paese, che nel 1975 si era opposto alla «legge Reale» e nel 1977 alla Convenzione di Strasburgo ma, negli anni dell’avvicinamento alla Dc, aveva maturato un cambiamento di linea irreversibile e, pertanto, rimase sulle nuove posizioni in materia di antiterrorismo anche quando tornò all’opposizione. Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, e la relativa legge di conversione n. 15 del 6 febbraio 1980 rappresentarono un salto di qualità. Le «finalità terroristiche o di eversione» divennero aggravanti per tutti i reati commessi a quegli scopi e incisero restrittivamente sulla disciplina della libertà personale degli imputati, ad esempio in materia di durata della carcerazione preventiva. Agli organi di polizia fu data facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di effettuare perquisizioni domiciliari anche senza previa autorizzazione del magistrato. Oltre che di repressione, la nuova legge si occupò di prevenzione, introducendo il fermo di sicurezza. La misura – la cui vigenza iniziale era di 12 mesi, e che con una proroga giunse fino a dicembre 1981 – riguardava coloro che fossero in procinto di commettere un reato. Essa veniva decisa ed eseguita dalle forze di polizia, e solo in una seconda fase era sottoposta al vaglio della magistratura. All’epoca, i potenziali effetti del fermo preventivo furono sopravvalutati tanto da chi paventava fossero liberticidi, quanto da chi da esso si attendeva grandi cose63. Dalle relazioni periodiche che per legge il ministro dell’Interno presentava al Parlamento, si evince che nella maggioranza dei casi i 63
Cfr. V. GREVI, Sistema penale e leggi dell’emergenza, cit., p. 44.
238
La risposta dello Stato ai terrorismi
fermi preventivi – alcune centinaia all’anno – consistevano in rapidi accertamenti seguiti dal rilascio ad iniziativa degli stessi soggetti procedenti; per il resto, le convalide in sede giudiziaria, inizialmente poche, si attestarono intorno alla metà dei casi64. Le disposizioni del decretolegge destinate ad avere maggiore impatto, piuttosto, furono le misure premiali in favore dei cosiddetti pentiti, all’articolo 4. I forti sconti di pena per coloro che si fossero distaccati dalle organizzazioni eversive ovvero avessero significativamente collaborato con le autorità ai fini della individuazione e cattura dei loro sodali allettarono numerosi terroristi, rossi e neri65, anche perché si innestarono nel contesto della crisi strategica attraversata dai gruppi armati all’inizio degli anni Ottanta e delle conseguenti crisi esistenziali serpeggianti nell’animo dei militanti con crescente frequenza. Il meccanismo escogitato dal legislatore italiano – alquanto originale, nel panorama internazionale di allora, e più tardi imitato da altri paesi – ebbe un successo perfino superiore alle attese. Pertanto fu poi esteso ad altri settori, cominciando con le bande di sequestratori e proseguendo con la criminalità di stampo mafioso e camorristico. La legge 29 maggio 1982, n. 304, articolo 1, arrivò a dichiarare la non punibilità dei terroristi che (prima di sentenza definitiva di condanna) avessero determinato lo scioglimento della banda armata, o ne fossero usciti fornendo agli inquirenti informazioni sensibili (non importava se nuove o meno), o avessero bloccato il compimento di delitti, delimitando tuttavia il perimetro a coloro che nella militanza si fossero macchiati di «reati quasi “inevitabili” […] concernenti armi, munizioni o esplosivi, reati di falso documentale o personale, reati di apologia o istigazione, ricettazioni» ma non di «ferimenti, omicidi, danneggiamenti, sequestri»66. Gli articoli 2 e 3 prevedevano sostituzioni di ergastoli con pene minori per coloro che tenevano compor64
Dati contenuti ed illustrati nelle suddette relazioni periodiche, documentazione della serie contrassegnata dal numero romano LXV. 65 In un’intervista del quotidiano «l’Unità» all’onorevole Luciano Violante, datata 30 gennaio 1983, appare la cifra di 360 soggetti collaborativi ed altri 77 «incerti». I dissociati dalla lotta armata che però non contribuivano ad estirparla erano 378. Qualcuno aveva anche ritrattato; fra “pentiti” e “dissociati”, il totale era di 45 casi. 66 Le delucidazioni tra virgolette sono tratte da una monografia del magistrato Guido SALVINI, La legge sui terroristi pentiti. Un primo bilancio, Unicopli, Milano 1983, p. 13.
239
VLADIMIRO SATTA
tamenti collaborativi, mentre il 6, il 7 e l’8 vertevano su concessioni di libertà provvisoria, sospensioni condizionali e liberazioni condizionali. La nuova norma, in sostanza, perfezionò e potenziò lo strumento premiale, che già da prima aveva iniziato a fare breccia67. La precedente legge n. 15/1980, attaccata da alcuni politici e giuristi, superò due prove: il referendum abrogativo promosso dai radicali, con una schiacciante maggioranza dell’85,1%; ed il giudizio della Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 14 gennaio 1982 stabilì che non era «irragionevole» l’allungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva tendente a fronteggiare «una situazione anomala ed eccezionale», purché la disposizione fosse «essenzialmente temporanea» e dunque fosse modificata al venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito l’adozione. Infine, non bisogna trascurare gli aumenti degli stanziamenti in favore delle forze di polizia (legge n. 651/1979) e la legge di riforma della polizia stessa (n. 121/1981) che, sia pure in misura non esattamente determinabile, sicuramente contribuirono al miglioramento complessivo della situazione. Periodizzazione e bilanci Venendo alle conclusioni, possiamo periodizzare l’intera vicenda della repressione dei terrorismi in Italia – che divamparono per cause indipendenti dal livello delle libertà civili e politiche del paese, dalle reali opportunità di cambiamento al suo interno, e non sono riducibili ad un riflesso irrazionale scattato all’indomani della strage di Piazza Fontana – delineando tre fasi: la prima, dal 1970 alla prima metà del 1974, caratterizzata da impreparazione degli apparati, arretratezza della normativa e sostanziale inerzia da parte del legislatore; la seconda fase, dalla metà del 1974 ai primi del 1978, segnata da interventi rilevanti ma ondivaghi, per certi aspetti persino contraddittori e, comunque, non sempre positivi nel breve termine, che interessarono sia l’assetto degli apparati repressivi, sia la normativa sull’ordine pubblico 67
Anche la normativa premiale incontrò qualche resistenza, ma stavolta non da parte dei “garantisti” alcuni dei quali (ad esempio Rodotà e Neppi Modona) anzi criticarono due collegi giudicanti di Roma e Bergamo per non averne tenuto conto adeguatamente. Cfr. G. SALVINI, La legge sui terroristi pentiti, cit., pp. 3-4. L’autore si schierava a favore della legislazione da poco introdotta.
240
La risposta dello Stato ai terrorismi
e sugli spazi di libertà dei cittadini e le relative garanzie; una terza fase, dal dopo Moro in poi, nella quale maturò la vittoria dello Stato grazie al concorso di molteplici fattori, fra i quali sono di primario rilievo la ricostituzione in versione rafforzata dei nuclei antiterrorismo dei Carabinieri e la legislazione che incoraggiò il cosiddetto pentitismo. Anche i risultati dell’attività repressiva contro i diversi aggressori sono stati difformi. I migliori sono stati conseguiti contro il terrorismo rosso, i cui militanti sono stati arrestati in massa e condannati, e contro lo spontaneismo armato nero comparso nella seconda metà degli anni Settanta. Non altrettanto con lo stragismo: quest’ultimo cessò, ma quasi tutti gli stragisti la fecero franca. Lo stragismo, obiettivamente, era più sfuggente, perché rinunciando a rivendicare gli attentati e a coltivare un radicamento sociale si rendeva meno esposto del terrorismo rosso; inoltre la destra eversiva usufruì di qualche protezione, attestata da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente. È da ritenere quindi che l’esaurimento dello stragismo sia stato determinato non tanto dall’azione delle forze di polizia e dei servizi segreti ma piuttosto dal fallimento degli obiettivi politici che esso perseguiva, nonché dallo scioglimento di un paio di organizzazioni neofasciste – il Movimento Politico Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale – disposto dal Governo rispettivamente nel 1973 e nel 197668. Sapremo forse qualcosa di più sullo stragismo nel 2015 allorché, ai sensi della legge n. 124 del 2007, scadrà il termine ultimo del segreto di Stato opposto nel 1985 dal presidente del Consiglio Bettino Craxi alla magistratura fiorentina che indagava sul neofascista toscano Augusto Cauchi ed altri. 68
L’allora ministro dell’Interno Taviani, rievocando lo scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo, ebbe cura di puntualizzare che, a rigore, non si trattava di atto dovuto, in quanto il provvedimento fu preso dopo una condanna giudiziaria in primo grado (per il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista) e non di una sentenza definitiva. Pertanto, fu un gesto politicamente mirato e significativo (cfr. P.E. TAVIANI, Politica a memoria d’uomo, Il Mulino, Bologna 2002. Le memorie di Taviani furono edite postume, per volontà dell’interessato). Sull’intera area della destra extraparlamentare, in generale, si veda F. FERRARESI, Minacce alla democrazia, cit. Ulteriori pregevoli contributi, ad opera dello stesso Ferraresi e del magistrato Rosario Minna, sono pubblicati nel volume Terrorismi in Italia, a cura di D. Della Porta, Il Mulino, Bologna 1984.
241
VLADIMIRO SATTA
La forte sensazione di inadeguatezza, in alcune fasi, trasmessa da forze di polizia e servizi segreti ai cittadini, presso una vasta area di opinione pubblica si mescolava al sospetto che gli apparati statali fossero complici o addirittura i veri mandanti dei terrorismi, sommariamente unificato sotto la fortunata etichetta giornalistica di “strategia della tensione”. Una moderna variante storiografica, detta dello stop and go, postula che nei confronti degli eversori i governanti abbiano intenzionalmente alternato periodi di repressione ad altri di libertà di insanguinare l’Italia, allo scopo di ricavarne benefici elettorali per i moderati e frenare la sinistra (senza riuscirci, peraltro)69. Che vi fossero carenze organizzative è una valutazione condivisa da tutti, e che di per sé non quadra con la tesi dello stop and go, poiché una strategia siffatta avrebbe eventualmente puntato su una guida volutamente sbagliata degli apparati antiterroristici, mantenendoli però in buona efficienza potenziale proprio per poter alternare i due comandi a seconda delle convenienze. È significativo, inoltre, che i migliori servitori dello Stato – i Dalla Chiesa, i Santillo e via dicendo – non ebbero affatto l’impressione che altri stessero praticando uno stop and go doloso, e non riferirono nulla del genere quando furono interpellati dall’inquirente parlamentare o in altre sedi70. Politicamente, poi, è stato obiettato ai teorici dello stop and go che una disastrosa situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza fa perdere e non guadagnare voti ai partiti che ne sono responsabili, tanto più se di area moderata, e dunque neppure il più machiavellico dei governanti avrebbe azzardato un tentativo di questo tipo71. Comparativamente, si rileva che in Germania dagli anni Settanta ai Novanta le attività eversive furono molto più discontinue che in Italia, ma nessuno ha insinuato che la loro periodica ripresa dopo le interruzioni imposte dalla repressione fosse voluta dalle autorità tedesche. In definitiva, l’al-
69
Il padre della teoria dello stop and go è il politologo Giorgio Galli. Nel 2008, al menzionato convegno Protesta sociale e violenza politica in Italia e nella Germania federale negli anni ’60 e ’70 del Novecento, la tesi del sabotaggio è stata per l’ennesima volta smentita da uno dei magistrati maggiormente impegnati nell’antiterrorismo, Gian Carlo Caselli. Per Caselli, nella lotta all’eversione vi furono incertezze, confusione, errori, ma non doppio gioco da parte delle istituzioni. 71 Osservazione dell’ex-ministro dell’Interno, il democristiano Virginio ROGNONI, Intervista sul terrorismo, cit., p. 36. 70
242
La risposta dello Stato ai terrorismi
ternanza di successi e insuccessi rientra nella normalità delle vicende umane, ivi comprese le attività di polizia e di intelligence. Le politiche antiterroristiche furono molto più di natura reattiva che preventiva. La prevenzione è comunemente ritenuta efficace – in questo come in altri contesti – ma raramente praticata, perché assorbe impegno e risorse che spesso si preferisce impiegare in altra maniera, finché si può. Nel caso del terrorismo, probabilmente, la prevenzione avrebbe comportato pure un altro ordine di costi: la restrizione delle libertà. Infatti, poiché gli eversori erano aggressori nei confronti di un paese democratico, non si sarebbe trattato di rimuovere ingiustizie e oppressioni, che non c’entravano con le insorgenze terroristiche, bensì di aumentare il controllo sociale da parte delle autorità. Una società democratica posta sotto attacco da elementi antidemocratici con mezzi violenti può trovarsi, purtroppo, nella necessità di limitare l’esercizio di taluni diritti al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza. In tal caso, il principio cui essa deve attenersi per non snaturarsi diventa l’instaurazione di una equa proporzionalità tra le misure adottate e gli scopi da raggiungere72. In Italia, l’emergenza legittimò norme e trattamenti giuridici di eccezione che non scalfirono la triade composta da libertà di espressione, pluralismo politico e libere elezioni la quale rappresenta una sorta di “nucleo duro” delle democrazie73. Anzi, la legislazione italiana di emergenza si mantenne più blanda che in altri paesi, quali la Germania Occidentale, dove il terrorismo era meno radicato nel tessuto sociale e in fondo meno pericoloso74. L’auspicio è che di fronte alle minacce del terrorismo internazionale dei nostri giorni l’Italia, oltre a difendersi efficacemente, riesca a salvaguardare le conquiste democratiche istituzionalizzate nel nostro ordinamento. 72
A p. 302 della monografia Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche (Il Mulino, Bologna 2006), Paolo BONETTI ha osservato che tali criteri si rinvengono diffusamente sia nella normazione costituzionale, legislativa ed internazionale, sia nella giurisprudenza costituzionale ed internazionale. 73 Si veda di nuovo P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, cit., a p. 303. 74 In attesa della pubblicazione degli atti del convegno Protesta sociale e violenza politica, per un accurato confronto tra il caso italiano e il caso tedesco si veda: M. TOLOMELLI, Terrorismo e società. Il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta, Il Mulino, Bologna 2006.
243
IL DELITTO MORO E LA TEORIA COMUNISTA DELL’«EVERSIONE ATLANTICA» Salvatore Sechi*
Nel suo recente libro1, Giuseppe De Lutiis offre i risultati di pazienti e appassionate ricerche, in corso ormai da molti anni, sul principale delitto politico dell’Italia repubblicana, quello del presidente della Dc Aldo Moro. Ma esso è anche una summula, nel bene e nel male, dei pochi studi non propriamente storiografici che attingono a fonti come quelle dei tribunali, delle commissioni parlamentari di inchiesta e dei servizi di intelligence. Si tratta di archivi poco usati dagli storici, e costituiscono non di rado l’occasione per distorcere e inquinare le più antiche regole del mestiere storiografico (da Johann G. Droysen a Delio Cantimori). Infatti, la loro utilizzazione incauta o spregiudicata, a fini di propaganda politica o di sovra-esposizione mediatica, consapevolmente o meno, molto spesso ha trasformato i magistrati in storici e i secondi (quando diventano consulenti di tribunali, di organi del parlamento ecc.) nei primi. Di qui la tumultuosa confusione dei ruoli e delle competenze oggi imperante, e il giustapporsi di studi in cui le fonti sono di origine diversa2.
* Desidero ringraziare Fernando Orlandi per avere ospitato una prima versione di questo lavoro come CSSEO Working Paper n. 133, marzo 2008. 1
G. DE LUTIIS, Il golpe di via Fani. Protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro, Sperling & Kupfer, Milano 2007. Per un’analisi assai diversa, in cui viene privilegiata l’origine dal proletariato industriale delle Brigate rosse, cfr. M. CLEMENTI, Storia delle Brigate rosse, Odradek, Roma 2008. 2 A volte il risultato è un’impietosa rivisitazione delle istruttorie e delle inchieste parlamentari, dei misteri e degli intrighi, come nelle recentissime, e assai utili, pagine di F. IMPOSIMATO e S. PROVVISIONATO, Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il giudice dell’inchiesta racconta, Chiarelettere, Milano 2008. Anche dall’uso della saggistica e dalle fonti a stampa è possibile trarre risultati molto interessanti come dimostrano D. Della Porta, a cura di, Terrorismi di sinistra, Il Mulino, Bo-
245
SALVATORE SECHI
Mi limiterò, in questa analisi critica dell’ultimo lavoro di De Lutiis, a rilevare alcune questioni sulle quali non concordo o che meritavano di essere affrontate con maggiore approfondimento. Desidero, però, premettere, per relativizzare le mie osservazioni e quindi mitigare i rilievi che muovo a De Lutiis e ad altri studiosi, che non esiste nulla di provabile nel senso che il rinvenimento di archivi o di documenti può mandare all’aria una certezza acquisita. Non esiste la prova assoluta di tutto, ma solo una relativa probabilità. Non solo per gli archeologi3 e i magistrati, ma anche per gli storici deve valere il principio epistemologico di Karl Popper secondo cui il lavoro di ricerca è un mondo di ipotesi. Le congetture che vanno bene, cioè funzionano, finché non si dispone di una congettura migliore, più affidabile, che sia in grado di demolire quella precedente. Grazie all’estesa attività di consulente parlamentare, De Lutiis ha potuto svolgere ricerche finora impossibili a qualunque altro studioso, come l’accesso ad archivi (anche riservati) dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dei servizi segreti, oltreché dei tribunali. Nell’espletamento di questi mandati, la legge prevede l’esercizio dei poteri del magistrato inquirente. Pertanto, egli, al pari del collega Aldo Giannuli, ha potuto entrare (ed uscire da) tutti gli archivi, pubblici e privati, riservati e no, del nostro paese. Dunque, nessuno più di loro ha visto, e accumulato, carte, numerosissime e preziose, sui principali misteri e vicende del periodo repubblicano. Come sanno gli storici, archivi e documenti restano muti, se non li si sa interrogare. Occorre saper fare le domande giuste, essere curiosi, privi di certezze o disposti a mettere in discussione e, se è necessario, ripudiare le stesse chiavi di lettura con cui si parte, inevitabilmente, all’inizio di ogni ricerca.
logna 1984 (in particolare il saggio in collaborazione col giudice G. Caselli, La storia delle Brigate rosse: strutture organizzative e strategie d’azione) e R. DRAKE, Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1989, al quale farà seguito The Aldo Moro Murder Case, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1995 (tr. it. Il caso Aldo Moro. Una tragedia italiana vista da uno storico americano, Tropea, Milano 1996). 3 Rimando a uno studioso della storia antica come Andrea CARANDINI, Nel subconscio di Roma, come Freud, intervista concessa a Maurizio Assalto, «La Stampa», inserto “TuttoLibri”, 14 febbraio 2009, p. XI.
246
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Senza questo atteggiamento di ripulsa nei confronti del principio di autorità e quindi di grande, continua apertura, i faldoni o le miscellanee restano senza voce o trascinano in una voragine senza fine. È un pericolo gravissimo soprattutto per chi si occupa di storia contemporanea (un periodo su cui le fonti sono assai numerose) con la volontà di capire l’itinerario che ci ha condotto al presente, a ciò che oggi siamo4. Chi non sa fare queste domande o, peggio, non ha alcuna intenzione di formularle, invece di preoccuparsi del giudizio storico è condannato ad accontentarsi di qualcosa di diverso, cioè del pregiudizio. Ne rilevo due. Il primo è quello fiorito e sviluppato dal Pci secondo cui i terroristi sarebbero stati manovrati, in funzione anti-Pci e anti-Dc, dalle solite oscure forze della reazione che, insieme ai socialisti di Bettino Craxi e ai radicali, avrebbero coperto e protetto le Brigate rosse. Per usare il linguaggio e le analisi retrò (da classico uomo della Terza Internazionale) di Antonio Tatò, il principale collaboratore di Enrico Berlinguer, si tratta di una «zona, non ancora individuata (sic!), del potere economico e finanziario, dell’apparato statale, della magistratura, dei servizi segreti, degli alti comandi della Difesa e degli Interni»5. Sul punto, dentro il Pci, non c’era uniformità di vedute. Infatti, mentre Berlinguer, il 9 ottobre 1980, durante l’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta su via Fani, respingerà il metodo di evocare complotti e immaginare la regia di un “Grande vecchio” che avrebbe tenuto le fila della politica italiana6, «l’Unità» parlava dei brigatisti come di «un pugno di fanatici, manovrati da forze che stanno molto in alto, probabilmente anche al di fuori del nostro paese» (corsivo mio)7. Credo che l’opinione prevalente corrisponda, ieri e oggi, a quella dell’organo del partito. 4
Si vedano le recenti riflessioni di C. PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007. 5 Si vedano le note e gli appunti riservati di A. TATÒ ad Enrico Berlinguer negli anni 1969-1984, Caro Berlinguer, Einaudi, Torino 2003. 6 Si vedano gli Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, vol. V (1984), Stenografici delle sedute dal 1º agosto al 6 novembre 1980, pp. 349-390. 7 Si veda l’editoriale, non firmato, Un uomo torturato, «l’Unità», 19 marzo 1978.
247
SALVATORE SECHI
Basta pensare al fatto che il giorno stesso in cui Moro venne sequestrato la Direzione nazionale comunista, dichiarando che l’obiettivo delle Br era di stroncare la politica del Pci e la formazione di una nuova maggioranza in parlamento, denuncia l’esistenza di un vasto complotto, organizzato sia all’interno del paese sia all’esterno. Si dava così avvio alla saggistica di impostazione “cospiratoria” che sarebbe seguita: la congiura è di ampie dimensioni, si sviluppa con metodi nazifascisti, e trova i suoi esecutori in raggruppamenti mascherati sotto vari nomi. L’unità delle masse lavoratrici e popolari, di tutte le forze democratiche, sconfiggerà i piani della reazione interna e internazionale8.
A contrastare, senza molto successo, questa cultura del complotto furono un giovane dirigente della federazione comunista di Torino, Giuliano Ferrara9, e due autorevoli dirigenti come Giorgio Amendola e Paolo Bufalini, in sede di Direzione nazionale e di Comitato centrale del Pci. Non molto lontana da questa posizione, mai sconfessata, sul ruolo delle cosiddette “centrali reazionarie”, anzi di essa è un’esplicitazione coerente, appare essere la teoria dell’“eversione atlantica”. Riprendo il termine dal titolo di un saggio di due giornalisti, i fratelli Cipriani10. Il concetto si trova, però, al centro dei numerosi saggi (pubblicati dagli editori Kaos, Bovolenta, Editori Riuniti) dell’ex parlamentare comunista Sergio Flamigni e del giornalista Gianni Flamini. Ad essi si deve un’imponente raccolta di materiale documentario, ma anche grande sollecitudine nel mettere in ombra, sottovalutare ecc. ogni traccia che portasse al Kgb o all’Stb (il servizio segreto ceco-
8
In data 17 marzo l’organo del Pci pubblica in prima pagina il testo di questa che è la prima presa di posizione del partito sulla vicenda Moro. Per un’analisi di supporto seguita, nei lavori successivi, da uno sforzo di rielaborazione dell’influenza dei poteri occulti nella storia della Repubblica rimando ai due studi di F. BISCIONE, Il delitto Moro. Strategie di un assassinio politico, Editori Riuniti, Roma 1998 e Il sommerso della repubblica, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 9 Giuliano FERRARA, Il terrorismo non è soltanto complotto, «l’Unità», 21 marzo 1978. Ma un altro torinese, U. PECCHIOLI, insistette a dire che il terrorismo era «sfuggito ai gruppi più pericolosi della reazione italiana ed internazionale» (Le novità del terrorismo, «l’Unità», 6 aprile 1978). 10 A. CIPRIANI e G. CIPRIANI, Sovranità limitata. Storia dell’eversione atlantica in Italia, Edizioni Associate, Milano 1991.
248
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
slovacco)11, mentre hanno valorizzato oltre ogni limite tutta la documentazione che potesse coinvolgere a Cia, i servizi occidentali e israeliani12. Dal pregiudizio anti-americano e anti-occidentale, se posso usare questa formula, sono ampiamente influenzati anche i precedenti lavori dello stesso maggiore esperto italiano, Giuseppe De Lutiis13. Che egli non si trovi in uno stato di solitudine interpretativa lo dimostra il fatto che la maggioranza assoluta degli studiosi di storia contemporanea (notoriamente orientati verso posizioni politiche di sinistra), ha fatto propria, direi in misura ossessiva, la certezza, anche se priva di convincenti elementi di prova, che sia esistita una sorta di regia internazionale, di natura imperialistica e quindi statunitense. Combinandosi con i grandi interessi capitalistici nazionali, l’Italia sa11
Per uno sguardo d’assieme, si veda P. BLAŽEK, P. ŽÁCˇ EK, Czechoslovakia, in A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe, 1944-1989, a cura di Krzysztof Persak, Łukasz Kami´nski, Institute of National Remembrance, Varsavia 2005, pp. 87-161, e la bibliografia citata. 12 Qualche ripensamento si scorge nell’ultimo tomo dell’opera di G. FLAMINI, L’amico americano. Presenze e interferenze straniere nel terrorismo in Italia, Roma, Editori Riuniti, 2005. Un aspetto della battaglia condotta da lui quanto da S. FLAMIGNI per sostenere la manipolazione delle Br ad opera dei servizi segreti è stato colto efficacemente da A. CARIOTI (Moro, la vulgata contro la storia, «Ideazione», a. 10, n. 3, maggio-giugno 2003), quando ha ricordato come il Comintern aveva trattato i seguaci di Lev Trockij. Molto più sensibile, invece, anche se resta ancora una petizione di principio, la correzione analitica di G. CIPRIANI, Storia dello spionaggio in Italia dal dopoguerra ad oggi, Sperling & Kupfer, Milano 2002. Ma c’è anche chi si tiene mille miglia lontano da queste teorie cospirative. Penso a uno storico come A. GIOVAGNOLI, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, Bologna 2005, e a un inviato del «Corriere della Sera», che ha ripercorso con grande equilibrio e minuziosamente un’enorme mole di documenti e interrogato numerosi testimoni dei 55 giorni di prigionia. Mi riferisco a G. BIANCONI, Eseguendo la sentenza. Roma 1978. Dietro le quinte del sequestro Moro, Einaudi, Torino 2008. Sui limiti delle dietrologie, delle trame e delle regie occulte fiorite sull’affaire Moro si sofferma ampiamente e con affilato vigore contestatorio V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. 13 G. DE LUTIIS, Storia dei servizi segreti, Editori Riuniti, Roma 1984; Id., Il lato oscuro del potere, Editori Riuniti, Roma 1996. Sulla stessa linea si muove G. GALLI, Piombo rosso, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004.
249
SALVATORE SECHI
rebbe stata tenuta in stato di soggezione, e avrebbe visto minate la propria indipendenza e libertà. Questa teoria si fonderebbe su due paradigmi: 1. Il funzionamento del sistema politico-istituzionale dell’Italia repubblicana come una democrazia parziale, incompiuta, a sovranità limitata. Questa mutilazione sarebbe scolpita, resa visibile, nella filiera di obblighi che, grazie al “doppio Stato”, legano ogni cittadino a molteplici appartenenze. Proprio in seguito all’assassinio di Moro si avvertirà l’evidente riavvicinamento tra i diversi piani che nel dopoguerra hanno rappresentato il doppio stato che ha esercitato il governo reale e quello formale in Italia. Nel 1991 saranno definiti tutti patrioti e fedeli servitori dello stato quei personaggi che, stando a ciò che sostengono la costituzione e il codice penale, potrebbero essere dichiarati cospiratori, golpisti, talvolta anche assassini. In realtà erano solamente leali a uno stato diverso da quello formale. Quello che, però, ha esercitato il potere reale14.
2. L’attribuzione alla Nato, ai governi occidentali, manipolati o guidati dall’intelligence soprattutto degli Stati Uniti, la regia di delitti e terremoti politici, forme di destabilizzazione, colpi di Stato, tensioni nei rapporti tra i paesi, con particolare insistenza sull’Italia assunta come cavia o vittima consenziente ecc15. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (1979-1983), venne istituita il 23 novembre 1979, e ultimerà i suoi la14
Rimando a quanto scrivono, senza remore, A. CIPRIANI e G. CIPRIANI, Sovranità limita, cit., p. 312. 15 Il giudizio è figlio dell’idea che i governi di centro in Italia siano stati non solo foschi, ma addirittura «il fascismo-che-torna», secondo le irresponsabili formule agitatorie del Pci pedissequamente riecheggiate da intellettuali-da-regime-interno e da “compagni di strada”. Si veda quanto scrivono N. TRANFAGLIA, La modernità squilibrata. Dalla crisi del centrismo al compromesso storico, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. 2, t. 2, Einaudi, Torino 1995, pp. 7-114; Id., Un capitolo del ‘doppio stato’. La stagione delle stragi e dei terrorismi, in Idem, vol. 3, t. 2; e M.G. ROSSI, Una democrazia a rischio. Politica e conflitto sociale negli anni della guerra fredda, vol. 1, La costruzione della democrazia, Einaudi, Torino 1994; P. COOKE, Tambroni e la repressione fallita, Teti, Milano 2000.
250
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
vori, dopo diverse proroghe, il 29 giugno 1983 con l’approvazione del testo della Relazione di maggioranza16 presentato dal presidente, senatore Mario Valiante. A firmarla sono in pratica17 gli esponenti dei partiti della “fermezza” al tempo del sequestro Moro, e da essi viene accolta la tesi del carattere pienamente indigeno del terrorismo e si respinge la teoria del complotto con regia straniera18. Va però detto come in seno a questo organo dura a morire fu l’idea di una sorta di Kombinat tra l’eversione interna e quella internazionale, di origine “atlantica”. L’analisi e la campagna in questa direzione montata da «l’Unità» e dai maggiori leader verrà assecondata in sede parlamentare. Non diverso sarà l’atteggiamento della minoranza (di sinistra) in seno alla Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il “dossier Mitrokhin” e l’attività d’intelligence italiana. Istituita il 7 maggio 2002 e sciolta il 15 marzo 2006 presentò quattro relazioni. Rossi anche di recente è tornato sull’argomento in La costituzione ha resistito, «Italia Contemporanea», n. 247 (giugno 2007), p. 217. La togliattesca identificazione della Dc col fascismo ha suscitato il sarcastico commento di un agguerrito ricercatore, membro, al pari di Mario G. Rossi, della Società italiana degli storici contemporaneisti (la Sissco), Andrea ROSSI, La Dc: il cassonetto della storia, nel suo blog (http://orientamentistorici.blogspot.com/) su Internet ripreso da Giovanni BELARDELLI, «Corriere della Sera», 12 gennaio 2008. 16 La minoranza presenterà 5 relazioni e rappresentavano Psi, Msi-Dn, Pr, Pli e indipendenti di sinistra. Ad essa sono seguite due altre Commissioni sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l’individuazione dei responsabili delle stragi (dall’ottobre 1986 all’aprile 1987, e dal 17 maggio 1988 al 22 marzo 2001). 17 Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, comunicata alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983, Roma 1983, costituisce il vol. I degli atti della stessa Commissione, Doc. XXIII, n. 5. Insieme ad altri materiali è stata pubblicata anche nel volume Dossier delitto Moro, a cura di S. Flamigni, Kaos, Milano 2007, pp. 57-313. 18 Sulla natura indigena del terrorismo italiano si veda la sopra citata relazione di maggioranza (p. 151) e l’atteggiamento di Luciano Violante, in particolare. Da molti anni sostiene che «sia il terrorismo nero che quello rosso nascono per ragioni politiche che sono italiane, non frutto di complotti diabolici». Cfr. L. VIOLANTE, Politica della sicurezza, relazioni internazionali e terrorismo, saggio pubblicato in AA.VV., La prova delle armi, a cura di G. Pasquino, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 97-98.
251
SALVATORE SECHI
Siamo ormai a qualcosa di simile alle calende greche, ma agli studiosi, anche quando è permesso l’accesso ai documenti raccolti e formati dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta sulla strage di via Fani, sulla loggia massonica P2 e sul “dossier Mitrokhin”, consultabili presso l’Archivio storico del Senato e in parte anche on-line, si oppone un cilicio micidiale. È stato, infatti, preservato l’originario vincolo di secretazione dei documenti, apposto dagli enti erogatori delle carte. È una decisione semplicemente irresponsabile (almeno dal punto di vista delle esigenze degli studiosi) dei membri delle commissioni parlamentari d’inchiesta. Proteste dei docenti e ricercatori, interpellanze parlamentari e richieste di liberalizzazione avanzate ai presidenti delle due assemblee elettive sono rimaste senza risposta o hanno ribadito l’occasione per fruste spiegazioni burocratiche. Il governo Berlusconi non dà segni, almeno finora, di attuare una discontinuità con quello presieduto da Prodi. Il progresso degli studi storici, già reso scarno e non molto affidabile dalla scarsità delle fonti (sono disponibili, e anche parzialmente, solo quelle di polizia), non sembra interessare proprio a nessun esponente del ceto politico. In qualche autore l’esposizione della teoria che scarica ogni onere relativo al malfunzionamento della democrazia in Italia sulle mene (che si ritiene) ordite dalla Nato e dalla Cia, si presenta combinato con un sentimento di esecrazione e di auto-flagellazione. Una storiografia da parti pris Ciò avviene quando, come nel caso degli studi (precedenti l’ultimo) di De Lutiis, Sergio Flamigni, Gianni Flamini, Giorgio Galli, Aldo Giannuli, Mario G. Rossi, Nicola Tranfaglia19 e in generale nella storiografia comunista che ha dominato, e domina, la storia contemporanea, si è rappresentata l’Italia repubblicana come una sorta di teatro dei pupi in cui alcune superpotenze (Stati Uniti, Urss e Gran Bretagna), ridotte a puppeters (burattinai muniti di un immenso e sinistro potere di 19
La bibliografia è estesa. Mi limito a ricordare: F. BISCIONE, Il delitto Moro, cit.; Id., Il sommerso della repubblica, cit.; G. CALVI e F. LAURENT, Piazza Fontana, Mondadori, Milano 1997; Ustica, la via dell’ombra, a cura di F. Cardini, Sapere 2000, Roma 1990; P. CUCCHIARELLI e A. GIANNULI, Lo Stato parallelo. L’Italia ‘oscura’ nei documenti e nelle relazioni della Commissione stragi, Gamberetti, Roma
252
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
condizionamento) avrebbero mosso, e continuerebbero a muovere, le fila della politica interna e di quella internazionale20. È una visione che ha una propria utilità. Infatti, serve ad assolvere i nostri partiti e leader, esonerandoli da ogni responsabilità per le decisioni prese, in quanto le conseguenze che ne sono derivate vengono messe a carico delle autorità anglo-americane di occupazione prima e delle principali potenze alleate successivamente21. Come mostrerò più avanti, questa vulgata non tiene conto di alcune importanti circostanze. Oltre ad essere un paese vinto, l’Italia ha pagato il prezzo di essere stata particolarmente solerte nello sfilarsi 1997; La strage di stato. Vent’anni dopo, a cura di G. De Palo e A. Giannuli, Edizioni associate, Roma 1989; S. FLAMIGNI, La tela del ragno. Il delitto Moro, 5ª ed. aggiornata, Kaos, Milano 2003 (1ª ed., Edizioni Associate, Roma 1988); Id., I fantasmi del passato, Kaos, Milano 2001; Id., Convergenze parallele, Kaos, Milano 1998; Id., La sfinge delle Brigate rosse, Kaos, Milano 2004; Id., Trame atlantiche. Storia della Loggia massonica segreta P2, Kaos, Milano 1996 (2ª ed. 2005); Id., Le idi di marzo. Il delitto Moro secondo Mino Pecorelli, Kaos, Milano 2006 ecc.; G. FLAMINI, Il partito del golpe. Le strategie della tensione e del terrore dal primo centro-sinistra organico al sequestro Moro [1964-1978], 4 voll. in 6 tomi, Bovolenta, Ferrara 1981-1985; G. GALLI, Affari di Stato 1943-1990, Kaos, Milano 2001; Id., La regia occulta, Marco Tropea, Roma 1996; S. PROVVISIONATO, Misteri d’Italia. Cinquant’anni di trame e delitti senza colpevole, Laterza, Bari-Roma 1993; U. SANTINO, La democrazia bloccata. La strage di Portella della Ginestra e l’emarginazione delle sinistre, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997; di trame e misteri si occupano N. TRANFAGLIA, Perché la mafia ha vinto, Utet, Torino 2008 e Id., in collaborazione con D. NOVELLI, Vite sospese, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007. 20 Rimando, per una valutazione critica, a Giovanni SABBATUCCI, Il golpe in agguato e il doppio Stato, in Giovanni BELARDELLI et al., Miti e storia dell’Italia unita, Bologna, Il Mulino 1999; e a Vladimiro SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit., in particolare, nelle pp. 407-439, Satta contesta le tesi avanzate, tra gli altri, da Francesco Biscione, Paolo Cucchiarelli, Aldo Sabino Giannuli, Giovanni Pellegrino, Antonio Tatò e Nicola Tranfaglia. Il carattere autoctono del terrorismo brigatista è stato ribadito nel recente saggio I collegamenti internazionali del terrorismo rosso italiano, «Nuova Storia Contemporanea», a. XI, n. 6 (novembre-dicembre 2007), pp. 23-52, anche in polemica con la rassegna di studi di un giovane studioso (Roberto BARTALI, Le Brigate rosse, una storia della guerra fredda, «Nuova Storia Contemporanea», a. X, n. 6, novembre-dicembre 2006, pp. 37-56). 21 Si veda, sul punto Ennio DI NOLFO, Sistema internazionale e sistema politico italiano: interazione e compatibilità, in La crisi italiana, vol. 1, Formazione del regime repubblicano e società civile, a cura di Luigi Graziano e Sidney Tarrow, Einaudi, Torino 1979, p. 103.
253
SALVATORE SECHI
dall’alleanza con Hitler, alimentando un giudizio assai condiviso di inaffidabilità, anzi di vera e propria impostura. Fiorito durante la prima guerra mondiale, il sospetto di propensione al doppiogioco ebbe modo di manifestarsi anche nel corso della seconda22. In secondo luogo, l’Italia venne liberata da una coalizione di forze tra le quali, accanto a quelle liberal-democratiche, ci fu, però, un partito comunista fermamente ostile ai principi e alle istituzioni dello Stato di diritto, anche se li accettò e contribuì a codificarli sous reserve. Era, e restò a lungo, legato ad una potenza straniera ed avversa come l’Urss, che esercitò un condizionamento sull’intero dopoguerra. In terzo luogo, il trattato di pace e l’adesione alla comunità atlantica non ebbero, nel paese, un consenso corale, ma furono scelte fatte in mezzo a contestazioni ed asprezze. In parlamento e nelle piazze si cercò di mascherare, o allentare, questa appartenenza alla cultura (e alla civiltà) occidentale con manifestazioni di natura neutralistica, terzomondista ecc. Progressivamente l’Italia più che dispensare lealtà atlantica finì per essere un fornitore di spazi territoriali per basi militari, missili atomici, sottomarini a testate nucleari ecc.23. Non ultimo, né minore, fu il peso esercitato dall’argomento della nostra scarsa o nulla auto-sufficienza, sia sul piano alimentare e in generale economico, sia militare, e l’insistente indecorosa richiesta (anche da parte del Pci) di potere conservare una parte del vecchio bottino coloniale. In queste condizioni non si poteva pretendere che al nostro paese venisse riconosciuto un regime di grande sovranità e di autonomia. A contribuire all’idea di un paese in preda a conati golpisti, prigioniero di manovre di destabilizzazione, disegni di conservazione dei servizi segreti anglo-americani fu la potente ed efficace macchina della propaganda creata da Stalin e adattata dal Pci all’Italia. La si può trovare consacrata in alcuni pamphlet24, che si ammantano di una ma22 Rimando alle considerazioni di Roberto VIVARELLI, I caratteri dell’età contemporanea, Il Mulino, Bologna 2005; e alla sua introduzione all’edizione italiana di Wolfgang SCHIVELBUSCH, La cultura dei vinti, Il Mulino, Bologna 2006. 23 S. ROMANO, L’Italia tra geopolitica e guerra fredda, in Interpretazioni della Repubblica, a cura di A. Giovagnoli, Il Mulino, Bologna 1998, p. 146. 24 Mi riferisco a R. FAENZA e M. FINI, Gli americani in Italia, Feltrinelli, Milano 1979; e R. FAENZA, Il malaffare. Dall’America di Kennedy all’Italia a Cuba al Vietnam, Mondadori, Milano 1978.
254
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
schera archivistica25, cioè di un florilegio di citazioni, spesso tronche e comunque estrapolate col solo criterio di avallare una tesi politica preconfezionata. All’uopo enfatizzano, o distorcono, i documenti rinvenuti in qualche archivio degli Stati Uniti a fini che risultano più romanzeschi che storico-politici26. Questa saggistica “popolare”, da ventre molle del dibattito politico, continua, tuttavia, ad avere fortuna presso il grande pubblico (e in qualche storico)27, a dimostrazione di come l’influenza del pregiudizio politico (o del partito preso che dir si voglia) sia dura a morire. Secondo uno studioso delle relazioni internazionali che condivide l’orientamento politico di De Lutiis, quest’ultimo sarebbe «un altro autore che fa ampio ricorso alle tesi di Faenza»28. Purtroppo (ma non intendo per niente fargliene una colpa) De Lutiis non è uno storico, e non ha a cuore, anche per le caratteristiche della collana editoriale rivolta al grande pubblico in cui è stato ospitato, la completezza della informazione, cioè delle fonti e della stessa bibliografia. Nel suo lavoro non si trova traccia di quanto possa contraddire, o negare, la rappresentazione privilegiata. Dai documenti del Dipartimento di Stato degli Usa (usati parcamente) a quelli della Cia non consultati a fondo (purtroppo neanche nell’efficace sintesi offerta dai corrispondenti del quotidiano «La Stampa»29) per fare un esempio, da quelli di A. Brogi, M. Del Pero, A. Giovagnoli a quelli di G. Formigoni, V. Satta ecc. A volte qualcuno di essi viene citato in una nota bibliografica, ma mai, o quasi, risulta oggetto di verifiche e confronti accurati. 25
I documenti non sono utilizzati con rigore, inducendo chi li conosce bene a parlare di «acerba e trasandata trattazione delle fonti». Si veda L. NUTI, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia, Laterza, Bari 1999, p. xi. 26 Per alcune precise contestazioni rimando ancora a L. NUTI, Gli Stati Uniti, cit., pp. xi, xiii, 379, 452 e 618-620. Ma anche C. PINZANI, che si serve di Faenza, non ha la minima incertezza a scrivere che «il rigore filologico di questo autore appare piuttosto dubbio», ne L’Italia nel mondo bipolare, in Storia dell’Italia repubblicana, cit., vol. 2, nota 208, pp. 116-117. 27 È il caso di N. TRANFAGLIA, Un capitolo del ‘doppio stato’, in Storia dell’Italia repubblicana, cit., pp. 15-16. 28 L. NUTI, Gli Stati Uniti, cit., nota 15, p. xiii. 29 Mi riferisco a P. MASTROLILLI e M. MOLINARI, L’Italia vista dalla Cia 19482004, Laterza, Roma-Bari 2005. I documenti da loro raccolti sono in via di ordinamento presso l’Ateneo di Ferrara, al quale sono stati generosamente ceduti.
255
SALVATORE SECHI
L’eliminazione di Moro: un’esigenza “planetaria”? Il presupposto da cui De Lutiis muove è la «grande attenzione» attribuita all’«ipotesi di una confluenza di interessi a livello planetario [corsivo mio] per l’eliminazione di Aldo Moro e del progetto di compromesso storico» (pp. 225 e 226). Per di più non esclude che ci sia stata una sorta di intesa, di fronte comune, per obiettivi diversi o non coincidenti con quelli dichiarati, con scambi dei ruoli e reciproca collaborazione tra Usa, Urss, Israele e palestinesi per far fallire un governo che includesse il Pci e anche per minare l’unificazione europea (come ha detto il vecchio manager democristiano Ettore Bernabei). I servizi segreti dei diversi paesi citati, appartenenti cioè a opposti schieramenti internazionali, avrebbero cooperato tanto al sequestro e all’assassinio di Moro quanto a «impedire che su questo accordo – disdicevole per ambedue i contraenti – si faccia piena luce» (p. 211). È la conferma di ciò che a certi livelli circolava nel Pci, cioè che «l’operazione Moro, seppure non gestita dall’Est, avesse il pieno benestare di quei regimi»30. È stata fin dal 1989 l’opinione di uno studioso come Stelio Marchese nel saggio sui collegamenti internazionali del terrorismo31. Sensazioni, sentimenti, paure e speranze appartengono all’ineffabile, all’inenarrabile. Essi per definizione non hanno bisogno di ancorarsi a prove, avere il suggello di documenti. Ognuno può giudicare quanto sia realistico immaginare che americani, sovietici, cecoslovacchi, palestinesi, israeliani possano essersi accordati su una divisione del lavoro per rapire, tenere nascosto, interrogare e uccidere Aldo Moro fino al macabro abbandono del suo corpo senza vita, crivellato di pallottole in un luogo che reca il nome di un antico palazzo romano, via Caetani. Ma alla fantasia, come all’amore, non si possono dettare leggi né porre limiti né razionalmente criticare, anche se uno dei più attenti studiosi del delitto Moro come Vladimiro Satta non si è tirato indietro nel dipanarli32. 30
Si veda la testimonianza dell’avvocato Giuseppe Zupo (che nel 1977 aveva la responsabilità del settore giustizia del Pci), a DE LUTIIS, Il golpe di via Fani, cit., p. 211. 31 S. MARCHESE, I collegamenti internazionali del terrorismo italiano (dagli Atti giudiziari), Japadre, L’Aquila 1989. 32 Mi riferisco al suo ultimo saggio, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, e a quello precedente, Odissea nel caso Moro. Viaggio controcorrente attraverso la documentazione della Commissione Stragi, Edup, Roma 2003.
256
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Per quanto concerne l’intelligence Usa, mi pare doveroso richiamare anzitutto la sobrietà e l’equilibrio con cui, rispetto al passato, De Lutiis affronta il delicato argomento. Sono, però, dell’avviso che il ruolo della Cia (di apprezzamento dell’opera svolta da Moro per far accettare ai comunisti le soluzioni di politica economica più sfavorevoli per il loro elettorato) non risulti adeguatamente messo a fuoco rispetto a quanto emerge dai documenti che conosciamo sull’atteggiamento del governo americano nei confronti di Moro. Al pari di Washington, il leader democristiano svolse un’opera infaticabile, per imporre le condizioni più umilianti alla cooptazione (e non alla legittimazione democratica) dei comunisti nella maggioranza e nelle vicinanze dello stesso governo. Per Moro l’unità della Dc, e la sua supremazia nel sistema politico, era un valore non negoziabile33. L’idea di solidarietà nazionale venne declinata come una mistura, un vero e proprio ingranaggio di innovazione e continuità, insistendo perché la composizione del governo Andreotti del marzo 1978 avvenisse senza la presenza formale del Pci e anche priva di uomini provenienti dall’area di riferimento del partito di Berlinguer. Fu Moro, e non Andreotti e Zaccagnini (più propensi ad accontentare i desideri dei comunisti), a respingere le preferenze e i veti che Botteghe Oscure gli avevano notificato34. La collaborazione dal presidente della Dc venne concepita come una proposta non solo diversa, ma anche opposta, a quella berlingueriana di compromesso storico35: Le forze principali che davano vita alla formula della solidarietà nazionale non condividevano in realtà nessun progetto. Al contrario, perseguivano strategie opposte, in prospettiva inconciliabili e ciascuna sperava di piegare la tregua ai propri scopi. Per il Pci era solo il primo passo verso un’alleanza ben più stabile. Per la Dc era l’estrema 33
Lo si rileva bene sia in C. BELCI e G. BODRATO, 1978. Moro, la Dc, il terrorismo, Morcelliana, Roma 2006; sia nell’accurata ricostruzione storica di A. GIOVAGNOLI, Il caso Moro, cit. 34 Per una forte sottolineatura di questa differenza rimando al lavoro, che ho avuto modo di scorrere nella correzione delle bozze di questo saggio, di A. COLOMBO, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo, Milano 2008, pp. 59-66. 35 È quanto si può rilevare dalle testimonianze e dalle valutazioni accurate di due dirigenti democristiani come C. BELCI e G. BODRATO, 1978. Moro, la Dc, il terrorismo, cit., p. 144, e dalla ricostruzione storica (attentissima, peraltro, alle ragioni della Dc) di A. GIOVAGNOLI, Il caso Moro, cit.
257
SALVATORE SECHI
concessione fatta ai comunisti, accettata controvoglia nella speranza di renderla più transitoria possibile e di sfruttarla per battere in campo aperto il Pci, non senza aver colto l’occasione favorevole per affrontare la crisi economica36.
Mai ci fu, da parte di Washington, anche quando Jimmy Carter divenne l’inquilino della Casa Bianca, la volontà di dare al Pci la patente di forza democratica e quindi di assegnare ad esso un compito analogo o pari a quello svolto da Pri, Pli e Psdi37. Se l’amministrazione americana era soddisfatta, come fu, dell’intesa raggiunta tra Moro e Berlinguer (quest’ultimo si arrese, accettandole, alle proposte di politica economica delineate dal Fondo Monetario Internazionale), sostenere che non aveva nessuna ragione di farlo fuori, o di vederlo fatto fuori da altri, corrisponde alla verità (che per gli storici non sempre è cristallina e trasparente). Invece, ho l’impressione che nella costruzione di De Lutiis (che ha il fascino di un giallo), anche se non si lascia più impigliare nella rete delle trame atlantiche38, essa venga tenuta per così dire a bagnomaria. Washington non poteva volere la morte di Moro De Lutiis alimenta il sospetto che, all’interno del ghetto di Roma, il palazzo Antici Mattei, della famiglia Caetani, possa essere stato uno dei luoghi in cui fu detenuto (e poi ritrovato, senza vita) Aldo Moro. Mi pare che vada oltre quando ne fa un crocevia di incontri e scambi dove convissero, e furono intessuti rapporti (anzi «operazioni politiche occulte», p. 170), tra i servizi segreti italiani, israeliani e americani, le Br, ambienti legati agli Stati Uniti (Usis, Centro Studi Americani) e via di seguito39. 36
A. COLOMBO, Un affare di Stato, cit., p. 66. Significative sono le pagine dedicate agli anni 1977-1981 dall’ex ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, il democratico R. GARDNER, Mission: Italy, Mondadori, Milano 2004, pp. 58-59, 170 e 213. 38 Dopo aver sostenuto la tesi dell’eversione atlantica, un fedele seguace di Sergio Flamigni, il giornalista e saggista G. FLAMINI, ha virato verso la cosiddetta “pista orientale” (L’amico americano, cit.). 39 Si veda la ricostruzione che ne hanno fatto G. FASANELLA e G. ROCCA, Il misterioso intermediario. Igor Markevitch e il caso Moro, Einaudi, Torino 2003. 37
258
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Credo che si potesse, e forse si dovesse, essere più netti. Anche se non si possono fare affermazioni apodittiche, quando in un evento sono implicati i servizi (e gli interessi) di diversi paesi, come chiave euristica la categoria dell’anticomunismo non è sufficiente a sorreggere la congettura che Washington abbia potuto armare, o far armare, la mano degli assassini di via Fani. Confesso di trovare poco convincente, sulla base delle carte disponibili, l’interpretazione secondo cui «i tentativi eversivi degli anni Sessanta e Settanta in Italia erano avvenuti tutti con la benevola protezione di ambienti americani» (p. 92). Per non lasciare dubbi su che cosa intende dire, De Lutiis aggiunge: Si concluse, dunque, nel 1974, una politica planetaria di protezione dei governi militari o apertamente fascisti che ebbe la sua espressione più violenta in Indonesia, con la deposizione di Sukarno nel 1964 e lo sterminio di oltre quattrocentomila comunisti e progressisti, e in decine di paesi del Centro e Sudamerica (p. 92).
Mi chiedo se la crisi della politica di containment del comunismo, avviata da George Kennan, e in generale del Cold War Liberalism, ma anche della politica estera di Henry Kissinger e dei neo-conservatori, possa essere semplificata in questo modo40. È ragionevole e necessario denunciare le «conseguenze illiberali di un impero liberale» quale fu in grande misura quello degli Usa. Questi limiti ci furono nel wilsonismo universalista e messianico come nel finalismo progressista e liberal che da Roosevelt e Truman si dispiega fino a Johnson. Soprattutto con quest’ultimo e con Kennedy (per non parlare dell’ultimo Bush) possono essere stati commessi, come nel caso del Vietnam e dell’Iraq, errori e prevaricazioni, attraverso covert actions o iniziative unilaterali molto gravi.
40
Rimando a studiosi come R. GARTHOFF, Détente and Confrontation. AmericanSoviet Relations from Nixon to Reagan, The Brookings Institution Press, Washington 1994; D.H. ALLIN, Cold War Illusions. America, Europe and Soviet Power, 1969-1989, St. Martin’s Press, New York 1995; W. LOTH, Overcoming the Cold War. A History of Détente, Palgrave, Basingstoke 2002; e J. HANHIMAKI, The Flawed Architect. Henry Kissinger and American Foreign Policy, Oxford University Press, New York 2004.
259
SALVATORE SECHI
I lavori sia di Giuseppe De Lutiis sia di Aldo Giannuli, dei fratelli Antonio e Gianni Cipriani, di Sergio Flamigni e Gianni Flamini, per citare solo alcuni, hanno documentato forme ed episodi di dirottamento impressionanti, prevalentemente, mi pare, ad opera dei servizi dei dicasteri militari e delle tre armi. È, però, doveroso premettere che nessun documento del National Security Council ha mai autorizzato (anzi tutti l’hanno esplicitamente escluso) il sostegno a movimenti o gruppi neo-fascisti. Su un piano più generale, la politica estera degli Stati Uniti ha sempre avuto al primo posto la lotta al comunismo e ai suoi alleati (come i nazionalismi asiatici o le guerriglie del Centro e del Sudamerica) preferibilmente col ricorso a profonde riforme (inserite in una linea di cosiddetta modernizzazione e di sviluppo) e non a sedizioni o colpi di Stato fascisti. Per quanto concerne l’Italia, l’orientamento della Cia è stato di estendere l’area della maggioranza fino ad includere il Psi e successivamente cooptare il Pci. I documenti esistenti, cioè consultabili da chiunque, provano che gli Usa in Italia non si prestarono ad alcuna azione complottarda né all’esecuzione di delitti politici. Diedero anzi il loro sostegno prima ad una politica di collaborazione tra Dc e Psi e successivamente tra Dc e Pci, escludendo in quest’ultimo caso l’assegnazione di portafogli ministeriali41. L’appoggio al centro-sinistra venne dato nella fase più critica, quella dopo le elezioni del 1963, in cui Dipartimento di Stato e Cia, non diversamente dal capo del Sifar, generale Viggiani, segnalarono «sentore di trame comuniste e fasciste», e la necessità di «rafforzare il governo democratico». Dal 1948 al 1968, gli Stati Uniti non si limitarono a proteste verbali nei confronti dell’alleato italiano. I gruppi avversi ad una politica di sinistra ricevettero 65 milioni di dollari. La Cia ebbe un ruolo che uno storico equilibrato come Richard Drake ha bollato come «devious and illegal»42. Secondo il rapporto Pike, nel 1972 cessarono le operazioni segrete della Cia in Italia, cioè 41
Per una ricostruzione corretta si veda V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit., pp. 335-353. 42 Cfr. R. DRAKE, The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy, cit., p. 66.
260
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
forme di interferenza nella politica interna italiana, sotto forma di finanziamenti a partiti politici o in altro modo. Per le elezioni che ebbero luogo in quello stesso anno, Henry Kissinger autorizzò l’ambasciatore Graham Martin a spendere circa 10 milioni di dollari (di cui 800 milioni di lire versati al capo del Sid, Vito Miceli) per assistere l’attività anti-comunista dei partiti e di altre organizzazioni43. Alla fine del 1975 secondo i giornali italiani William Colby, direttore della Cia, passò 6 milioni di dollari alla Dc per la campagna elettorale del giugno 197644. Dunque, dai dispacci della Cia emerge esattamente l’opposto di quanto denuncia De Lutiis, cioè che la Casa Bianca «non complottò con la destra italiana, ma si tenne pronta ad intervenire contro di essa. E che appoggiò molto decisamente il centro-sinistra»45. Il pericolo di un colpo di Stato in Italia sarebbe venuto, invece, dalle fila degli anti-comunisti. Molti di essi ruotavano intorno al presidente Antonio Segni, alimentandone le paure e i timori, come il generale Giovanni De Lorenzo (sostenuto sia dai socialisti di Nenni sia dallo stesso Moro), ma anche i presidenti dei due rami del parlamento Cesare Merzagora e Brunetto Bucciarelli Ducci, e personaggi come G. Martino, R. Pacciardi, I.M. Lombardo, E. Reale, R. Angiolillo, C. De Stefanis46. Nel 1974-1975 Ford, Kissinger, e l’ambasciatore Usa a Roma, John Volpe, da una parte, Moro e Rumor, dall’altra, si trovarono a convergere sulla linea di «aiutare le forze democratiche italiane a combattere ogni possibile espansione di quelle comuniste» (giugno 1975). Un atteggiamento fuori luogo di indulgenza nei confronti dei comunisti venne considerato quello di Jimmy Carter. Una volta alla Casa Bianca dopo aver sconfitto Ford, si attestò sulla linea della “non interferenza” nella politica italiana, ma anche della “non indifferenza” verso le sue scelte. Ciò avvenne nel momento in cui i mutamenti nella posizione di politica estera del Pci furono allentati dall’impenitente rappresentazione idilliaca del comunismo da parte di Berlinguer. 43
R. GARDNER, Mission: Italy, cit., p. 50. Si veda CIA, The Pike Report, Spokesman Books, Nottingham 1977, p. 193. 44 R. GARDNER, Mission: Italy, cit., p. 50. 45 Si veda l’esposizione di tale documento fatta da E. CARETTO, Berlinguer? Un artista di partito, «Corriere della Sera», 8 settembre 2003; e Id., Contrordine americani, il pericolo non è rosso, «Corriere della Sera», 18 dicembre 2003. 46 P.E. TAVIANI, Politica a memoria d’uomo, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 374-375.
261
SALVATORE SECHI
Nella relazione congressuale del 1975, egli diede in pasto ai congressisti una visione classicamente leniniana e leninista del capitalismo e dell’imperialismo in crisi precipitosa, con tutti i paesi colpiti da disoccupazione, carovita e «da un decadimento di idealità e valori etici e da processi sempre più ampi di corruzione e disoccupazione». Contemporaneamente Berlinguer non si sottraeva al fascino (tutto rodaniano) dei paesi del socialismo realizzato, cioè dell’Urss e degli Stati dell’Europa orientale investiti da «forte sviluppo produttivo», «ulteriori miglioramenti nel tenore di vita dei popoli e nel loro sviluppo civile e culturale», un «clima morale superiore» ecc.47. L’ambiguità, anzi la volontà di salvaguardare un giudizio ampiamente positivo sulla natura, e sui rapporti, dell’Urss e dei suoi paesi satelliti, prosegue nel 1977. Alla critica «a certi tratti illiberali dei regimi politici di alcuni paesi dell’Est europeo», Berlinguer accompagnò una risposta negativa («noi rispondiamo no») a chi vuole portarci a negare la funzione storica decisiva della Rivoluzione d’Ottobre, le conquiste irrevocabili di sistemi socialisti, e il carattere socialista dei rapporti di produzione che si sono realizzati di fatto, indiscutibilmente, in quei paesi, e la funzione che questi paesi hanno nella lotta per la pace48.
Pronunciate ad una manifestazione sindacale a Milano il 30 gennaio, queste parole vengono ribadite il 20 febbraio in un discorso alla televisione, dove il segretario comunista rimarca come l’autonomia del Pci da Mosca si spinge «non fino al punto di rompere con gli altri partiti comunisti», in quanto non considera tale rottura «come prova del carattere democratico del nostro partito». Ciò malgrado, la nuova amministrazione Carter a Washington diede un taglio alla linea intransigente dei predecessori repubblicani. Essi avevano alimentato spionaggio e propaganda anti-comunista, esercitando pressioni ed erogando finanziamenti occulti ai partiti di centro-destra. Ciò malgrado gli esponenti del Pri, del Psdi e del Pli a lungo furono considerati ospiti indesiderabili, e non vennero invitati a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore degli Usa in Italia. 47
Si veda per il periodo 1969-1984, la raccolta di documenti del segretario A. TATÒ, Caro Berlinguer, cit. 48 «l’Unità», 31 gennaio 1977.
262
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Ma tutto ciò, De Lutiis lo ammetterà, è cosa diversa da una politica di favoreggiamento o anche solo di incoraggiamento del neo-fascismo49. La Commissione di indagine del Parlamento degli Usa, nel 1975, sotto la presidenza del senatore democratico Frank Church, ha documentato una serie di interventi che sono arrivati a colpire la vita stessa di personaggi di primo piano. È il caso del presidente del Congo, Patrice Emery Lumumba, nel 1961; del dittatore della Repubblica domenicana Rafael Leónidas Trujillo, nel maggio dello stesso anno; del presidente del Vietnam del Sud, Ngo Din Diem, nel 1963; del generale cileno René Schneider, dei continui attentati alla vita di Fidel Castro ecc. Si tratta di partecipazione a delitti politici che dal presidente Gerald Ford (il famoso ordine esecutivo 11905 del 18 febbraio 197650, confermato da Jimmy Carter e Ronald Reagan) sarebbe stata vietata «in giro per il mondo», anche se ad avviso dell’inviato del quotidiano torinese continuarono, ma in casi estremi e circoscritti51. In Italia, l’ambasciata Usa a Roma tenne un comportamento più imperiale che diplomatico nei confronti degli stessi partiti di governo, ignorandoli o trattandoli da pedine di un gioco obbligato. Nell’ottobre 1976 si ebbe l’assunzione di una formula ambigua come quella della solidarietà nazionale/compromesso storico, per ridurre l’instabilità politica italiana e avviare una serie di riforme economiche (recupero dell’evasione fiscale, incremento della produttività, aumento della spesa sociale, riforma delle aziende statali ecc.)52. 49
Si vedano i documenti pubblicati da U. GENTILONI SILVERI, Gli anni Settanta nel giudizio degli Stati Uniti ‘un ponte verso l’ignoto’, «Studi Storici», vol. 42, n. 4 (ottobre-dicembre 2001), pp. 989-1020. 50 President Gerald R. Ford’s Executive Order 11905: United States Foreign Intelligence Activities, «Weekly Compilation of Presidential Documents», vol. 12, n. 8 (23 febbraio 1976); on-line: http:// www.ford.utexas.edu/LIBrARY/speeches/760110e.htm. 51 Se ne veda un ragguaglio in M. MOLINARI, Da Lumumba a Milesovic, tutti i complotti targati Cia, «La Stampa», 16 dicembre 2002. V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit., p. 360, fornisce un inventario degli episodi più eclatanti. 52 Cfr. il Memorandum, redatto dalla Cia, datato 1 ottobre 1976, Italia: la scena politica ed economica nell’autunno del 1976, che viene sintetizzato da P. MASTROLILLI e M. MOLINARI, Dc e Pci, questo compromesso s’ha da fare, «La Stampa», 12 settembre 2003.
263
SALVATORE SECHI
Dopo 16 mesi di collaborazione tra i due partiti per la Cia il Pci è giudicato come il «parafulmine del governo» e sempre più distante da Mosca53. Resta fermo l’obiettivo di «preservare il sistema democratico dell’Italia e il ruolo che questo paese ha per l’Occidente». Ma esso si deve realizzare «senza dare l’impressione, da un lato, di interferire con la politica interna italiana e, dall’altro, di essere favorevoli ad un accomodamento con i comunisti o di essere indifferenti alle scelte politiche dell’Italia»54. L’originale epilogo di questa nuova linea di condotta fu di rovesciare l’onere della prova: «ogni contrasto o incompatibilità con gli interessi occidentali apparirà come la conseguenza delle iniziative comuniste e non dei nostri tentativi di schiacciarli o punirli per il solo fatto di essere comunisti»55. Il servizio segreto Usa andò oltre questo limite di “non interferenza” e di “non indifferenza”, peccando di un surplus di ottimismo nei confronti dell’euro-comunismo. A mostrarne i limiti, nel 1979, sarà l’opposizione del Pci all’installazione dei missili Cruise, a Comiso, per fronteggiare gli SS-20 sovietici. Moro incontrò l’ambasciatore Gardner tre volte prima della formazione del governo che avrebbe incluso il Pci nella maggioranza. Nell’ultimo colloquio informativo, nel novembre 1977, prima della partenza per Washington, il presidente della Dc dichiarò che il terrorismo aveva un carattere politico e una dimensione internazionale, e più precisamente che ad appoggiarlo era la Cecoslovacchia (da Praga piuttosto che da Mosca, secondo la Cia, proveniva il rifornimento di armi delle Br). Un accorato appello il leader democristiano rivolse al rappresentante degli Stati Uniti perché perorasse la collaborazione con la nostra intelligence nella lotta al terrorismo, in quanto essa poteva pregiudicare un’intesa politica col Pci e segnare anche il suo personale destino56. 53
Si veda il Memorandum datato 10 gennaio 1978, Possibile sviluppo della crisi politica italiana, in P. MASTROLILLI e M. MOLINARI, L’Italia vista dalla Cia, cit., pp. 129-130. 54 Si veda il Memorandum, approvato da Carter il 14 marzo 1977, US Policy Toward Italy. Ne sono autori il segretario di Stato C. VANCE e il segretario al Tesoro M. BLUEMENTHAL, ed è pubblicato in appendice al volume dell’ex-ambasciatore Usa a Roma, R. GARDNER, Mission: Italy, cit., pp. 423-432. 55 Ivi, p. 62. 56 Ivi, p. 169. Si vedano, in appendice al volume, i rapporti dei consiglieri della Casa Bianca Zbigniew Brzezinski e Cyrus Vance.
264
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
De Lutiis non lo dice, ma ai dirigenti della centrale di Langley giunge dal loro agente a Roma un giudizio positivo sulla politica di accordo tra Dc e Pci. A patrocinarla, facendosene garante, fu proprio Moro. Dunque, era l’ultima persona di cui l’amministrazione Usa potesse desiderare la morte. Al funzionario americano della Cia si deve anche una dichiarazione che nel rapimento e nell’assassinio di Moro esclude un coinvolgimento di Mosca e di Praga. In un rapporto, il sequestro del leader democristiano viene considerato non con interesse (cioè con dissimulato piacere, come lascia intendere De Lutiis sulla base della logica – da lui privilegiata, mi pare, su ogni altra possibile spiegazione – della guerra fredda), ma come una vera e propria iattura: La natura di transizione del governo Moro ha portato i politici italiani a soprannominarlo ‘un ponte verso l’ignoto’. Ora, il rapimento del leader del partito da parte dell’organizzazione terroristica Brigate Rosse sta costringendo i politici italiani a superare un nuovo abisso politico. Le molte questioni sollevate dal caso potrebbero condurre a cambiamenti di rilievo nelle politiche del paese57.
Entrambe furono sottoposte a fibrillazione, un vero e proprio stato di tensione, che pare contraddire in maniera frontale la convinzione di De Lutiis, Flamigni, Flamini ecc., secondo cui Washington avrebbe puntato a mettere fuori scena o emarginare Moro. Le cose sono diverse, anzi mi sembrano semplicemente opposte a questa interpretazione, anche se nel corso dei 55 giorni, e dello stesso “processo” intentato a Moro, tutto precipiterà. In presenza di nuove fonti, non ho difficoltà ad ammettere che l’ipotesi di De Lutiis e dei suoi seguaci si potrebbe presentare come meno debole e velleitaria di quanto lo era stata precedentemente. Per la Cia, sei mesi dopo il rapimento del presidente della Dc, «un’aria di incertezza e di sfiducia (distrust) pervade la vita politica italiana». Essa rifletteva un’assai diffusa frustrazione sulla capacità del ministero dell’Interno e in generale del governo di ubicare la prigione di Moro e di salvarlo. 57
Cfr. il Memorandum della Cia, The Moro Kidnapping and Italian Politics, 27 aprile 1978, RPM 78-10174, p. 1.
265
SALVATORE SECHI
La magistratura e la polizia giudiziaria vedono i loro poteri investigativi avocati dal Viminale (il ministro dell’Interno si assicurò una sorta di diritto di accesso a tutti gli atti della Procura della Repubblica di Roma). Le indagini vengono sottratte a polizia e carabinieri e concentrate nelle sole mani dell’Ufficio centrale investigazioni generali e operazioni speciali (Ucigos). Questa struttura speciale del Viminale fu creata, il 31 gennaio 1978 (cioè un mese e mezzo prima che avesse luogo il rapimento di Moro), da Cossiga e venne diretta da Gaspare De Francisci. Si sovrappone al Sisde, il servizio segreto civile, e in quanto organo della Direzione generale della Pubblica Sicurezza, dipende direttamente dal capo della polizia, e di fatto dal ministro. Per fare posto all’Ucigos viene smantellato l’Ispettorato anti-terrorismo, creato nel 1974. Il suo dirigente, Emilio Santillo, il nostro maggiore esperto di anti-terrorismo58 è emarginato, insieme al suo vice Guglielmo Carlucci, un attento conoscitore delle Br, Umberto Improta. Il capo del Cesis (organismo di controllo dei servizi segreti) Gaetano Napoletano viene sostituito da un uomo di Federico Umberto D’Amato (il dominus dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale), il piduista Walter Pelosi, trasferiti ad altro incarico. Estromessi dalla candidatura al Sisde, Santillo sarà nominato vicecapo della polizia, e Carlucci viene inviato a Reggio Emilia. Non si può dire che abbia con certezza contato qualcosa il merito di avere, in tre occasioni (1975, 1976 e 1977) attirato l’attenzione sulla pericolosità della loggia massonica P2 scoperta nel 1981 dagli inquirenti di Milano. Malgrado le 37.000 perquisizioni (di cui 7.000 solo a Roma) operate nei 55 giorni che seguirono il suo rapimento, e il cospicuo numero di agenti mobilitati (circa 172.270 nella sola Roma e 510.724 in tutto il territorio nazionale), lo spettacolo dato da carabinieri, poliziotti e guardie di finanza sarà di colossale impotenza. Si deve forse parlare di disfacimento, ben al di là dell’impreparazione, degli apparati di prevenzione e repressione. Infatti, i due servizi di intelligence, Sisde e Sismi, e la struttura antiterrorismo (l’SdS di Emilio Santillo) erano stati decapitati. Non esisteva nessuna forma di coordinamento tra loro (per la verità neanche 58
Santillo fu il primo, insieme al servizio segreto francese (Sdece), fin dal 12 febbraio 1978, a preannunciare il rapimento di un esponente di spicco della Dc da parte delle Br.
266
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
tra i tre gruppi di lavoro messi insieme da Cossiga al Ministero dell’Interno) o non venne destinata loro una sede. Questa situazione durava da dieci anni, cioè dal 1968, per non parlare delle micce anti-democratiche collocate da settori importanti dei servizi contro le istituzioni e il consolidato pregiudizio per cui il pericolo veniva solo dall’estrema destra59. Il Viminale era un guscio vuoto. Poteva solo sentenziare e rassicurare, non avendo altro in cui potesse eccellere. Dopo la fuga nel Sud del re e di Badoglio nel 1943, mai il paese era rimasto così indifeso60. Ne è impressionato testimone Steve Pieczenik, assistente vice-segretario di Stato, psichiatra esperto degli atteggiamenti che caratterizzano la condotta dei rapitori e delle loro vittime nei sequestri di persona. Per venire incontro alle richieste del ministro dell’Interno Cossiga al residente della Cia a Roma, l’Ufficio anti-terrorismo del Dipartimento di Stato segretamente inviò Pieczenik in Italia, dove diventò uno dei consulenti più influenti del Viminale. I comunisti avevano pubblicamente riprovato la mancanza di progressi, di passi avanti da parte del governo, che continuò a girare a vuoto: La tensione riflette l’assenza della consueta influenza di Moro sia sul proprio partito che nei rapporti con i comunisti. L’eccellente sensibilità di Moro riguardo i rapporti fra cristiano democratici e comunisti ha rappresentato uno dei principali contributi alla politica dell’Italia61.
A venirne vulnerata è la tenuta della coesione interna alla Dc, che vide pregiudicata la sua capacità di continuare ad essere la maggiore forza politica italiana. Aspra fu la critica della Cia nei confronti del ministro dell’Interno Francesco Cossiga per non essere riuscito, malgrado un dispiegamento massiccio di forze, la creazione di comitati di consulenti e l’esclusione, di fatto, dei giudici dalle indagini, a rintracciare il covo in cui Moro era detenuto. 59
Si veda il capitolo L’impotenza dello Stato, in A. GIOVAGNOLI, Il caso Moro, cit., p. 75 sgg. 60 Si vedano le memorie dell’ambasciatore Gardner, del capo della polizia Giuseppe Parlato, del comandante dei Carabinieri Pietro Corsini e del direttore del Sisde Giulio Grassini, in V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit., p. 169. 61 Ivi, p. 3 sgg.
267
SALVATORE SECHI
Ma gli apprezzamenti positivi della centrale di Langley si spingono ben oltre la persona del presidente democristiano (che, invece, Kissinger non stimava, al pari di Willy Brandt e Olof Palme62). E finiscono per investire gli aspetti di politica economica dell’intesa che, nel 1977, si venne tessendo tra Dc e Pci. Di essa faceva parte la prosecuzione dell’austerity, la riforma del meccanismo della scala mobile, l’aumento della produttività, l’appoggio alle proposte del Fondo Monetario Internazionale, cioè riduzione del costo del lavoro, spostamento delle risorse dai consumi agli investimenti, maggiore mobilità del lavoro, la riduzione del deficit di bilancio ecc.63. Non solo la Cia, ma anche uno studioso come Sidney Tarrow ha identificato la partecipazione dei comunisti italiani al governo (la “non sfiducia” prima e la contrattazione sul programma poi) come un ruolo di stabilizzazione e di accettazione della tanto aborrita (quando la facevano i socialisti, nel corso del centro-sinistra) ‘politica dei due tempi’, cioè prima la stabilizzazione del sistema e successivamente l’avvio di un ciclo di riforme: l’esperienza della solidarietà registra, insomma, elementi di continuità piuttosto che di rottura con le scelte del governo precedente64.
Tale continuità è rilevabile soprattutto nella politica economica, che è il settore prioritario di intervento, in quanto profilerebbe una sorta di svolta nella politica “nazionale”65. Tutto restò sulla carta o venne semplicemente messo nel cassetto quando rapimento ed assassinio di Moro misero in primo piano la politica della lotta al terrorismo e dell’ordine pubblico: «Perciò», scrive l’uomo della Cia ai suoi superiori, «sarebbe prematuro dichiarare l’esperimento Moro-Andreotti un fallimento». Al contrario, gli sembra un esperimento promettente.
62
Si veda l’ultimo dei tre volumi di memorie, H. KISSINGER, Years of Renewal, Touchstone, New York 1999. 63 P. MASTROLILLI e P. MOLINARI, L’Italia vista dalla Cia, cit., pp. 110-111. 64 S. TARROW, Aspetti della crisi italiana, in La crisi italiana, a cura di L. Graziano e S. Tarrow, cit. 65 F. DE FELICE, Nazione e crisi, in Storia dell’Italia repubblicana, Einaudi, Torino 1995, vol. 2, p. 73.
268
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Purtroppo di questa analisi, accessibile ad ogni lettore del saggio di Mastrolilli e Molinari pubblicato dagli Editori Laterza, nella storiografia sull’“eversione atlantica” non sempre se ne trova traccia o notizia adeguata. Forse per non dovere ammettere che la tesi sull’interesse primario di Washington a vedere Moro messo fuori della scena politica è un pregiudizio, cioè semplicemente infondata. Pieczenik e la vita di Moro: un prezzo da pagare alla ragion di Stato Il giudizio che ho appena formulato può, però, cambiare sensibilmente, cioè rovesciarsi su se stesso. Basterebbe accertare chi eventualmente c’era dietro la decisione di Steve Pieczenik, capo dell’Ufficio istituito da Henry Kissinger per la gestione dei problemi del terrorismo internazionale presso il Dipartimento di Stato, di lasciare uccidere Moro per impedirgli di dare ai brigatisti informazioni lesive dell’alleanza atlantica e della persona di Andreotti. C’era il consenso dell’amministrazione di appartenenza? La domanda, che in questa occasione De Lutiis adombra con sobrietà, non può essere per nulla elusa o vilipesa per una sorta di lesa maestà nei confronti di Washington. Finora non abbiamo alcuna prova, salvo la dichiarazione di Pieczenik che non accenna a possibili ordini da Washington, ma presenta l’intera vicenda come se fosse affidata alla propria autonoma responsabilità. Servendosi di essa, egli dichiara: Sono stato io a decidere che il prezzo da pagare era la vita di Moro. La mia ricetta per deviare la decisione delle Br era di gestire un rapporto di forza crescente e di illusione di negoziazione. Per ottenere i nostri risultati avevo preso psicologicamente la gestione di tutti i Comitati dicendo a tutti che ero l’unico che non aveva tradito Moro per il semplice fatto di non averlo mai conosciuto.
Non si fida neanche di Cossiga. Munito di questo ruolo lo utilizza in grande autonomia: Presi in mano la situazione e decisi clinicamente come gestire l’esito finale delle Br, uno scambio mortale in termini di stabilità per il paese e per i suoi alleati. Cossiga era sempre informato sulla mia strategia e non poteva fare altro che accettare. Le Br invece potevano fermarmi in
269
SALVATORE SECHI
un attimo ma non hanno saputo farlo o voluto, questo non lo so. Avrebbero potuto concludere una trattativa con lo Stato, ottenendo delle pene ridotte liberando Moro ma erano troppo legati alla loro logica terrorista, in cui si preferisce essere più terroristi del terrorismo di Stato che io così bene conosco66.
Pieczenik resta impressionato da una circostanza che lo colpisce subito: «l’apparato dello Stato rimane in mano a vecchi fascisti che poi mi sono reso conto erano stati infiltrati dalla P2. Fra l’altro ho potuto constatare con il ministro dell’interno di allora Cossiga che costui non aveva nessuna strategia né alcun piano d’azione». Da una parte, dunque, questi «gruppi fascisti» che avevano il controllo del Ministero dell’Interno e dall’altra la facilità con cui i brigatisti erano ogni volta informati (dai figli o dai parenti di ministri ed alti funzionari dello Stato) di quanto veniva predisposto nel Palazzo. La macchina dello stato era infiltrata di alleati dei brigatisti. Non più di 24 ore dopo il suo ingresso all’Hotel Excelsior, dove amava trovare ristoro anche Licio Gelli, lo psichiatra americano è già nella lista degli indesiderabili, anzi una vittima designata, cioè delle persone che le Br annunciano di voler colpire67. A dominare è l’insicurezza, le divergenze sugli obiettivi, l’inaffidabilità dell’elite politica («i dinosauri dell’epoca mussoliniana e i loro giovani cloni») compresa quella dei servizi segreti sia italiani sia vaticani. L’incertezza finisce per toccarlo personalmente: Mi resi conto in fretta che anch’io ero poco al sicuro. Mi ero quindi reso conto che le Br avevano degli alleati all’interno della macchina dello Stato. Dopo qualche riunione che consisteva nell’identificare il centro di gravità attorno al quale la storia del rapimento girava, ho subito capito che le forze conservatrici volevano la morte di Moro, le Br lo volevano vivo, i comunisti invece, la loro posizione era quella della fermezza politica.
66
M. DOLCETTA, “Noi abbiamo ucciso Aldo Moro”. Parla il consulente americano di Cossiga, «l’Unità», 9 maggio 2007. In generale cfr. l’intervista resa ad E. AMARA, Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un protagonista esce dall’ombra, Cooper, Roma 2008. 67 Francesco GRIGNETTI, Ho manipolato le Br per far uccidere Moro. Dopo 30 anni le rivelazioni del «negoziatore» Usa, «La Stampa», 9 marzo 2008.
270
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Francesco Cossiga lo voleva sano e salvo ma mi diede carta bianca per elaborare una strategia. Il primo punto della mia strategia consisteva nel guadagnare del tempo, mantenere in vita Moro e al tempo stesso il mio compito era di impedire l’ascesa dei comunisti di Berlinguer al potere, ridurre la capacità degli infiltrati nei Servizi e immobilizzare la famiglia Moro nelle trattative. Cossiga non gestiva interamente la strategia che volevo sviluppare68.
Vengono istituti tre Comitati: uno tecnico-operativo (di cui fanno parte i responsabili dei vertici dei carabinieri, della polizia, della Guardia di Finanza, del servizio segreto civile e militare, della questura di Roma e di alti funzionari della Pubblica Sicurezza), con funzioni di coordinamento dell’attività delle forze di polizia; un secondo di intelligence (chiamato I) che opera a livello dei servizi non solo di Sismi, Sisde e Cesis, ma anche degli apparati informativi delle tre armi; e infine un terzo costituito da esperti di cui sono chiamati a far parte personaggi reclutati dalla P2, dalla Cia e in qualche caso del Kgb, cioè l’inviato del Dipartimento di Stato Steve Pieczenik, il criminologo Franco Ferracuti, il vice-presidente dell’Iai (Istituto Affari Internazionali), Stefano Silvestri, il linguista Ignazio Baldelli, lo storico del diritto prof. Mario D’Addio, lo psichiatra milanese Augusto Ermentini, il vice-presidente dell’Enciclopedia italiana Vincenzo Cappelletti (fu quest’ultimo, ha dichiarato Cossiga, a fornirgli la maggior parte di questi nomi), la prof.sa Giulia Conte Micheli, studiosa di psicografia, il linguista Mario Medici, docente all’Università «La Sapienza» ecc. I tre Comitati creati dal ministro dell’Interno finiscono per sovrapporsi, girano a vuoto intorno alla sua persona. È l’intera struttura amministrativa dello Stato a venire messa in ginocchio mostrando quanto fosse retorica e quindi volgare la sua esibizione muscolare e il lessico rutilante di minacce e di sicurezza di cui lascivamente per 55 giorni questo ectoplasma si riempie la bocca. Gli uomini dei tre Comitati, scelti dal ministro dell’Interno, sono sintonizzati probabilmente sull’unica emittente alla quale risultano tutti affiliati, la Cia e soprattutto la loggia massonica P2 di Licio Gelli. Non esistono prove per sostenere che questo vincolo fosse così stretto da prevalere su ogni altro. Bisogna dire che si tratta solo di un’ipotesi su cui lavorare. 68
M. DOLCETTA, “Noi abbiamo ucciso Aldo Moro”, cit.
271
SALVATORE SECHI
Infatti l’appartenenza alla P2, fin quando non si riuscirà a dimostrare che Gelli ha tirato le fila di questi puppeters, non può essere assunta come la chiave esplicativa dei comportamenti di queste “teste d’uovo”. Essi avevano altre appartenenze (quella delle singole professioni, degli eventuali partiti, di circoli, associazioni, alcove ecc.) e nessuno fino ad oggi ha potuto dire quale di queste membership ha prevalso sull’altra determinando il loro comportamento nell’affaire Moro. A prevalere sarà il Comitato di cui faceva parte Pieczenik. Secondo la sintesi che del loro ruolo è stata fatta di recente, sulla base della cultura del sospetto, questi consulenti erano «un agente della Cia e della P2; un sospetto agente doppio (Kgb e Cia) e un terzo agente americano legato a Kissinger e al Dipartimento di Stato»69. I magistrati Ferdinando Imposimato e Rosario Priore avevano in precedenza ricordato come tutti questi Comitati fossero formati da esperti che si rilevarono essere “antenne” di servizi di intelligence di molte potenze straniere. Quello di Pieczenik elabora una strategia che non comprende la salvezza di Moro, ma esattamente il contrario, la necessità, l’inesorabilità della sua morte: Lessi le molte lettere di Moro e i comunicati dei terroristi. Vidi che Moro era angosciato e stava facendo rivelazioni che potevano essere lesive per l’Alleanza Atlantica. Decisi allora che doveva prevalere la Ragione di Stato anche a scapito della sua vita. Mi resi conto così che bisognava cambiare le carte in tavola e tendere una trappola alle Br. Finsi di trattare. Decidemmo quindi, d’accordo con Cossiga, che era il momento di mettere in pratica una operazione psicologica e facemmo uscire così il falso comunicato della morte di Aldo Moro con la possibilità di ritrovamento del suo corpo nel lago della Duchessa. Fu per loro un colpo mortale perché non capirono più nulla e furono spinti così all’autodistruzione. Uccidendo Moro persero la battaglia. Se lo avessero liberato avrebbero vinto. Cossiga ha approvato la quasi totalità delle mie scelte e delle mie proposte e faceva il tramite con Andreotti70.
69 70
Si veda F. IMPOSIMATO e S. PROVVISIONATO, Doveva morire, cit., p. 8. Ibidem.
272
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Quest’ultimo prima considerato in stato di grazia per non essere depositario di segreti atlantici, sarà poi accusato di averli rivelati ai suoi carcerieri. Insomma aveva parlato troppo su Gladio, sugli equilibri militari, sulle grandi stragi, su piccoli e grandi scandali che coinvolgevano dirigenti politici, e interessi stranieri. È il prevalere della ragion di Stato nella quale finisce per essere coinvolto anche il nostro principale alleato, gli Usa. È impossibile che i suoi organi politici, come il Dipartimento di Stato e la Cia, abbiano lasciato troppa manica larga a Pieczenik fino ad affidargli la responsabilità di decidere sulla vita del leader democristiano. C’è stata sicuramente una scelta concordata, una soluzione condivisa. È importante conoscere le convenienze e gli svantaggi che vennero calcolati per un passo così pericoloso e azzardato: Fu un’iniziativa brutale, certo, una decisione cinica, un colpo a sangue freddo: un uomo doveva essere freddamente sacrificato per la sopravvivenza di uno Stato. Ma in questo genere di situazioni bisogna essere razionali e saper valutare in termini di profitti e perdite71.
Le Br di Moretti, stordite, infuriate, deluse, uccidono l’ostaggio. E questo è il freddo commento di Pieczenik: «L’uccisione di Moro ha impedito che l’economia crollasse; se fosse stato ucciso prima, la situazione sarebbe stata catastrofica. La ragion di Stato ha prevalso totalmente sulla vita dell’ostaggio»72. Il punto non è tanto quello di negare alla Dc la libertà di cooptare i comunisti nella maggioranza o nel governo, autonomia che da parte dell’amministrazione Carter non era in discussione, quanto quella di impedire e comunque bloccare un eventuale blitz dell’Armata rossa che nel giro di 15 giorni, sfruttando la propria superiorità militare sul piano terrestre, poteva occupare la Francia e anche la Spagna. È quanto Michael Ledeen cercò di far capire, senza molto successo, a Giovanni Galloni. Il viaggio di quest’ultimo a Washington intendeva saggiare le reazioni del grande alleato della Dc e dell’Italia, per conto della segreteria di Zaccagnini, sull’associazione del Pci alla maggioranza. Un governo Dc-Pci, in qualunque forma fosse stato varato, avrebbe eliminato o ridotto la filiera di basi militari di cui gli Usa disponevano in Italia per fronteggiare l’insidioso espansionismo sovietico? 71 72
F. GRIGNETTI, Ho manipolato le Br, cit. Ibidem.
273
SALVATORE SECHI
Kissinger non parve disposto ad accordare al governo italiano quanto fece per quello francese (dove poté contare sui socialisti per neutralizzare il Pcf). Invece di prepararsi ad un reazione diplomatica e politica dura verso l’Italia, alle prese con un esecutivo di cui facevano parte, direttamente o indirettamente, i comunisti, per rassegnarsi a trovare nei suoi confronti successivamente un modus vivendi, attraverso il suo allievo Pieczenik gioca la carta di eliminare dalla scena, e dalla terra, l’ostacolo, cioè Moro. La responsabilità del Dipartimento di Stato e della Cia, se provata, sarebbe inammissibile ed enorme. Per questa ragione, bisogna insistere a chiedere al governo italiano i verbali dei tre Comitati creati da Cossiga73 e la corrispondenza intercorsa tra Pieczenik, la Cia e il Dipartimento di Stato74. È quanto facemmo, durante il primo Convegno nazionale di studio sul delitto Moro, a Cento (Ferrara), il 16 marzo scorso, con studiosi come Giuseppe De Lutiis, Aldo Giannuli, Marco Clementi, Nicola Biondo, Francesco Biscione ecc. Per la verità senza alcun risultato fino ad oggi. Spetta al nuovo incontro di studiosi delle Università di Bari, della Luiss e di altre istituzioni accademiche, rilanciare l’iniziativa perché alla mediocre gestione politica della prigionia di Moro non segua l’indifferenza per il modo in cui è stato lasciato morire. L’arma delle Br che ha sparato è stata probabilmente caricata anche da altre mani, per intenderci quelle che con la politica della fermezza hanno mascherato quella della ragion di Stato. Un alleato maltrattato, Israele Probabilmente per la necessità di sintesi imposta dalla collana editoriale in cui è stato ospitato, poco generosa, anzi abbastanza omissiva, mi è sembrata la valutazione dei rapporti di buon vicinato con le Br attribuita agli israeliani (pp. 84-92). 73
Del Comitato di cui fanno parte Ferracuti, Piecznik, Silvestri ecc. sono stati pubblicati alcuni documenti in appendice al volume di F. IMPOSIMATO e S. PROVVISIONATO, Doveva morire, cit. 74 Pare che Pieczenik non abbia neanche redatto la relazione che gli viene normalmente attribuita. Cfr. Pieczenik, l’uomo delle cospirazioni, «Carmilla», 14 luglio 2003.
274
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
De Lutiis condivide il sospetto di Moro (comunicato da Giulio Andreotti e Giovanni Galloni) secondo cui, insieme alla Cia, il Mossad avrebbe avuto degli infiltrati in seno le Br, di cui conoscevano i piani, ma si guardarono bene dal rivelare all’intelligence italiana. In secondo luogo, ritiene che fosse interesse di Israele tenere l’Italia in uno stato di permanente de-stabilizzazione75, rendendola quindi inaffidabile agli occhi di Washington sempre più interessata ad esercitare una propria egemonia sul Mediterraneo. È probabilmente la strage compiuta dai palestinesi, alle Olimpiadi di Monaco nel settembre 1972, a far capire al governo di Tel Aviv la necessità di imitare i suoi spietati nemici trovando una sponda, se non qualche forma di collaborazione, con i gruppi dell’estremismo di sinistra (la Raf, le Br ecc.). Dal punto di vista del Mossad era, dunque, utile che le Br continuassero, con le loro azioni terroristiche, a svolgere una spossante opera di indebolimento del quadro politico-istituzionale in Italia e in questo modo contribuissero a tenere il Pci lontano dal governo. Anche perché la cooptazione di Berlinguer nella maggioranza o nel governo avrebbe reso meno compatto il collante filo-palestinese che l’eventuale successo del compromesso storico sembrava, invece, destinato ad irrobustire. Si tratta di ipotesi e valutazioni molto ragionevoli, ma non colgono, mi pare, la ragione principale dell’irritazione e della paura che Moro incute a Tel Aviv. La situazione è descritta efficacemente nelle inchieste e nelle sentenze del magistrato inquirente Carlo Mastelloni, presso il Tribunale di Venezia76. De Lutiis non dà l’importanza che merita al fatto che, andando ben oltre la linea di compromesso dei suoi predecessori, nel-
75
Il giudice Ferdinando IMPOSIMATO parlò anzi di «una situazione di guerra civile e di conflitto armato per costringere gli americani a non fare affidamento solo sull’Italia come base sicura nel Mediterraneo […] nonché per indurli a diffidare della lealtà politica dell’Italia». Cfr. Le Br erano in contatto con i servizi israeliani, «Il Tempo», 1º marzo 1999. Si veda anche Democrazia, terrorismo, e servizi segreti, in Forme di organizzazione criminale e terrorismo, a cura di F. Ferracuti, Giuffrè, Milano 1988, pp. 177-186. 76 Mi riferisco al Tribunale di Venezia, sentenza-ordinanza del giudice istruttore Carlo Mastelloni, procedimento penale n. 204 del 1983, depositato presso Archivio della Commissione Stragi (d’ora in avanti con l’acronimo ACS).
275
SALVATORE SECHI
l’autunno del 1973, come ministro degli Esteri nel governo presieduto da Mariano Rumor (7 luglio 1973-23 novembre 1974), Aldo Moro legittimò platealmente il terrorismo palestinese, notoriamente legato al Kgb. Lo fece in una misura sconosciuta a qualunque altro leader di un paese occidentale. In particolare l’11 novembre 1973 quando, dietro l’impegno formale (in data 19 ottobre) del rappresentante dell’Olp (Said Wasfi Kamal) di non ripetere in Italia nessuna azione dei suoi fedayn, i generali Vito Miceli e Francesco Terzani (capo e vice-capo del Sid), il generale Gianadelio Maletti, il colonnello Stefano Giovannone (influentissimo capocentro dei nostri servizi a Beirut), il vice-questore Silvano Russomanno, insieme ad alti funzionari della Farnesina (Ranieri Tallarigo, Concetta Di Stefano in Grignano ecc.), alla fine di diverse riunioni disposero la liberazione, in due momenti diversi, dei cinque terroristi di Settembre nero. La loro cattura, il 5 settembre 1973, si deve ad un’azione preventiva dei servizi segreti italiani e del Mossad. Il commando terrorista venne trovato in possesso di missili sovietici Strela, e neutralizzato in un alloggio di Ostia. Otterranno la libertà provvisoria e saranno espatriati, via Malta, in Libia, a bordo dell’aereo del Sid, “Argo 16”77. Di qui raggiungeranno i campi palestinesi. Francesco Cossiga l’ha riferito in una lettera al quotidiano «Libero», in data 14 luglio 2006. Si tratta di un intervento diretto, personale, di Moro sul presidente del Tribunale impegnato a giudicare i terroristi che ad Ostia avevano progettato di far saltare l’aeromobile civile israeliano della El-Al. Per Tel Aviv fu una scudisciata in piena regola dal momento che il Mossad aveva collaborato con l’intelligence italiana a catturare il drappello palestinese. La risposta non si fece attendere, e fu una ritorsione cruenta. Si tratta dell’abbattimento, il 23 novembre 1973, nel cielo di Porto Marghera, del Fokker bimotore in servizio al nostro controspionaggio per trasportare in Sardegna, alla base di addestramento di Capo Marrargiu, i reparti di una struttura segreta come Gladio. Per far comprendere al nostro governo che doveva smetterla di garantire l’impunità ai 77
Si veda ACS, Tribunale di Venezia, sentenza-ordinanza del giudice istruttore Carlo MASTELLONI, procedimento penale n. 204 del 1983 contro Abu Ayad e altri, pp. 1161-1163 e S. FLAMIGNI, La tela del ragno. Il delitto Moro, cit., pp. 197-198.
276
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
terrorristi arabo-palestinesi, la ritorsione del Mossad costò la vita a quattro militari del Sismi78. Ma Settembre nero non volle intendere ragioni. Circa un mese dopo, il 17 dicembre 1973, in piena crisi petrolifera (che segue alla guerra del Kippur del 6-22 ottobre 1973), nell’aeroporto romano di Fiumicino fece lanciare due bombe incendiarie a bordo del Boeing 747 della Pan Am, in partenza per Beirut. Il bilancio complessivo dell’attentato e del successivo dirottamento fu di 32 vittime, una carneficina79. Di fronte a questa prova di scarsa affidabilità degli arabo-palestinesi invece di interrompere con loro ogni rapporto, l’Italia decise di perfezionare l’intesa dando vita ad una sorta di “diplomazia parallela” (o all’italiana che dir si voglia). Questo “patto” segreto, esteso questa volta anche al Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) di George Habbash, venne «stipulato sulla parola tra la resistenza e il terrorismo palestinese da una parte e il governo italiano dall’altro […] al fine di tenere al riparo l’Italia dagli atti terroristici di quelle organizzazioni»80, e di salvaguardare gli interessi italiani all’estero (Agip e Alitalia) per quanto riguarda l’approvvigionamento di petrolio messo a dura prova dalla crisi petrolifera81. Da parte di governo (Rumor-Moro), magistratura e Sid si riconobbe ai combattenti dell’Olp e del Fplp di Habbash di potere operare in Italia, facendo transitare armi di proprietà palestinese, in quanto partigiani di una causa condivisa (il diritto ad avere un territorio ed uno Stato). Per quanto fatto in barba alle leggi del nostro ordina78
Riferisco sia l’opinione dell’ex generale del Sismi A. VIVIANI, Servizi segreti italiani 1815-1985, Adnkronos libri, Roma 1986, p. 355 (e l’intervista al settimanale «Panorama», 13 maggio 1987) sia la testimonianza successiva (cfr. «Adnkronos» del 20 luglio 2005) del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga resa in una lettera al senatore di An Enzo Fragalà, membro della Commissione Mitrokhin, ora nell’archivio della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokhin. 79 Si veda la testimonianza di Paolo Emilio TAVIANI nell’audizione del 1º luglio 1997 alla Commissione Stragi, 24º resoconto stenografico. Cfr. http://www.parlamento.it/bicam/terror/ stenografici/steno24.htm. 80 Si veda quanto scrive Francesco Cossiga in una lettera inviata al capogruppo di AN in Commissione Mitrokhin, Enzo Fragalà. Cfr. nota 78. 81 Si veda quanto riferito al giudice Carlo Mastelloni, nella sentenza-ordinanza sopra citata (procedimento penale n. 204 del 1983), pp. 302-304, da un ufficiale del vecchio Sifar, Di Blasi.
277
SALVATORE SECHI
mento, e mitigando le reazioni di Israele82, era un mutuo patto di non aggressione. Al nostro paese, escluso dalle azioni di rappresaglia o di attacco di Arafat, ne derivarono molti anni di pace. In secondo luogo, furono sancite una serie di garanzie nei confronti dei palestinesi residenti in Italia e che avessero traversie giudiziarie. Sull’accordo con le organizzazioni arabo-palestinesi vennero consultati, per iniziativa di un esperto, con buone relazioni con esponenti del Medio Oriente, come il generale Terzani, tanto la Cia quanto il Mossad (attraverso il capo-centro a Roma, Asa Leven). Questa linea di “diplomazia parallela” comportò scambi tra il governo e i gruppi terroristici palestinesi che avevano poco o nulla che fare sia con lo stato di diritto sia con le alleanze (dagli Usa a Israele). Ma nessuno, né nella Dc né nella maggioranza di governo né nell’opposizione comunista, ebbe qualcosa da eccepire. È la ragione per cui Moro la ricorda distesamente in una lettera a Flaminio Piccoli: … non una, ma più volte, furono liberati con meccanismi vari palestinesi detenuti ed anche condannati, allo scopo di stornare gravi rappresaglie che sarebbero poi state poste in essere, se fosse continuata la detenzione. La minaccia era seria, credibile, anche se meno pienamente apprestata che nel caso nostro. Lo stato di necessità è in entrambi evidente. Uguale il vantaggio dei liberati, ovviamente trasferiti in paesi terzi83.
Un’altra prova del fuoco fu la clamorosa vicenda che ebbe luogo nell’autunno del 1979. A Ortona, vicino a Chieti, il capo dell’apparato militare di Habbash, Abu Saleh Anzeh, insieme a Daniele Pifano e ad altri esponenti dell’Autonomia romana, furono trovati dai carabinieri con due missili 82
Forse perché non era un produttore di petrolio e, a differenza dei palestinesi, Tel Aviv non aveva centinaia di migliaia di propri cittadini inseriti in posti-chiave in Kuwait, Bahrein e Qatar (cioè negli Emirati arabi) e in Arabia Saudita. Non si conoscono i termini precisi dell’accordo raggiunto con l’Italia. 83 Il testo delle missive inviate da Aldo Moro durante i 55 giorni del suo rapimento è consultabile anche in Internet al sito http://www.archivio900.it/it/documenti/finestre-900.aspx?c=1043. Per l’edizione a stampa si veda: A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2008; un’edizione precedente delle lettere di Moro era stata pubblicata in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro». Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Brigate rosse, Kaos, Milano 1997.
278
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
terra-aria Sam-7 Strela, di fabbricazione sovietica, nascosti nel bagagliaio dell’auto in cui viaggiavano. Secondo i documenti raccolti dalla Commissione Mitrokhin, a procurare gli Strela risulterà essere stata la primula rossa del terrorismo Ilich Ramirez Sanchez, detto “Carlos”, legato ad Abu Anzeh Saleh, insieme ad Abu Shreda Salem, un ufficiale del controspionaggio libico. Quando i magistrati, ignari degli accordi tra l’Italia e l’Olp, emisero delle sentenze di condanna, Habbash intervenne duramente, attraverso la difesa degli imputati e il collegio giudicante, sul governo, servendosi dei buoni uffici del colonnello Giovannone, affinché gli accordi venissero rispettati84. Infatti, un dirigente del Fronte per la liberazione della Palestina, Bassam Abu Sharif, in un’intervista a «Paese Sera» (12 gennaio 1980), sostenne che le armi sequestrate, cioè i due missili, erano di proprietà della loro organizzazione. Sul territorio italiano sarebbero state di transito, in quanto destinate a essere usate contro Israele. Molto legato all’uomo di Habbash, Abu Saleh Anzeh, lo stesso Giovannone, in una lettera rinvenuta in una relazione del generale Giuseppe Santovito, capo del Sismi, parlò di «totale estraneità» dell’Olp nel trasporto dei missili di Ortona. La logica della ragion politica più implacabile (quella dello Stato) indusse, dunque, questo funzionario dei servizi all’orecchio di Moro a mentire, cioè a cambiare le carte in tavola85. L’esito fu di trasformare le condanne in miti sanzioni e in una relativamente rapida scarcerazione di Saleh. Dunque, l’accordo, anche se stipulato a voce, funzionava. L’obiettivo di Moro fu quello, assai commendevole, di evitare all’Italia di fare da teatro di guerra del conflitto con Israele86, e di avere un buon mediatore sui rifornimenti (e sul prezzo) del petrolio presso i paesi arabi. Si trattò anche, e anzi fu il prezzo pagato, di una aperta legittimazione del terrorismo arabo-palestinese. 84 Si veda l’attenta ricostruzione di G.P. PELIZZARO, Strage di Bologna, a un passo dalla verità, «Area», n. 7 (luglio-agosto 2005), pp. 13-18. 85 Rimando alla citata sentenza-ordinanza di Carlo Mastelloni, pp. 257-260. 86 Ne sono testimonianza le sue lettere dal carcere delle Br a Luigi Cottafavi, Flaminio Piccoli, Erminio Pennacchini, Renato Dell’Andro, Riccardo Misasi e al Partito della Democrazia cristiana, riportate in A. MORO, Lettere dalla prigionia, cit. e in S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro», cit. e anche nel sito Internet http://archivio900.it/documenti/finestre-900.aspxc=1043.
279
SALVATORE SECHI
Ciò non poteva che suscitare allarme, paura e un continuo stato di insicurezza e di ansia a Gerusalemme. Ai due episodi prima citati ne seguirono altri87. Negli ultimi 10 giorni di detenzione nella prigione delle Br Moro cercò di giocare la propria sopravvivenza. La affidò allo scambio con alcuni prigionieri “politici” brigatisti, richiamando ai suoi compagni di partito la tradizione di trattative e compromessi che il governo italiano aveva saputo praticare per salvare la vita di molti terroristi palestinesi88. Moro tessé in qualche modo l’elogio di uno Stato e di un governo come quello italiano che sempre, in passato, alla politica dell’intransigenza avevano preferito quella del negoziato, sulla base di un’intesa precisa, anche se non scritta (quindi informale) e affidata alla pura e semplice responsabilità dei contraenti89. Scrivendo a Renato Dell’Andro, durante la detenzione nel carcere brigatista, ricorda l’obiettivo degli accordi con i palestinesi: «allo scopo di stornare grave danno minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata». Più esplicitamente lo fa in una lettera al suo partito, la Dc: … per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. E, si noti, si trattava di minacce serie, temibili […] La necessità di fare uno strappo alla regola della legalità formale (in cambio c’era l’esilio) era stata riconosciuta90.
Della contrarietà alla trattativa si faranno alfieri il Pci, il Pri, il Psdi, Pertini, Andreotti, lo stesso Cossiga, Valiani ecc. Il secondo corno del
87
A farsene eco è Mino PECORELLI sulla sua rivista «Op» (Osservatore Politico), 10 ottobre 1978 e lo stesso generale Vito Miceli nell’intervista resa a Mario SCIALOJA, «L’Espresso», 10 marzo 1981. 88 Maestro di questa “diplomazia parallela” sarebbe stato il colonnello Stefano Giovannone, che affronterà da solo, senza il minimo sostegno del ceto politico, il calvario giudiziario legato a questa vicenda. Cfr. F. MARTINI, Nome in codice Ulisse, Rizzoli, Milano 1999, pp. 78-91, passim. 89 Una buona sintesi ne offre un giornalista attento e ben informato, Mino Pecorelli, nel suo commento alle lettere di Moro nella rivista «Op» (Osservatorio Politico), 10 ottobre 1978 (debbo il testo al dott. Roberto Bartali, che ringrazio). 90 Cfr. A. MORO, Lettere dalla prigionia, cit. e S. FLAMIGNI, «Il mio sangue ricadrà su di loro», cit.
280
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
dilemma sarà perseguito dal papa, dai socialisti di Craxi, dai radicali e da una parte della stessa Dc. A Moro (e a questi ultimi) si deve la ragione per la quale l’Italia poté godere, per un lungo periodo di tempo, di una relativa pace garantita proprio dall’essere stata esclusa, con uno scambio, dal teatro della sanguinosa contesa tra Israele e l’Olp91. Purtroppo De Lutiis si limita a indicare in bibliografia, a fini di puro decoro, molti di questi testi, ma in realtà non li ritiene degni di alcuna particolare menzione. In questo modo, finisce per andare, credo, al di là delle sue stesse intenzioni, contribuendo a mantenere il silenzio sull’esistenza di una corposa linea di politica estera parallela a quella ufficiale creata da Moro per favorire l’Olp. Perché tacere che, in linea teorica, possa essere stato interesse di Tel Aviv togliere di mezzo, o vedere sparire dalla scena politica, l’artefice di questa tortuosa e rischiosissima diplomazia? Il desiderio di farla finire mi pare il solido motivo per cui Israele sin dall’inizio alle Br sembra abbia offerto armi, soldi e soprattutto informazioni preziosissime. E probabilmente qualcosa di più, come De Lutiis insinua, cioè il “controllo” del capo delle nuove Br, Mario Moretti. Se non si può dire sia tenero con la Cia e col Mossad, De Lutiis non è malthusiano, cioè di manica stretta nel denunciare l’attività del Kgb nell’Urss e nell’Europa orientale. Il ruolo del Kgb Nelle trame che si costruirono intorno al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro, presentato come una vero e proprio golpe, il ruolo del servizio di contro-spionaggio sovietico è confermato dal giudice Rosario Priore che ha firmato l’introduzione al volume di De Lutiis. Ma in più occasioni, e con profitto, per la sua esperienza e probità, egli è stato sentito da diverse commissioni parlamentari d’inchiesta. 91
Questa vicenda è ben descritta in un bel saggio (non contagiato dal virus complottistico) di S. MARCHESE, I collegamenti internazionali del terrorismo italiano (dagli Atti giudiziari), cit., e nel romanzo del sottosegretario al Ministero dell’Interno F. MAZZOLA, I giorni del diluvio (pubblicato anonimo da Rusconi nel 1985, è stato riedito da Nino Aragno Editore, Torino 2007). In maniera documentata, distesa e realistica se ne trova un’esposizione nella Relazione sul gruppo Separat e il contesto dell’attentato del 2 agosto 1980 (depositata all’archivio della Commissione Mitrokhin dai consulenti Lorenzo MATASSA e Gian Paolo PELIZZARO).
281
SALVATORE SECHI
Di recente Priore ha dichiarato: «Il sequestro Moro fu una copia di quello di Schleyer compiuto dalla Raf supercollegata con la Stasi. Ed è evidente solo la presenza di servizi del campo orientale: dall’agente Sokolov al colonnello Conforto del Kgb»92. Malgrado questa evidenza di un magistrato capace e suo estimatore, De Lutiis stranamente attribuisce a Yalta la responsabilità di aver abbandonato i cittadini… a comportamenti repressivi del dissenso interno che gli autori di queste condotte sapevano di essere coperti dalla necessitata inerzia – al di là di scontate dichiarazioni di denuncia – dei vertici politici occidentali (p. XXXIX).
L’idea che questi potessero intervenire in Cecoslovacchia, Germania orientale, Polonia, Ungheria, nella stessa Urss, per impedire la repressione dell’opposizione interna, denota una concezione della guerra fredda che sfortunatamente non è stata sperimentata. Essa non presupponeva un sistema di frontiere aperte, ma si fondava sul rispetto di limiti precisi, cioè su una serie di confini (geografici, comportamentali ecc.) che i membri dei due blocchi non potevano superare, come dirò più avanti, se si voleva evitare una deflagrazione “calda” della guerra. Nell’estate del 1968 la Cia non intervenne a Praga, dove aveva un solo uomo, e non incoraggiò nessun gruppo di opposizione a pensare di potere contare sul suo appoggio93. 92
Rosario PRIORE, I servizi stranieri ebbero notizie prima, «Corriere della Sera», 15 novembre 2007, p. 21. Di opinione radicalmente diversa è V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit. 93 A dispetto della martellante propaganda sovietica sul ruolo svolto dagli imperialisti americani. Si veda The Prague Spring 1968, a cura di Jaromír Navrátil, CEU Press, Budapest 1998, p. xviii. Si veda anche John G. MCGINN, The Politics of Collective Inaction. NATO’S Response to the Prague Spring, «Journal of Cold War Studies», vol. 1, n. 3 (autunno 1999), pp. 111-138. Anche in Ungheria nel 1956 non ci fu alcuna attività. Non solo Washington fu colta di sorpresa, ma la Cia non aveva nessun uomo che parlava ungherese nella stazione di Vienna e a Budapest aveva un solo agente, peraltro occupato in mansioni di routine in ambasciata. Si veda Fernando ORLANDI, Il movimento comunista e la svolta del ’56, «East», n. 12 (dicembre 2006), p. 189; e Charles GATI, Failed Illusions, Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, Washington-Stanford 2006, pp. 5 e 71-73.
282
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Poco credibile, anche se diffusa, mi pare la convinzione che la “strategia della tensione” possa essere stata annunciata, anzi illustrata pubblicamente, per la parte teorica, in un convegno pubblico come quello dell’Hotel Parco dei Principi tenutosi a Roma dal 3 al 5 maggio 1965, con interventi di Guido Giannettini, di Renato Mieli, del colonnello dell’esercito Adriano Magi Braschi ecc. (p. XXIX). Coinvolgere Mieli in questa strategia è sinceramente improprio. Non so che cosa contenga il dossier su di lui messo insieme dai nostri servizi. Alla polizia, l’ex segretario di Togliatti appare come un dandy, amante di belle donne, appassionato di auto ultimo modello e, in generale, della vita comoda, resa possibile da fonti di lavoro assai remunerative, ma anche come uno studioso, non molto amico, ma critico intelligente e documentato, del Pci. Mi chiedo se non sia per fare agli ex-comunisti un regalo a scoppio ritardato, che si voglia liquidare Mieli come uno che teorizza la destabilizzazione politica a colpi di timer e di bombe innescate sotto i treni o dentro le banche. Sorprendente, però, trovarlo in una compagnia certamente impropria. Utili e ben centrate sono le pagine 1-18, 20-24 del libro di De Lutiis sui buchi aperti dell’inchiesta su Moro. Mi riferisco alla mancata prevenzione dei pericoli che correva la sua vita, alla (presunta) allucinante decisione, dopo il 1974, di quattro corpi investigativi e d’intelligence di non infiltrare nessuno – dopo Girotto e Pisetta e qualcun altro – tra le Br. Sfarzosi furono l’impotenza di fermi e posti di blocco, da Aosta a Trapani94 e il silenzio seguito sulla precisa ubicazione dei luoghi in cui Moro venne tenuto prigioniero. Imbarazzante fu il trattamento dei pentiti che in cambio dei benefici di pena non furono in grado di dire nulla sulle modalità del sequestro e dell’omicidio negando anche di avervi preso parte ecc. Si fece in modo che le Br facessero quel che volevano. Trovo impressionante, e ben ricostruita, anche la vicenda delle “vecchie e nuove” Brigate rosse, la denuncia delle inadempienze degli apparati di prevenzione e repressione (che infiltrarono le Br, ma le lasciarono operare senza muovere un dito fino al compimento del de94
Per pedinare i ragazzi dell’Autonomia e arrivare fino al covo-prigione di Moro sarebbero bastati appena 12 dei 4300 agenti impegnati ad annaspare a Roma, come disse Leonardo Sciascia alla Commissione parlamentare d’inchiesta Moro e conferma lo stesso De Lutiis.
283
SALVATORE SECHI
litto Moro), il compatto persistente silenzio sulla prigione, o meglio sulle prigioni, in cui Moro fu detenuto, la sottovalutazione del ruolo della criminalità organizzata ecc. Oscuro e centrale viene definito il ruolo di Giovanni Senzani e dell’Hypérion di Corrado Simioni95. Tutto il male che De Lutiis distilla, non sempre a torto, ma non sempre a ragione, sul nostro servizio avrebbe dovuto sostare, riconoscendo, oltre a quanto ricorda “Ulisse” (cioè l’ammiraglio Martini) nel suo volume, anche l’ottimo lavoro fatto su tre questioni delicate e importanti. 1. La documentazione sulle tangenti pagate al Pci (più precisamente: a società di intermediazione commerciale promosse dai comunisti) dalle imprese pubbliche e private di import-export con i paesi dell’Europa orientale. Molto di più si dovrebbe trovare nelle carte della Nato e della Guardia di Finanza, 2. La documentazione sulla formazione della struttura para-militare clandestina del Pci, il suo braccio armato in Cecoslovacchia dopo il 25 aprile 1945, 3. La capacità assicurata ai governi italiani, dopo l’attentato sanguinoso dei palestinesi all’aereo della Pan Am nell’aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973, di potere svolgere una “diplomazia parallela”, sostenendo le rivendicazioni e gli interessi dei palestinesi, senza (apparentemente) compromettere i buoni rapporti con Israele. Una politica tanto ambigua, giocata sul filo del rasoio, che impedisce sia un’efficace lotta al terrorismo palestinese sia una convincente difesa delle ragioni di sicurezza dello Stato israeliano. Per i primi due punti, tutto il materiale, assai esteso e convincente, è rinvenibile in un archivio che De Lutiis conosce perfettamente, come quello della Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi e sul caso Moro. Egli fu rapito, processato e assassinato dal gruppo dirigente delle Brigate rosse: «Sono state un fenomeno tutto italiano e di sicura matrice di estrema sinistra» (p. XXXIX). Si può aggiungere una precisazione alla quale De Lutiis rilutta o fa a mezza bocca. I membri delle Br venivano da un lontano passato segnato, in entrambi i casi, da radicalismo politico, cioè dalle file neo-fa95
Di questo aspetto si è occupato più distesamente, di recente, nel saggio G. DE LUTIIS, La vicenda Hypérion, in AV.VV., Il sequestro di verità. I buchi neri del delitto Moro, Kaos, Milano 2008, pp.189-211.
284
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
sciste (come Renato Curcio e Valerio Morucci) e in prevalenza dalle sezioni del Pci. Comunque, anche i primi, una volta abbandonate le fila missine, si erano formati nella cultura, nella militanza e nell’organizzazione dei comunisti. Erano figli, anche se non esecutori delegati, di una storia precisa, quella della sezione italiana dell’Internazionale comunista e del Cominform. L’importanza cruciale, e documentabile, del carattere italiano del sovversivismo che domina la vicenda Moro è stata sottolineata con forza nei lavori di Vladimiro Satta. Anche quando non li si condivida per un eccessivo amore di tesi, come mi pare sia il caso di De Lutiis, non possono essere ignorati, soprattutto per l’acutezza di molte parti e per la riflessione sull’interpretazione dei documenti che sollecitano96. Questa idea della natura indigena, tutta italiana, del brigatismo rosso non risulta essere stata, se non in misura occasionale, utilizzata. Si può, anzi, dire che progressivamente nello scorrere dei capitoli del saggio di De Lutiis scemi. Direi di più, cioè che giustapponendosi ad una serie di altri innesti, integrazioni, rilievi critici di cui il sociologo romano arricchisce, ma anche inonda, il suo lavoro, si appanna fin quasi a scomparire. Dalla radice italiana del brigatismo alla logica di Yalta Al suo posto emergono, occupando quasi interamente la scena, due altri aspetti. Non hanno natura documentale, ma si tratta di congetture, indizi. Niente di più. In primo luogo la convinzione, espressa come un’ipotesi, che «prima o durante il sequestro, ristrettissimi vertici delle Br siano entrati in contatto con elementi che operavano per conto di ambienti molto influenti a livello internazionale» e da essi abbiano appreso che il sequestro di Moro doveva avere la conclusione che ebbe, cioè la morte di Moro. In secondo luogo La logica di Yalta esigeva – secondo De Lutiis – che, con quel gesto, venisse di fatto impedito che i comunisti entrassero, sia pure in posizione subordinata, in un governo di coalizione in Occidente. Questa eventualità era troppo pericolosa sul piano militare per gli Stati Uniti 96
Mi riferisco a V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit.
285
SALVATORE SECHI
e addirittura devastante per la nomenklatura sovietica, perché l’esempio di un partito comunista democraticamente votato dagli italiani che entra in coalizione con partiti di altra estrazione avrebbe risvegliato antiche e giuste aspirazioni tra quei popoli dell’Europa orientale per i quali l’alleanza con l’Unione sovietica si era trasformata in un vassallaggio forzoso (p. XL).
Era quanto, e De Lutiis non lo ignora, aveva compreso, e descritto, un giornalista molto informato e per nulla banale, Mino Pecorelli97. Ed è l’asse portante della ricca saggistica, diventata oggetto di culto, dell’ex-deputato comunista Sergio Flamigni, e della stessa relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani. Mi chiedo che senso avesse uccidere Moro e attentare alla vita dello stesso Berlinguer, di cui il leader democristiano si fece garante presso la sua gente e in seno all’alleanza atlantica, e che la politica dell’euro-comunismo tendeva a legittimare. Si trattava di un’illusione. Veniva infatti accreditata una grande speranza rivelatasi fallace, cioè l’auto-riformabilità del comunismo. L’intervento sovietico a Praga nel 1968 la condannò come un investimento velleitario, una fiducia malriposta, dunque una strada interna senza uscite. Mi pare interessante, sul punto, la riflessione avviata da tempo da Adriano Guerra. D’altro canto, l’isolamento in cui il popolo ceco venne lasciato dall’Occidente dimostrò che quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di alimentare e guidare rivolte o insurrezioni all’interno del blocco comunista né di consentire esperimenti, come quello di Salvador Allende in Cile, che avessero come protagonisti di cambiamenti i partiti comunisti. Era, insomma, la logica della guerra fredda. Non ammetteva deroghe, e finì per colpire la stessa strategia del compromesso storico. 97
Mino PECORELLI, Processo, crocifissione, morte, resurrezione di Aldo Moro, «Op», 2 maggio 1978 (ora anche nella raccolta curata da S. FLAMIGNI, Le idi di marzo. Il delitto Moro secondo Mino Pecorelli, cit., pp. 291-296. Su Pecorelli si vedano Francesco PECORELLI e Roberto SOMMELLA, I veleni di “OP”. Le “notizie riservate” di Mino Pecorelli, Kaos, Milano 1994 (1995); V. IACOPINO, Pecorelli-Op. Storia di un’agenzia giornalistica, SugarcCo, Milano 1981; Marco CORRIAS e Roberto DUIZ, Mino Pecorelli. Un uomo che sapeva troppo, Sperling & Kupfer, Milano 1996; e Memoriale Pecorelli. Dalla Andreotti alla Zeta, a cura di Franca Mangiavacca, 2 voll., International Eiles, Roma 1996.
286
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Verrà lasciata cadere proprio perché, insieme alla primavera di Praga e al rinnovato fronte popolare cileno, alterava i confini di quanto, finché durava la guerra fredda, era condivisibile, e quindi realistico, da parte di Mosca e Washington. Per tale ragione, la politica dell’eurocomunismo fu avversata dall’amministrazione Carter, convinta che equivalesse all’introduzione nella comunità atlantica di una quinta colonna sovietica. Ma ebbe, congiuntamente, l’ostilità dei sovietici che la considerarono un cavallo di Troia destinato a far saltare i precari equilibri, cioè la sostanziale instabilità esistente nel blocco orientale, tenuto insieme dal pericolo di una marcia dell’Armata rossa nelle pianure europee. All’inizio degli anni Ottanta Mosca arrivò al punto di finanziare un lavoro frazionistico, a favore dell’ala filo-sovietica, all’interno del Pci. E contemporaneamente, ma per un brevissimo periodo di tempo, si ebbe la fine dell’alimentazione finanziaria del partito da Mosca. Di qui scaturì, come ha rilevato Massimo D’Alema, l’isolamento internazionale del Pci e una riflessione che porta, nel 1989, i comunisti italiani a resecare i rapporti con l’Urss, nella quale, malgrado complessità e «a tratti» anche conflitti, «la lunga storia del comunismo italiano è totalmente iscritta»98. Per superare «la centralità ed il carattere costituivo, anche in quella fase [cioè nel 1989, nota mia], del rapporto con Mosca» sarà necessario collocare il Partito democratico della sinistra, come fece Occhetto, nel socialismo europeo. Così stando le cose, l’interpretazione di De Lutiis della politica americana come epicentro dell’imperialismo, che punta a tenere soggiogata l’Italia e i principali leader di governo, come Moro, lascia perplessi. Il termine e anche il periodo storico per quale si può usarla sono assai vaghi, dal momento che il generoso aiuto sovietico (circa 60 miliardi all’anno di vecchie lire)99 arriva fino alle soglie del passaggio del Pci nel campo della socialdemocrazia nel 1989. Nel caso Moro la partita si sarebbe giocata su un’ampia scacchiera, ma con obiettivi convergenti, se non comuni, tra Washington e Mosca, tra Cia e Kgb, compreso il Mossad, a partire da quello di porre fine all’esistenza terrena di Moro. 98
Si veda l’intervento al convegno Il Pci nell’Italia repubblicana, tenuto a Roma il 25 e 26 maggio 2000, i cui atti sono stati pubblicati con lo stesso titolo, a cura di Roberto Gualtieri, Carocci, Roma 2001, pp. 349-350. 99 Valerio RIVA, Oro da Mosca, Mondadori, Milano 1999.
287
SALVATORE SECHI
Come si vedrà, nel corso della narrazione De Lutiis abbandona quasi subito l’identità di «fenomeno tutto italiano», meglio dire lo specifico delle Br, cioè di essere una forza di estrema sinistra che intendeva scompaginare gli equilibri politici dell’Italia, colpire il disegno del compromesso storico tra Dc e Pci, mostrare l’inefficienza e la debolezza dello Stato e dei suoi apparati di prevenzione e repressione, indicando così come praticabile una politica alternativa, cioè rivoluzionaria. Lo studioso romano sembra, invece, quasi esclusivamente interessato a che cosa si muove dietro questo scenario, cioè al mondo delle ombre, come da (inevitabile) deformazione professionale, se mi consente questa amichevole malizia. Il libro è, infatti, una ricca galleria di personaggi, di ogni calibro, e soprattutto di chi si suppone ordisca intrighi o trappole e manovri le stesse Br in un contesto più vasto di quello del territorio nazionale. Sarebbe il caso del servizio segreto israeliano e soprattutto della Cia. Gli “ultraclandestini” Si tratta probabilmente di quanto Renato Curcio aveva rivelato, nelle more del comune soggiorno in una cella, all’agente della Cia, Ronald Stark, e il magistrato romano Rosario Priore evoca nell’introduzione: Le Br […] sono soltanto una parte di un più vasto movimento rivoluzionario che risale agli anni immediatamente successivi alla fine dell’ultimo conflitto mondiale. In particolare il ‘movimento’ sarebbe costituito da un gruppo di ‘ultra-clandestini’ formato dai fondatori del movimento, ex partigiani che non hanno mai abbandonato l’idea di prendere il potere con le armi. Costoro vivono nell’ombra e hanno la direzione strategica del movimento stesso (p. XVIII)100. 100
La più serrata analisi di questa colonna armata del Pci in Cecoslovacchia è scarsamente nota e quasi mai citata. Mi riferisco a Rocco TURI, Gladio rossa. Una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra al caso Moro, Marsilio, Venezia 2004. Dimenticando che si tratta di persone condannate per delitti infami (assassini, torture, violenze private ecc.), parla, invece, con un afflato quasi risorgimentale, di «un piccolo gruppo di ex partigiani costretti ad abbandonare il paese dove avevano combattuto per la libertà e vivere in esilio» lo storico scozzese Philip COOKE, ‘Oggi in Italia’. La voce della verità e della pace nell’Italia della guerra fredda, «L’Impegno», a. 27, n. 1 (giugno 2007), pp. 39-54. A sua volta egli offre una visione idilliaca, smentita da tutti i documenti d’archivio del Ministero dell’Interno, della Presidenza del
288
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Si diedero una solida base finanziaria grazie alle lucrose rendite provenienti dall’attività dello spionaggio industriale e militare. In realtà, i gruppi clandestini, che comprendevano spesso certi “repubblichini”, arruolati ora dagli alleati ora dai nazi-fascisti ora dai comunisti, ora dai servizi segreti di tutte le parti, furono molti101. Che cos’era questa struttura di cui parla Priore? Purtroppo ne sappiamo ancora molto poco. Essa operò parallelamente a quella dei servizi, e se ne trova traccia nelle carte rinvenute nel 1990 in via Monte Nevoso. Ad avere sentore della sua esistenza, a seguito degli attentati di Savona, fin dal 1974-75 fu il generale Dalla Chiesa, che affidò al suo più fidato collaboratore, il generale Nicolò Bozzo, ricerche e verifiche. Si trattò di un’organizzazione risalente alla guerra di liberazione, costituita dal collegamento tra elementi della destra eversiva, della massoneria, dei settori dei servizi deviati e della criminalità organizzata. A metterle insieme sarebbero stati i servizi italiani e quelli alleati in nome di una comune preoccupazione, cioè che a dominare il dopoguerra, considerati i rapporti di forza delineatisi nella guerra di liberazione, potessero essere le sinistre. Pertanto, si crearono squadre di infiltrati, di ogni rango, nelle formazioni partigiane comuniste, socialiste e azioniste. Esse passarono le informazioni al nemico, cioè ai nazi-fascisti in modo che potessero annientare i reparti dei combattenti partigiani e, in questo modo, impedire loro di ipotecare la politica del dopoguerra. Il generale Bozzo, nel 1990, troverà nelle carte di Moro di via Monte Nevoso «una parte concernente proprio una struttura parallela dei servizi», cioè «qualcosa di molto simile a ciò di cui il generale mi parlava»102. Consiglio dei ministri, del controspionaggio e dai documenti acquisiti dai magistrati romani nel procedimento sulla “Gladio rossa”. Lo fa in Da partigiano a quadro di partito: l’educazione degli emigrati politici italiani in Cecoslovacchia, «Ricerche Storiche», n. 101 (aprile 2006), pp. 9-38. Per la verità le fonti cecoslovacche, citate da Fernando Orlandi nel saggio compreso in questo volume, sembrano autorizzare la versione di Cooke. 101 Insieme ad A. Giannuli, S. Flamigni, G. Flamini, lo stesso De Lutiis, Giovanni Pellegrino ne ha fatto una radiografia nell’intervista a Giovanni FASANELLA, La guerra civile, Rizzoli, Milano 2005, p. 24 e passim. 102 È quanto sul noto servizio “Anello” il generale Nicolò Bozzo dichiara agli inquirenti Franco Ionta e Francesco Nitto Palma l’11 maggio 1993, e ha confermato a me e a Roberto Bartali in un’intervista, a Genova, in data 6 o 7 novembre 2007.
289
SALVATORE SECHI
Mi chiedo se non si tratti del servizio di informazioni creato dopo il 1945 dall’ex capo del Sim generale Mario Roatta, che restò in funzione fino al 1972 con un organico di circa 200 persone. Il suo compito era di impedire l’avvento delle sinistre al governo, di ostacolarne l’avanzata incrinando così l’equilibrio esistente103. A questa descrizione, secondo Dalla Chiesa e Nicolò Bozzo, corrispondeva la formazione partigiana Franchi, creata dall’ambasciatore Edgardo Sogno, sia la Gladio. Successivamente confluirà nel Comitato di resistenza democratica, che faceva capo a Luigi Cavallo, Edgardo Sogno, Aldo Garosci, Nicola Matteucci, al magistrato milanese Adolfo Beria d’Argentine e su un altro piano a Renato Mieli. Il loro ruolo è demonizzato e svilito perché De Lutiis non riesce a concepire, come gran parte della storiografia italiana, l’esistenza di un anti-comunismo democratico. Tale fu quello de «Il Ponte», «Tempo Presente», «Lo Spettatore Italiano», «Il Mondo», «L’Espresso» ecc. I comunisti sospettarono sempre che fossero dei manutengoli della Cia, solo perché magari spuntavano qualche finanziamento per cause condivise come quella, che oggi appare benemerita, di arginare l’influenza di partiti e movimenti filosovietici. È improprio che uno studioso possa tacere sui pericoli che sono stati fatti correre alla nostra gracile democrazia repubblicana dal Pci, con i suoi rapporti privilegiati con un nostro nemico, quale fu l’Unione sovietica, con la contestazione e la diffamazione dei nostri alleati della Nato, l’addestramento di quadri alla guerriglia e al terrorismo in Cecoslovacchia e in altri paesi, l’infiltrazione di tutti i corpi dello Stato e della società civile, comprese le forze armate104. Suscita, invece, qualche stupore che lo stesso studioso, quando parla di formazioni politiche moderate (come la brigata partigiana monarchica di Sogno, la Franchi, o i Comitati di resistenza democratica), solo perché sono anticomuniste, lo faccia infilandosi l’elmetto in testa. Infatti, le liquida come tentacoli di una trama eversiva di estrema destra e comunque reazionaria. 103
Venne rinvenuta in una relazione anonima tra le carte recuperate in un archivio di deposito del Ministero dell’Interno in circonvallazione Appia n. 132, a Roma, da A. Giannuli. Il lavoro più analitico è quello di S. LIMITI, L’anello, cit. 104 Rimando S. SECHI, Armi, radio ricetrasmittenti, corrieri e cifrari del Pci: la penetrazione nella società italiana negli anni Cinquanta, «Nuova Storia Contemporanea», a. XI, n. 2 (marzo-aprile 2007).
290
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Qui il pregiudizio politico rischia di coniugarsi con la disonestà scientifica, approdando ad una robusta falsificazione della storia. Fortunatamente De Lutiis, essendo un ricercatore e senza consegne dall’esterno, sa fermarsi per tempo sul crinale di questo precipizio. Non può negare che tanto Cavallo quanto Dotti e Vincenzo Tiberti abbiano partecipato alla lotta partigiana e siano stati militanti nelle fila del Pci. Il primo di essi, Luigi Cavallo, fu membro della redazione torinese del quotidiano «l’Unità» (e successivamente inviato); il secondo, Roberto Dotti, svolse anche funzioni di dirigente della federazione comunista di Torino. Emigrerà a Praga per l’omicidio di un fascista, Alberto Raviola, dei Far (Fasci di Azione Rivoluzionaria). Quando rientrò in Italia assunse un incarico presso la Terrazza Martini di Milano. Cavallo e Dotti lasciarono il Pci, approdando a “Pace e Libertà” e ai Comitati di resistenza democratica (in quest’ultimo Dotti, essendo una figura di minore prestigio, operò come segretario di Sogno). In generale, con l’eccezione di Norberto Bobbio, il destino degli anti-comunisti, nel clima da guerra fredda, in Italia fu di essere trattati come “utili idioti” o manutengoli della reazione. L’essere stati dei socialdemocratici, cioè favorevoli a grandi riforme, non trattenne la micidiale propaganda del Pci dal riservare loro i peggiori maltrattamenti. Dal delitto Codecà a “Pace e Libertà” De Lutiis si sofferma ampiamente, oltreché su una figura-chiave come quella di Roberto Dotti105, sull’assassinio, avvenuto il 16 aprile 1952, di Eleuterio Codecà. Nato a Ferrara, dirigente di stabilimento della Fiat aveva lavorato a Berlino e a Bucarest. Al suo rientro a Torino fu responsabile di settori strategici e in generale il garante delle relazioni, mai intaccate dal mutare del clima politico a livello dei governi, con i paesi dell’Europa orientale. Fu un omicidio politico quello dell’ingegner Codecà? In questa chiave di “pericolo rosso” venne giocato dalla polizia e dagli avversari del Pci sin dal primo momento106.
105
Un profilo redatto sulla base della scarsa documentazione esistente si deve a R. BARTALI, Infiltrati nelle Brigate rosse, in AV.VV., Il sequestro di verità, cit., pp. 19-60. 106 Si veda, cinque giorni dopo il delitto, quanto scrive Celeste NEGARVILLE, Il delitto di Torino, «l’Unità», 2 aprile 1952, edizione piemontese.
291
SALVATORE SECHI
È certo che Dotti non riceverà nessuna imputazione di reato, ma la polizia sospettò che potesse esserne stato l’autore. Dirigeva l’ufficio quadri della federazione torinese del Pci, ed era anche ritenuto, a ragione o a torto, uno degli esponenti del suo apparato para-militare. Gli ambienti del Pci di Milano erano dell’opinione che tale colpo fosse stato commesso da un ex-gappista, data la particolare tecnica seguita nella consumazione del delitto stesso. Anche se delle Squadre di azione patriottica (Sap) Dotti aveva fatto parte, nel Pci lombardo si è propensi a credere che il Pci torinese, colpendo Codecà con una calibro 9 abbia voluto dare un avvertimento alla Fiat. Veniva cioè esortata a smetterla di allontanare dal ‘complesso’ i più facinorosi attivisti e responsabili sindacali, tattica che, a lungo andare, avrebbe neutralizzato le fatiche del partito e delle sue organizzazioni nel creare e mantenere la poderosa zona rossa fra i dipendenti del massimo complesso industriale italiano107.
A Torino il Pci avrebbe adottato la stessa tecnica adottata a Milano nei confronti della Volante rossa: invece di dare l’ordine di eseguire direttamente il colpo, si compiaceva quando esso andava a segno, cioè veniva data una “lezione” a qualcuno. Con l’esecuzione di Codecà si volle porre fine allo smembramento dell’apparato politico della Fiat, che per la sua importanza nazionale pare venisse seguito personalmente da Luigi Longo108. Resta aperta la domanda: come mai Vittorio Valletta, dopo avere affidato lo svolgimento di un’inchiesta riservata sul delitto a due investigatori privati di Milano, Costante Gandini109 e Filippo Argenti, 15 mesi dopo li ha fatti desistere? 107
Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione centrale della polizia di prevenzione, Nota del 24 aprile 1952, prot. n. 224/11924, inviata al capo della polizia, nel fascicolo intestato a “Eleuterio Codecà”, Categ. B. 108 Renzo GIANOTTI, Enigma Codecà. Uno sparo in via Villa della Regina, Spoon River, Torino 2002. 109 Su questa ambigua figura di investigatore si veda quanto riferisce la questura di Torino in data 15 ottobre 1954, Indagini delitto Codecà, p. 8. Gandini era un ex-fascista, espulso per tradimento dal Pnf, delatore al servizio dei nazi-fascisti ai quali consegnò dei partigiani per farne oggetto di rappresaglie come la deportazione. Fu anche collaboratore dell’intelligence britannica fino al 1950, anno in cui venne sconfessato perché intratteneva rapporti anche con dirigenti del Pci.
292
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Il pretesto fu la decisione di consegnare prima al ministro Scelba e successivamente al dottor Ugo Barletta, ispettore generale capo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, i documenti e le prove raccolti. In realtà, a questi personaggi non giunse niente. Valletta passò, invece, a un funzionario di polizia della questura di Torino le copie delle due relazioni, datate 6 settembre e 24 ottobre 1952 avute dal milanese Istituto di Investigazioni Private Gandini. In altre parole, secondo la polizia la Fiat volle mettere a tacere la vicenda, lasciando invendicata la morte di un suo alto dirigente, «per non affrontare un dibattito giudiziario, che avrebbe portato in luce magagne che la Fiat vuol nascondere»110. A questo punto, De Lutiis si fa scrupolo di «ricordare brevemente al lettore che cosa hanno rappresentato, nella storia italiana, “Pace e Libertà” e i Comitati di resistenza democratica» (p. 35). Temo che purtroppo si tratti di bolle di sapone. Contro “Pace e Libertà” i capi d’accusa sono due, e vengono tratti da rapporti del servizio segreto (Sifar). Il primo: il programma di schedare gli attivisti del Pci e le maestranze comuniste. Si trattò di un suggerimento della Cia e dell’ambasciata americana111. Ma fu schedatura politico-personale o solo allestimento di un indirizzario? Mi pare opportuno ricordare che a curarla, per solo 10 mesi, fu Luigi Cavallo, un dirigente ex comunista. Giornalista e saggista, forse anche per aver denunciato, nel 1949, il «Dio che è fallito», lo scandalo Ingic ecc. verrà successivamente imputato di ogni nefandezza. 110 Si veda la nota, a firma Sq54, Milano, 8 maggio 1954, sulla pubblicazione da parte della rivista «Il Borghese», nel numero datato 30 aprile 1954, di una Lettera alla signora Codecà. Essa consiste nel rifriggere, spillando nuovi soldi all’editore dopo quelli (circa 7 milioni e un’automobile) pagati dalla Fiat, le informazioni che erano state già date a Valletta. Seguirà la pubblicazione a puntate, nel 1954 sul «Secolo d’Italia», de Il caso Montesi n. 2. Cerchiamo un assassino, a cura di Franz Maria d’Asaro e Felice B. Faustini. La questura di Torino fece svolgere minuziosi accertamenti, per concludere che quelli dell’Istituto Gandini erano privi di qualunque fondamento. Si veda il fascicolo intestato a Eleuterio Codecà, e in particolare il rapporto Indagini delitto Codecà, 15 ottobre 1954 inviato al consigliere istruttore presso la Corte d’Appello di Torino, e quello, con lo stesso titolo, del questore Ferrante, di Torino, alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in data 19 ottobre 1954. 111 Giangiacomo MIGONE, Stati Uniti, Fiat e repressione antioperaia negli anni cinquanta, «Rivista di Storia Contemporanea», a. 3, n. 2 (1974), pp. 232-281.
293
SALVATORE SECHI
In realtà, fu Togliatti a munire il suo partito, modellato su un’esperienza clandestina durata 20 anni, di un servizio informativo, lo Spi (Servizio Informazioni Politiche). Ad esso si deve la raccolta di schede sia sugli anti-comunisti (indirizzi, abitudini, metodi di lotta ecc. al fine di neutralizzarli) sia su semplici iscritti e dirigenti del partito in maniera da poterli sottoporre a disciplina112. Era un comportamento che replicava quanto faceva il Pcus in Urss e anche l’ambasciata sovietica a Roma. Per trasmettere ordini e per assolvere al ruolo di “partito di riserva”113 aveva dato vita ad un’organizzazione di propria assoluta fiducia, che poteva tornare utile nel caso di un ritorno del partito nella clandestinità. La magistratura romana, che si era occupata del procedimento sulla “Gladio rossa”, calcolava che questi fiduciari del Pcus all’interno del Pci fossero circa un migliaio, di cui 50 solo a Roma. A questo lavoro di intelligence, negli anni Settanta, per conto del suo partito, ha partecipato il sindacalista genovese Guido Rossa. Compilò circa 14 faldoni di indirizzi, operai, dirigenti, ecc., mentre lavorava all’Ansaldo114. De Lutiis non vi fa minimamente cenno. Così non sappiamo se il lavoro di schedatura richiesto dal Pci ai propri militanti (in fabbrica, nell’esercito, nella polizia, negli uffici pubblici ecc.) era lecito e commendevole, anche se era uguale e identico, come una goccia d’acqua, a quello che si propose di fare l’esecrata “Pace e Libertà”. Secondo: sollecitare finanziamenti all’ambasciatrice Usa a Roma. Clare Boothe Luce intervenne a favore di questo movimento sia sul presidente Eisenhower (con scarso o nessun esito) sia sull’allora premier Mario Scelba, ma anche sulla Fiat, sulla Viberti e sui Pirelli, che invece lo sosterranno. Il Pci per la verità non fu da meno nei confronti di una parte degli stessi industriali. Quelli dediti all’import-export furono meticolosamente taglieggiati, esigendo una sorta di tassa prelevata su ogni affare, come hanno documentato i nostri efficientissimi servizi segreti. Il partito si avvalse anche di una scorta finanziaria sicura proveniente dall’estero: cioè i 60 miliardi all’anno rimessi dal Kgb e dal Pcus, come si è visto. 112
Si veda Virgilio ILARI, Guerra civile, Ideazione, Roma 2001. Si veda il saggio, vero e proprio apri-pista sull’argomento, di Maurizio CAPRARA, Lavoro riservato. I cassetti segreti del PCI, Feltrinelli, Milano 1997. 114 Cfr. l’intervista resa a Giovanni FASANELLA dalla figlia Sabina, Guido Rossa, mio padre, Rizzoli, Milano 2006. 113
294
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Terzo: riorganizzare i servizi di informazione della Nato, attraverso la creazione di nuclei o cellules nationales. Un organismo come “Pace e Libertà” poteva creare «un centro motore e coordinatore dell’azione anti-Comintern sul piano internazionale» (pp. 35-36). È curioso che mentre la storiografia si chiede se il comunismo non sia stata una dittatura simile, se non peggiore, del nazi-fascismo, De Lutiis consideri imperdonabile che dei movimenti anti-comunisti facciano le stesse cose che facevano gli organismi comunisti e filocomunisti, cioè si organizzino, battano cassa agli industriali e controllino molecolarmente i cittadini. Non quelli rispettosi delle leggi, ma i sospettati di mettere a soqquadro il regime democratico. Ancora più generica e inconsistente mi pare l’accusa rivolta al secondo movimento, i Comitati di resistenza democratica. Secondo De Lutiis, fu un gruppo di pressione «destinato a guidare nelle loro scelte elettorali, indicando uomini e partiti per cui votare, secondo una precisa scelta democratica e morale». Poiché in tutto ciò non è ravvisabile nulla di minimamente illegale, De Lutiis pensa di alzare il tiro notando che negli anni successivi ai primi anni Settanta questo «progetto politico presidenzialista […] assunse connotazioni golpiste» (p. 37). Il riferimento è alla loggia massonica P2115. È certamente inquietante leggere tra i suoi aderenti i nomi di noti uomini politici, giornalisti, imprenditori, dei più alti ufficiali dell’esercito, dei carabinieri, della polizia, della intelligence, della pubblica amministrazione. Era tutta gente di primo piano sul piano politico e militare. Avevano davvero bisogno di protezione o ciò che premeva loro, all’atto dell’iscrizione alla loggia, era la possibilità di fare più speditamente carriera e trovare gli appoggi più efficaci per farla? Credo sia il caso di ricordare che da quando esistono le regole dello Stato di diritto, accertare colpe e sanzioni è di competenza della magistratura. Ebbene, non uno di quelli della lunghissima lista di piduisti risulta condannato per l’adesione alla loggia “deviata”. Valga l’osservazione di un comunista ben attestato sulle posizioni della cultura liberal-democratica, Giovanni Pellegrino: «Sui singoli aderenti alla P2 di fatti illeciti paragonabili alle dimensioni dello scandalo non ne sono emersi: l’esito giudiziario della vicenda è stato sostanzialmente assolutorio»116.
115
Per un giudizio liquidatorio cfr. Sergio FLAMIGNI, Trame atlantiche. Storia della Loggia massonica segreta P2, cit. 116 G. FASANELLA e G. PELLEGRINO, La guerra civile, cit., p. 95.
295
SALVATORE SECHI
La P2 ebbe certamente un orientamento anti-comunista. Di qui il sostegno degli Stati Uniti e l’avversione del Kgb. Quest’ultimo, per poter screditare, ed anzi distruggere, i nostri servizi per la seconda volta, dopo avere venduto ai giornalisti del settimanale «L’Espresso» Lino Jannuzzi e Eugenio Scalfari la storiella del Piano Solo117, montò «il mito oscuro della P2»118. L’acquiescenza a una visione complottistica della storia temo spinga De Lutiis a denunciare l’influenza piduista sul Comitato di crisi creato da Cossiga al Viminale durante il sequestro Moro. Era un team filo-americano, e – come ha ricordato l’ex capo dello Stato – fu proprio il presidente della Dc, o esponenti della sinistra democristiana, a imporre in questo Comitato la presenza del direttore del Sisde Giulio Grassini, del Sismi Giuseppe Santovito, del segretario generale della Farnesina Francesco Malfatti di Montetretto, del prefetto Walter Pelosi, del banchiere (della Bnl) Alberto Ferrari. Comunque, mi limito a osservare che della leggenda nera sulla P2 fece parte l’accusa di essere favorevole alla forma presidenziale dello Stato. Il Pci, e il Kgb, rivelando la loro scarsa bibliografia, hanno creato l’equazione sciocca presidenzialismo=golpismo. Sinceramente non si vede che cosa ci sia di anti-democratico nel regime presidenziale. Basta leggere qualunque manuale di diritto costituzionale. In secondo luogo, il golpismo, di cui verrà accusato Licio Gelli, viene dopo, e Dotti non poteva essere ad esso associato essendo venuto a mancare agli inizi degli anni Settanta. In terzo luogo, come De Lutiis sa e riconosce, l’accusa dell’allora giudice istruttore Luciano Violante a carico di Luigi Cavallo, Remo Orlandini, dell’ex ministro Randolfo Pacciardi e di Edgardo Sogno, di avere dato vita ad un’associazione sovversiva, «al fine di mutare la Costituzio117
Si tratta dell’accusa mossa al comandante dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni De Lorenzo, di preparare (insieme al capo dello Stato Antonio Segni) un colpo di stato per impedire la formazione di un governo di centro-sinistra. La macchinazione fu ordita dal Kgb. Si veda anche la nota del figlio, Alessandro De Lorenzo, acquisita dal deputato di An, Vincenzo Fragalà, all’archivio della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokhin. In generale cfr. V. ILARI, Il generale col monocolo. Giovanni De Lorenzo (1907-1973), Nuove Ricerche, Ancona 1993. 118 Cfr. l’intervista a Francesco Cossiga di Aldo CAZZULLO, Il caso Moro e i comunisti. In mille sapevano dov’era, «Corriere della Sera», 14 novembre 2007, p. 17.
296
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
ne dello Stato e la forma di governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato», fu rigettata dalla Corte di Cassazione di Roma. Gli imputati furono prosciolti il 12 settembre 1978. Dunque, De Lutiis dopo aver promesso una caratterizzazione reazionaria e addirittura golpista delle due associazioni mi pare non riesca a invocare che un solo argomento, cioè l’anti-comunismo di chi le dirigeva. In Italia è considerato un atteggiamento non molto simpatetico ai valori di una parte (minoritaria) della popolazione. Ma ancora non è diventato un reato. Luigi Cavallo119 creò giornali e alimentò iniziative contro il comunismo sovietico, a carattere europeo, che ebbero il sostegno, anche finanziario, di Enrico Mattei, Konrad Adenauer, Vittorio Valletta ecc. Posso documentare che successivamente ad accollarsi tale onere fu la stessa rappresentanza sindacale degli imprenditori, cioè la Confindustria. Dotti pare sia stato un esponente dell’apparato militare del Pci (un argomento del quale De Lutiis non ama parlare) e vice-federale di questo partito in Piemonte. A conoscere il comunismo, vaccinandolo per sempre da ogni seduzione, fu probabilmente l’esperienza fatta nei due soggiorni in Cecoslovacchia. Dotti resta tuttavia una figura sfuggente, poco studiata e anche ambigua. Chi lo ha conosciuto dubita possa avere impartito lezioni di sabotaggio, che esige un’elevata specializzazione nell’uso delle armi e degli esplosivi. Pare che durante la Resistenza non abbia mai organizzato un gruppo armato né avuto la responsabilità di una scuola di addestramento politico o militare.
119
Per un’analisi costruita non di rado su una sorta di “intelligenza politica” delle cose (come è costume spesso nella sinistra) cfr. Alberto PAPUZZI, Il provocatore. Il caso Cavallo e la Fiat, Einaudi, Torino 1976. Un’estesa contestazione, sul piano dei fatti e dei documenti, è stata opposta da Luigi Cavallo a Papuzzi, nel corso di numerosi interventi sulla stampa. Cavallo fu un comandante partigiano (fondò e diresse Stella Rossa, il primo gruppo armato formatosi a Torino contro il nazi-fascismo), redattore e inviato del quotidiano «l’Unità», collaboratore di Togliatti ecc. Malgrado si fosse dimesso, sarà espulso dal Pci nel 1949 per avere denunciato la natura dispotica dei paesi di “democrazia popolare” e per aver solidarizzato con Tito contro Stalin.
297
SALVATORE SECHI
Emigrazione politica e addestramento militare in Cecoslovacchia Posso integrare le informazioni di De Lutiis. Dotti nel 1949-50 era responsabile di Democrazia popolare, una sorta di sindacato (ma anche partito) fondato nel 1948 dalla Cgil e dal sindacato ceco, che a Praga raccoglieva tutti gli emigrati politici. Svolgeva corsi di marxismo all’università, di storia e letteratura italiana nelle scuole destinate agli italiani. Parlava ogni settimana a Radio Praga. Frequentava «corsi per sabotatori in Praga» ed era vice-direttore di quelli rivolti agli emigrati italiani a Praga o nella periferia di essa. A testimoniarlo sono le notizie fornite dai connazionali che rimpatriavano e gli elenchi dei fuorusciti comunisti italiani che i servizi preparavano e aggiornavano120. Per gli anni Cinquanta e Sessanta Ministero degli Esteri e Ministero dell’Interno registrarono documenti121 dedicati all’attività dei comunisti e in particolare alla partecipazione di gruppi di militanti a corsi di cultura politica militare o a «speciali corsi di istruzione sulla guerriglia e sulla lotta partigiana». A frequentarli furono scelti, come rileva il prefetto di Ravenna, in data 15 marzo 1958, ex-partigiani provenienti dalle province di Bologna, Carrara, Massa, Mantova, Forlì ecc. inviati in paesi oltre cortina (in particolare Cecoslovacchia e Urss).
120
Si veda il rapporto Attività di comunisti italiani in Cecoslovacchia. Scuola di cultura politica, militare e sabotaggio di Praga e Brno (notizie fornite da connazionale rimpatriato nel novembre 1952), redatto dal contro-spionaggio di Bologna, in data 20 dicembre 1954, Prot. n.13385. 121 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno. Gabinetto Partiti Politici 1944-1961, sotto-fascicolo n. 161-33, Partito Comunista Italiano. Corsi di cultura politica, e il fascicolo militare 161-P/2, su Partito Comunista Italiano-Inquadramento e formazioni paramilitari. Quello su Reggio Emilia reca il titolo Attività del Pci. Esercitazioni pratiche di guerriglia. Corsi di lezioni teorico-pratiche, per completare la preparazione morale di quadri sul marxismo, nota 136/3 R., 3 ottobre 1950. Il Prefetto di Ferrara, in data 14 marzo 1950 nel fascicolo 161 P-2, Partito Comunista Italiano. Inquadramento paramilitare, riferisce sull’oggetto “Segnalazione riservata. Colloquio avvenuto in Bologna tra esponenti sindacali paramilitari politici e Partito Com. in collegamento con rappresentante dell’URSS per l’organizzazione d’una azione insurrezionale”, con rimando al fascicolo 161 P1, P.C.I. Azione sobillatrice.
298
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Il capo della polizia Giovanni Carcaterra riferì che in Cecoslovacchia dovrebbe aver luogo, dopo le elezioni politiche in Italia (presumibilmente a luglio), un corso di addestramento politicomilitare (secondo alcune fonti, un vero e proprio corso per sabotatori), con partecipazione di attivisti comunisti di tutti i paesi europei e di fidati elementi comunisti italiani delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e Modena122.
Sfortunatamente, comunica il Ministro d’Italia in Praga, con telespresso del 28 aprile, «le scuole di addestramento politico per stranieri» sono state sospese da circa tre anni, e non risulta siano state riaperte123. La Direzione comunista, secondo quanto riferisce il prefetto Gaipa di Bologna, avrebbe incaricato le federazioni provinciali di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini e Modena di segnalare i nominativi di giovani comunisti, che abbiano già frequentato scuole di partito, e che per cultura, serietà, riservatezza e sicura fede comunista diano affidamento di frequentare con profitto un corso di spionaggio politico militare124.
Rocco Turi nell’arresto e nell’esecuzione di Moro ha visto dipanarsi «una strategia cecoslovacco-sovietica»125, che faceva capo ai vecchi dirigenti partigiani. Reduci da Praga e dintorni, beneficiati dal voto di scambio tra il Pci (amnistia e pensione per i vecchi ex-partigiani riparati all’estero spesso per delitti immondi) e Saragat (offerta di una consistente provvista di voti per essere eletto capo dello Stato), osteggiarono la strategia berlingueriana e morotea del compromesso storico. Per loro la vittima sacrificale doveva essere proprio Moro. Seguendo, in maniera ritengo inconsapevole, il costume comunista di ignorare (o non parlare di) chi potrebbe contrastare la sua tesi, De Lutiis 122
Ivi, Al Gabinetto dell’on. Ministro, 23 aprile 1958, Prot. n. 441/07399, “Attività del P.C.I.”. 123 Ivi, capo della polizia al gabinetto dell’on. Ministro, 4 giugno 1958, prot. n. 441/012820, “Attività del P.C.I.”. 124 Ivi, Prefettura di Bologna, 15 marzo 1958, Prot. n. 1594, “Attività del P.C.I.”. Tale corso sarà rimandato a dopo le elezioni politiche, come informa il prefetto Gaipa in data 21 aprile 1958. 125 R. TURI, Gladio rossa, cit., p. 183.
299
SALVATORE SECHI
cita solo una volta e di sfuggita il libro di Turi. Il giudice Priore, invece, accoglie la sua tesi sul potere di controllo e di indirizzo esercitato dagli ex-partigiani sulla politica del Pci, tesi che De Lutiis non condivide. Capisco imbarazzo e difficoltà. Su aspetti cruciali il saggio di Turi difetta purtroppo di documentazione o di informazioni controllabili o affidabili. Nuoce a questo lavoro il carattere prevalentemente indiziario e congetturale con cui è condotta la parte sul delitto Moro. È un limite che colpisce anche la sezione del volume in cui Turi descrive, con buoni ragionamenti, ma con una documentazione incompleta o solo evocata, la fuga dei partigiani in Cecoslovacchia, i corsi di addestramento al sabotaggio, al terrorismo e alla sovversione, l’attività di falsificazione sulla situazione politica italiana e di esaltazione spudorata della dittatura comunista. Non di rado l’autore si blinda nel richiamo a incontri e a informatori, purtroppo entrambi segreti e anonimi. Per esempio, evoca un tentativo di golpe contro l’Italia, nel 1951, da parte della colonna messa su dal Pci in Cecoslovacchia, di cui non sa fornire una prova minimamente convincente. Dominano le congetture. La stessa tesi portante del libro, cioè la formazione di un gruppo di pressione da parte dei vecchi dirigenti partigiani che avrebbe condizionato le principali scelte politiche del Pci, malgrado la sua probabilità, è più evocata e presupposta che dimostrata. Sono limiti indubbiamente gravi. Non dovrebbe, però, dispiacere e tantomeno far inorridire De Lutiis che da par suo, cioè con molto acume e sulla base di qualche documento (o più di uno, a seconda delle vicende), si rifugia analogamente, molto spesso, in congetture e ipotesi di ampie volute. In generale, anche gli storici non possono prescindere dal ricorso ad esse, in maniera controllata. In secondo luogo, essendo la trama ceco-sovietica descritta da Turi ben argomentata e piena di fatti, anche se debole sul piano della documentazione, non si capisce – se si esclude il malvezzo comunista prima ricordato – come si possa, oltre a non condividerla, far finta che non esista. De Lutiis temo si lasci fuorviare, ancora oggi, da una vecchia prassi, funzionale al depistaggio, dei brigatisti, che nelle perquisizioni domiciliari solevano lasciare indirizzi e riferimenti alla Cia e ai suoi agenti. Nell’ultimo capitolo, I legami con l’Europa orientale: l’ombra di Yalta (pp. 197-226), maneggiando con cautela e destrezza diverse fonti, 300
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
ammette due cose. In primo luogo che fino agli anni Sessanta la Cecoslovacchia sia stata un rifugio sicuro per gli ex-partigiani comunisti che si erano macchiati di crimini dopo il 25 aprile 1945. In secondo luogo, che in diversi centri di questo paese siano stati attivi campi di addestramento, in cui a diversi esponenti del terrorismo, italiano e no, venivano impartiti corsi su tecniche di guerriglia e sabotaggio126. Sul primo punto, che viene dato per «ben noto»127, l’ammissione è purtroppo generica, quasi sfuggente se non proprio reticente. Mi pare opportuna renderla esplicita, completando così la narrazione di De Lutiis. Dal 1946 fino al 1979 (almeno) rapporti dei nostri servizi documentano la natura dei rapporti tra il Pci e la Cecoslovacchia. Più precisamente si occupano dell’emigrazione politica, cioè dei numerosi ex-partigiani, comunisti per lo più, che clandestinamente espatriano verso Praga e le altre città ceche. Pensavano così di sfuggire alle pene detentive comminate (o in via di emissione) dai tribunali italiani per reati assai gravi, a cominciare dai delitti politici commessi a danno di ex-fascisti, industriali, proprietari terrieri, avversari politici ecc. dopo il 25 aprile 1945. Secondo il nostro servizio militare (Sismi), l’emigrazione, nel periodo 1948-79, toccò la punta di duemila persone, delle quali circa 600 erano a conoscenza del nostro servizio militare. L’orientamento politico di questi comunisti, divisi in collettivi di lavoro in Boemia, nella ricca regione dei Sudeti, aveva poco e nulla da spartire con la concezione togliattiana del “partito nuovo” e con l’accettazione della democrazia parlamentare. Un loro “educatore”, che ne diventerà anche dirigente, ha parlato di «concezioni spesso rudimentali e non di rado assai distanti dalla linea del partito»128. 126
G. DE LUTIIS, Il golpe di via Fani, cit., p. 203. Lo è così poco che uno dei massimi dirigenti inviati dal Pci in Cecoslovacchia (dove stette per 16 anni), l’ex comandante partigiano emiliano Araldo Tolomelli nella sua recente autobiografia non ne fa il minimo cenno, e anzi, interrogato, nega recisamente la circostanza. Cfr. Ludovico TESTA, “La vita è lotta”. Storia di un comunista emiliano, Diabasis, Reggio Emilia 2007. Analogamente ha fatto una persona affidabile come l’ex ministro per l’Ambiente Carlo Ripa di Meana da me interrogato, insieme a Fernando Orlandi, nottetempo, in un hotel di Brescia nel 2008. Di qui la necessità di ricerche più approfondite. 128 Cfr. la biografia di Ludovico TESTA dedicata ad A. Tolomelli, “La vita è lotta”, cit., p. 192. 127
301
SALVATORE SECHI
Anzi, in maniera esplicita Tolomelli ricorda come, salvo qualche eccezione, la maggior parte dei compagni aveva un’idea estremista e settaria circa le finalità della politica del partito. Era gente fuggita dall’Italia perché accusata di qualche reato politico e che difendeva gelosamente quella concezione insurrezionale e rivoluzionaria, con la quale in molti erano usciti dalla guerra. Mi resi conto di quanto fosse difficile fare loro capire i contenuti della svolta di Salerno, il concetto di democrazia progressiva e la necessità delle fasi intermedie sul cammino verso il socialismo. Reagivano con insofferenza a tutti quei discorsi con i quali, appellandomi anche all’esempio della rivoluzione russa, cercavo di illustrare le differenze tra la tattica e la strategia, tra gli obiettivi di fondo e l’inevitabilità della via parlamentare, tra la necessità della mobilitazione popolare e quella di non oltrepassare i limiti imposti dalla Costituzione, anche quando la polizia di Scelba ne violava palesemente le norme129.
Il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (Cesis) redige un rapporto, nel settembre 1979, fondato sugli accertamenti dell’Arma dei Carabinieri, del Sisde e del Sismi, sugli attivisti terroristi che avevano frequentato corsi riservati in Cecoslovacchia e in altri paesi, ed erano in contatto con elementi del controspionaggio cecoslovacco, in particolare a Milano e a Roma. La selezione degli espatriandi veniva effettuata dalla Direzione del Pci in base di un’accurata documentazione sui compagni volontari da parte delle sezioni provinciali. Successivamente questi dossier passavano al filtro all’ambasciata cecoslovacca a Roma che li inoltrava a Praga, quasi sicuramente al Ministero degli Esteri e dell’Interno, al partito e all’intelligence: A questo punto – continua il rapporto del Cesis – gli elementi ritenuti di maggiore spicco per fanatismo, aggressività e attitudine militare vengono avviati a veri e propri corsi paramilitari, in Cecoslovacchia o in altro paese, forniti di passaporti falsificati nelle nazioni ospiti. Una volta superato il ciclo addestrativo, i terroristi fanno ritorno in Italia con un bagaglio notevole di nozioni teoriche sulla guerriglia, che possono a loro volta riversare sugli altri elementi delle organizzazioni di appartenenza130. 129
Ivi, p. 193. La relazione è rinvenibile in un faldone dell’inchiesta sulla “Gladio Rossa” condotta da Luigi De Ficchy, Francesco Nitto Palma e Franco Ionta, e depositata presso gli archivi delle Commissioni Moro e Mitrokhin, a Palazzo San Macuto. 130
302
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Pronti per sabotaggio e guerriglia in Italia È soprattutto l’ufficio per l’organizzazione, cioè Pietro Secchia e Celso Ghini, almeno fino a metà degli anni Cinquanta, a curare questa alimentazione di un vero e proprio braccio armato del Pci all’estero. Seguaci di Secchia sono Francesco Moranino e Roberto Dotti che, insieme ad Araldo Tolomelli, Domenico Ciufoli, Natale Burato (l’ex capo della Volante rossa milanese) ecc., dirigono in periodi diversi questo consistente gruppo di emigrati. Oltre ai militanti da avviare nei campi di addestramento e nelle scuole di educazione ideologica, il gruppo dirigente comunista curava tutti gli aspetti logistici di questo ingresso in clandestinità di una parte dei suoi attivisti. Mi riferisco all’itinerario fino a Tarvisio e a Venezia e poi alla periferia di Vienna, ai biglietti di viaggio, alle parole d’ordine per il riconoscimento da parte dei propri emissari, ai nascondigli e ai covi in cui sostare prima di attraversare la frontiera, alle guide nei sentieri di montagna, ecc. Per non parlare della lunga tenace battaglia parlamentare e di stampa per far ottenere l’amnistia e l’indulto e successivamente la pensione a questi militanti, in un’azione di vero e proprio scambio politico con i candidati alla presidenza della Repubblica. Questa esperienze di vita clandestina, di preparazione al sabotaggio e alla guerriglia tornerà utile al Pci. A metà degli anni Settanta questi compagni saranno contattati dai membri della Direzione che volevano conoscere i luoghi e le persone da utilizzare nel caso in cui, come Longo temeva, il partito fosse stato costretto a tornare in clandestinità di fronte ad un golpe di estrema destra, come quello del 1973 in Cile e al tentativo abortito di Junio Valerio Borghese131. L’esistenza di campi di addestramento a Praga, Bratislava, Brno ecc. in cui vennero iniziati o specializzati all’uso delle armi, alle pratiche di sabotaggio e in generale di violenza e sovversione, gli ex partigiani del Pci, dai nostri servizi è data per operante ancora nel 1982132. Che senso ha riepilogare questa vicenda ancora una volta? Non si tratta solo di rivangare una storia che il Pci non ha mai ammesso, se 131
Questo contatto della Direzione nazionale è evocato anche da A. Tolomelli, che lo racconta al suo biografo L. TESTA, “La vita è lotta”, cit., pp. 237-238. 132 Si veda la testimonianza dell’ingegner Renzo Soresino, resa a R. TURI, Gladio rossa, cit., p. 244.
303
SALVATORE SECHI
non nei termini della collaborazione tra partiti-fratelli e dell’aiuto dato a partigiani braccati dalla “giustizia di classe”, e neanche di completare un aspetto rimasto in ombra. Ritengo che il richiamo a questo passato di addestramento alla guerra di guerriglia da parte dei comunisti spieghi una vicenda che De Lutiis non mi pare riesca a chiarire e precisare come si deve. Essa è contenuta nella domanda: per quale ragione Berlinguer spedisce per ben tre volte (1974, 1975 e 1976) Salvatore Cacciapuoti, vice-presidente della Commissione Centrale di Controllo del Pci, a parlare con i dirigenti comunisti cechi col compito di accertare se erano vere le notizie che nei loro campi militari, venivano addestrati terroristi italiani e, se fosse risultata vera la notizia circolata sin dall’8 settembre 1974 (cioè fin dall’arresto di Curcio e Franceschini), per esortarli a mettere fine a questa consuetudine. Con lo stesso obiettivo si mossero, in direzioni diverse, Giorgio Amendola, Gianni Cervetti, Arturo Colombi, Emanuele Macaluso, Ugo Pecchioli ecc.133. Ciò avvenne appena cominciarono a essere diffuse (e durarono fino all’11 ottobre 1999, quando in Italia venne reso pubblico il “dossier Mitrokhin”) presso la stampa e il mondo politico notizie, con nomi e cognomi, sulla presenza di terroristi delle Brigate rosse e di Prima Linea nei campi cecoslovacchi. Rispetto alla spiegazione proposta da De Lutiis, ritengo che, in realtà, l’allarme, l’ansia di Berlinguer nascesse da una doppia paura. La prima è che l’inettitudine e l’impreparazione dimostrata per 55 lunghi giorni dai corpi di prevenzione e di repressione potesse sfociare in una rivolta contro lo Stato e i suoi rappresentanti. La seconda era che si venisse a sapere quanto era stato denunciato dall’estrema destra, cioè che ad aprire, e a lastricare, la strada della specializzazione nella guerra di guerriglia in Cecoslovacchia dei propri iscritti (addirittura dei comandanti partigiani) era stato il Pci. Tra i circa duemila militanti che vi inviò, fino al 1978, qualcuno poteva essere passato successivamente nei ranghi delle Br o di Prima Linea ecc., stabilendo così una continuità con la prima ondata post-bellica. 133
Si veda quanto ha documentato Nicola BIONDO, Relazione sui supposti appoggi dati dal Primo Direttorato del Servizio Cecoslovacco alle Brigate Rosse e in particolare a Renato Curcio e Alberto Franceschini, nell’analisi depositata presso l’archivio della Commissione Mitrokhin, e ripresa dal dottor Roberto BARTALI, L’ombra di Yalta sugli anni di piombo, tesi di dottorato discussa il 18 febbraio 2008 presso l’Università di Siena, relatore il prof. Paul Corner.
304
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
In realtà, la questione non è proprio nuova. La rende tale la resistenza, anzi l’ostinazione, dei dirigenti comunisti ad ammetterla, parlando d’altro o rimpannucciandosi nel contributo dato alla guerra di liberazione e alla redazione della carta costituzionale. Meriti certamente preziosi e innegabili. La Commissione d’inchiesta Lombardi sul cosiddetto colpo di Stato nel luglio 1964 accertò che nella rubrica “E” del Sifar erano elencati 731 elementi esperti in sabotaggio ed eversione capaci di predisporre, individualmente o inquadrati in organizzazioni paramilitari, atti di sabotaggio, atti di guerriglia, azioni di disturbo contro le Forze Armate, le infrastrutture ed i materiali in uso alle Forze Armate o comunque destinati ad alimentare la difesa del nostro paese in guerra.
Esisteva, dunque, un pericolo serio che correvano le Forze Armate, l’ordine pubblico, cioè in generale, la sicurezza dello Stato. Chi la metteva a repentaglio non era proprio una folla sconosciuta. Il generale Franco Picchiotti nel corso dell’audizione alla Commissione Lombardi spiegò che gli schedati della Rubrica “E” avevano frequentato corsi di sabotaggio e di formazione politica oltrecortina e in Italia. Nel corso della sua deposizione sui fatti del giugno-luglio 1964, raccolta dalla commissione parlamentare d’inchiesta precisò che tale corsi di addestramento erano suddivisi in «corsi elementari per esecutori; corsi tecnici e di cultura politica per i capigruppo; i dirigenti, invece, non dovevano adoperare dinamite né altro esplosivo», in quanto erano tenuti a organizzare e dirigere quadri e sabotatori134. Con costernazione e sarcasmo il comandante ex-partigiano e giornalista ex-comunista, dieci anni dopo, cioè nel 1974, si rivolgeva a Taviani per chiedere come mai fossero stati spiccati mandati di cattura contro patrioti ed antifascisti come Pacciardi ma sino ad oggi, nessun comunista è comparso di fronte ad un tribunale per essere stato addestrato al sabotaggio ed al terrorismo in Italia o all’estero, o per avere organizzato in Italia corsi di addestramento o per avere insegnato in quelle scuole a far saltare in aria impianti petrol-
134
Ricavo questi dati da un articolo di Luigi CAVALLO, Il terrorismo comunista, «Difesa Nazionale», n. 2 (novembre 1974).
305
SALVATORE SECHI
chimici, fabbriche, dighe, ponti, centrali elettriche, case per aver istruito specialisti a sabotare aerei, treni, impianti industriali; per aver formato e diretto propagandisti e specialisti della guerra psicologica a distruggere il morale delle forze armate135.
In secondo luogo, l’esistenza del braccio militare in Cecoslovacchia avrebbe portato a far luce sulla struttura para-militare che dalla guerra di liberazione prolungò la propria attività, seppure sempre più inerziale probabilmente, nel dopoguerra. Lo spettro, dunque, dell’album di famiglia agitato da Rossana Rossanda. Purtroppo nel suo libro di memorie136 non ha voluto sfogliarlo, e ci ha privato anche dell’indice dei nomi. Mettere a disposizione dell’opinione pubblica questo elemento della tradizione del Pci e dei suoi rapporti con Praga significava togliere smalto, ma anche credibilità, alla lotta contro il terrorismo. Ingaggiata da Berlinguer, e condivisa – in un lancinante tormento tra i doveri istituzionali di ministro dell’Interno e quelli di amico di Moro – da Francesco Cossiga, subito dopo il rapimento del leader democristiano aveva il suo fondamento nel principio della fermezza. In base ad essa non era ammissibile trattare con chi faceva dei prigionieri politici e proponeva scambi che potevano danneggiare in maniera gravissima l’immagine dello Stato di diritto. La mancata chiarificazione di questo punto indebolisce o rende lacunosa la ricostruzione di De Lutiis. Anche perché dà l’impressione di puntare a nascondere, come ho detto, un altro elemento rimosso o lasciato in ombra della storia dei comunisti italiani, cioè la militarizzazione della loro politica per ragioni ora offensive ora difensive. Al pari che nel Pci, nel dibattito in seno alla direzione della Dc, ma anche in diversi settori dell’opinione pubblica, prevalse la politica della fermezza. Venne opposto un corale rifiuto ad ogni trattativa con le Br. Un no perentorio fu pronunciato dal segretario della Cgil Luciano Lama, nel comizio del 16 marzo, alle 11 del mattino (cioè due ore dopo la notizia del rapimento di Moro), a Piazza San Giovanni a Roma, ad ogni scambio tra la vita del leader democristiano e i “prigionieri politici” (cioè i brigatisti detenuti nelle carceri). 135 136
Ibidem. Rossana ROSSANDA, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino 2005.
306
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
A mostrare i muscoli è uno Stato a pezzi e un governo che ancora non c’è. Non avendo ricevuto la fiducia dal parlamento, non è neanche in carica. Ma a preoccupare e animare diffidenza, intrisa di sospetti, è che della difesa dello Stato e delle forze dell’ordine si faccia artefice, anzi paladino, il Pci, cioè un partito che è nato impastato della stessa cultura politica dei terroristi. Nelle fabbriche, come mostrano le inchieste del quotidiano «la Repubblica», gli operai non si stracciano le vesti per il rapimento (e neanche per la morte) di Moro. La condanna del terrorismo è incerta, blanda. Questa reazione è anni luce lontana da quella del gruppo dirigente berlingueriano. Attestandosi sul sostegno delle istituzioni dello Stato e del principio dell’inflessibilità tende a segnare un solco, un abisso tra sé e le Br. Da compagni che sbagliano, «sedicenti», non si può trasformarle in fascisti oppure nemici e criminali. Ma la Dc non abbocca, non cade in questa trappola. Proprio quella di aver messo al mondo le Brigate rosse è l’accusa verso il Pci che i dirigenti della Dc non si stancano di mettere in evidenza per fronteggiare l’offensiva scatenata da Berlinguer e Lama volta a far capire che a difendere lo Stato di diritto hanno titolo solo i comunisti. A loro avviso, non poteva arrogarsi questa prerogativa un partito come la Dc che anche nel recente passato avrebbe ordito manovre anti-democratiche e tentativi golpisti, e si era abbandonata ad ogni genere di corruzione e malcostume. Pertanto, nei suoi maggiori esponenti, in queste ore, non risparmiò ogni possibile enfasi nel presentare le proprie credenziali di baluardo della democrazia. Sulla base di uno spoglio minuzioso dei verbali della direzione democristiana, è stato chiarito come i dirigenti delle Dc «continuavano ad attribuire al Pci pesanti responsabilità in ordine a una persistente fragilità della democrazia italiana: le Brigate rosse avevano un retroterra ideologico comune con dirigenti e militanti del Partito comunista»137. Giovanni Galloni non la pensa diversamente da Rossana Rossanda. De Lutiis sul punto è tanto sbrigativo quanto ambiguo. In un paio di frasi (pp. 203 e 204), nel tentativo di spiegare perché Alberto Franceschini sia stato, malgrado le sue smentite, considerato un frequentatore (insieme a Feltrinelli, Curcio, Pelli, Viel, Spazzali e Negri) dei
137
A. GIOVAGNOLI, Il caso Moro, cit., pp. 65-66.
307
SALVATORE SECHI
corsi sulle tecniche di guerriglia e di sabotaggio impartiti nei campi di addestramento cechi, sostiene che: 1. tali corsi e campi sono realmente esistiti (un’affermazione certamente coraggiosa rispetto alla storiografia e alla saggistica di parte comunista), 2. proprio là dove erano stati istituiti, cioè nei paesi del Patto di Varsavia, i loro servizi segreti «hanno sempre cercato di rafforzare all’interno del Pci il gruppo più strettamente legato all’Unione Sovietica», 3. nel «dopoguerra questo gruppo si identificava in parte con la ben nota struttura parallela, impropriamente denominata successivamente “Gladio rossa”». Il riferimento è a Pietro Secchia e ai suoi seguaci. Non si capisce perché, dopo aver fatto queste coraggiose ammissioni, De Lutiis chiami «ben nota» la struttura paramilitare (o allude a qualcosa di diverso, cioè alla colonna filo-sovietica, legata al Kgb?). Non essendo mai stata ammessa dal Pci, ma anzi sdegnosamente negata, come ha ripetuto più volte Emanuele Macaluso, ben nota proprio non mi pare di possa chiamare, 4. tale struttura «era stata disarmata» dopo la morte di Stalin e l’allontanamento di Secchia dalla sezione organizzazione del partito, ma dagli ambienti secchiani «pervennero i primi incoraggiamenti alle nascenti Brigate Rosse» (p. 204), 5. quando, a metà degli anni Settanta, Longo cercò di preparare il Pci al rientro nella clandestinità, per paura di un colpo di Stato, non fece ricorso agli uomini di Secchia (legati alle Br), ma avrebbe creato un altro gruppo chiamato “Vigilanza democratica”. Invece di rinnovellare i vecchi rapporti con l’Urss, dal 1974 il Pci, grazie soprattutto a Ugo Pecchioli, si mise a collaborare con i nuclei anti-terrorismo del generale Dalla Chiesa. Se il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno (che, col consenso imprevisto dei ministri Arturo Parisi e Giuliano Amato, ora li centellinano, anzi hanno sospeso l’erogazione), e soprattutto l’Arma dei Carabinieri (che, non essendo obbligata a versare le proprie carte all’Archivio Centrale dello Stato, solo di recente ha avviato un’autonoma conservazione e un’apertura al pubblico della documentazione di interesse politico) aprissero finalmente i propri archivi, si potrebbe determinare precisamente il periodo in cui questo processo diverso e giustapposto alla costituzionalizzazione del Pci ha avuto luogo e chi ne furono i protagonisti. 308
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Anche se gli archivi pubblici (Commissioni parlamentari di inchiesta, Ministero dell’Interno, della Difesa, Arma dei Carabinieri) vengono mantenuti deliberatamente chiusi, per fortuna sopravvive una memoria pubblica e di intellettuali (Piero Calamandrei, Benedetto Croce, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini) e di giornalisti (Gaetano Baldacci, Guglielmo Emanuel, Giovannino Guareschi, Leo Longanesi, Indro Montanelli ecc.). Essi seppero percepire, e denunciare tempestivamente i pericoli di una sovietizzazione violenta dell’Italia, le stragi di massa (contro fascisti e vittime innocenti, come avvenne a Bologna nell’estate 1945), la dittatura di una minoranza (quale si delineò essere quella dei partigiani, da un lato, e dei comunisti infiltratisi tra di essi, dall’altro). Tutto ciò derivava dalla minaccia di un nuovo totalitarismo (quello comunista diretto da Mosca). Nelle intenzioni di Stalin e di Secchia, venne agitato sull’Italia post-fascista attraverso la retorica, la mitizzazione e quindi la stessa falsificazione della Resistenza138, identificandola puramente e semplicemente con l’anti-fascismo139. Ai dirigenti del Pci come a quelli del Psiup (la denominazione del Partito socialista in quel periodo) non sfuggì che il dibattito sorto in seno ai Comitati di Liberazione Nazionale, alla fine del 1944, su «Tutto il potere ai CLN» era la metafora di quello dei bolscevichi nel 1917 «Tutto il potere ai Soviet»140. Ci fu connivenza (o forse solo silenzio) nel deformare, fino alla caricatura, la realtà della guerra di liberazione. Si trattò di un fenomeno spesso spontaneo e generoso, ma minoritario, di scarsa incidenza sul piano militare, ostile (almeno nella componente social-comunista) alla cultura e alle istituzioni della democrazia occidentale e alla collocazione dell’Italia nell’alleanza guidata dagli anglo-americani. Si volle negare che tra i diversi rivoli confluiti nella Resistenza ci fu anche una folla di disertori, per esempio. 138
È quanto fece Piero CALAMANDREI nel suo bellissimo Uomini e città della Resistenza, Laterza, Roma-Bari 2006. 139 Si vedano le osservazioni di Ugo FINETTI, La Resistenza cancellata, prefazione di Sandro Fontana, Ares, Milano 2003, e di Eugenio DI RIENZO, Quando l’antifascismo processò la Resistenza, «il Giornale», 22 aprile 2006. 140 Su tutti questi aspetti si veda la corrispondenza tra Ernesto ROSSI e Gaetano SALVEMINI, Dall’esilio alla Repubblica. Lettere 1944-1957, Bollati Boringhieri, Torino 2004; e Benedetto CROCE, Taccuini di guerra, Adelphi, Milano 2004.
309
SALVATORE SECHI
Il carattere di “democrazia sous reserve” del dopoguerra emerge sempre di più con l’aprirsi degli archivi. A metà degli anni Cinquanta a Torino, per fare qualche esempio, il Ministero dell’Interno e i servizi possono delineare la ripresa, e l’aggiornamento, dell’organizzazione para-militare del Pci, con la divisione della città in settori (Barriera di Milano, Borgo San Paolo, Barriera di Nizza-Lingotto-Mirafiori, di cui si hanno i nomi dei responsabili). Ognuno di essi disponeva di gruppi di pronto intervento, di apparecchi radioriceventi e trasmittenti. Erano noti gli obiettivi: l’interruzione delle comunicazioni tra le prefetture e il “centro nazionale”, portare lo scompiglio nell’organizzazione dei servizi di ordine pubblico, presidiare l’imbocco delle autostrade, bloccare la circolazione dei tram, sabotare le opere stradali e creare false indicazioni di percorso. Il grosso delle forze di polizia andavano attirate alle FerriereFiat dove, in senso orizzontale, nei cunicoli, era murato un ingente quantitativo di armi, per lo più fucili tedeschi, mitragliatori, bombe a mano ed armi automatiche come Mitra e Sten. Qui era necessario tenerle impegnate in modo da permettere ad altri gruppi di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Era inoltre previsto di sabotare posti di polizia e garages, attaccare le caserme per impedire l’intervento dei militari a fianco delle forze di polizia, procedere al fermo immediato di dirigenti di fabbrica, esponenti civili e militari. Nelle città emiliane di Bologna, Parma, Ferrara, fino all’inizio degli anni Sessanta viene segnalata l’attività di circa 50 “gruppi di vigilanza”. Quelli di Bologna sarebbero formati da 40-50 elementi, e quelli della provincia da 10 o 20. A Parma si arriverebbe a circa 200 uomini e altrettanti nella provincia, più limitati (da 10 a 20 unità) i centri di Fidenza, Fornovo, Salsomaggiore, Langhirano141. Come mostra in questo volume Roberto Bartali, solo verso il 1974, una data cruciale anche per altre ragioni come De Lutiis documenta, Berlinguer e Pecchioli diedero inizio ad una massiccia “campagna di
141
Si vedano gli appunti delle “fonti fiduciarie” (che vanno esaminate contestualmente ad altre fonti) del 18 e 27 novembre 1956, da Torino, del 31 ottobre e del 3 dicembre 1958, come del 31 maggio 1960 per quanto concerne le città emiliane citate nel testo, rinvenibili presso il Ministero dell’Interno e l’Archivio Centrale dello Stato, in Z4.Organizzazione para- militare del Pci.
310
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
orientamento”, come si diceva una volta, cioè di denuncia aperta della pericolosità delle Br, della loro estraneità al movimento operaio, della necessità per ogni militante di combatterle, anche a livello personale. Cessarono di essere chiamate “compagni che sbagliano”. E venne meno la preoccupazione, di cui si fece interprete il giudice milanese Ciro De Vincenzo, di indurli a consegnarsi agli inquirenti e contrattare uno sconto delle pene. In altre parole, saranno dipinti come dei nemici, da annientare con ogni possibile mezzo, compresa la delazione. Il punto di non ritorno venne toccato quando il servizio investigativo del Pci mise a disposizione dei nuclei anti-terrorismo del generale Dalla Chiesa tutti i dossier che negli anni aveva provveduto a far compilare nelle fabbriche e in ogni luogo di lavoro, come nell’esercito e nelle imprese e negli uffici pubblici. Chi non si piega a nessuna reticenza è l’ex presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle stragi. Giovanni Pellegrino non ha difficoltà ad ammettere che questo “esercito rosso” sia stato lentamente smantellato col modificarsi delle tecnologie militari durante la guerra fredda, e verso la metà degli anni Settanta sia stato sostituito da un reparto di circa 700 uomini pronti a schierarsi dalla parte delle truppe sovietiche nell’eventualità di una loro occupazione del territorio nazionale, cioè la Gladio rossa142. Secondo l’ex-parlamentare comunista questa «organizzazione paramilitare funzionava anche come centrale di intelligence che agiva in stretto rapporto con la rete degli agenti del Kgb in Italia»143. Anche se ritiene infondati i sospetti su un collegamento tra Br, Cecoslovacchia e Kgb, De Lutiis non si chiude nessuna porta. Ammette onestamente che non la generalità, e quindi alcuni brigatisti rossi «siano stati pedine consapevoli di disegni strategici di servizi segreti orientali o occidentali» (p. 206). Ricorda gli appunti del generale Dalla Chiesa in cui si annota che i servizi di sicurezza della Germania orientale pilotano il terrorismo tedesco, e il Kgb manovra l’Olp, che fornisce le armi alle Br (pp. 206-207). Anche se il sospetto che Sergeij F. Sokolov fosse uno studente russo di Moro infiltrato dal controspionaggio, si rivela infondato, De Lu-
142 143
G. FASANELLA e G. PELLEGRINO, La guerra civile, cit., p. 45. Ivi, p. 57.
311
SALVATORE SECHI
tiis non nega che «non vi siano stati contatti o connivenze, su alcune delle quali abbiamo già informazioni, o che non vi possano essere stati altri contatti che potrebbero emergere in futuro» (p. 210). Questa di non ipotecare il futuro, e cioè che quanto non è dimostrabile oggi (come il fatto che il movente per far fuori Moro per gli Usa sarebbe stato l’anticomunismo) possa diventarlo domani, è anche l’opinione di Nicola Tranfaglia. Per lui l’abbattimento dell’aereo di Ustica come la strage del 2 agosto alla stazione di Bologna, entrambi nel 1980, pur mancando ogni prova, prima o poi esse sarebbero scaturite144 . Basta attendere, insomma, e tutto e il contrario di tutto può essere provato. Pertanto, ci si serve di proposizioni ipotetiche e di mere congetture come fonti da cui ricavare conclusioni perentorie145. Insomma, la storiografia da scienza a una sorta di chiavistello di lego, bon a tout faire. Una volta esclusa la pista cecoslovacca, e quindi quella del Kgb, resta aperta quella israeliana, su cui De Lutiis insiste, e di conseguenza quella della Cia. Ma questa sapeva perfettamente che Moro non era depositario di nessun segreto, rivelando il quale potesse far correre dei pericoli alla sicurezza dei paesi del Patto atlantico. Va riconosciuto che rispetto al passato l’atteggiamento di De Lutiis verso l’intelligence degli Stati Uniti è meno perentorio e criminalizzante, e rispetto ai vecchi veleni e pregiudizi complessivamente più equilibrato. È un episodio di onestà intellettuale che gli va riconosciuta dal momento che fino ad alcuni anni fa, sul disegno dell’amministrazione americana era stato in preda ad una vera e propria ossessione. Si può parlare di un lascito generazionale. Gli strali che la storiografia di sinistra in Italia hanno lanciato contro la Cia non possono giustificare in alcun modo i loro gravi peccati di omissione. Mi riferisco al silenzio che essi mantengono sull’opzione che l’intelligence degli Stati Uniti ha sempre manifestato a favore dello spostamento a sinistra dell’asse dei governi post-bellici, in controtendenza rispetto allo stesso Dipartimento di Stato. 144
Cfr. N. TRANFAGLIA, Un capitolo del ‘doppio stato’, cit., pp. 7-8 e 72. Per una serrata contestazione delle tesi complottistiche di Tranfaglia, che discendono pari pari da quelle di Paolo CUCCHIARELLI e Aldo GIANNULI, Lo Stato parallelo, cit., p. 450, si veda G. SABBATUCCI, Il golpe in agguato e il doppio Stato, cit. e più distesamente V. SATTA, Il caso Moro e i suoi falsi misteri, cit., pp. 423-429. 145
312
Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»
Ciò è avvenuto in occasione della crisi del 1947 quando, insieme a Marshall, si preme su De Gasperi e su Saragat perché il nuovo governo senza i comunisti e i socialisti conservi un carattere per così dire “di sinistra”, realizzabile imbarcando il Psdi e il Pri. Si ripete nella crisi dopo la fine del centrismo, in cui viene proposta l’apertura al Psi. Infine nella seconda metà degli anni Settanta gli uomini della Cia presso l’ambasciata Usa a Roma approvano gli accordi di politica economica tra la Dc e il Pci e quindi danno disco verde al governo di solidarietà nazionale. Ad un servizio segreto non sempre deliziato da una buona stampa, come quello degli Stati Uniti, non si può chiedere molto di più.
313
APPENDICE
Appendice 1 Il testo del comunicato n. 2 delle Brigate rosse fatto ritrovare il 25 marzo 1978. Nella trascrizione sono state conservate tutte le “caratteristiche dattilografiche” dell’originale, compresi gli errori. In neretto sono evidenziate le parole e le espressioni commentate da Renzo Rota nella “Relazione breve” (si veda Appendice 2). 1- IL PROCESSO AD ALDO MORO. Lo spettacolo fornitoci dal regime in questi giorni ci porta ad una prima considerazione. Vogliamo mettere in evidenza il ruolo che nello SIM vanno ad assumere i partiti costituzionali. A nessuno è sfuggito come il quarto governo Andreotti abbia segnato il definitivo esautoramento del parlamento da ogni potere, e come le leggi speciali appena varate siano il compimento della più completa acquiescienza dei partiti del cosidetto “arco costituzionale” alla strategia imperialista, diretta esclusivamente dalla DC e dal suo governo. Si é passati cioè dallo Stato come espressione dei partiti, ai partiti come puri strumenti dello Stato. Ad essi viene affidato il ruolo di attivizzare i loro apparati per le luride manifestazioni di sostegno alle manovre controrivoluzionarie, contrabbandandole come manifestazioni “popolari”; più in particolare al partito di Berlinguer e ai sindacati collaborazionisti spetta il compito (al quale sembra siano ormai completamente votati) di funzionare da apparato poliziesco antioperaio, da delatori, da spie del regime. La cattura di Aldo Moro, al quale tutto lo schieramento borghese riconosce il maggior merito del raggiungimento di questo obiettivo, non ha fatto altro che mettere in macroscopica evidenza questa realtà. Non solo, ma Aldo Moro viene citato (anche dopo la sua cattura!) come il naturale designato alla presidenza della Repubblica. Il perchè è evidente. Nel progetto di “concentrazione” del potere, il ruolo del Capo dello Stato Imperialista diventa determinante. Istituzionalmente il Presidente accentra già in sè, tra le altre, le funzioni di capo della magistratura e delle Forze Armate; funzioni che si-
317
Appendice
no ad ora sono state espletate in maniera più che altro simbolica e a volte persino da corrotti buffoni (vedasi Leone). Ma nello SIM il Capo dello Stato (ed il suo apparato di uomini e strutture) dovrà essere il vero gestore degli organi chiave e delle funzioni che gli competono. Chi megli di Aldo Moro potrebbe rappresentare come Capo dello SIM gli interessi della borghesia imperialista? Chi meglio di lui potrebbe realizzare le modifiche istituzionali necessarie alla completa ristrutturazione dello SIM? La sua carriera però non comincia oggi; la sua presenza, a volte palese, a volte strisciante, negli organi di direzione del regime è di lunga data. Vediamone le tappe principali, perchè di questo dovrà render e conto al Tribunale del Popolo. 1955 Moro è ministro di Grazia e Giustizia nel governo Segni. 1957 Moro è ministro della Pubbl. Istruzione nel governo Zoli, retto dal MSI 1959-60 Viene eletto segretario della DC. Sono gli anni del governo Tambroni, dello scontro frontale sferrato dalla borghesia contro il Movimento Operaio. La ferma resistenza operaia viene affrontata con la più dura repressione armata: nel luglio ’60 si conteranno i proletari morti, massacrati dalla polizia di Scelba. 1963 In quest’anno parte la strategia americana di recupero della frangia di “sinistra” della borghesia italiana con l’inglobamento del PSI nel governo, nel tentativo di spaccare il Movimento Operaio. E’ la “svolta” del centro-sinistra e Moro se ne assumerà la gestione per tutti gli anni successivi come Presidente del Consiglio. 1964 E’ Presidente del Consiglio. Emergono le manovre del Sifar, di De Lorenzo e di Segni, che a conti fatti risulterà un’abile macchinazione ricattatoria perfettamente funzionale alla politica del suo governo. Quando la sporca trama verrà completamente allo scoperto, come un vero “padrino” che si rispetti, Moro affosserà il tutto e ricompenserà con una valanga di “omissis” i suoi autori. 1965-68 E’ ininterrottamente presidente del consiglio. 1968-72 In tutto questo periodo è Ministro degli Esteri. La pillola del centro-sinistra perde sempre più la sua efficacia narcotizzante e riprende l’offensiva del Movimento Operaio con un crescendo straordinario. La risposta dell’Imperialismo é stata quella che va sotto il nome di “strategia della tensione”. 1973-74 E’ sempre ministro degli Esteri. 1974-78 Assume di nuovo la Presidenza del Consiglio e nel ’76 diventa Presidente della DC. E’ in questi anni che la borghesia imperialista supera le sue maggiori contraddizioni e procede speditamente alla realizzazione del suo progetto. E’ in questi anni che Moro diventa l’uomo di punta della borghesia, quale più alto fautore di tutta la ristrutturazione dello SIM
318
Appendice
Su tutto questo, ed altro ancora, é in corso l’interrogatorio ad Aldo Moro. Esso verte a: chiarire le politiche imperialiste e antiproletarie di cui la DC è portatrice; ad individuare con precisione le strutture internazionali e le filiazioni nazionali della controrivoluzione imperialista; a svelare il personale politicoeconomico-militare sulle cui gambe cammina il progetto delle multinazionali; ad accertare le dirette responsabilità di Aldo Moro per le quali, con i criteri della GIUSTIZIA PROLETARIA, verrà giudicato. 2- IL TERRORISMO IMPERIALISTA E L’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO. A livello militare è la NATO che pilota e dirige i progetti continentali di controrivoluzione armata nei vari SIM europei. I nove paesi della CEE hanno creato “L’organizzazione comune di polizia” che è una vera e propria centrale internazionale del terrore. Sono i paesi più forti della catena e che hanno già collaudato le tecniche più avnzate della controrivoluzione ad assumersi il compito di trainare, istruire, dirigere le appendici militari nei paesi più “deboli” che non hanno ancora raggiunto i loro livelli di macabra efficienza. Si spiega così l’invasione inglese e tedesca dei super-specialisti del SAS (Special Air Service), del BKA (Bundeskriminalamt) e dei servizi segreti israeliani. Gli specialisti americani invece non hanno avuto bisogno di scomodarsi, sono istallati in pianta stabile in Italia dal 1945. ECCOLA QUI L’INTERNAZIONALE DEL TERRORISMO. Eccoli qui i boia imperialisti massacratori dei militanti dell’IRA, della RAF, del popolo Palestinese, dei guerriglieri comunisti dell’America Latina che sono corsi a dirigere i loro degni compari comandati da Cossiga. E’ una ulteriore dimostrazione della completa subordinazione dello SIM-Italia alle centrali imperialiste, ma é anche una visione chiara di come per le forze rivoluzionarie sia improrogabile far fronte alla nacessità di calibrare la propria strategia in un’ottica europea, che tenga conto cioé che il mostro imperialista va combattuto nella sua dimensione continentale. Per questo riteniamo che una pratica effettiva dell’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO debba cominciare oggi anche stabilendo tra le Organizzazioni Comuniste Combattenti che il proletariato europeo ha espresso un rapporto di profondo confronto politico, di fattiva solidarietà, e di concreta collaborazione. Certo, faremo ogni sforzo , opereremo con ogni mezzo perché si raggiunga fra le forze che in Europa combattono per il comunismo la più vasta integrazione politica possibile. Non dubitino gli strateghi della controrivoluzione e i loro ottusi servitorelli revisionisti vecchi e nuovi, che contro l’internazionale del terrore imperialista sapremo costruire l’unità strategica delle forze comuniste. Ciò detto va fatta una chiarificazione. Sin dalla sua nascita la nostra Organizzazione ha fatto proprio il principio maoista “contare sulle proprie forze e lottare con tenacia”. Applicare questo principio, nonostante le enormi difficoltà, é
319
Appendice
stato per la nostra Organizzazione più che una scelta giusta una scelta naturale; il proletariato italiano possiede in se un immenso potenziale di intelligenza rivoluzionaria, un patrimonio infinito di conoscenze tecniche e di capacità materiali che con il proprio lavoro ha saputo collettivamente accumulare, una volontà e una disponibilità alla lotta che decenni di battaglie per la propria liberazioni ha forgiato e reso indistruttibile. Su questo poggia tutta la costruzione della nostra organizzazione; la crescita della sua forza ha le solide fondamenta del proletariato italiano, si avvale dell’inestimabile contributo che i suoi figli migliori e le sue avanguardie danno alla costruzione del PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE. Mentre riaffermiamo con forza le nostre posizioni sell’Internazionalismo Proletario, diciamo che la nostra Organizzazione ha imparato a combattere, ha saputo costruireed organizzare autonomamente i livelli politico-militari adeguati ai copiti che la guerra di classe impone. Organizzare la lotta armata per il Comunismo, costruire il Partito Comunista Combattente, prepararsi anche militarmente ad essere dei soldati della rivoluzione é la strada che abbiamo scelto,ed è questo che ha reso possibile alla nostra Organizzazione di condurre nella più completa autonomia la battaglia per la cattura ed il processo ad Aldo Moro. INTENSIFICARE CON L’ATTACCO ARMATO IL PROCESSO AL REGIME, DISARTICOLARE I CENTRI DELLA CONTRORIVOLUZIONE IMPERIALISTA. COSTRUIRE L’UNITA’ DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE. ONORE AI COMPAGNI LORENZO JANNUCCI E FAUSTO TINELLI ASSASSINATI DAI SICARI DEL REGIME. Comunicato N. 2 25/3/1978
Per il Comunismo Brigate Rosse
320
Appendice
Appendice 2 Le «Osservazioni» di Renzo Rota riguardanti il comunicato n. 2 delle Brigate rosse del 25 marzo 1978. È qui trascritta solo la terza colonna dell’Allegato n. 1 (ossia della “Relazione breve”). Il testo fu redatto tra il 27 e il 29 marzo 1978. Non sono state trascritte le parole in russo e alcune voci del vocabolario sovietico fotocopiate da Rota nel suo testo. servitorelli: infelice traduzione di “prislusniki” parola impiegata ad ogni piè sospinto nel linguaggio propagandistico sovietico, con inflessione molto più spregiativa che non nella normale denominazione “servo”. “Prislusnik” è un servo sciocco, servile, strisciante. Il linguaggio sovietico, su un piano stilistico più corrente, adopera anche (lakiei) dal francese “laquais”, con significato però molto più spregiativo che nell’originale. Per tradurre l’intraducibile “prislusniki” senza far ricorso al francesizzante “lacchè”, che suonava prezioso, l’estensore sovietico ha adoperato un “servitorelli” che suona fatuo e non consono alla gravità che si voleva dare all’accusa e al tono epico di tutta l’invettiva. revisionisti: la prassi di chiamare “revisionisti” i socialisti e i socialdemocratici (revisionisti del marxismo-leninismo) è una costante dello stile propagandistico sovietico, che adopera per questo due espressioni stereotipate: o “revisionisti vecchi e nuovi” (come qui) oppure “revisionisti d’ogni colore” – È troppo significativa la citazione di questo principio maoista, pochi giorni dopo che la rivista sovietica «Tempi Nuovi» aveva addebitato alla Cina la organizzazione del terrorismo in Europa per sviare le indagini. Accusatio non petita… patrimonio infinito: È una traduzione inappropriata dal russo: immenso, che non ha confini. Un patrimonio non è “infinito”, ma immenso, sconfinato. Disponibilità alla lotta: infelice ed affrettata traduzione dell’espressione della propaganda comunista sovietica, impossibili da tradurre letteralmente, ma che implicano l’idea di “uno stato d’animo pronto alla lotta”. Impiegata anche l’espressione – anche questa intraducibile letteralmente che esprime l’idea di “un animo teso alla lotta”. Del resto la parola “disponibilità” è troppo pacifica, amministartiva quasi, in un contesto che si vuole eroico. I comunisti italiani in genere adoperano la parola “combattività”. forgiato: nessun italiano, e tanto meno rivoluzionario, userebbe oggi il verbo “forgiare” che ricorda troppo lo stile fascista.
321
Appendice
La parola “forgiato” è stata notata dalla stampa (v. ad esempio «Il Giornale» del 26 marzo, pag. 2) come un francesismo. È invece la traduzione del verbo adoperato ad ogni piè sospinto dallo stile propagandistico sovietico: temprare, forgiare. Un’opera classica della propaganda sovietica (relativa agli anni della Rivoluzione) s’intitola infatti: “Come tempravano l’acciaio”. Del resto il verbo “temprare”, “forgiare” è comune al linguaggio di tutte le dittature, ivi compresa quella fascista. solide fondamenta: è espressione classica dello stile propagandistico sovietico, tanto più particolare perché la propaganda sovietica adopera la parola singolare che vuol dire anche “fondamenta” al plurale; una parola poi di origine latina, al posto di quella russa nel tentativo di dare un’aria più scientifica a tutta l’espressione. [Mentre riaffermiamo con forza le nostre posizioni sull’internazionalismo proletario] È una frase talmente classica della propaganda sovietica che si trova perfino, tale e quale, a pag. 569 del vocabolario sovietico N.B. Tutte le volte che si parla in queste pagine di vocabolario sovietico, si fa riferimento a quello compilato dai sovietici, edito a Mosca dalla “Sovietskaia Enziklopedia” nel 1972 internazionalismo proletario È talmente una frase fatta della propaganda sovietica che viene citata persino nel dizionario sovietico (pag. 440) diciamo: in italiano questo “diciamo” non sta. La completa espressione sovietica comporta a questo punto il verbo: “dichiariamo”. Per evitare l’enfasi dello stile sovietico, si è caduti in uno stile che non è italiano La parola russa (letteralmente: standard) è stata male tradotta con “livelli”. Al plurale, come è qui il caso, “standard” significa in russo (che si discosta un poco dalla accezione occidentale) “strumenti e strategie”. Forse si è voluto scimiottare l’espressione “livelli istituzionali” e si è finito col creare una espressione ancora troppo inusitata in italiano. lotta armata per il comunismo: è una espressione trita e ritrita della propaganda sovietica, perché è stata usata dal 1917, dai tempi di Kolciak, Denikin, degli interventi occidentali.
322
Appendice
soldati della rivoluzione: altra espressione stereotipata della propaganda sovietica. Ma in sovietico la parola “soldati” ha un senso vero, all’inizio: erano i soldati di Budionni, dell’”armata a cavallo”, dell’“armata rossa” La traduzione “nel partito combattente” è troppo sbrigativa. Il russo impiega in questa frase stereotipata la preposizione: “all’interno del partito combattente”. Le “invocazioni” finali (tre, in questo caso) sono uno strumento caratteristico della propaganda comunista sovietica, che ha inventato per loro anche un nome. Con scrupolosità liturgica, li adopera nelle occasioni importanti, ne riempie le prime pagine dei giornali in occasione del 1º maggio o del 7 novembre. In occidente non c’è nemmeno un nome per questo tipo di espressioni: si potrebbero chiamare “appelli”; i comunisti nostrani le chiamano “tesi”. L’espressione “Onore ai compagni” è la traduzione letterale dell’invocazione (onore, gloria) (+ dativo) di cui sono materialmente pieni i muri, le strade, le case di Mosca e di Russia. L’espressione normale italiana è sempre stata “Viva” ecc.! personale, in italiano, viene impiegato nelle accezioni commerciali di “personale di una fabbrica, di un’azienda, di un ente”. In casi come questo si adopera normalmente in italiano “il complesso delle persone”. In russo, invece, la parola è impiegata in tutti e due i casi. Adesso si cerca di introdurre la parola in italiano anche nel secondo significato. Essa segue un po’ il destino dell’altra parola russa “collettivo” (il collettivo di una fabbrica) che a metà degli anni ’60 era ancora scansata in buon italiano e che ora viene accettata. sulle cui gambe cammina: in italiano si direbbe, caso mai, “camminare con le gambe ecc.”; il fatto è che in russo si dice “camminare sulle gambe”. Da ricordare inoltre l’espressione russa (letteralmente: stare sulle proprie gambe) che vuol dire “essere indipendente” (pag. 431 del vocabolario russo-italiano). Qui invece, che si voleva dire “dipendere”, si è impiegato per analogia “camminare sulle gambe di un altro”, che in italiano è strano.
323
Appendice
2. IL TERRORISMO IMPERIALISTA E L’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO La suddivisione in titoli è classica della propaganda ideologica sovietica. continentali per dire “europei” è espressione russa; “continente” è l’Europa fuori dell Russia; la rivista dei fuoriusciti russi, diretta da Solzenitzin, è stata chiamata (Continente), cioè l’esilio; fuori di Russia. controrivoluzione armata è espressione classica sovietica e propria all’Urss; nella sua accezione primordiale la vera “controrivoluzione armata” era quella di Kolciak, Denikin, ecc.: cioè quella dei russi bianchi e degli eserciti interventisti europei. trainare: cattiva traduzione del verbo russo “trenirovat” che significa “allenare”. L’estensore probabilmente, oltre l’italiano, conosceva o ha nozioni del francese, dove “entraîner” significa appunto allenare. Deve aver dedotto che anche l’italiano “trainare” fosse della stessa famiglia. A meno che avesse un ricordo dell’espressione italiana “funzione trainante” che qui poi ha sviluppato in modo improprio. appendici militari: la parola russa ha due significati: “appendice” e “reparto”. Qui l’estensore sovietico ha scelto la parola sbagliata. Non “appendici” militari, quindi, ma “reparti” militari. Del resto, se si lascia “appendice” non torna il senso della frase: sarebbero tedeschi, inglesi che, sotto varie etichette istruiscono “appendici”, quindi facenti parte della loro organizzazione. Questo non è. Gli “indigeni” secondo quanto vuol dire il testo sono strumentalizzati dagli inglesi e tedeschi, non sono presi a far parte della loro organizzazione. Boia imperialisti: è frase stereotipata della propaganda sovietica. pratica in italiano significa “prassi”, quindi, come tale, è sempre effettiva. Essendo poi una prassi, non può “dover cominciare”: essa indica infatti un fenomeno in atto da tempo. “Practika” in russo vuol anche dire “messa in opera”, “applicazione”, come è qui il caso. “Practikovat” è verbo che significa “mettere in opera”, “applicare”. [che il proletariato europeo ha espresso] La frase è chiara in russo, dove si capisce subito che “le organizzazioni comuniste combattenti” sono espressione del proletariato europeo, perché in russo viene impiegato un participio passata passivo (generate dal proletariato) che elimina il “che” e la successiva frase relativa (“che che il proletariato europeo ha espresso”) ed è posto nello stesso caso ablativo delle “organizzazioni”.
324
Appendice
In italiano invece il verbo “ha espresso”, seguito senza virgola da “un rapporto di profondo confronto politico” ingenera confusione, e sembra che il proletariato europeo abbia espresso un rapporto di profondo confronto politico. L’estensore sovietico, per spiegare, per srotolare cioè la concisione del participio, che è caratteristica della lingua russa, ha usato un “che” e conseguente frase relativa che allunga il periodo e lo confonde completamente. È stato notato («Il Giornale», 26 marzo) che l’espressione “A nessuno è sfuggito ‘come’”, avrebbe dovuto essere: “A nessuno è sfuggito che”. Il fatto è che in russo l’espressione è: “A nessuno è sfuggito come” e l’estensore si è lasciato trasportare dalla costruzione verbale russa. attivizzare: l’estensore sovietico è stato ingannato dal verbo russo “aktivisirovat” e ha scritto “attivizzare”, mentre il verbo italiano è “attivare”. lurido: traduzione letterale del classico aggettivo della propaganda sovietica (lurido) che in italiano non è impiegato nel linguaggio politico, neppure comunista. Manovre controrivoluzionarie: traduzione letterale dell’espressione nella quale ci si imbatte ad ogni piè sospinto nei testi propagandistici sovietici. Il participio russo “votato” è impiegato con eccezionale frequenza nello stile propagandistico sovietico, mentre in italiano “votato” comporta una sfumatura di sacro, di nobile, e si impiega normalmente “dedicato”. Nella mentalità sovietica i due sostantivi vanno sempre appaiati (delatori, spie), e sono appaiati nel vocabolario sovietico russo-italiano, pag. 228
L’espressione “schieramento” nel senso di “unione di tutte le forze” e, in certi casi, di “fronte”, è comunemente impiegata dai sovietici che parlano italiano, tratti in inganno dai testi sui quali studiano. Il vocabolario italiano-russo, compilato da due sovietici, espressamente pone (pag. 766) sotto la voce “schieramento”, l’esemplificazione “schieramento democratico”, nel senso di “unione di tutte le forze democratiche”. Nessun italiano avrebbe scritto la frase “il maggior merito del raggiungimento di questo obiettivo”, troppo concisa e con quel “raggiungimento” che nella nostra lingua è veramente desueto. In russo (raggiungimento) è di uso corrente e molto comodo, e la frase, tradotta troppo letteralmente in italiano, scorre in russo normalmente.
325
Appendice
Del resto, nel loro vocabolario, i sovietici trovano la voce tradotta con “raggiungimento” e questo li porta a fare una equiparazione troppo stretta tra le due parole. La parola italiana “citato” è qui forzata; essa traduce letteralmente il verbo russo “zitirovat”, che invece s’attaglia benissimo, perché in russo il significato della parola si allarga fino a comprendere il senso di “designato”. [con l’inglobamento del PSI nel governo, nel tentativo di spaccare il Movimento Operaio] Alle Br cosa dovrebbe importare? Danneggiava caso mai il Pci e certamente il Pc dell’Urss. Ma se si pensa che l’estensore della nota fa parte dell’“establishmente” sovietico, la cosa cambia e si spiega il risentimento. contraddizioni: in italiano avremmo piuttosto detto “contrasti interni”. “Contraddizioni” in questo senso è frase stereotipata dello stile sovietico. procede speditamente. È troppo mal tradotto in italiano. In una frase tesa, polemica, che comincia con un tronco: “È in questi anni che, ecc.”, si scrive poi che la borghesia imperialista, contro la quale si sente che l’animo dell’autore si scaglia, cosa fa? “procede speditamente” ecc. Ma è troppo prosaico! C’è una caduta di tono insostenibile in italiano. Un italiano avrebbe scritto perlomeno, dopo queste premesse, “si getta alla realizzazione del suo progetto”. Il fatto è che il verbo russo comprende benissimo anche questo significato. L’estensore ha scelto invece, per l’italiano, una traduzione troppo letterale (“procede speditamente”), troppo scolastica infine… prosaica! uomo di punta viene impiegato in italiano nel linguaggio sportivo. Nel vocabolario russo-italiano, invece, che è stato fatto da sovietici, viene messa la frase “uomini di punta” (pag. 651) Da tenere presente, che nella lingua sovietica esiste la parola che significa “lavoratore d’avanguardia, d’assalto”. […] Nessun italiano avrebbe scritto “l’interrogatorio ad Aldo Moro”, ma l’“interrogatorio di Aldo Moro”. Il fatto è che nella prassi sovietica l’“interrogatorio”, “procedimento istruttorio” formano un tutt’uno […]. E come il processo si fa a una persona, così l’estensore sovietico ha pensato che dopo “interrogatorio” (= processo amministrativo, di polizia) andasse messo un “a”: “interrogatorio ad”.
326
Appendice
portatrice: infelice traduzione della parola russa (etimologicamente: portatore) adoperata però nell’accezione impersonale dell’italiano “vettore”, come “razzo vettore” oppure di veicolo, come “veicolo d’infezione”. Come si vede, tutti termini maschili, che nell’estensore sovietico non dovettero sembrare bene accordabili col soggetto femminile (Democrazia Cristiana). Egli, naturalmente da tempo a contatto col linguaggio quasi il gergo progressista italiano, deve aver avuto presente l’espressione tipo: “la teoria, di cui sono portatori ecc.” ed ha impiegato per analogia la frase “le politiche di cui è portatrice la DC”, ricorrendo ad un “portatrice” che in italiano è impiegato solo nell’accezione, tra l’altro desueta, di “portatrice d’acqua”. controrivoluzione: di quale rivoluzione? Di quella sovietica, naturalmente. I propagandisti sovietici – tra i quali l’estensore della presente nota – non sono ancora saltati fuori dal loro sessantennale schema mentale.
327
Appendice
Appendice 3
Due lettere di Bettino Craxi a Giovanni Spadolini e Giorgio Napolitano su Ugo Pecchioli (27 ottobre e 5 novembre 1993) a cura di Salvatore Sechi Nell’inverno del 1993 dall’Unione sovietica viene riversata sull’Italia un’ampia documentazione concernente i rapporti di assai fraterna solidarietà, assistenza e collaborazione esistenti tra il Pci e il Pcus, e lo stesso Kgb. L’opinione pubblica scopre che sono intessuti di fili d’acciaio, al di sopra di ogni malumore e divergenza che possa increspare le relazioni tra i due partiti. Da parte dei comunisti italiani, la riprovazione dell’intervento sovietico in Cecoslovacchia nel 1968, il riconoscimento – da parte di Enrico Berlinguer – del ruolo positivo della Nato, la prospettiva dell’euro-comunismo ecc. non impediscono loro di considerare i compagni sovietici i più affidabili. Sono quelli in cui viene riposto il maggiore investimento fiduciario, come dichiara Ugo Pecchioli al settimanale «Panorama». Le comuni radici sono come il sangue, e il sangue non è acqua, dicono i sardi. Gli italiani vengono a sapere che, ad onta di ogni puntura di spillo e anche profondo dissenso, il Pci continua a inviare propri militanti a istruirsi – attraverso la sorveglianza del Kgb – nell’uso delle più sofisticate radio-rice-trasmittenti e di documenti cifrati, nel costruire una rete bilaterale di radio-comunicazioni, nella decifrazione di codici, nello studio delle tecniche di camuffamento fisico, nella falsificazione dei documenti di identità, nella creazione di apparati clandestini e nella pratica dello spionaggio politico e militare. È un interscambio che copre gli anni 1966-1981, quando il Pci aveva scelto l’alleanza atlantica ed era entrato a fare parte delle coalizioni di governo. In prima fila in questi rapporti col Pcus e col suo servizio segreto sono A. Cossutta, L. Longo, E. Berlinguer e soprattutto Ugo Pecchioli. È il ruolo ambiguo e contraddittorio di quest’ultimo a colpire il leader socialista Bettino Craxi. Infatti, Pecchioli da un lato collabora con i servizi segreti di Mosca e degli altri paesi dell’Europa orientale in attività illegali, clandestine e di spionaggio; dall’altro si mantiene a stretto contatto con i capi dell’intelligence italiana. Addirittura ha una consuetudine di appuntamenti fissi, in una località riservata, col capo del Sismi ed esponente della loggia massonica P2, gen. Santovito. Che, per queste ragioni, il dirigente comunista torinese possa ricoprire la carica di presidente del Comitato parlamentare di controllo dei servizi di informazione e di sicurezza civile e militare a Craxi non sembra proprio opportuno. Chiede, pertanto, le dimissioni di Pecchioli da tale responsabilità istituzionale in una lettera inviata a Giorgio Napolitano e a Giovanni Spadolini, rispettivamente presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. Lo fa una prima volta il 27 ottobre 1993, e la reitera il 5 novembre. Chi è Pecchioli se non il capo del braccio armato del Pci all’estero? Anzi Craxi parla di «una vera e propria diramazione italiana della polizia segreta sovietica» assicurata dalle «strutture clandestine e di pratiche di addestramento di elementi italiani selezionati dal Pci nelle scuole moscovite del Kgb».
328
Appendice
329
Appendice
330
Appendice
331
Appendice
332
Appendice
333
Appendice
334
Appendice
335
Appendice
336
Appendice
337
Appendice
338
Appendice
339
Appendice
340
Appendice
341
Appendice
342
Appendice
343
Appendice
344
BIO-BIBLIOGRAFIA DEGLI AUTORI
ROBERTO BARTALI, Ph.D. (Erice, 1972). Ha pubblicato, in collaborazione con M. BORGOGNI, Diario e memorie di guerra del marinaio Mario Panfili, 19401945, Ed. Cantagalli, Siena 2005; Red Brigades and Moro Kidnapping: Secrets and Lies, in A. BULL e A. GIORGIO (a cura di), Speaking Out and Silencing: Culture, Society and Politics in Italy in the 1970s, Legenda 2006 (trad it.: Le Brigate Rosse, una storia della guerra fredda, «Nuova Storia Contemporanea», a. X, n. 6, novembre-dicembre 2006) e Infiltrati nelle Brigate Rosse, in AA.VV., Il sequestro di verità, Kaos, Milano 2008. LUIGI CARLI, allievo di Gaetano Foschini, Luigi Conti e Giovanni Conso, è cultore a livello universitario di diritto processuale penale ed autore di tre monografie e di numerosissimi studi in questo settore. Magistrato di cassazione f.d.s., esplica in atto funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari. In precedenza presso la Procura della Repubblica di Genova, di Imperia e di alcune città del Piemonte, si è occupato a lungo di criminalità organizzata, politica e comune, di attentati contro la Nato, di terrorismo medio-orientale, di tangentopoli, della morte di Francesca Vacca Agusta e del leader democristiano Antonio Bisaglia, accertandone compiutamente cause e particolari. MARCO CLEMENTI, è ricercatore di storia dell’Europa Orientale presso l’Università della Calabria e membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca “Memorial” di San Pietroburgo. È autore, fra gli altri, di Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar. La beneficenza italiana da Pietroburgo al Caucaso (1863-1922), Periferia, Cosenza 2000; Il diritto al dissenso. Il progetto costituzionale di Andrej Sacharov, Odradek, Roma 2002; Storia del dissenso sovietico (1953-1991), Odradek, Roma 2007. A Moro e alle Brigate rosse ha dedicato: La pazzia di Aldo Moro, Bur, Milano 2008, e Storia delle Brigate rosse, Odradek, Roma 2007. RICHARD DRAKE, insegna storia europea all’Università del Montana. Attualmente è preside del Dipartimento di storia. Tra le sue opere più significative: The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy,
345
Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1989 (col quale ha vinto il premio della Society for Italian Historical Studies “Howard R. Marraro”); Il caso Aldo Moro: Una tragedia italiana vista da uno storico americano, Marco Tropea editore, Roma 1996; e Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Le Lettere, Firenze 2008. FRANCO MAZZOLA, avvocato, è stato deputato dal 1972 al 1983 e senatore dal 1983 al 1994. Sottosegretario alla difesa, al Commercio con l’Estero e alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi d’informazione e sicurezza nei governi Andreotti, Cossiga, Forlani e Craxi. È autore de I giorni del diluvio, Nino Aragno Editore, Torino 2007, dedicato al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro. FERNANDO ORLANDI, esperto di Guerra Fredda e dei rapporti all’interno del mondo comunista negli anni Cinquanta. Ha collaborato a vari progetti internazionali di ricerca. Dal 1999 dirige il Centro studi sulla storia dell’Europa orientale (CSSEO) di Levico Terme. GABRIELE PARADISI, imprenditore, ha fondato e dirige www.cielilimpidi.com. È autore di Periodista, di la verdad! Controinchiesta sulla Commissione Mitrokhin, il caso Litvinenko e la repubblica della disinformazione, Giraldi Editore, Bologna 2008. VLADIMIRO SATTA, fa parte del Servizio Studi del Senato, ha lavorato presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e le stragi dal 1989 al 2001. Negli anni Ottanta si era occupato del Psi dalle origini alla prima guerra mondiale, tema al quale aveva dedicato un paio di saggi pubblicati sulla rivista «Clio». Nello stesso periodo, aveva redatto alcune voci del Dizionario Biografico degli Italiani edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. È autore, tra l’altro, di Odissea nel caso Moro (Edup, Roma 2003) e Il caso Moro e i suoi falsi misteri (Rubbettino, Soveria Mannelli 2006) nonché di numerosi saggi sulla rivista «Nuova Storia Contemporanea» tra cui I collegamenti internazionali del terrorismo rosso italiano (fascicolo novembredicembre 2007). Altri suoi scritti relativi ai cosiddetti “anni di piombo” sono di prossima pubblicazione in Italia e all’estero. SALVATORE SECHI, professore di storia contemporanea presso l’Università di Ferrara. Ha insegnato e svolto ricerche nelle università di Torino, Venezia, Oxford, Bologna, Berkeley. Si è occupato di storia del fascismo, del Pci, del movimento sindacale e dell’America latina. È stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, Usa, e consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dossier Mitrokhin. È autore, tra gli altri, di Compagno cittadino. Il Pci tra via parlamentare e lotta armata, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
346
INDICE DEI NOMI
Adamoli, Roberto 61-62 Adenauer, Konrad 297 Aga-Rossi, Elena 132 n Agnelli, famiglia 40, 47 Agnelli, Gianni 46-47 Agnelli, Susanna 47 Agnelli, Umberto 47 Allavena, Giovanni 217 Allegra, Antonino 83 e n, 84 e n Allende, Salvador 286 Allin, Dana H. 259 n Amadesi, Luigi 131 e n, 133 e n Amara, Emmanuel 198 n, 199, 270 n Amato, Giuliano 308 Amato, Mario 232 e n Amendola, Giorgio 10, 111-116, 153, 248, 304 Amerio, Ettore 9, 81-82, 86, 97, 104, 105 n Andreassi, Ansoino 220 n, 233 n Andreotti, Giulio 13-14, 40, 44 e n, 148, 151, 207, 214 e n, 257, 268269, 272, 275, 280, 286 n, 317, 346 Andrew, Christopher 112 n, 152 n, 182 n Andropov, Yurii 111, 136 n, 152-153 Angiolillo, Renato 261 Anselmi, Tina 213 n Antonetti, Luciano 134 n, 136 n, 137 n Arafat, Yasser 278 Argenti, Filippo 292 Armeni, Gianremo 220 n, 235 n Arnaldi, Edgardo 57
Arnaldi, Edoardo 56-57, 70 Assalto, Maurizio 246 n Badoglio, Pietro 267 Baget Bozzo, Gianni 15 n Baldacci, Gaetano 309 Baldelli, Ignazio 271 Baldoni, Adalberto 77 n Balzerani, Barbara 72 Baramová, Anna 131 Barbara, Danilo 181 n Barca, Luciano 179 Barletta, Ugo 293 Bartali, Roberto 8-10, 51, 77, 130 n, 138 e n, 145 n, 146 n, 156 n, 159 n, 163 n, 253 n, 280 n, 289 n, 291 n, 304 n, 310, 345 Bartošek, Karel 122 n, 131 n, 132 n, 133 n, 134 n Barzini,Luigi 149 n Belardelli, Giovanni 251 n, 253 n Belci, Corrado 257 n Bellagamba, Giovanni 224 n Bellamio, Simona 164 n Bellocchio, Marco 34 Benedetti, Amedeo 184 n Benocci, Mario 134 n Bensi, Giovanni 143 n Beria D’Argentine, Adolfo 290 Berio, Duccio 82 Berlinguer, Enrico 10, 25, 77, 79 e n, 80, 82, 87, 90-91, 95-97, 108-110, 115, 119-120, 137, 140, 154 n,
347
192-193, 202, 207-209, 247 e n, 257, 258, 261 e n, 262 e n, 271, 275, 286, 304, 306-307, 310, 317, 327-328 Bermani, Cesare 126 n Bernabei, Ettore 256 Bernardi, Antonio 148 e n Berselli, Filippo 231 n Bertelli, Sergio 131 n, 132 n Bertolazzi, Pietro 62 Bertoli, Gianfranco 177, 218 n Bertona, Silvio alias Secondo Villa 128 Betassa, Lorenzo 52 n, 67 Biagi, Marco 25, 184 n Biancardi, Daniele 16 Bianconi, Giovanni 8 n Biasini, Oddo 164 n Bigazzi, Francesco 131 e n, 132 n Biľak, Vasil 150 e n, 153 n, 159 e n Biloslavo, Fausto 113 Biondo, Nicola 8 n, 11, 159 n, 198 n, 274, 304 Bisaglia, Antonio 345 Biscione, Francesco M. 8 n, 41 n, 161 n, 248 n, 253 n, 274 Bisso, Lovrano 59, 68, 89, 91, 93, 94 n Blanco, Carrero 71 e n Blažek, P. 158 n, 249 Bluementhal, Michael 264 n Bobbio, Norberto 291 Bocca, Giorgio 179 e n Bocca, Riccardo 231 n Bodrato, Guido 257 n Boffano, Ettore 95 n Bonaventura, Umberto 86 n, 228 n Bonavita, Alfredo 62, 98 e n, 100 n Bonetti, Paolo 243 n Bonifacio, Paolo 221 n Boniver, Margherita 10 Boothe Luce, Clare 294 Bordiga, Amadeo 24 Borghese, Junio Valerio 218, 303 Borgogni, Massimo 345 Bozzo, Carlo 55, 57, 59-60
Bozzo, Nicolò 59, 79 n, 85 e n, 88-89, 228, 233 n, 235 n, 236 n, 289 e n, 290 Bracke, Maud 137 n Brandt, Willy 14, 268 Brezhnev, Leonid 153 Brogi, Alessandro 255 Brzezinski, Zbigniew 264 n Bucciarelli Ducci, Brunetto 261 Bufalini, Paolo 148, 248 Bukovskij, Vladimir 130 n Bull, Anna C. 345 Burato, Natale 137 Burato, Natale 137, 303 Bush, George 259 Cacciapuoti, Alba Libera 108 n Cacciapuoti, Salvatore 10, 95-96, 98, 107, 108 e n, 109, 110-117, 136 n, 150 e n, 151-153, 159, 304 Caetani, famiglia 258 Caetani, Topazia 195 Cafiero, Carlo 23, 29, Cagol, Mara 21, 101 n, 110, 180 n Calabresi, Luigi 215 Calamandrei, Piero 309 e n Calvi, Guido 252 n Canosa, Romano 215 n Cantimori, Delio 245 Cantore, Romano 154 n Cappelletti, Vincenzo 228, 271 Cappelli, Aldo 125 Caprara, Maurizio 10 n, 294 n Carandini, Andrea 246 n Carcaterra, Giovanni 299 Cardini, Flaminia 252 n Caretto, Ennio 261 n Carioti, Antonio 249 n Carli, Luigi 8 e n, 9, 51-69, 72-75, 345 Carlucci, Guglielmo 266 Carter, James (Jimmy) E. 258, 261263, 264 n, 273, 287 Caruso, B. 140 n Casamassima, Pino 162 n
348
Caselli, Gian Carlo 95 n, 98, 110, 219 n, 242 n, 246 n Castellano, Carlo 63 Castro, Fidel 263 Castronuovo, Manlio 162 n Catellani, Peppino 148 e n Cauchi, Augusto 241 Cavallo, Luigi 290-291, 293, 296, 297 e n, 305 n Cazzullo, Aldo 101 n, 119 n, 296 n Cervetti, Gianni 10, 114-115, 132 n, 150 e n, 151 e n, 304 Cesqui, Elisabetta 232 n Chichiarelli, Antonio (Toni) 198 Churáň, M. 158 n Church, Frank 263 Cipriani, Antonio 101 n, 109 n, 213 n, 248 e n, 250 n, 260 Cipriani, Gianni 8, 79 n, 85 n, 101 n, 109 n, 213 n, 248 e n, 249 n, 250 n, 260 Ciruzzi 61 Ciufoli, Domenico (“Paolo Belli”) 129 e n, 330 Clementi, Marco 8-9, 14, 31, 34 n, 162 n, 219 n, 245 n, 274, 345 Cocconi, Gianni 55, 67 Coco, Francesco 53, 234 n Codecà, Eleuterio 291, 292 e n, 293 n, Coiro, Michele 157 n Colby, William 261 Colombi, Arturo 10, 111, 115-116, 134, 153, 304 Colombo, Andrea 8, 231 n, 257 n, 258 n Concutelli, Pierluigi 212 Conforto, Giorgio 211 n, 282 Conso, Giovanni 345 Conte Micheli, Giulia 271 Conti, Luigi 345 Cooke, Philip 123 n, 124 n, 128 n, 134 n, 250 n, 288 n, 289 n Corner, Paul 304 n Corrias, Marco 286 n Corsini, Pietro 236 n, 237 n, 267 n
Cossiga, Francesco 14, 40, 106 e n, 112, 113 e n, 114 e n, 155 e n, 195, 198-199, 201, 204 n, 221, 227, 266, 267, 269, 270 e n, 271-272, 274, 276, 277 n, 280, 296 e n, 306, 319, 346 Cossutta, Armando 130, 328 Costa, Andrea 23 Costa, Piero 53 Cottafavi, Luigi 279 n Craxi, Bettino 10 e n, 200, 241, 247, 281, 327-328, 346 Cristiani, Gianluigi 55, 57, 66 Croce, Benedetto 309 e n Croce, Fulvio 225 Cucchiarelli, Paolo 13, 253 n Curcio, Renato (avvocato calabrese) 159 Curcio, Renato (fondatore delle Br) 11, 21, 28, 84 e n, 96 e n, 100, 101 e n, 109-111, 116, 147-148, 151, 159, 180 n, 192, 221 n, 233, 234 n, 285, 288, 304 e n, 307 Curzi, Alessandro 149 n Custodero, Alberto 38 n D’Addio, Mario 271 D’Alema, Massimo 108 n, 287 Dalla Chiesa, Carlo Alberto 9, 12-13, 51, 52 n, 68, 79 n, 85, 87-90, 92, 95, 97, 100-101, 119, 147, 148 n, 157 n, 220 n, 221, 228 e n, 232234, 235 e n, 236 e n, 237 e n, 238, 242, 289, 290, 308, 311 Dalla Chiesa, Nando 237 n D’Amato, Federico Umberto 218 e n, 221, 266 D’Antona, Massimo 25, 183, 184 n d’Archirafi, Raniero Vanni, 125 da Rold, Gianluigi 184 e n D’Asaro, Franz Maria 293 n D’Avanzo, Giuseppe 182 n Dean, Robert W. 149 n De Benedetti, Carlo 235 n
349
De Carli, Giuseppe 230 n, 235 n De Carolis, Massimo 227 n De Ficchy, Luigi 95 n, 96 n, 116 n, 302 n De Francisci, Gaspare 266 De Gasperi, Alcide 126 n, 313 Delera, Roberto 215 n Delfino, Francesco 176 e n, 177, 178 e n, 179 e n, 180 e n, 186 e n Dell’Andro, Renato 107 n, 190, 279 n, 280 Della Porta, Donatella 205 n, 209 n, 215 n, 231 n, 241 n, 245 n Delle Chiaie, Stefano 213 De Longis, Pietro 93 De Lorenzo, Alessandro 296 n De Lorenzo, Giovanni 47, 48 n, 114 n, 217, 261, 296 n, 318 Del Pero, Mario 255 De Lutiis, Giuseppe 8, 13, 105 n, 121 n, 163 n, 182 n, 186 e n, 214 n, 245 e n, 246, 249 e n, 252, 255, 256 e n, 257-261, 263, 265, 269, 274-275, 281-282, 283 e n, 284 e n, 285-288, 289 n, 290-291, 293300, 301 e n, 304, 306-308, 310312 De Matteo, Giovanni 228 De Mauro, Tullio 180 e n De Mita, Ciriaco 157 n Denikin, Anton I. 322 De Palo, Giancarlo 253 n De Rosa, Gabriele 77 n d’Estaing, Giscard 222 n De Stefanis, Celso 261 De Vincenzo, Ciro 82-85, 148 e n, 311 Devlin, Kevin 149 n, 150 n Diem, Ngo Din 263 Di Giovanni, Edoardo 210 n Di Nicola, Primo 159 n Di Nolfo, Ennio 253 n Di Rienzo, Eugenio 309 n Di Stefano in Grignano, Concetta 276 Di Vittorio, Giuseppe 124
Dogliotti, Chiara 8 n Dolcetta, Mario 270 n, 271 n Donno, Gianni 118 n, 126 n, 127 n, 155 n Dotti, Roberto 101 n, 128 n, 291-292, 296-298, 303 Douglass, Joseph D. 146 n Dozier, James L. 117 Drake, Richard 15 e n, 19 e n, 20 n, 22 n, 23 n, 246 n, 260 e n, 345 Droysen, Johann G. 245 Dubček, Alexander 135, 137, 150 Duiz, Roberto 286 n Dura, Riccardo 52 n, 58, 65 Durdo 132 Emanuel, Guglielmo 309 Ermentini, Augusto 271 Esposito, Antonio 53, 68 Esposti, Giancarlo 213 n Essan, Aba 106 n Faenza, Roberto 254 n, 255 e n Faina, Gianfranco 53, 54 Fanfani, Amintore 40, 199, 200, 207 Farini, Carlo 134 n Fasanella, Giovanni 68 n, 69, 72, 78 e n, 84 n, 90 e n, 91 n, 92 n, 96 n, 97 n, 101 n, 103 n, 148 n, 258 n, 289 n, 294 n, 295 n, 311 n Faustini, Felice B. 293 n Fava, Antonino 149 n Feltrinelli, Carlo 144 e n Feltrinelli, Giangiacomo 84 n, 102, 117 n, 133, 135 n, 143, 144 e n, 177, 192, 205 e n, 206, 307 Fenzi, Enrico 53, 55, 63, 97 n Ferracuti, Franco 102 n, 271, 274 n, 275 n Ferrajoli, Luigi 225 n Ferrante 293 n Ferrara, Giuliano 248 e n Ferraresi, Franco 232 n, 241 n Ferrari Bravo, Luciano 11, 192
350
Ferrari, Alberto 296 Finetti, Ugo 309 n Fini, Massimo 254 n Fioravanti, Giuseppe Valerio (Giusva) 231 n, 232 Fiori, Giuseppe 11 Fiori, Publio 227 n Flamigni, Sergio 41 n, 101 n, 107 n, 162 n, 163 n, 190 n, 248, 249 n, 251 n, 252-253 n, 258 n, 260, 265, 276 n, 278 n, 279 n, 280 n, 286 e n, 289 n, 295 n Flamini, Gianni 248, 249 n, 252, 253 n, 258 n, 260, 265, 289 n Floris, Alessandro 143 Fontana, Sandro 309 n Ford, Gerald R. 261, 263 e n Forlani, Arnaldo 49, 119 n, 346 Formigoni, Guido 255 Forst, Jaroslav 151 n Foschini, Gaetano 345 Fragalà, Enzo 106 n, 145 n, 146 n, 148 n, 179-180, 277 n, 296 n Franceschini, Alberto 9, 11, 21, 6162, 78, 81, 82 e n, 83, 84 e n, 8586, 87 n, 88 e n, 95, 96 e n, 98, 99 e n, 100 e n, 101 e n, 102 e n, 103, 104 e n, 110, 113, 115 e n, 116, 147, 148 e n, 151, 159, 160 n, 180, 192, 233, 304 e n, 307 Franceschini, Sergio 159 Franchi, Franco 164 n, 175 e n, 186187 Franco, Francisco 71 n Franzinelli, Mimmo 212 n, 213 n, 214 n Frattasio, Antonio 154 e n Freda, Franco 213-214, 231 n Frolík, Jan 113, 129 n Fumagalli, Carlo 177, 213 Fusco, Anna Maria 212 n Fusco, Matteo 212 n Gaipa, Aurelio 299 e n Galati, Michele 213 n
Galli, Giorgio 77 n, 104 e n, 242 n, 249 n, 252, 253 n, Gallinari, Prospero 31, 36 n, 221 n, 228 Galliussi, Anita 132 Galloni, Giovanni 39 e n, 273, 275, 307 Galluzzi, Carlo 87 Gandini, Costante 292 e n Gardner, Richard N. 44, 140 e n, 258 n, 261 n, 264 e n, 267 n Garigliano, Roberto 55, 57, 68 Garosci, Aldo 290 Garrone, Riccardo 68, 71 Garthoff, Raymond L. 259 n Gati, Charles 282 n Gava, Silvio 213 n Gelli, Licio 227 e n, 270-272, 296 Geminder, Bedřich 128 e n, 129 e n, 133 e n Gentiloni Silveri, Umberto 263 n Ghini, Celso 303 Giacumbi, Nicola 73 Giannettini, Guido 213, 214 e n, 218 n, 283 Giannuli, Aldo S. 8, 13 e n, 14, 119 n, 210 n, 211 n, 212 n, 216 n, 218 n, 246, 252 e n, 253 n, 260, 274, 289 n, 290 n, 312 n Gianotti, Renzo 292 n Giolitti, Giovanni 24, 25 Giorgio, Adalgisa 345 Giovagnoli, Agostino 249 n, 254 n, 255, 257 n, 267 n, 307 n Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) 131, 204 Giovannone, Stefano 191, 276, 279, 280 n Giralucci, Graziano 147 Girotto, Silvano (“Frate Mitra”) 84, 85 e n, 101 n, 102, 147, 283 Gori, Francesca 133 Gorresio, Vittorio 47 Goruppi, Silvano 149
351
Gotor, Miguel 31 e n, 32, 33 e n, 34 e n, 35 e n, 36 e n, 37-39, 107 n, 161 n, 176 n, 190 n, 278 n Gottwald, Klement 131 Gozzini, Giovanni 134 n Gramsci, Antonio 24 Grassi, Stefano 187 e n Grassini, Giulio 227 n, 267 n, 296 Grasso, Luigi 53 Graziano, Luigi 253 n, 268 n Gremmo, Roberto 126 n Grevi, Vittorio 218 n, 230 n, 238 n Griboiedov, Alexandr 170 Grignetti, Francesco 211 n, 270 n, 273 n Gronchi, Giovanni 47 Gualtieri, Roberto 287 n Guareschi, Giovanni 309 Guarisco, Vincenzo alias Guido Marinoni 133 n Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) 7 Guerra, Adriano 286 Guerriero, Carlo 126 n Guerzoni, Corrado 39 e n Guttuso, Renato 140 Guzzanti, Paolo 178 n Habbash, George 277-279 Hagan, Jim 123 n Hajek 153 n Hampl, Dagmar 113 Hanhimaki, Jussi 259 n Havelka, Jan 153 n Höbel, Alexander 137 n Hoffer, Eric 19 e n Hoření, Zdeněk 147 e n Hübl, Milan 149 Hůla, Václav 153 n Husák, Gustáv 153 n Iacopino, Vincenzo 286 n Iannucci, Lorenzo 320 Ilari, Virgilio 294 n, 296 n
Imposimato, Ferdinando 102 e n, 103104, 140, 141 n, 182 n, 184, 229 e n, 230 n, 245 n, 272 e n, 274 n, 275 n Improta, Umberto 266 Infelisi, Luciano 14, 228-229 Ionta, Franco 95 n, 96 n, 116 n, 289 n, 302 n Jannuzzi, Lino 114 n, 296 Johnson, Lyndon B. 259 Kaderka, Oldřich 134 Kamal, Said Wasfi 276 Kaminski, Lukasz 158, 249 n Karner S. 136 n Kennan, George 259 Kennedy, John F. 190, 254 n, 259 Kennedy, Robert F. 190 Kissinger, Henry 14, 44-45, 46 e n, 176, 193, 259 e n, 261, 268 e n, 269, 272, 274 Köhler, Bruno 131 e n Kolciak, Alexandr V. 322, 324 Kostylev, Mikhail 132 e n Koucký, Vladimir 111-112, 134, 153 Koudelka, F. 158 n Kruscev, Nikita S. 20 Kryuchkov, Vladimir A. 131 n Kundera, Milan 156 Labate, Bruno 80 Labriola, Antonio 24, 27 Labriola, Arturo 24, 27 Labruna, Antonio 214, 218 Lajolo, Davide 149 Lama, Luciano 306, 307 Larrabee, F.S. 149 n Lasch, Christopher 27 e n Laurent, Frederic 252 n Lazagna, Giovanbattista 61, 84-85 Ledeen, Michael 273 Lenárt, Jozef 153 n Lenin, Vladimir I. (Ul’janov) 20-21, 23, 30, 67
352
Leone, Giovanni 201, 318 Lettieri, Nicola 181, 227 Leven, Asa 278 Levi, Arrigo 180 Ligini, Marco 210 n Limiti, Stefania 13, 290 n Lipari, Nicolò 225 n Lombardi, Luigi 217, 305 Lombardo, Ivan Matteo 260 Longanesi, Leo 309 Longo, Luigi 118, 135, 303, 308, 328 Loth, Wilfried 259 n Ludman, Annamaria 52, 58, 67 Lumley, Robert 77 n Lumumba, Patrice E. 263 Luxemburg, Rosa 67 Macaluso, Emanuele 10, 140, 150 n, 304, 308 Maccari, Germano 31 Macchiarini, Idalgo 83 Maggi, Carlo Maria 210 Magi Braschi, Adriano 283 Malagodi, Giovanni 207 Malagugini, Alberto 82-83, 85 Maletti, Gianadelio 86, 214, 216-218, 276 Malfatti di Montetretto, Francesco 296 Mambro, Francesca 231 Manca, Vincenzo 179, 182-184 Manconi, Luigi 210 n Mangiavacca, Franca 286 n Mantica, Alfredo 145 n, 146 n, 148 n Marazzita, Nino 229 Marchese, Stelio 256 n, 281 n Marchetti, Maria Riccarda 43 n, 222 n Marchio, Michele 164, 175, 186-187 Marcinkus, Paul 211 Margolius, Rudolf 132 e n Marighella, Carlos 61, 64, 68 Marini Recchia, Vincenzo 142 n Marino, Raffaele 181 n Markevitch, Igor 195-196, 258 n Marra, Francesco 101 n
Marshall, George C. 313 Martin, Graham A. 44, 261 Martinelli, Renzo 134 n Martini, Fulvio 122, 156-157, 280 n, 284 n Martino, Gaetano 261 Marx, Karl 21, 23, 25, 29, 67 Mastelloni, Carlo 105-106, 213 n, 275277, 279 Mastrolilli, Paolo 8, 255 n, 263 n, 264 n, 268 n, 269 Matassa, Lorenzo 231 n, 281 n Mattei, Enrico 297 Matteucci, Nicola 290 Mazzetti, Roberto 80 n Mazzola, Franco 3, 5, 8, 10-12, 189202, 281, 346 Mazzola, Giuseppe 147 McGinn, John G. 282 n Medici, Mario 271 Merlino, Mario 213 Merzagora, Cesare 260 Miceli, Vito 261, 276, 280 Mieli, Renato 283, 290 Miglietta, Fulvia 55, 60-61, 72, 74-75 Migone, Giangiacomo 293 n Mincuzzi, Michele 102 Minicangeli, Marco 98 n Minna, Rosario 231 n, 241 n Misasi, Riccardo 200, 279 n Mitrokhin, Vasilii 112 n, 152 e n, 181 n, 182 n Molinari, Maurizio 255 n, 263 n, 264 n, 268 n, 269 Monina, Giancarlo 77 n Montagnana, Rita 132 Montanari, Bruno alias Cesare Zerbini 133 n Montanelli, Indro 309 Montesano, Tommaso 151 n Montesi, Maria 293 n Moranino, Francesco 126, 133 n, 303 Morelli, Vincenzo 203 n, 235 n Moretti Franco 126, 133
353
Moretti, Mario 32, 36, 40, 42, 102-103, 138, 145, 168 n, 183, 192-193, 223, 228-229, 273, 281 Morlacchi, Piero 82 Moro, Giovanni 179 Moroni, Ilaria 163 n Morris, Benny 98 n Morucci, Valerio 215, 285 Mosca, Carla 28 n, 168 n Mumolo 68 Musci, Aldo 98 n Mussolini, Benito 24 Mutti, Claudio 231 Napoletano, Gaetano 266 Napolitano, Giorgio 10, 327-328 Navratil, Thomas J. 282 n Negarville, Celeste 291 n Negri, Antonio (Toni) 11, 20-21, 24, 307 n Nenni, Pietro 261 Neppi Modona, Guido 240 n Netanyahu, Benjamin 117 n Nitto Palma, Francesco 289, 302 Nixon, Richard M. 259 n Niznansky 153 n Nobile, Gianni 92 Novelli, Diego 253 n Novotný, Antonín 131 e n Nulchis, Francesco alias Francesco Orsini 133 n Nuti, Leopoldo 255 n Obzina, Jaromír 109, 151 Occorsio, Vittorio 212 Ochetto, Valerio 149 e n Orfei, Ruggero 157 e n Orlandi, Fernando 8 n, 10, 11, 245 n, 282 n, 289 n, 301 n, 346 Orlandini, Remo 87, 96, 98, 169, 173, 190, 194 Ortolani 53
Pacciardi, Randolfo 261, 294, 305 Pacner, K. 153 n, 158 n Paggio, Giulio alias Ten. Alvaro alias Antonio Boffi 126, 137 Pajetta, Giancarlo 88, 100, 148 Palme, Olaf 14, 34, 39, 173, 185, 223, 268 Palombo, Giovan Battista 89 Panciarelli, Piero 52, 67 Panfili, Mario 345 Panzieri, Raniero 20, 21 Paolo VI (Giovanni Battista Montini) 15 Papuzzi, Alberto 297 n Paradisi, Gabriele 12-13, 161, 346 Parisi, Arturo 308 Parlato, Giuseppe 267 Paroli, Tonino 62, 147 Pascalino, Pietro 228 Pasolini, Pier Paolo 37 Pasquino, Gianfranco 206 n, 251 n Pecchioli, Ugo 10 e n, 79 n, 86 e n, 88-89, 92, 95, 100, 113, 115, 130131, 151, 153, 248 n, 304, 308, 310, 327-328 Peci, Patrizio 52, 56, 62, 98 Pecorari, Alessandro 134 n Pecorelli, Carmine (Mino) 107, 253, 280, 286 Pecorelli, Francesco 286 Pelikán, Jiří 135 n, 136 n Pelizzaro, Gian Paolo 118 n, 231 n, 279, 281 Pellegrino, Giovanni 83, 148, 179, 180, 182-183, 194, 253, 289 n, 295 n, 311 n Pelli, Fabrizio 11, 109, 113, 116, 125, 143, 145-147, 151, 153, 159, 192, 307 Pelosi, Walter 266, 296 Pennacchini, Erminio 190, 279 Perfetti, Francesco 8 n Pergolizzi, Paolo 78 n, 87 n, 90 n, 147-148 n
354
Persak, Krzysztof 158 n, 249 Pertini, Sandro 280 Petricola, Ave Maria 71 Petruccioli, Claudio 94 Picasso, Caterina 55, 69, 73 Picchiotti, Franco 305 Piccoli, Flaminio 107, 190, 278-279 Pieczenik, Steve 14-15, 198-199, 267, 269-274 Pifano, Daniele 278 Pignero, Gustavo 147, 154 Pike, Otis G. 260-261 Pinelli, Giuseppe 213 Pinzani, Carlo 255 n Pisetta, Marco 99-101, 283 Pomarici, Ferdinando 220 Ponomarev, Boris 130, 131 n Pons, Silvio 133 n Popper, Karl R. 246 Pozzan, Marco 214 Priore, Rosario 8 n, 180-183, 220, 272, 281-282, 288-289, 300 Provvisionato, Sandro 8 n, 77 n, 141 n, 182 n, 229 n, 245 n, 253 n, 272 n, 274 n Quaglia, Giuseppe 51 Raisi, Enzo 231 Raito, Leonardo 51 Ramirez Sanchez, Ilich (“Carlos”) 279 Ramundo, Luigi 69 Rando, Gaetano 123 n Raviola, Alberto 291 Reagan, Ronald W. 27, 259, 263 Reale, Eugenio 132-133, 261 Reale, Oronzo 220-221, 224-225, 238 Reiter, Herbert 215 Reviglio Della Veneria, Carlo 88, 100 Riccò, Gianni 151 n Ripa di Meana, Carlo 301 n Risaliti, Renato 154 n Riva, Valerio 82 n, 130 n, 132 n, 137 n, 287
Roatta, Mario 290 Rocca, Giuseppe 258 n Rocca, Renzo 258 n Rodotà, Stefano 220 n, 240 n Rognoni, Giancarlo 119, 210 Rognoni, Virginio 230 n, 235 n, 237 n, 242 n Romano, Sergio 254 Romeo, Giovanni 102, 109 Rondinelli, Fausto 126 n Roosevelt, Franklin D. 259 Rossa, Guido 8, 52-53, 59, 65-69, 71, 90 n, 91 e n, 92 n, 97 e n, 294 e n Rossa, Sabina 68 e n, 72, 90 e n, 92 n, 97 n, 294 n Rossanda, Rossana 28, 79, 168, 306307 Rossellini, Renzo 141, 142 e n Rossi, Andrea 251 n Rossi, Ernesto 309 Rossi, Mario 143 Rossi, Mario G. 250 n, 251 n, 252 Rota, Renzo 12, 162-163, 164 e n, 165 n, 166-174, 175 e n, 176, 177 e n, 179, 180, 182-188, 317, 321 Ruffilli, Roberto 203 Ruggieri, Angelo 95, 181 Ruggiero, Lorenzo 41 n, 162 n, 163 n, 174 n Ruggiero, Michele 79 n, 228 n Rumor, Mariano 261, 276-277 Russomanno, Silvano 276 Ryzhov, Nikita 112, 153 Saba, Giuseppe 143 Sabbatucci, Giovanni 210 n, 253 n, 312 n Sacharov, Andrej D. 345 Salem, Abu Shreda 279 Salemi, Ignazio 136 Salvemini, Gaetano 309 n Salvini, Guido 119 n, 239, 240 n Santillo, Emilio 12, 18, 221-223, 242, 266
355
Santino, Umberto 253 n Santovito, Giuseppe 279, 296, 328 Sapegno, Pierangelo 235 n Saragat, Giuseppe 126, 299, 313 Satta, Vladimiro 8 n, 12, 14, 163 n, 181, 182 n, 185 n, 249, 253 n, 255256, 260 n, 263 n, 267 n, 282 n, 285 n, 312 n, 345 Scalfari, Eugenio 114 n, 296 Scelba, Mario 225, 293-294, 302, 318 Schietroma, Dante 164-165 Schivelbush, Wolfgang 254 n Schleyer, Hanns-Martin 42, 227, 230, 282 Schneider, René 263 Scialoja, Mario 107 n, 280 n Sciascia, Leonardo 108 n, 140 e n, 175 e n, 176, 283 n Scoppola, Pietro 14 Scozzafava, Angela 55, 72 Scutti, Vittorio 154 n Secchia, Matteo 131 e n, 132 e n Secchia, Pietro 116-118, 128, 131133, 205, 303, 308-309 Sechi, Gian Paolo 119-120 Sechi, Salvatore 7, 8 n, 15, 51, 85 n, 89 n, 91 n, 93 n, 94 n, 114 n, 118 n, 121 n, 290 n, 327, 346 Seghetti, Bruno 226-227 Segio, Sergio 95 Segni, Antonio 47, 261, 296, 318 Šejna, Jan 146, 192 Seniga, Giulio 131 Senzani, Giovanni 284 Serravalle, Gerardo 106 Serri, Rino 90 Sestieri, Claudio 148 n Setti, Giuseppe 109, 113-114, 151 Sharif, Bassam Abu 191 n, 279 Silvestri, Stefano 14, 271, 274 Simioni, Corrado 284 Skála, Josef 135 Slánský, Rudolf 133 n Smrkovský, Josef 149 e n, 150
Sofri, Adriano 24, 215 Sogno, Edgardo 101, 119 n, 290-291, 296 Sokolov, Sergeij 178 e n, 180-181, 182 e n, 282, 311 Sommella, Roberto 286 n Soresino, Renzo 303 Sossi, Mario 41, 53, 59, 81, 85-91, 93, 97, 100, 142-143, 194, 219, 232 Spadolini, Giovanni 10, 327-328 Sparti, Massimo 231 Spazzali, Giuliano 307 Speciale, Roberto 9, 89, 91-93 Stalin, Iosif V. (Dzugasvili) 20, 118, 124, 132, 254, 297, 308-309 Stark, Ronald 288 Stortoni, Luigi 223 n Štrougal, Lubomír 153 n Suk, J. 158 n Sukarno, 259 Suslov, Mikhail A. 171 Tallarigo, Ranieri 276 Tambroni, Fernando 47-48, 250, 318 Tarrow, Sidney 253 n, 268 n Tassani, Giovanni 15 n Tatò, Antonio 247 n, 253 n Taviani, Ermanno 77 n Taviani, Paolo Emilio 87 n, 97 n, 212 n, 232, 234 n, 241 n, 261 n, 277 n, 305 Terzani, Francesco 276, 278 Tessandori, Vincenzo 95, 147 Testa, Ludovico 128, 134, 301, 303 Tiberti, Vincenzo 291 Tito (Josip Broz) 297 Tocqueville, Alexis de 15, 23 Togliatti, Palmiro 24-25, 114, 128, 131-133, 283, 294, 297 Tolomelli, Araldo 128 n, 133 n, 134 n, 301 n, 302, 303 e n Tolomelli, Marica 7, 77 n, 243 n Tomilina, N. 136 n Tortorella, M. 132 n
356
Tranfaglia, Nicola 250 n, 252, 253 n, 255 n, 312 n Triaca, Enrico 229 Tritto, Francesco (Franco) 181 e n, 182 Trujillo, Rafael L. 263 Truman, Harry S. 259 Tschubarjan, A. 136 n Turatello, Francis 13 Turati, Filippo 24-25, 29-30 Turi, Rocco 115 n, 118 n, 127 e n, 137 e n, 138 e n, 185 e n, 186, 288 n, 299 e n, 300, 303 n Tuzet, Flavio 4 Vacca Agusta, Francesca 345 Valcini, Alceo 126 n Valiani, Leo 280 Valiante, Mario 139, 164, 251 Valletta, Vittorio 292-293, 297 Valpreda, Pietro 212-213, 219, 225 Vance, Cyrus 264 Vavruš, Antonín 108, 109, 111, 151153, 153 n, 159 Vecellio, V. 140 n Ventura, Giovanni 213 Ventura, Marco 235 n Viberti, Angelo 294
Viel, Augusto 11, 143-145, 159, 192, 307 Viggiani, Egidio 260 Vigna, Pier Luigi 224 Viola, Guido 143, 203 Violante, Luciano 239 n, 251 n, 296 Vitalone, Claudio 14 Vivarelli, Roberto 254 n Viviani, Ambrogio 105, 106 n, 217 n, 277 n Volcic, Demetrio 149 n Volpe, John 44, 261 Waldheim, Kurt 221 Zaccagnini, Benigno 114, 201, 257, 273 Žáček, P. 158 n Zaslavsky, Victor 118 n, 132 n, 137 n Zavoli, Sergio 77 n Zevi, Zamir 106 Zhdanov, Andrei 128 Zidar, Ferdinando 149 Zorzi, Delfo 210 Zucca, Enrico 13 Zupo, G. 142 n, 256 n
357
Finito di stampare in Firenze presso la tipografia editrice Polistampa Maggio 2009