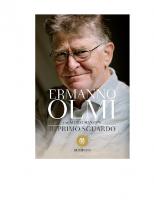Il primo sguardo 8845278530, 9788845278532
"Lo sguardo" a partire dal quale Ermanno Olmi si racconta a Marco Manzoni è quello che si sono scambiati i suo
112 101 1MB
Italian Pages 186 [117] Year 2015
Polecaj historie
Citation preview
“Lo sguardo” a partire dal quale Ermanno Olmi si racconta a Marco Manzoni è quello che si sono scambiati i suoi genitori quando si innamorarono l’uno dell’altro: un momento che Olmi non ha vissuto direttamente, ma che continua ad accompagnarlo come un ricordo presente ed eterno. Dalla scoperta di quel primo gesto d’amore, il suo sguardo non ha mai smesso di indagare il mistero dell’uomo, raccontando come un poeta dell’immagine i segreti del tempo e il ritmo della natura, la dignità del lavoro e le profondità dello spirito. Ermanno Olmi ripercorre sessant’anni del suo cinema, dai documentari degli esordi ai film premiati nei festival internazionali, sempre fedele a quel primo sguardo innamorato della vita.
MARCO MANZONI ha fondato nel 1988 Studio Oikos-progetti culturali e scientifici il cui fil rouge è la ricerca di senso. Tra i suoi libri ricordiamo Velocità: tempo sociale e tempo umano, (1989), Creazione e mal-essere (1990), Il futuro della memoria (2007), Il libro dell’aria e del respiro (2008), Il canto della vita con Franco Loi (2010), Tanti amori con Gianni Mura (2013). Ha intervistato diverse personalità laiche e religiose tra cui Rossana Rossanda, Fritjof Capra, Carlo Petrini, Marco Vitale, Carlo Maria Giulini, Franco Battiato, Gabriele Mandel, Moni Ovadia, Vito Mancuso, Raimon Panikkar. Vive e lavora a Milano.
TASCABILI BOMPIANI 529
Marco Manzoni IL PRIMO SGUARDO
I BOMPIANI
GRANDI
TASCABILI
ISBN 978-88-58-77117-4 © 2015 Bompiani/RCS Libri S.p.A. Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano Prima edizione digitale 2015 da edizione Bompiani maggio 2015 Immagine di copertina: © MJ Kim/Getty Images. Progetto grafico: Polystudio. Copertina: Paola Bertozzi.
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
PREFAZIONE
C’è un istante preciso che per Ermanno Olmi segna la sua autentica nascita e per il quale prova gratitudine. È il primo sguardo che si scambiarono sua madre e suo padre, quando si innamorarono l’una dell’altro. Quello sguardo non lo ha potuto vedere, ma lo ha sentito interiormente e lo ha accompagnato per tutta la vita. A quello sguardo se ne sono affiancati molti altri significativi. Certamente quello della nonna materna che Olmi considera la sua prima maestra di vita, “il mio Virgilio”. Poi gli sguardi affettuosi, e anche preoccupati, che lo hanno nutrito nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale quando era sfollato a Treviglio nella casa di campagna della nonna insieme alle zie e ai cuginetti. La sera tutto era sbarrato, porte e finestre, perché non uscisse un filo di luce in modo da evitare i bombardamenti. Dopo cena, le donne cantavano in coro. Il canto – racconta Olmi – era un modo di pregare, di sperare. Quegli sguardi impauriti dalle bombe, e al contempo illuminati dai canti, hanno alimentato la fonte interiore a cui Olmi ha attinto per le sue opere cinematografiche. Se il primo sguardo tra il padre e la madre ha segnato l’inizio della sua vita, mi sono domandato quale sia stato “il primo sguardo” cinematografico di Olmi. Nei documentari industriali della Edisonvolta e nei primi film – che hanno segnato l’inizio della sua vita cinematografica – lo sguardo di Olmi sulla realtà del mondo del lavoro, sui suoi protagonisti e sulla natura è attento, delicato. È uno sguardo che ascolta. Non a caso in queste opere i silenzi sono molto presenti e “parlano”. Olmi non giudica né è sentimentale, anche se un sentimento lo prova per la gente comune, gli umili. Nel suo primo film, Il tempo si è fermato, c’è lo sguardo tra il vecchio guardiano della diga e il giovane che lo affiancherà: uno sguardo diffidente, guardingo e via via più aperto e affettuoso. C’è poi il primo sguardo, tenero e timido, tra i due giovani protagonisti di Il posto, Domenico e Antonietta, che andranno a lavorare negli uffici di Milano della Edison. Qui cinema e vita si intrecciano. La Edison è l’azienda dove lavorava il padre e dove Olmi entrerà giovane e farà le prime esperienze cinematografiche. Loredana Detto, che interpreta Antonietta, diventerà sua moglie. Infine, tra i tanti sguardi significativi di Olmi presenti nei suoi documentari e film, ne scelgo uno relativo a un film non celebre, ma a cui penso sia affezionato perché dedicato a una città che ama.
Si tratta del documentario Milano ’83 girato negli anni della “Milano da bere”, con l’ingresso arrembante di finanza, moda, pubblicità, media che costituiscono i nuovi potere metropolitani. Olmi li ignora, non ne parla, non li fa vedere, sceglie di raccontare la città con le sue strade, i suoi cittadini comuni: i pendolari che arrivano all’alba, gli studenti, gli innamorati, gli anziani. Lo sguardo è rivolto all’anima popolare di Milano, al suo tessuto resistente di onesta e brava gente che fa quotidianamente il proprio mestiere e dovere. Questa narrazione minimale non deve trarre in inganno: nulla a che vedere con il minimalismo del nonsense o del relativismo etico, dove tutto è permesso. No, Olmi con queste piccole storie parla dell’uomo, dei suoi fondamenti etici e spirituali: l’altruismo, la solidarietà, il mondo degli affetti, la convivenza nella casa comune. Il suo è un umanesimo né formale né retorico. Nello sguardo cinematografico di Olmi si leggono stupore e umiltà e questi ultimi sono i segni inconfondibili che collegano le prime esperienze degli anni cinquanta, quando era ventenne, alle produzioni più recenti. Ma non di sguardo ingenuo si tratta. Nei film che hanno contrassegnato la sua arte e la sua carriera Olmi toccherà il cono d’ombra dell’uomo: il potere, l’avidità, la guerra, la distruzione della natura. Lo sguardo si farà anche dolente e indignato per la stupidità umana. Speranza, stupore, umiltà saranno messi a dura prova, ma resisteranno nel tempo. Sono gli stessi sentimenti che prova nella vita di tutti i giorni, per l’inedito che può comparire in qualsiasi momento: come l’incontro con lo scoiattolo dietro casa o una serata passata con i vecchi amici. Durante le conversazioni che abbiamo avuto a casa sua, ad Asiago, per la preparazione di questo libro – quando il suo racconto diveniva più intenso – Olmi “cercava” con gli occhi. Gli occhi, mobilissimi e quasi ridenti, salivano in alto verso un punto indeterminato ed è come se annusassero l’ispirazione, percepissero qualcosa di invisibile a cui dare poi parola. Uno sguardo pieno di meraviglia, sogno, mistero, pietas. Il cinema di Olmi stupisce ancora perché ha l’impronta di quello sguardo. “Il primo sguardo” – lo stesso degli innamorati e del poeta che è in lui – è ancora vivo.
PRIMA PARTE
IL CINEMA DENTRO LA VITA Conversazione con Ermanno Olmi
MARCO MANZONI: Ermanno, tu sei considerato non solo uno dei grandi
maestri del cinema internazionale, ma anche una delle voci più autorevoli dell’epoca contemporanea. Vorrei iniziare questa conversazione partendo da uno dei tuoi documentari, Terra Madre, dedicato all’importante esperienza della rete di contadini di tutto il mondo fondata da Carlo Petrini e Slow Food, nel quale affronti un tema che ti è molto caro: l’emergenza ecologica e i conseguenti sprechi di una società consumistica imperniata sull’idea di uno sviluppo illimitato. Nelle persone più consapevoli c’è oggi la sensazione di una sostanziale immaturità dell’uomo contemporaneo a comprendere l’entità dei problemi e la conseguente necessità di cambiare rotta. In cosa, a tuo parere, l’uomo ha mancato, per essere giunti a una situazione così critica? ERMANNO OLMI: L’elenco, non dico delle colpe, ma degli sbagli – che sono a volte anche incolpevoli perché si può sbagliare per inesperienza – sarebbe lunghissimo. Però alcuni aspetti di questo elenco possono ben indicarci qual è stata complessivamente la nostra colpa. La colpa vera è che siamo stati disattenti e abbiamo lasciato che certi processi, soprattutto di tipo economico, come la ricerca esasperata del profitto, avvenissero senza preoccuparci più di tanto delle conseguenze. Anzi, abbiamo pensato che questo profitto per alcuni avrebbe avuto ricadute positive su tutto l’insieme sociale e sarebbe stato una sorta di conferma del benessere di tutti i consumatori. Avremmo potuto perciò prenderci la soddisfazione di godere di certi beni di consumo, dall’abito all’automobile, al cibo. Questa falsa idea di ricchezza proviene anche dal pensiero che posso sprecare all’infinito: compro in abbondanza e poi butto, tanto non ci sono problemi. Vedi, sono venuto a stare qui ad Asiago cinquant’anni fa e questa casa in cui abito è stata concepita in quel periodo. In quel momento eravamo nel pieno del boom economico che era iniziato nel dopoguerra. Allora non avevo affatto considerato che, per riscaldare questa casa, ci volessero grandi quantità di gasolio o di petrolio, perché qui l’inverno dura nove mesi l’anno, quando va bene. L’estate è sempre più breve. Non mi ponevo la questione. Anch’io non sono stato avveduto. In quegli anni pensavamo che la pace sarebbe durata per sempre, non ci sarebbero più state guerre. Tale era stata la dolorosa esperienza vissuta che avevamo detto: “Basta, saremo sempre in pace.” La stessa cosa è avvenuta con l’idea che saremmo stati sempre ricchi. Ricordo che dicevamo che in America anche lo spazzino (allora si diceva ancora spazzino) ha l’automobile. Questa idea
di ricchezza illimitata ci ha fatto commettere una serie di sbagli di cui oggi possiamo renderci conto, e nel momento in cui siamo consapevoli diventiamo responsabili. Pertanto, da adesso in poi, tutto ciò che faremo – nonostante il fatto di aver capito alcune cose – sarà per noi una colpa grave. Non siamo stati avveduti.
È come se avessimo interpretato il rapporto con la materia – quindi con la natura, con la Terra – in un modo miope e predatorio. Prendo, consumo, spreco, non penso alle conseguenze: i rifiuti, gli sprechi, le diverse forme di inquinamento. Forse la crisi ecologica che stiamo vivendo potrebbe essere invece un’occasione per una crescita di consapevolezza non solo della limitatezza delle risorse del pianeta, ma anche della nostra comune origine. Al di là di considerazioni filosofiche o religiose, noi e la natura, il pianeta Terra, abbiamo un’origine comune. Il problema che ci poniamo oggi con l’allarme ambientale non è solo ecologico: è un problema economico, come giusto equilibrio tra ciò che la Terra può fornirci e il nostro modo di godere di questi frutti. Quindi non è solo una questione ecologica ma di spreco di risorse economiche. La crisi economica, in questo momento, ci fa capire che questo spreco non ce lo potremo più permettere. Ancora una volta impariamo di più dalla realtà che dalla nostra ragione. Questo non mi stupisce più di tanto, ma in fondo mi rammarica constatare che l’uomo non riesca con la ragione a modificare se stesso e debba aspettare che accadano le carestie, le guerre e quant’altre catastrofi per potersi rendere conto degli errori che commette. Nel momento in cui si sono affacciati i primi segnali della crisi ecologica speravo che coloro i quali, in qualche modo, hanno la responsabilità istituzionale di questi problemi fossero più onesti. Perché non sono stati onesti? Perché sono stati comprati. Voglio dire che i grandi potentati economici hanno strumentalizzato l’opinione pubblica e hanno imposto una verità che era una bugia. Quando dico una falsa verità intendo affermare che i grandi poteri si sono serviti di coloro che erano ritenuti attendibili – come certi scienziati, non tutti – per rispondere in modo non veritiero alle domande dell’opinione pubblica sull’emergenza ecologica. Veniva detto: “Questi signori dicono il vero!” Come una volta si diceva: “L’ha detto il giornale” – se lo dice il giornale è perché è vero. Oggi sappiamo che questo non è più scontato. L’ecologia ha poi camminato da sola e ci ha posto di fronte a segnali molto precisi. Ancora una volta non è stata la ragione ma la paura a farci attenti e sensibili a quanto potrebbe accadere. Per l’economia si è verificata la stessa cosa. Pensa a come ci hanno raccontato che eravamo ricchi perché avevamo il nostro gruzzolo messo in banca come risparmio. Poi sono avvenuti gli scandali finanziari (da quello della Parmalat al Monte dei Paschi di Siena, solo per citare i casi italiani) ed è come se ci avessero detto: “No, guarda che i tuoi soldi che hai messo qui, che prima erano veri, adesso non sono più veri perché non valgono più niente.” E tu a chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi! Ecco che ancora una volta l’uomo, ahimè, deve imparare
dalle conseguenze dei propri errori, che molto spesso sono assai gravi.
Il fiume come elemento della natura è stato presente in molti tuoi film. Penso, per esempio a Lungo il fiume o a Centochiodi. Ne hai parlato come di una metafora dell’esistenza. Puoi dire in che senso? Tutto ciò che passa davanti ai nostri occhi può essere ritenuto una metafora della vita, dipende molto dal nostro sguardo. Anche se la nostra vista non arriva oltre quei puntini luminosi che vediamo di notte che stanno nel cosmo, noi sappiamo che oltre il nostro sguardo tutto ciò che esiste è vita. Perciò il fiume come paradigma di un’esistenza, quindi di una vita, è una bella immagine. Il fiume nasce sempre da una sorgente. C’è un momento in cui i rivoli che non vediamo, perché scorrono sotto terra, trovano il punto giusto per trovare uno sbocco alla luce. Ed è una nascita: l’acqua zampilla da una roccia, è come un bambino che viene al mondo. Dopo di che, man mano, aumenta il volume della sua portata d’acqua. Devo dire che è bello pensare a questo gorgogliare in mezzo alle pietre della montagna come a un’infanzia gioiosa. Ecco, il ruscello montano è come un’infanzia gioiosa, finché arriva al piano e acquista il suo passo naturale, e poi riceve altri contributi acquei alla sua possanza, alla sua forza. E cosa fa? Fa questo lungo percorso, e torna al mare. Io mi sento quasi vicino alla foce. Non so quanto grande o piccolo sia, come fiume, ma certamente so che non finirò mai di essere acqua e luce. Perderò certamente la mia individualità, ma ho la speranza che non si disperderanno di me tutte quelle componenti che sono la vita.
Un altro tema che è stato più volte al centro delle tue riflessioni è quello del potere e del sapere intellettuali separati dall’esistenza reale. Nei tuoi film questo potere e sapere sono interpretati spesso da figure ideologiche e asfittiche, senza vita. Vorrei citare, tra gli altri, i commensali presenti in Lunga vita alla Signora!, oppure il prelato e il preside di Centochiodi. A questi sapientoni hai contrapposto la figura dei semplici che sembrano richiamare i poveri di spirito di Gesù. Qual è il tuo pensiero su queste due figure un po’ antitetiche, i sapientoni intellettuali e i semplici? Non vorrei stabilire a priori due categorie, vale a dire i semplici sono i poveracci, quelli che non hanno niente, né titoli né beni, e di conseguenza sono degli sprovveduti mentre chi ha le conoscenze scientifiche e una cultura accademica è considerato appartenente a una categoria superiore. Ecco, non si può dividere in maniera netta e grezza in due categorie. Tra le persone semplici ci possono essere delle persone illuminate. Per conto mio, posso dire che l’illuminazione dei semplici è un’illuminazione che pone queste persone più vicine a un’idea di verità. Il semplice è semplice come un bambino perché è ingenuo. Il bambino, nella sua totale ignoranza delle cose intellettuali, ha una grande ampiezza di visione proprio perché non è limitata da coloro che avendo un’alta cultura creano incasellamenti e verità a priori. La verità non può avere, una volta acquisita, un valore fisso. Il momento in cui
hai raggiunto una verità questa è già superata, perché c’è un’altra verità, immediata, dopo quella che tu hai appena constatato. Il bambino è così: il bambino è aperto al mondo e possiede, nel suo rapporto ingenuo con la vita, la felicità dell’apprendimento. Ogni volta che apprende una cosa in più gode di questa sua conquista, e lo fa senza essere inquadrato in determinati schemi precostituiti. Ecco perché la scuola, molto spesso – e sono cosciente di usare un termine forte – è un crimine. Perché pone alcuni paletti che delimitano dei percorsi all’interno dei quali tu devi stare, e se ne esci sei squalificato. Chi sono coloro che godono del valore della semplicità? I bambini, gli ingenui, i poeti. I poeti sono quelli che magari non possiedono certe cognizioni scientifiche e filosofiche ma hanno interiormente questo orizzonte amplissimo. Nelle notti d’estate questi piccoli, luminosi mondi che intravediamo sono delle verità così lontane da essere per noi soltanto un lumicino in un buio immenso. Ma noi sappiamo che quel lumicino è un pianeta, è un mondo. Ecco, il poeta quando scrive dei versi e l’artista che dipinge una tela di blu creano un puntino di luce e quello è il mondo che hanno scoperto, nonostante quel mondo non si rivelerà mai. Però l’artista e il poeta lo sanno cogliere. Quindi questi sono i semplici: i bambini, gli ingenui – non gli sciocchi – e i poeti. Un poeta è un intellettuale, non è necessariamente un ignorante. Il poeta naïf non ha le cognizioni di un uomo cosiddetto di cultura. Omero, ad esempio, non credo fosse una persona corredata di tutte le nozioni che oggi può avere un poeta contemporaneo, eppure ha dato vita ad altissima poesia. Il poeta di oggi, che invece ha queste conoscenze, come può esserlo realmente se non si libera di questi preconcetti, se non esce da un inquadramento culturale e accademico? Il poeta argentino Jorge Luis Borges giustamente ha detto: “I poeti non sono consapevoli di ciò che scrivono.” Come il bambino che non è consapevole di ciò che fa, e di quello che dice o che canta. Quando gioca non è consapevole: è pura felicità. Gli intellettuali, invece, quelli che non solo non amo ma che addirittura considero quasi affetti da una malattia, sono coloro che sanno molte cose e si servono di queste cose per trarne profitto. Ti dicono: “Tu non sai quello che so io. Allora fai quello che ti dico perché so quello che devi fare.” Vendono qualsiasi tipo di merce. Questi intellettuali sono dei traditori dell’umanità. Mi vengono in mente i miei maestri, coloro che mi hanno dato indicazioni quando da solo non sono stato in grado di vedere o capire alcune cose. Questi maestri lo hanno fatto soprattutto con l’esempio, col loro comportamento, il loro modo di essere. Mia nonna, contadina, è stata la mia prima vera maestra. Il bambino apprende la vita in un determinato luogo con determinate persone e la apprende non come insegnamento imposto ma perché, vedendo il comportamento delle persone che ha intorno, man mano scopre e capisce il significato di gesti, parole, decisioni, atti concreti. Tutto ciò che si apprende da un libro, che pure è importante, non ha lo stesso valore di ciò che si apprende dalla vita. Certo, tu puoi soffrire leggendo una storia esemplare per i valori umani che
vi sono presenti, e il fatto di leggere questa pagina di grande suggestione e verità ti arricchisce e dà una qualità diversa al tuo sguardo sul mondo. Ma se tu soffri direttamente solo allora capisci l’autentico valore del dolore, non solo come un dato letterario o filosofico o anche emotivo: lo capisci attraverso la carne e il sangue. Come è stato l’esempio di Cristo, che si perpetua continuamente perché ogni giorno c’è qualcuno che soffre, che viene colpito, che viene mortificato. Quando mi sono ammalato in maniera grave ho capito cosa significa il dolore. Prima, certo, se vedevo un malato dicevo: “Oh, poverino, è malato!” E lo stesso mi capitava se leggevo la storia di qualcuno malato. Ma prova ad ammalarti tu, allora capisci cos’è il dolore, cos’è la malattia! Con questo non voglio dire che la vita deve essere un orizzonte di sofferenza. Anche la gioia ha la sua parte di sofferenza, l’innamoramento ha la sua sofferenza, i sentimenti umani, l’amicizia hanno la loro sofferenza. Perché è sofferenza la gioia, l’innamoramento, l’amicizia? Perché, nel momento in cui vivi queste esperienze, pensi: “E se tutto questo mi venisse a mancare?” Allora ne capisci il valore, e questo è sofferenza. Quando vedo dei bambini piccoli che soffrono questo per me è autentica sofferenza. Quando i miei figli erano piccoli mi faceva star male solo l’idea che uno di loro potesse soffrire. Però la felicità era più della sofferenza.
Nei tuoi film hai parlato spesso dell’amicizia. A questo proposito vorrei ricordare, tra gli altri, il protagonista di La leggenda del santo bevitore, che spende continuamente i soldi donatigli dall’uomo che ha avuto la grazia da Santa Teresa di Lisieux per offrire da bere agli amici, oppure il protagonista di Centochiodi secondo cui vale più un caffè preso con un amico che tutti i libri del mondo. Qual è stato, nella tua vita, il valore dell’amicizia e dello stare insieme, in comunità con gli amici? Ecco, tutto il discorso che ho fatto si risolve in questa battuta di Centochiodi. Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico. Possiamo dire che non valgono uno scambio di sguardi fra due persone che non sono ancora amici, ma già si rispettano.
In più occasioni hai fatto riferimento a luoghi domestici a te cari e a figure che sono state affettivamente significative come tua nonna, che, tra le altre qualità, aveva anche quella di far quadrare i conti di casa con pochissimo denaro: con poche risorse riusciva ad accontentare tutti. Qual è stato, nella tua formazione interiore, il posto degli affetti famigliari, e in particolare di quelli femminili? Non riesco a fare una selezione e una graduatoria. Quando prima citavo mia nonna non mi riferivo solo a lei in maniera esclusiva, ma a tutte quelle persone che nella vita ti passano accanto e con un niente, un gesto, una parola, compiono una sorta di testimonianza che ti rimarrà addosso per sempre. Quando parlo di mia nonna parlo di figure che mi hanno toccato emotivamente. Mia nonna mi è stata vicina per molto tempo, ma come lei anche altri ti passano accanto e ti lasciano un profumo del loro passaggio che non dimentichi più. A volte ti scordi
della persona ma dentro ti rimane una memoria non catalogata di questa emozione, di questo profumo che hai avvertito. Ecco, credo che quando siamo bambini noi inconsapevolmente siamo molto attenti a quanto accade intorno. Man mano che gli anni passano ci chiudiamo come fossimo dentro a scatole nelle quali facciamo entrare solo quello che riteniamo ci possa servire. Ci manca questa libertà di convivere e dialogare con chi è diverso da noi. Se io faccio del cinema, tu la televisione, un altro scrive o fa il panettiere, va a finire che ci chiudiamo dentro le scatole specialistiche della nostra disciplina e perdiamo la curiosità per tutto il resto. Come certi italiani che vanno in un paese straniero e ordinano gli spaghetti e la bistecca. È così bello, invece, vedere come gli altri ti accolgono alla loro tavola con quello che loro ti possono offrire di meglio. Se non ti apri al diverso, cosa scopri? Non scopri più niente. Il segreto è proprio quello di avere la forza di essere liberi. Credo che l’uomo sia veramente grande quando è piccolo. Ricordo un tuo commento al film Cantando dietro i paraventi nel quale,
ricordando le donne italiane di un tempo che mentre lavoravano spesso cantavano, dicevi che quando il cuore delle donne canta è un bellissimo segno di pace. Perché a tuo parere non si canta più, si è perso quell’entusiasmo che avevano una volta le donne, ma non solo loro? Questa è un po’ come la questione degli intellettuali e dei semplici. Cantano solo quelli patentati. Vale a dire che ormai l’offerta del canto è così traboccante che i poveri tapini, che magari cantavano benissimo, vengono esclusi. Sono convinto che tempo addietro, nell’ambito del canto popolare, si cantasse con una qualità eccelsa. Analogamente avviene oggi per quanto riguarda la politica e la cultura. Di questi temi in televisione parlano solo i patentati, gli altri stanno tutti zitti. La televisione è sovente un comunicatore arrogante e senza contraddittorio che ti impedisce prima di tutto di pensare con la tua testa e di rispondere con le tue parole. Ci hanno tolto la parola. Direi che nell’ambito dell’ecologia morale questo è un brutto avvelenamento. A proposito di canto e anche di ballo basta guardare i popoli dei paesi che noi stupidamente chiamiamo “arretrati”, come se poi noi fossimo la società “avanzata”. Avanzata dove? Bene, questi popoli ancora cantano e ballano e a me pare che sono più poveri ma forse più felici. Ecco, ci hanno tolto anche la felicità di cantare e di ballare. A proposito del canto voglio raccontare un’esperienza che ho vissuto. Per fortuna voi non avete visto l’ultima guerra mondiale che fu davvero una tragedia. Durante l’ultimo anno di guerra ero a casa di mia nonna che stava a Treviglio, lontano da Milano dove bombardavano praticamente una notte sì e l’altra ancora. Eravamo tutti sfollati a casa sua. Dalla nonna c’erano le figlie, i cui mariti erano al fronte, e i bambini. Perciò era una comunità di donne e di bambini. La nonna era la vecchia chioccia che teneva sotto le ali protettive le figlie che ogni giorno si ponevano l’interrogativo: “Mio marito sarà ancora vivo?” La guerra non risparmiava più
neanche i civili. Una situazione davvero tragica. Ricordo che la sera si chiudeva tutto, porte e finestre, perché doveva esserci l’oscuramento, non doveva uscire un filo di luce per il rischio che cadesse una bomba. Finita la cena, c’era una zia che sparecchiava e lavava i piatti, un’altra che cuciva e rammendava gli abitini dei bambini, senza che nessuno desse un ordine. Eravamo tutti in una stanza e la zia quando cominciava a lavare i piatti si metteva a cantare, dopodiché anche le voci delle altre zie si aggiungevano e formavano un coro, con tanto di armonizzazione: una faceva la voce principale, l’altra il controcanto, e cantavano alcune canzoni. Quando noi bambini cominciavamo a tentennare per il sonno facevamo il segno della croce, si diceva il rosario e si andava a dormire. Non era certo una situazione da canto gioioso: il canto era un modo di pregare. Era proclamare la preghiera come affermazione di speranza, di voglia di vivere e di attendere i segnali di una ritrovata armonia. Oggi che stiamo tutti meglio economicamente, non canta più nessuno.
Che ruolo ha avuto nel tuo lavoro la coincidenza? Ricordo che sia nel caso del ritrovamento, in mezzo alla nebbia, della cascina per L’albero degli zoccoli e sia in quello del bar Paradox di La leggenda del santo bevitore sono successe delle cose quasi inspiegabili. Sì, tu cerchi delle cose che sembrano introvabili e sai che non puoi proseguire in quel progetto senza quello che stai cercando. Certe volte è come se avessimo un radar che si sintonizza su quello che vogliamo trovare. Allora se ci credi, se pensi che quello che vuoi trovare c’è, alla fine lo trovi davvero. Questo mi è capitato con L’albero degli zoccoli. Non riuscivo a trovare la cascina che volevo. Io e lo scenografo ci eravamo rassegnati. Avevamo già avviato gli accordi con i proprietari di una cascina e mentre l’organizzatore era lì che trattava su questo nostro momentaneo possesso dell’ambiente della cascina sono andato via per tornare nel nostro piccolo albergo, vicino a Palosco, nella Bergamasca. C’era una gran nebbia. Avevo fatto quella strada di campagna più volte, perciò la conoscevo bene. Però con la nebbia non avevo più riferimenti e quindi mi sono ritrovato allo sbando. Procedevo guardando il bordo della strada, cercando quantomeno di non finire in un fosso, quando improvvisamente mi sono trovato davanti a un cancello. Sono sceso e ho visto la cascina che volevo trovare, una cascina che era lì nei dintorni ma che durante i nostri sopralluoghi non avevamo mai visto. C’è voluta la nebbia. Ti domandi: “Ma perché? Perché è avvenuto così?” È meglio non cercare risposte: è avvenuto perché doveva avvenire, perché io volevo trovare questa cosa e l’ho trovata. È accaduto lo stesso con il bar Paradox a Parigi mentre facevamo i sopralluoghi per La leggenda del santo bevitore. Siamo arrivati di fronte alla chiesa di Sainte Marie des Batignolles e ci chiedevamo cosa fare, perché dal bar dovevi per forza vedere la chiesa. Be’, la chiesa e il bar erano lì che ci aspettavano. Perché in quel bar dove Roth andava a bere i suoi Pernod, l’assenzio, era in atto un trasferimento di proprietà. Il bar era chiuso! Ci siamo informati, abbiamo trattato con la persona che avrebbe
acquistato il locale e ci siamo trovati padroni di quello spazio per il tempo necessario alla lavorazione. Che sia stato Roth? Probabilmente. Nel finale di Il segreto del bosco vecchio la gazza chiede al vecchio colonnello
Procolo, avido e anaffettivo: “Ma perché vuoi nascondere che vuoi bene a quel bambino?” Prendo spunto da questa frase per chiederti: qual è il tuo pensiero sull’amore, sul senso dell’amore? Che segnale è l’appetito? È il segnale che desideri alimentarti e il desiderio è tale perché non puoi fare a meno di mangiare. Non puoi rinunciare. Puoi rinviare di qualche ora, ma l’appetito aumenta sempre di più, finché devi mangiare. Perché? Perché vuoi vivere. Vale a dire che i meccanismi della vita, della natura, mettono in moto degli stimoli per cui tu sei obbligato a fare quella cosa lì: devi mangiare. Se ti tolgono l’aria e non puoi più respirare ti rendi conto che respiravi inconsapevolmente, ma respiravi, e questo respirare era un atto che ti garantiva la vita: quindi se ti viene sottratta l’aria senti che ti manca una ragione vitale. Se ti sottraggono l’amore è la stessa cosa. L’appetito dell’amore che cos’è? Io credo sia proprio l’idea che l’esistenza solitaria è solo la morte, è nella morte. Nel momento in cui esisti hai bisogno di specchiarti nell’altro per sentire che esisti. Allora qui può nascere l’amore come può nascere l’odio. Ma l’amore è proprio il bisogno dell’altro per riconoscergli il valore che ha attraverso il tuo sentimento d’amore. Quando tu non hai figli, pensi che l’amore per un figlio possa essere una cosa molto bella e molto intensa, e questa necessità naturale vive con la complicità del desiderio sessuale. C’è qualcosa, nella vita, che ti costringe a compiere degli atti. Posso perfino immaginare che una persona che non si riconosce in particolari valori esistenziali, nel momento in cui prova attrazione sessuale per una donna e da questo incontro ne consegua la nascita di un bambino, possa poi scoprire l’amore per un figlio. E che questo evento le cambi la vita. Quindi l’amore è un grande appetito spirituale. Nella mia adolescenza mi sono innamorato molte volte, e tra un amore e l’altro non passava molto tempo perché quando ne ero senza mi sentivo a disagio, ero proprio solo. Anche gli amici sono una forma di innamoramento. Quando sei molto piccolo ti innamori addirittura di chi non c’è. Mi ricordo che mi innamoravo di una bambina che non esisteva. Poi questa bambina cominciava a rivelarsi in qualche compagna di giochi. Ma come mai mi innamoravo, così piccolo? Si è piccoli, eppure ci si innamora. I bambini piccoli, nella loro ingenuità, ti dicono: “Quella è la mia fidanzata.” Tu dici: “Ma lei lo sa?” “Non importa che lo sappia, ma è la mia fidanzata, io sono innamorato.” L’amore è un appetito.
Vorrei parlare della presenza femminile nei tuoi film. Come donna protagonista c’è stata la famosa piratessa in Cantando dietro i paraventi, ma in molti altri film anche se non c’è una vera protagonista donna mi sembra che l’elemento femminile, simbolicamente, emerga dalla disposizione d’animo dei protagonisti maschili.
Ad esempio, il protagonista di Centochiodi o di La leggenda del santo bevitore, o anche quello di Il mestiere delle armi sono uomini che non sono mai aggressivi e violenti, ma sempre piuttosto dolci anche se combattuti interiormente. È così? È vero, perché io sono un maschio, e quindi racconto da un punto di vista maschile. Per me la donna è l’interlocutrice ideale. E anche la donna di Cantando dietro i paraventi, la piratessa che rimane vedova – il marito è stato eliminato da trame di potere – in questa sua condizione agisce nel nome del marito. Quindi per me c’è una chiara collocazione, che è il punto di vista maschile che guarda il femminile. Non sarei capace di fare un film dal punto di vista femminile. Nel finale di Cantando dietro i paraventi la piratessa rinuncia all’ultimo
combattimento e si dispone all’accordo con il principe, che è una figura maschile saggia e le propone il perdono come risoluzione del conflitto. Hai descritto il perdono come un atto di umiltà. Anzi hai detto di più, una frase che mi ha molto colpito: “Il perdono è un atto di umiltà e di grandezza, perché un uomo in ginocchio è più grande di un uomo in piedi.” Perché a tuo parere l’uomo fatica così tanto a inginocchiarsi? Perché non ha sempre delle buone ragioni per farlo. Soltanto quando la ragione per farlo è più forte del proprio orgoglio, allora lo fa. Ad esempio penso che, in riferimento all’innamoramento, se sono davvero innamorato mi inginocchio volentieri davanti alla mia amata. Non voglio pormi nelle condizioni di una stupida superiorità, per cui sono io che debbo essere in qualche modo gratificato dall’inginocchiamento della fanciulla che mi si pone davanti. Sarebbe umiliante. Se sono innamorato mi inginocchio volentieri, se questo è l’atto che più di tutti può esprimere l’intensità del mio sentimento. Credo che potrei inginocchiarmi anche di fronte a un potente prepotente, se questo atto fosse in grado di cambiare la sua opinione. Forse è l’arma più forte, in certe circostanze. Mi torna alla mente il ragazzo di piazza Tienanmen in Cina. Qualcuno pensa che abbia compiuto un atto eroico un po’ spavaldo. No, la spavalderia non arriva a quel punto. Secondo me quel ragazzo avrebbe anche potuto inginocchiarsi. Anzi, era in ginocchio, con la sua borsetta di plastica, solo di fronte alla strapotenza di quei carri armati. Era un uomo in ginocchio, disarmato. Sono convinto che non sia stato un gesto di esaltazione spavalda ma che egli avesse la consapevolezza di questa soglia estrema, dove se t’inginocchi sei più forte del tuo avversario, di quello che sta in piedi.
Ogni uomo nella sua vita attraversa momenti di difficoltà, di sofferenza. Prima hai accennato a una seria malattia che hai poi superato. Qual è stata la tua esperienza di quel momento di crisi e quale insegnamento ti ha lasciato? Quando le sofferenze sono vicine alle soglie estreme non puoi più dartela a intendere. Perché quando viviamo nella normale quotidianità, anche se prima di addormentarci facciamo il bilancio della nostra giornata, tendiamo sempre un po’ a barare, nel senso che diamo valore a quello che ci fa comodo e lo togliamo a quello che è più scomodo, e ci giustifichiamo continuamente. È una forma di
ipocrisia finalizzata alla sopravvivenza. Quando ti trovi invece in condizioni estreme, dove la tua vita può dipendere solo da uno o due fili ancora collegati, allora non puoi più barare. Quella sofferenza ti fa capire la differenza tra questi due modi diversi di dare un giudizio su te stesso. Rivedi radicalmente l’intero tuo rapporto col mondo, come hai speso il tuo tempo, le tue giornate, e tutto cambia completamente. Ad esempio, quelli che vengono sequestrati e tenuti nascosti dentro un buco per mesi quando tornano dicono che hanno compreso cose di cui prima non avevano consapevolezza. In ciò che accade c’è sempre da fare un bilancio tra quello che consideriamo “bene” o “male”. A volte il male, il dolore fisico, può essere un bene. E quindi dipende tutto dalla capacità che l’uomo ha di accettare ciò che la vita gli propone come sorpresa, come spiazzamento. Quante volte, ad esempio, devi avere un incontro importante e pensi: “Adesso devo incontrare questa persona, gli dirò questo e quest’altro.” Poi arrivi lì e ti accorgi che se dici quello che hai pensato è una recita, e quindi sei fasullo. Invece se lasci che tutto avvenga spontaneamente, cioè ricevi delle sollecitazioni alle quali reagisci, tutto assume un altro colore, sapore, verità. Mi viene da pensare a un suggerimento che viene dal Vangelo, Cristo dice ai suoi Apostoli: “Andate a predicare e non portate niente con voi, non mettetevi il denaro nella fascia che portate in vita e soprattutto non preparatevi a dire le cose che dovrete dire: dite quello che in quell’istante vi viene da dire.” Pensa quale scadimento di stile sarebbe andare a un incontro d’amore dicendosi: “Adesso vado, mi presento così, metto questo abito, e quando lei arriva le dico…” Insomma, fai tutta una sceneggiata pensando a come ti dovrai comportare. Però quando arrivi, se davvero il tuo sentimento è robusto, appena lei ti guarda cancella tutti i tuoi propositi e ti trovi in ginocchio davanti a lei.
In un’occasione hai parlato della vecchiaia non tanto come perdita di vitalità ma come l’età più bella nella quale, proprio per il fatto che non devi più correre e competere, ti puoi un po’ rilassare e, finalmente, guardi e ricordi. Ti chiedo: oggi Ermanno Olmi cosa guarda e cosa ricorda? Ci hai pensato un po’, per fare queste domandine insidiose, eh! Vedi, quando si dice che i vecchi e i bambini sono abbastanza simili è perché il bambino fa tutto inconsapevolmente. L’anziano lo fa come un bambino, ma consapevolmente, sennò sarebbe rimbambito, il che è un’altra cosa. Penso che la vecchiaia sia un’età molto bella perché puoi rivivere nel pensiero, modificandola, la vita che hai fatto. Ci sono momenti che sono rimasti impressi nella tua mente perché ti hanno dato forti suggestioni, come una pellicola esposta con grande luminosità, e quindi la materia che vi rimane impressa è palpabile. Allora rivedi situazioni della tua vita che hai vissuto spontaneamente, senza ragionarci su troppo, altrimenti avresti rovinato quel momento. Prova a ricordarlo e a riviverlo cogliendo tutti quegli aspetti che allora non potevi cogliere con consapevolezza, soprattutto quelle situazioni in cui il tuo comportamento magari non è stato dei più nobili. Ecco che, rivedendo la situazione in cui ti sei
comportato poco bene, lo puoi correggere col ricordo. Magari in un’occasione hai trascurato un amico o hai tradito la fiducia di qualcuno. Il fatto stesso di correggere il tuo comportamento nel ricordo è un modo per chiedere perdono a coloro che hai in qualche modo offeso. È così anche per la gioia. Mi vengono in mente tante belle situazioni di esaltazione amorosa di cui – mentre le vivevo – coglievo soltanto la parte immediata: le risonanze di questi sentimenti arrivano dopo, come degli echi che giungono da lontano. Allora rivedo fanciulle o amici a cui devo una gratitudine che a quel tempo non sono stato capace di esprimere, perché non pensavo nemmeno di doverlo fare. Oggi quante volte – lo dico anche a mia moglie Loredana – penso a questi miei amori giovanili! Perché gli amori sono il patrimonio che più suscita dentro di te il piacere di ricordare. Quante volte le dico: “Ti ho voluto bene, ti voglio bene, non ti ho mai tradita. Però ho voluto bene anche ad altre ragazze, e anche tu avrai voluto bene ai tuoi morosini.” Quell’amore lì non lo cancello e anzi ogni tanto un suo dettaglio, una nota, mi fa tornare alla mente, anche casualmente, quelle esperienze lontane. Senti di dovere della gratitudine a quelle persone, anche se non le incontrerai più, perché hanno suscitato in te sentimenti d’amore belli.
In relazione alla religione non ti sei mai definito come un uomo di fede vera e propria, ma costantemente in cerca di fede, e hai definito Cristo e Tolstoj come amici, come compagni. Hai anche aggiunto di sentire frequentemente sul collo il fiato di Gesù. Cosa intendevi dire con questa espressione così particolare: “Sentire sul collo il fiato di Gesù”? Qual è il tuo pensiero, oggi, sulla spiritualità? Non mi sono mai posto la questione della fede come un problema. Che sia Dio ad avermi procurato la vita può essere importante, ma anche no. Il fatto stesso che ho potuto vivere un’esistenza che in qualche modo mi ha posto nella consapevolezza di esistere, questo non ha bisogno di un atto di fede perché è una realtà constatabile. Devo essere grato a Dio, del fatto che esisto e vivo questa vita che mi sorprende e stupisce continuamente? A chi posso dire un grazie? Se lo dico a Dio, confesso che la cosa non mi dà grande soddisfazione. Se ha creato la vita è perché aveva le sue ragioni. Lo verrò a sapere quando tornerò a essere una nuvola che è evaporata dal mare. A chi debbo essere grato, allora? Io sono grato a quel primo sguardo che mio padre e mia madre si sono scambiati capendo, in quell’istante, che si stavano innamorando l’uno dell’altra. Questa è la mia data di nascita: quel primo sguardo ha dato origine a tutto il resto come un accadimento inevitabile.
È questo il sacro, per te? Sono questi momenti che rappresentano il sacro, la sacralità della vita? Be’, se non è sacro questo, cos’è sacro? Voglio dire, è come un big bang che dà origine a un’intera galassia. Nell’istante in cui avviene questo scambio di sguardi che si fermano l’uno sull’altro parte il big bang, parte qualche cosa che sta in uno spazio infinito ed è in continua espansione. Allora, se mai c’è un Dio è proprio questo big bang nel quale l’esplosione è l’atto d’amore da cui nasce tutto.
Invece per quanto riguarda Cristo, cui si attribuisce la diretta discendenza dal Padre Eterno, mi pare che questa sia una questione che col tempo non ci porremo più. Ogni volta che fai qualcosa nella tua vita, e vuoi avere un’idea del valore o del disvalore di ciò che compi, hai bisogno di un parametro. Cristo è stato un tale testimone di eroicità umana che, per me, è il giusto parametro. Allora, quando mi chiedono: “Sei cristiano?” rispondo che io sono un aspirante cristiano, nel senso che vorrei essere di quel livello esistenziale, per me irraggiungibile. Non so se avrei il coraggio di farmi mettere in croce. Gesù, per quello che ha fatto e come l’ha fatto, per le idee che ha suscitato nel mondo, ce l’hai sempre lì davanti. È come se ti dicesse: “E tu cosa fai? Dopo che io ho fatto questo, tu cosa fai?” E tu dici: “Eh, sai, si fa fatica, è dura.” “Certo, lo so,” ti dice lui, “io ho fatto il Calvario. Vuoi che non lo sappia?” “Però tu sei il figlio di Dio.” “No! Io sono figlio di una donna, come te.” Fosse il figlio di Dio, avrei un sollievo. Gli direi: “Eh, per forza, sei il figlio di Dio, caro mio! Prova a fare quello che fanno tutti gli uomini.” Cristo ti dice: “Io sono come te. Quindi è dura.” Tolstoj lo sento come amico perché è stato, lungo tutta la sua vita, uno che senza volerlo ha camminato verso Cristo finché l’ha trovato, negli ultimi momenti, quando muore in quella stazioncina nella steppa russa. Ritrovo altri piccoli frammenti di Cristo in tante persone che oggi sono ancora disposte a un atto di sacrificio. Parlavi prima dei partigiani. Alcuni hanno accettato di morire per la propria idea di libertà, per testimoniare un ideale che valeva il baratto addirittura con la vita. Quella è la misura della loro convinzione: erano così convinti del valore della libertà che accettarono di morire. Questo lo vediamo testimoniato anche oggi in molte persone e situazioni cui non diamo forse sufficiente importanza perché poi incalzano altre notizie e il varietà della sera, così ricco di veline da velarci completamente la vista.
Il teologo ed esponente del dialogo interreligioso Raimon Panikkar, che hai conosciuto bene, ha detto due frasi che volevo riportarti per chiederti un commento. La prima frase è: “Lo spirito della religione è lo spirito della libertà. La parola religione deriva dal latino religare; lega, ma anche slega, libera.” E la seconda: “Chi non sa piangere non sa pregare.” Cosa ti evocano queste due immagini di Raimon Panikkar? Molto spesso la religione è vissuta come una sorta di inquadramento dentro una convenzione di comportamenti e di modalità. La religione è configurata in una serie di princìpi, ma se a questi princìpi tu ottemperi solo per spirito di disciplina non è vera religione. Un conto è praticare la convivenza civile per disciplina perché sei obbligato a fare così, un conto è praticarla perché hai educato te stesso al piacere di essere rispettoso delle regole. Se ogni volta che sei rispettoso lo fai perché lo decidi tu, e non per disciplina, ecco, questo ti slega. Perché la religione sleghi occorre che chi vive una religiosità la viva dentro di sé, nella propria interiorità. Riguardo all’altra frase di Panikkar a proposito del pianto credo che la gioia, come dicevo all’inizio, ti procura sofferenza nel momento in
cui pensi che ti possa essere tolta. Mentre la sperimenti, ogni tanto hai degli istanti in cui dici: “Oddio, speriamo che non mi capiti nulla, che tutto questo continui.” Il pianto interviene dopo che la gioia ti è stata sottratta e rappresenta il sentimento che ha capito il suo valore ancora più in profondità. Questo non vuol dire che per dare valore alla gioia dobbiamo piangere. No. Però, poiché sappiamo che la gioia ci viene data e ci viene tolta, ne comprendiamo di più il significato nel momento in cui ci viene tolta, quindi nel momento in cui si piange. Panikkar, un amico pieno di gioia. Lo ricordo così: gioioso, festoso. La sua era la gioia dell’innamorato sorpreso dal fatto che l’istante dopo in cui sa di essersi innamorato si accorge di esserlo ancora più di prima. La gioia è proprio questo meccanismo di continua e sorprendente crescita del sentimento d’amore. Qualche volta l’amore – se è vissuto con ambiguità meschina – viene relegato, come la religione, in una serie di comportamenti e gestualità stereotipati: “Oh, ciao, cara, come va, hai passato bene la giornata?” “Sì, bene.” Sono regole dettate da un comportamento esteriore che dovrebbe manifestare il sentimento. In realtà, il comportamento continua anche quando il sentimento non c’è più, ed è un’ipocrisia imperdonabile. Ho avuto la fortuna di bisticciare almeno due o tre volte al giorno con mia moglie, ed è il modo per mettere alla prova il nostro sentimento d’amore, che in quarantacinque anni si è via via trasformato, come il fiume. Anche l’amore nasce come un bambino gioioso, poi man mano trova il suo percorso, procede e alla fine anche il fiume più piccolo diventa il mare. Quindi, pensa che soddisfazione poter arrivare al mare.
Qual è stato, nella tua vita e nel tuo lavoro, il posto del sogno? Il significato, il valore del sogno? Io sogno moltissimo, di notte e di giorno. Vedo delle cose bellissime. Ad esempio, vedo spesso dei paesaggi straordinari. Probabilmente sarà una delle conseguenza del mio lavoro non ripetitivo, che mi fa fare i sopralluoghi anche di notte. Il sogno può riguardare l’idea di un soggetto, di una storia o come potrò montare una sequenza. Il cinema occupa un certo spazio della mia vita, ma non è tutta la mia vita: è una delle opportunità che la vita mi ha dato per fare delle cose. Ad esempio, qui ad Asiago, da trentacinque anni, la domenica sera con Loredana andiamo a mangiare la pizza con un gruppo di amici: tre, quattro coppie. Qualche volta, quando mi accorgo che è domenica, dico: “Ah, bene, stasera andiamo a mangiare la pizza con gli amici.” E faccio un piccolo sogno, perché so che incontrerò Maurizio, Valentino, Flavio. Certo, sono sogni della quotidianità, ma anche quelli sono sogni. Poi magari fai il sogno che i tuoi figli abbiano una vita felice, quantomeno sopportabile, perché ci sono anche esistenze insopportabili. Avevo sognato un nipotino, ma ancora non è arrivato. Ogni tanto dico agli amici: “Se sapete che c’è qualcuno che ne ha uno e non lo può tenere, invece di buttarlo nel cassonetto portatemelo qui che lo tengo io.” Mi piacerebbe trovare un bimbo sullo zerbino. Anche questo è un sogno, utopico,
ma è un sogno. Penso che una delle fortune dell’età avanzata sia quella che guardi i bambini con un occhio il cui stupore non ha paragone con nient’altro. Direi addirittura che se c’è un’idea che, in qualche modo, può raffigurare la meraviglia dell’esistenza è proprio il volto di un bambino piccolo. Quando poi comincia a farti capire che ha la possibilità di intrattenere un dialogo con te è una meraviglia continua. Ti avvicini a un nuovo essere che ha come prima manifestazione il pianto e il canto. Sì, i bambini cantano, fanno i versetti, si ascoltano. E se tu vai vicino a un bambino che è alla sua prima apparizione sulla scena del mondo e canti, lui ti risponde. È il dialogo alle sue origini. Gli animali si intendono così. Credo che anche l’uomo abbia cominciato, prima di articolare dei suoni che sono diventati parole, proprio a fare dei versi, dei gesti. E pensa che oggi verrebbe considerata una comunicazione primordiale e limitata. Eppure anche questo modo di comunicare, anzi forse questo modo particolare di comunicare è una comunicazione universale. Mi ricordo che una volta stavo andando in aereo negli Stati Uniti insieme a un produttore e lui aveva con sé il figlio – era piccolino, avrà avuto tre, quattro anni – che continuava a venire da me e mi mostrava ogni volta un suo gioco. Lui parlava in inglese, che non conosco, e io in italiano. Abbiamo parlato tutto il tempo. In quel momento noi, che non parlavamo la stessa lingua, comunicavamo con dei versi. Perché quel bambino mi rispondeva? Perché capiva, non dalle parole, ma dalla sonorità della parola, che io ero in relazione con lui. Quando Federico Fellini vide molti anni fa a Milano il tuo primo film, Il tempo si è fermato, si fece vivo e ti disse: “Da questo momento noi due siamo fratelli.” A
proposito di fratelli e fratellanza, qualche anno fa è venuto alla luce un disegno di Fellini del 1961, Il sogno del quarto fratellino coraggioso, che nasce da un suo sogno nel quale immagina che ci siano quattro fratellini che salveranno il mondo e che tu faccia un film su di loro. Tutti gli spettatori si commuoveranno e tu avrai un grande successo. Sono stato molto colpito da queste due coincidenze: il tuo primo contatto con Fellini, che subito, spontaneamente, ti ha definito suo fratello, e un sogno di Fellini che emerge dopo che lui è morto, in cui si parla di un film che tu farai sulla fratellanza. Qual è il tuo pensiero? È un’altra di quelle circostanze inspiegabili di cui parlavamo prima. Ti chiedi: “Perché è avvenuto questo? Perché è avvenuto così?” Non puoi rispondere. Tutto questo avviene nel momento in cui decido di non fare più film. Un mese prima che io vada a Rimini a ritirare il premio della Fondazione Fellini nell’autunno del 2007, la nipote (la sorella di Federico era morta) autorizza a prelevare dalla cassetta in banca tutti i disegni di Federico e a pubblicarli. Mi chiama Tullio Kezich e mi dice: “Guarda che c’è questo disegno di Federico che parla di un suo sogno che ti riguarda.” Io dovevo ritirare il premio Fellini l’anno prima, però stavo girando Centochiodi e avevo detto che sarei andato l’anno venturo. Non vado volentieri a ritirare i premi, però Federico era un amico. Fossi andato l’anno prima questa coincidenza non sarebbe avvenuta. E invece
quell’anno, in quel preciso momento decido di non fare più film e Federico mi dice di fare questo film. Quando Fellini presentò La dolce vita e venne a Milano, vide Il tempo si è fermato. E mi disse: “D’ora in poi siamo come fratelli.” Come finisce La dolce vita? L’ultima scena è quella di Marcello (Mastroianni) sulla spiaggia, con questi pescatori che hanno trovato nella rete un mostro marino, una sorta di bestia orrenda, quasi fosse un segnale di ammonimento. Cos’è quel pesce mostruoso, quella cosa che turba Marcello? E ora viene fuori il suo disegno-sogno con la storia dei quattro fratellini che salvano l’umanità da un pesce-bomba, un pesce che è stato caricato con un potenziale distruttivo enorme. Come va letto, questo? Chi salverà il mondo? Quattro fratellini. Quattro bambini. Qui c’è un’immagine bellissima e salvifica dei bambini. E Federico conclude: “E tutti faranno una grande festa.” Quindi non è una storia che finisce con la lacrima. No, è una storia che finisce con una grande festa, con quella gioia che è la ragione prima di tutta l’esistenza. Be’, Federico mi ha combinato uno straordinario scherzone! Gli piaceva fare queste marachelle. Ancora non lo so, cosa farò; non lo so perché in questo momento non mi è chiaro quello che potrò fare. Devo anche misurarmi con l’età: una volta lavoravo venti ore al giorno ed ero felice; oggi, dopo due ore davanti al montaggio o a una pagina da scrivere mi devo fermare. Mi capita tra capo e collo questa cosa in un momento in cui le mie forze sono quelle di un nonno. Vedrò. Anche qui lascio che sia il mistero a guidarmi. Sentirò “il suo fiato sul collo”. “Ermannino, che fai!” mi dirà. Lui usava sempre i diminutivi. Infatti io lo chiamavo Federicone. Che uomo straordinario!
L’hai sentito anche tu come un fratello? Veramente mi sentivo, dal punto di vista razionale, in grande sintonia con Rossellini. Però era un fatto appunto razionale perché capivo il valore del suo cinema: il neorealismo. Federico invece era un mistero anche per se stesso. Del resto, i grandi non sanno quello che sono. L’ultimo tuo film, Torneranno i prati, è sulla Prima guerra mondiale. Qual è
stato il senso per te di girare oggi un film su quella guerra? Credo che le guerre, non dico dalle origini dell’umanità, ma certamente quelle degli ultimi secoli hanno corrisposto sempre alla volontà di chi stava ai piani alti del potere. La classe dirigente allora era composta dal re, l’aristocrazia, l’alta borghesia e poi c’era il popolo bue sottomesso che era plagiato dal potere e a volte ne condivideva le guerre. In questo contesto c’era però anche il senso della patria, vale a dire la terra dei tuoi padri dove ti eri formato venendo al mondo. Il popolo sentiva un’appartenenza al proprio territorio e questo generava un rispetto per la propria casa comune. Bene, credo che la guerra – che per noi italiani è del 1915-18 – è stata l’ultima guerra che ancora poteva essere definita una guerra di popoli che si riconoscevano in una patria comune.
Nella Seconda guerra mondiale non c’era più il sentimento patrio: era una guerra tra ideologie e, come sempre, l’ideologia prevarica su tutto il resto e genera una dittatura, come sono state quella tedesca e italiana. Paradossalmente potremmo dire che perfino le religioni sono “dittature” basate su ideologie, com’è avvenuto per la religione cattolica con i papi. Oggi in Italia c’è molta attrazione verso un papa che finalmente si fa reale interprete del primo comandamento dell’ideologia cristiana: l’amore per il prossimo. Guarda come – mancando il sentimento per la patria – milioni di persone affollano San Pietro: cercano una patria spirituale. Penso che oggi, perché non avvenga la terza guerra mondiale, noi dovremmo trovare un senso comune europeo. Quindi non più una patria terra dei padri, ma una patria nella quale ci riconosciamo per un ideale, un obiettivo comune. In questi giorni c’è una grande discussione: euro sì, euro no. Ma il tema dell’Europa unita non è una questione di moneta; il denaro non sarà mai una patria e, se per caso lo diventasse, sarebbe una patria infernale, criminale. Noi dobbiamo riconoscerci nell’Europa come tanti popoli che diventano da oggi un popolo unito: è la globalizzazione che lo impone. Nel fare il film sulla guerra 1915-18 ho voluto proprio mettere in evidenza quest’ultimo momento di amor patrio non retorico, pur essendo ben consapevole che attorno a quella guerra c’è stato molto ciarpame nazionalista. Ma quanti giovani hanno creduto con un autentico sentimento patrio! Nel film questo sentimento è presente perché quando si è tutti vicini alla morte che può arrivare all’improvviso, da un istante all’altro, non è più una questione di ideologie contrapposte. No, si condivide l’ultimo istante di vita e la parola vita assume proprio il significato di patria. Il film si svolge in un piccolo caposaldo in alta montagna, un avamposto che è come il borgo di una volta dove tutti si conoscevano e c’erano a volte degli screzi, ma mai con cattiveria. Soprattutto c’era la solidarietà, perfino con il nemico, perché i soldati italiani e austriaci avevano la stessa idea di patria tanto è vero che nelle pause dei combattimenti si parlavano, si aiutavano, annullavano l’ufficialità delle dichiarazioni di guerra di cui non conoscevano il significato, subendone solo le conseguenze. “Tu soldatino, sei lì in questa trincea e quando tardivamente riesci a comprendere che la guerra è un grande disastro intellettuale, morale, civile allora non ci credi più.” Lo stesso è avvenuto per tanti ufficiali che stavano al fronte coi soldatini. La cosa straordinaria è che alla fine di questa esperienza, che è stata dirompente in tutto il mondo ma che si rifletteva in ogni piccola realtà come il caposaldo nel film, non sono stati tanto i soldatini a capire il concetto di borghesia ma piuttosto i borghesi che stavano al fronte a comprendere il concetto di popolo attraverso il contatto con quei soldati.
Alla fine sono stati gli ufficiali a imparare una lezione, una lezione di vita.
A questo proposito, nel film c’è un atto di disobbedienza che unisce un soldato a un ufficiale, anche a costo della vita. Sì, e avviene perché si trovavano accomunati in tutto: dividevano il rancio che spesso non arrivava, pativano il freddo, che era un atto di giustizia perché tutti lo sentivano indistintamente.
In quella guerra la realtà umana prende il sopravvento sulle ideologie, sul potere che mette gli uni contro gli altri: con la vicinanza fisica delle trincee c’è il gesto di solidarietà del passaggio delle borracce di acqua. Sì, mentre quelli che comandano dall’alto fanno parte di un’umanità di cui non arriva nemmeno l’odore. Anche oggi i potenti stanno così in alto che non li riconosciamo e quelle poche volte che attraversano le strade del popolo sono come dei fantocci, oppure hanno i vetri oscurati delle macchine blindate e non li vedi nemmeno. Durante le riprese del film la natura ci ha riservato una sorpresa che non ci aspettavamo. Avevo fatto allestire per il caposaldo due ben distinte postazioni: una per l’interno del camminamento delle trincee e l’altra per le riprese in esterno. Quest’ultima è stata costruita a 1.900 metri per avere la garanzia della neve; il film infatti si svolge in inverno perché in quei mesi era difficile per tutti muoversi nella neve e la guerra ristagnava. Quando abbiamo finito di girare le riprese degli interni e siamo saliti al caposaldo esterno non c’era più una traccia della trincea: erano caduti 4,9 metri di neve e allora noi con delle lunghe stecche cercavamo di capire dov’era la trincea, dove avevamo piazzati tutti i cavi e le cassette di derivazione. Finalmente si trova una traccia, ma abbiamo dovuto spalare a mano e con le turbine duecento camion di neve solo per far riapparire la trincea che sporgeva dal terreno. Puoi capire il mio sgomento per la lavorazione del film. A un certo punto però ho capito che non dovevo oppormi alla natura ma dovevo assecondarla: chi lo sa per quali misteriose e ineffabili ragioni proprio quest’anno è venuta così tanta neve e noi abbiamo dovuto girare in queste condizioni… Sembrava proprio un ammonimento della natura, come se dicesse: “Basta guerre!” Abbiamo accettato questo essere sepolti sotto la neve e alla fine siamo riusciti a girare le scene. C’è stata poi un’altra difficoltà che, pur vivendo in montagna, non avevo previsto ed è che lassù ogni minuto cambiava la situazione meteorologica: c’era il sereno, poi improvvisamente arrivava la nebbia, poi nevicava, poi smetteva, e tutto nel giro di pochi minuti. E allora come fai a combinare i campi e i controcampi? È stata davvero una lotta, ma mi sono detto: “Guarda, accetto ciò che la natura mi ha riservato per questo periodo di lavoro.”
A proposito del senso del film mi hanno colpito due tue frasi: la prima è “La storia è maestra solo se è sincera”, la seconda “Siamo noi il nostro nemico”. La sincerità va correlata all’onestà, c’è sincerità solo se c’è anche onestà. Penso che molto spesso siamo noi il nostro nemico perché a volte compiamo scelte che non corrispondono alla nostra consapevolezza del valore dell’esistenza bensì alla convenienza momentanea, all’occasione da sfruttare, all’idea di prevaricare sugli altri solo perché ritieni di essere più intelligente e furbo. Nel momento in cui trascuri il rigore dei tuoi comportamenti c’è una mancanza di rispetto per gli altri, li offendi. Quando uno si ritiene a priori superiore all’altro e lo tratta con supponenza è preda di un virus molto diffuso che è la stupidità. Crede che il suo sapere corrisponda al sapere universale, poi se vai a chiedergli: “Quando si semina la fragola o il cavolfiore?” non lo sa. C’è tutto un sapere al di fuori del tuo che occupa lo spazio cosmico dell’infinito in continua espansione e tu, miserabile, con quelle quattro nozioni pensi di sapere tutto? È inutile che ripeta che “più sai, e più sai di non sapere”. C’è un magnifico aforisma – mi pare di Raymond Chandler, anche se per me oggi non ha più nessuna importanza se è un aforisma o un proverbio, o chi l’ha detto per primo – che dice: “Colui sapeva veramente tutto, ma solamente quello.” Il documentario che hai realizzato per Expo si intitola L’Acqua e il Pane di ogni giorno ed evoca il Padre Nostro: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano.”
Qual è il senso che ha avuto per te girare un documentario con un titolo che allude alle cose basilari della vita? L’edizione di Expo 2015 ha come titolo Nutrimento del pianeta, energia per la vita. Quindi fa esplicito riferimento al cibo. Quel cibo che la Madre Terra ha predisposto prima della nostra comparsa su questo pianeta e che ha preparato con amorevole accoglienza per la nostra venuta. Qui mi viene immediatamente da aggiungere: ecco, guarda come abbiamo ringraziato il pianeta che si è amorevolmente curato di noi prima che arrivassimo e che è stato attento a qualsiasi dettaglio! In questo contesto, mi dispiacerebbe molto che Expo si trasformasse in una sorta di strategia di mercato. Il “mercato” non è una parola brutta, lo diventa quando non è un’opportunità per avere buoni esiti nelle diverse attività umane, ma è solo privilegio di pochi potenti che lo organizzano con gli strumenti più infernali di cui conosciamo ormai l’identità: sono i media e la pubblicità che ci annunciano quotidianamente che quello che ci mettono a disposizione è per il nostro bene. A questa favoletta ormai non crediamo più perché lo fanno per il loro esclusivo interesse. Siamo arrivati addirittura ad avere disastri ecologici in tutto il pianeta perché
costoro non si fermano davanti a nulla. Allora se l’Expo avrà il coraggio di parlare di queste cose con sincerità e onestà, avrà un senso; se invece è soltanto un apparente spot pubblicitario che propone tutte le gioie possibili del cibo e perfino la soluzione dei problemi della fame del mondo, sarà una delusione. È da quando sono al mondo e ho iniziato a percepire la realtà con consapevolezza che si parla dei problemi della fame del mondo e ancora non si intravede una possibile soluzione. Oggi ci sono otto grandi potentati sulla Terra che dicono che si preoccupano della nostra salute e del nostro cibo: ebbene, costoro sono quelli che rovinano il pianeta e non hanno nessun riguardo a produrre un’enorme quantità di cibo di cui ben un terzo va regolarmente sprecato e buttato mentre miliardi di persone non hanno di che mangiare. Oltretutto per produrre il cibo con quel tipo di agricoltura intensiva e chimica distruggono l’equilibrio climatico e le condizioni di vita sul pianeta. Avrai sentito parlare della banca dei semi realizzata anche con i contributi di questi potentati nel permafrost delle Isole Svalbard. Un grande personaggio mondiale [José Barroso, ex Presidente della Commissione europea, N.d.R.] l’ha definita “il giardino dell’Eden congelato”. Pensa a che punto di stupidità criminale siamo arrivati! Questi potentati vogliono possedere i semi naturali che si riproducono e nel contempo mettono in circolazione i semi OGM che non si riproducono. Mi chiedo: ma chi gli ha dato il permesso di fare queste cose? Chi ha consentito a questi criminali di prendere queste decisioni? Almeno un criminale come Hitler si vedeva cosa faceva, bruciava gli ebrei, faceva massacri e ci si poteva ribellare, tanto è vero che ha perso la guerra perché il mondo si è ribellato. Questi criminali di oggi non li vedi, e allora? Chi potrà salvarci? Noi stessi. Se ci mettessimo di impegno a non comprare i loro prodotti, soprattutto quelli superflui, allora potremmo combatterli efficacemente. Ogni casalinga ha sotto il lavandino quindici e più boccette di detersivi: cominciamo a non usare più i detersivi, l’aceto sostituisce bene tutti quei prodotti chimici. Ma come fare a lottare contro un nemico che si muove nell’oscurità, nell’ambiguità, e si infiltra nelle parti meno difese del nostro corpo? Ti trovi a essere complice senza nemmeno saperlo. Forse quando vedremo veramente il pianeta agonizzante – e il punto di non ritorno non è tanto distante – quando la popolazione del mondo sarà di nove, dieci miliardi voglio vedere come potremo, camminando nella cenere di ciò che è stato il mondo, trovare ancora una traccia di vita. Bene, tu potrai pensare che io sia un pessimista. Arrivo a dirti che il mio pessimismo totale ha dato origine a un ottimismo perché tutto ciò che accadrà di doloroso forse sarà la nostra salvezza.
Solo con il dolore potremo capire quanto noi siamo stati stupidi per aver ascoltato dei potenti stupidi.
A questo proposito, mi pare ci siano alcune differenze simboliche tra il film e il documentario: nel film c’è una guerra visibile con un nemico tangibile, oggi invece la guerra per l’alimentazione e per il controllo dei semi è una guerra più invisibile perché non si sa fino in fondo chi è il nemico. Guarda che ora lo stiamo vedendo sempre più chiaramente: se pensi che la banca dei semi nelle Svalbard l’ha fatta Bill Gates, la Monsanto e altre grandi multinazionali, sono quegli otto lì! Sono ben visibili attraverso i prodotti che ci costringono a comprare. Qui, fuori dalla porta di casa, ho un piccolo orto e penso che tutti dovremmo avere il diritto a un piccolo orto. Vorrei che venisse fatto un decreto di legge per cui ogni bambino che nasce ha diritto a venti metri quadrati di terra, di orto, così in questo modo sopravvive. Invece ci hanno portato via anche la terra e poi si inventano l’orto verticale nelle città, ti par possibile? Prova a immaginare un mondo diverso con tanti orti quanti sono i bambini. Una volta dicevo a Carlin Petrini, a proposito del progetto di Slow Food di incrementare gli orti anche in Africa: questi sono gli orti di civiltà che non ti danno solo il frutto della terra ma ti insegnano a capirne il suo valore e a voler bene alla terra.
Parli di terra, e anche di dolore. E che forse solo attraverso il dolore riusciremo ad acquisire quella consapevolezza per cambiare. A proposito delle ferite della terra, c’è un altro nesso tra il film e il documentario: nel caso della guerra c’è una ferita che è dovuta ai bombardamenti e al sangue umano versato, nel caso dei diversi inquinamenti c’è una ferita che tocca tutto il pianeta e ne mette a repentaglio la vita. Il titolo del film parla proprio di questo: dove ci sono stati bombardamenti, distruzioni, sangue umano versato “torneranno i prati”. Ma questo paradossalmente non è nulla in confronto a ciò che il nostro nemico in questo momento compie come atto mortale contro la Terra. E guai se anche Expo fosse un modo diabolico per coprire quelle malefatte come se fossero per il bene dell’umanità. Aspetto proprio di vedere cosa succede: se corrisponderà a una consapevolezza di condivisione, di civiltà, di rispetto per le persone e per la Terra o se è un pretesto, una lusinga come uno spot pubblicitario per favorire scambi commerciali, con il cibo che va da un emisfero all’altro per ragioni di mercato. Per quanto riguarda il dolore, per comprenderlo nella sua essenza dobbiamo pensare alla natura, a Madre Terra, che nel suo momento migliore, nel fulgore dell’estate ci profonde frutti di ogni genere con grande generosità, ma che pensa a noi anche in inverno quando può fornire solo poche cose. Bene, il dolore è presente anche nella natura.
Pensa quando improvvisamente una mattina ti alzi e vedi che sui rami c’è la brina: ecco, lì la natura si addormenta, ma soffre. E quando vedi che soffre? Quando insorge la primavera e la natura deve svegliarsi da questo sonno prolungato (e uno, romanticamente, pensa: “Oh che bello, è arrivata la primavera!”). Pensa alle viti: qui fuori casa ho una piccola vite che per me è un continuo miracolo. Quando poti la vite a primavera vedi che piange perché venire al mondo è uno sforzo grande. Tua madre, caro Marco, quando ti ha partorito ha provato dolore. Il Vangelo dice: “La madre, che partorisce nel dolore, appena si è compiuto l’atto della nascita gioisce perché un nuovo uomo è venuto al mondo.” Pensa la madre che opportunità ha per capire l’amore che non ammette equivoci. E noi siamo diventati così stupidi e criminali che buttiamo i bimbi nei cassonetti della spazzatura! Certo, è sempre accaduto ma una volta suscitava scandalo e ribellione nelle persone; adesso è tutto appiattito sotto questo grande spot che addormenta le coscienze. Prima o poi dovremo affrontare il dolore del nostro riscatto e non sarà un riscatto gratis, sarà un riscatto che dovrà accettare un grande dolore.
Nella crisi contemporanea che è economica ma ancor di più di valori etici e spirituali ci sono alcuni segni di speranza. Uno di questi è rappresentato per i credenti e anche per i laici da papa Francesco. Ti sei definito in più occasioni “un aspirante cristiano”, qual è il tuo pensiero? Certamente papa Francesco è un segno di speranza nel cambiamento verso una Chiesa più vicina nei fatti ai poveri, agli umili e più distante dal potere economico e politico. Ma ci sono anche altri segni di speranza, altri “papi laici” come Carlo Petrini o Vandana Shiva che combattono da anni una giusta battaglia per la difesa del pianeta, dell’agricoltura e dell’alimentazione buona e sana. Sono temi che riguardano tutti, ma i media li sottovalutano e li mettono in mezzo a tante notizie futili, come fossero un’informazione tra le altre. No! Questi temi toccano l’essenza della vita umana e della Terra, la stessa idea di futuro del pianeta ma poiché toccano anche i grandi interessi economici e finanziari vengono sminuiti nella loro importanza e drammaticità.
Prima parlavi del dolore che prova la Terra nel risveglio dall’inverno alla primavera. Forse c’è un equivoco nell’essere umano dovuto alla preminenza della parola umana, che ovviamente è fondamentale per comunicare e capirsi, ma che non rappresenta la totalità della comunicazione. Non dobbiamo recuperare quel tipo di intelligenza e sensibilità che ci consente di comprendere e comunicare anche con il non verbale della natura?
È proprio così. Neanche per sogno la parola è tutta la comunicazione! Come parla la natura per farsi riconoscere? Coi profumi, i colori, i sapori: noi oggi non riconosciamo più questi sapori e profumi perché non ci sono più, li hanno eliminati. Ci danno pomodori bellissimi all’apparenza e insapori dentro. Perfino quando nevica, prima che nevichi senti il profumo della neve. Come mai? Avverti proprio qualcosa di speciale al di là delle nuvole morbide ma compatte: annusi l’aria e ha dentro un aroma.
Anche il silenzio magico della neve parla… Tutto parla, nell’universo non c’è nulla che non parli e la cosa incredibile, ma nemmeno tanto se ci pensiamo bene, è che noi conosciamo cose che esistono, ma che non abbiamo mai visto. Sono inimmaginabili? No, sono immaginabili. E continuo a ripetere ai miei amici che la velocità della luce – che è un dato scientifico che ci impressiona molto – non è nulla al confronto alla velocità del pensiero. L’uomo ha questa capacità divina di immaginare l’universo cosmico che è in continua espansione: noi con un battito d’occhio siamo là. Un battito d’occhio e la tua mente ti pone là dove ancora è in atto la creazione dell’universo. Il tuo primo film si intitolava Il tempo si è fermato. Lo trovo un titolo profetico,
visionario. A me pare che in quel film, come negli altri filmati industriali per la Edison, non solo documenti ma “canti” il fare umano, la dignità del lavoro con quei volti umili, come i minatori di Manon finestra 2. Forse sono gli stessi volti dei soldati della Prima guerra mondiale. Sì, sono loro.
Canti la fatica di quei lavori e anche i silenzi di quei lavoratori, come quei silenzi bellissimi in Il tempo si è fermato, tra il custode della diga e il giovane. Nel film si percepisce che la ricostruzione del dopoguerra conteneva ancora un sentimento di speranza e di miglioramento sociale. Ce l’aveva, ce l’aveva! L’ho vissuta quella speranza, ci credevamo! Pensavamo che fosse davvero la primavera del mondo, la primavera di tutti i mondi e – come posso dirti – quei cinque anni di guerra sono stati come un lungo inverno particolarmente rigido dove molti uomini sono morti per il freddo, ma quelli che hanno resistito si sono purificati. L’inverno è proprio la stagione nella quale si sta in silenzio e sembra che “il tempo si sia fermato” per lasciarti lo spazio per rispondere a tutti i perché a cui non hai ancora risposto. In inverno il tempo si ferma: non ci sono azioni ben visibili, tutto è segreto e nascosto sotto terra e dentro la linfa degli alberi. Anche per noi avviene la stessa cosa. Invece adesso riempiamo anche l’inverno di inutilità, nelle nostre città caotiche
e ribollenti, e non dedichiamo più a questo tempo che si è fermato l’attenzione che merita. Un certo giorno, del 1968, forse non è al vertice stilistico della tua carriera
cinematografica ma, dal punto di vista della tua poetica, è a mio parere fondamentale. In quel film cogli intuitivamente già negli anni sessanta i prodromi di quella crisi dell’Occidente di cui stiamo vivendo oggi, dopo cinquant’anni, l’esito più grave. Il tempo della crisi che quasi nessuno ancora intravedeva, iniziava già in quegli anni. Erano segnali precisi di cui non si è tenuto conto perché la classe dirigente degli Stati più avanzati sperava di risolvere tutto creando una società economicamente trionfante ed era come se dicesse ai suoi cittadini: “Adesso con il tuo stipendio puoi vivere sempre meglio e tu consumatore puoi comprare tutto quello che vuoi: l’auto, la casa.” Con un’idea di crescita illimitata che si è mostrata un’illusione. Ora siamo arrivati a capire che era solo il gioco delle tre carte. Successivamente con film come Lunga alla vita alla Signora!, La leggenda del santo bevitore, Il segreto del bosco vecchio, Il mestiere delle armi, Cantando dietro i paraventi, Centochiodi e Il villaggio di cartone attraversi l’avventura
umana nella sua complessità: l’avidità umana, il rapporto con la natura, il potere, la guerra, la necessità di una nuova spiritualità. Oggi, con L’Acqua e il Pane di ogni giorno e Torneranno i prati simbolicamente è come se tu tornassi alle origini, alle cose fondamentali della vita. Sì, è vero, e questo corrisponde all’età che hai. C’è un momento in cui scopri la realtà, ti poni delle domande ma non ti affanni tanto a trovare la risposta, in qualche modo ti accontenti e non vai più di tanto in profondità, percepisci che la risposta a quelle domande verrà più in là. A me è capitato che da un certo momento in poi – in particolare dopo che sono tornato alla regia dopo la malattia neurologica che mi aveva come dimezzato – ho girato film che sono più delle icone che film realistici, come invece erano stati quelli sul mondo del lavoro industriale o in campagna. Anche quest’ultimo film è un’icona e non ha niente a che vedere con un film sulla Prima guerra mondiale ricostruito da un punto di vista storico. Non dico affatto che uno sia meglio dell’altro, Francesco Rosi, ad esempio, ha fatto un capolavoro, Uomini contro, ispirato al romanzo Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu, e ci sono stati altri grandi film su quella guerra come La grande illusione di Renoir o Orizzonti di gloria di Kubrick. Tutti film che rievocavano rigorosamente un’epoca attraverso una rappresentazione di quel che è avvenuto. Ma a partire da Lunga vita alla Signora! e poi con La leggenda del santo bevitore, Il segreto del bosco vecchio e Il mestiere delle armi, i miei film sono icone.
Cosa è avvenuto in te dopo quella malattia? È successo che ero diverso. Ma anche dopo il nostro incontro di oggi o se mi fermo in un autogrill per un caffè e vedo un bambino che piange, sono diverso. Se vedo un bimbo che piange inizio a domandarmi se è stata anche colpa mia, se ho contribuito anch’io a far diventare desideri irrinunciabili quegli oggettini colorati nei banchi dell’autogrill. Anche quel bambino è stato illuso e tradito. Tutto ciò che avviene, se sei attento, ti cambia, ti rende diverso.
Siamo giunti al termine di questa conversazione sui tuoi film e sui temi dell’esistenza che hai toccato. Vorrei concluderla tornando, come in un ideale cerchio, al tuo punto di partenza, al tema che è stato all’origine dei primi documentari e dei primi film: il lavoro. Tu ne hai colto la dignità, la sacralità, anche la durezza. Oggi sembra che il lavoro, soprattutto quello manuale, sia soppiantato dai nuovi poteri finanziari, tecnologici e della realtà virtuale. Sembra quasi diventato una cosa marginale, sorpassata. Invece, proprio in questa crisi epocale ci si interroga di nuovo, per fortuna, sul valore del lavoro e sul suo futuro, in particolare per le nuove generazioni. Ricordo che da bambino, sia nel paese di mia nonna sia a Milano, vedevo le botteghe di questi artigiani, che diventavano qualche volta anche luoghi di convivialità. Quando l’artigiano ripeteva la lavorazione di un prodotto, ad esempio una sedia, non lo faceva uguale a quello precedente. In teoria era uguale, ma ogni volta, muovendo le sue mani con la curiosità della sua mente, apportava al suo prodotto un miglioramento, o comunque ne dava una connotazione inconfondibile, per cui quando gli chiedevo una sedia lui la faceva per me. Di conseguenza in quell’oggetto c’era la sedia con la sua funzione, ma intanto tra noi si era stabilito un rapporto che andava oltre la sua pura utilità e il prezzo pattuito. Se all’uomo togli questa soddisfazione relazionale lo mortifichi in maniera davvero umiliante. E al tempo stesso cosa fai? Produci una situazione in cui anche l’oggetto che acquisti è mortificato, perché è stato replicato in milioni di copie. Ecco allora che abbiamo tutti lo stesso abito, gli stessi oggetti e così via. Anche le case d’abitazione sono tutte uguali, hanno tutte più o meno quella cucina, quel salotto. Persino gli odori sono stereotipati, massificati. Ricordo che una volta ogni casa aveva il suo odore, a seconda di come si cucinava. Oggi ci sono due o tre tipi di deodorante e tutti hanno quell’identico odore. In realtà tutta la produzione di massa, che produce grandi profitti per pochi, produce contemporaneamente una mortificazione per molti. Ci tolgono proprio la coloritura della vita. Pensiamo ai cibi. Una volta il vino veniva un anno più buono, un anno meno. Si diceva: “Quello dell’anno scorso era meglio.” Oppure: “Quello di quest’anno è un vino formidabile.” Quando vai al supermercato ci sono queste cellette tutte uguali e anonime. Nei limiti del possibile cerco ancora di avere rapporti con gli ultimi artigiani. Stamattina è passato qui da me il calzolaio. Loredana ha delle riparazioni da fargli fare perché non vanno buttate via le scarpe appena sono un po’ consunte. Non è per risparmiare, per taccagneria, ma
perché non bisogna consumare più del necessario. Oggi quando un matrimonio va in crisi cambiano i mobili di casa per salvare il matrimonio. Non serve. Prova a metterti in casa il canterano di tua nonna invece di acquistare l’ultimo modello della cucina o del televisore. In casa ho tutti i ricordi della mia famiglia. Il tavolo che ho di sopra è lo stesso che c’era in casa mia quando ero piccolo. Ricordo ancora la prima volta che sono riuscito a vederne il piano, perché ero più piccolo del tavolo. Ecco, tutto questo mi tiene compagnia. Oggi anche un tavolo del più affermato designer non mi dà la stessa soddisfazione di quel tavolo lì che è stato fatto a mano da un artigiano: l’ha fatto apposta per quel signore che era mio nonno. Recentemente ho letto un articolo molto interessante in cui il grande economista e sociologo Richard Sennett sostiene che se non torniamo alla modalità artigiana, alla filosofia del prodotto artigianale non avremo un futuro sostenibile. Mi auguro proprio che si possa prossimamente vedere una rinascita di un lavoro più artigianale e umano. Mi piacerebbe avere ancora la possibilità di sbirciare questo possibile cambiamento, dove torniamo ad amare le cose che hanno valore e a diffidare delle cose che ci vendono e che sono costruite per essere buttate via il prima possibile. Crediamo di fare un buon affare e invece è una presa in giro dei consumatori. Questo è ciò che ci meritiamo perché non siamo stati abbastanza avveduti. Ma ho fiducia. Girando il documentario Terra Madre ho ascoltato dei ragazzi giovanissimi e straordinari. Ad esempio, nel film c’è un ragazzo del Massachusetts, di quindici anni, che ha fatto l’orto nella scuola per produrre pomodori e patate per la mensa scolastica. Finisce il suo intervento alla manifestazione di Slow Food Terra Madre a Torino dicendo: “Noi saremo la generazione che riconcilierà l’uomo con la terra.” Mi pare un buon motivo di speranza.
SECONDA PARTE
DAL PICCOLO ALL’UNIVERSALE La poetica di Ermanno Olmi
Nel grande fiume del cinema di Ermanno Olmi vi sono alcuni affluenti narrativi che attraversano l’intera opera cinematografica: il mondo del lavoro, il tempo, la natura, la spiritualità. Attorno a questi temi Olmi ha dato forma alla sua poetica: storie con personaggi minimali che toccano questioni universali.
1. Il mondo del lavoro Ermanno Olmi, fin dai primi documentari industriali, opera la scelta di fondo che costituirà il fil rouge di tutto il suo cinema: vicende di una normale quotidianità dove al centro vi sono i lavoratori e gli umili. In queste sue prime opere, nelle quali il protagonista è l’uomo che lavora, Olmi dà vita a un grande cambiamento formale nel documentario industriale. Il suo obiettivo è la realtà messa in scena, tipica del grande documentarismo di Robert Flaherty. Il lavoro viene considerato nella sua interezza: come fattore di progresso e promozione sociale con la conquista del posto fisso, ma anche nella durezza che è insita nel lavoro manuale – la fatica fisica, il rischio per la propria incolumità – come saranno i casi dei minatori di Manon finestra 2 o dell’incidente nella raffineria siciliana in I fidanzati. Olmi privilegia le figure di lavoratori che dignitosamente e umilmente fanno il loro lavoro e ne coglie l’autenticità negli sguardi, nel linguaggio, nella forza delle loro mani. I documentari di montagna mostrano operai che hanno gli stessi volti dei contadini delle pianure e delle valli: non c’è ancora quella sorta di distacco, di lacerazione antropologica di cui Pasolini parlerà profeticamente. È un racconto corale che evita gli accenti retorici, ma che contiene una forte carica etica. Il suo è un umanesimo non di facciata, ma che ricerca valori autentici nelle pieghe della realtà quotidiana. I documentari di Olmi riguardano un passaggio d’epoca, gli anni cinquanta, nel quale l’industria si affermerà definitivamente, ma senza stravolgere l’ambiente naturale come avverrà, purtroppo, nei decenni successivi. Il rapporto del lavoratore con la terra e la montagna assomiglia a quello che il marinaio ha con il mare: fatto di rispetto, senza sottovalutarlo mai. Non c’è ancora un vero conflitto ecologico, il rapporto con la natura è ancora misurato, è una sorta di prevalenza mite, senza protervia e arroganza.
La montagna nel cinema di Olmi mantiene la sua forza, la sua dignità ed è, insieme al lavoro umano, l’altro vero protagonista. Ciò che interessa a Olmi in questi documentari è la qualità umana che si esprime nel lavoro onesto, fatto con l’intelligenza e le mani, quando legittimamente si può provare l’orgoglio per un lavoro fatto bene. È qui che per Olmi l’uomo si fa grande, che l’umanità si realizza. È l’etica del lavoro così come si è dipanata nel Novecento tra l’umanità lavoratrice delle campagne rappresentata in L’albero degli zoccoli e quella dei primi insediamenti industriali, e che traspare, ad esempio, dalla figura di Il pensionato. Il vecchio operaio che non vuole mandare in pensione l’esperienza e i valori accumulati nella sua lunga vita lavorativa e che, quasi miracolosamente, riesce a metterla al servizio di alcuni giovani tipografi. Ma c’è anche la ripetitività tipica dei lavori d’ufficio, come quella che vive il giovane Domenico, protagonista del suo secondo film, Il posto. E l’alienazione, in questo caso dai valori umani, che traspare dalla figura del director dell’agenzia pubblicitaria di Un certo giorno, prototipo profetico del manager tutto teso al successo. Per dare ancora più corpo al realismo di questi racconti di lavoro, Olmi mette in grande risalto la componente fonica: si sentono distintamente i rumori degli strumenti di lavoro come i martelli perforatori dei minatori utilizzati nelle diverse fasi di costruzione delle dighe. Ascoltare il lavoro, non solo vederlo. Ascoltare la rumorosità di strumenti di lavoro faticosi da gestire fa sì che lo spettatore entri ancor più precisamente nell’esperienza dell’operaio, del minatore. “Mi interessa la vita più che il racconto. Cioè la possibilità di raggiungere un risultato di assoluta credibilità nelle dimensioni e con il ritmo diverso del cinema. Non sottovaluto la tecnica che, grazie a un lungo tirocinio documentaristico conosco abbastanza.”1 Infatti, in questi primi anni di attività Olmi impara il montaggio e l’utilizzo della macchina da presa. È la sua gavetta, facilitata da un ambiente lavorativo e da dirigenti dell’Edisonvolta che lo aiutano a fare questi primi passi. Olmi racconta che proprio per provare una nuova macchina da presa, che la Edison gli aveva messo a disposizione, l’Eclair 300 – che aveva già utilizzato per Il tempo si è fermato –, decide di mettere in scena la celebre Operetta morale di Giacomo Leopardi Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. L’occasione diventa un esempio illuminante del cinema di Olmi inteso come sceneggiatura della realtà. Ambienta l’Operetta nella Milano degli anni cinquanta, in piena espansione e alla vigilia di Natale. Nella frenetica metropoli un passeggere-passante e un ambulante discettano surrealmente sul valore del tempo, tra calendario cronologico e tempo vissuto. Questa materia prima – il mondo del lavoro – che accomuna i documentari industriali dell’Edison e i suoi primi film (Il tempo si è fermato, Il posto, Un certo
giorno) rappresenta un percorso di ricerca che per Olmi è molto preciso ma che non era predisposto come un piano prestabilito. L’ultimo film di questo percorso è stato L’albero degli zoccoli: nelle sue intenzioni doveva essere il primo, avendo come oggetto il lavoro nella campagna, ma non ebbe allora la possibilità di girarlo. Inizia perciò a realizzare documentari nei cantieri in alta montagna dove vengono costruite le grandi dighe per i laghi artificiali necessari alla produzione di energia elettrica. Ciò permette a Olmi di star vicino, da subito, a uno degli elementi chiave del suo cinema: il fare umano e la sua dignità. Un fare che qui si coglie nella sua forza espansiva, ma con un senso ancora di rispetto per l’ambiente circostante. Un accostarsi a essa non in modo predatorio e violento, ma con qualcosa che assomiglia alla consapevolezza che lì c’è un mistero che non va travolto. Anche quando si costruiscono le dighe o si scava nelle miniere c’è, nei volti degli operai, dei minatori, uno sguardo quasi timoroso di chi sta, in qualche modo, violando la natura. Si coglie la timidezza della povera gente delle valli del Nord o degli immigrati che diventano minatori. Nel lavoro c’è misura. In questi film si respira un’aria composta di fatica mista a timore, silenzio, solitudine, solidarietà. Il suo primo film, girato all’età di ventisette anni, si intitola Il tempo si è fermato ed è la storia di due guardiani di dighe, un vecchio operaio e un giovane operaiostudente che durante l’inverno si trovano isolati dal mondo. È la storia di due generazioni dove si evidenzia una prima frattura che però nel film trova una sua composizione con l’avvio di un dialogo. Il tema del confronto generazionale è l’architrave narrativo anche di Il pensionato, nel quale un capo operaio andato in pensione, prima inveisce contro i giovani operai di una tipografia che lavorano anche di notte nel cortile di casa e poi si ritrova a collaborare con loro fino a tarda sera, mettendo a disposizione il sapere tecnico che gli proviene dalla sua esperienza. In questo caso Olmi trova il modo per ricomporre una frattura, una distanza generazionale tra chi il lavoro lo ha ma è senza esperienza e chi, il pensionato, non lo ha più e invidia i giovani. Oggi l’invidia del pensionato si è ribaltata nel suo contrario: è il giovane che si sostituirebbe volentieri al lavoratore in età avanzata per prenderne “il posto”, anche se più precario. Queste sono le storie quotidiane con protagonisti minori che a Olmi interessa raccontare: “È vero, mi piace raccontare storie di piccoli uomini. Ma cosa siamo noi tutti al confronto con l’infinito? Cosa, se non dei piccoli uomini? Eppure, qualche volta, potremmo anche essere grandi, se solo riuscissimo a riconoscere di essere piccoli.”2
2. Il tempo Il tempo è uno dei grandi temi che Olmi ha affrontato fin dai primi documentari
industriali realizzati per la Edison e dedicati ai nuovi insediamenti idroelettrici in alta montagna. Negli anni cinquanta quei luoghi erano realmente isolati dal mondo e le lavorazioni erano difficoltose e duravano diversi mesi. Era una quotidianità sensibilmente diversa da quella della città o anche della campagna, fatta di solitudine, silenzio e scandita dalla maestosità e terribilità della montagna: il tempo atmosferico determinava l’andamento delle lavorazioni. Poi c’era il tempo interiore: le relazioni umane tra gli operai, le lettere e le cartoline dei propri cari. Un tempo di ascolto, un tempo di attesa per il ritorno a casa. Non è quindi per nulla casuale che il primo lungometraggio – girato anch’esso in alta quota all’insaputa della Edison che si aspettava un nuovo documentario – Olmi l’abbia intitolato Il tempo si è fermato: a sottolineare che, in quelle condizioni, il tempo normale era come sospeso. Ma è proprio in un tempo così anomalo che un uomo maturo e un giovane prima si scrutano guardinghi e poi entrano in una relazione emotivamente significativa, favorita paradossalmente da un guasto elettrico e da un malanno del giovane. Il vuoto apparente di giornate sempre uguali si riempie di una nuova relazione umana che è, insieme al mondo del lavoro, il vero interesse di Olmi. La dimensione del tempo si ripresenta come elemento centrale anche in Un certo giorno. Qui si evidenzia la differenza tra il tempo vissuto dai manager di un’agenzia pubblicitaria, tutti tesi all’obiettivo del profitto, e quello del corpo e delle emozioni. Infatti l’amministratore delegato, colpito da un attacco cardiaco, si ritirerà dal lavoro e dovrà cambiare radicalmente vita. Quando il malore sopraggiunge, i momenti più significativi della sua esistenza emergeranno in brevissimi flash. In questo modo Olmi rappresenta con grande efficacia il contrasto tra tempo produttivo e tempo interiore. Questo tema emerge, ancor di più, nella vicenda del director a cui – nel pieno del successo professionale e anche personale – “un certo giorno”, un giorno qualsiasi capita un incidente che cambierà la sua vita. Olmi con questa metafora parla dello scarto tra il tempo dello sviluppo industriale pensato come esponenziale e quello della vita quotidiana, dove ci sono rettilinei ma anche curve, discese e salite. E dove l’imprevisto è dietro l’angolo. È il tempo dell’Occidente di cui parla Olmi, il tempo del progresso illimitato, del no limits. L’incidente banale, di cui nemmeno ci si accorge, sta lì a ricordarci che i nostri desideri e ambizioni si devono confrontare con un tempo fatto anche di riflessione, responsabilità, affetti veri. Il tempo è anche l’architrave del film più famoso di Olmi, L’albero degli zoccoli. L’epopea della comunità di famiglie contadine che vivono in una cascina lombarda a fine Ottocento ha avuto grandi riconoscimenti internazionali proprio grazie alla sua capacità di ricreare, utilizzando veri contadini come attori, la realtà di un tempo storico.
Quello rappresentato nel film non è un tempo idealizzato o nostalgico perché si vedono bene le fatiche e le ristrettezze economiche con cui i contadini devono fare i conti, e anche le furbizie che essi adottano per raggranellare dal raccolto qualche soldo in più. In questo contesto, Olmi ci mostra momenti di altissima poesia propri di un’altra temporalità, di un altro sentire. Ci sono scene indicative di un tempo in cui la comunità condivideva il lavoro e anche le sere, con le donne che cantavano riunite in coro o le famiglie che ascoltavano fantasiose narrazioni. E l’immagine dei carretti dei due sposini che partono all’alba per recarsi in chiesa: Maddalena, la giovane sposa, tutta raccolta nella sacralità del momento che sta vivendo, osserva in religioso silenzio l’alba. Ma la campagna ha le sue leggi e arriva anche “il tempo del dramma”. Batistì, uno dei capifamiglia che per fare gli zoccoli nuovi necessari al figlio per andare a scuola ha tagliato un albero, verrà scoperto dal padrone che, senza alcun indugio, manderà via dalla cascina l’intera famiglia, con l’ultimo bimbo appena nato. L’albero degli zoccoli è allora, anche, il tempo degli zoccoli, un tempo fatto di terra, legno, asprezza e poeticità della vita e di due volti della figura maschile: quello duro e intransigente del padrone, quello ironico, premuroso e affettuoso di Batistì. Nella trasposizione cinematografica del racconto di Joseph Roth La leggenda del santo bevitore, Olmi ci porta in un tempo nel quale la quotidianità si incontra con il miracolo e la coincidenza. Il protagonista, Andreas Kartak, riceve più volte in dono del denaro con l’impegno di restituirlo alla statuina di Santa Teresa di Lisieux. La metafora del dono intende parlarci dei piccoli miracoli che accadono nella quotidianità, che fatichiamo a riconoscere e che, in ogni caso, hanno dei doveri cui corrispondere. Rappresentano occasioni di cambiamento per una vita più consapevole, più attenta. Nel film i miracoli sono affiancati alle coincidenze. Molti sono i momenti in cui ricompaiono le persone importanti della vita di Andreas e il più delle volte queste coincidenze sono problematiche perché rappresentano il passato non risolto che pesa ancora sul suo presente. Tanto da distoglierlo dal compito etico-spirituale che ha di fronte: la restituzione del denaro. Anche la coincidenza ci parla di un tempo “altro” nel quale ci si interroga se ciò che ci capita sia dovuto al caso o meno. Certe coincidenze, come avviene nel film, sembrano tutto fuorché casuali. Il tempo del miracolo e della coincidenza è un tempo dove realtà e sogno si mescolano: Andreas ha visto veramente la piccola Teresa sotto il ponte della Senna e dentro al bar Paradox? E i due genitori seduti a un tavolo, li ha visti o li ha sognati? Allora il tempo di cui parlano Roth nel romanzo e Olmi nel film è il tempo della psiche dove realtà e sogno convivono. La stessa vita cinematografica di Olmi è stata segnata dal “miracolo” e dalla coincidenza. Quando ha trovato, perdendosi nelle nebbie della pianura padana, la cascina di L’albero degli zoccoli, esattamente come doveva essere. O il bar
Paradox trovato di fronte alla chiesa di Sainte Marie des Batignolles, in vendita e libero per il tempo necessario alle riprese. Nei film che Olmi ha dedicato più direttamente alla dimensione spirituale, l’elemento tempo è presente con grande evidenza. A proposito di questa parte della produzione cinematografica di Olmi, Centochiodi è un film incentrato proprio sulla separazione tra il tempo passato – i libri antichi che rappresentano la memoria dell’umanità – e il tempo presente. Per Olmi se la cultura tradizionale non sa più raccordarsi con la vita reale, non ha più nulla da dire, anzi diventa un ostacolo alla comprensione dei problemi esistenti. Il sapere accumulato nelle università e nelle biblioteche non ha futuro se non si collega al sentire e al fare dell’uomo di oggi. La frase più provocatoria ed emblematica del protagonista del film esprime bene questa convinzione: “È meglio un caffè con un amico che tutti i libri del mondo”, con la quale Olmi mette in evidenza che il tempo degli affetti, dell’amicizia non è secondo a nessuno. In realtà non sono i libri antichi, cioè il passato, a dover essere inchiodati, ma l’uso asfittico e intellettualistico che ne fa l’istituzione, sia religiosa sia laica. Il giovane assistente, poi chiamato Gesù dai vecchi del paese, insegue quell’umanità e temporalità. Fuori dall’università e dalle biblioteche c’è il tempo di una vita semplice e naturale che Olmi rappresenta con il fiume e le persone buone del paese. Quando il sapere non era separato dalla sapienza e dalla saggezza.
3. La natura La natura è sempre stata molto presente nel cinema di Olmi. Dai documentari girati in alta montagna a L’albero degli zoccoli, al recente documentario Terra Madre e a L’acqua e il pane di ogni giorno per Expo 2015. È interessante seguire come è cambiato nel tempo lo sguardo di Olmi verso la natura. Nei primi documentari la natura è ancora forte e quasi incontaminata: l’alta montagna, i torrenti, i fiumi sono pieni di vitalità e non ancora compromessi dallo sviluppo industriale. Negli operai che lavorano in quota o nelle miniere c’è molto rispetto per il mistero della natura. Nei contadini che lavorano in campagna in L’albero degli zoccoli c’è fatica ma anche ascolto e considerazione per i ritmi e le stagioni della natura. La sapienza contadina intuisce che la natura ha una sua sacralità ed è necessario collaborare con essa avendo il senso del limite. Dopo film nei quali l’interesse di Olmi si concentra sull’uomo e sulla sua evoluzione, la natura torna a essere recentemente un elemento centrale della sua ricerca come conseguenza della problematica ecologica e dello squilibrio climatico del pianeta. Olmi intuisce che qualcosa di grave e forse di irreparabile sta avvenendo sulla Terra e ne comprende la valenza non solo economica ma spirituale. L’uomo si è separato sempre più dalla natura, dalla Madre Terra e questa separazione non è un fatto tecnologico o finanziario, è un evento etico e
spirituale. C’è un’urgenza etica che impone a un artista come lui di tornare ai reali problemi del mondo, documentandoli senza il filtro della fiction. Una delle questioni più impellenti e serie dell’epoca contemporanea è la sostenibilità della vita del pianeta. Olmi non si sottrae a questa dura realtà. In questa nuova fase della sua produzione Olmi incontra compagni di viaggio antichi e nuovi: il poeta Tonino Guerra, Carlo Petrini fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Vandana Shiva fisica ed ecologista indiana. Gli elementi archetipici della natura – il pane, l’acqua – sono al centro del documentario che ha realizzato per Expo 2015. L’acqua e la terra accompagnano l’intera narrazione cinematografica di Olmi: l’acqua dei torrenti raccolta nelle dighe della Edison, quella del Po in Lungo il fiume e in Centochiodi. La terra è quella delle miniere dei primi documentari, della campagna di L’albero degli zoccoli, del documentario Terra Madre. La spiritualità di Olmi – al cui interno la natura ha un valore fondamentale – sembra essere tornata oggi al punto da cui era partita, agli elementi fondamentali della vita. Con più consapevolezza, più amarezza, ma senza rinunciare alla speranza. Ci sono molti momenti biografici nei quali Olmi racconta episodi di rapporto con la natura. Ne scelgo alcuni. Il primo è legato al dopoguerra: “La guerra era finita, e anche la scuola. Era la prima estate senza più sirene d’allarme, i bombardamenti. La sera tutti uscivano per le strade a passeggiare, dopo anni chiusi in casa per il coprifuoco. La canzone che cantavamo tutti era Solo me ne vo per la città. Le case avevano le finestre aperte con la luce accesa perché non c’era più l’oscuramento. Nei prati abbandonati, intorno al ponte della Ghisolfa, l’erba era rimasta alta come quando ci nascondevamo per giocare agli indiani. Distesi, si sentiva profumo di prato, l’odore buono della terra. La sua pelle odorava di sapone e di gioventù. Lei aveva due anni più di me. Io avrei compito quattordici anni di lì a pochi giorni.”3 Il secondo è il racconto dell’amicizia nata tra Olmi e uno scoiattolo: “La nostra amicizia era cominciata così e se questa parola ha un senso preciso, questo era il caso. Giorno dopo giorno, prendeva coraggio e io scoprii che andava a bere dal secchio dove Loredana raccoglieva l’acqua piovana per i suoi fiori. Mettemmo una ciotola d’acqua più vicina con accanto una noce. Gli scossoni ai rami del vecchio abete erano il segnale che lui era là ad attendere il momento propizio per portarsi via la noce. Finché un giorno si accostò tanto da prenderla direttamente dalla mia mano. E questa fiducia non era forse amicizia? Sarebbe una gran cosa se tutti potessimo fidarci l’uno della mano dell’altro. Il sodalizio con lo scoiattolo durò tutta l’estate.”4 Concludo con la citazione che Olmi fa di un brano di uno dei più grandi poeti africani, Léopold Sédar Senghor, padre della negritudine, per vent’anni presidente del Senegal, cristiano in un paese musulmano: “Nell’Africa primordiale, animali e piante erano intimi con l’uomo. Là si è intessuta allora, fra
gli elementi della natura, una rete di legami e di corrispondenti che dormono nel fondo della nostra memoria. Il negro ‘sente’ prima ancora di vedere e reagisce immediatamente. Attraverso questa emozione egli prende coscienza dell’oggetto. Lo assimila, poi, in un atto d’amore, lo incorpora a sé per conoscerlo più profondamente. Il bianco europeo, invece, tiene l’oggetto distaccato. Lo guarda, lo analizza, lo distrugge o per lo meno lo soggioga per utilizzarlo…”5
4. La spiritualità C’è un filo, a mio parere, che tiene insieme i film di Olmi che hanno toccato esplicitamente il tema spirituale – come nel caso di E venne un uomo,
Camminacammina, Genesi: la Creazione e il Diluvio, Centochiodi, Il villaggio di cartone – e quelli che lo hanno toccato più simbolicamente, come i documentari girati in alta montagna o quelli più recenti. È rappresentato da una ricerca costante, inesausta e anche sofferente per una spiritualità non istituzionalizzata, vicina nel concreto ai deboli, agli umili e alla loro quotidianità. Non è un caso che in questa ricerca ancora aperta, Olmi sia partito dalla figura di papa Giovanni XXIII, il “papa buono”. Un papa che sovvertì l’istituzione Chiesa, la sua liturgia e il rapporto con il mondo contemporaneo. Nei film che seguiranno Olmi farà risaltare con sempre più evidenza la spiritualità nella vita reale di tutti i giorni. È per questo che le figure che ha utilizzato per parlarne sono più laiche che religiose. A Olmi interessa molto il dialogo tra credenti e laici perché pensa a una spiritualità aperta e non confessionale. Aperta al non credente, aperta alle altre spiritualità. Lui stesso si definisce “un aspirante cristiano”. Fin dall’inizio della sua produzione cinematografica la dimensione spirituale è ben presente. Il sentimento umano a cui si ispira si intravede già nei documentari industriali dell’Edison. Non c’è forse spiritualità in quei lavoratori, in quegli sguardi, in quei silenzi, in quelle solitudini, in quelle fatiche? E non se ne trova altrettanta nella maestosità della montagna, che certo può essere anche terribile, o nella luce che viene vista come una nuova epifania dai minatori che riemergono dalle miniere? Olmi ci mostra la spiritualità laica legata al mondo del lavoro: quella degli operai d’alta montagna, dei contadini delle campagne e degli impiegati negli uffici delle città. Nel suo capolavoro L’albero degli zoccoli, dedicato al mondo del lavoro contadino, la spiritualità percorre tutti i momenti dei faticosi lavori nelle campagne, accompagnati spesso dai canti in coro delle donne e sottolineati dalle musiche sacre per organo di Bach. C’è spiritualità nel primogenito della vedova Runk che, di fronte alla prospettiva di mettere in orfanotrofio i due fratellini più piccoli, è disposto a lavorare come garzone giorno e notte, ma c’è anche nel vecchio contadino Anselmo che
insegna alla nipotina Bettina a piantare i “pomidori” e concimarli con lo sterco di gallina invece che di mucca per farli maturare prima. È la sapienza che proviene dalla terra, dai suoi insegnamenti. C’è in Batistì, uno dei capifamiglia, che pur sapendo di fare una cosa che vìola la legge, taglia di nascosto un albero per fare zoccoli nuovi necessari al figlio per andare a scuola, che dista chilometri. È un momento di grande spiritualità quando di notte intaglia il legno senza farsi sentire dalla moglie che ha appena avuto un bimbo. E, infine, c’è spiritualità nella coppia di giovani sposi a cui viene affidato dalla zia suora, con una dote, un piccolo orfano. Verrà accolto in famiglia con gioia e stupore. Una spiritualità laica emerge da figure umili come il giovane Domenico protagonista di Il posto che sta entrando nella sua nuova vita lontano dalla campagna: si avvicina quasi con timore alla metropoli e con timidezza al primo sentimento per una ragazza. Domenico è un ritratto umano di grande tenerezza, e la tenerezza – lo ricordava papa Giovanni XXIII e, oggi, papa Francesco – è considerata un’alta forma di spiritualità. A me Domenico ha fatto pensare al giovane Olmi che, orfano di padre, inizia, forse con un po’ di timore e timidezza, a lavorare alla Edison. Nel nuovo mondo del lavoro della città Olmi ci mostra anche figure dominate dal potere e dal successo dove la spiritualità – o anche solo la dimensione etica – è smarrita. È il caso del protagonista di Un certo giorno, il director di un’agenzia pubblicitaria che insegue le sue ambizioni professionali e le conquiste femminili. Qui Olmi mette in gioco non l’individualità di un manager ma l’intera impalcatura dei valori consumisti e materialisti dell’Occidente, quelli stessi messi in questione oggi dalla crisi economica e finanziaria. Abbiamo necessità di un “incidente” per comprendere che la strada dello sviluppo senza limiti è sbagliata? Che il potere e il successo non sono i valori primari di una vita? A questo proposito Olmi si è chiesto: “Quale sarà nel futuro il nuovo ordine di importanza che sostituirà il denaro al primo posto dei valori?” La spiritualità a cui pensa Olmi può dare un grande contributo a questa inversione di tendenza, come sta dimostrando il papato di Francesco: recuperare dalla tradizione alcuni valori – la solidarietà, l’affettività, la sobrietà – che possono essere condivisi anche dai non credenti e abbandonare, come fosse un rifiuto, il desiderio di onnipotenza che droga, ancora, l’umanità. C’è spiritualità in Giovanni dalle Bande Nere, protagonista di Il mestiere delle armi, che vive da eroe e che di fronte alla morte imminente dice: “Vogliatemi bene quando sarò morto” – che la sua memoria sia onorata dall’affetto. Il medesimo affetto che proverà “vedendo” il figlio cresciuto e mai conosciuto: allora le lacrime che non ha versato quand’era amputato e moribondo possono scendere senza vergogna. Il “mestiere delle armi” lo ha vissuto con dedizione e onestà, ha difeso la sua causa in condizioni di minorità militare, ma con grande spirito ed è stato sconfitto solo da un inganno. Di fronte alla morte la sua persona è integra: aspetta, come dice il sacerdote nell’estrema unzione, “più che le
sentinelle, l’aurora”. C’è spiritualità anche nella piratessa Ching di Cantando dietro i paraventi e nel figlio dell’imperatore che le propone il superamento della violenza e dello scontro frontale con il perdono e la gentilezza. A proposito di spiritualità laica, questo è il film nel quale Olmi mette a confronto più esplicitamente il pensiero maschile con quello femminile. Ma, almeno fino alla conversione finale della piratessa, a parti invertite. È la donna che incarna una relazione tipicamente maschile con il potere e la guerra, ed è il figlio dell’imperatore che ispirandosi all’antica spiritualità cinese è andato oltre questa visione materialista e le propone una via più femminile: il perdono. Nel momento cruciale della decisione, alla piratessa il segno spirituale arriva dagli aquiloni librati nel cielo dal figlio dell’imperatore che contengono frasi di saggezza. Questa antica saggezza tocca il cuore della donna, che dismette il ruolo di vendicatrice del marito ammiraglio per tornare alla sua originaria identità femminile ispirata alla gentilezza. Il film nel quale l’incontro tra spiritualità e vita quotidiana è più evidente, tanto da costituirne l’architrave, è La leggenda del santo bevitore. Qui vi sono due figure centrali che incarnano la dimensione spirituale: il misterioso uomo devoto di Santa Teresa di Lisieux – che dona più volte soldi ad Andreas, il clochard protagonista del racconto di Joseph Roth – rappresenta una spiritualità più tradizionale; mentre Andreas è l’emblema di un escluso dalla società e di una ricerca spirituale faticosa e mai conquistata definitivamente. Nella sua vita, apparentemente senza senso e che trascina da un ponte all’altro della Senna, compaiono piccoli miracoli e coincidenze che sono segni di un oltre, di un qualcosa che lo può riportare a un’esistenza più accettabile. Il riscatto non solo sociale ma interiore, può realizzarlo se fa i conti con il suo passato: la donna amata, l’omicidio perpetuato, gli amici non sempre fidati, i genitori. Se il medium di questo riscatto è il misterioso uomo devoto alla piccola Santa Teresa di Lisieux, il titolo del racconto di Roth ci indica che c’è una santità laica anche nel bevitore più accanito. Sulla genesi di questo film Tullio Kezich, critico cinematografico del “Corriere della Sera” e grande amico di Olmi, afferma che il regista si innamora istantaneamente del racconto, che non conosceva. La moglie di Kezich, Lalla, aveva avuto un’intuizione: aveva percepito che Olmi, uscito da poco da una grave malattia neurologica, era nello stato d’animo per poter apprezzare una storia un po’ surreale che metteva al centro i piccoli miracoli quotidiani. Forse questo aveva a che fare con la recente vicenda che aveva vissuto Olmi, con il suo timore di non poter più tornare a fare cinema e il desiderio di un riscatto. La coincidenza tra l’intuizione di Lalla Kezich e l’interiorità di Olmi danno vita al piccolo miracolo di questo film, che non a caso è costellato di coincidenze. Un altro film nel quale Olmi ha toccato il tema spirituale in un confronto serrato tra religiosità tradizionale legata all’istituzione e spiritualità laica collegata alla vita reale di tutti i giorni è Centochiodi. Questa tensione è rappresentata
efficacemente dalla figura del protagonista, il giovane assistente universitario che entra in una grave crisi esistenziale che lo porterà a lasciare l’università e gli insegnamenti del prete che fu il suo punto di riferimento spirituale. Nell’ultimo colloquio in università si trova di fronte una giovane studentessa indiana che incarna una spiritualità ancora vividamente legata al suo paese, ma che vuole andare oltre la tradizione: infatti, il suo tema di ricerca è il ruolo della donna nelle grandi religioni del mondo, la donna come tramite della volontà divina. Ma il giovane assistente non crede più alla religione come istituzione e considera che nella storia dell’umanità le religioni non hanno salvato il mondo, anzi sono state spesso causa di conflitti e guerre. Rifiuta parole e libri separati dalla realtà e va alla ricerca, forse anche un po’ semplicistica, di una natura e di un’umanità che contengano ancora qualcosa di autentico. Ha desiderio di una verità tangibile, di una vita più semplice dove alle parole seguono i fatti e le scelte sono radicali e coerenti. Olmi ci dà un ritratto di un giovane uomo la cui ricerca esistenziale è all’insegna di una ritrovata povertà, che non è miseria subita ma scelta consapevole di rinuncia. La rinuncia dei beni materiali in vista di un bene spirituale è uno dei grandi insegnamenti del Cristianesimo e Olmi sceglie di dar corpo a questo tema con la rinuncia del giovane assistente alla carriera universitaria, con riconoscimenti e guadagni. I vecchi del paese, che diventeranno i suoi nuovi amici, lo soprannomineranno Gesù. Un Gesù laico, molto attento e sensibile alla natura e consapevole del disastro che l’uomo contemporaneo sta mettendo in atto non rispettando i limiti ecologici del pianeta. Olmi fa scorrere la sua idea di spiritualità in passaggi poetici del film: le note di un famoso valzer che proviene da un barcone lungo il fiume, le candele poggiate ai lati della stradina del bosco, che illuminano oscurità e attesa. In Il villaggio di cartone Olmi entra nel vivo del tema spirituale contemporaneo, quello legato alla migrazione proveniente in particolare dall’Africa e al dialogo interculturale e interreligioso. Olmi mette a confronto due figure religiose: l’anziano sacerdote, disperato per l’abbattimento della sua chiesa, e il suo sacrestano, cinicamente disposto ad accettare il corso degli eventi. La differente disposizione spirituale è ancor più evidenziata dall’arrivo dei migranti, inseguiti dalla polizia. Qui Olmi ci parla con franchezza di una Chiesa che deve tenere aperta la sua porta al diverso e più debole perché quella, oggi più che mai, è la sua missione. In questa simbolica apertura la religione può trovare dei compagni di viaggio che sono rappresentati nel film dal medico non credente, ma solidamente ancorato a valori etici laici. Olmi sembra dirci che questo incontro e collaborazione tra un Cristianesimo non di facciata e l’etica laica è il meglio che l’Occidente può mettere in campo in quest’epoca così travagliata e piena di drammi umani, in primo luogo quello dei migranti che continuano a morire nel Mediterraneo, in quella che è stata la culla della cultura occidentale. Ma ci sono, per fortuna, segni di una nuova spiritualità in alcuni dei giovani migranti che hanno trovato riparo. Come il nero integrato che resterà nella chiesa fino alla fine
e che aprirà le porte alla polizia. Olmi sembra consegnare simbolicamente a lui le chiavi della futura chiesa, una chiesa aperta, accogliente che non ha paura perché non ha nulla da nascondere o da conservare gelosamente. E infine per Olmi spiritualità è anche rispetto per il lato misterioso della vita, che non va indagato e scoperto a tutti i costi ma semplicemente accettato. “Più noi togliamo il margine di mistero alla nostra vita e più diminuisce il nostro sentimento religioso, che è proprio legato al mistero delle cose. C’è una bella differenza tra il mistero di come funziona la televisione e il mistero di un albero che ogni primavera fiorisce e dà i suoi frutti. Il televisore è un problema subito risolvibile da un tecnico, il mistero di un albero è cosmico: nonostante i grandi telescopi spaziali non siamo ancora riusciti ad avvicinare il nostro sguardo nelle lontananze del mistero.”6 “Se dovessi rinascere, cercherei di capire di più gli animali, gli alberi, le stagioni, i colori, il giorno e la notte, l’ora che fugge. Gli uomini rimarranno sempre un enigma.”7
5. La poetica di Olmi Per Olmi fare cinema è parlare della vita e dei suoi umili protagonisti. C’è, nascosto nelle pieghe della quotidianità e di cose che normalmente diamo per scontate, un senso di poesia e di sacralità di cui non ci accorgiamo e che va colto e svelato. La narrazione di Olmi è indirizzata a storie minime – nella prima parte della sua produzione legate al mondo del lavoro, più avanti a figure storiche o ad altre raccontate in forma di apologo – di cui far esaltare un tratto archetipico e universale. A proposito della relazione tra vita e cinema e dei suoi esordi Olmi ha raccontato: “Le scelte della nostra vita non sono mai casuali: c’è sempre una riserva di emozioni, di ricordi, che, più di altri, le determinano. Ricordo due grandi emozioni: la prima risale all’incirca ai miei quattro anni di età, quando i miei genitori mi portarono a teatro. Era un teatro dell’oratorio, alla Bovisa, il quartiere operaio, intorno alla metà degli anni trenta. Ricordo l’emozione grandissima delle luci che si spegnevano in sala e del sipario che si apriva sulla scena. L’altra emozione risale ai miei quindici, sedici anni, quando, dopo aver cominciato a frequentare assiduamente gli spettacoli cinematografici del dopoguerra, con tutta la ventata di ‘americanità’ che si portavano dietro, vidi Roma città aperta. Quindi, la prima emozione mi lasciò una cotta per lo spettacolo, questo appuntamento tra pubblico e ribalta; la seconda mi permise la scoperta di un cinema diverso dalla commedia americana o dal film d’avventura, che facevano sognare le platee proponendo favole che si confondevano con la vita reale. Roma città aperta fu la scoperta di un cinema che era la vita, che non divideva lo schermo dalla strada, ma proponeva una continuità per mezzo di quel mediatore ideale che è, o dovrebbe essere, il poeta. Il cinema, quindi, è stato il mio secondo amore… Il cinema fu per me, più che un’emozione, una specie di ceffone liberatorio. La
sberla che presi da Roma città aperta mi mise in un rapporto diverso con tutto il cinema che, da spettatore, frequentai. Cominciarono le prime cotte per Grierson, la grande scoperta di Flaherty. Mi resi conto che andavo al cinema non più per sognare, ma per capire qualche cosa in più della vita.”8 Olmi non ama la retorica e il sentimentalismo: “Sentimentale è un aggettivo che non mi piace. Io sono un uomo ‘di sentimenti’. Una cosa è essere semplicisticamente buonisti, un’altra è avere a cuore il bene comune.” A mio parere, dall’inizio della sua carriera Olmi ha avuto come faro il bene comune e la speranza nell’uomo: “Il cinema è anche tutto questo, come la famiglia, come il lavoro: un atto religioso dell’uomo, l’affermazione della sua fiducia nella vita.”9 Dopo aver raggiunto il successo internazionale nel 1978 con L’albero degli zoccoli, nel giugno 1984 Olmi è colpito da una malattia neurologica rara che lo costringe, nel giro di tre giorni e per diversi mesi, all’immobilità e che gli impedirà in futuro di fare l’operatore di macchina da presa: una cosa cui teneva molto. È un momento capitale che mette a repentaglio la sua vita e la relazione con il cinema. L’imprevisto, l’“incidente” – metafora che aveva utilizzato nel film Un certo giorno – arriva anche nella sua vita e interrompe drammaticamente una carriera che era in pieno sviluppo. Olmi racconta così quell’esperienza: “L’ho detto anche a eminenti figure religiose, in quel momento non mi ha aiutato il sentimento religioso proprio di un uomo che ricorre a Dio per chiedere aiuto, mi ha aiutato piuttosto questa forte presenza d’amore da parte di mia moglie. Ho concluso dicendo: ecco sicuramente Dio vuole questo amore, non vuole che indirizziamo tanto i nostri sguardi, le nostre filosofie, i nostri ragionamenti, i nostri atti clamorosi o intimi a Lui, ma a colui che rappresenta Dio accanto a noi e cioè all’uomo che ci accompagna. Mi ha tormentato a lungo una malattia che mi faceva sentire le terminazioni nervose scoperte. E ho appreso, con un corpo trasformato in mortificazione e ingombro, quanto può essere eccezionale la normalità.”10 Come ha raccontato Olmi, la moglie Loredana rimane al suo fianco per sei mesi, giorno e notte. Esce da questa esperienza faticosamente ma rigenerato. Se per il manager di Un certo giorno, che ha smarrito la sua dimensione interiore, l’incidente non deve lasciar tracce e tutto deve tornare come prima, per Olmi avviene qualcosa di diverso. L’“incidente” rappresentato dalla malattia lo porta a una consapevolezza ancora più forte del sentimento della vita, dello stupore con cui accogliere ogni nuovo giorno, della spiritualità terrena che passa, prima di tutto, dall’amore. Quello del primo sguardo tra sua madre e suo padre, quello che gli ha rivolto la moglie in quei lunghi mesi, quello altrettanto caro di figli e amici. E i nuovi frutti artistici di questa consapevolezza arrivano. Toccherà altri vertici della sua arte con film come La leggenda del santo bevitore, Il mestiere delle armi, Cantando dietro i paraventi. L’incontro tra quotidianità e spiritualità sarà l’architrave anche dei film più recenti. Olmi esalta il lato poetico e sacrale della vita di tutti i giorni con personaggi minimi e che fanno scelte controcorrente: il
clochard di La leggenda, il giovane assistente universitario di Centochiodi, l’anziano sacerdote di Il villaggio di cartone. La sensibilità spirituale e amorosa di Olmi si incarnerà vividamente nel santo bevitore che riesce in extremis a dare i soldi a Santa Teresa, nel capitano di ventura che piange il figlio sconosciuto, nella piratessa che accetta il perdono, nel giovane docente che preferisce un caffè con un amico ai tanti libri, nel sacerdote disperato ma non rassegnato, nella sacralità della natura, del pane e dell’acqua. “Queste dunque sono le tre condizioni dell’uomo: l’uomo di fede che, come un bambino innocente, accetta di tutto e si affida completamente all’adulto (che ha il dovere di non tradirlo); l’intellettuale che accetta di essere guida percorrendo però a volte i sentieri della convenienza piuttosto che quelli che portano alla ricerca della verità; il poeta e l’innamorato, in questo disagio continuo dello smarrimento. Io aspiro, senza averne la forza o la convinzione, ad appartenere a questa straordinaria categoria.”11 A seguire sono presentati, con sinossi e commenti, i documentari e i lungometraggi più significativi dell’opera di Ermanno Olmi. “I registi degli anni ’60. Ermanno Olmi”, in Vittorio Spinazzola (a cura di), Film 1962, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 169-170. 2 Ermanno Olmi, L’Apocalisse è un lieto fine. Storia della mia vita e del nostro futuro, Milano, Rizzoli, 2012, p. 86. 3 Ivi, p. 84. 4 Ivi, p. 73. 5 Citato in Ermanno Olmi, Lettera a una Chiesa che ha dimenticato Gesù, Milano, Piemme, 2013. 6 Ermanno Olmi, “Sono un aspirante cristiano”, in Giampaolo Mattei, Fabrizio Contessa, Il cinema e la fede. La messa è finita?, Torino, Elle Di Ci, 1995. 7 Ermanno Olmi, L’Apocalisse è un lieto fine. Storia della mia vita e del nostro futuro, cit., p. 233. 8 Emma Neri, “Conversazione con Ermanno Olmi”, in AA.VV., EuropaCinema ’85, Rimini, 1985. 9 Ibidem. 10 Donata Righetti, Olmi 2100, incontro ravvicinato con Socrate, “Corriere della Sera”, 21 agosto 2000. 11 Emma Neri, “Conversazione con Ermanno Olmi”, cit. 1
TERZA PARTE
I DOCUMENTARI
I DOCUMENTARI DELLA SEZIONE CINEMA DELLA EDISONVOLTA
Per Ermanno Olmi la Edison è stata, negli anni cruciali della sua formazione, un punto di riferimento essenziale. Durante la guerra la Edisonvolta aveva fatto sfollare tutti i figli dei dipendenti dalle grandi città del Nord che erano sottoposte a continui bombardamenti e li aveva portati nella colonia di Suna a Pallanza, sul Lago Maggiore, dove Olmi vivrà per due anni. L’ultimo anno di guerra lo passerà invece a Milano perché aveva già quattordici anni. In quel periodo suo padre muore per le conseguenze di un bombardamento e sua madre viene immediatamente assunta al suo posto perché la Edisonvolta, come allora usava, si fece carico della famiglia. L’azienda per Olmi perciò non è semplicemente un luogo di lavoro ma una grande famiglia, vissuta con un forte senso di appartenenza. L’ha definita, in riferimento agli anni del dopoguerra, “il suo paese”. Olmi deve molto alla Edisonvolta anche per la sua prima formazione cinematografica. È grazie a essa che, partendo da una prima esperienza teatrale nella Filodrammatica del dopolavoro dell’azienda, può fare quell’apprendistato sulle macchine da presa che risulterà decisivo per la sua carriera cinematografica. La Edisonvolta gli dà l’opportunità di realizzare i suoi primi documentari industriali fornendogli via via nel tempo l’attrezzatura necessaria a cimentarsi come giovane documentarista attorno a un tema – le nuove dighe e gli impianti idroelettrici – che sono un simbolo della nuova industrializzazione del paese. I documentari di Ermanno Olmi, dedicati al mondo del lavoro, si sviluppano nell’arco di tempo 1953-61. Gli ultimi – Le grand barrage e Un metro lungo cinque – saranno realizzati in contemporanea con Il posto, il suo secondo lungometraggio. Nella Sezione Cinema della Edisonvolta, Olmi metterà insieme una rete di valenti collaboratori come gli operatori Lamberto Caimi e Roberto Severo, la montatrice Carla Colombo, gli organizzatori Walter Locatelli e Alberto Soffientini, il musicista Pier Emilio Bassi. In quegli anni dialoga e coinvolge nei suoi progetti figure intellettuali come Pier Paolo Pasolini, Goffredo Parise, Tullio Kezich. LA DIGA DEL GHIACCIAIO Produzione: Sezione Cinema Edisonvolta, 1955.
Questo documentario è girato, in uno splendido bianco e nero, nell’Alta Val Formazza, a quasi 2.000 metri. All’inizio del filmato Olmi fa vedere la chiesetta di Riale eretta a ricordo di quella rimasta sommersa nel lago e dedicata agli operai caduti sul lavoro durante la costruzione della grande diga di Morazzo. Queste prime immagini sono un riconoscimento simbolico che Olmi intende dare al mondo del lavoro, ponendo l’accento sulle tante vite occorse per la costruzione delle dighe in alta quota. Il documentario è dedicato a un nuovo importante impianto idroelettrico, il più alto di tutta la vallata e riprende con grande dovizia di particolari la storia e le fasi iniziali della sua costruzione. È tutto un avvicendarsi di lavori con badili, picconi, martelli pneumatici, carrucole, vagoncini per trasportare sassi e terra che Olmi sottolinea nella loro materialità e anche sonorità, come avviene con il fragore delle mine che scoppiano sui fianchi della montagna. Sono lavori molto umili e faticosi, ma allora insostituibili. Ogni tanto c’è il momento, quasi sacro, di una pausa e di una sigaretta fatta a mano. Il tema del documentario è quindi quello del lavoro manuale e della sua durezza, ma è anche quello della solitudine di questi uomini e dalla lontananza delle famiglie. Tra uomini, specie in quei tempi, le confidenze erano difficili da farsi. Il commento del documentario mette bene in evidenza questa condizione: “Si sono sentiti soli la sera e hanno girato e rigirato tra le mani l’ultima cartolina ricevuta da casa. Noi stiamo bene e così speriamo di te, c’era scritto. Ed era il conforto dei milleduecento uomini del Sabbione, uomini che si sentivano soli e che hanno vissuto a 2.500 metri per cinque lunghi anni di lavoro.” Attorno la natura, maestosa, silenziosa, da rispettare e temere. MANON FINESTRA 2 Testo: Pier Paolo Pasolini. Produzione: Sezione Cinema Edisonvolta, 1956. “Val di Fumo, nell’Alto Chiese, ai piedi dell’Adamello. Sta nascendo tra queste montagne uno degli impianti idroelettrici più grandi d’Europa. La valle è infatti ricchissima di acqua che discende dai ghiacciai dell’Adamello. Tutta l’acqua della valle verrà raccolta in immensi bacini dai quali, attraverso una serie di gallerie scavate nella montagna, verrà incanalata nella condotta forzata che la porterà alle pale delle turbine. Qui sono in costruzione cinque dighe e quattro centrali di cui una, la più imponente, quella di Cimego, avrà le turbine più grandi del mondo. Per scavare le gallerie si sono operati lungo le pareti della montagna dei fori che nel gergo dei minatori si chiamano finestre.” Una sirena suona, seguita dalle campane e dal cinguettio degli uccellini, uomini con picconi attraversano un torrente illuminato dall’arcobaleno mentre le mine scoppiano su un versante della montagna. Così inizia uno dei documentari più poetici di Olmi dedicati al mondo del lavoro. Anch’esso fa parte dei cortometraggi girati per la Edison. Il documentario è stato una delle due occasioni della collaborazione con Pier Paolo Pasolini,
conosciuto nel 1956 a Roma insieme a Goffredo Parise. Pasolini scrive il testo che accompagna questo filmato e collaborerà in seguito anche a un altro documentario, Il grigio. La macchina da presa segue i minatori nei loro diversi turni di lavoro dentro la miniera. I minatori arrivano silenziosi e aspettano gli ordini del caposquadra per il nuovo turno. Il tema centrale del documentario è la solitudine degli operai che sono arrivati dalle valli vicine, dalle pianure lombarde o addirittura dal meridione. Il testo di Pasolini poeticamente lo sottolinea: “Sono qui, soli, in questa specie di esilio così vicino al cielo e dal cielo così lontano, nelle viscere della montagna.” Olmi ferma gli sguardi assorti, e anche un po’ timorosi, dei minatori prima dell’ingresso nella miniera. I loro pensieri vanno alle famiglie e a ciò che è caro e lontano. C’è una loro gentilezza del cuore che ha dato un nome al foro scavato nella montagna: “finestra Manon”, come se il foro fosse parte di una casa. È la stessa gentilezza d’animo che fa sì che non manchino mai i fiori al quadro di Santa Barbara posto vicino, in una piccola cappella. Il lavoro inizia, si entra guidati dalle torce ed è uno scatenamento di martelli perforatori. Come in tutti i film di Olmi la parte fonica è molto curata così da sentire distintamente tutti i rumori relativi alle diverse fasi di lavorazione, come il posizionamento delle mine negli anfratti della roccia. Le mine scoppiano con fragore e aprono il varco alle ruspe, i minatori continuano a perforare senza proferir parola. Quando il lavoro ha termine e i minatori escono all’aria aperta è come rinascere. Là fuori c’è la natura, il sole, gli aromi dei boschi e della campagna. Il testo di Pasolini conclude così il documentario: “Cose che sembrano improvvisamente nuove, come se non si fossero mai viste. Fortune anch’esse, gioie domenicali.” È la riscoperta dell’eccezionalità della vita e la gioia di cose quotidiane che si danno troppo spesso per scontate e di cui non ci si accorge più. In questo caso la natura, ma anche la salute fisica, gli affetti. Il minatore che riemerge all’aperto è un simbolo con il quale Olmi ci fa riflettere sulla freschezza del nuovo giorno, sullo stupore che proviamo quando ci facciamo sorprendere dal già conosciuto, ma mai uguale. IL PENSIONATO Produzione: Sezione Cinema Edisonvolta, 1958. La vecchia e rumorosa sveglia segna le 22.50, il pensionato è a letto con la moglie, si gira e si rigira tra le coperte disturbato dal rumore di una macchina tipografica. Inveisce in dialetto milanese: “Te sentet no che bacan che fan! (Non senti che baccano fanno!).” Spazientito si alza: “Ades voo fora e ghe ne disi quater. L’è ora de finila! (Adesso vado fuori e gliene dico quattro. È ora di finirla!).” E la moglie apostrofa: “Ma fa no el sufistic (Non fare il sofistico).” Così inizia questo documentario che vuole rappresentare lo scontro generazionale tra un operaio pensionato e i giovani tipografi che devono finire un
lavoro di notte. Il tutto si svolge nel cortile di una casa di ringhiera. Giuseppe Bonfanti è stato meccanico presso le Officine del Gas, considerato da tutti un simpatico brontolone e temuto dagli apprendisti. Quando arriva però l’ultimo giorno di lavoro si commuove come un bambino. Dopo trentacinque anni di lavoro c’è l’inoperosità, il vuoto. Ha tanto tempo libero ma non sa come utilizzarlo, è lì che osserva dalla sua ringhiera il mondo che va avanti senza di lui. I giovani tipografi al lavoro, i bambini che schiamazzano. Fino a quando si accorge delle difficoltà dei tipografi a svitare un bullone. Inizia così una sorta di collaborazione nella tipografia che lo porterà a restar lì anche oltre la mezzanotte. Di fronte alle rimostranze della moglie per l’ora tarda risponde: “Cosa gli danno domani ai clienti? Le dita negli occhi? ’Sti pover fioeu! (Questi poveri figlioli).” Olmi ci fa vedere la metanoia, la conversione che il pensionato ha nella relazione con i giovani operai. Da brontolone un po’ invidioso a maestro di officina che, inaspettatamente, può mettere a disposizione la sua decennale esperienza. Accettato come guida dai giovani non si risparmia, non c’è più orario che tenga. La passione che lo aveva guidato nel suo lavoro alle Officine del Gas vive una nuova stagione. Olmi ci propone visionariamente temi – il rapporto tra generazioni differenti e la passione per il lavoro – che sono di grande attualità.
ALTRI DOCUMENTARI
DIALOGO TRA UN VENDITORE DI ALMANACCHI E UN PASSEGGIERE Soggetto: dall’Operetta morale di Giacomo Leopardi. Produzione: RTC, 1954. In questo documentario Olmi tocca un tema – quello del tempo e della sua qualità – che sarà l’epicentro del suo primo lungometraggio, Il tempo si è fermato, e che poi svilupperà in altri film. Ciò che lo ha interessato dell’Operetta morale di Leopardi del 1832 è proprio il confronto e la riflessione sulle diverse identità del tempo: quello cronologico, il nuovo anno solare, e quello interiore con le insoddisfazioni avute nella vita vissuta e le aspettative per il futuro. L’incipit del documentario mostra la campagna innevata e immersa nella nebbia fuori Milano. Due uomini ben intabarrati camminano su un viottolo di campagna. Hanno con loro zampogna e piffero e si dirigono verso la città. Passano sotto un ponte ferroviario tra tram, camion e una fitta nebbia. Cercano un luogo, su un marciapiede, dove poter suonare le loro musiche e raccogliere qualche spicciolo. Il loro posto di lavoro è lì, in strada. Lo trovano in una via di periferia, ma nel momento in cui stanno iniziando a suonare il loro sguardo incrocia, dall’altra parte del marciapiede, quello di un altro suonatore di strada che sta avviando la pianola con le sue malinconiche nenie. Lo sguardo dei due musicisti di campagna è attonito e quasi intimorito, quello dell’organista è implorante e, insieme, quasi aggressivo. Vuol far capire loro che quel posto nebbioso e con poco passaggio è comunque il suo. I due musicisti scambiano uno sguardo d’intesa e sconsolati se ne vanno. Olmi ci parla, senza necessità di parole ma solo con sguardi intensi, di un’umanità povera ma ancora dignitosa. In quegli sguardi si colgono antichi valori, in primo luogo il rispetto dell’altro. È una metafora potente e sempre attuale sulla “guerra dei poveri”. Il Natale è alle porte, le vetrine illuminate sono piene di desideri da soddisfare. In un sottopassaggio una serie di ambulanti offrono ai passanti: almanacchi, cartoline con gli auguri di buon anno, bolle di sapone per bambini. Un passante si avvicina al vecchio e malandato venditore di almanacchi e dà vita al celebre dialogo di Giacomo Leopardi. Il “passeggiere” inizia con la domanda: “E credete che sarà felice l’anno nuovo?” Il dialogo ruota attorno all’insoddisfazione per la
vita passata e termina con la domanda: “E che vita vorreste?” a cui il venditore risponde laconicamente: “Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti.” La conclusione del “passeggiere” è: “Quella vita bella che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce, non la vita passata ma la futura.” Olmi ambienta questo dialogo leopardiano nel sottopassaggio di una città, simbolo di una società che sta cambiando velocemente, dando così la sensazione di una sospensione surreale, come se la riflessione sul tempo potesse dipanarsi in qualsiasi luogo e tempo, in un istante di eternità. Intorno, il carosello del nuovo consumismo impazza, fa “il suo giro”. E pur tuttavia è sovrastato dal suono delle campane. MILANO ’83 Produzione: Trans World Film in coproduzione con Rai, Regione Lombardia, Comune Milano, Provincia Milano, Camera di Commercio, 1984. Il documentario, prodotto dalla Rai, doveva far parte di una serie dedicata alle capitali europee. Nelle intenzioni dei poteri pubblici e privati di allora doveva essere una celebrazione della “Milano da bere”: la Milano che aveva fatto seguito, andando all’estremo opposto, a quella mortifera degli anni di piombo. Ma Olmi, con una magistrale interpretazione, fa sparire quella Milano inebriante e “di cartone”, e realizza un ritratto dell’anima popolare di Milano: l’essenza della città colta nelle sue strade tra la gente comune. Ancora una volta, come nei primi documentari, i protagonisti sono le persone normali nella loro quotidianità. Non c’è commento verbale alle immagini che si susseguono come narrazione dell’anima cittadina. Il film inizia dal luogo d’eccellenza di Milano: il Teatro alla Scala nella sera della prima di Ernani, la celebre opera di Giuseppe Verdi, con il pubblico festante nel foyer, tra cui si scorge l’étoile Carla Fracci. Come contraltare al grande teatro musicale, Olmi riprende la città che lavora anche di notte: operai e saldatori dei binari del tram, netturbini che con potenti getti d’acqua puliscono i monumenti. Per Olmi è l’altra eccellenza ambrosiana: il culto del lavoro onesto e fatto per bene. Poi c’è l’umanità che quando è ancora buio si appresta ad andare a lavorare o studiare: su un treno pendolare lavoratori scherzano in dialetto milanese, molti leggono un libro, altri sono immersi nei loro pensieri. Arrivano in città che non è ancora l’alba, la nebbia avvolge tutto, mamme e papà accompagnano i figli infagottati all’asilo, cambiano loro le vestine, li abbracciano, ridono prima di lasciarli. Sono le otto, la città inizia a pulsare, i passanti già corrono, alcuni hanno valigie legate con lo spago, altri mangiano nei bar nella pausa lavorativa, e cortei sfilano con campanacci e bandiere rosse invocando “il contratto subito”. Giovani innamorati si baciano nel parco, altri vanno a scuola di danza, altri
ancora hanno scritto frasi d’amore sui muri. Una donna si trucca su una panchina del parco, due anziane cantano un motivo d’epoca in una casa fatiscente di ringhiera cosparsa di panni stesi come in un rione di Napoli. Bambini giocano a pallone in uno spiazzo di terra battuta, il Naviglio coi suoi ponti è immerso nella nebbia, prostitute si scaldano col calore di un fuoco, basiliche e monumenti stanno nella loro sacralità, lo stadio di San Siro urla i suoi cori, petardi scoppiano come bombe di guerra, la voce di Enrico Ameri in Tutto il calcio minuto per minuto riempie le solitudini domenicali. Gli animali stanno stancamente nello zoo, un vecchio dà da mangiare ai piccioni, bimbi si travestono e si truccano per le feste imminenti. Arriva il Natale, la banda comunale suona nelle strade, i Navigli sono illuminati dalle luminarie, tutta la città brilla di luci e negozi invitanti, la Rinascente brulica di gente che va su e giù per le scale mobili, le donne si fanno belle dal parrucchiere e si tengono in forma in palestra, i salumieri esibiscono portentosi cotechini e zamponi, un corteo illuminato da torce arriva in piazza del Duomo, scoppiano i fuochi d’artificio, si festeggia l’anno nuovo. Sembra un grande circo, il circo della città con il suo lato frizzante, l’ebbrezza, l’illusione. Poi, dopo i bagliori del Capodanno tutto si ferma, torna alla normalità, i giovani dicono con semplicità il loro nome, un altro giorno arriva. È il ritratto dell’umanità di Milano vista con gli occhi di Olmi, attenti alle cose e ai volti della quotidianità. La Milano del 1983 che interessa a Olmi – e che, non a caso, assomiglia molto a quella degli anni sessanta – è questa: la quotidianità, la semplicità, la povertà, non la miseria. I protagonisti sono gli umili della città: i lavoratori, i bambini, i giovani innamorati, le donne, gli anziani, persino gli animali dello zoo. I potenti, i poteri forti, il mondo della finanza, il terziario avanzato, la pubblicità, la moda, le diverse apparenze della “Milano da bere” sono – almeno per un momento – svanite, evaporate, scomparse, come per una grande magia (come suona il titolo di una bella commedia di Eduardo rappresentata al Piccolo Teatro di Milano proprio in quegli anni, con la regia di Giorgio Strehler e l’interpretazione magistrale di Franco Parenti). Questa, invece, è la “grande magia” di Olmi per la sua Milano. LUNGO IL FIUME Produzione: Cinema 11 Undici/Rai Uno, 1992. Il documentario – accompagnato dalle musiche della Messa di Georg Friedrich Händel – è dedicato al Po e al suo ecosistema naturale composto di gabbiani, anatre, aironi, caprioli. All’inizio compaiono dei versetti di Isaia 40, 5: “Si rivelerà la magnificenza della creazione, e ogni uomo la vedrà…” Il film è costellato da testi ispirati dal Vangelo di Giovanni. Il primo è indicativo del senso non solo ecologico ma spirituale della ricerca di Olmi e dell’importanza che egli dà al rapporto con la natura, in questo caso con il fiume.
“Il regno della Creazione è sparso su tutta la Terra e gli uomini non la vedono. Se coloro che vi dirigono vi dicono: ecco il mistero della Creazione è nelle altezze del firmamento, allora gli uccelli del cielo vi precederanno, se vi dicono: è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno invece è dentro di voi e fuori di voi, quando conoscerete voi stessi allora saprete quale fu la vostra vera fonte di vita, ma se non vi conoscerete allora sarete nella povertà, voi stessi sarete la povertà. Colui che conosce tutto ma non conosce se stesso ignora tutto. Quando in voi stessi genererete ciò che avete esso vi salverà. Se in voi stessi non avete nulla ciò che non avete vi ucciderà. Da tanto tempo sono con voi e voi ancora non mi avete conosciuto. Io sono mandato a portate la vita e non mi accogliete. Gli altri si presentano di propria autorità, allora li ascoltate. Com’è possibile che possiate apprezzarmi voi che mendicate sicurezza gli uni agli altri e non vi fidate del bene che viene da tutto ciò che è stato creato e vive intorno a voi? Non sarò io ad accusarvi, ma è la vita stessa che vi accusa.” Il fiume scorre lento e lentamente scorrono le immagini della vita dentro e attorno a lui. Passa una grande chiatta, i pescatori pescano sulla riva circondati dalla nebbia azzurrina, gli uccelli e le campane del paese cantano. È inverno: alcune case hanno il tetto scoperchiato, una macchina giace riversa nella campagna, molti tronchi di alberi sono stati tagliati, un cane abbaia. Uomini lavorano sulla chiatta e su una gru, un vecchio osserva, un camion si allontana con il suo carico, le ciminiere delle fabbriche sbuffano non lontano dai bellissimi filari di pioppi, un pescatore trascina a fatica una piccola barca nel fango, un gregge di pecore si avvicina all’argine, cavalieri a cavallo passano nel bosco, la pioggia battente increspa il fiume, riflessi dorati e argentati emergono dalle onde, e poi uno stormo di uccelli, poltrone di cinema abbandonate in campagna, l’acqua di un torrente di montagna scende allegra a valle, aquiloni volano alti nel cielo. Tutto permane e tutto scorre nel silenzio della natura. Arriva la primavera: margherite e fiorellini violetti, il bosco si rianima, pesci a filo d’acqua, farfalle felici, uccellini si passano il cibo. Poi l’estate: uomini segano e tagliano alberi, un elicottero sparge il diserbante, scavatrici e gru spostano grandi massi lungo gli argini, vecchie chiatte arrugginite abbandonate e ricoperte di vegetazione, il paese deserto nella calura estiva, le cicale friniscono, voci allegre di donne e bambini, gialli campi di grano, uomini in canottiera osservano il fiume, il picnic domenicale di bagnanti con ombrelloni e asciugamani sulla sabbia del Po, una barca passa sulle note di un valzer. È notte: imbarcazioni illuminate con torce, fuochi d’artificio, musiche di banda. Dopo la festa restano i residui e i rifiuti umani: una lampadina, un barattolo, un tronco incatenato. Arriva il temporale: tuoni e fulmini nel cielo, le acque si intorbidiscono, scrosci impetuosi di pioggia, il fiume in piena. Un altro testo ispirato dal Vangelo di Giovanni: “A volte la natura sembra compiacersi nell’ostentare la sua forza distruttiva, all’improvviso insorge e
trasgredisce ogni regola, sovverte l’ordine come se volesse ribellarsi alle leggi della creazione… In verità vi dico: la natura non fa da sola cosa alcuna che non abbia preso dalla vita stessa da cui ha avuto origine. Quello che fa lo fa secondo ciò che si compie nell’infinità del cosmo.” Ecco che un tramonto d’oro fiammante scende sul Po, la notte incantata è scandita dal canto dei grilli e illuminata dai raggi di luna: in questo splendore del mondo si ascoltano le parole di Gesù condannato, che si rivolge agli apostoli. E infine, il Po che sfocia nel mare. Olmi sembra dirci che tutto è sacro perché tutto esiste – una parte della natura a fianco all’altra – senza gerarchia, senza arroganza. Le stagioni si susseguono, tutto ritorna, tutto scorre, come il fiume destinato a raggiungere il grande mare. RUPI DEL VINO Produzione: Ipotesi Cinema, Fondazione ProVinea, con Banca Popolare di Sondrio, Provincia di Sondrio, Fondazione Cariplo, 2009. Il documentario nasce da un’idea dell’economista d’impresa Marco Vitale, grande conoscitore della Valtellina e amico di Ermanno Olmi. Vitale propone al regista di realizzare un ritratto della valle, con i suoi particolari vitigni e le forti tradizioni enologiche. Il filmato è dedicato a Mario Soldati e al suo libro L’avventura in Valtellina. Per cogliere l’insieme della bellezza della Valtellina e dei suoi vitigni terrazzati e incuneati tra le rocce, Olmi ha girato il film durante le quattro stagioni. Un elicottero trasporta dentro a un cassone di legno un pianoforte su un alpeggio dove si terrà un concerto, vicino a un laghetto di montagna, cui assisteranno dei giovani. Inizia così il documentario di Olmi che è commentato da brani letterari dedicati alla Valtellina. Da quelli di Mario Soldati (“Per chi arriva dalla via del Lago di Como alle sei del pomeriggio da giugno a settembre è l’ora trionfale della Valtellina…”), allo storico bormiese Gioacchino Alberti (“Questa terra abbonda di castagne e di vini squisitissimi della bontà dei quali molti storici parlano, sia antichi come moderni”), a Indro Montanelli (“Questa gente vive soprattutto di due cose: di vino e di onestà. Il vino lo spremono da certe vigne inerpicate a terrazze sui fianchi della montagna, l’onestà è quella che impedisce ai benestanti di diventare ricchi e ai poveri di diventare miserabili”). Scorrono immagini di operai che intagliano grandi pietre, ponti romani, paesi, chiesette, boschi che danno l’idea di un territorio ancora integro. Per entrare nel vivo delle tradizioni enologiche della valle il filmato è accompagnato dai brani dei Ragionamenti di agricoltura (Sondrio, 1752) del pittore Pietro Ligari. Si parla delle cantine tipiche, i crotti, della legislazione che sovrintende al lavoro dei tavernieri dell’epoca e delle diverse fasi di lavorazione nei vitigni, di cui il più nobile è il Nebbiolo. Per preservare i vitigni sono fondamentali i lavori invernali: a novembre con lo
sradicamento dei roveti e il trapianto di nuove viti, a dicembre con l’allestimento di muraglie di pietra ben asciutta per proteggerli dal gelo, a gennaio con le grandi pietre spaccate per conquistare nuovi terrazzamenti. Attorno, nella valle, Olmi riprende – accompagnati dal suono delle campane – affreschi della Madonna con il Bambino, chiesette immerse nella nebbia, rigogliosi torrenti di montagna, la neve che scende copiosa sui vitigni, le antiche botti con vini pregiati: Sforzato, Sassella, Inferno, Grumello. La chiamano “la viticultura eroica”, a significare l’eccezionalità dell’opera umana in un territorio non facile: da Ardenno a Tirano si trova la più vasta area terrazzata d’Europa protetta da duemilacinquecento muretti a secco. L’elicottero fa la spola per trasportare nuova terra per i terrazzamenti. Ogni terrazzo è un piccolo miracolo di ingegneria. I precursori più probabili sono stati gli Etruschi che, secondo Enzo Biagi, erano “bevitori affatto zotici, sapevano distinguere e apprezzare”. La primavera si avvicina, a marzo si piantano tranciaroli di viti. Si scorge la strada panoramica del Passo San Marco che si chiama così perché, quando il bergamasco apparteneva alla Repubblica di Venezia, era il transito tra la Valtellina e Venezia. È la valle del Bitto, il formaggio essenziale per il tipico piatto valtellinese, i pizzoccheri, che è buono anche giovane. Ghiacciai morenici, cascate impetuose, alpeggi immacolati: è la Val Malenco, la principale vallata, che prende il nome dal fiume Mallero che attraversa Sondrio per poi confluire nell’Adda. Risalendo il Mallero si giunge a un’ampia conca morenica, dove si ergono vette oltre i 3.500 metri che dal Monte Disgrazia vanno oltre il Bernina. Più in là ci sono i laghi artificiali di Campo Moro con la perfetta piramide del Pizzo Scalino. Dalla parte opposta c’è la Val Poschiavina e la meraviglia del trenino rosso che da Tirano passa dal Bernina per arrivare a Saint Moritz. Sul trenino che sferraglia, imbiancato dalla neve, compare un valtellinese purosangue e grande compagno spirituale di David Maria Turoldo: è Camillo De Piaz. La tradizione religiosa della Valtellina è sì cattolica ma anche autonoma e molto tollerante. I Comuni della valle furono anche i primi a sconfiggere l’analfabetismo. Arriva l’estate, è giugno e si procede a sgarzolare le viti mentre mandrie di mucche stazionano negli alpeggi. Siamo ora nella Val Masino con i suoi famosi Bagni e il secolare albergo costruito ai primi del Settecento. Qui c’è la meravigliosa acqua calda termale che sgorga dalla roccia quasi smaltata. È piena estate, nelle vigne si continua a sgarzolare e a dare un po’ di aria alle viti per favorire la maturazione dell’uva. È mezzogiorno, nella calura estiva tutto è immobile, vuoto, silenzioso, scorre solo la corrente dell’Adda. Arriva un bel temporale estivo, ci si ripara sotto le baite, le acque del torrente diventano impetuose. Il pittore Pietro Ligari racconta che è stato lontano dalla Valtellina per ben trentasei anni e torna felice nella terra natale. Racconta del rione Scarpatetti a Sondrio, il quartiere più antico della città, con
bellissime case di pietre, archi e un’edicola che custodisce un piccolo altorilievo in legno colorato: la Madonna con il Bambino, ed entrambi hanno in mano grappoli di uva nera. Scorrono immagini di uva nera e rigogliosa di vita, è il tempo della vendemmia e mani sapienti raccolgono i grappoli, è il prezioso raccolto dopo le fatiche di tutto l’anno. Olmi ci mostra la sacralità della terra e dell’uomo che la coltiva e la rispetta, scorrono i volti dei contadini, vecchi e giovani: volti sinceri, puliti, naturali. Quello di Olmi è un ritratto poetico di un territorio e di un’umanità particolari che si ricollegano simbolicamente ai suoi primi documentari. Anche qui c’è una forte presenza della natura – i vigneti, la montagna – ed è presente l’altro elemento fondamentale: il lavoro umano, con la sua sapienza e dignità. In Valtellina è quello dei contadini che lavorano la terra dei dirupi. Dirupi che l’arte, la pazienza, la sensibilità di quegli uomini hanno trasfigurato nelle “rupi del vino”. Il film si conclude con la scritta “Dove c’è vigna c’è civiltà” e la voce di Ermanno Olmi che legge un brano di Oddone Colonna, papa Martino V, del 1434: “Cinque sono i motivi per bere: l’arrivo di un amico, la bontà del vino, la sete presente e quella che verrà, e qualunque altro.” TERRA MADRE Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi con il contributo di Carlo Petrini. Franco Piavoli e Mario Piavoli hanno realizzato L’orto di Flora; Maurizio Zaccaro ha realizzato L’India di Vandana Shiva. Produzione: Cineteca di Bologna, Ipotesi Cinema, IBC Movie, Rai Cinema con MiBac, Slow Food, 2009 Interpreti: Omero Antonutti (voce narrante), Carlo Petrini, Vandana Shiva. Il documentario inizia con le riprese amatoriali di un orto scolastico nel 2008 e la voce di Omero Antonutti che legge – come epigrafe del film – un passo dalle Georgiche di Virgilio: un vecchio lavora un po’ di terreno abbandonato e con le sue coltivazioni “è in grado di pareggiare le ricchezze dei re”. La parte iniziale del film è dedicata a Terra Madre, la manifestazione biennale ideata da Carlo Petrini e Slow Food. Alla seconda edizione del 2006 partecipano oltre milleduecento comunità di contadini, pastori, nomadi, pescatori provenienti da centocinquanta paesi, uniti dalla volontà di difendere la agro-biodiversità. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, nella presentazione della manifestazione illustra l’obiettivo di fondo di Terra Madre ponendosi la domanda: “Qual è il seme che bisogna piantare? È quello della pratica dell’economia locale per accorciare la distanza nell’alimentazione tra produttori e consumatori. Solo così possiamo difendere sul serio il futuro di Madre Terra che è la nostra casa comune.” Si susseguono gli interventi di diversi rappresentanti delle comunità agricole: da quello di Moises Quispe Quispe, agronomo che parla a nome delle etnie discendenti dagli Inca che si sentono “umili servitori e custodi della biodiversità”,
alla scrittrice Aminata Traoré che racconta storie di emigrazione, dolore e morte mentre scorrono i primi piani di volti severi e dolenti di chi quelle storie le conosce per esperienza diretta. L’intervento più atteso è quello di Vandana Shiva, fisica ed ecologista indiana che tocca il tema delle contraddizioni dell’alimentazione mondiale: da una parte l’iperproduzione e conseguente obesità dell’Occidente e dall’altra la malnutrizione delle parti più povere del pianeta, in primis l’Africa. Vandana Shiva è diventata nota in tutto il mondo per la sua lotta decennale in difesa delle sementi originarie dell’India contro i brevetti delle stesse da parte delle multinazionali, in particolare la Monsanto. Una privatizzazione che ha portato in molti casi all’indebitamento e al suicidio di contadini indiani che non riuscivano più a sostenere i costi dei semi geneticamente modificati. Il filmato riprende l’inaugurazione nel 2008 della Banca mondiale dei semi costituita dal Fondo mondiale per la diversità delle colture nelle Isole Svalbard al largo della Norvegia. La Banca, che è posta sotto un consistente strato di permafrost, è nata con lo scopo di creare una sorta di “arca” dei semi da custodire prima che deperiscano a causa del cambiamento climatico; i semi all’inizio erano duemilaseicento con l’obiettivo di arrivare a quattro milioni. Ora scorrono immagini lievi e poetiche, accompagnate da musiche per organo di Bach, di uccelli sui fili dell’alta tensione e api che impollinano fiori. Nella seconda parte del documentario viene raccontata la vicenda di un contadino del Nord-Est, Ernesto, che per oltre quarant’anni ha vissuto da solo in un podere di tre ettari senza luce, gas, telefono. L’uomo è un bravo falegname che costruisce tutto ciò che gli abbisogna: sedie, vanghe, rastrelli. È totalmente autosufficiente e lavora la terra senza l’uso del trattore o di antiparassitari.12 La voce di Omero Antonutti commenta: “Povero eppure ricco, ha saputo trarre dal poco, molto.” E continua: “Un pomeriggio di novembre, la porta è aperta, non sappiamo quando ha consumato l’ultimo pasto.” Tutto nella casa è abbandonato, ha lo struggimento della polvere, di ciò che è stato vivo e ora assiste al proprio declino. Lì, fuori dalla casa, attorno a un tavolo di legno, vi sono uomini e donne di cultura e scienza a dibattere il presente e il futuro della questione ecologica alla luce dell’esperienza del contadino del Nord-Est. Per Vandana Shiva l’obiettivo è “limitare i consumi, avere una gratificazione dall’aver consumato meno. Il nuovo Rinascimento sarà vivere con meno”. Carlo Petrini ha un sogno: “Far diventare il podere del contadino il primo simbolico presidio di Terra Madre”; lo storico Aldo Schiavone pensa che “abbiamo bisogno del messaggio insito nell’esperienza del contadino non per riproporlo come stile di vita ma perché è presente un elemento che non va perduto: la ricongiunzione con la Terra”; per il biologo Angelo Vescovi “l’obiettivo di quel contadino era un benessere interiore non legato al possesso dei beni materiali”; Pier Paolo Piaggio, storico, afferma che “siamo in presenza di una crisi ecologica globale e c’è da temere che sia molto difficile riorientare la tecnologia.
La carenza principale è nell’inadeguatezza e impreparazione della classe politica mondiale a gestire questa crisi”. Il film torna sulle battute finali di Terra Madre del 2008 con l’intervento di uno studente del Massachusetts che racconta la storia del Progetto Germoglio: la realizzazione di orti biologici nelle scuole americane che in breve tempo si diffondono in altri Stati americani e addirittura in una scuola del Senegal.13 La conclusione è che con questi orti i giovani vogliono dimostrare che ci sanno fare. Ermanno Olmi definirà i giovani che si cimentano in questa nuova esperienza “ortolani di civiltà”. Infine il regista ci riporta nella campagna della Valle Adige per seguire le lavorazioni di un agricoltore nelle diverse stagioni: la vendemmia in autunno, la preparazione del terreno e del vigneto in inverno, la delicata posa dei semi sotto terra, il raccolto in tarda primavera ed estate di ortaggi e frutti colorati e saporiti. Ci vuole lentezza e tanta pazienza. Il film si chiude con un’allegra brigata di bambini che gioca nel frutteto e con il contadino che conserva con cura e amorevolezza i semi di fagiolo e di finocchio, non prima di aver gustato uno splendido caco arancione, denso di calore e luce solare. A proposito della genesi del documentario Olmi racconta: “Il primo appunto che Carlo Petrini mi ha inviato è del 1° luglio 2006. E dice: ‘Questo sarà un film politico e preveggente per far conoscere a tutti coloro che ancora non sanno, quegli esempi positivi che le Comunità dei contadini di tutto il mondo e i Presidi Slow Food mostreranno nel corso del grande raduno Terra Madre 2006 a Torino.’ E io, naturalmente, ero fra coloro del nostro tempo che non conoscevano la solidale unione di intenti testimoniati in questo raduno mondiale fra tutte le genti contadine. Uomini e donne che nelle loro terra ancora resistono all’incalzare di una delittuosa politica di sfruttamento esasperato e devastante dei suoli fertili, unica risorsa per il cibo di tutti i popoli. Una testimonianza eroica di eterna e leale alleanza con la natura e i suoi frutti. Un’alleanza che non ha barriere di lingue, divisioni di ideologie e religioni, né confini di Stati. Al forum di Terra Madre ho riconosciuto i contadini come li ricordavo nelle nostre campagne, al tempo della mia infanzia. I volti dei contadini si somigliano in ogni angolo del mondo. Sono volti su cui si riconoscono le medesime tracce di vita, così come le fisionomie dei paesaggi con i campi arati, le colture, i pascoli. Oggi quel mondo dei contadini è assediato dalle grandi imprese il cui scopo è il profitto. Anche il contadino vuole guadagnare, ma il suo attaccamento alla terra è anche un atto d’amore ed è in questo sentimento solidale che si genera il rispetto della natura. Sono sicuro che questi onesti cittadini non tradiranno mai la loro Terra. E noi cittadini metropolitani, che viviamo inscatolati nelle nostre città, senza più i colori e i profumi delle stagioni forse, in un giorno molto prossimo, se ci capiterà di passare accanto a un orto dove un nonno e una piccola bimba colgono i frutti maturi, allora potremo ancora riconoscere la vera casa dell’uomo.”
La storia è tratta dal libro di Fulvio e Ignazio Roiter, Un uomo senza desideri, Verona, Edizioni Siz, 2005. 13 Slow Food sta incentivando lo sviluppo degli orti sia in Occidente sia nelle altre parti del mondo, in particolare in Africa con il progetto “Diecimila orti in Africa”. 12
TERZA PARTE
I LUNGOMETRAGGI
IL TEMPO SI È FERMATO [1959] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Sezione Cinema Edisonvolta. Interpreti: Natale Rossi, Roberto Seveso. Riconoscimenti: Premio San Giorgio alla XX Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Sezione informativa.
Sinossi È la storia di due guardiani di dighe, un vecchio operaio e un giovane studente lavoratore, che durante l’inverno si trovano isolati dal mondo. Nella vicenda rappresentano due generazioni che si incontrano e piano piano si conoscono. La diga, i cui lavori devono essere ultimati, è posta a 2.600 metri, alla Vedretta del Venerocolo, sull’Adamello. Durante la pausa invernale il cantiere viene abbandonato, rimangono solo due operai. La vicenda inizia con i due che giocano a scacchi nel casotto. “Mangia, mangia, te se obligà a mangià!” dice uno all’altro mentre fuori nevica. La mattina dopo c’è un sole splendente e un cielo azzurro terso. Uno dei due uomini scende a valle per le feste di Natale e dovrà essere sostituito. Ma il sostituto non arriva perché gli è nato un figlio, al suo posto giunge invece un giovane che si è offerto e che lavorava in magazzino (nella realtà si tratta di Roberto Seveso, dipendente della Edison e che Olmi utilizza come attore e operatore). L’uomo resta sorpreso e anche un po’ contrariato per la novità ed è guardingo. Il tema del film è già da subito chiaro: l’incontro tra due generazioni in alta montagna, in solitudine. L’uomo prepara la minestra e dà al giovane, non visto, le posate migliori. Si mette a leggere un libro mentre il ragazzo studia e poi va a dormire: entrambi hanno sbirciato furtivamente il libro dell’altro per vedere di cosa si tratta. L’uomo comunica i dati della temperatura a valle e conclude: “Tempo sereno e la vita è bella.” La mattina dopo il giovane mette un disco di rock a tutto volume cantato da Adriano Celentano. I due continuano a studiarsi, a scrutarsi facendo finta di niente. L’uomo gira la polenta con un lungo mestolo di legno, poi la mangiano con grande piacere e giocano a dama: vince il giovane e il guardiano ci resta un po’ male. A un certo punto, a causa di una valanga, va via l’energia elettrica e si allaga un locale che devono svuotare. Una tormenta di neve infuria, accendono la stufa
a legna per scaldarsi perché sono al buio. Qui Olmi filma immagini bellissime nella semioscurità, con la luce che filtra dal fuoco della stufa. Poi l’uomo accende una lampada da minatore e mangiano insieme con la piacevolezza che deriva dal momento di emergenza e da una più evidente solidarietà umana. Dormiranno in cucina per stare al caldo e lì, nel calore del fuoco e nell’assenza della luce elettrica, avviene la prima bella conversazione tra di loro che li avvicinerà emotivamente. L’uomo sta leggendo il libro Cuore e il giovane gli dice: “Che bello Cuore, è un bel libro, l’ho letto anch’io, è commovente.” L’uomo risponde: “Proprio, ci son su tante belle cose, cose che però oggi non so se capiteranno ancora.” “Anche mio padre dice sempre così, ma in fondo in fondo il mondo è sempre lo stesso, no?” “Non è vero, oggi la gente ha cambiato sentimento. Una volta un uomo si vendeva persino la camicia per salvarsi l’onore, oggi per quattro palanche accopperebbe anche suo padre.” L’uomo si confida finalmente col giovane e gli parla della sua famiglia e dei costumi che cambiano: “Sai cosa diceva la mia nonna? Che la carne messa in vetrina non è mai di prima qualità.” Il giovane guarda quasi rapito l’uomo che parla, con la contentezza che gli deriva dall’aver conquistato un dialogo alla pari. Il vento fischia forte e rompe il vetro di una finestra, devono uscire nella tormenta e ricoverarsi in un altro locale ma il ragazzo non si sente bene, ha la febbre e vorrebbe, l’indomani, scendere a valle. Allora l’uomo se ne prende cura, esce di nuovo per recuperare delle medicine e scaldargli del latte a cui aggiunge una buona dose di grappa. Così il giovane riesce a riposare bene e la mattina dopo non c’è traccia di malattia. L’uomo lo porta a spalle nel casotto e il giovane gli dice di non far menzione che non è stato bene e che voleva tornare a valle. Ora vuole rimanere nel casotto insieme al custode. Il ghiaccio è rotto, ci si può conoscere più a fondo.
Il tempo del dialogo Questo è un film a cui Olmi è molto affezionato. È il suo primo lungometraggio, girato oltretutto all’insaputa della Edison che si aspettava un documentario sulla nuova diga. La struttura narrativa si snoda attorno a vicende minimali che però rimandano a temi molto più complessi com’è, in questo caso, quello del rapporto tra le generazioni. Cosa vuole dirci Olmi con questo suo primo film? Le due generazioni a confronto sono molto diverse: la prima è quella della ricostruzione industriale del dopoguerra e l’altra è quella che si sta affacciando al boom economico e alla modernità con i suoi simboli, tra cui i beni di consumo e il
rock. Olmi suggerisce che è possibile un dialogo se si fa ricorso ai sentimenti, ai valori umani e alla memoria: il libro Cuore, i racconti familiari. Qui avviene il primo contatto emotivo con il giovane che vede nell’uomo maturo una sorta di maestro non solo di lavoro ma di vita e l’uomo che trova nel giovane un interlocutore interessato e interessante, che non lo snobba. Le contraddizioni che lacereranno la società borghese e consumista e la famiglia tradizionale sono di lì a venire, qui c’è un inizio di colloquio e di ascolto reciproco. Il tempo si è fermato rappresenta bene la sospensione dal tempo della quotidianità urbana vissuta dai due protagonisti proprio grazie all’isolamento in alta montagna, una sospensione nella quale è possibile comunicare ricordi o emozioni non sempre comunicabili nella quotidianità ordinaria. Ma qui, in alta montagna, di ordinario c’è ben poco. La struttura del film emerge come quella di un romanzo di formazione, con un uomo maturo che propone a un giovane valori etici che vanno al di là delle apparenze e della ricchezza materiale. Emerge anche la bellezza e la terribilità della natura, che non bisogna sottovalutare né pensare di poter dominare. È come un rito di iniziazione. La modernità è dietro l’angolo con Adriano Celentano che, sui titoli di coda, canta King of Rock e simboleggia l’allegria e l’energia dei giovani degli anni cinquanta: c’è ancora speranza e forza propulsiva verso il futuro.
IL POSTO [1961] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Titanus/ The 24 Horses. Interpreti: Loredana Detto, Sandro Panseri. Riconoscimenti: Premio della Critica, XXII Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 1961; David di Donatello per la regia, 1962.
Sinossi Domenico, il giovane protagonista, arriva dalla campagna lombarda, da Meda, con la timidezza tipica di un giovane ai primi passi in città, per partecipare a una selezione di lavoro presso una grande azienda. Siamo a Milano in pieno boom economico nei primi anni sessanta e la città sta vivendo una grande espansione economica e culturale. Per Domenico c’è la scoperta della metropoli ma anche la conoscenza con Antonietta, che si fa chiamare Magalì, incontrata agli esami di ammissione per il posto di lavoro; è interpretata da una giovanissima Loredana Detto, che diventerà poi la moglie di Olmi. In una pausa degli esami si ritrovano a mangiare nella stessa latteria e poi passeggiano in centro, dove è in corso la costruzione della metropolitana. Nasce una timida intesa fatta di sguardi silenziosi e sorrisi e sembra l’inizio di un sentimento tra i due giovani e, infatti, Domenico quella sera tornerà a casa cantando a squarcia gola Volare, canzone simbolo di quegli anni interpretata da Modugno. Entrambi si aggiudicano il posto di lavoro. Lui prima come fattorino poi, dopo la morte di un dipendente, come impiegato. Domenico spera di incontrare Antonietta al veglione di Capodanno nel Cral aziendale ma lei non verrà. Si ritrova così solo, in mezzo a un’umanità un po’ surreale: sguardi di complicità tra una donna piacente e un uomo non certo bello ma più virile del marito; una simpatica signora che, vedendo Domenico smarrito, lo invita a ballare. Per lui quel Capodanno è comunque un momento di formazione sentimentale fuori dall’ambito familiare da cui proviene. L’incontro tra i due giovani non avrà seguito, forse c’è troppa distanza tra la disinvolta consapevolezza di sé di Antonietta e l’insicurezza ancora acerba di Domenico.
Il posto agognato In questo suo secondo film, dolce e malinconico, Olmi ci mostra il contrasto tra le aspettative inevitabilmente ingenue di Domenico, simbolo della nuova gioventù che arriva dalla campagna in città e che si avvicina ai lavori d’ufficio piena di
speranze, e i coni d’ombra di questo impiego: l’alienazione derivata da un lavoro ripetitivo, il servilismo verso i capi, le piccole invidie tra i dipendenti tipiche del lavoro d’ufficio. Questa sarà l’esperienza di tanti giovani che negli anni sessanta andranno a lavorare nelle grandi aziende dove si è considerati poco più che numeri. Un’esperienza di l’alienazione che fa il paio con quella alla catena di montaggio nelle grandi fabbriche. Anche da queste due alienazioni, oltre che dalla ribellione studentesca, prenderà le mosse il Sessantotto. Il posto di lavoro sarà messo in discussione non solo nella sua componente salariale ma anche per la massificazione e l’alienazione che produce, e per la necessità di una sua migliore qualità e di una valorizzazione dell’individuo. Nello slogan dei cortei operai “il posto di lavoro non si tocca” sarà presente la contraddizione vissuta anche da Domenico: non se ne parla proprio di lasciare l’agognato posto conquistato, ma che ripetitività, che tempo di vita buttato!
E VENNE UN UOMO [1965] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi, Vincenzo Labella. Produzione: Sol Produzioni/ Harry Saltzman. Interpreti: Rod Steiger, Adolfo Celi.
Sinossi Il film si apre con alcune immagini di papa Giovanni XXIII in occasione delle sue frequenti visite al popolo dei fedeli e degli esclusi, nelle quali emerge tutta l’umanità del “papa buono”: la simpatia, la confidenza, la semplicità, la fiducia. Questo il commento alle prime immagini: “Era uscito dal conclave eletto inaspettatamente e aveva scelto da papa un nome non più usato da secoli, Giovanni. Subito scoprimmo il suo sorriso che non era solo un segno di bonarietà, ma un soccorso offerto a tutti. Papa Giovanni sorrideva come chi viene a noi con un dono e lo tiene nascosto dietro alla schiena. Subito cominciò a uscire senza scorta per far visita a un quartiere popolare o a un amico malato, la gente prende a rivolgersi a lui con confidenza. Si presentava alla folla con il saluto biblico ‘Sono il vostro fratello’, ed era come se entrasse in ogni casa, rivolgendosi a tutti e a ciascuno, visitando le gioie e i terrori dell’uomo, nel vivo dell’uomo, nella casa dell’uomo, non discendendo dall’alto ma camminando sul nostro stesso piano per la via diritta della simpatia. ‘Dunque eccoci qui. Ho fissato i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il mio cuore vicino al vostro cuore,’ disse ai detenuti nella visita al carcere di Roma. E aggiunse: ‘Quando scrivete a casa dite alle vostri madri, alle vostre sorelle, alle vostre spose che il papa è venuto a trovarvi e che prega per voi e per loro.’ Ogni giorno nel suo rosario pregava per i bambini. Diceva: “Non nasce un bambino senza che abbia subito una preghiera del papa per sé.” In occasione di una visita in un ospedale infantile dal suo letto un bambino gli chiede: “Come ti chiami?” “Quando avevo la tua età mi chiamavo Angelo.” “Io mi chiamo Arcangelo,” risponde il bambino. “Vedi? Sei più importante di me.” Una memorabile sera, dalla finestra dove si affaccia sulla piazza del Vaticano, dice: “Tornando a casa fate una carezza ai vostri bambini e dite loro che è la carezza del papa. Troverete forse una lacrima da asciugare, dite una parola. Il papa è con voi.” Ma chi era quest’uomo venuto nel nome del Signore? Da dove era partito? Quali strade aveva percorso? Olmi è stato mosso da questi interrogativi.
Il film ripercorre la vita di papa Giovanni con la figura e il commento dell’attore Rod Steiger che resta se stesso per tutta la durata del film, sia quando all’inizio racconta la storia dell’infanzia del papa, sia quando si farà mediatore del personaggio di Angelo Giuseppe Roncalli e ne ripeterà le parole autentiche e i gesti. Questa è stata una precisa scelta stilistica di Olmi che voleva rispettare la figura del papa. Il film – girato nella parte iniziale nei luoghi autentici dell’infanzia del futuro papa, a Sotto il Monte in provincia di Bergamo – prende avvio dalla nascita e dal rapporto affettuoso con i genitori. Tra gli altri, c’è l’episodio nel quale il piccolo Angelo prende una grande zucca in un campo senza il permesso del padrone e il padre gli impone di riportarla subito indietro. Il contadino, toccato da quest’atto di onestà del signor Roncalli, per ringraziarlo torna e regala loro molte zucche. In questo frammento di vita contadina si scorge la dignità della povera gente di campagna che aveva una sua forte etica del lavoro: in primo luogo non rubare il raccolto ai vicini. Il film riepiloga i momenti principali che hanno costituito la formazione religiosa di Giovanni XXIII: gli studi in seminario, il primo viaggio in Vaticano, le sue riflessioni sui mali del mondo e su Gesù, la lettera che scrive da Roma ai genitori e allo zio sul bene che vuole fare nel mondo. Poi viene ordinato sacerdote e diventa segretario del vescovo di Bergamo. Dopo la morte del vescovo e terminata la guerra va all’istituzione FIDE in Vaticano. Nel 1925 viene nominato vescovo in Bulgaria. Quando compie cinquant’anni scrive una lettera ai genitori dalla Bulgaria nella quale dice che gli insegnamenti più preziosi li ha imparati da loro e che “se la sua famiglia non diventerà ricca di denaro sarà sempre ricca di quei tesori spirituali che sono la gloria vera di una casa”. Dopo dieci anni passati in Bulgaria, paese e gente a cui si era molto affezionato, tanto da sentirsi “fratello di Bulgaria”, nel 1935 viene nominato delegato apostolico di Turchia e Grecia a Istanbul. Cerca di trovare punti di contatto tra la Chiesa e la Turchia, come per esempio pronunciare “Dio è benedetto” in turco. Da un punto di vista simbolico è un primo inizio di dialogo interreligioso per superare la separazione tra Cristianesimo e Islam. In questo contesto si pone la sua forte critica al nazionalismo che per lui è in contraddizione con il Vangelo perché “Gesù è venuto per tutti”. Viene nominato dal papa alla Nunziatura di Parigi nel 1944. Quando termina la Seconda guerra mondiale così esprime la sua riflessione e le sue speranze: “I giorni della collera, della calamità, del dolore universale sono passati sulle nostre teste, ma Dio ha umiliato gli orgogliosi che volevano soggiogare il mondo, ha punito i responsabili e le loro formidabili armate. Ecco ormai orizzonti nuovi
aprirsi davanti a noi e nuovi orientamenti disegnarsi verso il miglioramento e il progresso dell’ordine sociale. La pace è il dono incomparabile di Dio ma è altresì la suprema aspirazione dell’uomo. La pace è una casa, la casa di tutti.” Nel 1953 viene nominato cardinale a Venezia dove conquista la gente con il suo modo di porsi, semplice e anticonvenzionale. Infine il 28 ottobre 1958, con grande stupore suo e della comunità religiosa, diventa papa. Sorprende tutti con il calore umano, il buon umore, la gentilezza che emana: “Tutto il mondo è la mia famiglia.” Quando è vicino alla morte dirà: “In quest’ora estrema mi sento tranquillo. Le anime, le anime che esse siano una cosa sola. Questo è il mistero della vita, non cercate altre spiegazioni.”
L’umanità del papa buono È il primo film che Olmi dedica esplicitamente alla dimensione spirituale. E forse non poteva che essere un film con al centro la figura religiosa che ha segnato maggiormente l’epoca contemporanea, dal dopoguerra ai giorni nostri: papa Giovanni XXIII. Giovanni XXIII è il primo papa che apre il Vaticano a tutti, ai fratelli di ogni credo: ortodossi, protestanti, ebrei, anglicani, buddisti. Tutti stringono la sua mano, raccolgono il suo sorriso. È il primo papa che, profeticamente, mette al centro il dialogo interculturale e interreligioso dando a tutte le confessioni la medesima dignità. È anche il primo papa che inizia quel lungo percorso di confronto con il comunismo che sfocerà decenni dopo nell’evento simbolico dell’abbattimento del Muro di Berlino. Quel Muro comincia a sgretolarsi con il dialogo tra Giovanni XXIII e il presidente Chruščëv. La sua vita di pontefice si conclude con un prodigio di intuizione e buona volontà: il Concilio Vaticano II. Il Concilio che porrà le basi di un rinnovamento radicale della Chiesa e della sua liturgia, all’insegna del dialogo con le altre spiritualità e con il mondo laico. Papa Roncalli ha incarnato una religiosità poco convenzionale e molto umana, attenta ai poveri, ai deboli, ai bambini. È una religiosità nella quale Olmi si è riconosciuto e nella quale ha trovato alimento e ispirazione per i film che segneranno più avanti la sua ricerca esistenziale. C’è una grande delicatezza nel modo in cui Olmi si avvicina alla figura di Giovanni XXIII. Nel film vi sono molti momenti di grande intensità, sia quando si parla delle sue origini famigliari sia nei passaggi chiave della sua vicenda pastorale all’estero e poi, ancor di più, a Venezia. E venne un uomo è un film che non fu compreso nella sua inconsueta struttura narrativa. In particolare non fu apprezzata adeguatamente la figura del mediatore-narratore interpretato da un Rod Steiger essenziale e scarno, che è contemporaneamente dentro e fuori della finzione, e quando è dentro non si confonde con la figura del papa perché conserva sempre abiti civili. Il narratore
verrà utilizzato ancora da Olmi in Genesi e in alcuni passaggi chiave di Cantando dietro i paraventi. Questa scelta stilistica gli permette, nello stesso tempo, di rispettare la realtà che sta descrivendo e di introdurre – attraverso lo sguardo del narratore – un altro livello di lettura più simbolico che rivela fatti e personaggi nella loro essenza. Lasciando anche spazio a quella dimensione di un’esistenza che resta indescrivibile. “Quando un uomo è in vita, specialmente se è un grand’uomo, tutti credono di conoscerlo bene e di sapere tutto di lui, ma appena quest’uomo ci lascia ci accorgiamo di non sapere nulla. La sua vita e la sua morte, tutto ci diventa misterioso. Comprendo bene che di un papa si voglia conoscere tutto e tutto possa servire alla Storia, ma la mia anima, ciò che più di ogni altro scritto sembra appartenermi, è dentro a questi fogli.”14 14
Giovanni XXIII, Il Giornale dell’anima, Alba, Edizioni San Paolo, 2003.
UN CERTO GIORNO [1969] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Cinema S.p.A. Interpreti: Brunetto Del Vita, Lidia Fuortes, Vitaliano Damioli.
Sinossi A Torino, il protagonista Bruno, director di un’agenzia pubblicitaria, presenta ad alcuni clienti la strutturazione in reparti: direzione, marketing, ricerche, creatività, mezzi, contatto. L’amministratore delegato e il director, che funge da numero due dell’agenzia, hanno una riunione con i clienti per presentare il lavoro creativo della campagna pubblicitaria di un deodorante per uomo, una pubblicità che rappresenta un uomo virile, aria da duro, che è su una motocicletta con una donna che accarezza il braccio del suo “eroe”. La pubblicità recita: “Per gli uomini di scorza dura la freschezza del deodorante…” Durante la riunione l’amministratore delegato si sente male ed esce. Seguono diverse scene in cui Bruno è protagonista. Prima si trova con l’amante in una camera d’albergo, poi incontra il capo dell’agenzia madre tedesca per il resoconto dell’attività. Vanno a lavorare nella sua casa in Toscana, luogo della sua infanzia, dove ha comprato molta terra perché i contadini l’hanno abbandonata. Il capo tedesco gli propone di prendere il posto dell’amministratore delegato e lui accetta. Ha pronti nuovi programmi di ampliamento dei clienti e dei prodotti. All’insegna dell’affermazione “i nuovi desideri non esistono, esistono aspettative che un nuovo prodotto può soddisfare”, Bruno lancia un nuovo prodotto alimentare. Una ricercatrice esterna e un dipendente del settore ricerca escono tardi dagli uffici dell’agenzia e camminano insieme, lui è un po’ depresso e solo. Decidono di mangiare insieme nel suo studio di pittura. È modesto e disordinato, ma a suo modo allegro perché pieno di quadri. Lei è carina e lo ascolta, lui sembra triste e racconta che talvolta ha anche momenti di contemplazione in cui si sente parte dell’insieme che lo circonda: le sedie, i quadri, le pareti, senza distanza, senza tempo. Si definisce romantico, un po’ fuori moda. Una sera Bruno trova a tarda ora in ufficio la ricercatrice, alla fine escono insieme e lui l’accompagna. Vanno a cena in un ristorante ungherese, parlano di
lavoro ma in realtà lui inizia a corteggiarla. Poi Bruno va a trovare l’amministratore delegato nella sua bella casa sul Lago di Garda dove quest’ultimo gli comunica che ha deciso di cambiare vita e di ritirarsi dal lavoro in agenzia. Bruno e la ricercatrice si incontrano di nuovo a Brescia: nevica, vanno a cena e passano la notte insieme. Intanto la sua proposta di una nuova linea di prodotti alimentari “Job dinner” viene accettata dal cliente che ha casa anch’egli nella campagna toscana. Tutto sta procedendo per il meglio: la promozione imminente, la nuova linea di prodotti alimentari, la storia con la ricercatrice. Mentre guida e parla con la segreteria dei prossimi progetti sente un colpo contro l’auto, si ferma e decide di tornare indietro per controllare cos’è successo e si accorge di avere investito un vecchio operaio che lavorava sulla strada. È grave e lo portano all’ospedale. Lui dovrebbe andare a Francoforte per presentare la nuova proposta e diventare amministratore delegato ma non può allontanarsi. Parla con l’avvocato per l’avvio delle indagini. L’incidente capita un giorno qualsiasi – “un certo giorno” – proprio nel momento in cui le cose stanno andando molto bene. Mentre Bruno è solo gli vengono in mente alcuni istanti vissuti: rivede la scena in albergo con la ricercatrice che si spoglia lentamente ma risolutamente, volendo affermare la sua scelta di donna. Poi vede la conversazione avuta con l’amministratore delegato nella quale quest’ultimo racconta che, nel momento del collasso, gli sono tornati in mente tanti ricordi significativi della sua vita. La figlia gli porta a Brescia gli indumenti di ricambio ma lui non ha ancora chiamato la moglie per avvisarla dell’incidente. In realtà non vuole accettare ciò che è successo: l’operaio è morto. Lui “non ha visto niente”, ed è una metafora dell’atteggiamento di autoreferenzialità che non si accorge del contesto, dell’altro. Però, in un sussulto di consapevolezza, dice alla figlia: “Non ci si rende conto più di niente, di come si vive, di come ci si comporta e solo quando ci capita qualcosa di grave allora, allora…” C’è l’incontro con gli avvocati per la strategia difensiva. È la prima presa di realtà, e l’inizio della sua crisi. Quando va a casa dalla moglie le dice “mi dispiace” mentre lei piange. Dalla finestra dell’ufficio vede la ricercatrice che ha un appuntamento con il dipendente depresso. Vanno fuori a pranzo, lei vorrebbe tornare nella soffitta, ci vanno anche se lui l’ha affittata perché non dipinge più. Poi vanno a ballare e amoreggiano timidamente. Bruno incontra la ricercatrice per sapere se sta insieme al dipendente e per dirle che in ogni caso la loro storia deve finire. Poi torna al lavoro per il progetto “Job dinner”. Il vecchio amministratore delegato torna a salutare tutti in agenzia e gli dice che a casa si annoia terribilmente perché non sa cosa fare.
Viene il giorno del processo, la notte prima Bruno dice alla moglie che “alle persone che più si amano offriamo soprattutto le nostre colpe per farci perdonare”. Il processo finisce bene e allora lui porta la famiglia nella casa in Toscana per rilassarsi. La sera la figlia esce con un’amica e lui con la moglie guarda la tv e le dice: “Adesso deve tornare tutto normale, come prima,” dandole un piccolo bacio. In realtà ha uno sguardo triste, è depresso mentre lei appare serena. La moglie si addormenta, a lui torna in mente l’incidente mentre alla tv scorrono le immagini e il sonoro di esplosioni in montagna per nuove costruzioni. Il progresso va avanti incessantemente, e la tv lo propaga.
I conti con la realtà Olmi prepara questo film stando a diretto contatto per un mese con i pubblicitari di un’agenzia di Milano, in modo da conoscerne strategia e linguaggio per la sua esigenza di narratore di essere il più possibile vicino all’autenticità della realtà lavorativa e dei protagonisti. Un primo punto tematico di grande interesse del film è rappresentato dall’idea creativa di una pubblicità di deodorante maschile in cui è presente un uomo che, virilmente, è a cavalcioni della sua motocicletta mentre una donna, affettuosa e adorante, gli accarezza il braccio. Qui viene proposto l’archetipo, che verrà in seguito utilizzato in molteplici pubblicità, dell’“uomo che non deve chiedere mai”. Un archetipo che ben rappresenta il modello di maschio presente negli anni sessanta nella società e nell’immaginario femminile e che poi nei decenni successivi vivrà dei momenti di crisi, ma mai definitivi. Quest’idea di uomo forte e invincibile aveva avuto nel Novecento una versione distruttiva nelle figure dei dittatori, da Hitler e Mussolini a Stalin, e una più complessa, a tinte chiaroscure, nelle figure dei nuovi leader politici ed economici della ricostruzione o anche nel cinema americano, pensiamo ad esempio a John Wayne. Nel film la figura dell’uomo forte ha due contraltari. Il primo si evidenzia subito nella figura dell’amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria che non regge lo stress dei tanti impegni e delle periodiche verifiche con l’agenzia madre tedesca (pare quasi una profetica metafora delle attuali relazioni economicofinanziarie tra Italia e Germania). Da subito Olmi fa emergere nitidamente la contraddizione tra l’immagine dell’uomo duro e invincibile della pubblicità e la figura del manager, simbolo di un’efficienza produttiva che si dimostra impraticabile. Dopo il collasso, l’amministratore delegato racconta al suo più stretto collaboratore che lo sostituirà i ricordi della sua vita che gli sono venuti in mente in quel momento: “È incredibile quante cose si pensino in un brevissimo spazio di
tempo, torna in mente tutto, anche l’infanzia, si rivedono momenti di vita lontanissimi e volti di persone dimenticate e c’è una sensazione di rimpianto generale per un sacco di cose trascurate. È tutta la nostra vita che si ripresenta in quegli ultimi istanti per essere giudicata da noi che siamo gli unici responsabili di come l’abbiamo vissuta e il bello è che lì non ci sono più scuse o giustificazioni, siamo costretti a dare di ogni cosa il giudizio esatto.” Nel momento della possibile morte tutto ciò che di importante abbiamo vissuto torna alla coscienza, con una gerarchia di valori che difficilmente cogliamo nella quotidianità. In questo colloquio l’immagine del manager forte, che non ha mai dubbi o momenti di crisi, va in pezzi e torna a manifestarsi e a ridiventare centrale la dimensione etica della vita. Olmi racconta un’esperienza di vita che capita prima o poi, anche se in forme diverse, a tutti. Il secondo caso, ancor più significativo, di messa in discussione di quel modello maschile riguarda il director. Tutto gli sta andando bene, l’imminente promozione, la proposta di una nuova linea di prodotti alimentari, le avventure con le amanti. Tutto gira a meraviglia. Fino a che un imprevedibile incidente con la sua auto, che procura la morte di un operaio sul ciglio di una strada, mette in questione la su vita e i suoi valori. Qui Olmi ci parla – tramite la casualità di un incidente che sembra di poco conto, tanto che il protagonista non si è accorto dell’impatto – di una cosa ben più consistente, che nei decenni successivi si affermerà come fenomeno socioculturale: il narcisismo contemporaneo, l’autoreferenzialità in particolare di chi ha potere, politico o economico che sia. Così come il pubblicitario è tutto concentrato a parlare dei prossimi progetti alla sua assistente e non si accorge di quello che avviene fuori dall’abitacolo dell’auto così lo yuppie degli anni novanta o il finanziere degli anni duemila saranno totalmente concentrati sui propri business, sull’ampliamento del proprio potere e non si accorgeranno di quello che avviene al di fuori del loro ego. La loro vita è una linea retta, esponenziale che non prevede crisi, rallentamenti, incidenti. Se succede qualcosa di imprevisto ci si sente senza colpa perché “non ci si è accorti”. La relazione con l’altro è puramente funzionale, strumentale, utile. Essere egoriferiti è vantaggioso e di moda, fa sentire forti e senza limiti. Ma gli “incidenti” capitano, e solo uno sguardo superficiale può definirli eventi puramente negativi. Nel film l’incidente è tragico per l’operaio che muore ma contiene un potenziale valore evolutivo per il pubblicitario. Per Bruno l’incidente è una paradossale grande occasione di cambiamento. Nel momento della crisi imprevedibile si mette in discussione tutto, la centralità del potere e la dimensione affettiva sacrificata. Si fa chiarezza dentro di sé. Ci si confronta con il senso del limite. Da questo punto di vista, la crisi del pubblicitario rappresenta la metafora di una società che, negli anni sessanta, è ancora in pieno boom consumistico e vive
un’espansione economica che appare illimitata. È la grande stagione dei nuovi prodotti e beni di consumo e la società occidentale si sente solidamente poggiata sui pilastri del mercato e di una pubblicità sempre più creativa e accattivante. Ma l’“incidente” socioculturale è dietro l’angolo. Già si è manifestato con la ribellione dei giovani del maggio francese e di lì a poco il Sessantotto dilagherà anche in Italia e in tutto l’Occidente. L’“incidente” è rappresentato dalla generazione nata nell’immediato dopoguerra e cresciuta durante la ricostruzione che urla che quell’idea di sviluppo consumistico è sbagliata, che ci sono altri valori umani, che “l’uomo non è a una dimensione”. Da quel momento in poi inizieranno i primi segnali di recessione e si confermerà il fatto che l’autentica civiltà non si basa unicamente sulla ricchezza economica. La crisi del pubblicitario è per Olmi simbolicamente la crisi di tutto l’Occidente, del maschio dominatore, della vita basata essenzialmente sul potere e sui beni materiali. È la crisi epocale, economica e anche di valori nella quale siamo immersi da anni e che è la conseguenza in primo luogo dell’avidità. Non solo di finanzieri e di speculatori. Nel commentare il film Olmi, a questo proposito, ha detto: “La crisi del pubblicitario non è individuale ma è la crisi di una società. In quel momento la realtà era tentare di far sopravvivere una condizione economica di ricchezza che già allora era malata e questo è un segno di colpa della classe dirigente. Credo che la classe dirigente politica, industriale, economica solo nell’immediato dopoguerra era all’altezza morale della sua responsabilità. Subito dopo decade questa limpidezza di comportamenti e noi da allora, non solo in Italia ma dappertutto, viviamo in una situazione nella quale la classe dirigente non è moralmente responsabile. Anche per questo iniziano le barricate nel Sessantotto. Perché il Sessantotto? Tra il 1945 e il 1950 nasce la nuova generazione, chi nasce nel 1950 ha diciotto anni nel 1968, i ragazzi nati nel dopoguerra e cresciuti nel boom economico a diciotto anni ti dicono ‘non va bene, quello che state facendo è sbagliato’, lo dicono in modo disperato e sconsiderato perché i giovani non possono avere la saggezza dei vecchi, ma segnalano un disagio. Non l’hanno capito, la classe dirigente si è rifiutata di capire. Oggi questa irresponsabilità continua in maniera sempre più tragica.”15 Ma la metafora dell’incidente richiama alla mente un altro pilastro su cui si è basata la crescita economica di questi decenni: il dominio dell’uomo sulla natura, il consumo indiscriminato di risorse naturali pensate come illimitate, la creazione di centrali nucleari pensate come fonti di energia illimitata. Quanti incidenti sono avvenuti in questi decenni a causa di questo pensiero dominante? Gli scoppi avvenuti nelle centrali nucleari e le catastrofi naturali causate dagli squilibri del clima del pianeta sono i moderni “incidenti” che hanno una matrice comune: il superamento da parte dell’uomo di qualsiasi senso del
limite. Un secondo punto tematico di grande interesse e attualità è quello della giustizia e della responsabilità personale. L’avvocato riesce a far assolvere con vari stratagemmi il pubblicitario che però deve fare i conti con la sua coscienza. Quando comincia la sua prigione? Dopo che è stato assolto perché dovrà fare i conti con se stesso. Ha saputo aggirare la legge, ma non potrà mai aggirare il giudizio che deve dare su di sé. Quando alla fine è con la moglie nella casa in Toscana davanti alla tv e lei si addormenta, perché “tutto è tornato normale”, per lui non sarà così perché dentro la mente rimangono i ricordi, i bagliori dell’incidente. Nell’apparenza tutto è tornato come prima, in agenzia come tra gli affetti ritrovati di casa. Ma il tormento interiore, il rimorso per quello che si è causato rimane. A questo proposito Olmi ha raccontato: “Devo confessare che un’esperienza analoga è avvenuta veramente. Dopo molti anni incontrai un professionista a cui era capitata questa cosa mentre ero in macchina con lui. Lo incontrai all’aeroporto di Roma mentre tornavamo a Milano e ci siamo seduti vicini, non abbiamo parlato minimamente di quello che era successo per tutto il viaggio, quando ci siamo salutati a Milano mi ha trattenuto un attimo e mi detto: ‘Non mi dimentico di quella cosa.’”16 Olmi sembra parlarci di quanto dolore, quanta sofferenza siamo capaci e possiamo procurare all’altro senza accorgerci perché troppo concentrati su di noi, e sembra indicarci che l’unico, reale perdono può derivare dall’assunzione di responsabilità verso ciò che è avvenuto e che abbiamo provocato, non dalla sua rimozione o autoassoluzione. Ci dice anche quanto la vita può essere fragile, cambiando improvvisamente il suo corso, quanto non possiamo dare nulla per scontato e quanta attenzione dobbiamo mettere nelle cose quotidiane. Nulla è certo e sicuro, tutto è fragile, appeso a un filo che può spezzarsi in ogni momento. Olmi ha intuito profeticamente che “un certo giorno” – il giorno nel quale la società contemporanea avrebbe dovuto fare i conti con la mancanza di valori autentici – sarebbe prima o poi arrivato. È arrivato con la crisi attuale da cui non possiamo uscire, come nel film, facendo finta di niente perché “tutto è tornato come prima”. 15 16
Intervista video di Federico Sperindei, 2009. Intervista video di Federico Sperindei.
I RECUPERANTI [1969] Soggetto e sceneggiatura: Mario Rigoni Stern, Tullio Kezich, Ermanno Olmi. Produzione: Rai/ Palumbo. Interpreti: Antonio Lunardi, Andreino Carli. Riconoscimenti: Premio Rododendro d’oro XXI Festival della Montagna Trento.
Sinossi Siamo nel 1945, la guerra è finita, il giovane alpino Gianni torna a casa dalla Russia. Ha camminato per mezza Europa: la Polonia, la Boemia, la Germania, la Francia. C’è una pioggia battente e si ferma per ripararsi nella locanda vicino al suo paese. Lo raggiunge il fratello Francesco che lo abbraccia dopo due anni. A casa c’è il padre che nel frattempo si è risposato con Margherita, una giovane donna. Francesco ha già deciso che andrà a cercare lavoro in Australia perché in montagna di lavoro non ce n’è proprio. Gli uomini del paese, esasperati dalla situazione economica, decidono senza autorizzazione di tagliare molti alberi del bosco e di riaprire la segheria, ma vengono fermati da un’ordinanza comunale e da una multa. Gianni incontra per strada un vecchio un po’ alticcio, di nome Du, che straparla di un tesoro nascosto tra le rocce delle montagne. Du gli propone di lavorare con lui e di mettersi in società: si tratta di recuperare i materiali bellici della Prima guerra mondiale sepolti sotto il terreno e le rocce, da cui estrarre minerali preziosi come rame e ottone. La fidanzata di Gianni non vede di buon occhio questo lavoro per la sua pericolosità e cerca di dissuaderlo, ma Gianni, che non vede alternative, accetta la proposta del vecchio. Iniziano così una vita insieme nella baita di montagna. Di giorno vanno a cercare dove erano posizionate le linee e le gallerie austriache per trovare i residui di guerra. Du è come un rabdomante, “sente” dove sono i metalli, infila nel terreno dei sottili bastoni di ferro e, a seconda del colore, riconosce quale metallo è presente. È in questo modo che ritrovano bombe e granate i cui minerali venderanno in un improvvisato mercato all’aperto in montagna. Gianni decide di comprare con la sua liquidazione di militare un cercamine moderno, all’inizio Du
non ne è contento ma poi si convince della bontà dello strumento quando, grazie a esso, trovano decine di casse austriache. Tutto sembra procedere bene ma quando vanno a vendere le casse al mercato arriva la notizia che due giovani fratelli sono saltati in aria a causa di una granata. I due moriranno. Gianni e Du tornano in montagna e trovano in una galleria mitragliatrici, munizioni e anche resti di teschi umani. La vista di questi, insieme alla morte dei due giovani, mette in crisi Gianni che torna in paese, cerca la sua fidanzata che è ancora innamorata di lui, e decide di cambiare vita: andrà a fare il manovale nella costruzione di nuove abitazioni. Un giorno passa dal cantiere il vecchio Du che impreca contro Gianni che lo ha abbandonato e lo canzona per la scelta conformista e “borghese”. Se ne tornerà da solo su per i monti a continuare la sua vita anarchica e randagia.
Recuperare la vita La guerra è finita. Il ritorno del giovane Gianni nel paese natio nelle valli del Vicentino è mesto, timoroso, pieno di incognite. Quale futuro lo attende? Ci sarà un lavoro? Elsa lo ama ancora? È il dramma che hanno vissuto i nostri soldati rientrati in Italia dopo anni di guerra, è un ritorno agognato ma anche temuto. Il lavoro si impone da subito come tema centrale del film. Di lavoro nella valle non ce n’è e gli uomini disoccupati sono costretti a infrangere la legge: riaprono la segheria e abbattono indiscriminatamente gli alberi del bosco. Ecco che Olmi ci pone davanti a un dilemma che attraverserà tutta la modernità fino ai giorni nostri: qual è il limite dello sfruttamento della natura che non è lecito attraversare anche se c’è poco lavoro? Dove e come fermarsi? Nel film paradossalmente l’unico lavoro che capita a Gianni è quello proposto dal vecchio Du, una via di mezzo tra il matto del paese e un visionario: infatti vede e sente dove gli altri non riescono. Du ha affinato la sensibilità per intuire dove sono celati gli ordigni sotto i prati e le rocce. È un lavoro rischioso ma a suo modo ecologico: Du ripulisce il terreno dai residui bellici e impedirà nuovi incidenti. I metalli contenuti negli ordigni diventeranno merce preziosa da vendere. C’è un momento simbolicamente importante per il rapporto tra guerra e terra quando Du dirà a Gianni che i prati sono più verdi – paradossalmente – dove sono stati nutriti dalla carne umana dei soldati morti. La terra violata dalla guerra sarà un tema che Olmi non casualmente riprenderà nel suo ultimo film Torneranno i prati. Ma nell’immediato dopoguerra che cosa in realtà si trattava di recuperare oltre gli ordigni, cosa si trattava di ripulire oltre la terra? Olmi ci sembra dire, in primo luogo, il lavoro e la dignità umana. L’umanità è chiamata a un’opera di ripulitura della sua interiorità dopo anni di distruzione. Bisogna in qualche modo tornare alla normalità di una vita i cui pilastri sono gli affetti, il lavoro, la convivenza civile. È una normalità che Du – con il suo spirito libertario – rifiuta come “borghese” preferendo a questa la vita randagia in mezzo ai monti del recuperante. È una normalità che Gianni – messo in guardia dall’esplosione della granata che
provoca la morte di due giovani – infine accetta: fa il manovale, sposerà Elsa e costruirà una famiglia. Non ci sono vincitori tra Du e Gianni e forse un po’ di ragione la hanno entrambi. Lo scambio generazionale tra il vecchio Du e Gianni richiama quello di Il tempo si è fermato o di Il pensionato: in questi casi si è realizzata una composizione fertile, ne I recuperanti c’è frattura inevitabile provocata da una modernità che mette ai margini pensiero libertario, follia, anche intuizione visionaria.
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI [1978] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Rai/ Italnoleggio Cinematografico. Interpreti: Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli. Riconoscimenti: Palma d’oro e Premio ecumenico al XXI Festival di Cannes 1978, Premio San Fedele Milano 1979, César per il miglior film straniero, 1978.
Sinossi Il film è stato girato da Olmi con attori non professionisti, tutti contadini della campagna bergamasca. In una cascina a Palosco, tra l’autunno 1897 e la primavera 1898, vivono quattro famiglie di contadini: una piccola comunità che lavora la terra, il cui raccolto per due terzi spetta al padrone. Il film si apre con i canti in coro dei contadini e il dialogo tra il sacerdote e Batistì, uno dei capofamiglia, sul futuro del figlio, Mènec, di sei anni. Il padre vorrebbe che lo aiutasse nei campi, il sacerdote pensa sia meglio indirizzarlo allo studio. Il film è un susseguirsi di scene di vita quotidiana di questa piccola comunità. Il lavoro nei campi, i giochi dei bambini nel fienile, i cori delle donne in circolo mentre sfilano le pannocchie di mais. Batistì parla con il bambino che è contento di andare a scuola. Il giorno della pesa del raccolto alcuni contadini nascondono, con furbizia, grandi pietre dentro alle sacche per aumentarne il peso mentre il padrone mette a tutto volume, per l’occasione, un’opera lirica. Giopa, un povero mendicante, va nelle diverse famiglie della cascina in cerca di un po’ di cibo. Si lavano i panni nell’acqua del ruscello. Tutto è forte e mite nello stesso tempo. In un’altra scena della vita di campagna c’è il timido corteggiamento di un giovane, Stefano, a Maddalena, fatto d’intensi e casti sguardi e pochissime parole. Lui la segue disciplinatamente a distanza in piena campagna e poi la saluta: “Volevo sapere se potevo salutarvi, mi farebbe piacere darvi la buonasera.” “Se è solo per quello, non c’è niente di male.” “E voi non mi dite niente?” “Eh, vi dico anch’io buonasera.” Intanto il padre di lei, da lontano, scruta cosa succede. La vedova Runk, lavandaia, è rimasta con sei figli e il più grande viene preso come garzone da un amico del padre. Il nonno Anselmo, padre della vedova, mentre nevica va di nascosto di notte a mettere nell’orto lo sterco delle galline, che è migliore come concime di quello della vacche, per far venir su dei bei “pomidori” e poterli così vendere prima degli altri. Anselmo è molto amato dai
bambini ed è il continuatore della cultura popolare, fatta di proverbi e filastrocche, che si tramanda oralmente di generazione in generazione. Una notte arrivano gli zampognari con le loro cornamuse per annunciare l’imminente Natale. Il rosario è recitato in coro la sera. L’inverno è rigido e i lavori faticosi. Il prete propone alla lavandaia vedova di mandare i due figli più piccoli in orfanotrofio. Lei ne parla con il figlio più grande che fa il garzone e lui, serio, le dice: “Io lavorerò giorno e notte piuttosto, ma i miei fratelli li teniamo qui in casa con noi.” La mamma lo guarda compassionevole. Tutti si danno amorevolmente una mano. La donna va a pregare nella piccola chiesetta perché la mucca si è ammalata e chiede la grazia della sua guarigione. Poi prende in un fiasco l’acqua del ruscello e la dà da bere, come fosse benedetta, alla mucca morente, e intanto prega. C’è poi il secondo colloquio in campagna tra i due giovani. Lui le dice: “Volevo darvi un bacio.” “Queste sono cose che bisogna aspettare il suo tempo,” risponde lei e se ne va via un po’ seccata. C’è anche una zuffa violenta tra due contadini. La mucca nella stalla miracolosamente si è rialzata e la donna ringrazia il Signore. Il prete fa un’omelia sui miracoli di tutti i giorni: in primo luogo l’amore, la terra che dà i suoi frutti, l’aria, la luce che dà la vita. Poi arriva il momento dell’allegria popolare con le giostre, i giochi e i balli popolari. C’è anche un comizio dei primi socialisti contro i privilegi e per il progresso a cui assiste Finard, un altro capofamiglia della cascina, che trova per terra una moneta d’oro, la prende e viene via tutto contento. Tornato in cascina la nasconde nello zoccolo del suo cavallo. Nasce il figlio di Batistì, un altro maschio. Il bimbo piange e il padre lo guarda quasi timoroso da lontano, e dice alla moglie: “Insomma, un’altra bocca da sfamare.” E lei: “La vostra mamma diceva: ‘Quando viene al mondo un bel bambino la Provvidenza gli dà il suo fagottino.’” Le musiche per organo di Bach accompagnano le diverse scene e ne sacralizzano i momenti più intensi. Il figlio di Batistì che va a scuola torna a casa a piedi nudi con lo zoccolo rotto. Batistì va di nascosto di notte in piena campagna a tagliare un albero per fargli degli zoccoli nuovi. Torna a casa, comincia a lavorarlo, lo taglia, lo sega. Il nonno Anselmo va nell’orto per mettere le piantine dei pomidori prima degli altri contadini, le mette vicino al muro perché mantenga il caldo di cui hanno necessità, così saranno pronti due settimane prima. La sera Batistì racconta a tutti – che rapiti lo ascoltano riuniti in circolo – una storia spaventevole. Arriva il disgelo, la primavera. Dopo qualche tempo Finard cerca di recuperare la moneta. Accortosi che non c’è più, inizia a inveire contro il cavallo che s’imbizzarrisce e quasi lo travolge. Dallo spavento il contadino va “fuori di sentimento” e viene curato con una pozione a base di aglio e vermi. Arriva il momento del matrimonio di Stefano e Maddalena. I due giovani vanno separati con due carretti, prima lo sposo poi la sposa con il padre. Lei sul carretto
sembra una Madonna, con uno sguardo silenzioso e dolcissimo mentre sorge l’alba. Si sposano la mattina presto perché poi andranno il giorno stesso in barca a Milano per andare a trovare in un convento di bambini suor Maria, zia di lei. Non si parlano ma si guardano e si sentono vicini, vanno su un barcone lungo i Navigli e lei delicatamente lo prende sottobraccio. Arrivano in città e incrociano subito un simbolico segno della modernità, un gruppo di ribelli ammanettati dai militi dell’esercito. La città in quei giorni, maggio 1898, è agitata dai tumulti della cosiddetta “Protesta dello stomaco”, che sarà poi violentemente repressa dal generale Bava Beccaris. Poi arrivano nel convento-orfanotrofio dove c’è la zia suora che dà loro il benvenuto e indica i valori spirituali a cui ispirarsi: “Non bisogna cercare le ricchezze della terra ma il bene del Paradiso e il Paradiso comincia con l’amore che saremo capaci di volerci noi qui sulla terra.” Dopo il pasto c’è il dolce canto delle suore. Poi la zia li porta nella loro camera per la loro prima notte da sposi. Restano soli e sono molto imbarazzati. La mattina dopo la zia porta loro un bimbo piccolo di dodici mesi che si chiama Giovanni Battista, orfano ma con una discreta dote di denaro che verrà versato dall’Istituto Pio fino ai quindici anni. La giovane sposa lo prende tra le braccia e sembra quasi che sia il bimbo che accoglie la nuova madre, con la testina che si avvicina per tre volte contro la testa della donna. Tornano alla cascina e il bimbo è accolto da tutta la famiglia con sorpresa e amore. Nel frattempo il padrone della cascina viene a scoprire che è Batistì il colpevole del taglio dell’albero. La famiglia di Batistì, con la moglie Battistina e i tre figli, tra cui Mènec e un bimbo ancora in fasce, viene cacciata dalla cascina portando via loro anche la mucca e il vitello. Montano le loro povere cose su un carretto e partono nella notte mentre la vedova Runk con nonno Anselmo e i figli recitano, per loro, il rosario.
Il tempo degli zoccoli L’epopea contadina girata da Olmi è ancor oggi un vertice insuperato della vita in campagna all’inizio del Novecento. Sono tanti gli aspetti di questo film che colpiscono e che restano nella memoria. Il primo è il ritmo di una vita che, diversamente da oggi, è collegata e anche condizionata dalle stagioni della natura. C’è una ritualità a noi sconosciuta che si avverte come iscritta in un ordine superiore. Tutto accade e si succede secondo un andamento a suo modo armonico. Il rigido inverno con i lavori faticosi, la concimatura dei “pomidori”, l’arrivo del Natale con le cornamuse, le feste nel paese. Poi arriva il disgelo, la primavera, il matrimonio a maggio dei due giovani sposi. Tutto a tempo debito. Il secondo aspetto è relativo alla comunità umana della cascina nella quale tutto è come intrecciato: i lavori nella campagna, i canti in coro delle donne, i racconti riuniti in circolo la sera, il figlio della vedova Runk che vuole a tutti i costi
che i fratellini non vadano in orfanotrofio, la mucca che guarisce miracolosamente, il timido innamoramento dei due giovani. Anche i momenti difficili e violenti, come le zuffe tra contadini o “l’andar fuori di sentimento” di Finard contro il cavallo, fanno parte di questo insieme, di questo mosaico umano e affettivo. C’è un procedere di questa comunità lento, faticoso, con qualche piccolo evento positivo, come il matrimonio dei due giovani. Sono tanti momenti di vita minimali che nella loro interezza comunicano qualcosa che si avvicina alla sacralità dell’esistenza. Ma Olmi non ha voluto fare un ritratto elegiaco di quella vita, c’è un evento dissonante e traumatico che spezza questo insieme unitario. È l’albero tagliato di nascosto da Batistì per dare zoccoli nuovi al figlio Mènec e permettergli di andare a scuola. Questa trasgressione delle leggi della campagna è punita drasticamente dal padrone con l’allontanamento di tutta la famiglia dalla cascina. Olmi, nel momento cruciale in cui Batistì carica il carro con il mobilio per apprestarsi a lasciare la cascina, non mostra una solidarietà evidente degli altri contadini che assistono, intimoriti, alla scena da dietro le inferriate delle finestre. Nella comunità affettiva della cascina qualcosa si è rotto definitivamente, Batistì non racconterà più la sera le sue storie inverosimili e spaventevoli agli astanti riuniti. Ciò che Olmi mostra è la grande dignità di Batistì mentre parte con la famiglia straziata. Solo la vedova Runk, la lavandaia, con il nonno Anselmo e i figli recitano un rosario “perché è un castigo troppo grande per questa povera gente qui”. La litania accompagna, con misericordia e speranza, il carretto che all’imbrunire si allontana mentre i contadini si raccolgono silenziosi nel cortile.
LUNGA VITA ALLA SIGNORA! [1987] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Rai Uno/ Cinemedia/ Istituto Luce. Interpreti: Marco Esposito, Simona Brandalise. Riconoscimenti: Leone d’argento e Premio Fipresci alla XLIV Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1987.
Sinossi Un gruppo di sei giovani allievi di una scuola alberghiera arrivano in una stazione ferroviaria di una località di montagna. Vanno a fare il praticantato in un lussuoso hotel-castello per un banchetto in onore di una vecchia Signora. I convitati sono personalità della finanza, della politica, della cultura. L’organizzazione è gestita in modo militaresco dalla segreteria della Signora che controlla che tutto sia perfettamente in ordine: i posti assegnati, i cartellini con i nomi e titoli relativi (conte, eccellenza ecc.). Ai giovani vengono impartite severe norme di comportamento. Tra di loro vi è il giovane Libenzio che è il protagonista del film con le sue timidezze, ingenuità, paure. I convitati giungono alla spicciolata con le consorti, per ultimo arriva un uomo maturo su una rombante motocicletta che si scoprirà essere il figlio della Signora. Finalmente ecco la Signora, emblema di un’aristocrazia vetusta ma ancora potente, che viene riverita e omaggiata con un lungo applauso dei convitati. Da dietro una veletta la Signora scruterà ora l’uno ora l’altro invitato con l’ausilio di un piccolo binocolo. Le portate si susseguono con l’apprezzamento di quasi tutti i commensali. Solo l’uomo maturo esprime la sua trasgressione prima buttando la cicca di una sigaretta nella zuppa, poi mostrando la lingua alla Signora, che è sua madre. Tutto è molto raggelato e quasi mortifero. Libenzio viene chiamato fuori dalla sala perché suo padre, di passaggio con il furgoncino da lavoro, è venuto a salutarlo. Gli ricorda che la nonna ci tiene molto che lui dica le orazioni. In un flashback Libenzio rivede la scena del funerale della madre e il successivo accudimento della nonna. Nella sala viene proiettato un filmato a cui seguirà un discorso di un invitato che sarà però interrotto da alcuni musicisti. L’oratore seccato se ne andrà anzitempo con la bella e angelica figlia che, uscendo, rivolge un ultimo sguardo a Libenzio.
La Signora si ritira e dà appuntamento agli invitati per l’indomani quando li incontrerà riservatamente. Prima di andarsene fa dire al figlio che lo aspetta per la buonanotte. A questo punto i convitati si riversano nelle varie sale, chi a bere, chi a fare giochi d’azzardo. Una signora cerca di attrarre nella sua camera Libenzio che scappa a gambe levate. Dopo un incubo notturno, alle prime luci dell’alba, decide di andarsene via. Corre a perdifiato nel bosco, viene inseguito e poi raggiunto dal feroce cane della Signora, che però non lo attacca. Il film termina con la scritta: “Dunque il feroce mastino non azzannò il povero Libenzio, anzi attese che il ragazzo riprendesse a correre e a giocare.”
Il potere e la vita Il film ha come tema evidente quello del potere, un potere freddo, estremamente formale e gerarchico. La Signora lo rappresenta molto bene: non parla, comunica tramite un assistente, ha la veletta e scruta gli invitati con un binocolo. È il vero potere, di origine aristocratica, che sovrintende addirittura ai poteri moderni della politica, della finanza, della cultura rappresentati dai molti e influenti invitati. La Signora è omaggiata come una divinità: l’applaudono e la incontreranno il giorno dopo per colloqui individuali nei quali saranno da lei attentamente valutati. Questo è il volto raggelato, quasi terreo del potere da cui si distacca parzialmente solo il figlio irriverente. Se questo è il mondo degli adulti, Olmi ci mostra come contraltare quello dei giovani praticanti che invece è composto da quella timidezza e ingenuità già presenti in Domenico, il protagonista di Il posto o, in forma diversa, nel giovane operaio di Il tempo si è fermato. Qui Libenzio incarna perfettamente lo stupore e anche il timore per un mondo mai immaginato e molto lontano da lui. Ogni tanto vi sono candidi sguardi tra i giovani praticanti che, in questo modo, si danno reciprocamente man forte nel reggere una situazione ambientale per loro difficile da sostenere. Olmi sembra volerci mettere di fronte a due visioni della vita: una fredda, tutta irregimentata in gerarchie e formalismi, con l’unico valore di riferimento che è il potere, l’altra – quella dei giovani – ancora fresca, semplice, diretta e sensibile alle cose belle e naturali. Il potere è seduttivo ma Libenzio vi resiste, trova la via di fuga nel bosco per tornare a una vita magari più povera ma più autentica. Anche il mastino – simbolo della ferocia del potere, ma pur sempre parte della natura – riconosce questa purezza, si fa accarezzare e gli lascia campo libero.
LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE [1988] Soggetto: Ermanno Olmi, dal racconto omonimo di Joseph Roth. Sceneggiatura: Ermanno Olmi e Tullio Kezich. Produzione: Roberto Cicutto e Vincenzo di Leo per Aura Film/ Cecchi Gori Group/ Tiger Cinematografica/ Rai Uno. Interpreti: Rutger Hauer, Antony Quayle, Sandrine Dumas. Riconoscimenti: Leone d’oro alla XLV Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1988; 4 David di Donatello 1989; 2 Nastri d’argento 1989.
Sinossi Un vecchio e misterioso uomo con cappello e ombrello scende lentamente le scale che portano sotto a un ponte sulla Senna a Parigi. Dietro di lui arriva un uomo barcollante e mal vestito, Andreas Kartak, ex minatore senza tetto. Il primo uomo chiede: “Dove vai fratello mio?” Il clochard risponde: “Non sapevo di avere un fratello.” Da questo dialogo prende avvio il film che Olmi ha tratto dal racconto di Joseph Roth, il cui epicentro narrativo è costituito dai piccoli miracoli quotidiani. Il vecchio signore ha letto la storia della piccola Teresa, la santa di Lisieux, e da allora sta vivendo il miracolo della conversione. Ha deciso di vivere da povero, come quelli che vivono sotto i ponti. Lui è devoto alla statuina della piccola Teresa che si trova nella chiesa di Sainte Marie des Batignolles. Dona duecento franchi al clochard e gli chiede di restituirli, quando potrà, al sacerdote dopo la messa perché il suo debito d’ora in poi sarà con la piccola Teresa. Andreas gli risponde: “Sono un uomo d’onore senza indirizzo. Le do la mia parola che manterrò la parola.” Qui avviene il primo miracolo. I soldi avuti gli cambiano la vita. Torna alla normalità, compra il giornale, va in un caffè. Mentre è dal barbiere si ricorda di quando arrivò con il treno, giovane e speranzoso, da Karoline, la donna che amava. Allora faceva il minatore. Da quel momento nella vita di Kartak si susseguono molte coincidenze e riemergono persone significative del suo passato. I soldi avuti in prestito gli danno una sensazione di libertà e di ebbrezza. Va con una prostituta. Beve molto. Di fronte alla chiesa di Sainte Marie des Batignolles, dove deve restituire i soldi alla statuina di Santa Teresa, c’è il bar Paradox, un nome che ben si inclina allo svolgimento del film. Lì si siede ad aspettare che inizi la messa. Quando sta
per entrare in chiesa incontra per caso Karoline che è in un taxi e che lo porta via con sé. Questo è il primo episodio-coincidenza nel quale il suo passato si ripresenta. Andreas piange ricordando quando scoprì che la giovane donna aveva poi sposato un suo amico, anche se l’amore tra loro non era affatto finito. Vanno a mangiare insieme in un bel ristorante e lei vuole sapere tutto di lui. Nella mente tornano i ricordi dei momenti d’amore passati insieme. Le dice: “In questi ultimi giorni mi capitano spesso dei miracoli. Tu credi nei miracoli?” Vanno a ballare e poi dormono insieme. Dopo che si sono lasciati ricorda il momento tragico nel quale il marito della donna scoprì che si amavano ancora e lui, per difenderla da quest’ultimo, lo ammazzò. Per questo andò in prigione: lì ci fu la svolta della sua vita. Dopo aver speso tutti i soldi per pagare il pranzo a Karoline, torna a dormire sotto i ponti della Senna e qui ha l’apparizione della piccola Teresa che gli dà simbolicamente una seconda chance donandogli altri duecento franchi con il patto però di restituirli. Teresa gli chiede il motivo per cui domenica non è andato da lei in chiesa. Lui risponde: “Ma che modi sono di parlarmi? Dimentichi che sono tuo padre.” Stava sognando di avere una figlia piccola come lei. Poi trova un portafoglio per terra in cui ci sono addirittura mille franchi e grazie a questi soldi si gode un po’ la vita e i piaceri borghesi, tra cui l’incontro con una giovane danzatrice. E ritrova Kanjak, il suo primo compagno di scuola, diventato un pugile famoso. Torna alla chiesa di Teresa ma proprio davanti al bar incontra un altro vecchio amico che lo abbindola con una storia inventata e lo commuove al punto da farsi dare i duecento franchi. Entra comunque in chiesa e vede per la prima volta la statuina della santa. I due amici si ubriacano insieme al bar Paradox. Incontra una seconda volta il misterioso uomo dell’inizio che gli presta un’altra volta duecento franchi. Mentre dorme al bar dove si è riparato dalla pioggia ha un sogno e vede seduti a un tavolo una coppia di anziani con davanti due tazze: sono i suoi genitori. Si commuove e mostra loro il vecchio orologio cipollotto di casa. Quando si sveglia vede che le due tazze ci sono veramente. Sta finalmente entrando in chiesa quando un flic lo ferma per dargli un portafoglio (che il flic pensava avesse perso lui) con dentro altri duecento franchi. Dentro al bar purtroppo ritrova l’amico ubriacone a cui racconta l’episodio del flic e del portafoglio ritrovato. In quel mentre entra nel bar una bambina che sembra la piccola Teresa e si siede a un tavolo. Il clochard con le lacrime agli occhi si inginocchia davanti a lei. Le dice: “È incredibile. Mai avrei pensato che una santa così grande e così piccola, una creditrice così piccola e così grande mi facesse anche l’onore di cercarmi dopo che ho mancato per tante volte il mio impegno di venire da lei. Capisco, lei è molto delicata e premurosa ma io ho mancato. Le devo duecento franchi e posso sdebitarmi finalmente, signorina santa. Ho provato tante volte.”
La piccola gli risponde che deve andare in chiesa perché la messa è quasi finita e stanno arrivando i suoi genitori. Lui barcolla, ha un malore e sviene. Lo portano a braccia nella canonica della chiesa e mentre lo assistono intravede vicino all’altare la piccola Teresa. Lui tiene stretti in mano i soldi e li mostra simbolicamente alla piccola. Morente, ha finalmente mantenuto la parola di “uomo d’onore senza indirizzo”.
L’ostinazione del bene Il film è dedicato a Lalla, moglie di Tullio Kezich, critico cinematografico e grande amico di Olmi, che ebbe la felice intuizione di suggerire il racconto di Joseph Roth – da cui è tratto il film – al regista. Olmi era uscito da poco da una grave malattia neurologica, aveva già girato Lunga vita alla Signora!, Lalla pensò che, in quel momento particolare della sua vita, un racconto del genere potesse interessargli. Il romanzo di Roth parla, infatti, dei piccoli miracoli quotidiani. Tullio Kezich propone a Olmi, che non conosceva Roth, di leggerlo e lui, che non aveva mai fatto un film tratto da un romanzo, ne esce conquistato: “Lo facciamo subito.” La leggenda del santo bevitore sarà il film che darà a Olmi, dopo L’albero degli zoccoli, i più grandi riconoscimenti e che lo ha riproporrà a livelli internazionali. Il film si dipana in tutta una serie di “miracoli” e coincidenze che capitano in rapida successione al protagonista, Andreas Kartak. I miracoli consistono nella donazione da parte di sconosciuti di soldi – il misterioso uomo devoto, la piccola Teresa, un flic – che lui dovrà però restituire alla statuina della santa di Lisieux. Andreas è un clochard divenuto tale a causa di un misfatto: l’assassinio dell’amico che aveva sposato la donna amata. Il detto popolare “i soldi ti cambiano la vita” nel film di Olmi è vero solo in apparenza. È vero perché ad Andreas si aprono possibilità insperate di tornare alla normalità, non solo nei consumi e nei beni materiali, ma anche nelle relazioni umane. Apparentemente perché – come quelle persone a cui capita di vincere grandi somme di denaro a qualche lotteria e però sono incapaci di gestirle – quelle opportunità lui le spreca: non più abituato ad avere denaro resta sostanzialmente subalterno all’ebbrezza che si accompagna a questa nuova condizione di non indigenza. Andreas manca più volte all’impegno assunto della restituzione del denaro, ma manca ancor di più simbolicamente a questi appuntamenti di rinascita che la vita gli dona. Il denaro rappresenta la possibilità di riprendere in mano il proprio destino. In questo passaggio esistenziale così significativo si ripropongono alla sua mente momenti e persone importanti del suo passato. È la memoria che bussa e che gli fa ripercorrere istanti salienti: la donna che amava, l’assassinio non voluto dell’amico-rivale, i compagni d’infanzia, i genitori.
Gli amici ritrovati casualmente si approfittano più volte della sua buona fede e della sua ingenuità e saranno l’ostacolo alla restituzione del denaro. La sensazione che se ne ricava è di un passato non ancora pienamente risolto che incide pesantemente sull’oggi e sui compiti che lo attendono. Ma qualcosa, tenacemente, resiste. Quando si presenta nel bar Paradox una bambina dalle sembianze di Teresa, Andreas crolla e, piangendo, si inginocchia di fronte alla santa che è il simbolo della sua redenzione. Sa che ha mancato tante volte, ma di fronte all’ostinazione di volerlo salvare di Teresa e dei suoi emissari – l’uomo misterioso, il flic – la sua mente vacilla, sviene e, infine, muore in chiesa. Ma con stretti in mano i duecento franchi per Teresa, e interiormente salvo.
IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO [1993] Soggetto: dal racconto omonimo di Dino Buzzati. Sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Roberto Cicutto e Vincenzo di Leo per Aura Film/ Mario e Vittorio Cecchi Gori/ Penta Film. Interpreti: Paolo Villaggio, Giulio Brogi.
Sinossi Il colonnello Sebastiano Procolo, un vecchio militare in pensione avido, incattivito e senza affetti − interpretato da Paolo Villaggio −, eredita dal cavalier Morro, per conto del nipote Benvenuto ancora minorenne, una grande casa e un terreno boschivo, chiamato Bosco Vecchio con l’impegno di dedicargli tutte le cure necessarie al suo mantenimento. In realtà il colonnello, abituato a una vita militaresca, vuole impossessarsi del bosco al posto del nipote e imporre radicali cambiamenti, in primo luogo il taglio massiccio degli alberi per collegare la casa alla strada. Ma nel bosco esistono molti geni, spiriti benefici sia tra la vegetazione sia tra gli animali che comunicano tra di loro e che possono essere ascoltati solo dai bambini che hanno ancora una purezza d’anima. Tra di essi vi è una gazza che funge da sentinella per l’arrivo di sconosciuti: un segnale, una persona. Un forestale che in realtà è anch’egli un genio del bosco racconta al colonnello la storia del bosco e del brigante Giaco. Il brigante braccato fu colui che decise di dar vita al bosco per avere un luogo in cui nascondersi. Il forestale-genio mette in guardia il colonnello che toccare il bosco sarebbe una malvagità. Procolo infastidito dai versi notturni della gazza le spara e la uccide. Il colonnello, nonostante gli ulteriori consigli del forestale, non sente ragione e fa iniziare il taglio degli alberi con la relativa separazione del bosco in due parti. Una notte segue il forestale e sente che parla con gli esseri del bosco, dice agli altri geni che c’è un solo modo per fermare l’azione violenta e dissacrante di Procolo: liberare il vento Matteo che è stato rinchiuso vent’anni prima in una caverna. Allora il colonnello decide di far saltare la roccia dentro cui si trova il vento Matteo e si accorda direttamente con lui: lo libera, ma dovrà rispondere ai suoi ordini. Quando viene tagliato il primo albero tutti i geni del bosco sono presenti – come se fosse un rito religioso – a omaggiarlo e a dirgli che ora potrà tornare nella grande foresta.
Intanto il nipote Benvenuto insieme ad altri amici una notte fugge dal collegio e va nel bosco ad ascoltare un concerto con coro provocato dal vento Matteo. Il taglio degli alberi continua incessantemente e il forestale dice a Procolo che “gli uomini a una certa età cambiano e diventano irriconoscibili, non rimane più nulla di quello che erano da piccoli”. Le stagioni si susseguono, arriva l’estate e un giorno sopraggiunge un vecchio con un carretto e una grande cassa da cui fa uscire centinaia di farfalle. Urla al colonnello che è la sua anima che è volata via. È inverno, Procolo sente un rumore continuo che lo inquieta, convoca il forestale che gli dice che il rumore rappresenta il male che si è inserito dentro gli uomini, e anche dentro di lui. Il rumore-male è arrivato il giorno delle farfalle da cui sono usciti i bruchi che stanno divorando le foglie delle piante e distruggendo tutto il bosco. C’è solo un modo per salvare il bosco dalla distruzione ed è parlare con il vento Matteo, cosa che Procolo fa su consiglio della nuova gazza, la sorella di quella uccisa. Con l’aiuto del vento i bruchi vengono sconfitti. Il piccolo Benvenuto si ammala e in un primo tempo lo zio colonnello tiene il solito atteggiamento duro e militaresco. Una notte a trovare il colonnello viene la sua ombra-anima e gli dice che è cambiato, non è più lo stesso di quando era militare. L’ombra-anima ha deciso di lasciarlo perché non lo riconosce più e per questo non sarà più in pace. Procolo si accorge che il nipote sta morendo, entra in crisi e decide di andare a parlare nel bosco con il forestale-genio per chiedergli aiuto. Il forestale gli risponde: “A volte gli uomini muoiono perché devono morire, ci sono leggi che non si possono spezzare. Ma quando si tratta di un bambino noi geni possiamo provare, conserviamo ancora qualcosa della nostra antica potenza.” Procolo è pronto a fare qualsiasi cosa purché Benvenuto si salvi. Il genio replica: “Lo sai cosa vogliamo. Che ci lasci in pace. Che non si tagli più nemmeno un albero.” Procolo acconsente. È la fine dell’anno, è mezzanotte, il vento Matteo va a trovare il colonnello e gli dice che il suo desiderio di ereditare tutto il bosco si è avverato perché il nipote Benvenuto è morto sotto una slavina. Procolo sconvolto esce nella notte e nella tormenta scava nella neve ma non lo trova. Il colonnello sta morendo congelato e tutti i geni escono per dargli l’ultimo saluto. In realtà si è trattato di un brutto scherzo del vento Matteo: Benvenuto dorme tranquillo nel collegio. Il vento Matteo ha voluto punire Procolo perché si era vergognato di avere un cuore, di essere come tutti gli uomini. Procolo, con il suo ultimo gesto, si riconcilia con la propria anima. Mentre intravede un battaglione di giovani soldati accompagnati da un’allegra musica di una banda militare, muore.
L’avidità umana e la natura salvifica
Il film di Olmi è una straordinaria e attualissima favola sul tema ecologico. La figura del colonnello Procolo è un emblema molto efficace, con tratti un po’ grotteschi, del pensiero dominante che, incurante dei segnali che gli arrivano dalla natura e oggi anche dalla scienza, continua la sua incessante distruzione dell’equilibrio ambientale e climatico della Terra. Il colonnello, che è privo di affetti significativi ma è posseduto dall’avidità, arriva nel Bosco Vecchio, un millenario santuario naturale, e proclama: “Il padrone sono io, comando io.” Con il suo comportamento militaresco e decisionista vuole imporre il suo dominio e non ascolta niente e nessuno: né i domestici della casa del cavalier Morro, lo zio che aveva mantenuto un equilibrio nel bosco, né i forestali, né gli animali e le piante che sono i geni e gli spiriti benefici che abitano e preservano da sempre il bosco vecchio. Procolo simboleggia il progresso senza limiti né vincoli: e, quindi, dà il via al taglio indiscriminato degli alberi per realizzare la strada che collegherà più agevolmente la casa al paese. Il resto sono sciocchezze, leggende, romanticherie. Ma la natura attaccata e offesa si ribella. Il vecchio con il carretto e la cassa piena di farfalle rappresenta la vendetta della natura: se il bosco deve morire lo sarà per via naturale e non per mano dell’uomo. È solo a questo punto che inizia, anche se parzialmente, la crisi del colonnello: deve chiedere aiuto al vento Matteo per sconfiggere i bruchi e salvare il bosco. Quando il nipote Benvenuto si ammala e lui continua ad avere un atteggiamento duro e distaccato la sua ombra-anima lo lascia, non lo riconosce più. È la separazione totale tra la sua mente dominata dall’avidità e dalla durezza e la sua interiorità. Ma è anche il momento della sua metanoia. Si accorge che il nipote sta morendo anche per sua responsabilità e finalmente il suo orgoglio si piega: chiede aiuto ai geni, emblemi delle forze della natura. Il suo disegno di onnipotenza e di distruzione del bosco viene definitivamente sconfitto. Il suo ego deve ridimensionarsi e fare spazio al suo cuore, agli altri esseri: il giovane nipote che prenderà possesso del bosco e tutti i geni millenari. Punito con la morte per congelamento ma pacificato nell’anima. È un film non solo ecologico ma altamente spirituale, nello stile non enfatico di Olmi. Una spiritualità che, anche grazie all’arte di Buzzati, arriva a noi dalla terra, dalle piante, dal vento. Un film che fa certamente sorridere di scherno i grandi poteri multinazionali che stanno divorando il pianeta, a loro volta divorati interiormente dall’avidità e da una vergogna che quello scherno non può celare.
IL MESTIERE DELLE ARMI [2001] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Cinema 11 Undici/ Rai Cinema/ Studio Canal, Taurusproduktion. Interpreti: Hristo Jivkov, Sergio Grammatico, Sandra Ceccarelli. Riconoscimenti: 9 David di Donatello 2002, 3 Nastri d’argento 2001, Premio Flaiano 2001, Premio Globo d’oro 2001.
Sinossi Il film narra le vicende di Joanni de’ Medici, conosciuto come Giovanni dalle Bande Nere, soldato italiano di ventura al servizio dello Stato Pontificio durante le guerre d’Italia nella prima metà del XVI secolo. Nel 1526 un’armata imperiale di lanzichenecchi luterani al comando di Georg von Frundsberg scende in Italia con l’obiettivo di saccheggiare Roma e punire il voltafaccia del papa, impiccandolo con un cappio d’oro. A queste armate dell’imperatore tedesco Carlo V – re di Spagna e imperatore del Sacro Romano Impero – si contrappongono le truppe pontificie di Clemente VII al comando del generale Francesco Maria Della Rovere, duca d’Urbino. Tra le truppe pontificie si distingue il capitano Giovanni dalle Bande Nere, stimato per la sua esperienza nel “mestiere delle armi” è considerato già in vita un mito irraggiungibile. Consapevole della scarsità delle proprie truppe, Giovanni adotta la tattica di attaccare con brevi schermaglie i vettovagliamenti degli imperiali in modo da ritardarne la marcia. Il marchese di Mantova, Federico Gonzaga, volendo evitare la guerra sui suoi possedimenti, decide di lasciar transitare liberamente i lanzichenecchi sul suo territorio, negando invece il passaggio, poche ore dopo, alle truppe pontificie guidate da Giovanni. Nello stesso tempo Alfonso d’Este, duca di Ferrara, in cambio del matrimonio di suo figlio con una principessa imperiale e venendo meno ai patti stabiliti col papa, cede alle truppe di Frundsberg un nuovo tipo di arma da fuoco: quattro falconetti, una sorta di primitivi cannoncini, in grado di forare qualsiasi armatura. La domenica del 24 novembre 1526 Giovanni riesce tuttavia a raggiungere un gruppo di soldati imperiali tra i quali c’è lo stesso generale Frundsberg. L’attacco si risolve però in un fallimento: il capitano italiano è ferito gravemente a una gamba da un proiettile esploso da un falconetto. La gamba andrà in cancrena e nonostante l’amputazione dell’arto, Giovanni morirà di sepsi dopo
quattro giorni di agonia. L’esercito dei lanzichenecchi di Frundsberg arriverà così a Roma e la saccheggerà il 6 maggio 1527.
Il senso della guerra Nel titolo c’è già un’indicazione precisa dei temi essenziali del film: le armi, la guerra come mestiere ma anche l’etica del combattimento che ispirava l’azione di Giovanni dalle Bande Nere. Il film viene preceduto da una citazione di Tibullo (I sec. a.C.): “Chi fu il primo che inventò le spaventose armi? Da quel momento furono stragi, guerre… Si aprì la via più breve alla crudele morte. Tuttavia il misero non ne ha colpa! Siamo noi che usiamo malamente quel che egli ci diede per difenderci dalle feroci belve.” Frase che può essere applicata a tutte le innovazioni delle armi da guerra che si sono succedute durante tutta la storia dell’umanità, dalla bomba atomica ai droni. Il film mostra i campi di battaglia dove poveri uomini si sacrificano per un disegno di potere di cui nulla sanno. Dentro questi campi di battaglia avvengono anche episodi, come nel caso di Giovanni delle Bande Nere, di alto eroismo che interessano a Olmi perché su di essi molte volte sono state operate le speculazioni più basse. Infatti, queste grandi figure di eroi sono state utilizzate involontariamente per nobilitare un fatto osceno come la guerra, legata sempre a un disegno di potere. Nel film un attendente legge al capitano Giovanni una frase di Machiavelli: “I danari sono il nerbo della guerra prima ancora della politica.” Una frase che sintetizza profeticamente il senso di gran parte delle guerre anche degli ultimi tempi. A questo proposito il commento di Olmi è molto esplicito: “Le guerre si assomigliano tutte perché le ragioni per le quali le guerre avvengono sono sempre le stesse: il potere politico, gli interessi economici, la superiorità di cultura o religione. Iniziano con piccole incrinature che all’inizio non hanno il segno della gravità, ma più passa il tempo e più diventano delle voragini fino a creare una tale separazione tra gli uomini che è la condizione ideale perché il virus attecchisca nell’umanità. Ma dietro a questa guerra ce n’è un’altra, è la guerra tra la stupidità dei potenti. Una stupidità che non ha rimedi perché non dà, a chi la pratica, la consapevolezza della loro condizione. Questo potrebbe sembrare un discorso senza speranza perché quello che avviene nel film cinque secoli fa avviene ancora oggi e quindi potremmo dire che non è cambiato nulla. Se così fosse non avrei fatto questo film perché di fronte a questa stupidità e alla rinuncia a essere più attenti agli eventi non può non corrispondere un filo di speranza.”17 Nel film il capitano Giovanni de’ Medici appare come un eroe positivo che si batte per una causa che lui giudica giusta, la difesa del papato dagli invasori lanzichenecchi, che va perseguita con un atteggiamento coerente.
C’è infatti una scena nella quale i suoi soldati infreddoliti per scaldarsi nella notte bruciano anche le assi di un crocifisso: Giovanni scandalizzato colpirà un suo sottoposto. Nella vicenda storica Giovanni viene sconfitto grazie all’inganno e al tradimento di Alfonso d’Este, duca di Ferrara e all’utilizzo di inedite armi da guerra, i falconetti, che vengono date ai lanzichenecchi e che rappresentano nel XV secolo un salto di qualità nella potenza di fuoco contro il nemico. Il capitano in uno scontro con le truppe tedesche viene colpito proprio da un falconetto che gli procura una grave ferita alla gamba. Qui simbolicamente Olmi intende mettere l’accento non solo sul salto di qualità tecnico, ma sul fatto che fino ad allora la guerra si faceva sostanzialmente a diretto contatto con il nemico. La spada era un prolungamento del braccio e il nemico lo si guardava negli occhi. Le armi da fuoco operano una separazione dal nemico, lo tengono a distanza fisica ed emotiva. Con l’evoluzione tecnologica questa separazione si allargherà sempre di più fino ad arrivare ai droni che sostituiscono la presenza umana nei conflitti. I nemici diventano obiettivi lontani e anonimi da annientare. In questo modo, come dice Olmi “si perde sempre più la coscienza della sofferenza e della pietà”. Quando Giovanni è in punto di morte, Federico Gonzaga va a trovarlo e si rende disponibile a qualsiasi sua richiesta. Lui risponde lapidario: “Vogliatemi bene quando sarò morto.” A Federico, abbassando lo sguardo, non resta che andarsene. Con questa frase Giovanni intende affermare che nessuna cosa materiale ha più valore della memoria. Ciò che egli desidera resti dopo la sua morte sono le gesta eroiche che lo hanno contraddistinto. La memoria è come una sacralità dell’essere. Giovanni affronta stoicamente l’amputazione della gamba offesa e in quel dolore ha delle visioni, tra cui i momenti d’amore passati insieme alla moglie di un nobile conosciuta dopo un torneo a cavallo. Prima che lui muoia la donna lo informa che aspetta un figlio suo e gli chiede di scrivere una lettera al marito per spiegargli cosa è successo affinché la perdoni, nell’interesse del bimbo che nascerà. Non resterà perciò di lui solo la memoria delle gesta ma anche un bimbo che non conoscerà, sangue del suo sangue, frutto dell’amore provato per quella donna. Quando la fine giunge, Giovanni si rivolge al sacerdote che è venuto per dargli l’estrema unzione con queste parole: “In questi anni della mia vita sono sempre vissuto come un soldato, allo stesso modo sarei vissuto secondo il costume dei religiosi, se avessi vestito l’abito che voi portate.” Le ultime parole del sacerdote sono: “L’anima mia confida nel tuo perdono e il mio cuore ti aspetta, più che le sentinelle, l’aurora.” Tutto si è compiuto. Il film si conclude con lo sguardo simbolico e sognante di Giovanni de’ Medici
per il figlio ormai cresciuto che lo osserva da dietro un’inferriata: uno sguardo dolente da cui sgorgano, sante, le lacrime del distacco e del rimpianto. Intervista video a Ermanno Olmi presente nel DVD del film realizzato da Multimedia San Paolo. 17
CANTANDO DIETRO I PARAVENTI [2003] Sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Cinema 11 Undici/ Rai Cinema/ Pierre Grise Productions/ Lakeshore Entertainment. Interpreti: Bud Spencer, Jun Ichikawa, Sally Ming Zeo. Riconoscimenti: 3 David di Donatello 2004, 4 Nastri d’argento 2004.
Sinossi In incipit compare una citazione di Omero: “Infuriava una terribile tempesta che solo un grande poeta potrebbe descrivere…” Il film ha inizio con un giovane studente che si ritrova per errore in un piccolo teatro fuori mano nel quale, durante la rappresentazione, è possibile ottenere prestazioni sessuali. Un vecchio capitano – interpretato da Bud Spencer – dal palcoscenico situato nella sala centrale sta recitando un monologo sul fascino della pirateria, per poi introdurre il racconto delle vicende di Ching, la più ammirata piratessa ai tempi della Cina Imperiale. Ching è la vedova di un temuto ammiraglio pirata che aveva tormentato le coste cinesi mettendo a ferro e fuoco i villaggi, nonostante le drastiche misure prese contro di lui dai funzionari imperiali. Una notte l’ammiraglio viene avvelenato e ucciso a tradimento dai suoi finanziatori, offesi per la sua disponibilità a collaborare con l’imperatore. Incapace di accettare la morte del marito, Ching decide di indossare l’armatura del pirata e di continuare l’opera di scorribande e tenere alto l’onore offeso da un gesto così vigliacco. Ad affiancarla nella guida della flotta troviamo lo stesso capitano portoghese, narratore nel teatro, in un continuo controcanto tra racconto e rappresentazione. La vedova Ching si rivolge ai suoi pirati con queste parole: “L’onore offeso non si lava con le parole, né con il sapone. Indosserò la sua corazza, impugnerò la sua spada così che i naviganti di questi mari scrutandoci da lontano crederanno ancora di scorgere la nobile figura dell’ammiraglio Ching al suo posto di comando. Né con i generali corrotti, né con gli ingordi azionisti.” Le gesta impavide che compie le fanno guadagnare una grande fama, ma le sue azioni intaccano la stessa collaborazione che il defunto compagno intendeva stipulare con il governo cinese. Al tempo stesso introduce nuove regole di comportamento e rispetto delle merci saccheggiate e delle donne rapite.
La vedova rivendica una sorta di pirateria etica, suscitando l’entusiasmo dei pirati depressi per la morte dell’ammiraglio. All’assistente che le chiede: “Il braccio di una donna riuscirà a reggere il peso della spada?” Risponde: “La forza del braccio è nella ragione che lo muove.” La fama della vedova Ching e delle sue imprese raggiunge quella dei più agguerriti pirati che battono i quattro mari della Cina. Infatti i cinesi praticano la pirateria da tempi antichi. Per porre termine alle ripetute scorrerie lungo i villaggi costieri il governo imperiale ordina l’evacuazione di tutti i villaggi e la distruzione – da parte delle popolazioni che dovranno stabilirsi definitivamente all’interno – di tutte le imbarcazioni e di qualsiasi attrezzatura utile alla pesca. In questo modo i pirati restano all’asciutto, senza più bottino. Alla morte del vecchio imperatore, il figlio Kai Qing appena asceso al trono, affida al supremo ammiraglio Kwu Lang il compito di combattere la piratessa. La flotta imperiale attacca i pirati in uno scontro notturno, ma viene sconfitta dalle forze di Ching e l’ammiraglio Kwu Lang si toglie la vita per lavare il disonore subito. Il comando supremo delle flotte imperiali passa nelle mani di Thin Kwei, stretto parente dell’imperatore, e il governo prepara una grande armata per attaccare e distruggere la vedova Ching. Il suo credo è: “Nello scontro della guerra il primato è delle forze in campo, ma nello scontro tra le forze il primato è della mente.” A un certo punto si vede la vedova che guarda con intensità il figlio di un’altra piratessa, come a sottolineare che qualcosa di importante – come donna – le manca nella vita. È il primo momento nel quale compare la sua identità femminile. Il secondo è quando viene ripresa in una notte di luna piena nella sua solitudine e raggiunge nell’oscurità un bellissimo e giovane pirata. Ma la battaglia finale con la grande flotta imperiale è inevitabile. Non era mai accaduto che il principe imperiale, “Il figlio del Cielo”, presenziasse a uno scontro in mare. Il discorso della vedova a tutti i pirati prima della battaglia è: “Siamo stati onesti fuorilegge che hanno rischiato la vita ogni giorno con lealtà. Altri invece cosiddetti rispettati cittadini, rispettabili e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di queste nefandezze, questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.” È Il suo testamento spirituale. A questo punto accade l’imprevedibile. Dopo avere ammainato le vele, dalle navi della flotta imperiale si levano in cielo degli aquiloni che riportano messaggi per la piratessa seguendo un’antica tradizione: ogni aquilone riporta sulle proprie ali frammenti di un’antica favola cinese, con la quale l’imperatore chiede alla vedova Ching di arrendersi senza combattere. Le scritte sulle ali degli aquiloni contengono un messaggio simbolico per la
vedova. In uno di questi vi è scritto: “Del castigo e del perdono.” Inizia qui la metanoia della piratessa. Parla con la sua cameriera – che era la favorita del mandarino quando il marito ammiraglio affondò la nave di quest’ultimo – per avere un consiglio sull’interpretazione della scritta dell’aquilone. Entrando come in uno stato di meditazione si fa portare tutti gli aquiloni per leggere il significato delle diverse scritte: “Il Drago Imperiale, sovrano del vento e della pioggia, invoca la farfalla perché ripieghi le sue ali sui petali dei fiori. Il Divino sovrano è il giudice supremo del castigo e del perdono. Attende il ritorno della farfalla tra i fiori del suo giardino celeste.” Sentendosi ormai sconfitta, vista la disparità delle forze a confronto, Ching decide di arrendersi al nemico deponendo l’armatura, buttando nel mare la spada e consegnandosi in abiti femminili per risparmiare al proprio equipaggio un inutile conflitto. Sull’ammiraglia imperiale incontra l’imperatore che le chiede perché combattere essendo “il perdono più forte della legge”. La vedova Ching si accorge che il perdono è l’unico mezzo per evitare di far soffrire chi le sta accanto. Il film si conclude da dove è iniziato, nel teatro. Il capitano narratore spiega l’epilogo della storia: da quel momento tutti i mari conobbero la pace, gli uomini non ebbero più bisogno di armi per combattere e i giorni vennero rallegrati dalle voci delle donne che “cantavano dietro i paraventi”.
La legge, la vendetta e il perdono La sceneggiatura del film fa riferimento a documenti conservati negli archivi di Pechino: Memorie concernenti il Sud delle montagne Meihling e l’opera del poeta cinese Yuentsze Yunglun Piratessa Ching, dedicata all’epopea della piratessa. Molte scene del film sono girate in teatro a rappresentare la sua natura di favola, di apologo non realistico. Il film si caratterizza per la scelta stilistica di Olmi di iniziare il racconto sul palcoscenico di un teatro dove gli attori, a partire dal capitano narratore, introducono la vicenda che poi si svolgerà nel Lago di Scutari in Montenegro. Anche la presenza per errore di un giovane capitato nel piccolo teatro dove si rappresenta la storia, disorientato e turbato dal piacere dei sensi e accompagnato da una raffinata prostituta che ha le stesse fattezze della protagonista, la piratessa Ching, crea un gioco di rimandi e allusioni che aprono alla possibilità di leggere il film su più livelli. Il giovane cercava una conferenza di cosmologia e, in effetti, in quel teatro è come se fosse entrato in cosmi sconosciuti: quello della pirateria, quello della sensualità. Questo film, a differenza di altre pellicole sui pirati, ha un messaggio di pace. Nel corso della narrazione il conflitto si sposta da un livello materiale a uno
morale: da uno scontro fisico a un confronto di valori, fra legge e perdono. C’è nell’apologo una doppia metanoia: quella maschile del figlio dell’imperatore, che con lo stratagemma delle frasi scritte sugli aquiloni sposta il conflitto su un altro livello − la forza si combatte con l’intelligenza che viene dal cuore, col perdono; e quella della piratessa, che rinuncia al potere maschile acquisito in anni di arrembaggi e razzie e torna sotto le ali imperiali, che sono sì un potere maschile ma in questo caso equanime, illuminato. Prima che accada lo scontro finale con la flotta imperiale, decide infatti di togliersi gli abiti maschili del marito pirata e rimette quelli da donna: ripudiando così la violenza, aprendosi al perdono e, uscendone, in questo modo, vittoriosa. Come avviene nelle fiabe dove le principesse – indossando abiti maschili – sottopongono a impossibili indovinelli i loro pretendenti a cui poi fanno tagliare la testa. Alla fine però sposeranno solo il principe che – non usando armi maschili – le farà sorridere e che in questo modo le ha liberate dalla loro armatura difensiva. Tutto questo è di grande attualità. Le donne che, fortunatamente, sempre più occupano posizioni di potere, in alcuni casi purtroppo lo fanno rinunciando alla loro essenza femminile, ricopiando stereotipi maschili. Nella notte che precede lo scontro finale la vedova Ching “vede” il marito morto e l’ex favorita le dice: “Se accetti un gesto gentile devi deporre la spada.” Per lei deporre le armi è quasi una liberazione da un compito gravoso che si era posta per vendicare l’uccisione del marito. Quando si inchina e a testa bassa attende il perdono del principe qualcosa dentro di lei si scioglie, qualcosa nella sua interiorità torna in un posto più naturale. A questo proposito Olmi ha detto: “È un apologo che anche oggi potrebbe essere di grande attualità. Mi piacerebbe ancora sentire le donne, come dice il poeta, cantare dietro i paraventi rallegrando il giorno. È la stessa cosa che avveniva nelle nostre campagne nei pomeriggi assolati e si ascoltava il canto di una donna. Questa è una cosa confortante e un’immagine di pace assoluta. Quando il cuore di una donna canta vuol dire che siamo tutti in pace. Nel Mestiere delle armi la pacificazione auspicabile si affermava passando attraverso il dolore della morte, qui invece la realtà storica è trasfigurata in un contesto leggendario con i contorni della favola, dell’apologo.”18 Il messaggio più forte del film di Olmi si trova nella sua conclusione: “Perché combattere?” Gli aquiloni delle scene finali si sostituiscono, con la loro leggerezza, alle armi a dimostrazione che non sempre è necessario arrivare allo scontro per trovare una soluzione, ma che perdonare può essere un atto più potente di qualunque altra arma che l’uomo possiede. È un invito a trovare altre soluzioni, a dialogare, a comprendere come raggiungere il cuore dell’altro. 18
Intervista televisiva di Vincenzo Mollica, Rai Uno.
CENTOCHIODI [2007] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Luigi Musini e Roberto Cicutto/ Cinema 11 Undici/Rai Cinema. Interpreti: Raz Degan, Luna Bendandi.
Sinossi Il film inizia con il ritrovamento di cento preziosi incunaboli inchiodati al pavimento della biblioteca universitaria di Bologna. Chi ha compiuto l’atto sacrilego è un giovane assistente di Filosofia della Religione che, con questo clamoroso gesto simbolico di ribellione, ha voluto colpire il simbolo di una cultura vecchia e separata dalla realtà. Alla vista della crocefissione dei libri il reverendo tradizionalista crolla per lo sgomento mentre il preside, avvisato del fatto, arriva inguainato in una tuta nera con una grande motocicletta ed esclama, in forma ben poco accademica: “Porca troia!” Il giovane assistente universitario ha deciso di abbandonare la propria vita di intellettuale affermato e scomparire senza lasciare alcuna traccia. Si congeda dagli studenti prima dell’estate con una frase di Karl Jaspers: “Viviamo in un’epoca in cui ogni spiritualità si converte in profitto. Tutto viene fatto in vista di un guadagno. Un’epoca in cui la vita stessa è una mascherata e la felicità del vivere è falsa come l’arte che la esprime. In una simile epoca di perduta genuinità è forse la follia la soluzione per la nostra esistenza?” È una frase che lascia gli studenti scioccati. Una studentessa indiana gli chiede un colloquio perché vuole fare uno studio sul tema della figura femminile all’interno delle grandi religioni: la donna come tramite della volontà divina, la donna complice di Dio. La giovane gli dice: “L’unica verità per il mio popolo è la religione.” Lui risponde: “La verità è che la religione non salva il mondo. Non ne fa un luogo migliore. Si guardi attorno. Siamo circondati dal sapere universale. Quanta verità è stata proclamata in questi libri, a cosa sono serviti? A ingannarci gli uni con gli altri.” Il giovane assistente fugge in auto verso il Po, l’abbandona sotto un ponte e lancia le chiavi nel fiume. Mentre le forze dell’ordine lo cercano per quell’atto di vandalismo in biblioteca, sceglie di stabilirsi in un cascinale in rovina lungo le rive del fiume dove impara a vivere con lentezza e a entrare in sintonia con la natura. Viene accolto con semplicità dagli abitanti del luogo, che lo chiamano,
scherzosamente ma non troppo, Gesù, per il suo aspetto e la sua scelta di vita. Raggiunge un rustico abbandonato e brucia il libro che doveva pubblicare. Poi sistema meglio che può il rustico per poterlo abitare. È estate e vive assorto nella magia della natura e del fiume, anche se è già evidente la distruzione dell’ecosistema del Po a causa dei pesci siluri che fanno fuori tutte le altre specie. Una sera va a ballare con la giovane panettiera nella balera all’aperto suonano il valzer “Non ti scordar di me, la vita mia legata a te…”. C’è un momento di magia quando passa un’imbarcazione sul Po con gitanti che stanno ballando lo stesso valzer. Il postino e i vecchi del paese – che hanno costruito un casotto abusivo lungo gli argini del fiume dove giocano a carte e ballano – gli danno una mano a ristrutturare il rustico. Diventa amico degli anziani. Lui racconta loro il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana quando trasmuta l’acqua in vino, che era finito. Poi racconta a un vecchio, che sogna spesso il figlio che se ne è andato via con la giovane con cui ha avuto un bimbo, la parabola del Vangelo del figliol prodigo. Arrivano però tecnici e geometri del Comune per prendere le misure dei terreni e delle costruzioni, compreso il loro casotto, di cui è stata dichiarata la pubblica utilità perché coinvolti nel Progetto Grande Porto Fluviale del Medio Po. I vecchi riuniti per decidere cosa fare dicono al giovane frasi che esprimono una semplice sapienza: “La nostra vita è stata sempre più sull’acqua che a casa nostra”, “Ho sognato che c’erano i pesci di una volta, i branzini, i persici e i lucci. Io li guardavo e loro non scappavano. A un certo momento ho visto che ridevano, ridevano come noi”, e il sempliciotto del gruppo conclude: “Il fiume va lontano.” Ma il progetto e gli scavi procedono. Arrivano una forte ammenda e lo sgombero immediato. Il giovane chiamato Gesù decide di pagarla con la carta di credito ma in questo modo si fa rintracciare dai carabinieri. Una sera arriva la ruspa per sgomberare il casotto e gli anziani gli si parano davanti sedendo nella stradina del bosco. Questo è il discorso d’addio che il protagonista fa ai vecchi prima di seguire i carabinieri. “Non siate stupiti se vi cacceranno da questi luoghi… Molti si illudono con le loro imprese di poter fare cose meritevoli ma senza il rispetto per ciò che regola la vita. Ma arriva anche il momento che la natura stessa si ribellerà a tutte queste offese e cancellerà ogni cosa che umilia tutte le creature.” C’è poi un colloquio tra il maresciallo e il protagonista sull’importanza dei libri nella vita, nel quale il giovane assistente universitario cerca di spiegare le motivazioni del suo gesto vandalico in biblioteca. Si vede la scena dissacrante nella quale l’assistente inchioda tutti i libri al pavimento. A un certo punto egli legge su un libro antico: “Bisogna che ognuno torni a nascere. Chi non comincerà dal principio non potrà conoscere la verità.” C’è anche il colloquio in cella con l’anziano sacerdote che ama i libri e che lo
rimprovera aspramente per quello che ha fatto. Il prete dice: “I libri sono amici fidati.” Lui risponde: “Dio non parla coi libri, i libri servono qualsiasi padrone e qualsiasi Dio.” Alla fine i vecchi che hanno potuto salvare il loro casotto preparano una festa serale e attendono, con le candele a lato della stradina del bosco, che il giovane chiamato Gesù torni. Ma non tornerà più, con grande dispiacere della panettiera innamorata.
Il sapere, la saggezza Nella primavera-estate 2005 fra Bologna e la provincia di Mantova (San Benedetto Po, Bagnolo San Vito), Olmi torna a girare “lungo il fiume”. Il film è un apologo. La forma dell’apologo è stata presente più volte nei film di Olmi, come nel caso di Cantando dietro ai paraventi e, più recentemente, di Il villaggio di cartone. C’è una citazione di Raymond Klibansky all’inizio del film: “Ma i libri – pur necessari – non parlano da soli.” Olmi ha più volte espresso forti critiche sia alla cultura laica intellettualistica sia alla spiritualità istituzionalizzata, entrambe, a suo parere, separate dalla realtà e dalle condizioni dei deboli. Centochiodi ha il suo fondamento narrativo in questa grande tematica. Olmi la tocca utilizzando un paradosso ben evidente già nel titolo. Il sapere depositato da secoli nelle università e nelle biblioteche inchiodato al pavimento. Un’immagine, una provocazione fortissima che ha sollevato polemiche da parte del mondo culturale e accademico. Oltretutto i libri inchiodati nel film non sono romanzi recenti ma libri antichi, incunaboli. Essendo Olmi un regista che non ha mai amato il coup de théâtre, c’è da chiedersi perché è ricorso a una scelta stilistica e narrativa così forte. Evidentemente per lui la cultura e la spiritualità espresse dalle istituzioni – la Chiesa, l’Università – sono oggi così lontane dai reali problemi delle persone e in particolare dei deboli che è necessario, per cambiare, un atto trasgressivo come quello di inchiodare libri preziosi. Olmi appare disincantato, disilluso sulla possibilità del sapere tradizionale di autoriformarsi senza un atto che faccia da scintilla a un cambiamento divenuto improrogabile. Inchiodando i libri è come se Olmi avesse voluto “inchiodare” alle proprie responsabilità le istituzioni che troppo a lungo non hanno mantenuto fede ai loro compiti: educare le persone a una cultura e a una spiritualità autenticamente vissute. Le due istituzioni messe sotto accusa sono rappresentate nel film da due figure opposte ma complementari: il sacerdote tradizionalista e fervido sostenitore dei libri antichi e il preside ipermoderno dell’università che arriva su una scattante motocicletta e che alla vista del misfatto si esprime con un perfetto linguaggio urbanizzato, ma per niente civile. Entrambi sono scandalizzati dall’avvenuto ma incapaci di cogliere le motivazioni della provocazione, derubricata ad atto
vandalico. Questa loro incomprensione è la stessa delle istituzioni culturali e religiose quando non riescono a cogliere le richieste di cambiamento, qualche volta espresse in modo trasgressivo, che salgono dalla società. Chi è nel film il soggetto che trasgredisce l’ordine costituito e che quindi si pone come alternativa simbolica a quel sapere separato dalla realtà? È un giovane assistente universitario che proviene e conosce bene quel sapere e che ne è disilluso, tanto da rispondere alla giovane studentessa indiana, che ancora crede nella forza della religione, che tutti i libri di cui sono circondati non sono serviti ad altro che a ingannare l’umanità. L’assistente, nell’ultima lezione prima della pausa estiva, aveva citato una frase di Karl Jaspers che appare anch’essa provocatoria. Quella frase inaugura un autentico cambiamento della sua vita: lascia università, auto e agi quotidiani e va a vivere in un rustico abbandonato lungo il fiume Po. Chi troverà come sostegno alla sua scelta così radicale? Olmi guarda ai semplici, agli umili. Il postino e la panettiera del paese, gli anziani che si sono sistemati in un casotto abusivo dove fanno le belle cose che gli anziani da sempre fanno: giocano a carte, ballano, mangiano insieme. È un’umanità forse ingenua, certamente vera. Chiameranno l’assistente Gesù, un Gesù moderno, laico, attento alla natura, un po’ panteista. Quando il potere, simboleggiato dai tecnici del Comune che fanno i rilievi per il Progetto del Grande Porto Fluviale del Medio Po, si farà vivo per sgomberare gli edifici abusivi degli anziani sarà Gesù che pagherà per loro l’ammenda. Degli agi trascorsi ha infatti mantenuto la carta di credito. Ma in questo modo lo stesso potere, in questo caso i carabinieri, lo rintraccia e lo accusa del misfatto dei libri. Gesù nell’accomiatarsi dai vecchi dice parole ancora una volta dure, sferzanti verso un potere che non è in relazione con la vita e la natura. C’è un ultimo colloquio altamente emblematico di ciò che Olmi vuole comunicare con questo film. È quello che si svolge tra Gesù e il maresciallo dei carabinieri che lo interroga nella caserma dov’è rinchiuso. Gesù dirà al maresciallo: “Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico.” In queste parole così definitive Olmi esprime una invocazione, quasi disperata, per un ritorno dell’umanità ai valori della solidarietà, della vicinanza affettiva, di una conversazione fatta di parole, sguardi, sorrisi. Dove ciò che chiamiamo cultura non è separata dalla vita e dalla relazione umana.
IL VILLAGGIO DI CARTONE [2011] Soggetto e sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Luigi Musini/ Cinema 11 Undici/ Rai Cinema. Interpreti: Michael Lonsdale, Rutger Hauer, Alessandro Haber, Massimo De Francovich.
Sinossi Il film è dedicato a Suso (Cecchi D’Amico) e Tullio (Kezich). A esergo compare la scritta “Diabasis” – un antico vocabolo greco il cui significato è: la parola che si fa atto, azione, gesto. Una piccola chiesa deve essere sgomberata per far posto a un’altra costruzione. Il film inizia con la disperazione del vecchio sacerdote: “Devo tenere in mente, tutto, come in questo istante… Mio Dio.” Nella chiesa prima entra un bimbo africano sorridente che poi scappa, poi gli operai con i mezzi meccanici mentre un sacrestano cupo e rassegnato assiste senza parlare. Gli operai tolgono anche il crocefisso mentre il sacerdote piange per il Cristo ancora una volta deposto. Alla tv compaiono le immagini di una piccola imbarcazione andata alla deriva, forse di migranti. Il sacerdote, anche se straziato, vuole restare nella canonica. Intanto un giovane clandestino si nasconde. Il prete fa un’omelia struggente alle panchine vuote rimembrando le messe passate e dicendo: “Certe domeniche mi capitava di provare una sensazione di vuoto che allora non capivo. Solo adesso di fronte a questa solitudine mi rendo conto che quel vuoto era il dubbio dentro di me e io non volevo riconoscerlo.” Altri clandestini si nascondono mentre si sente il frastuono di elicotteri e di sirene della polizia che li cerca. I clandestini entrano nella canonica con un ferito e il sacerdote decide di usare il mobilio della canonica per far alloggiare, in qualche modo, l’uomo bisognoso d’aiuto. C’è un sorriso di solidarietà tra due donne clandestine mentre un bimbo mangia i biscotti che gli ha dato il prete. Nella notte i clandestini montano alcune piccole tende nella chiesa come se fossero in un deserto. Un giovane telefona alla madre di un altro ragazzo per informarla che suo figlio non ce l’ha fatta. Il sacerdote si alza e va a pregare inginocchiato davanti a un piccolo crocefisso: “Venite adoremus…” e piange sconsolato. C’è un dialogo tra lui e il sacrestano che non condivide la scelta di ospitare i
migranti: “Perché ha fatto entrare quella gente nella nostra chiesa?” “Perché è una chiesa.” “Quella è gente diversa, avere a che fare con loro è un rischio per tutti.” “Quando la carità è un rischio quello è il momento della carità.” A questo dialogo ne segue un altro tra il prete e il medico non credente che è venuto a visitare il ferito: “In altri tempi i preti e i medici hanno collaborato.” “Una volta il prete era il prete e il medico faceva il medico e neppure Dio fa il suo dovere come vede.” “Ha mai provato a pregare?” “Sì, da bambino in un campo di sterminio.” Un libricino sulla Genesi viene ritrovato dopo il naufragio e i migranti ne condividono la lettura. Una clandestina terrorista lo commenta: “La Madre dell’Umanità è stata uccisa e il tempo della rassegnazione è finito. La ricchezza di pochi si paga con la miseria di molti, ma la nostra miseria è l’inizio della loro fine. Quelli che hanno tutto ragionano seduti sulle loro pance piene di cibo e noi risponderemo con il ventre pieno di esplosivo.” C’è un dialogo tra lei e un giovane nero pacifico. Torna il medico a trovare il prete malato e quest’ultimo gli racconta i suoi ricordi più cari: “Proprio in questo periodo le rondini arrivavano a quest’ora del giorno, il cielo si riempiva di voli e facevano acrobazie in mezzo alle cose come una festa. Ah, quante primavere ho visto da questa finestra. Nella nostra devozione religiosa il mese di maggio è dedicato alla Madre di Dio. In quegli anni le chiese si riempivano di giovani perché era una rara occasione per stare con le ragazze, di sera al buio. E cos’erano quelle notti? Nell’aria si sentivano tutti i buoni odori della terra. Quando una sera mi sentivo come se avessi la febbre dentro di me… I miei occhi si incontrarono con quelli di lei e quegli occhi mi hanno tentato per tutta la vita. Quante volte in certe notti mi sono posto sempre la medesima domanda: perché il Creatore ha messo questo fuoco dentro di noi? E poi ci minaccia con il suo castigo. In questi ultimi anni c’è sempre quella medesima domanda che mi perseguita. Se quella sera in chiesa avessi fissato più a lungo quegli occhi cosa ne sarebbe stato di me? Non lo so (piangendo). Ho fatto il prete per fare del bene, ma per fare del bene non serve la fede. Il bene è più della fede.” Il sacrestano aiuta la polizia a entrare nella chiesa per arrestare i clandestini. Arriva il prete, inveisce contro le forze dell’ordine e le scaccia. Poi si rivolge al piccolo Cristo in croce che aveva salvato: “Così da vicino quasi non ti riconosco, cerco i tuoi occhi, ma tu mi guardi da un tempo troppo lontano e io non riesco a sentire per te quella pietà che dovrei. Persino nella pietà quanta menzogna e tu lo sai. Anche tu hai conosciuto la solitudine dell’ultimo respiro.” Un vecchio clandestino racconta la sua storia di quando è arrivato e di come ha cercato di andare avanti vendendo libri per comprare le medicine per i figli rimasti in Africa.
Il prete è morente, un vecchio clandestino lo ringrazia a nome di tutti mentre si preparano a partire. Alcuni decidono di tornare indietro in Africa, altri proseguiranno per l’Europa, ma c’è anche chi sceglie la via del terrorismo. I clandestini escono tutti dalla chiesa ma poco dopo si sentono di nuovo le sirene della polizia e gli elicotteri. Rimane solo il giovane africano integrato mentre un elicottero infrange la vetrata colorata della chiesa. Il giovane spalanca il portone, fuori attendono le macchine della polizia. Al termine del film compare la frase: “O noi cambiamo il corso impresso alla storia o sarà la storia a cambiare noi.” Nei titoli di coda compare anche la menzione “con considerazioni di Claudio Magris e monsignor Gianfranco Ravasi”, personalità con cui Olmi ha scambiato idee e pareri attorno ai temi del film.
Il bene è più della fede Il film è un apologo e rappresenta un seguito ideale di Centochiodi, nella ricerca di Olmi di una spiritualità più autentica. Olmi ne ha raccontato la genesi. Doveva girare un documentario sulle sponde del Mediterraneo per verificare cosa era rimasto di un luogo che era stato, per lungo tempo, il centro del mondo e culla di grandi culture. Ma un infortunio, che gli procura la frattura a una gamba, gli impone di stare a letto per due mesi. A questo punto, anziché andare in giro per il Mediterraneo, decide di convocare le diverse culture in un unico luogo scrivendo un apologo. Infatti il film, che verrà girato nel Palazzetto dello Sport di Bari, intende rappresentare una realtà che è quella dell’immigrazione e del confronto-scontro di civiltà che ne deriva. Il villaggio di cartone è per Olmi il villaggio globale che è fondato sull’apparenza – dell’economia, della finanza, della comunicazione – e non su valori umani. Per Olmi di “cartone” sono le istituzioni, la Chiesa, il consumismo. Una società, un mondo di cartone, come i cartelloni pubblicitari. Un villaggio di cartone che si regge sul profitto e sull’esproprio dei beni naturali ai danni dei più deboli. Come succede attualmente in Africa: infatti l’Occidente rifiuta una reale politica di accoglienza degli immigrati provenienti da quel continente e nel contempo sottrae loro, per due soldi, il bene primario, la terra, comprata sia da multinazionali occidentali sia dal regime comunista cinese. “Diabasis” – la parola che si fa atto – posta da Olmi a esergo del film, simboleggia le parole che non sono di cartone, cui seguono fatti precisi. Per Olmi un vero pensiero deve avere come conseguenza necessaria l’azione coerente, in caso contrario rimane solamente una speculazione filosofica. Ci sono tre figure che emergono nel film e che simboleggiano le diverse posizioni dell’Occidente di fronte al fenomeno dei migranti e più in generale
rispetto al rapporto con gli esclusi. La prima figura è il sacerdote che prova disperazione per l’abbattimento della chiesa e solidarietà per i migranti all’insegna di una fede in Dio e nell’uomo. Per lui la carità non ha bisogno di istituzioni. Colui che vede l’altro che soffre deve diventare suo complice, la carità non è un’elemosina, è un atto d’amore. È la Chiesa che ci fa intravedere oggi papa Francesco. La seconda è il sacrestano che, cinicamente, ha già sposato le scelte del potere economico e politico, non si cruccia più di tanto per la chiesa ma, soprattutto, è totalmente contrario all’ingresso nella stessa dei migranti. È la ragion pratica. Non c’è posto per tutti, tantomeno in chiesa, ed è inutile opporsi al corso della storia e del progresso. Rappresenta l’uomo che non ha più fede e l’ha sostituita con l’adesione allo stato delle cose. L’ultima figura è il medico non credente che avvia un dialogo con il sacerdote, gli confida che non prega più da quando era, giovane ebreo, in un campo di sterminio. Si sente però accomunato al prete da un atto d’amore e di carità verso gli immigrati. Non ha più fede in Dio ma nell’uomo, in qualche modo, sì. Prova ancora pietas per questa povera gente e assiste il sacerdote malato. In questo dialogo tra un credente e un laico c’è spazio per la memoria affettiva, quella del prete che ricorda momenti di vita nei quali fede e amore si sono toccati. Qui Olmi cesella il vero punto di contatto tra chi ha fede religiosa e chi ha valori etici laici. Tutto è nella frase del sacerdote: “Per fare del bene non serve la fede. Il bene è più della fede.” Per Olmi è questo l’autentico, e non intellettualistico, dialogo tra credenti e laici. Nell’apologo ci sono altri personaggi simbolici, come l’uomo di colore già integrato che, alla fine del film, rimane nella chiesa e spalanca le porte alla polizia. Questo spalancamento della chiesa operato dal giovane nero non è una resa al potere e alle sue leggi, in questo caso, ingiuste. Per Olmi è un segno di speranza che gli uomini con uno spirito genuino abbiano la buona volontà di aprire le porte, le porte dell’ascolto reciproco. Quella volontà di apertura verso l’altro che, per il regista, la Chiesa troppo spesso non ha avuto e che si augura che papa Francesco aiuti a ritrovare.
TORNERANNO I PRATI [2014] Sceneggiatura: Ermanno Olmi. Produzione: Cinemaundici/ Ipotesi Cinema/ Rai Cinema. Interpreti: Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Formichetti.
Francesco
Sinossi Inverno 1917, fronte Nord-Est. Notte di luna piena. Su un altopiano innevato, un soldato di guardia all’avamposto canta una canzone napoletana, Tu ca nun chiagne. Altri soldati spalano la neve per creare un varco al mulo che porta in quota il rancio. La notte è silenziosa, magica. Ogni tanto il lieve fruscio di un leprotto o di una volpe risuona nell’aria. L’avamposto è circondato da filo spinato, cavalli di frisia, campanelli per avvertire dell’arrivo del nemico. Un piccolo corteo di soldati si avvicina. Lo guida un maggiore che deve consegnare al capitano dell’avamposto l’ordine del comando di divisione: per facilitare le comunicazioni bisogna raggiungere un rudere poco lontano, esposto al tiro dei cecchini. Il capitano sa che ciò significa mandare a morte sicura i suoi soldati e, imprecando, acconsente per senso del dovere. Il primo soldato – dopo aver baciato un tozzo di pane che ripone sotto il giaccone – esce dall’avamposto, striscia tra la neve ma viene centrato. Il secondo militare è un padre di famiglia, consegna la foto dei figli e si appresta a uscire. Un commilitone si offre al suo posto ma prima di tentare l’impresa si rivolge al superiore: “Se permette comandante mi uccido da solo” – e si suicida, premendo il grilletto del suo fucile davanti ai compagni.19 A questo punto il capitano esasperato urla al maggiore: “Che importa sia fatta giustizia dopo? Dopo è troppo tardi. Rinuncio al grado e riprendo la mia dignità.” E si strappa dalla divisa le mostrine. Il maggiore nomina comandante dell’avamposto un giovane e inesperto tenente, il “tenentino”. C’è smarrimento negli occhi dei soldati, l’attesa del nemico è snervante. La trincea sottoterra è un affresco umano di povertà desolata e disperata: pagliericci, coperte che non bastano a riparare dal freddo pungente, piccole stufe, piatti di latta, biancheria stesa sulla corda, fotografie di figli appese con una puntina. Arriva la posta con le lettere dei famigliari, vengono letti i nomi dei destinatari a cui non corrispondono volti. Olmi riprende con una carrellata piena di pietas queste facce anonime, ammutolite.
Il nemico è invisibile ma di lì a poco si manifesterà con il fragore di cannoneggiamenti sempre più precisi sull’avamposto. Molti soldati moriranno, altri saranno feriti gravemente. Al soldato che cantava viene dato l’ordine di farlo di nuovo ma lui si rifiuta perché “si canta quando il cuore è contento” e attorno c’è solo disperazione e morte. A seguito dell’offensiva nemica arriva l’ordine del ripiegamento dell’intero fronte Nord-Est. I sopravvissuti seppelliranno i morti nella neve, e uno di loro si domanderà: “Dove è nascosto Dio? Ma vuoi, che se non ha ascoltato il figlio, ascolti noi poveri cani?” La Prima guerra mondiale ha avuto diciassette milioni di morti, di cui seicentomila italiani. Al termine del film compare la frase di un pastore sardo: “La guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai.”
Gli umili della terra Il film è dedicato da Ermanno Olmi al padre, che quando era piccolo gli raccontava della guerra dove era stato soldato. Olmi ha preso spunto per la sceneggiatura non da studi storici, ma dalle lettere e dai diari dei soldati. I protagonisti del film sono ancora una volta gli umili, i semplici, i senza nome e identità. I giovani soldati che sono morti a milioni senza sapere il perché della guerra e del loro tragico destino. Uomini portati via ai loro affetti, alla loro esistenza povera ma dignitosa. Il film tocca alcuni dei temi più significativi della poetica di Olmi: gli ultimi, il potere staccato dalla vita, l’insensatezza della guerra, e ha non casuali risonanze con altre sue opere. I volti dei soldati sporchi di fango, stanchi, infreddoliti rimandano a quelli dei minatori di Manon finestra 2, anche se questi ultimi esprimevano un po’ di speranza nello sguardo; il film si svolge in un tempo quasi immobile, in un’unica notte nell’attesa dell’attacco nemico, sembra quasi che il tempo si è fermato, come il titolo del suo primo film; l’attacco poi avverrà con il fragore dei cannoni che rimanda alle mine di I recuperanti; e, infine, l’auspicio contenuto nel titolo Torneranno i prati prefigura che sia possibile un ritorno alla normalità dopo la guerra, la distruzione, l’orrore. Ma il dubbio rimane. Così come avviene in Un certo giorno: dopo l’“incidente” della guerra torneremo come prima? Il film si giova della bellissima fotografia di Fabio Olmi che partendo dal colore è arrivato a tonalità plumbee che rendono molto bene sia la magia della notte di plenilunio e dei monti innevati, sia l’atmosfera di disperazione e crudeltà di quei giorni. Anche la dimensione fonica è una componente rilevante nel film perché mette a confronto il silenzio della natura e la gentilezza dei piccoli animali notturni con lo stupro operato dal rumore assordante e distruttivo dei cannoni. È la guerra che
irrompe su un pezzo di terra immacolata, stravolgendola, violentandola. I volti anonimi dei protagonisti ci sono vicini e richiamano quelli che vediamo quotidianamente nei telegiornali: emigranti nei barconi, profughi siriani, combattenti curdi. Sono gli umili della Terra, come quelli immortalati nelle miniere a cielo aperto del Brasile da un altro occhio compassionevole, quello di Sebastião Salgado. O come quello, anch’esso profondamente umano, di un altro grande regista scomparso tragicamente mentre girava il suo ultimo film: Theo Angelopoulos. Il regista greco che nel film Lo sguardo di Ulisse compie un dolente viaggio simbolico in un’altra guerra più recente, quella dei Balcani. Sguardi pieni di pietas sulla vicenda umana: Salgado, Angelopoulos, Olmi. Ermanno Olmi ha iniziato la sua opera – i primi documentari, sessant’anni fa – con i volti umili dei lavoratori e oggi è giunto a quelli impauriti e tenerissimi dei giovani soldati, sono gli stessi volti della povera gente che non ha potere ma trattiene ancora un po’ di autenticità: il tenentino ricorda Domenico, il giovane impiegato di Il posto. A quei volti, al loro sguardo denso di significato umano Olmi affida un ennesimo, accorato ammonimento: “C’è stato un tradimento nei confronti dei milioni di giovani soldati a cui non è stato detto perché sono andati a morire. Perché non lo abbiamo spiegato? Perché con i morti e i bambini non si bara. Questo è un film per chiedere a loro perdono. Ora, dopo cent’anni, ricordiamo e festeggiamo con discorsi, fanfare, bandiere. Ma se prima non sciogliamo questo nodo di ipocrisia e vigliaccheria resteremo in una fascia neutrale che è già tradimento. Dobbiamo perlomeno chiedere scusa. Ho in mente un ammonimento di Albert Camus: Se vuoi che un pensiero cambi il mondo, prima devi cambiare te stesso.” 19
L’episodio è tratto da La paura (1921) di Federico De Roberto.
INDICE
PREFAZIONE IL CINEMA DENTRO LA VITA Conversazione con Ermanno Olmi Dal piccolo all’universale La poetica di Olmi I DOCUMENTARI I documentari della Sezione Cinema della Edisonvolta Altri documentari I LUNGOMETRAGGI Il tempo si è fermato [1959] Il posto [1961] E venne un uomo [1965] Un certo giorno [1969] I recuperanti [1969] L’albero degli zoccoli [1978] Lunga vita alla Signora! [1987] La leggenda del santo bevitore [1988] Il segreto del bosco vecchio [1993] Il mestiere delle armi [2001]
Cantando dietro i paraventi [2003] Centochiodi [2007] Il villaggio di cartone [2011] Torneranno i prati [2014]