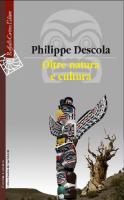Il cinema, e oltre. Diari 1988-1991 8880330845, 9788880330844
309 p.. Molto buono (Very Good) .
188 5 7MB
Italian Pages 311 [310] Year 1997
Polecaj historie
Citation preview
Serge Daney
IL CINEMA, E OLTRE. Diari 1988 - 1991
Editrice
Il Castoro
Serge Daney // cinema, e oltre. Diari 1988-1991 Prima edizione marzo 1997 © Editrice II Castoro S.r.l. Milano, viale Abruzzi 72 Tutti i diritti riservati E-mail: [email protected]
ISBN 88-8033-084-5 Traduzione di Enrico Nosei e Silvia Pareti Titolo originale: L’Exercice a itiprofitable. Monsieur © 1993, Editions P.O.L., Paris Opera pubblicata con il contributo del Ministero della Cultura francese
In copertina: John Mohune in II covo dei contrabbandieri
Progetto grafico di Giorgio Bulzi e Antonina Taccori
Serge Daney è morto nella notte fra rii e il 12 giugno 1992, in seguito a sindrome da immuno-deficienza acquisita (AIDS). Si sarebbe potuto pensare che coloro che chiamiamo, in omaggio a Spinoza, “Ultimi barbarorum” (ultimi in ordine di tempo) lo avrebbero lasciato riposare in pace. Ma non è stato così, ringraziando Dio! Qualche mese dopo la sua morte, su «Libération» del 13 ottobre 1992, la redazione del canale televisivo francese TF1 si lamentava (!) dei “micidiali articoli di Serge Daney" volti a smontare la meccanica dell’informazione-spettacolo durante la guerra del Golfo. Senza saperlo, questi ultimi barbari rendevano un bell'omaggio a Serge di cui, in questo libro, ritroviamo quel pensiero ferocemente gioioso così caratteristico della sua scrittura. Mi sia anche permesso testimoniare che, negli ultimi anni della sua vita, forse infine riconciliato, egli non si considerava più un marginale della società, piuttosto un “minoritario". Che, come diceva lui, non è una buona parola, ma è una parola bella. E.C.
7
Fin da quant?era molto giovane, Serge Daney ebbe chiaro di non esse re posseduto dal desiderio di fabbricare dei film. Qualche volta, forse, le sue fantasticherie lo spingevano in quella direzione, ma egli non vi diede mai molto peso. Amava soprattutto vedere i film degli altri, penetrare nel loro meccanismo, definirne qualche principio singolare, fare confronti col suo sentimento passeggero del mondo, lasciar riposare, scoprire altri film altrove, più lontano, tentare raccordi, dimenticare, ritornare, par lare, scrivere, trovare uno spazio e un pubblico. Credo considerasse i film come attori di una immensa compagnia in aii, nella divina commedia del cinema, anche le comparse hanno un ruolo da giocare e le palesi incompatibilità una parte da svolgere. Egli vide la compagnia abbandonare la scena protettrice dei teatri, dividersi, perdere un po’ della sua anima durante il cammino e filarsela “ognuno per sé..." nei poco sicuri labirinti mediatici. Seguì i cambiamenti del tempo, il suo rannuvolarsi, registrando ciò che all’improvviso i film gli rivelavano del mondo; ma di tutto questo la scrittura non fu che una tappa transitoria. Daney nutriva piuttosto la passione (ter la parola — tentata, suggerita, lanciata come una palla, ripresa come un’eco, sempre all’erta — e per il suo alter ego fìsico, la marcia: l'una facendo coraggio all’altra nel fondo di lui stesso. Dopo il 1968, i numerosi viaggi com piuti definirono in lui i confini di una sorta di nomade’s land in cui avvenne il sereno incontro con il mondo e con la sua analisi. Ma, qua lunque sia divenuto in seguito lo scenario, Daney amava anche quella solitudine che sorveglia la buona tenuta di un testo in cui egli sajieva ancora mantenere viva la traccia di una parola spossessata. E che garantisce un momento di silenzio a tutti quei lettori che temono di non percepire ilfresco mormorio della vita nelfondo di ciò che leggono. È a questo desiderio di ascolto solitario che io attribuisco la passione, tattile e visiva, che Daney nutrì sempre per i libri. Aveva raccolto gran parte dei suoi testi pubblicati sui «Cahiers du Cinéma» fra il 1970 e il 1981 in La rampe, poi quelli scritti fra il 1981 e il 1986 in qualità di responsabile del settore cinema di «Libération» in Ciné-Journal, e infine, in Le salair du zappeur e Devant la recrudescence des vols de sacs à main, gli articoli usciti su «Libération» aventi per oggetto: la televisione quotidiana, i film filtrati dalla televisione, gli avveni menti del mondo socializzati dalla televisione. Nel 1986, quando 9
lascia la direzione del settore cinema del giornale, Daney sogna di fon dare una rivista. Riuscirà a realizzarla solo nel 1991, si chiamerà «Trafic». Ma aveva un altro sogno: quello di scrivere un “vero” libro. Risparmiando le sue ultime forze per la rivista, ne aveva terminato un solo capitolo, “Il carrello di Rapò”, che, non potendo più scrivere, utilizzò come apertura del quarto numero di «Trafìc». Questo libro, che avrebbe dovuto rendere conto della sua vita “letta” in confronto a quella vita più vasta che il cinema gli aveva rivelato e dato incarico di conoscere, doveva contenere una equilibrata lezione morale della quale egli aveva trovato la commovente definizione in una battuta più volte pronunciata dal bambino John Mohune in II covo dei contrabbandieri di Fritz Lang, battuta che nella versione francese del film suona: «L’exercice a été profi table, Monsieur». Dal 1988 alla fine del 1991, Serge Daney annotò sul computer riflessioni, domande, ipotesi su film, registi, fenomeni socia li o politici ormai mediatizzati. Alcune gli servirono come materiale di base per degli articoli, altre no, ma tutte furono corrette e migliorate nella prospettiva di costituire un “giornale di bordo” — che proseguì, più alleggerito, nei primi numeri di «Trafile» - in grado di testimoniare quella che lui sapeva essere la sua ultima traversata delle apparenze. Non si fa menzione della malattia - che tuttavia, per una sorta di fraterna solidarietà e con imparziale caparbietà, egli aveva reso pubbli ca. Tuttalpiù, a partire dal 1990, si può notare una radicalizzazione dei suoi punti di vista, con la conseguente e inesorabile accelerazione del pensiero che riduce le cose al loro schema. Nell’anno 1988 compare pro babilmente qualche errore di data, ma senza gravi conseguenze per lo svi luppo complessivo. Malgrado l’abbondanza dei testi qui raccolti, un certo numero di idee o di sensazioni espresse oralmente non sono state riportate. Non ho dimen ticato l’immagine che gli venne alla mente un giorno parlando delle sinfonie di Bruckner delle quali, riferendosi a quell’esperienza della marcia attraverso una foresta che anche lui conosceva, disse: «Si vede bene come, nelle sue sinfonie, ci siano le pause-radure». Nell’estate 1991 Serge Daney partì per i Vosgi per fare, un’ultima volta, delle lunghe marce a piedi. J.-C. B.
io
IL CINEMA, E OLTRE.
Nell’elenco dei ragazzini che non sono mai stato, ce ne sono cinque, un poco più giovani di me, che hanno condotto, in alcu ni grandi film degli anni Cinquanta, un’esistenza di celluloide. John Powell, John Mohune, Michel Gérard, Edmund Koeler e Antoine Doinel: tutti abbandonati. Qualcuno in America, qual cun altro in Italia, solo uno in Francia. Era il 1959 e ancora ricordo il Gaumont Voltaire, da cui uscii con il mio primo, vero magone. La sala oggi è scomparsa ma non è scomparso il film che lì divenne parte della mia vita e di cui tutti ancora parlano: / quattrocento colpi. Era un magone allo stato puro, una lucidità che solo un bambino sconvolto dalla scoperta che ha appena compiu to può avere: e cioè che la vita dispone senza alcuna attenzione del destino degli esseri umani e che il male arriva presto. Non riesco ancora a capire perché tutti citassero Vigo e parlassero di rivolta quando il mio stato d’animo era diametralmente opposto. Trufiàut sarebbe stato l'autore meno romantico di una Nouvelle vague che, del resto, ad eccezione di Godard, di romantico aveva ben poco. E anche il meno religioso. Persuaso com’era che, oltre la capacità propria del cinema di procedere da un “qui ed ora" a un "culto dei morti”, non esisteva altro mondo. Tutte cose che ho capito solo dopo la sua morte, vedendo La camera verde. Se fossi stato un bambino più normale, mi sarei identificato con Antoine Doinel, cioè Jean-Pierre Léaud. Se questo cinema già eccentrico rispetto alla norma non avesse rappresentato gli inizi della Nouvelle vague, l’identificazione sarebbe stata sem plice e inevitabile. Ma io, cinefilo alle prime armi, ero già l’uomo che sapeva troppo. Sapevo che non era più tempo di tenere separato Léaud da Truffaut, né di credere, sempre nel 1959, che Martin Lassalle non dovesse tutto a Bresson. Divenuti i “modelli” dei loro autori, gli attori non erano più gli stessi. Diventavano indimenticabili perché ad un certo punto un regi sta — o il Cinema - li aveva usati per compiere impudentemente un atto A'amore verso se stesso. Léaud non ne sarebbe più uscito, né Martin Lassalle, che incontrai di sfuggita nel 1986 a Città del Messico e ebbe solo il tempo di dirmi che aveva passato la vita cercando di dimenticare Pickpocket. Nel 1959, quindi, non 13
dovetti identificarmi solo con Doinel o Léaud ma anche con ciò che li legava a Truflaut. Così come quest’ultimo non si era sem plicemente innamorato di Monica ma di ciò che poteva indovina re del rapporto fra Harriet Andersson e Ingmar Bergman.
Ero dunque un mostro, incapace di identificarmi, inadatto a essere semplicemente questo o quel personaggio? Non mi sono forse riconosciuto, chiacchierone e dinoccolato com'ero, in quell’eterno adolescente di Paul Biegler-James Stewart di Anatomia di un omi cidio? Non mi sono entusiasmato nel vederlo sferrare un montan te a quel bruto di Wayne in un film di Ford? Non sono forse stato innamorato di Henry Fonda cinquantenne, e come ho potu to non intuire che Cary Grant derivava il suo indiscutibile fasci no da un'evidente bisessualità? Non ho puntualmente sperato che Robert Ryan facesse bella figura quando invece avveniva il contrario? Non ho amato senza riserve tutti quegli oggetti ame ricani, dal taglio dei costumi ai taxi gialli di New York, dall’accento inglese di Mason alla parlata sudista di Walter Brennan? Non ho perdonato tutto a Kazan per il solo motivo che aveva diretto Monty Clift e Lee Remick, la coppia dello scanda lo? Potrei vedere, senza avere un tuffo al cuore, Deborah Kerr che si fa investire da un’auto, Dorothy Malone giocata a dadi, Kim Novak col suo abito verde o Anne Bancroft mentre centellina il suo veleno? No, decisamente no. Gli attori sono la carne e il sangue del cinema. Ma sono anche la realtà ultima della società americana. È per questo che il cine ma è, in qualche modo, spontaneamente americano, così come sono americani tutti gli attori che ho appena citato. Ancora oggi, parlando tra amici, sono i loro nomi ad essere ricordati, come se l’America avesse custodito, fino al dopoguerra inoltrato, il segreto definitivo del nostro processo di identificazione. Un segreto così nascosto che non si è dissipato in ingenuo mimeti smo. Ho sempre guardato con una certa compassione coloro che, non distinguendo Robert Mitchum dagli stivali che portava, volevano imitarlo fino ai suoi stivali! Eppure questi cinefili americanolatri erano più logici di noi: amavano più gli attori dei registi e più lo stile di vita americano degli attori. Per me, la sola idea che ci si potesse vestire all’americana era stupida, addi rittura indegna. L'americanofobia del francese medio fu il mio vessillo e non fu certo Los Angeles a farmi sognare, ma New York. Come se il cinema americano appartenesse al cinema e 14
non airAmerica. Da qui ebbe origine il nostro imbarazzo schi zoide quando, qualche anno più tardi, ci ritrovammo politicamente anti-americani ma pur sempre fedeli ai modelli inimita bili della nostra adolescenza. Anche su John Wayne, che un tempo sembrava incartiate l’oggetto primo del nostro odio, ho cambiato idea: è un grande attore.
15
1988
DI FRONTE ALLA RECRUDESCENZA DEGLI SCIPPI1 (marzo 1988)
25/3 PASSAGGIO PASSIVO. Non “la crisi" del cinema ma “che cosa è in crisi nel cinema?". Due cose. 1) la sala buia 2) la regi strazione. Queste due cose hanno un punto in comune: entram be si fondano su una certa “passività" della pellicola e/o dello spettatore. Le cose si imprimono due volte: una volta sulla pel licola, un’altra nello spettatore. Ogni volta si tratta di un movimento della luce verso qualcosa, una luce che viene dall’esterno e che passa per la camera oscura. Questo dispositivo è fatto di un unico pezzo. Se dovessimo trovarne il contrario, potrebbe essere da un lato il disegno, dall’altro la luce in pieno giorno. Per questo, di fronte a un cartone animato giapponese trasmesso in un appartamento illuminato a giorno, provo la fastidiosa sensazione che tutto ciò non mi “riguardi in alcun modo”. Il tempo non è lo stesso a seconda che lo si abbia programmato o lo si subisca. Tempo di svolgimento della pellicola (rushes) e tempo di “maturazione" di un film nel corpo e nel sistema ner voso di uno spettatore immerso nel buio.
Forse è proprio questo rapporto col tempo che permette ad alcuni (tra cui io) di passare dalla posizione passiva di colui che vede a quella attiva di colui che scrive. Il tempo del cinema è preso tra tychée automaton2, il tempo della scrittura (“su" o piutto sto “a ridosso” del cinema) è invece un tempo infinito, comunque non programmabile. Scrivere significa riconoscere ciò che si è già scritto da sé. Nel film (film come insieme organizzato di segni) e in me (organizzato a mia volta da un insieme di tracce mnesiche che, alla lunga, costituiscono anche la mia storia). È dunque la stessa cosa che andare verso l’autore (e gli arcani — cfr. Douchet — della sua piò “intima fantasticheria") e ripiegarsi su se stessi (psi coanalisi selvaggia). La politica degli autori è stata inventata da 19
una generazione capace di scrivere, di scrivere sul suo rapporto con gli autori e su questo stesso rapporto, alla luce del fatto di averla formulata (cfr. Truffàut e i suoi "padri", Wenders, ecc.). La registrazione (Lumière) possiede immediatamente una dimensione morale. Poiché è impossibile prevedere tutto ciò che rimarrà impresso sulla pellicola, non rimane che adattarsi a ciò che ci sarà "in più”. Divine scoperte, scorie, sintomi oggettivi, verifiche e prove, brutte sorprese, punte di realtà che impedisco no all’immaginario di chiudersi, pretesti per discussioni dialetti che di ogni genere... Il regista guarda una volta sola e poi, anche lui in posizione passiva, deve fare i conti sia con ciò che ha resti tuito (come visione propria) sia con ciò che non ha registrato volontariamente (come realtà, richiamo dell'Altro). Gli corri sponde (in genere i protagonisti sono gli stessi) un tipo di critica anch’essa morale, perché invece di giudicare la visione (Fellini) valuta lo sguardo (Godard). Confronta lo sguardo con l’oggetto guardato e stabilisce le “migliori condizioni possibili della loro inadeguatezza”. L’autore appare così tanto più quanto più è visto nell’atto di guardare, quanto più entra a far parte del quadro (cfr. Merleau-Ponty). La sua traccia (la direzione dello sguardo, l’indi zio che qualcuno sta guardando, il punto di vista, la posizione della cinepresa, ecc.) è allo stesso tempo ciò che, idealmente, dovrebbe scomparire del tutto (l’utopia rosselliniana della traspa renza assoluta) e ciò che protegge da un rapporto troppo violento (mistico) con la cosa “vista”. Nel corso del tempo è stata la secon da tentazione a prevalere: in questo senso, dal momento che si è generalizzata, “la politica degli autori” è diventata un caso di “manierismo” (la firma ha la meglio su ciò che è firmato). La storia del carrello come "problema morale” deve apparire sempre più incomprensibile ai nostri giorni. Non tanto perché tutti sono diventati immorali, quanto perché è cambiato qualco sa nel dispositivo di base (registrazione-sala buia), che rendeva possibile la frase di Godard. Prima lo spettatore, a causa dello stato di infermità fisica in cui veniva a trovarsi ("visione blocca ta”, oscurità, obbligo del silenzio), estendeva agli attori del film questa sua situazione, solidarizzava con essi (con la loro passività di fronte all’Autore e alla Luce: la passività delle "creature” nel senso religioso del termine). Da qui ha origine l’istanza cristiana dei pensiero di Bazin, con il suo rovescio complice di "crudeltà" e di “non intervento”. 20
Soffriamo e godiamo ciò che loro hanno sofferto e goduto, non permettiamo che tutto ciò sia rimpiazzato da un piacere procura to solo per farci dimenticare proprio questa esperienza.
Crisi della sala buia e crisi della nozione di registrazione = crisi del prima/dopo. Prima: si è scritti (lavorati). Dopo: scriviamo (lavoriamo). Scrivere significa quindi svelare la scrittura (rendere visibile ciò che è stato scritto a inchiostro simpatico). O prepa rarsi a scrivere. “Il" cinema o il Cinema. Nulla è meno certo dell'esistenza di questo personaggio con cui vado pericolosamente dialogando (a tu per tu). Dicevo: quelli che hanno preferito il film alla sala e gli altri, forse più numerosi, che hanno preferito la sala e non hanno seguito l’“arte del film” nella sua deriva perché l’“arte della sala” progrediva meno velocemente. Come se chiunque oggi, a proposito del cinema, avesse il diritto di dire: ci tenevo per tal motivo, tal idea, tal desiderio. Il diritto di dare un nome al mistero che l’ha afferrato. Di riafferrarlo in quanto proprio. Bella formula di Rohmer: il cinema non è immagini, ma inquadrature. Formula che esprime che cosa sia per lui (e per me) il cinema. Ma per gli altri è e sarà sempre un insieme di immagi ni. L’inquadratura è un blocco indivisibile di immagine e tempo. È il tempo che mi è necessario per abitare (e anche per abituarmi a) un’immagine che altrimenti mi farebbe paura (paura di esserci/paura di esserne escluso: Barthes). La bellezza di un’inquadra tura, la sua giustezza, è una cosa diversa dalla bellezza di un'immagine. Per finire, l'inquadratura è musicale. Respirazione, ritmo. C’è del cinema quando, inspiegabilmente, un respiro aleg gia tra le immagini. Altrimenti resta solo la noia del decorativo (assolutamente cieco di fronte alla scena, entro in una scena solo se accompagnato da uno sguardo). Forse un giorno sarà possibile dire: del cinema conservo (come fu per Jean Mitry) solo il ricordo delle inquadrature. Del cinema mi hanno interessato solo le inquadrature. Il resto, che esiste e esisteva senza di me, può continuare senza di me ed io senza di lui. L'inqua dratura, contrariamente all’immagine, ma come la musica, non si può riprodurre, né citare: la sua durata fa parte di essa. Se è breve, può continuare ad essere un’inquadratura solo se viene prima o dopo una lunga. L’unica cosa che conta è la concatenazione. 21
Logica da marciatore, da parlatore solitario, da masturbatore. Necessità del racconto. Del cinema antico più bello (i titoli più presenti in questo momento sono La morte corre sul fiume e Ordet — La parola) che cosa conservo se non il ricordo del suo procedere, a colpi di inquadrature allo stesso tempo inaspettate e fatali, su più livelli contemporaneamente? Nei film brutti, niente si muove: è la costruzione della sceneggiatura che fa muovere la scena. Nei film belli, c’è sempre almeno un elemento che si muove e che, con orgoglio e umiltà, si obbliga ad ogni istante a riscoprire il resto del quadro (che, infetti, non si muove). Che strana emozio ne nella scena di Pickpocket in cui il treno lascia la stazione: per ché si muove qualcosa, che non è né il personaggio né il marcia piede ma un terzo ladrone: il treno. Emozione ironica: fuggire restando immobile. Nei grandi film, ogni elemento del quadro si muove ma a diversa velocità. La metafora più calzante per questi film è, più che lo schermo bianco, il cielo, a causa delle nuvole.
Vedere dei film, viaggiare. È la stessa cosa. Viaggiare, e non eva dere o fuggire (to escape). Viaggiare significa sapere che, per poter trarre piacere dal viaggio stesso, bisogna avere una meta, cioè tro varsi "fra” due estremi, in altre parole essere protetti. Lo stesso per i film: le inquadrature sono i sobbalzi dei vagoni. Vedere dei film, viaggiare: un tempo fu così anche per gli altri, il pubblico norma le. Ma poi sono diventati tutti turisti (consumatori di viaggi) e non si aspettano più dal cinema che esso dia loro il brivido dell’esotico, né dal film che li conduca con il suo ritmo (lento). La frase di Straub: «ho impiegato vent’anni per imparare a guardare un film». La pronunciava con l’irritazione di un operaio che tiene al suo sapere conquistato con difficoltà. Che cosa vuol dire in fondo guardare un film? Vedere e sentire ciò che è (visibi le e udibile). Per esempio vedere - con lo stesso colpo d’occhio — l’inquadratura di John Ford, la ripresa di questa inquadratura, il cavallo, l'attore distinto dal suo ruolo, il personaggio distinto dal suo corpo, l’essere umano distinto dalla sua funzione sociale. Sentire della musica e sapere che un ebreo dell’Europa centrale in fuga da) nazismo ha suonato una sottospecie di Schonberg per guadagnarsi da vivere, riconoscere se il suono è in presa diretta o no, ecc. Evidentemente rappresenta un limite, ma è l’unico approccio materialista possibile. Certo è un programma folle. Ma questa esasperazione della percezione di ciò che è eterogeneo sotto l’omogeneo è anche ciò 22
che rende possibile la critica. La critica riesce a vedere del "mon tato" (cioè del fabbricato) là dove gli altri vedono dell’omogeneo (cioè del “naturale”). Ancora Barthes. Il critico (restiamo straubiani) è colui che se fosse capace di questa sovra-percezione potrebbe discutere del film con gli autori stessi. Parlerebbe da artigiano. Ma da artigiano molto colto, capace di mettere a fuoco tutti gli strati della millefoglie che è il film. Limite straubiano: la cultura, giustamente. Non potrebbero fare niente di tutto ciò, perché esiste una storia generale del cinema che dice che Ozu ha copiato Capra. Bisognerebbe formulare la stessa domanda oggi e domani. Partire dai gesti, dal sistema nervoso, dal corpo (e non dal conte sto sociologico) e cercare di capire a che cosa corrisponderà la sovra-percezione futura. Quella delle persone nate non solo sotto il segno della televisione, ma con un videoregistratore, il fermo immagine, lo zapping, gli schermi, i computer, e le immagini digitali. Capire in quale momento spunta qualcosa di simile a un bisogno, in quale momento servire la macchina (o sfruttare fino in fondo le sue possibilità) non basta più perché diventa necessa rio che essa serva a qualcosa.
VERGINE TAGLIA 36 (Catherine Breillat). Una trama troppo ricca mi fa sembrare tutto bello, il film e il cinema. Ah, l’impres sione di libertà che sa suscitare un racconto che comincia non si sa dove e che mi trasforma, con il mio consenso, nel compagno di strada di una ragazzina, stanca di esser vergine, in viaggio tra Biarritz e Bayonne. Un personaggio che, nella vita reale, non rischio e sicuramente non ci tengo ad incontrare, come i frutti verdi di Rohmer. È l’ambiguità del moralista: grazie a un film (e a un film che non bara, dunque il meno pubblicitario possibile) compio un passo immaginario verso quella parte di umanità che mi è del tutto indifferente (gli adolescenti). Mi ritrovo a barattare allegramente l’indifferenza che provo nei loro confronti con la mia preoccupazione che abbiano però un’esistenza cinematografi ca. Al limite il cinema potrebbe servirmi per questo tipo di "igie ne". Lungi dall’essere solo e semplicemente il luogo di un’apertu ra verso l’altro, diverrebbe l’unico luogo in cui potrei aprirmi, in incognito, all’altro. E (il cinema) sarebbe allora il "mio” luogo. Sarebbe lui a venire “da me” (dove so che potrei cavarmela) e io, da parte mia, esigerei che lui fosse assolutamente “altro” (altri menti avrei la sensazione di barare). Come in quelle sceneggiatu 23
re a sfondo sessuale in cui il masochista paga l'altro perché si tra vesta da un altro altro. Godard: Si salvi chi può (la vita).
La sala buia è piuttosto il luogo in cui abbiamo sognato, inge nuamente, di essere tutti uguali. In cui abbiamo pensato che tutti i sogni convergessero verso gli stessi oggetti (le star), con la stessa spontaneità. Non andavamo a scoprire l’altro, tanto meno a vedere noi stessi. Piuttosto un misto dei due, un io che si “alte ra”. La sala buia era anche il luogo in cui abbiamo ipocritamente atteso l’apparizione sostituitiva dell’altro sessuale (il corpo desi derato, nudo, il feticcio). Nel qual caso la sua oscurità era sola mente un colpo di fortuna (ipocrisia). Qualcuno ha aspettato, nell’oscurità, che dallo schermo uscissero personaggi ai quali era indifferente, e cui era legato solo da un sentimento astratto e oceanico (“chi ben ama, ben corregge” o Nietzsche: «La vita è sempre sopportabile come fenomeno estetico»). Nel cuore del cinema francese (ed anche nei film della Breillat) c’è una costante che mi infastidisce: è l’unico cinema in cui le azioni si trasformano in atti. Per cui è debole nella narrazione e forte nel racconto in prima persona. La ragazzina protagonista di Vergine taglia 36 è in cerca di un atto. Perdere la sua verginità deve essere un atto. Così cerca un “attore” e scopre che gliene ser vono due. Uno per l’amore, l’altro per il piacere. Ma l’amore è solo paura di essere amata e il piacere una formalità senza impor tanza. Sistema bressoniano, romanzesco (il triangolo). Matrice di tutte le gestioni sublimi di un’insoddisfazione strutturale (bovarismo, ninfomania, misticismo). La Breillat dice che le piace filmare solo ciò che è diffìcile da filmare. E infatti il film regge bene in tre scene a sfondo sessuale. Una masturbazione, una fellatio, un coito. La forza del film sta proprio lì, nel suo modo di spingersi più lontano di altri nella “moralizzazione” dei gesti sessuali. Nel filmare i volti e non gli organi, non per paura della censura, ma perché il nocciolo del problema è proprio questo: l’umiliazione di tentare di adattare il proprio cervello al proprio corpo e a quello dell’altro. Gag triste della ragazzina che, dopo esser rimasta immobile come un sasso per darsi senza donarsi, fa perdere il controllo all’uomo che deve succhiare, il quale viene troppo presto e l’abbandona (con il sapo re nuovo dello sperma in bocca) proprio nel momento in cui lei invece avrebbe finalmente voglia di fare l’amore. C’è qui una cru24
deità sconosciuta ai film inglesi vagamente paragonabili a questo (Vorrei che tu fossi qui di Leland o i film di Frears) perché quelli considerano — un po’ troppo sbrigativamente? - la scopata come un tabù o come un’esperienza che non ha bisogno di commenti. La Breillat si stupisce che il suo film susciti reazioni ostili.
26/3 Ieri, mezza serata, davanti alla tv. Abbandono quasi subito 8 112, che peraltro non ho mai visto ma che ha la capacità di portarmi all'esasperazione, e mi ritrovo a seguire fino alla fine un film che è obiettivamente malconcio e mal raccontato, insomma brutto: // verdetto di Sidney Lumet. Schizofrenia della tv: non solo vediamo ciò che non va (non è riuscito), ma lo vediamo ancora meglio che al cinema (il montaggio, per esempio); nondimeno può capitarci di preferire vedere un film mancato piuttosto che un film riusci to. O meglio: le nozioni di "mancato" e “riuscito" non sono per tinenti a ciò che si vede in tv. Sia perché il film ha un forza tale per cui riesce ad imporsi, sia perché ci muoviamo nella relatività di un mondo di immagini, di un bagno di immaginario in cui tutto è interessante. Dipende dall'umore del momento. Ieri, ho preferito guardare Mason e soprattutto Newman scendere a patti con la loro età, con tutto. Lumet è il prototipo di regista che filma dal punto di vista di nessuno, e crea perciò un'efficacia astratta, così astratta che rimane sempre ai margini di qualsiasi punto della sceneggiatura. Cambia marcia là dove non serve. Un momento riuscito. Newman ha finalmente trovato l’infermiera che "sa” cos’è successo. La donna si occupa di bambini a Chelsea e ha un bel volto da sindacalista passionaria. È nel cortile della ricreazione. Newman, che viene da Boston, la avvicina in modo maldestro. Particolare sul biglietto Boston-New York che spunta dalla tasca. E qui, un piccolo tocco di cinema dei vecchio Lumet, un po’ di convincente accelerazione: controcampo su Newman che non fa più lo sbruffone: «Will you help me?». Lei lo aiuterà, non tanto perché la sceneggiatura lo prevede quanto perché noi ci siamo messi al suo posto (nella messa in scena) e lei al nostro e il desiderio che lei lo aiuti è stato inscritto nel film. Cose vecchie, ma ancora vive, buon dio! LA COMUNICAZIONE COME STROBOSCOPIA. Incurabile idealismo per cui ci deve essere un A che propone a un B (il pub blico) un oggetto C, che sarà più o meno ricevuto, più o meno 25
accettato, non si sa, non bisogna neppure saperlo. Ne deriva uno scambio di staffetta (di testimone, come in atletica) solo se, una volta che l'ha passato, A accetta che non gli appartenga più. Questa situazione ideale e, temo, abbastanza mistica, è l’unica che riesce in qualche caso a rendere interessanti i rapporti com merciali (offerta-domanda), perché si tratta di un prodotto sem pre in balia degli eventi. Solo gli americani hanno saputo formu lare la morale di questo rapporto (Hawks) o un sapere tecnico su di esso (Hitchcock). Supponiamo che la comunicazione non sia più un atto, un gesto, un momento, ma il contrario: delle azioni, delle tecniche, un tutto generalizzato. Si comunica all’interno del mondo della comunicazione, e non per aprire il mondo a ciò che esso rifiuta. Il mondo deve allora necessariamente diventare quello del consu mo, deve abbigliarsi (successo della parola "abbigliamento”, e non “travestimento”), deve disporsi, rendersi affascinante ai suoi stessi occhi. Forse è stata Hollywood (cfr. il mio vecchio articolo Sur salador?) a gettare le basi di ciò che viviamo oggi. Se, come dice Riegi4, gli europei hanno idealizzato la natura, gli americani hanno esitato tra la tentazione di migliorarla e quella di sfidarla. Minnelli, per esempio.
La sfera della comunicazione deve diventare di giorno in giorno più ampia e al contempo più chiusa. Solo questa capacità di riincantamento del mondo (per parlare come Gaucher) può per mettere “nuove avventure” della comunicazione. La pubblicità ne è la tecnica e l’estetica di base. Pubblicità nel senso del “divenire pubblico” di tutte le cose, comprese quelle che un tempo erano considerate private, o perché non facevano immagine o perché la loro immagine rimaneva sacra o era tabù. La pubblicità lavora quindi all’omogeneizzazione del mondo, aH’allontanamento delle differenze (che ormai eccitano soltanto i perversi), all’interioriz zazione del sacro (Gauchet) ridotto (Lipovetsky) ad una "gestio ne” personale dell’alterità presente in se stessi e della somiglianza presente nell'altro.
L’esempio del tennis, che va sempre bene. Gli incontri di ten nis sono ripresi sempre meglio perché (senza fatica) si è trovato il modo di mostrare simultaneamente entrambi i giocatori. Il pas saggio dai campo-controcampo allo split screen ha abolito il momento fuggente dello scambio (quando la pallina - oggetto A 26
— non appartiene più a nessuno dei due). Così la palla (difficile da filmare) viene ripresa meno dei due corpi che le servono da sem plici terminali. Lo spettacolo di chi serve è poco più interessante di quello di colui che riceve. D'altronde si può essere ottimi gio catori di tennis essendo (come Connors) soprattutto dei gran ribattitori. Le inquadrature intermedie (attesa, gioco di gambe, gioco scenico) diventano altrettanto interessanti di quelle "importanti”. Queste ultime poi, grazie al ralenti, diventano più enigmatiche, più ricche.
Che cosa ha fatto la fotografia rispetto alla pittura? Ha aperto la via all’istantaneità, in altre parole si è resa sensibile alle "pose” che la realtà assume ad ogni istante e che prima ci sfuggivano solo perché mancavano i mezzi per "bloccarle". Ha inventato il “movimento qualunque” di cui parla Deleuze. Che cosa ha fatto il cinema rispetto alla fotografia? Ha moltiplicato la foto per ventiquattro per ottenere un secondo di movimento. Ha demol tiplicato i momenti qualunque, gli interstizi, creando, anch’esso, un tipo di "posa” (e di bellezza) che non è esattamente quello della pittura o della fotografia. La bellezza di un’inquadratura è di tipo diverso e nuovo. Siamo stati noi che spingendo le cose più lontano (feticismo barthesiano, “terzo senso", ecc.) abbiamo rico nosciuto diritto di cittadinanza al “fotogramma”, di volta in volta “carne” del film, inconscio dell’immagine, ma anche, a par tire da un certo momento, immagine tout court (cfr. le cartoline con i sottotitoli), anch’essa con una sua bellezza “bloccata”. Le conseguenze sono chiare. Da un lato la vertigine dell’infini to del “realismo”, Bazin e il “guadagno di reale”, causa del desi derio di vedere. Versante scientifico, registrazione sempre più sofisticata, ecc. Verso il micro (Godard: il caffè di Due o tre cose...), quindi verso il macro (Godard: il cielo di Passion). È stato questo versante che, in un primo tempo, mi ha indotto a scrivere. Dall’altro lato la vertigine di un altro infinito (barocco?), in cui quello spazio interstiziale tra le cose già viste si popola, si addo mestica, diventa a sua volta immagine. Al posto della deriva che promette sempre un di più di reale alla fine di un movimento o di una ricerca, ecco un movimento che mira ad abbigliare-perabitarlo il mondo già scoperto. Un tempo l’immagine era — retaggio sacrale — paragonabile a un incrocio stradale che finisce per avere un’esistenza autonoma 27
grazie alia so v rad e term inazione che esercita su di esso un luogo particolarmente utile (come una città). Incroci-immagine, come i calvari che si incontrano percorrendo le strade di campagna. Immagine come eccezione e non come regola. Lo stesso al cine ma, in cui stranamente si trovano a coesistere le inquadrature (specifiche del cinema), le immagini (ventiquattro al secondo, materia di base) e l’immagine (ciò che resta identitico a stesso attraverso le inquadrature: la star, per esempio). Oggi — è il ruolo della pubblicità — l’immagine non è più come la palla da tennis che passa da un emittente a un ricevente, da uno che batte ad uno che risponde, oggi l'immagine segue con temporaneamente i due giocatori. Perché attendere che sia la palla a dirci qualcosa dei due giocatori, quando possiamo ottene re la stessa conoscenza osservandoli contemporaneamente in azio ne? La palla (l’oggetto, l’opera d’arte) è diventata il pretesto, non più ciò che rivela. Lo stesso accade in politica: i sondaggi per mettono di porre l’uno contro l’altro il discorso pronunciato e la relativa risposta. Il discorso (non si tratta nemmeno più di pen siero) fa scattare tutta una serie di immagini (anche il sondaggio è un’immagine, una "fotografia”, come ci ricordano i ricercatori). Immagini che del resto diventano molto rapidamente non inter pretabili, prive della monumentalità di quelle di un tempo. Dal punto di vista politico possiamo leggervi il dispositivo col quale i paesi tecnicamente in grado di dare questa veste al mondo firmano e circoscrivono il loro ripiegamento su se stessi. Andare verso l’altro (sconosciuto, esotico, minaccioso: il terzo mondo, presto il quarto) non consiste più nel rischiare di perder lo andandogli incontro (per salvargli l’anima?) o — persistenza del “documentario” — nel dargli diritto d’immagine. È così che, dopo lo scacco rosselliniano, le grandi guerre del mondo povero (Iran-Iraq, ma anche Libano, Medio Oriente, Cina post maoista, sikhs o tamil, ecc.) sono combattute senza che le nostre immagi ni le documentino. Godard (lei et aillettrs) aveva perfettamente sintetizzato il disagio prodotto dall’avere quei soggetti come attori gratuiti e dall’essere noi per loro "mediatori" benevoli. Poi, il "documento" ha sostituito il "documentario” e il “docu mento”, in quei paesi, non poteva che essere mostruoso, sanguino so, fatale. E, in seguito, i media occidentali hanno inventato un modo antico e al contempo (post)modemo di risolvere il proble ma. Invece di andare verso i paesi poveri (per informarli, aiutarli, 28
sostenerli, capirli), hanno preso l’abitudine di rimanere nei propri confini e, per alleviare tutta quella sofferenza che non mostrano più, organizzano degli show mediatici di beneficenza, che diven teranno poi un’occasione per festeggiarsi e far mostra di sé. Il disprezzo per se stessi che tanto faceva schifo a Bruckner è scom parso. Non ci si vergogna più di niente. L'immagine mancante degli altri è stata sostituita da un'immagine in più di noi. Poiché ormai siamo condannati a noi stessi e alla carità come businness. Riassumiamo questa storia non riassumibile. L’immagine come semplice rivelatore di A e B (per esempio la pittura delle icone). L’immagine come verifica di A che lancia un messaggio in botti glia verso B (per esempio un romanzo di Kafka). L'immagine di A e B, sempre più intercambiabili e omogenee, l’immagine che diventa un pretesto ludico. L’immagine di A per B in nome dell’immagine assente di C.
29/3 TEORIA DEL RAPIMENTO. Che cosa rispondere a coloro che mi dicono «sei uno spettatore troppo cerebrale, non sei (come me) un buon pubblico»? Dir loro che non c'è niente di più facile per me che piangere davanti a un film? Ma essi non parlano di emozioni, parlano dell'atteggiamento che è bene assumere davan ti a un grande spettacolo, a un’immagine e a delle scenografie Ufi- Della meraviglia “normale” davanti a ciò che esce dalla normalità. Ed io mi dico: anche da piccolo, i film spettaco lari non mi entusiasmavano più degli altri (e ancor meno i “film per bambini”, che devo riconoscere a mia madre di non avermi mai imposto). Al contrario: anche da adulto, i film in cui “entro” sono quelli in cui c’è una porta d’ingresso, e il solo spettacolo che ancora mi tocca è quello che scopro nella stanza una volta entra to. Tutto, allora, diventa spettacolo. In queste parole riconosco un'eco di ciò che avevo scritto su Rossellini (il Litigi XIV): per un voyeur, tutto è spettacolo, solo che da questo stesso spettacolo egli rimane escluso in virtù di un feno meno misterioso, che solo lui conosce (il nascondiglio del bambino non è il posto normale dello spettatore di fronte a un film-quadro). Se il film è per me, io sono per lui: di fronte a lui e dentro di lui. Ripenso a tutto ciò che abbiamo scritto sui «Cahiers» a proposito del “posto dello spettatore” davanti a un film, sul fatto che c’è una 29
doppia scena, un doppio modo di esistere davanti al film: come corpo inerte tra gli altri, e come sguardo vivo tra le inquadrature. L’amore dell’inquadratura è quello degli interstizi in cui infilarsi, di nascosto o ben accolti dallo svolgimento del film. L’esempio tratto dal film di Lumet, qualche giorno fa (la domanda di Newman all'infermiere: «Willyon help me?»), riassu me perfettamente tutto. È logoro, ma sufficiente. L’inquadratura di Newman - di un Newman che chiede aiuto e che lo chiede due volte: una volta all’altro personaggio (off), l’altra a me che — per un' secondo — mi sono infiltrato nel film al posto del perso naggio assente dall’immagine. E otterrà due volte aiuto: nel sog getto del film e da me (a partire da quell’istante accetto di cam minare con il film, quindi di farlo avanzare). Ricordo che dicevo la stessa cosa nella prefazione a La Rampe, con i lebbrosi del Sepolcro indiano anch'essi avanzanti verso di me e il movimento dell’attrice che riconosco come mio: non restare con le spalle al muro, bloccaci, ma correre più velocemente di loro, di fianco a loro, verso di loro, verso un'altra uscita.
L’infanzia, senza dubbio. Il rimpianto ultimo di non essere stato rapito, portato via, di non essere stato (deliziosamente) "rubato” da un uomo, un padre — mio padre - tornato dal cinema per cercarmi. Il destino di approffittare più tardi del passaggio di qualche bambino perduto (senza collare), e di essere quel padre (perverso) verso cui, forse, tenderanno altri bambini perduti. L'infanzia, in quel momento, con quel La morte corre sul fiume, il più bel film americano del mondo. Il mio testo su Les mendiants, la condivisione di // covo dei contrabbandieri con B.J. Il cinema ha consentito a Sherlock-Keaton di entrare nell’imma gine, poi ha fatto sì che Ulysse, uno dei carabinieri godardiani appeso alla tenda di un sipario si schiantasse contro una parete, infine ha permesso all'eroe di Woody Alien di uscire dallo scher mo per scendere in sala. Il cinema ha rapito il suo pubblico, l'ha tenuto a distanza e poi l’ha vomitato. Nel braccio di ferro filmpubblico è quest’ultimo che ha (ai nostri occhi) l’ultima parola. Al punto da non avere più bisogno della sala buia per introdursi di nascosto nel film, non visto né riconosciuto. Non visto per vedere meglio, non riconosciuto per imparare a conoscersi. Un bambino “normale” impara presto a identificarsi con un personaggio che gli assomiglia e, attraverso di lui, a entrare in sintonia con il film. I bambini normali hanno come alter ego 50
altri bambini perché sanno di essere come loro. Ma il figlio “unico”, che non si riconosce naturalmente a partire dall’altro, rifiuta questo tipo di identificazione. È obbligato a rimanere unico anche a costo di un'alienazione che lo fa vivere per procura. Finirà per identificarsi con la macchina da presa, con l'autore, con dei personaggi che non gli assomigliano per niente. La "morale" diventerà per lui una questione di carrello solo perché egli attraverserà il film immaginariamente appollaiato sulla mac china da presa e rifiuterà fin da subito l’illusione di essere lì e altrove allo stesso tempo. L'autore sarà la figura razionale ultima di colui che l’ha fatto arrampicate sulle proprie spalle e di cui impara a conoscere il corpo, i movimenti, i riflessi. Gli stivali dalle sette leghe di Marcel Aymé (mentre la madre dorme?). Il "passare attraverso i muri”5. Non comunicherà con gli altri durante il film (potrebbe vederlo in una sala vuota), racconterà agli altri ciò che ha visto e lo confronterà con ciò che hanno visto loro. Viaggiatori paralleli, non in gruppo. Già, non turisti.
Il turismo reale ha sostituito una delle funzioni di base del vec chio cinema: l’esotismo a portata di tutti, il paese lontano visto dal torpedone, il viaggio collettivo che fa sognare a tutti le stesse cose nello stesso momento.
Che cosa è "generalizzabile” di tutto ciò? Storicamente? Forse è giunto il momento di scrivere il libro sul bambino al cinema. Ant putriiAtri libri. LES MENDIANTS (Jacquot). Niente è chiaro in questo film che gira le spalle al pubblico in diversi modi. Il paragone con // covo dei contrabbandieri non regge fino in fondo perché il film di Lang metteva in scena l’alleanza tra un adulto fuorilegge e un bambi no. Questo imparava qualcosa della vita, quello reimparava il gioco. È forse ciò che manca al film di Jacquot, più rivolto a un aspetto tipo Prince Eric6 senza assumerlo però completamente, senza illusioni rispetto al mondo dei "grandi", esplicitamente votato al non-mélange (sempre questa purezza francese e l’impos sibilità di ibridazione rappresentata dall’attore di colore).
SUL “VALORE DI SCAMBIO”. Cosa fanno i "mediatori” televi sivi: scambiano dell’informazione con dello spettacolo. È un modo più concreto di parlare di “fondo” e “forma”. Quando però non è più l’informazione a divenire spettacolo, ma è lo spettacolo 31
dell’informatore stesso che esaurisce tutta l’informazione", allora lo scambio si fa ineguale. Nel primo caso ci troviamo di fronte al modello delle vecchie propagande (come dire le notizie, come sistemarle, come predisporre il pubblico). Oggi invece si ha spesso l’impressione che la notizia venga persa di vista (o piuttosto che abbia trovato una sua forma definitiva - pezzi di reportage, fermi immagini —, che però non basta più).
Da quel che si può vedere, la televisione americana è rimasta a questo proposito molto più dogmatica della nostra. Gli speaker americani si sforzano di assomigliare a delle macchine senza sguardo (cfr. Max Headroom), impersonali, forgiate con un unico stampo (capelli bianchi, bel vecchio rude). La spettacolarizzazio ne dell’informazione ha forse radici francesi (così come è stata acutamente ricostruita da Les Nuls7), nel senso che — ci tengo la nostra cultura politica è fortemente legata al modello teatrale classico (racconto raciniano o corneilliano).
L’informazione senza spettacolo rappresenta un limite tanto irraggiungibile quanto quello dello spettacolo senza informa zione. Nel primo caso, anche la diffusione pubblica delle noti zie da parte dell’AFP (Agence France Presse) si riduce ad uno spettacolo minimale di lettere verdi su fondo nero. Nel secon do, è nostra abitudine — facendo dello zapping — trarre da uno spettacolo quell’informazione involontaria che comunque esso produce (ma bisogna essere semiologicamente allenati, un po’ perversi, ecc.).
L’informazione resta ciò che ci giunge dal "luogo della cono scenza assoluta" (per parlare come Legendre), malgrado i nostri sforzi (Godard: Continent fa va) di ridurla al livello delle attività umane, fallibili, relative. E questo luogo ha bisogno di servitori. Che, subito, si mettono a disposizione. Alcuni di loro finiscono poi col sostituirsi all’informazione stessa (senza di noi, non avrete nessun accesso ad essa).
30/3 IMMAGINE ANALOGICA, BLASONE CONTROVERSO. Telefonata di A. Rouillé a proposito di un convegno sulla foto grafia. La fotografia, mi dice, gioca un ruolo sempre meno importante nella ricerca scientifica. Mentre solo vent’anni là... 32
La stessa cosa dunque sta accadendo alla fotografia, al cinema e in generale a tutte le immagini analogiche. La loro utilità non risiede più nel loro “rapporto con la natura”, esse informano poco. Da un’immagine analogica ci si aspetta sempre meno che porti dei messaggi (codificati o meno, voluti o no). È per questo che porre, come fa Rouillé, la questione dei rap porti tra cinema e fotografìa in termini di ambiti rispettivi è senza dubbio un procedimento universitario, accademico. Bisognerebbe invece scandagliare il concetto di FERMO IMMAGINE. L’immagine è bloccata non dalla mancanza di movimento ma dalla mancanza di senso (e di meta) del movi mento stesso. È bloccata sì, ma potrebbe muoversi. Se animare l’immagine, vederla muoversi, è stato il sogno dell’umanità, oggi possiamo avanzare l’idea di assistere al movimento oppo sto: la vogliamo vedere fermarsi, mettersi in posa, fissarsi, oscillare tra immobilità e movimento. Pulsione di morte (ritor no all’inanimato). Ecco allora che invece di una funzione conoscitiva (immagine=documento scientifico), essa starebbe assumendo sempre più una funzione di riconoscimento. Il suo elemento costituivo non sarebbe più la natura, ma la cultura: starebbe passando compietamente dalla parte della messa a punto dei codici sociali, propo nendo agli uomini dei modi (dei trucchi) di convivenza attraver so la comunicazione pubblica. La pubblicità è diventata il model lo comune a tutte le immagini, pubblicità nel senso stretto della parola, nel senso del “divenire pubblico di ogni cosa”. Scandagliare l’idea di un’araldica sociale.
Ciò che poteva capitare a un’immagine era di muoversi. Il movimento le era naturale (ne sarebbe stata “naturalmente” pri vata, come un invalido che sa cosa gli manca). Oggi non ha più senso né utilità aggiungere movimento a un’immagine fìssa. Essendo una “cultura”, l’immagine non ha altro orizzonte se non l’araldica di cui parlavo prima. Finché resta una “natura", l’immagine non ha altro orizzonte che le avventure della propria modellizzazione (rileggere Quéau). Se c’è qualcosa da scoprire nell’immagine, lo si può fare solamente declinandone la produt tività interna. L'immagine è "fotografìa” di momenti di socialità pura (cfr. i sondaggi), chiusa in se stessa.
33
6/4 FERMO IMMAGINE. Restavamo immobili di fronte a immagi ni che sfilavano via. Ci muoviamo lungo immagini che restano immobili. Immobili come uomini o donne di strada, che per bat tere si mettono in posa. "Proposte” (come si dice per la moda). Più un’immagine è in concorrenza simultanea con tutte le altre, meno deve muoversi (il pezzo di marciapiede, di spazio pubblici tario, è caro, bisogna occupare il proprio e diventarne il “logo”). Rivedere sotto questa luce il cinema di Fellini (La città delle donne) e l’idea di “sfilata" in lui e in Godard (lei et ailleurs).
Una storia del fermo immagine sarebbe davvero istruttiva. Per quel che mi riguarda potrebbe iniziare con l’inquadratura finale dei Quattrocento colpi. Ma c’è un altro fantastico fermo immagine più o meno all’inizio di La vita è meravigliosa di Frank Capra (film appassionante). Il fermo immagine (ritorno all’inanimato=pulsione di morte) ci dice che ci sono immagini oltre le quali il movimento non prosegue. Possono essere uno dei 24 momenti qualunque di un secondo di registrazione di un film. Ma, a un dato momento, non sono più immagini qualunque: sono — per essenza — dei “terminali".
L’immagine "terminale" è il significato che esige quanto gli è dovuto, è movimento pietrificato, posa, immagine senza altro (altra immagine, fuori campo); in questo senso, è forse un’immagine sacra. Un tempo invece il cinema ha saputo acco gliere e organizzare il divenire delle immagini. I due poli consi derati all'epoca antagonisti (Rossellini — Ejzenstejn, per inten derci) avevano in comune la stessa preoccupazione di come arti colare (la famosa domanda: come passare da un’inquadratura a un’altra?), come modulare il tempo, come tener conto delle metamorfosi di un’immagine in un’altra, come impostare un movimento adeguandolo all’insieme (anche movimento di paro le, certo, metaforico, letterale). Vedere qualcosa muoversi era il non plus ultra del mio amore per il cinema: vederlo insieme per durare nel suo essere e modificarsi davvero. Al limite: sguardo assoluto di colui che vede ogni cosa muoversi secondo la propria velocità (dalle nuvole alla recitazione degli attori, dalle idee alle emozioni). Ecco perché, anche nei brutti film, il trucco del tempo che passa e dell’attore artificialmente invecchiato riesce sempre a commuovermi (Cavalcata, Mrs. Muir, Il gigante, Paradiso perduto, ecc.).
L’immagine attuale è votata all’immobilità. Il fatto di essere animata non significa che sia “in movimento". La televisione è il regno dell’animazione, non del movimento. Vi si animano (il meno possibile) dei blasoni, delle figure, dei logo, degli emblemi. Che non hanno altro avvenire se non quello di essere sostituiti da altri, e non possono evolversi troppo perché ciò nuocerebbe alla loro "immagine”. Servono oggi in attesa di non servire più domani. La cosa migliore che può capitargli è di “fare immagine" al punto da emanciparsi dal loro supporto e rimanere identifica bili. È il senso del gesto geniale di Andy Warhol con Marilyn e la lattina della Campbell. In termini più generali, l’immagine non è passibile di antropo morfismo. Attribuendo loro avventure, una velocità propria, una storia personale e uno sviluppo organico (“le nostre amiche immagini"), trasformiamo le immagini nell'equivalente dei per sonaggi (reali o fittizi) che esse ci restituiscono. Al solito: trema re per ciò che capita all’eroe, quindi all’immagine dell’eroe. Morale possibile (Godard, sempre lui). Oggi si ha sempre più a che fare con un momento virtuale all’interno di una simulazione. Anche in un futuro anteriore, è un fermo immagine che permetterà di attualizzare questa o quel la stasi di un processo sul quale è possibile fare anticipazioni. Guardare non è più al primo posto, nel migliore dei casi è al secondo. Vedere prima (mistica?), vedere dopo (pragmatica?).
3/4 L’UMANO, MA COME? Come se la cava la nuova generazione dei «Cahiers» con la sua eredità (noi) e la sua esperienza (se stes sa). Sabouraud vuol credere che l’umano (o l’umanesimo?) non sia andato perduto per il cinema. Concordiamo che — oggi come ieri — i registi che senza tante smancerie possiamo definire umanisti hanno avuto tutti a che fare con il teatro. Da Renoir e Lubitsch a Fassbinder e Bergman. Se le due grandi tendenze del cinema, la tendenza-disegno e la tendenza-registrazione, rappresentavano due modi di ingabbiare l’inumano nell’umano, è proprio nel mezzo, dal lato della tendenza-scena (scena perduta, scena indi menticabile), che l'inumano è tenuto a debita distanza. Mentre parlo, mi viene in mente che la scoperta — scoperta obbligata — da parte dei registi dell’essere umano come maggiore preoccupa zione (dopoguerra, Rossellini, ecc) sia stata nel medesimo tempo 35
come una matassa da dipanare. Per far apparire “dell’umano” (non come un dato ma come una cosa vista) era necessario che i corpi, gli attori i ruoli, i personaggi fossero assolutamente appiattiti, non più sinteticamente, ma analiticamente. Rossellini è forse stato colui che ha esplorato — molto veloce mente — i tre vertici del triangolo. È partito dalla registrazione (Paisà), ha sconvolto l’idea del casting (rapimento di una star di Hollywood) e verso la fine si è indirizzato verso il disegno anima to del progetto pedagogico. Godard detesta troppo il teatro (troppo legato al principio di piacere) per affrontarlo direttamente (è stato Rivette a portare Anna Karina sulla scena). Tuttavia, prende la scena generale dei media come un teatro, per produrvi, anche lui, degli esperimenti di casting (recupero di star popolari sul viale del tramonto). Si limita a dire a quali condizioni c’è/ci sarebbe/c’è stato/ci dovreb be essere/ci sarà dell'umano. Procedure d'accesso all’altro ma senza incontro con esso. Ora, l’altro non si incontra, l’altro è solo uno dei ruoli che una troupe teatrale ritaglia per sé. Avevo scritto queste cose, ma la lettura della biografia di Fassbinder scritta da Robert Katz mi ha dimostrato che niente è meno idilliaco di quel tipo di teatro. Fassbinder ha dovuto orga nizzare fino allo sfinimento estremo la satellizzazione sessuale, amorosa, professionale della sua troupe affinché ognuno, al momento opportuno, si trovasse al posto delfaltro cattivo”. Oggi, chi ha il coraggio di continuare su questa strada? A distan za, si ha l’impressione che le macchine Visconti, Renoir, Lubitsch o Bergman fossero meno distruttrici. E Brecht, uomo di teatro?
Tre tappe (sempre tre, indiscutibilmente) per risalire la storia del cinema: la specie umana, l'essere umano, lo spazio umano. La folla, l’individuo, l’ambiente. Se Renoir o Ford procedono dalla folla all’individuo, Godard o Coppola passano dall'individuo all'ambiente.
J.L.G. E W.A. Godard spiega a Woody Alien che il cinema era una cosa bella perché era uno spazio difeso, o perlomeno un modo di sfuggire alla famiglia. Al giorno d’oggi questo discorso suona davvero strano, dal momento che nessuna famiglia sembra ormai capace di suscitare odio. Ad ogni modo, per tutti i barn >6
bini cresciuti al l’ombra della televisione, la questione non può più essere posta in questi termini. Non si capisce perché il cine ma possa essere loro proibito (si comprende meglio la proibizio ne della tv) ed è sotto i nostri occhi come i genitori cinefili spin gano i figli a vedere bei vecchi film in condizioni giuste. La tra smissione di film alla televisione dovrebbe diventare una sorta di annuncio promozionale, di promessa del passaggio dalla riproduzione all'originale. Non per noi (che conserviamo un ricordo molto nitido della versione originale), ma per i giovani. Affinché essi possano uscire da una telepercezione del mondo che li avrà certamente formati, ma che gli avrà anche trasmesso un'altra visione del mondo (cine-mondo, tele-mondo). Impossibile rispondere al loro posto. È stupido pensare che ad ogni nuova era della storia (materialista) della percezione le cose passate non possano essere riscoperte, riaffrontate. Come se ci dovessimo vergognare di aver scoperto Keaton senza l’accompa gnamento al piano in sala. La cosa più triste per me sarebbe che questi giovani pensassero che il cinema sia passato compietamente dalla parte della Cultura e che per questo debba essere consumato solo in forma celebrativa, tipo “son et lumière”*. La cosa meno triste, al contrario, sarebbe che per realizzare un video-clip si rileggesse EjzenStejn.
12/3 ROSSELLINI PERCHÉ? (Scritto con rabbia al computer dopo che un lungo discorso è stato cancellato dallo schermo!) Dopo aver letto Vaclav Belohradsky {L,Américanìsatìon)').
- Se tecnica = neutralità, questione della “passione dell’indifferenza” (Blanchot — Musil) e del “tutto sullo stesso piano" (R.R.). Accenti profetici degli amanti della neutralità. - Coppola: “il rinvio” prima che un’invenzione sia recuperata. Esiste un tale rinvio (siamo in grado di trovare nuove conclusioni adatte a questi nuovi mezzi)? - Rossellini: la tecnica (cinepresa, video) come neutralità (con tro Rouch). Il mio discorso post-zapping. - Rossellini: unità della sua “opera”. Non esiste verità e com prensione che non provenga e non sia dell’altro (of, from). Come accade che qualcuno aderisca a una causa? Alla fine, egli non lo mostra più, lo rappresenta. Passa ad illustrare un processo che per sonalmente non lo interessa più (ma che è di interesse generale). 37
- Questione (col senno di poi) dei campi di sterminio (fino ad allora muti) scoperti dalla fotografìa e dal cinema (la registrazione). - Storia della registrazione (memoria di ciò che è fatale). - Modernità — il pathos dell’educazione — l'uscita dalla "mino ranza” (doppio senso: minore e minoritario). «Il linguaggio comporta il rischio di farsi trasformare dalla parola altrui». (V.B.) - Gadamer: «Non c’è asserzione che non possa essere compresa come risposta a una domanda e... questo è l’unico modo con cui possa essere compresa». - «Il nemico in assoluto più temibile è colui che pretende di essere padrone del linguaggio”» (V.B.). - Arendt: «Il mondo umano è costantemente invaso da stranie ri nuovi arrivati le cui azioni non possono essere previste». Manierismo contemporaneo: l’incapacità di passare da una cosa ad un’altra. Ci si sofferma piuttosto sugli effetti della firma autoriale, sulle tautologie (A la guerre camme à la guerre, Bushiness is business). Lo stesso vale per i media, la comunicazione, il cinema.
ATTUALITÀ. S.T. mi comunica che, quanto ad ascolti, la serata televisiva sui premi Cesare è stata un fallimento. Tanto meglio. Dimostrazione spontanea di disgusto e scarso interesse. Mio leit motiv attuale: «il cinema interessa poco» (evito espressamente il “mi"). Dopo il mio articoletto su Kubrick, comparsi nuovi segnali dello stesso disinteresse. A proposito di Frantic di Polanski, stessa sensazione che intorno a me si provi piacere nel dichiararsi delusi. Non più «Polanski è peggiorato», ma «Frantic è fastidioso». Nessun occhio di riguardo per il nome dell’autore, nonostante tutto uno dei più mediaticamente celebrati e abbastanza accade mico da rappresentare il pantheon ufficiale. Errore della prima pagina dei «Cahiers»: non serve a niente mettere dell'acqua (Polanski) nel proprio vino (chi?). È un compromesso che non ha più ragione di esistere. I registi forse hanno smesso di frequentare i vecchi generi. CINEMA DIRETTO/REGISTRAZIONE. La mia idea è questa: non c'è cinema diretto che non sia legittimato da ogni tipo di morte (grande o piccola), o almeno, da capovolgimenti radicali dell’identità (la risata di Normandin). Vecchia idea su Rouch: les maitres fous (trasformazione dei Neri in Bianchi). Vecchia idea di 3S
Godard (dei boia in vittime), di Rossellini (gli indifferenti in cre denti), di Straub (dei corpi in natura-roccia?). Conseguenza tecnica di una trasformazione storica più radicale. Perché La tecnica per mette di celebrare due volte questa trasformazione: una volta per ogni film, e poi tante volte quante il film è proiettato. Perversione del cinema alla luce dell’impossibilità della catarsi (Fuller: «Verboten, Forbidden, Proibito»). Modernità: bisogna “apprendere” questo grazie a quello.
Forza di Rouch: ha applicato il cinema diretto a dei miti: mito surrealista dell’i neon tro-rf/A^wr/w, miti africani (fanbara Dama). E i nostri miti? Baudrillard: come può la questione ebrea dei campi di sterminio diventare mito, cioè entrare a far parte del genoma dell’umanità (sotto forma di racconto e non sotto forma di spettacolo)? Efficacia dei racconto e efficacia del mito. Che cosa significa “Olocausto”? A volte si afferma: il buon senso di un racconto che dice che quel fatto è raccontabile, quindi stru mentalizzabile, quindi riproducibile (niente più atti unici dei quali si può guardare un solo spettacolo). Altre invece: la possi bilità di dimenticare senza alcuna costruzione mitica, dal momento che l’efficacia dei segni corrisponde all’efficacia della “soluzione finale”. DOPO VALENZA. Tanti discorsi dopo il dibattito sull’informa zione televisiva (Brusini, Missika, Blum, Ramonet, Boyer ed io). Mi viene un’idea. Il tema era informazione/spettacolo. Missika sostiene che lo spettacolo gli sembra un argomento “bidone”. Ma (dico io) capita di vedere — in senso stretto — io spettacolo sostituirsi all’informa zione o piuttosto uno spettacolo rimpiazzarne un altro. Per esem pio l’Etiopia e il problema della carestia. Prima ipotesi: il docu mentario insopportabile (ma ci diciamo che, per rispetto nei con fronti della realtà, bisogna sopportarlo). Seconda ipotesi: il rias sunto di questo documentario, con il fermo immagine, il logo, se vuoi il video-clip, il blasone pavioviano della situazione. Terza ipotesi: lo spettacolo di chi — per noi, al nostro posto — va a cer care questa immagine e questa informazione {L’inganno di Volker Schlóndorff). Quarta ipotesi: il concerto rock i cui incassi, nel migliore dei casi, finiranno in Etiopia. Quest'ultimo spettacolo, piacevole e sottratto alla critica (chi oserebbe dire che il tal can tante canta male?), ne sostituisce un altro. E diventa quindi a sua volta un’informazione (cfr. Geldof). 39
Che cosa significa preferire i cantanti di qui ai moribondi di laggiù? Perché legare le due cose? (Sarebbe ridicolo anche se can tassero sul posto). Per l’equivalenza degli spettacoli o per l’obbli go di avvicinarci per forza, artificialmente, ad un problema che tutti preferiremmo ignorare? Ma anche: limiti (vedi quanto detto prima) dell’idea di regi-' strazione, del cinema diretto, della mediazione ridotta al mini mo. Obbligo per tutti di trovare un altro modo di trattare ciò che risulta insopportabile o fastidioso.
Che cosa significa soffrire/godere dello spettacolo macabro delle “cose stesse"? Dignità di chi? Del Cinema che morirebbe se smettesse di registrare? Dell’unico legame che il cinefilo conserva col mondo?
Vaclav Belohradsky: «L’Europa è il luogo in cui si radica la buona volontà dell’occidente, la volontà, cioè, di rintracciare il senso dell’esistenza nella differenza tra l’immagine e la realtà, tra il segno e il significato, tra l'icona e il suo signifìcatum visibile». A questo oppone, citando Baudrillard, l’americanizzazione, la conquista del pianeta, (’America, in cui questa differenza non costituisce più un problema ormai da molto tempo. Da un lato, quindi, il pieno giorno delle cose sempre a disposizione, delle cose-pronte-per-lo-schermo (pornografia, direi), dall'altro il mondo di luci e di ombre europeo. È sotto gli occhi di tutti che cosa sarebbe stato il cinema americano senza l’apporto dell'Europa centrale negli anni Trenta. E come, pur amando il cinema americano, abbiamo continuato ad amare anche l’espres sionismo tedesco. Allora, potremmo dire: Oriente: senso/senso (segni fissati, non interscambiabili), Europa: segno/senso, America: segno/segno? Dopo Valenza, due giovani (colpiti da ciò che ho detto) di Montbéliard. Non accaddi forse che le persone torneranno verso il cinema per disgusto del resto (tesi di Truffaut negli ultimi anni di vita)? Con argomenti negativi non si avanza, dico io. Bisogna tro varne di positivi. Il cinema deve diventare un lusso indispensabile.
CONVINZIONE/COMUNICAZIONE. Bel film, domenica sera, di William A. Wellman (Il cacciatore del Missouri). Clark Gable sposa un’indiana birichina e commovente, che muore prima di aver imparato l'inglese. La donna per tutto il film comunica (così come tutti gli altri indiani) con la propria lingua, 10
grazie all'aiuto di un interprete (interpretato da Adolphe Menjoul). Dimostrazione di modernità da parte di Wellman, che, come ho spesso fatto notare, non filmava mai senza un “punto di vista” (fatto assai raro nel cinema americano). Ciò che mi tormenta (in sostanza: che fare di questi due apprendisti stregoni, Rossellini e Godard?) è esattamente quello che ha fatto di Paisà un film tanto importante. Il suo realismo era così “neo” da essere, di fatto, profetico, mostrando (primo episodio, tra gli altri) come, nell'Italia appena liberata, la gente parlasse lingue diverse (italiano, inglese, tedesco). Partendo da questa semplice scelta di non-inganno, una massa di altre astuzie drammatiche diventano impossibili. Del resto, trent'anni dopo, Godard con là et aillctirs (e le celebri frasi non tradotte pronun ciate dai feddayin) eseguirà — in vitro — la stessa operazione, deri vandone lezioni pedagogiche.
Ma c’è un altro modo, meno idilliaco, di vedere le cose. Rossellini è un uomo senza solide “convinzioni”. Si cambia d’abito, sa adattarsi molto bene, non è né un resistente né una grande coscienza critica (l’anti Visconti). È un avventuriero ed è il primo a mostrare (prima di vendere) la comunicazione (diffìci le) laddove gli altri espongono le loro convinzioni (facili). La sua mancanza di interesse per il contenuto delle convinzioni (essere pro/contro) gli permette di non transigere su ciò che per lui — per lui per primo — è il vero grande soggetto: la comunicazione diffi coltosa (anche tra persone molto vicine, coppie che si formeran no, Bergman in Italia, ecc.). Ma in seguito la sua scoperta gli sfugge di mano (l'icomunicabilità diventa il tema proprio di Bergman o di Antonioni), ed egli finirà per voltarle le spalle, optando per lo spettacolo leggen dario della comunicazione riuscita. Tutti gli eroi storici della sua ultima produzione, Socrate, Cartesio, Pascal, sant’Agostino, Marx, Gesù Cristo, Luigi XIV (ma anche san Francesco), non devono far altro che parlare per essere compresi da chi sta loro vicino (nostalgia rosselliniana di non essere lui stesso un profeta). Dimentica (a benefìcio dei successi della convinzione) ciò che aveva scoperto (i perdenti della comunicazione).
Lo stesso schema si può applicare a Godard, perché neppure lui è uomo di convinzioni ma in cambio è intransigente sul modo 41
con cui "gli uomini di convinzioni" barano con la comunicazione (autocri ticandosi in lei et ailleurs). Normale che i due siano - da qualche parte - in una dimensione religiosa in cui le due cose si confondono: se la comunicazione è una convinzione (anche vuota). Al limite, questo schema potrebbe valere anche per Antonioni, uomo di sinistra ma anch’egli scientista (e assolutamente non religioso).
Fino a che punto costoro anticipano il paesaggio attuale? Sorpassati dalla loro stessa scoperta. Godard si considera più un artista, laddove a Rossellini questo status fa orrore. Il loro godi mento sta nello scarto tra convinzione (senso) e comunicazione (segno), ed è anche il loro sentirsi legittimati a intervenire per aiutare. Entrambi pedagoghi ed entrambi senza immaginazione (Storia con la maiuscola per Rossellini, storie strane per J.L.G.).
Con loro, la comunicazione entra nel cinema, in quanto ancora da conquistare. Prima, bisogna supporre che i registi profetici (Abel Gance, Dziga Vertov) la credessero “tecnica” e “miracolo sa" (dovuta alla sola virtù del cinema). All'inizio: è data come sovrappiù. Poi è da conquistare. Infine (oggi) è il dato di base. Può passare (facile), passa (difficilmente), è passata (deludente?).
17/3 HAWKS IN TV. Rivisto Gli uomini preferiscono le bionde, film culto, che si suppone molto amato, visto e rivisto, che però, venerdì sera, nonostante la versione originale, mi è sembrato privo di interesse. Tutto il suo fascino era svanito e le scene esi laranti erano appena piacevoli. Colpa del mio umore? Rivedere dei film in televisione significa prima di tutto ricondurli alla loro eterogeneità di base. In un medium così frammentatoframmentante come la televisione, tutti i film che fondavano la loro unità unicamente sul dispositivo-sala (contratto sala-fìlmpubblico) sono da rivedere per quello che effettivamente sono: scuciti, mal cuciti. Nel caso di Hawks è davvero sorprendente. Ma già II magnifico scherzo tiene solo nell’ultima parte, quando l’ingranaggio inizia a cedere ed entra in gioco il vero bambino. In Gli uomini preferiscono le bionde, ogni cosa è impostata in armonia coi titoli di testa, molto eleganti, che s’inseriscono, come attraverso uno zapping, nella canzone iniziale (DPfc are two little girls, from Little Rock. We live on the wrong side of the 42
track...)- Davvero ii film non è altro che un carosello di grade voli numeri musicali (con l’handicap di due star che non sanno ballare) conditi con un po’ di burlesque scabroso e di arbitrio al posto della fantasia. Mistero (per lo meno mentre sto qui a scrivere) di questo film scambiato per un’opera monumentale quando è semplicemente un modo molto elegante (quasi un bluff) adottato da Hawks per risolvere un'equazione a n incognite. Egli può fil mare il cameratismo tra donne solo ricorrendo ad un’analogia con quello tra uomini (il vecchio tema hawksiano: chi veglia su chi?), rendendolo così assolutamente inverosimile. Hawks non ha neppure tentato di imbrogliare: le due ragazze non “comu nicano" mai (salvo che nell’azione), ognuna delle due recita separatamente la sua parte (la cinica innocente, la scaltra senti mentale), inascoltata dall’altra (il suono dei film d’epoca, parti colarmente quello del muco, aggrava questa impressione di autismo). L’autismo è un po’ il soggetto del film. Le ragazze non parlano tra loro, gli uomini sono dei mostri (un vecchio disgustoso, un miliardario stupido, un poliziotto glauco, un bambino già vec chio), non resta che una sola cosa da fare (ultima ancora di salvez za): scendere le scale insieme con un’aria stupidamente conqui statrice, che è poi un modo di guadagnare tempo e di urlare il proprio desiderio. Forse è proprio questa la parte più autentica del film (non ci si prende la briga di far funzionare qualunque cosa) e l'aspetto che convince di meno vedendolo in tv. Perché? Perché tutti i film la cui verità ultima è nella facciata (film a una sola dimensione, luc cicante, scintillante, mimetica e dissuasiva allo stesso tempo) sono quelli per cui la televisione — che ha questa funzione cardine — risulta più ostica. Così come certi film di Hitchcock, ad esem pio intrigo internazionale, basati anch'essi sull’effetto di stupefa zione (stupefazione come coprisesso) e di seduzione, mi erano sembrati perdere qualcosa, come una mano di vernice, se visti in tv. Al contrario, i film basati sulla forza di convinzione, sulla messa in gioco dei valori umani (Chaplin, Capra) in tv sono vin centi. Dopotutto è logico: la seduzione-cinema degli anni Cinquanta è troppo vicina alla sua erede-tv, le due si confondono. In seguito, abbiamo visto molte di queste discese di scale, anche nella loro versione berlusconiana e caricaturale. Questa, nel suo genere, resta la migliore (grazie a Marilyn e alla Russell), ma non c’era bisogno di farne un film. 45
19/4 Finkielkraut10 presenta alla Fondazione Saint-Simon il secondo numero del «Messager européen». Conferenza scampa. Untuosa convinzione da gentiluomo. Anime belle. Dice — idea che sembra giusta — che in Francia si è iniziato tardi a riflettere sul totalitari smo o sul genocidio perché tutto quanto è stato valutato nell’ottica dello schema resistenza/collaborazione. La doppia ferita del secolo (Hitler-Stalin) è stata coperta dalla resistenza (fantasmatica) e dalla collaborazione (reale). Allora, fedele al mio chiodo fisso (che il binomio Rossellini-Godard riassume bene), mi dico che il cinema, invece, non ha perso tempo nel registrare queste ferite e nell’impedire che si cicatriz zassero. Non ha forse agito con molto anticipo (prima di per derlo)? E forse lo ha fatto perché era obbligato ad andare sui luo ghi, a riportare immagini, a inventarne altre, ecc. Quando, come è successo a me da adolescente, si scopre Notte e nebbia, si può dire con certezza che l’informazione passa al 100%. Ciò che con il cinema è successo in seguito non deve stupire. Da un lato la riflessione (europea) sull’immagine e il ritorno di un "dibattito” sulle immagini (Loin citi Vietnam). Dall'altro, il tempo (america no) di riciclare quella storia e farne una storia tra le altre (Holocanit). E, conseguenza di entrambi, oblio graduale di ciò che è accadu to, passaggio nel “mito” (inteso nel senso cattivo del termine: revisionista) e blocco del passaggio (Baudrillard) nel mito (nel senso forte del termine). Ma che cosa vorrebbe dire un mito della “soluzione finale”? Che ogni nuovo essere umano, al momento della nascita, tra le tante storie fondanti avrebbe, come un cro mosoma, anche questa? Finire di leggere il libro di J.L. Nancy.
20/4 INFORMARE. Telefonata lamentosa di Moumen Smihi rifiutato da Cannes persino alla Quinzaine. Per consolarlo, gli faccio un quadro rappresentativo del mio pensiero attuale sullo stato delle cose. Parlando, mi infervoro contro la televisione. La televisione, dice J.L.G., è la cultura. Dal momento che tra smette oggetti già culturali (opera, film, teatro). Senza dubbio penserà anche che dovrebbe essere informazione. Ora, se è vero che su certi argomenti la televisione informa, per quanto riguar da il cinema, essa è invece una macchina assolutamente incapace di passare informazione. Rare trasmissioni cinefile (più o meno
del tipo "piccoli saggi”), qualche cineclub, accori che vanno a vendere la toro zuppa a vancaggio di inceressi particolari. La vergogna è doppia. Da un lato perché, essendo il cinema una cosa abbastanza importante, quelli che lo amano avrebbero il diritto di ricevere un po’ di informazioni su di esso: anche econo miche, tra le altre. Dall’alcro perché la televisione “vive” della rendita del cinema, vive di questo lavoro abbandonato e vive anche, “esteticamente”, riciclando qualche eredità cinematografi ca. Informazione, arte, cultura. La televisione non è che informa zione. Anche quando questa informazione è fatta all’ennesimo grado o su oggetti senza interesse. Non è ancora una volta il vec chio sogno di Godard e Rossellini? La certezza decisamente viva in me (il mio bazinismo) di qualcosa “dietro” l’immagine? Se la televisione è cultura, lo è nel senso in cui rivela sempre più la verità della sua funzione (di guardiano, araldica). Se la televisione è arte, allora no, il problema non si pone. Complici gravi, i professionisti del cinema, che non vogliono sentir dire che il cinema va male e che preferiscono la vergogna dello show dei premi Césars a un po’ di utile informazione. Sono i registi peggiori a stare in prima fila nella lotta per la difesa del cinema. Quelli che ci interessano, invece, raramente si battono contro la televisione (che, a sua volta, li ignora quasi sempre). Il divieto di dire che così non funziona è condiviso da entrambe le parti. Informazione. Nei festival ce sempre una “sezione informati va”. Dovrebbe esserci anche in televisione, per poter trasmettere ogni sera un film definito “d’arte e ricerca” come informazione sullo stato attuale del cinema. Se reale perduto-*-segno/segno-»-misticismo o illusionismo o manipolazione (barocca).
22/4 JEAN-LUC NANCY/LA COMUNITÀ INOPEROSA. «La società non si è edificata sulle rovine di una comunità (...). La comunità, lungi dall’essere ciò che la società avrebbe perso o infranto, è ciò che ci accade — attesa, evento imperativo — "a par tire" dalla società» (p. 37).
«Una comunità è la presentazione ai suoi membri della loro verità mortale» (p. 44) — «comunità della finitezza perché la fìni45
tezza, ed essa soltanto, è comunitaria» (p. 63) — «l'essere singola re, che non è l’individuo, è l’essere finito» (p. 64) — «un essere singolare appare in quanto è la finitezza stessa» (p. 65) — «Questo apparire non è un'apparenza, ma l’apparire, insieme glo rioso e miserabile, dell’essere-finito stesso» (p. 65) — «La finitez za compare, è esposta: tale è l’essenza della comunità» (p. 67) — «[La com-pari zi one] consiste nell’apparire del fra come tale: tu e io (il fra noi), in questa formula la e non ha il valore di una giu stapposizione, ma di un’esposizione. Nella com-parizione si espo ne questo: “tu e io; tu sei (completamente altro da) me" (p. 68). «L’inoperosità della comunità ha luogo sul versante di quel che Bataille ha chiamato per lungo tempo il sacro» (p. 72)".
23/3 DAL VALORE AL “VALEVOLE”. Seria questione del “valore". Come impostarla? Per esempio a proposito della televisione o dei media? «Questa cosa ha valore per voi?» Questa domanda può ancora essere accolta. Ma “questa cosa” è un oggetto (oggetto culturale, singolare, opera d’arte) o un’idea (un concetto, un "valore", giustamente)? Per me — e per la cultura da cui derivo — i valori non hanno un valore astratto, ma ogni vera opera li cele bra, li incarna e li mette in gioco. Dunque sono i film ad avere del valore. Si veglia sui valori - anche sui propri o sugli oggetti a cui li "dobbiamo”. Vegliando su di essi, non transigiamo, e — se neces sario — abbiamo il coraggio di essere dominaci o in minoranza. La democratizzazione, l’individualismo (alla Lipovetsky) sem brano porre la questione in modo diverso. È discutibile che di per sé un oggetto (unico, singolare, solitario) dispensi valori, ma è certo che il bagno collettivo (l'orizzonte, il paesaggio) nel quale galleggiano tutti gli oggetti ha del valore, a scapito degli oggetti stessi. Astrazione del valore “cultura”.
Al punto che - per fare un esempio - qualcuno a cui non piace Frantic perché lo trova, per lui, senza valore (che non significa trovarlo nullo), può oggi trovare del valore nel fatto che questo film è libero di incontrare altri (spettatori) per i quali potrà (potrebbe) avere del valore. La TOLLERANZA diventa allora il
46
valore che tutti gli oggetti tollerati (da me per gli altri, dagli altri per me) celebrano indifferentemente.
Che cosa è cambiato? Che l’unico valore assoluto è la relatività dei valori. E che chi ritiene che Frantic abbia per lui del valore non deve farsene proselita. Caricare di qualsiasi altra valenza la tolleranza significherebbe cadere nel dogmatismo, nei settarismo, nell’intolleranza.
Supponiamo allora (è implicito nel “consumo culturale”) che chiunque sia personalmente coinvolto in un oggetto NE ABBIA ANCHE L’USO (compreso l’uso limite "valore”). Non gli si chiederà di dimostrarlo, né di sconfinare nei gusti degli altri. In questo ritrovo ancora una volta Godard. Il suo sistema è noto: ciò che conta non è inabissarsi in prima persona nel godimento del PROPRIO oggetto, ma condividerlo, arrivando così ad incontra re l’altro, e piuttosto l'altro lontano che quello vicino. E non con una condivisione tipo “setta” (il club di quelli che amano questo o quell’oggetto), ma, se possibile, sotto la forma inusuale di uno o due altri oggetti. È la comunicazione come balocco socio-maoista. Spiegami che cosa ci ha ispirato il tale oggetto (che tu ami) e, parlandoti di ciò che tu hai fatto (critica, maieutica, inchiesta, ecc.), mi arrogherò il diritto di comunicare con te. Detto altrimenti: al posto del senso comune che vuole che si cominci col comunicare per poi, in un secondo tempo, raggiungere uno stadio in cui la critica diven ta dicibile e recepibile (buoni costumi, amicizia), Godard propo ne di cominciare dalla critica per trarre da essa della comunica zione (su che cosa? non si sa). Evidentemente accade che la critica prende di mira e offende tutti, così la comunicazione si blocca ancor prima di aver luogo. Godard — critico superdotato — si meraviglia che gli altri siano così vulnerabili (Jacques Rivette), lui che, quando gli capita di essere criticato dimostra di conosce re bene tutte le astuzie dell'autoflagellazione e della fìnta umiltà (di fronte a Marguerite Duras).
Ma J.L.G. non fa altro che amplificare — fino all’impasse — un’esigenza vera, nella quale riconosco me stesso e la mia cinefilia.
In effetti — e qui sta l’astuzia maoista di base a connotazione cristiana — si parte dal principio che il “valore” di un oggetto si 47
dimostra e si mette alla prova a partire da ciò che produce in colui che l'ha incontrato. "Produce" qui nel doppio significato di dar luogo a un risultato e fabbricare. Dall’oggetto deve "risulta re” una produzione. Piuttosto cosciente che incosciente. Se io amo qualcosa, devo fare di questo amore un oggetto. Che sarà allo stesso tempo una prova, un’occasione sociale e il punto di partenza per comunicare. Grazie a quest’oggetto, si uscirà dalla cinefilia amatoriale per raggiungere la necessità per i non-cinefìli di comprendere che, fino a un certo punto, essi sanno già da che cosa ritornano (facendo ritorno sui propri gesti). Il consumo culturale è il nuovo spazio tra la consumazione e lo stoccaggio (mi manca una parola migliore). Finché c’è stata una cultura popolare (nel senso bachtiniano del termine), gli oggetti propri di questa cultura si sono contemporaneamente autogene rati e autodistrutti (come il nastro magnetico di Missione impossi bile). Il momento cruciale di un match, il più rituale possibile (dibattito politico, finale di tennis), [’apparizione anch’essa ritua le di una star, il tiro al fantoccio e il carnevale (in televisione, stranamente, con il Bébete show'2, che è in questo momento ben più crudele di tutta la stampa scritta messa insieme) non lasciano tracce. Tanto che si deve farli ritornare regolarmente. Al limite, essi richiedono un’amplificazione mimetica, come quelle dei fanclub, delle imitazioni — tautologiche. La cultura popolare resta molto vicina al mito, operazione falsamente chiusa in se stessa che genera solo se stessa. Il mito, dice Nancy, comunica solo il mito. Rende possibile la comunicazione, ma non la alimenta.
Al contrario, il sistema “artista" procede come lo stoccaggio. Guardare — dice J.L.G. - significa custodire due volte. Certi oggetti, non consensuali, producono in certi soggetti una disse minazione di effetti a scoppio ritardato, come delle bombe a frammentazione. Questi effetti, presto o tardi, produrranno nei soggetti degli effetti particolari. Ma questi effetti non saranno l'identico rispecchiamento dell’oggetto che li ha scatenati anzi, non gli assomiglieranno per niente. Soggiornando all’interno del corpo (corpo sociale), subiscono una metamorfosi. Il loro tempo è quello di un’incubazione non necessariamente visibile. Si imita solo ciò di cui ci si vuole sbarazzare (per ritrovarsi intatti davanti a lui la volta dopo). Non si imita ciò che nel tempo assume un volto nuovo. È nota l’importanza del l’effetto-Bresson o dell'effet to Godard su una massa di registi — del mondo intero —; ma in 4k
fin dei conci questo, invece di creare dei cloni, ha assunto cento forme a loro volta particolari. Il critico può divertirsi a rintrac ciarle come un agopuntore.
Il consumo sta tra le due cose. Ciò che è consumato non deve avere la pesantezza della “festa” (troppa violenza, troppa carica nervosa) né (’impercettibilità della mutazione cromosomica. Non deve giungere all'inconscio da nessuno dei suoi due estremi (l’estremo estasi-oblio, l’estremo lavoro-iscrizione). Il consumo appartiene dunque al dominio dell’irrigazione di un corpo, da cui deriva una data ecologia dell’informazione. Il consumatore non esce più da se stesso, né in se stesso entra. È dispensato dal dover restituire — in una forma personalizzata — ciò che l’ha scelto, così come è dispensato dal dover condividere — in una forma impersonale — ciò che l’ha livellato. È proprio grazie a questa “dispensa” che l’industria culturale si sviluppa all’infinito.
Riprendiamo Frantic. O ancora meglio: una banale sit comedy televisiva. Coloro che producono questo genere di programmi seguono un unico criterio: l’Audimat (Auditel). Criterio non solo astratto, ma in grado di valutare unicamente la risposta alla domanda sulla SODDISFAZIONE. Se si ponesse al pubblico una domanda sul piacere, o perfino, sul valore, c’è da scommettere che i dati non sarebbero gli stessi. Nessuno immagina che in tv ci possano essere dei programmi dotati, in se stessi, di un certo valore. O meglio, pur supponendo che essi esistano (intimidazio ne proveniente dalla "Cultura"), non necessariamente saranno quelli che si scelgono. O ancora: è la Televisione globale che, nella sua varietà (tipo “ce n’è per tutti i gusti”), viene accreditata di un valore: la tolleranza, la democrazia. Si può così approdare a un vero solipsismo ("tautismo” secondo Sfez?). Data l’astrattezza (degli indici d’ascolto) e le supposte scar se esigenze del campione interpellato (“soddisfazione”), coloro che controllano la televisione non fanno che misurare, giustamente, delle soglie di tolleranza. Delle soglie minime. Non sanno nulla di ciò che sta al di là della tolleranza (rivendicazione qualitativa: più di). Per poter lavorare basta loro un po’ di volgare sociologia, la riproduzione di ciò che a suo tempo era già stato tollerato, la rispolveratina di una dogmatica e di una liturgia già collaudate. 49
Un soggetto A, poiché tollerante, può considerarsi soddisfatto che un oggetto X (che egli trova nullo) esista dal momento in cui rispetta il soggetto B che troverà X geniale. Per esempio, il pub blico popolare si limita a non guardare le trasmissioni “intellettua li”, ma non osa criticarle. Se gli intellettuali in questione si met tessero a dichiarare che, dal loro punto di vista, queste trasmissioni sono brutte, allora il pubblico di massa inizierebbe a porsi delle domande. E viceversa. Ma questo non capita mai: gli amanti dei varietà televisivi non rimproverano nulla a Drucker (seguendo i loro desideri) e gli intellettuali non se la prendono con chi massa cra l’opera riprendendola in modo piatto. Gli uni e gii altri si dimenticano però dei propri interessi di pubblico selezionato.
Turismo culturale. Me, I and myself versus l’uno e (è) l’altro. Consumo = ecologia.
24/3 DIVENIRE IMPERCETTIBILE. Una bella frase in apertura del primo racconto di Rua, dello scrittore portoghese Miguel Torga. «L’indomani, era là. E quando, stanchi dopo aver vagato per la città, si lasciarono presso la casa di lei, avevano aperto sul mondo una finestra in più, dalla quale si poteva vedere il mare della vita, calmo e blu, in accesa di una barca con due esseri a bordo» (Non andate oltre...). L’idea della finestra torna più volte nella raccolta. Idea baziniana.
Essere preso in considerazione/Passare inosservato. Storia della mia vita. Figurare sulle liste (la paura di non trova re il proprio nome su una lista in ordine alfabetico), “contare”, ed essere contato. Ma anche: passare inosservato, viaggiatore anoni mo, “in sovrimpressione” sullo spettacolo del mondo. Cfr. Ciò che scrivevo poco sopra a proposito del rapimento. Cfr. Una frase di Paulhan (dove?) che dice che la letteratura ci dà il mondo “quando noi ne siamo assenti”. Follia dell’assenza di una presenza. L’assenza intesa non come contrario della presenza, ma come il momento in cui non si dovrebbe più essere presenti per continuare ad esserlo. Altra frase pronunciata da Simone de Beauvoir a bordo, credo, della Transiberiana: tutti questi paesaggi che continuano a esiste re anche quando nessuno li guarda. 50
Essere rapito, dunque, e poi dimenticato. Essere adottato dal film e poi trattato normalmente. Essere il figlio del cinema e non di Pierre Ski che lavorava alla post-sincronizzazione delle voci del cinema. Il posto giusto, quello in cui si è talmente esposti (pro prio al centro, come la lettera rubata) che non si rischia più nulla, se non di vedere tutto, di vedere tutto ciò che non ci ri-guarda. Ma, ogni tanto, ribattere. Adottatemi (non mi rifiutate) ma non scomodatevi per me.
Il mio oggetto preferito: le concatenazioni. Sempre: nella musi ca, nei film, nei viaggi, in una giornata. Lo stile (la felicità, la gra zia) sta nell’arte di passare da una tappa all’altra (stadi, stasi) con la coscienza zelighiana di essere (se stessi) e di non essere (lo stesso). Il solo cinema che mi coinvolge è quello in cui la necessità di con catenare diventa l’oggetto di un vero lavoro: impadronirsi del tempo, inventarlo, dilatarlo. L’idea di cammino. Secolarizzazione dell'idea dell”'aldilà”. È sufficiente una svolta per creare dell'aldilà. Semplice gioco di prospettiva: prospettivismo. Jean-Paul Aubert, parlando dell’opera di Xi’an, il più interes sante nella Cina popolare. Considerano la Kivoluzione Culturale come un cataclisma paragonabile alla nostra seconda guerra mon diale. Hanno quindi bisogno di una sorta di rallentamento baziniano delle cose, di ambiguità, di profondità di campo. La storia si ripete? Avranno anche loro una Nouvelle vague e poi dei media? Ne avranno il tempo?
26/3 VISITE E SOLILOQUIO. Un giovanotto (vent’anni, pulito) che fa una rivista («I quattrocento colpi») con degli amici. Il loro primo numero: La Nouvelle vague. Interviste: Toubiana, Ciment (!). Questo ragazzo mi conosceva solo come esperto di zapping. Mi sento offe so. Provo vergogna dell’essere offeso. Soggetto del prossimo nume ro: la crisi della critica! Ma se è morta, dico io, testardo. Piccolo creatore di riviste nell’animo? Ci vuole un gruppo, una banda, dice lui, e non dubita che, a queste condizioni, tutto andrà bene. Un ragazzo (appena più giovane) che avevo già visto una volta (ma dove?). Mi mostra alcuni pezzi brevi, abbastanza approssima tivi, scritti con un po’ di ispirazione, più vicini all'aforisma che alla critica. Deluso che io non esulti. Sorridente e buffo nella sua 51
pretesa. Gli parlo di «Globe», la cosa lo offende. Trova i film di oggi nulli (grande sorriso luminoso) e si chiede: perché non io? Ha incontrato Godard e gli ha detto di voler fare un film su Socrate. J.L.G., piuttosto freddo. Deluso, ma vuole vedermi ancora. Un canadese (della rivista «Parachute») che, lui sì, mi ha molto letto. Anche lui con un’idea per una rivista. Lunga intervista sul tema: il cinema e le altre arti. Ma in fondo, «il cinema è davvero un’arte?». Mi lamento a torto, dunque. Vergogna di attendermi da questi giovani un’ammirazione estatica. Desiderio di avere [’ultima parola: troppo pesante.
Con l’ultimo dei tre visitatori avanzo un'ipotesi. Noi abbiamo già un’idea di cosa sia la modellizzazione (o la sintesi? o la pro grammazione?) con il fotogramma. L’adozione del fotogramma (carne e inconscio del film) segna (ben prima del videoregistrato re) un momento importante e solleva nuove domande (Barthes, Sylvie Pierre). «La verità ventiquattro volte al secondo»: brillante formula di Godard, così brillante che non vi abbiamo riflettuto abbastanza. Rapporto tra il tutto-in-movimento (il secondo) e i ventiquattro frammenti bloccati (fotogrammi). Il tutto non è sempre, e anche in questo caso, più della somma delle sue parti? Consideravamo i frammenti come il prodotto materialista dell’immagine percepita di un secondo di film. Era il capriccio dell’epoca (anche per Godard) questo desiderio di andare dal falso naturale di un’immagine verso il "terzo senso” che, se da un lato collabora a quel naturale, dall’altro, a volte, fa di testa sua. Perversione (come se).
Oggi, avremmo la tendenza a trattare la questione in modo opposto: daH’immagine globale ai suoi erratici componenti. L’immagine globale come punto di partenza, non più come pro dotto. Un punto di partenza non più messo in discussione o deri so per la sua visione stroboscopica, ma che deve condurre a un’immagine altra. Non si fa più l’archeologia di un’immagine, si passa da un’immagine all’altra. Dunque, l’immagine di parten za funziona come un modello robot (statistica) e le immagini d’arrivo come delle potenzialità che appartengono al suo pro gramma (e che, di conseguenza, non lo mettono in discussione). Virtualità (ventiquattro al secondo) che si scoprono come per anamorfosi dei modello. È un modo di intendere la cinefilia, il manierismo e tutto il resto. 52
La critica. Forse un giorno sarà possibile la percezione immediata (ma solo ai bambini nati davanti a un computer) di un eventuale talento nel scegliere tra queste potenzialità. Fra ventiquattro foto grammi, ci sono molte ragioni, di ordine differente, per sceglierne alcuni: in base alla loro conformità al “modello” o, al contrario, per il loro “terzo senso”. Ma Barthes, e io stesso, consumatori (e non produttori) di immagini, ci accontentiamo di godere di questo scarto (S!Z). Altri possono invece prendere tutta la questione molto seriamente. Ci potrebbe essere o meno del talento nel costruire un'immagine B a partire da un’immagine A. È del resto ciò che sempre più spesso fanno i direttori di casting (pubblicità, ecc.): là dove noi vediamo solo un corpo nella sua globalità, loro seleziona no delle virtualità che questo corpo ha in sé ma ignora compietamente. Siamo veramente in pieno consumo (mentre Barthes ci metteva di fronte piuttosto a una consumazione del senso). ENTRARE NELL’IMMAGINE è la sintesi di questo percorso che non ha più bisogno di verifiche esterne. Ciò che fa sì che si sceglierà questo o quel modo di arrivare a un’immagine B poggia su un vago criterio di “validità — atmosfera dell’epoca’’. La Moda può essere il modello di questo processo. Si tratta di “proposte" sotto vuoto che necessitano di poca “aria fresca" (fuori) per ridi spiegare l’insieme dei segni già usati e continuamente rinnovati.
Prendiamo gli attori e la loro recitazione. Il grande attore è colui che riesce a essere press’a poco lo stesso in ventiquattro fotogrammi (fedeltà inconscia di un corpo a se stesso) o colui che, pur essendo ventiquattro volte “altro”, riesce a produrre una forte sensazione di identità? “Io” è un altro o un altro è “io”? Domanda da rivolgere alle star (da rivedere al ralenti), per esem pio. Recitazione molto articolata (perfino pesante) di alcuni grandi attori americani (Cary Grant) considerati i simboli stessi della leggerezza. Oggi, Harrison Ford, da Spielberg a Polanski. Figli diversi di Hitchcock. Che forza, Hitchcock: ha sempre lavo rato con attori che di per sé erano già una teoria del montaggio. Parlare di questo con persone come Patrice Chéreau, André Téchiné e altri amanti di carne fresca.
27/4 A proposito di quanto detto sopra, una frase (a caso) di un libro ricevuto (per caso) di Peter Handke (L’ora del vero sentire). 53
«Ad un altro tavolo, stavano fotografando un bambino — ma la foto fu scattata solo quando il bambino ebbe realmente un sorriso infantile».1}
F.F. e J.L.G. Il parallelismo-schiena contro schiena tra Godard {maitre [tenser di sempre) e Fellini (che ho imparato ad amare da poco) se lo si facesse sul serio, permetterebbe qualche passo in avanti 1) nella valutazione del cinema nel suo complesso 2) nell'interminabile e aspra autocritica. (Walking down tbe boulevard Beaumarchais) — Se il cinema è una finestra, da essa ci si può gettare (suicidio), si può spiare (sorella Anna) dei miracoli (R.R.), la si può prendere come il ponte di Murnau («e non appena ebbero attraversato il ponte...»), come il buco nero del godimento, l’impossibile reale, ecc. Che lo si creda o no, esiste una funzione “al di là", un passare “oltre", “ultra mondo” o “dietro il mondo” (Nietzsche, che non ci crede). Ad ogni modo, è un asse perpendicolare, verticale, penetrante-penetrato (schermo-imene).
Eroticamente, potremmo dire: è il luogo di una possibile metafora, la sostituzione di una cosa con un'altra, perché si è “oltrepassata” una linea (cfr. la secca risata di Normandin, il cine ma diretto), perché siamo precipitati nel retro dello specchio, in una specie di morte, piccola (orgasmo) o grande. Passaggio dal segno alla “cosa stessa”, dal corpo all’anima, dal significante al significato. Da questi passaggi si fa sempre ritorno («gioco generalizzato di rinvio», diceva Derrida: si è rinviati da quel luogo oscuro e prezioso, inesprimibile). Eroticamente, dunque, potremmo dire: è il buco attraverso il quale si raggiunge un altro reale (un’altra dimensione dell’esistenza, confusione dell’oggetto e del soggetto, amour fou, coalescenza fra segno e referente, ecc).
Alcuni registi reinventano ad ogni occasione questa funzione del buco. E non solo in ambito erotico. Godard, per esempio. Ma quando si tratta di sesso, Godard non immagina altro se non l’atto di inculare e di guardare il fresco visino indifferente di chi è inculato — Si salvi chi può (la vita) -. Nelle sue opere non c’è erotizzazione delle cose, ma solo la secca metafora possibile ovun que, e sempre, di un corpo penetrato (dal linguaggio, dall'Altro, da un sesso). È dunque la prostituzione il suo soggetto preferito, perché per definizione essa ironizza questa penetrazione, non 54
essendo altro che una tecnica. E l'amore non ha nulla a che fare con la sessualità. Che è una sinistra formalità (isteria), filmata dal punto di vista del voyeur prosseneta.
Lo stupro (Maria violentata da Dio) è la sola realtà in materia di sessualità (da cui il tratto di strada comune percorso da J.L.G. e dalle femministe: il suo trucco: assicurarsi che nel profondo non si goda, mai). Il luogo della metafora è quindi eternamente indicato e condan nato in J.L.G. La morte (il calcio al cadavere in Pino all’ultimo respiro) è per lui irrappresentabile. L’orgasmo (come piccola morte), pure. In // disprezzo, formidabile colpo di genio nella prima scena, in cui la Bardot parla del suo corpo, parte per parte, sottraendolo così alla supposta lubricità del pubblico. Godard inventa un cinema estremamente moderno e sensibilissimo in cui il mondo non è più frammentabile. Quando filma un oggetto o un corpo, non suscita mai il desiderio di ciò che sta fuori campo (cosa che invece accade ancora nei film di Antonioni o di Bresson) o anche solo lì accanto. Detto altrimenti: indietreggia davanti alla metafora (l’immagine-buco) e rifiuta la metonimia (immaginebordo). Il suo è uno tra il primo cinema a-metonimico mai cono sciuto. Solo Moullet, che l’ha capito così presto e così bene, si è spinto altrettanto lontano e anche oltre (in entrambi i casi, stesso burlesque antipatico del piccolo gentiluomo fiero dei suoi limiti).
Che poi non sia rimasto asfissiato - preso com’era in tali morse — è davvero sbalorditivo. Ma la ragione è evidente: consiste nel fatto che, a partire da un certo momento, la metonimia non è più la paura e il piacere di scoprire a poco a poco uno stesso ambiente (o corpo), ma il fatto che l’"a poco a poco” definisce il nostro rap porto obbligato con quel nuovo corpo costituito dall'insieme delle immagini che scorrono davanti a noi. L’amore del prossimo (della prossima inquadratura, della poco a poco) è sostituito dalla scomparsa del lontano (e del suo folle amore, raccomandato rabbiosamente da Nietzsche). L’amore del lontano è immediata mente stroncato dal latto che il lontano è divenuto vicino, cioè dal fatto che un’immagine cinematografica è sempre “messa sullo stesso piano” (chiamata a comparire) più di qualsiasi altro tipo di immagine. Il momento-Godard del cinema è quello in cui inizia ad insi nuarsi la preoccupazione culturale-semiologica. All’epoca si parla 55
di collage, ma Godard descrive un mondo già-collato (incollato, inculato). È lui ad essere realista. Metafora impossibile, nuova metonimia. Non più una scena che procede passo passo, fino al cuore — messa in scena classica, Lang, Mizoguchi -, ma una scena che a tratti si accorda con altre (vestigia, immagini bloccate, sinistrate). Godard è il primo ad aver preso sul serio (in verità cera già stato Dziga Vertov) il fatto che il fuori campo di un'immagine non è più nella scena imme diatamente contigua ma in una qualunque delle altre immagini che nello stesso momento circolano nella memoria viva degli altri. Cui si accede attraverso giochi di parole, rebus, analogie, tramite tutti i giochi linguistici possibili.
Rispetto a questo, Fellini rappresenta l'altro polo. A partire da La dolce vita, anche lui rinuncia a raccontare una sola storia, accu mula gli episodi, non procede più dalla periferia di una scena al suo cuore (bucato). Mette in scena, con ironia, l’attesa sempre delusa di questo buco del godimento (o della performance, della catarsi, della parola finale). Come il miracolo troppo atteso de La dolce vita, che non accade mai. Ma, diversamente da Godard, egli resta sistematicamente fedele alla metonimia. I suoi film esplora no un luogo allo stesso tempo chiuso e infinito, in cui non si smette mai di entrare (false entrate - Roma) e di uscire (false usci te). Il luogo è di per sé un programma ma utilizzabile in mille modi. La golosità felliniana (credo che, a differenza di Godard, sia un mangione) fa sì che l'a poco a poco costituisca l'oggetto stesso del desiderio. Senonché l’idea di sfilata, che Godard immagina sempre come la fila d'attesa davanti ai forni di Auschwitz, in Fellini diventa ludi ca. È il mondo che sfila davanti a una cinepresa che si defila. Da questi due movimenti (anche sonori) nasce una soddisfazione sem pre provvisoria e l'oblio che tutto questo deve per forza '‘andare da qualche parte". Per Fellini, dunque, la metafora è vietata, non c’è possibilità di coalescenza tra il niente e il niente (post-sincronizzazione sempre molto elaborata), non c’è significato, non c’è reale. Com’è possibile? È possibile grazie al fatto che i suoi film non pre sentano né temi, né soggetti, ma miti. La dolce vita, l’infanzia (Amarcord, I clowns), Roma, la (città delle) donna (e), la nave che va, la televisione. Tutte cose inesauribili che si riflettono in ogni dettaglio, ma che non hanno mai "consistenza”. Nel cinema di Fellini, la rappresentazione è la condizione umana. 56
In Godard si avverte una nostalgia della consistenza delle cose (e una rabbia divertita davanti all’inconsistenza dei segni). Per vendicarsi, si è messo a dirigere e a fare la morale ai segni, trat tandoli come cose o esseri umani. Transfert del rapporto con l’altro sul rapporto dell'altro con la sua immagine e di noi con questa stessa immagine. Rapporto a tre per salvarsi dall’orrore del rapporto a due. Così due si coalizzeranno contro uno.
Anche in Fellini troviamo questa stessa consistenza perduta a vantaggio della sfilata delle maschere e delle voci (e di una voce che ricorda). Ma Fellini ha l’eleganza di non prendersela con nes suno in particolare (non ci sono cattivi nei suoi film, non ce colpa) e l’intelligenza di non confrontare i suoi personaggi con dei valori, ma solo con personaggi più grandi di loro, con delle immagini giganti (Roma, ecc.). Ginger e Prede commovente per ché la vecchia cultura popolare (basata sul “numero”, quindi sull’interruzione) è distrutta dalla cultura di massa che non fa che accelerarla (sempre meno tempo per ogni numero). Anche in lui è il tempo (la durata) che comincia a mancare. Nell7»/erw.tfrf — così come in Passion — l’inquadratura finale (l’alba vista dall’appartamento) è la ricerca di un luogo inedito da cui si possa ancora assistere a una cosa che abbia una durata propria.
29/4 ALOUETTE, JE TE PLUMERAI (Zucca). Ormai, qualsiasi film che dichiari subito la sua “andatura”, il suo modo di procedere (in qualsiasi direzione) è, per me, il benvenuto. Questo respiro manca talmente alla televisione da diventare inestimabile al cine ma. Il mio odio per il turismo (programmato) e il mio amore per il viaggio (non programmabile) si possono applicare tali e quali agli audiovisivi. I film sono viaggi, la televisione turismo. I telemediatori sono le guide (imposte), gli autori si accontentano di aver riconosciuto il terreno e di non aver scoperto nulla, solo una loro isoletta, in cui noi siamo liberi di seguirli o no. L’iper-intelligenza di Zucca è un piacere sia da ascoltare (a «Microfilm»14) che da vedere nei suoi film. Un po’ troppo soddi sfatto di sé, comunque, cosa che impedisce al film la sua vera emozione, collocato com’è in una monomania evidentemente logica, studiato/a. Ancora un cinema fatto a scapito degli attori, dei personaggi e del pubblico. Si può goderne se ci si trova dalla 57
parte giusta della barriera intellettuale, ma davanti all’evidenza dell’enigma, bisognerebbe poterne godere più semplicemente come accade con Bunuel o Ruiz. Solita storia degli artisti baroc chi (illusionisti e prospettivisti), più convincenti se spagnoli che se franco-cartesiani. Tuttavia, buone idee (anche a livello teorico). I personaggi che si imbrogliano reciprocamente ma che, allo stesso tempo, sono così accecati dalla storia in cui si immaginano di essere da non rendersi conto che le loro vittime non corrispondono a questo ruolo (logico, visto che anch’esse imbrogliano). Qualche momen to potenzialmente interessante, quando i “giocatori” sono a tal punto prigionieri delle immagini (la propria e quella che viene loro proposta degli altri) che non riescono più a “giocare’’. A mio avviso, in tutti i suoi film Zucca gira intorno al solito pretesto: un falso infermo finisce col non sostenere più la finzione perché le sue vittime sono troppo stupide (catturate in una rete di immagini) per avere dei sospetti. Al punto che il falso infermo può perfino smettere di fingere (fìngere non serve più a niente) o addirittura smascherarsi. Momenti diffìcilmente accettabili dallo spettatore, che, in generale, non ama spezzare la verosimiglianza delle apparenze a favore della logica del desiderio. Potrebbe esse re un grande soggetto (quello dell’accecamento reciproco di per sonaggi che condividono — apparentemente - uno stesso spazio), in Lang o Chabrol, appunto. L’attore migliore è quello che diventa trasparente. In tutti i sensi. Crediamo di averlo decifrato e, di colpo, non lo vediamo più (anche quando bara). Oppure porta dei vestiti trasparenti (la fanciulla che rifiuta di mostrarsi nuda e che indossa, alla fine, un superbo abito trasparente, aderente e verde senape). Diventare impercettibile = guadagnare un corpo invisibile. O visibile da una persona sola. Perverso = colui che, nel quadro che tutti vedo no, riesce a vedere un quadro diverso. Condurre lo spettatore a cambiare quadro, dettaglio dopo dettaglio. Si riesce a vedere troppo tardi. Non si guarda lo spettacolo che si è scelto e voluto e che riproduce un primo spettacolo visto per caso. Si rivede mentalmente il primo spettacolo diven tato prezioso perché lo si è fatto riprodurre. Lo si rivede come un assoluto dopo averne goduto come si gode di ciò che accade per caso. I piccoli perversi fanno rifare una cosa per appropriar sene tramite la sua ripetizione. I grandi perversi godono due 5S
volte: una volta all’idea che il fortuito diventerà “voluto" grazie alla sua futura celebrazione (celebrazione che deve essere ottenu ta — e a prezzo di quali astuzie! — ma che vale come nuova prova). Essi celebrano in anticipo ciò che non possono afferrare nel momento presente dell'evento. Originarsi da se stesso è il mito della perversione di uno solo. Se mi vedo impossibilitato a guardare più tardi questa cosa che vedo ora e che mi sfugge, godo "a credito”. Prowederò a saldare il conto di questo godi mento in un secondo tempo, che sarà la messa in scena di questa visione attuale. Ma attenzione: la visione di una cosa e la messa in scena di questa visione sono diverse e non coincidono mai. Godo per due volte, recito due volte: guardando ciò che non vedo (perché non sono affatto Divedendo ciò che non guardo (perché ci sono completamente).
Zucca conosce troppo bene Klossowski per non sapere tutto questo, che è quasi spaventoso. Egli mette in scena la famosa sequenza del cieco che dice di essere guarito in La donna del mira colo di Capra. È interessante come riesce a tenere distinti la visio ne (masochista) — l’immagine (sempre falsa) — e lo sguardo (inte riore). In un certo senso, il suo soggetto è la persistenza retinica. E anche la persistenza culturale (cinema, pittura). Per trovare un esempio appropriato, risale fino a Tintoretto, spiegandomi che Susanna al bagno è diventato Susanna e i vecchi perché sotto uno strato di pittura sono stati scoperti questi personaggi di voyeurs che non credevano di fare una cosa giusta nascondendosi. TRUFFAUT. La Corrispondenza15. F.T. conserva le copie delle sue lettere, sapendo fin da subito che saranno pubblicate. Allo stesso tempo non si serve di quest’attività per confidarsi, sfogar si o atteggiarsi. Sa così presto chi è e dove sta andando che la scrittura non gli serve da parte “maledetta”. Non dubita mai, neanche per un secondo, che sia possibile, sempre, fare il punto su tutto. Altrimenti di certo non scriverebbe. Per lui, la scrittu ra non è legata al dubbio ma al sapere e alle cose pratiche. Dà consigli, ordini e appuntamenti. Senza alcun romanticismo. Le lettere sono sempre delle sceneggiature e il destinatario non può leggerle senza fare (o non fare) qualcosa che prima ignorava. Piccoli servizi, grandi servizi. Spiega a Lachenay come deve fare per spedire a lui, Truffaut, una lettera d’insulti ben meritata. Truffaut non crede che le lettere suggellino delle alleanze (che esistono già), ma che concludano delle cose nel presente. Non le 59
scrive per avvicinarsi all’alcro, ma alla Henry James, cioè con l'idea che esse non costituiscano un rimedio alla timidezza ma che le siano superiori. Sono già degli atti, non delle promesse di atti. Sono scritte per restare e lui, che le ha scritte, non è altri che colui che esse faranno vivere. Il suo esibizionismo è davvero strano: consiste nell’incontrarsi con se stesso, tra gli altri, “già scritto”. Tra le pagine del dizionario, con una notizia fredda come la morte, ellittica e senza sentimentalismi. Egli è scritto. Ha amato così tanto l’oggetto libro che gli basta immaginare che sarà prodotto da esso. È figlio dei libri, non di una madre detestata. Anche i film sono figli dei libri, gli si deve dunque rispetto (fedeltà all’autore, non al suo spirito ma proprio all’autore reale: Roche, Pons, Good is). BASTA CON L’IMMAGINE. Il risultato del primo turno delle elezioni dovrebbe farci (farmi) riflettere. Barthes ha scritto in pieno poujadismo; il lepenismo ha bisogno (per essere combattu to) di nuovi Barthes? I media, ad esempio «Liberation», hanno minimizzato Le Pen. Il suo elettorato, se lo si conosce, risulta impresentabile. Stirbois e Mégret sono dei piccoli fascisti, dei sicari. Ma gli elettori (scioperanti, poveri) non ne hanno un'immagine nitida. È più facile conoscere le loro supposte ragioni che i loro volti o i loro discorsi. Allo stesso tempo, facen do zapping sul divano, la nostra capacità collettiva di concentrar ci sulle immagini presentabili e sempre ripresentate è stata spa ventosamente corrotta. Siamo tutti dei Séguéla. E questo mentre un terzo degli elettori dichiara - in modi diversi — che ne ha piene le scatole di quelle immagini. Al di là dei leader (compreso Le Pen), il 30% dei francesi senza volto condivide lo stesso desi derio di ideale e la stessa sete di delirio. L’ideale è regressivo (guerra di classe, natura, isteria nazionale) ma corrisponde alfa severa realpolitik dei tre grandi, le cui rispettive qualità attoriali non sono mai state così ben valutate grazie al fatto che d’ideale resta loro ben poco. Vincerà Mitterrand perché è sopravvissuto a più ideali rispetto agli altri ed ha occupato così il posto simme trico a quello di Le Pen. Mitterrand proteggerà i democratici del reale (fa Francia tutta a destra, quella del febbraio ’34) e Le Pen gli altri, i democratici della realtà (fa piccola Franfrance in Europa). La sconfìtta della destra cosiddetta civile è dovuta al fatto che in questo momento non c’è altro ruolo disponibile. Adesso l’immagine è diventata fa posta in gioco. Al fantasma dell'inimmaginabile sono indubbiamente preferibili delle imma 60
gini contrastanti. Ma bisogna fabbricarle, perché non esistono in natura. La strategia elettorale di Le Pen, diversa dall’anti-parlamentarismo degli anni Trenta, obbliga i mass media, con la loro tradizionale concezione deH’immagine (tempo accordato per par lare proporzionale al peso elettorale), ad una sfida nuova. Trattandosi di un movimento populista (e popolare), non è possi bile ridurlo ai suoi capi, anche se la semplice visione delle loro facce basta a farsene un'idea definitiva. Altra idea: il doppio catenaccio del gaullismo e del comuniSmo — i soli garanti storici e beneficiari impudenti di quel poco di resistenza che c’è stato in Francia - è appena saltato. Nello stesso tempo, il razzismo non rappresenta piti uno scoglio dei discorsi politici. Per la prima volta da quando sono nato, il sospetto di razzismo non discredita più un uomo politico, neppure presso quei suoi elettori che razzisti non sono. Non è più un ostacolo insormontabile. La sinistra si sentiva talmente sicura su questo argomento che si stupisce ora di dover reinventare Tanti-razzi smo. Mitterrand le concede sette anni di tempo, al massimo.
3/3 I VALORI FANNO PARLARE DI SÉ. Dopo il mio zapping sul video-clip di Mitterrand (piuttosto ben riuscito). Come ricom porre il tutto? O ancora: dove affondano le radici del mio astio contro la propaganda? Vecchia questione ("les journées de Bondy”, sono già passati dieci anni?). Risposta (semplice?). Qualcuno pensa che il linguaggio sia sem pre adeguato a ciò che si intende dire, che gli enunciati non sono mai prevaricati dalla loro enunciazione. Che la parola - contraria mente a quanto diceva Sacha Guitry — non sia stata donata all’uomo per “mascherare’’ il proprio pensiero. Essi non credono al sospetto (vecchia citazione di Nietzsche, da ripescare). Truffaut, per esempio (in opposizione, ancora una volta, a Godard). Costoro non sono né infastiditi né shoccati quando viene loro rivolto un discorso edificante. Se già ne sono convinti, accetteranno senza batter ciglio le infinite maniere di articolarlo. E se percepiscono che l'oratore non è sincero, lo screditeranno e rideranno (o si infurieranno) non del discorso, ma di chi lo ha pronunciato. L’enunciato, per loro, non sani contaminato dal sospetto che nutrono verso l’enunciatore. Perché provo questa repulsione affascinata davanti ad ogni discorso edificante (o davanti al moralismo che sento proprio del modo di parlare degli americani)? 61
Concezione (da cui Lacan & co.) secondo cui il solo fatto di dire i valori li invalida. Perché necessariamente aggiunge loro qualco sa: l'enunciazione. Il solo fatto di dire (e il solo fatto che questa dizione sia automaticamente personale, singolare) fa precipitare il detto verso una perdita di verità. La verità può essere solo quella di un rapporto (enunciato/enunciazione), non quella del solo enunciato. Nell’ambito di questo rapporto, poi, può trovarsi più dalla parte dell’enunciazione (sincerità) o più dalla parte dell’enunciato. In ogni caso, rimane sempre irriducibile, solita ria, singolare. Nei film di Bunuel (Élt per esempio) mi risulta pressoché impossibile non distinguere un discorso pietoso (laico o religioso) da colui che lo tiene e dal momento in cui lo tiene. Individualismo perverso. Mentre le persone per bene godono ancora di più se è un bambino che canta o che interpreta uno spettacolo edificante, io mantengo assolutamente separati spetta colo e bambino. Barthes si è interessato alla questione. In Frammenti di un discorso amoroso racconta, citando Abou Nouwas (?), fino a che punto sia possibile godere solo dell’enunciato (il “ti amo” del gigolo) pur sapendo che l’enunciazione è falsa. Questo significa: io non credo che possa esistere — se non in momenti privilegiati — una verità che inglobi (package) il detto e il dire. È la base stessa della tecnica psicoanalitica, ma trasferita sul piano dei discorsi coscienti e impersonali. Possiamo anche dire: i valori sono degli orizzonti (atteggia mento da viaggiatore), non degli strumenti. Solo dell’ideologia diventano strumenti e, come essa, incollano (adesione) la massa alle sue credenze. L'ideologia ha forse bisogno di “sceneggiature”, diverse in apparenza, in realtà identiche. Queste sceneggiature sono dei falsi viaggi. Solo turismo. Continuando a girare in tondo, e muoversi nella tautologia, si arriva a credere di scoprire un “caso preciso” (carrello ottico circolare). Pierre Legendre ha ragione nel sostenere che la verità deve vedersi e dev’essere trattata esteticamente. Tutte le religioni hanno lavorato su questo punto. Se l'enunciato è dogmatico, per mette di fare l’economia della verità come “rapporto personale". L'enunciazione allora conta poco, perché la lettera ha avuto la meglio sulla parola. Forse le propagande moderne (politiche, totalitarie, pubblicita rie) suscitano irritazione perché fingono uno spirito ma non osano tener fede a una lettera che non hanno. Parole d'ordine, 62
linguaggio stereotipato, ecc. Si dice: o il dogma (in quanto sempre-già-scritto) o la verità (in quanto processo), ma tra i due c'è troppo fariseismo.
DA CHOCOLAT AL TEMPO, SEMPRE IL TEMPO. Valanga di idee uscendo dal film di Claire Denis.
1. Potremmo porre una sola domanda ai film: quella relativa al tempo che si concedono. Questo tempo è posto sotto la garanzia (la protezione) di un fine, di un punto d’arrivo, di una linea d’oriz zonte che devono essere sufficientemente legittimi per giustifi care tutta l’operazione. Tempo logico della sceneggiatura: tempo per vedere, per giudicare, per prendere coscienza o per fare conoscenza, per chiudere il cerchio o trovare il bandolo della matassa. Ma poi — e qui comincia il cinema — il film ha la possibilità di collocare dentro al primo molti altri tempi. I film brutti sono quelli che non fanno altro che emblemetizzare il tempo della sce neggiatura (ogni sceneggiatura è fatale: cfr. quanto scritto ieri, sulla propaganda o la pubblicità). I film buoni, invece, sottomet tono tanti tempi parziali a un tempo dominante. E i film molto buoni lasciano apparire una pluralità di tempi che non sono ammassaci gli uni sugli altri {La morìe corre sul fiume è il film a cui penso più spesso). Nei film brutti tutto attende la fine della sce neggiatura per trovare compimento: gli attori, i paesaggi si agi tano ma non si muovono, attendono solo la parola “fine”. Cfr. il mio pezzo su Jean de Florette. Due tipi di tempo: coagulazione o emorragia. Il cinema vicino alla musica. Nella musica tutto si muove nello stesso tempo. O anche lì ci sono casi di immobilità? 2. Finzione/Documentario. Vecchio motivo (J.Dt.): ogni grande film è allo stesso tempo finzione e documentario. Cerchiamo di essere piti precisi. Il cinema non ha forse cominciato constatando che, anche quando si focalizzava sulla scoria e sull'attore, portava necessariamente con sé tutto un ambiente metonimico che più tardi avrebbe acquistato un valore documentario? Differenza dal teatro (in cui questa focalizzazione può aver luogo). E poi, l'indebolimento della finzione (il dubbio) non ha riequilibrato la bilancia, sca vando un fossato tra i personaggi e il loro ambiente (Viaggio in 63
Italia)"! E non è forse vero che negli anni Cinquanta-Sessanta anche il cinema americano ha dovuto far suo lo scrupolo “euro peo” di portare avanti insieme storia e documento (Preminger), laddove prima (verificare) la “documentazione” era uno stadio preso sul serio, ma preliminare al film (non ricordo più per quale film di Ray gli attori avevano dovuto fare uno stage in fabbrica o qualcosa del genere). Quando gli autori non fanno più questo lavoro con i loro attori (Godard di fronte a Huppert in Passion), i film diventano dei documentari sul non mestiere degli attori stessi (non-mestiere che solo l’amore o la tirannia del regista-autore salva). Non siamo stati forse costretti a sostenere un cinema in due tempi, in cui del mai-visto (documentario) viene immediatamente irregimentato per contribuire a nutrire il già-saputo (finzione)? In cui la regola del gioco è presente contemporaneamente nelle parti singole? In cui il solo punto d’incontro tra finzione e docu mentario è il racconto in prima persona, forma di compromesso tra i due? Da Pickpocket a Chocolat. 3. In Chocolat, una cosa assolutamente riuscita: la ragazzina. Ma essa a volte è “finzione” (la storia passa attraverso di lei), a volte è “documentario" (il documentario passa attraverso di lei). Un’inquadratura per lei, un’inquadratura grazie a lei. A volte “soggetto”, a volte “oggetto" (utile alla individuazione dei luoghi).
4. Il tempo in Chocolat. Stranamente, ho subito pensato al Preminger dei grandi film per adulti: Exodus, per esempio. Forse perché ci sono scene che cominciano con un récadrage, come se il tempo fosse scivolato avanti e noi cogliessimo solo la fine di qualco sa. Simulacro del tempo trascorso.
5. Una domanda, una sola. Perché, quando non si sa (né si vuole) far confluire tutti gli elementi separati verso uno scopo comune, quando si rifiuta ogni contatto con la Storia (secondo me il senso del film di Claire D. è che l’Africa non appartiene a nessuno), non si ha la semplicità di iniziare il proprio film come ha fatto Tourneur in Ho camminato con uno zombi: «Non dimenticherò mai...»? Perché far fìnta di seguire la grande tradizione della fic tion (“un cammino collettivo") per dire che non è altro che la perfetta evanescenza di un’evocazione d'infanzia, che non può essere condivisa se non detta e data come posta in gioco (soggetto 64
che ricorda se stesso, torna sui suoi passi, si illude, si cerca)? Come poter essere al centro del quadro se questo quadro lo si è fatto troppo grande?
10/4 SPOSTAMENTO. Parlando con Guy Scarpetta e Dominique Paini (intervista per «Artpress»). Il cinema come “arte” del secolo, un secolo che, fin dai suoi inizi, aveva abbandonato per sempre l*idea di rappresentazione e che avrebbe avuto bisogno del cinema per non deludere il desiderio del popolo che invece voleva ancora la rappresentazione. “Arte" e “popolare” anche per questo. La crisi della rappresentazione, di cui si parlava tanto quindici anni fa, finirebbe per colpire quel desiderio. Ma pro prio quando noi (saggi cinefili) abbiamo smesso di parlare di essa. Non c'è più nessuno, in effetti, che pone a un film o a un'immagine la domanda su che cosa rappresenta (nel senso di “delega" di potere).
C’è un modo semplice per tornare sulla questione simbolizzata dal “carrello di Rapò". A partire da un dato momento, è sembrato che il cinema stesse diventando realista e persino neo-realista. Ma questo concetto di ritorno alle cose stesse è ingannevole. Perché infatti Rossellini rimane sempre lo stesso sia quando manipola in modo grossolano degli animali morti (Fantasia sottomarina) sia quando pone la macchina da presa in una posizione di attesa pas siva? Perché lavora a un simulacro. E perché ciò che registra è un “rapporto con”, un punto di vista. Infatti, solo del reale (o alme no delle parvenze realistiche) può far da sfondo e da fissaggio all’emergere di un oggetto morale o mentale: l'atteggiamento, la postura — il rapporto. Il mondo distrutto e ri-umanizzato degli italiani non è il soggetto dei film di Rossellini ma la condizione alla quale un soggetto filmante/guardante può apparire, nella sua situazione. Dunque il cinema moderno ha fissato, fotografato dei rapporti, non delle cose. In una nuova versione delle “tre epoche”, potremmo dire: 1) sog getto ►immagine; 2) immagine ►soggetto; 3) immagine ►sogget to ► immagine. Alois Riegl: abbellire/spiritualizzare/rivaleggiare.
Ecco una prova di quanto detto (alla radio con Étienne Chatiliez): gli dico che la famiglia Groseille (nel suo film La vita 65
è un lungo fiume tranquillo, ndt) viene dal cinema italiano (dice di aver pensato alla Magnani), perché, in quel genere, nel cinema francese non c’è niente a cui poter fare riferimento. È d’accordo. Ma fa altri due ragionamenti: quello della testimonianza sociale impegnata (“queste persone esistono”, ecc.) e quello del pubblici tario (“ma per me esistono solo in ‘versione italiana’”). L'idea di cogliere nella realtà francese degli elementi mai visti non lo sfio ra più (a parte forse qualcuno, nel suo angolo, come Mehdi Charef): è ben più vantaggioso trasferire (francesizzare) un’imma gine italiana (Scola). Immagine chiama immagine.
Sfez e il “tautismo”. Soldi chiamano soldi, alla guerra come alla guerra, ecc. Parvenza di saggezza. Invece, al contrario, segno che qualcosa non va. Certamente, tutto ciò non è falso, ma è terribile limitarsi a questo. Sta forse qui la crisi della rappresentazione: nel non saper più fare metafore. Così, l'immagine chiama l'imma gine (non fa altro che passare attraverso il soggecto/codificatore/ decodificatore), e non rappresenta più niente. L’immagine non è più un significante nel senso lacaniano: «ciò che rappresenta il soggetto come un altro significante», perché il soggetto che essa rappresenta è colto solo nella sua dimensione di decodificatore o di lettore. Idea di fondo sul “carrello questione di morale — Kapò". Nella storia, nella storia di Francia e del cinema francese. Tutto il cinema francese successivo a Renoir e alla sua generazione (che ha conosciuto le guerre, gli orrori, le scelte e l’esilio) si trova di fronte a una situazione nuova: quarant’anni di pace. Il regista non è più obbligato a testimoniare (a far propaganda, anche per le cause migliori), può creare standosene in disparte, se lo desi dera (Bresson), ma, nello stesso tempo, non riesce a dimenticare ciò che non ha potuto vivere: la guerra (Les carabinieri), la rever sibilità carnefìci/vittime (collaborazione, epurazione) ed anche, naturalmente, l’innominabile (i campi di sterminio). È lasciato libero ma, se si pone il problema morale, libero non è. Lascia così le ultime testimonianze, spostate o differite, su delle situa zioni limite che filma (di sbieco) solo perché gli permettono di moralizzare (a cose fatte) i gesti elementari del mestiere di regi sta (montare, tagliare, mostrare, nascondersi, avvicinarsi, ecc.). Vecchia idea che persone come J.L.G. o Hans Jùrgen Syberberg non cessano di chiedersi che cosa avrebbero fatto. Condizionale passato. 66
Idea (con Chatiliez). L’industria del visibile. Le avventure della “fotologia” (seguito). Bisogna avere un’immagine che ci stia incollata, che ci nasconda e protegga allo stesso tempo. Utopia di un mondo senza immagine e utopia di un mondo in cui le nostre immagini ci rappresentano (e ci sostituiscono). Visione tragica di questa sostituzione (del tipo: io valgo più della mia immagine: alienazione, ecc.). Ma della stessa cosa ci può anche essere una visione gioiosa. L’immagine diventa allora un angelo custode, come nel film di Wenders. L’immagine come doppio sociale-narcisistico in un mondo in cui il legame sociale si ricostituisce con difficoltà. Espressione triviale e giusta: parla al mio culo, la mia testa è malata. Il mio pezzo su Max Headroom. Saremo tutti sostituiti? L’immagine come robot. Come artifìcio (pubblico) che permette di restare se stessi (in privato). Da cui la tragica fine delle vere star sostituite ancora vive dalla loro immagine. Bella espressione di Sibony. I valori: tutto gira intorno al signi ficante “solo”. Io e solo io, la mia famiglia, il mio gruppo, la mia patria, la mia razza — loro e solo loro. Così si creano solo legami interni. I "valori” di sinistra? È possibile? Meglio, dei “principi”? (continua).
13/4 IL NOCCIOLO DURO. Mi accorgo che quando parlo per delle ore a quelli che volentieri mi ascoltano, non faccio che girare attorno ad un “nocciolo duro”, quello dei film che, come dice Jean Louis Schefer, “hanno ri-guardato la mia infanzia”, o meglio la mia adolescenza di cinefilo innocente. Lista di questi film, storia di questa lista, modi diversi di gestirla, di teorizzarla, di imporla. Ma in fin dei conti, a Eric S., che mi domanda se ci sono dei criteri estetici oggettivi per stabilire la bellezza di un film come Ordet La parola, non so che cosa rispondere, se non rimarcare il facto che per alcuni (tra cui io) ci deve essere stato un effetto Ordet, un effetto di cui noi siamo i testimoni, i traghettatori e i guardiani (non del film, dell’effetto). Il gioco degli specchi non è finito, dunque, ed è stato molto imprudente l'aver voluto ad un certo momento (ai «Cahiers») “simbolizzare” la cosa (io/i “miei” fìlm/“il” cinema). Così si è formato il nocciolo duro, che non cambierà più.
«Alcuni film sanno qualcosa di me» è il correlativo di «io so due o tre cose di loro» per averli visti e rivisti. Dovrei avere il coraggio 67
di sceglierne uno e raccontarne la nostra scoria. Per esempio il primo su cui ho scritto: Un dollaro d’onore. Azzardo cento metafore che tornano allo stesso punto: il film è una casa o un paesaggio, in esso ci si introduce (rapimento volontario) per perdercisi e ritrovarcisi, liberati dal film e liberi di cornare a visitarlo in un secondo momento, stupiti di trovarvi altre vie d’accesso. Mistero di ciò che resiste all’interpretazione conservandone intatto il desiderio. Eric S. mi parla di “bellezza assoluta”, ecc. Adora Tarkovskij. D’un tratto non ho più tanta voglia di sorridere. La bellezza è proprio ciò di cui ho pensato di fare a meno. La bellezza quando vuole stupire non vuole niente, non esprime niente, si perde in se stessa. Per me (per noi) la bellezza era solo la diretta conseguenza di una ricerca della verità. Era la ricompensa di una specie di eroismo morale. Non si confondeva dunque mai con la grazia (a quesco proposito, non era necessario dare tante spiegazioni all’apprendista critico dei «Cahiers» per dimostrargli, ad esem pio, che L’ìsola nuda era pura commedia). Così, sono rimasto fermo allo stadio 2 di Riegl: “spiritualizzare” la natura. Ed ho vissuto la tentazione mac mahonisca attraverso il filtro di Bazin: rispettare una certa solidarietà degli esseri e delle cose immersi in un continuum spazio-temporale. Ma la solidarietà contava più degli esseri, mentre la verità di Mac Mahon consisteva, in fondo, nel perseverare intorno a dei campioni di razza superiore un ambiente ecologicamente respirabile (famosa frase di Mourlet su Charlton Heston — assioma: assioma come fallo). LA MAGIA. Dibattito a Cannes su Océaniques con Rouch, Delvaux, Boutang. Idea di partenza: la magia del cinema nell’epoca della televisione. L’idea non tiene e ce rendiamo conto quando proiettia mo due estratti di film (Fino all'ultimo respiro e Stromboli). Sono due grandi film ma il termine magia non gli si addice. Il film di Godard ha della grazia e quello di Rossellini un viscerale ipnoti smo. Perché allora usare la parola magia come se riassumesse tutto il cinema mentre ne designa solamente le origini? La magia è l’esi tazione di un mago di professione (Méliès) tra i suoi trucchi e quel li che gli mette a disposizione la tecnica del cinema, quella tecnica di registrazione illustrata da Lumière. Da allora la magia non ha smesso di perdere colpi. I trucchi sono svelati.
Ma di fronte a un film come Steps di Zbigniew Rybczinski, la magia ritorna. La tecnologia video che permette di inserire dei 68
turisti americani nella scena delia scalinata di Odessa è un’ope razione magica. Molto semplicemente, il film di Ejzenstejn è diventato la realtà di riferimento. Se aggiungiamo a questo i recenti tentativi di Alien (La rosa purpurea del Cairo, Zelig) appare chiaro che la magia, oggi, consiste nell’arte di scivolare furtivamente fuori dallo schermo o dentro l’inquadratura. Genesi in atto, forse troppo cosciente, ma che dimostra a che punto ci troviamo. Xavier B., Frédéric S., Francois G.: i ragazzi che amo vogliono fare dei film. Ingenui, si potrebbe dire, ma probabilmente inten zionati a uscire vittoriosi da questa avventura. Tanto desolata (ai miei occhi) quanto Loro sono sono pieni di fiducia. Non mi ascol tano come si ascolta un disfattista troppo lucido, ma, spero, come uno che traccia per loro un quadro dell’eredità che gli pesa addosso senza che essi neppure ne abbiano coscienza. L’amore del cinema. Da un lato, si presume debba essere indi pendente, dall’altro si cerca colui che se ne farà garante. In una trasmissione tv un uomo della tv (P.A.B.) mi chiede, serio: lei ama sempre il cinema? Io amo del cinema ciò che mi ha “facto”, dal momento che di cinema io non ne ho fatto. Un dollaro d’onore, Anatomia di un omicidio, Intrigo intemazionale, La donna che visse due volte, Psyco, Vittoria amara, Il paradiso dei bar bari, Lo specchio della vita, Hiroshima mon amour, Lola, donna di vita, Il disprezzo, I quattrocento colpi, Ordet - La parola, Gertrud, Il posto delle fragole, Il covo dei contrabbandieri, L’alibi era perfetto, Freaks, Il diavolo è femmina, È nata una stella, Le strane licenze del caporale Dupont, La regola del gioco, Il ladro di donne, Il diavolo zoppo, La vita trionfa, La morte corre sul fiume, Sentieri selvaggi, Cavalcarono insieme, Soldati a cavallo, L’uomo che uccise Liberty Valance, Missione in Manciuria, Un amore splendido, Le petit garfon, l^a dolce vita, Un re a New York, Il generale, I racconti della luna pal lida d’agosto, Nuovi racconti del Clan Taira, Uwasa no onna, Dodes'ka-den, Aurora, Shangai Express, L’isola della donna contesa, Roma città aperta, Francesco giullare di Dio, Viaggio in Italia, Uccellacci e uccellini, Rocco e i suoi fratelli, Le amiche, La linea genera le, Bonjour tristesse, Un giorno a New York, Occhi senza volto, Il gran de cielo, Pickpocket, lei et ailleurs, Einleitung, La tortura della freccia, Viaggio a Tokyo, Ukigumo, Guade d’amour, Notte e nebbia, Il regno di Napoli, Cronaca familiare, Stalker, Aniki-Bobo, Il silenzio, A idade 69
da terra, El, Il fascino discreto della borghesia, Cera fina volta il West, Playtime — Tempo di divertimento, Luci del circo. Lista selvaggia, di prova. Più o meno i film visti tra il 1959 e il 1964. Bisognerebbe distinguere poi tra questo gruppo, di forma zione, e i film venuti dopo, quelli che, mi dico oggi, avrei dovuto (o potuto) amare prima. Lista dei diversi shock. Una volta fatta una nota è indimenticabile.
Possibili categorie: - il gruppo di partenza (per esempio Un dollaro d’onore) - Film che si ha voglia di ammirare, ma senza connivenza (Perfìdia) - Film a parte, a cui ripensare, solitari (ad esempio Freaks, Lo sconosciuto) - Film impeccabili ma non (ancora) di coinvolgimenco personale (Senso) - Film ufficialmente ammirevoli ma mai più rivisti (Partner) - Film scoperti un po’ tardi (La vita è meravigliosa).
A. Indiscutibile. Film compagno di strada. Visto e rivisto. “Gruppo” primitivo. Sempreverde. B. Divenuto indiscutibile o supposto tale. Ma poca connivenza reale. C. Meteora vista solo una volta, classificato a parte, secondo “gruppo” virtuale. D. Memoria viva, ma vaga, di avervi aderito. E. Capolavoro per gli altri e, finalmente, anche per me. F. Emozione personale, ma non necessariamente condivisibile. G. Sublime o importante, un tempo, per “noi”. Mai più rivisto. Per paura. H. Pol (jetton i presenti in modo erratico. Legati all’infanzia. A
SHADI ABD AS-SALAM. El mumiaa (D.), Ue paysan eloquent (F.) CHANTAL AKERMAN, lo, tu, lui, lei (G.) BORHAN ALAOUIE. // ne suffìtpas que Diai soit ava: les pauvres (G.) ROBERT ALDRICH. Un bacio e una pistola (E.) YVES ALLEGRET. Oasis (H.) WOODY ALLEN, lo e Annie (D.), Broadway Danny Rose (D.) RENÉ ALLIO. Rude joumée pour la reine (G.) MICHAEL ANDERSON. Il giro del mondo in ottanta giorni (H.) JOAQUIN PEDRO DA ANDRADE. La congiura (D.) 70
MICHELANGELO ANTONIONI. Le amiche (C.) L’avventura (E.), Professione reporter (B.) DENYS ARCAND. Rejeanne Padovani (D.) JACK ARNOLD. Radiazione BX distruzione uomo (E.) ALEXANDRE ASTRUC. Una vita. Il dramma di una sposa (G.) B
BORIS BARNET. Sobborghi (E.), La ragazza con la cappelliera (D.), In riva al mare più azzurro (B.) MARIO BAVA. La maschera del demonio (G.) JACQUES BECKER. Palbalas (C.), // buco (D.) MARCO BELLOCCHIO. Sbatti il mostro in prima pagina (D.) YANNICK BELLON. Goemons (D.) ABDELLATIF BEN AMMAR. Sejnane (D.) CARMELO BENE. Salomé(C.) INGMAR BERGMAN. Till gladie (C.), Afow/tw e il desiderio (G.), Sogni di donna (D.), Il posto delle fragole (A.), // silenzio (E.), Il rito (D.), Un mondo di marionette (D.), Panny e Alexander (E.) RAYMOND BERNARD. / miserabili (H.) BERNARDO BERTOLUCCI. Partner (G.), // conformista, La luna, La tragedia di un uomo ridicolo (D.) HERBERT BIBERMAN. Il sale della terra (E.) ALESSANDRO BLASETTI. Vecchia guardia (E) BERTRAND BLIER. Buffet freddo, La femme de mon potè (D.) YVES BOISSET. Dupont Lajoie (D.) WALERIAN BOROWCZYK. Diptyquetf.) FRANK BORZAGE. Tre camerati (C.) MICHEL BRAULT. Gli ordini (G.) ROBERT BRESSON. Perfidia (B.), Un condannato a morte è fuggi to (D.) e (H.), Pickpocket (A.), // processo di Giovanna d’Arco (A.), Lancillotto e Ginevra, II diavolo probabilmente..., L'Argent (D.) PHILIPPE DE BROCA. Cartouche (F.) MEL BROOKS. Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco (D.) RICHARD BROOKS. Lultima caccia (C.), Ilfiglio di Giuda (A.) TOD BROWNING. Lo sconosciuto (C.), Freaks (B.), Mark of the Vampire (E.) LUIS BUNUEL. Làge cPor (E.), Las Hurdes (A.), Estasi di un delit to (A.), tl (B.), Violenza per una giovane (D.), L’angelo sterminatore (E.), Simon del deserto (C.), Bella di giorno, La via lattea, Il fantasma della libertà, Quell’oscuro oggetto del desiderio (D.), Tristana (B.) 71
c FRANK CAPRA. Luci del circo (C.), La donna del miracolo (D.), La vita è meravigliosa (E.) MARCEL CARNÈ. Amanti perduti (E.) JOHN CASSAVETES. L’assassinio di un allibratore cinese (D.) ANDRÉ CAYATTE. Lo specchio a due facce (H.), Occhio per occhio (H.) CLAUDE CHABROL. Donne facili (G.), L’oeuil du malin (D.), Il tagliagole (D.), Lamico di famiglia (D.) YOUSSEF CHAHINE. El ousfour (D.), Iskandariah lek? (D.) CHARLES CHAPLIN. Luci della città (D.), La febbre dell’oro (E.), Il grande dittatore (E.), Monsieur Verdoux (B.), Luci della ribalta {B.\UnreaNetuYork&.) GUERGUI CHENGUELAIA. Pinumani (D.) VASSILI CHOUKCHINE. Des gens etranges (D.) CHRISTIAN-JAQUE. Francesco / (H.) VERA CHYTILOVA. Qualcosa d’altro (D.) MICHAEL CIMINO. // cacciatore (E.) RENÉ CLÉMENT. Monsieur Ripois (D.), Delitto in pieno sole (E.) JEAN COCTEAU. // testamento di Orfeo (B.) LUIGI COMENCINI. Pinocchio (D.), Lo scopone scientifico (D.) Delitto d’amore (G.) FRANCIS COPPOLA. Apocalypse Noia (D.), Un sogno lungo un giorno (C.), Rusty il selvaggio (F.) SERGIO CORBUCCI.// grande silenzio (D.) VITTORIO COTTAFAVI. Repris de justice (F.), Le legioni di Cleopatra (D.), Ercole alla conquista di Atlantide (F.) J.-Y. COUSTEAU. Il mondo del silenzio (H.) GEORGE CUKOR. // diavolo è femmina (A.), È nata una stella (E.), Sangue misto (E), Il diavolo in calzoncini rosa (E), Sessualità (C.) MICHAEL CURTIZ. Robin Hood principe dei ladri (H.), Lo spar viero del mare (H.), // giuramento dei forzati (D.), Il lupo dei mari (C.), Sinuhe l’egiziano (H.) D
JULES DASSIN. La legge (H.) GIANFRANCO DE KOSIO. Il terrorista (G.) JEAN DELANNOY. Hotre-Dame de Paris (H.) ANDRÉ DELVAUX. Duomo dal cranio rasato (G.) CECIL B. DE MILLE. Maschio e femmina (D.), Donna pagana (C.), Gli invincibili (E), Il più grande spettacolo del mondo (D.) 72
JACQUES DEMY. Lola, donna di vita (A.), Les parapluies de Cherbourg (A.), La favolosa storia di Pelle d’asino (E.), Josephine (G.), Une chambre en ville (C.) BRIAN DE PALMA. // fantasma del palcoscenico (D.), Carrie — Lo sguardo di Satana (C.), Vestito per uccidere (D.) EDWARD DMYTRYCK. / giovani leoni (H.) JACQUES DOILLON. La femme qui pleure (C.) STANLEY DONEN. Un giorno a New York (B.), Sua altezza si sposa (B.), Cantando sotto la pioggia (E.), Sette spose per sette fratelli (C.), Baciala per me (D.), indiscreto (D.) MARK DONSKOJ. L’infanzia di Gor'kij (D.), Arcobaleno (C.), A caro prezzo (E), Cuore di madre (D.) ALEXANDR DOVZENKO. Stors (D.), Storia degli anni di fuoco (E), La Desna incantata (E) CARL TH. DREYER. Blade af Satan’s Dagbog (D.), La passione di Giovanna d’Arco (E.), Vampyr (B.), Dies Irae (E.), Ordet - Im parola (A.), Gertrud (A.) SLATAN DUDOW. Kìihle Vampe (B.) MARGUERITE DURAS. Nathalie Granger (D.), India song (E.), Giorni interi tra gli alberi (E), Lei enfants (D.) JULIEN DUVIVIER. Panico (C.), Duomo dall’impermeabile (H.), Marie-Octobre (H.) ALLAN DWAN. Tennessee’s Partner (C.), Angel in Exile (D.), Veneri rosse (D.), The Restless Breed (D.), // diavolo nella carne (D.) STEPHEN DWOSKIN. Behindert (C.)
E BLAKE EDWARDS. Hollywood Party (E), / giorni del vino e delle rose (D.) SERGEI M. EJZENSTEJN. Ivan il terribile (C.), // prato di Bezin (C.), La linea generale (G.) JEAN EPSTEIN. L’oro dei mari (D.) VICTOR ERICE. Lo spirito dell’alveare (D.) JEAN EUSTACHE. La maman et laputain (B.), Une sale histoire (D.)
F
RAINER WERNER FASSBINDER. Selvaggina di passo (D.) La paura mangia l'anima (E.), Germania in autunno (C.), Un anno con tredici lune (D.), Veronika Voss (D.) LEONARDO FAVIO. El romance del Aniceto y de la Francisca (D.) 73
FEDERICO FELLINI. La dolce vita (A.), La strada (H.), Le notti di Cabiria (H.), I clowns (E), Amarcord (B.), Roma (G.), Ginger e Fred (fi) MARCO FERRERI. La grande abbuffata (E), Non toccare la donna bianca (D.), L’ultima donna (B.), Chiedo asilo (E), La cagna (D.), Storia di Piera (D.), Come sono buoni i bianchi (E) LOUIS FEUILLADE. Juve cantre Fantomas (D.) W.C. FIELDS. The Fatal Glass of Beer, The Barber Shop, The Pharmacist (C.), Mia bella pollastrella (C.) TERENCE FISHER. Distruggete Frankenstein! (D.) ROBERT FLAHERTY. L'ultimo eden (E), Nanuk l’eschimese (E.) RICHARD FLEISCHER. I diavoli del Pacifico (D.), / vichinghi (H.), 20.000 leghe sotto i mari (H.) PETER FOLDES. A short vision (H.) JOHN FORD. Missione in Manciuria (A.), I tre della croce del sud (E), Duomo che uccise Liberty Valance (B.), Cavalcarono insieme (A.), Soldati a cavallo (E), 24 ore a Scotland Yard (C.), Sentieri selvaggi (B.), Le ali delle aquile (C.), La carovana dei mormoni onsabile del sondaggio (l’autore) un sapere su di lui, oggi, lo ringra zia per avergli teso uno specchio. La legge del successo è diventa ta molto più rigorosa: si andrà a vedere un film perché è un film di successo e perché, come tale, è portatore di un qualche interes se generale. L'esperienza personale della visione di un film diven ta del tutto secondaria. Film che nessuno trova così “geniali” (Jean de Fioretto), descrivibili con pochi, poveri cliché, sono ugualmente visti “per curiosità" (come quei programmi televisivi di cui non ci importa niente).
La programmazione è la prova che il concetto è riuscito. Perché essa è anche una “declinazione" (linee di oggetti). Il concetto è di diritto infinito. Lo si può declinare in innumerevoli varianti, supporti e durate. E così, la tipica questione dei cinefili — quella del tempo — diventa assolutamente frivola. Non c’è nessuna diffe renza, nessuno scarto, tra il prodotto di referenza (il film) e le sue versioni derivate (manifesto, campagna di stampa, trailer, versio ni per la televisione, foto in circolazione). Industrie di programmi/industrie del tempo libero. Bisognerebbe lavorare su questo con maggiore serietà. L’offerta è sempre più sofisticata (andare a caccia dello yeti, in Tibet, per 92
qualche milione) ma i venditori di tempo libero vendono nello stesso tempo del significante hard e del confort soft. Se Le grand bleu può essere inteso come il simbolo di una serie di esperienze chiavi in mano, è normale che esso alterni tempi forti (che giusti ficano il viaggio e provano che non ce truffa) e tempi deboli. Ritrovo qui la mia vecchia definizione di cinema popolare: quello in cui il tessuto connettivo non disturba, in cui si sa che attorno ai pezzi di bravura ci deve essere per forza qualcosa di molle. Tempo facoltativo, ben lontano dal tempo irrimediabile, scono sciuto e vivente del film. Così, come un tour operator, il promautore è dispensato dal dovere di sviluppare delle idee di contenuto. È inutile, infatti, trovare parole nuove per vendere dei signifìcanti-tipo (la Cina in Bertolucci, il mare in Besson, il Midi in Berri). Bisogna solo assi curarsi che nessuno si sentirà truffato! Fare “vero" non più lavo rando il verosimile, ma facendo il verosimile con del vero! Torniamo al cine.
COLORS - COLORI DI GUERRA (Dennis Hopper). Non necessariamente antipatico ma di un’insopportabile disinvoltura. È difficile capire su che cosa si basi il successo di questo film negli Stati Uniti. Verosimilmente sulla presenza delle gang di Los Angeles, presentate come una realtà onnipresente che — e viene da chiedersi il perché — tutti fino ad ora si sarebbero dimenticati di filmare. Altrimenti, altro non è se non un grosso Hill Street Blues con due grossi attori (Duvall e Penn) nei ruoli di due poliziotti di pattuglia. È difficile (solo per me?) capire che cosa cerchi ottenere Hopper dall’esibizione dei suoi personaggi. Né un di più di verità documentaria, né un motivo drammaturgico, né un appello al senso e alla morale. Così finisce che un numero impressionante di comparse appartenenti alle diverse gang si agitino violentemente e si massacrino a vicenda nella più com pleta indifferenza, perché è del tutto improbabile che anche solo una di esse rimanga sullo schermo il tempo necessario per suscitare qualche interesse. E le riprese in primissimo piano sono ridicole, come se non si facesse altro che sgonfiare dei pal loni gonfiati. È, precisamente, uno spettacolo decorativo, come i graffiti di Los Angeles. Episodio del giovane (e grazioso) ragazzo a cui Penn 93
(Mac Gavin) tinge con lo spray il volto di verde = colors. Mercante di colori, robivecchi, ecc. Ma non c’è il talento di Coppola in Rtisly il selvaggio', il decorativo non diventa stilizzazio ne dal momento che nulla è correttamente valutato, misurato: durata delle scene, espedienti di sceneggiatura, ecc. A un punto tale che all’inizio si può credere di trovarsi di fronte a un proget to di “lezioni di vita” curato nei minimi dettagli, la dimostrazio ne, in vitro e con un eccesso quasi didascalico, del lavoro dei poliziotti a Los Angeles. Finché un filo narrativo, tanto fragile, quanto senza interesse, non li manda alla deriva. Un film come questo, che passa da un approccio all’altro come si fa col telecomando, laborioso e leggero al tempo stesso, è forse piaciuto proprio per queste ragioni. La mancanza di un punto di vista, si sa, è la chiave per una facile adesione. Si finisce per per dere completamente di vista il senso della storia: che tutte queste gang variopinte e violente si ammazzino a vicenda con una media di trecento morti all’anno finisce per apparire altrettanto irrisorio dei poco convinti agenti del CRASH che le sorvegliano. Il punto di contatto del film con la realtà è proprio questa sproporzione che riguarda tutto. Il tema "nobile”: amicizia virile tra due poliziotti, uno giovane e zelante, l’altro prossimo alla pensione e più saggio, è recitata assolutamente sopra le righe (soprattutto negli atteggiamenti minimi) dagli attori, che, tutto sta ad indicarlo fin dall’inizio, si amano da sempre. Insopportabili movimenti del capo di Sean Penn, più pivello che mai, prima di ogni minima frase. Momenti piacevoli: quando High Top, il Nero malvivente, inseguito dai due poliziotti, fa irruzione in un ristorante e si serve di una cliente (bianca) come ostaggio-scudo. Rinculando con lei su una scala, la donna si inarca con tale vigore da richie dere uno sforzo sovrumano per trascinarla: mai visto in un altro film un ostaggio compiere un simile gesto. Una bella frase: «Ho più tempo che denaro», detta dal capo (Frog) della gang “mista” (quello che picchia) quando gli propongono di pagare la cauzione (preferirà andarsene in prigione).
21/8 Colors, il giorno dopo. Ciò che resta è qualche grande movimento zebrato, orizzontale, come Los Angeles. Il grande corpo del ragazzo nero riverso sul letto, ucciso mentre stava scopando (gli è stato fatale cercare gli slip. Un poliziotto bianco nervoso e gron 9i
dante di odio l’ha steso, e non era neppure lui quello che cercava no). Non molto di più. Problema: bisogna credere che la televisione non basti più (agli americani) visto che vogliono vedere della televisione dal vero, cioè in una grande sala. Ben poco distingue Colors da uno sceneggiato televisivo, ma quel poco deve essere essenziale: vere star, un po' di culi nudi, folclore a grandezza naturale, le vedute notturne di L.A. dall'elicottero, ecc. Tolto questo, lo stesso tono cronachistico, le stesse emozioni standard. La televisione non sarebbe allora lo stadio terminale dei film di fiction, ma piuttosto un momento della loro sopravvivenza prima del ritorno sul grande schermo, gonfiati dagli ormoni del folclore iperreale e della disinvoltura decorativa. È così, dunque!
24/8 QUALCHE GIORNO CON ME (Claude Sautet). È strano andare a vedere il nuovo Sautet come se avessi familiarità con i suoi film precedenti. Ecco un piccolo universo in cui raramente ho messo piede. È anche strano trovarlo poco riuscito, ma senza provare avversione. Non ci sono più film nemici, ci sono soltanto differenti stadi di una malattia che rende esangui i film. Lo stadio-Sautet.
Imbroglio di sceneggiatura. All'inizio del film, si dice che il protagonista esce da una clinica psichiatrica e che è di quelli che soffrono di afasia (tema dell’afasia — a seguire). Lo si dice, ma non lo si fa vedere, così che, malgrado tutte le sue qualità, l’interpre tazione di Auteuil non poggia su questo tipo di disturbo (nondi meno, l’idea di una falsa guarigione parte bene) ma su un segreto “a priori”. Il personaggio, per lo spettatore, non deve mai porsi come oggetto, ma come puro soggetto: l’apprendista stregone di un piano oscuro. Se il film fosse riuscito, la fine avrebbe dovuto chiudersi sull’inizio, rischiarandolo indirettamente.
Bisogna forse rimproverare al film una cattiva resa psicologica, dal momento che la sua logica potrebbe essere totalmente diver sa? È una buona domanda, che evoca immediatamente Bunuel, altro pittore tardivo della borghesia francese in ciò che essa ha di massivo e codificato. Ma Bunuel ha dalla sua una logica del significante, cioè la nitidezza del sogno e l’irrisolvibile dei giochi di parole. La psicologia è nei dettagli, non nella struttura. Sautet è tra due fuochi. 95
Idea trasversale: già in altri due film (Noire histoìre di Blier e Le paltoquet di Deville) ci troviamo di fronte a questa bizzarra situazione: un variegato gruppo di attori conosciuti, che imper sonano una bislacca banda di personaggi appena abbozzati, è alla ricerca di una storia, che esiste poco, per niente o a fatica. La scena del ricevimento a casa di Auteuil crea senza forzatura que sta banda che, più o meno, riunisce in sé tutti i personaggi medi del cinema francese di sempre (Simenon), ma anch’essi privi di consistenza e di storia, di cui graziosamente sono alla ricerca. Auteuil sembra un po’ Delon nel film di Blier: dovrebbe essere l’eroe, ma non ci riesce. Attori fuori ruolo’. Marielle e Lavanant (caricaturali). Sempre le stesse cose: si pensa anche a Cura la tua destra... Facile metafora: il soggetto del film è la sceneggiatura. Auteuil è in attesa di una storia, gli altri alle dipendenze della sceneggiatura.
La debolezza del film riguarda l’identificazione dello spettato re. È auspicata nella parte più convenzionale (carica anti-borghese, anti-clichés), non lo è nella parte più misteriosa (la storia d’amore). Ce ne ineschiamo di una parte del film, in nome di una parte che manca.
Il tema di Sautet è il segreto. Ma egli non riesce a creare il desiderio di custodirlo o di svelarlo. Non è altro che una cosa che ci si è dimenticati di dire (all'inizio) o che (alla fine) non avrà nulla di segreto.
La Bonnaire attesa al varco dai tic del sorriso ammiccante-rapido-distruttivo. Salamandra degli anni Ottantacinque-Novanta, trota, inafferrabile. Vuole restare libera e si ritrova sposata. Autobiograficamente, rimango molto colpito dal modo in cui Auteuil non fa mai un passo falso fino al momento cruciale. Trucco della sceneggiatura: il regolamento di conti fra borghesi è reso ancora più piacevole dal fatto che il giustiziere è egli stesso un borghese un po’ pazzo, in rotta con la sua classe ma conser vandone tutto il savoir-faire. Cfr. Chabrol nell’ultimo Zucca, molto più ambiguo.
Merito di Sautet: quegli ambienti gli piacciono quanto basta per riuscire a restituire un po’ del mondo del lavoro (quadri, ecc.) c a suscitare, a partire da questo, un po’ di suspense. 96
Aspettando settembre. Non passa giorno senza che io, parlando del cinema, faccia il mio cinema. A chiunque, purché mi ascolti. Pubblico impietrito davanti alla mia rabbia sorda. Sono saturo di un oggetto informe che vomito al rallentatore. Il "mio" cinema. Quello in cui mi sono perduto di vista e che ha quasi trent’anni. Trovare il tono, il formato, il luogo. Dopo la passata euforia del quotidiano. Rinunciare alle pastoie del soliloquio, fare un libro. Osare leggere gli altri, verificare, rivedere. La vera difficoltà sta nella mia pigrizia: come uno che cammina sul fuoco puntando tutto su una sola carta: se stesso. Articoli veri. Rivista, ecc.
13/9 Sono riuscito anche a vivere il mio... (quale sarà la parola giusta?) con Frédéric al ritmo del mio cinema. Fino a suggerirgli le parole di cui aveva bisogno per sostenere il suo ruolo. Sceneggiatura, storia, mito. Perché sono rimasto così colpito da questo episodio durato un'intera estate? Perché questo ragazzo che "non è del mio genere”, una donnina, in fondo, a metà strada tra bondage e bovarismo, ha rappresentato tutto per me? Perché veniva da una storia e mi suscitava il desiderio fortissimo di non passare per i luoghi consueti. Ripartiamo da qui, mi dico da ieri (La Malibran, il suo primo bidone), ma senza di lui, è mai possibile, non soffro più. E perché ho creduto così fermamente che questa volta si trattasse davvero di una storia? Perché mi è venuto incontro, sul marciapiede della stazione di Valenza, e perché, seduti nella prima classe del TGV che ci riportava a Parigi, non mi sono neppure accorto che si stava innamorando di me. Non mi era mai accaduto prima. Ne sono uscito stranamente forte, poi debole. Innamorato: ho detto a tutti che lo ero. Innamorato dell’amore, come lui. Quando l'altro ha l'iniziativa, ecco che il mio tran tran quotidiano (why should I be so lucky?) sembra, per una volta, andare in cortocircuito. Jouhandeau dice da qualche parte che ogni argomentazione contraria alla quale mai avrebbe pensato, di colpo, gli sembrava incontestabile. L'altro esiste per ché il suo amore per me mi ha preceduto nel luogo in cui, una volta giunto, non potrò trattenerlo. Ed esiste solo nel momento in cui lui esce da se stesso ed io non sono ancora rientrato in me. È questa una storia. Di questo abbiamo parlato, consapevolmen te, troppo consapevolmente. Apriamoci a questo "noi” più forte della paura accumulata da due “io”. E poi più nulla. 97
Che cos’è una “storia”? Qualcosa che non finisce. Ti prende al collo, ci porta al guinzaglio lungo i marciapiedi delle strade, con tinua anche senza attori, altrove. Gli attori, da parte loro, ripeto no qualcosa, non la storia. Nel mondo del desiderio, gli attori dominano le sceneggiature, le fanno procedere di fronte ad ogni fatalità, predatore contro preda. Quel mondo del desiderio così ben reso da Guitry {La Malibran, visto senza di lui): un mondo tecnico in ogni sua parte. L’unico che conoscevo, ricavandone bolsi risultati a scapito, e senza pericolo, più di un ragazzo senza padre e con problemi sessuali. Stupidamente ho gioito nel dirmi: sono innamorato, è una cosa diversa, che può accadere anche a me, anch’io appartengo a questo mondo in cui si soffre. Ogni storia, allora, è forse una storia d'amore. Ogni sceneggiatura, forse, il compimento di una pulsione. La storia non si ripete, la sceneggiatura sì. La storia era già inziata prima che io scoprissi di esserne uno degli attori, come Sanders che credeva che Rossellini andasse a girare Viaggio in Italia con tutto predisposto. Proprio per questo entro nella parte con tanta naturalezza. Nel momento in cui recito ancora una volta il mio ruolo, non so che il pubbli co non dev’essere sedotto. Se dovessi sedurlo volontariamente, farei un errore dopo l’altro. Ogni storia è una storia d’amore, comprese quelle a cavallo tra l’individuale, il collettivo, il sacro. Una storia vera oscilla, prende al collo, è una zebratura su un tes suto, come La morte corre sul fiume. Una storia vera mi prende come si prende un bambino, perché solo un bambino sa ancora che cosa vuol dire venire dopo, dopo i grandi. I bambini amano le storie fissate nel corpo e nella voce dei grandi che gliele rac contano. Da bambino, mi piaceva quando mia madre raccontava a mia nonna il film che avevamo visto insieme. La ricollocavo là dove lei era: all’inizio, al livello “c’era una volta”. L’adulto sa che le cose si ripetono. Si ripetono perché hanno un punto zero e un punto omega, cosa tutt'altro che normale. Subire le loro evolu zioni con distaccata ironia, lasciandoci sempre meno le penne: saggezza e estinzione del fuoco della vita. Cinema attuale. Sono stato amato senza saperlo, ma lo faccio troppo sapere a colui che mi ama e che non ne può più. Così rifiuta la storia, riscopre i consueti scenari: impasse sessuate, "passe” spirituale, “è necessa rio che io vada, cocco”, non sono fedele, ecc. Ingrato fallimento.
Detto questo, ecco un modo — ancora un missile a tre stadi per fare un po’ d’ordine nella massa di idee che la visione di pochi film è sufficiente ad alimentare. Ci sono tre mondi: quello della 98
sceneggiatura, quello della scoria, quello del mito. La mia cinefi lia si è soddisfatta del secondo stadio del missile. Due situazioni mi piacciono: la cinepresa piazzata al centro del campo in attesa che i personaggi passino, come per caso, davanti a lei: Francesco giullare di Dio, L’intendente Sansho. Oppure: un luogo vuoto e un mago che dispiega un mondo di soldatini di piombo umani, popola lo spazio, abbozza delle leggi, dispone ogni cosa e se ne va: / clowns, Playtime - Tempo di divertimento. Ma, in tutti e due i casi, prima c’è qualcosa. Niente è già qualche cosa. Perché ho amato quel tipo di cinema? Perché all’idea di un cinema permanente si è aggiunta l’idea di una vita permanente, di uno sfondo sempre disponibile sul quale potevano sorgere le immagini. Perché que sto cinema è il più impegnato socialmente e mi permetteva di rendere al sociale ciò che gli era dovuto e a cui io avevo così poco accesso. Accompagnare il flusso del tempo, della vita, ma anche le contraddizioni nel loro divenire comune, prendersi dei tempo. Farla finita con ciò che non finisce mai, da cui le fini miracolose, gli interventi di forza, le lacrime finali. Condividere del tempo con dei personaggi che condividono l’immagine e il suo fuoricam po. Passare il tempo a vederlo passare.
Il primo stadio del missile è affascinante in modo diverso. Ma era già sfiorito all’epoca della mia scoperta del cinema. Franju che parla dei feuilletons di Feuillade è attraente, ma il nostro feuilleton personale era la filmografìa completa dell’autore, non l’elenco integrale delle avventure di questo o quell’eroe o attore. La sceneggiatura è uno stock di effetti potenziali, come l’attore. La sceneggiatura è un riassunto, come l’attore. Il grande attore del passato è la somma misteriosa di tutte le parti che avrebbe potuto e potrebbe interpretare. L’attore moderno, quello inventa to su misura dagli autori, non è che l’uso che di esso si fa e che lo esaurisce in una sola apparizione. La sceneggiatura è la parte maledetta di ciò che ha presa su tutto. È un diritto di prelazione che sta sempre dalla parte del potere.
Il vero eroe del cinema di sceneggiatura è il produttore. Anche se interviene nella realizzazione, è lui che produce le condizioni di riproducibilità del proprio lavoro. Non produce un film, ne pro duce in anticipo tutte le possibili varianti e continuazioni, produ ce il desiderio di tornare a vedere qualcosa di simile. I comici sono i più grandi perché non c’è niente di più immediatamente amabi le di un attore, del suo ritornare in altre sceneggiature che ce lo 99
restituiranno, ogni volta, identico. Anche il fatto di invecchiare, che lo modifica, non è che una sceneggiatura più vasta, fatale e comune a tutti, in cui egli resta lo stesso, solo invecchiato. Questo avevo colto in Hawks, puro regista della sceneggiatura. Produrre significa ri-produrre, significa realizzare una terza cosa a partire da due precedenti. La terza cosa, il film, che nasce da uno, il pro duttore, più uno, il pubblico. Ricordare il senso della rivendica zione godardiana, perversa perché proferita dall’alto dello statuto d’aurore in un momento in cui il produttore non sa più cosa far tornare, a causa dell’eccessiva “personalizzazione” del mercato. L’eroe del cinema basato sulla “storia” è il regista. Suo compi to è quello di far tornare la qualità di uno sguardo, il suo, qua lunque sia l’oggetto sul quale lo ha posato. E questo sguardo può essere visto solo da coloro che lo colgono nel tempo, nel momento in cui il regista stipula il contratto tra film e pubbli co. La regia è un accompagnamento spazio-tempotale, così come sostengono i mac-mahoniani teorizzando all'eccesso. Il loro erro re consiste nel sognare un mondo che si muove senza andare da nessuna parte, in un conservatorismo politico che gli fa odiare quei film che vanno “da qualche parte” con la sceneggiatura ma che non prendono il volo dal punto di vista della regia. Quando Morlet dice che Charlton Heston è un assioma non fa che teoriz zare il decollo verticale. È troppo presto per dire che si tratta di mito, di specie umana, di un modello superiore. Il termine mettenr en scène (regista) viene dal teatro: la scena, in un certo senso è quella del teatro, essa non si muove, è il quadrato di luce sul muro prima che qualche immagine vi sia proiettata, è il ripre sentarsi di questo quadrato, sempre identico a se stesso, sempre dello stesso formato. Il cinema non ha inventato la proiezione su schermi variabili.
L'eroe del cinema basato sul mito è il programmatore. Su questo, bisogna fare molta attenzione alle parole. La sceneggia tura è un movimento che avanza: dal modello verso le sue illu strazioni. Il mito è un movimento che indietreggia: dalle illu strazioni verso il modello. E il modello, giustamente, è un assioma del tipo: il film è il film, io sono io. Il programmatore può così anche essere chiamato ideatore, promotore, promauto re. Non sviluppa, declina: Sviluppare — accompagnare — decli nare: queste sarebbero le tre operazioni vagamente in successio ne del cinema. 100
In altre parole. C’è la serie, l’opera e il prototipo. La serie è un credito emesso sul conto del pubblico. E dura quanto lui, lo segue anche nel passaggio dalla sala al consumo televisivo. Il pro totipo non è fatto per essere seguito, ma per auto-generarsi come evento unico. Se fallisce non lo si ripete, e nemmeno se funziona. Kubrick deve essere stato il primo grande creatore di prototipi: non ripetersi, cambiare scile anche nello stesso film, lasciarsi desiderare. Tra la serie e il prototipo sta l’opera, benché il termi ne sia davvero roboante. In quanto inserita in una durata, nella faticosa scoria di vira e di lavoro di un uomo, sta dalla parte del prototipo. Perché si tratta di un uomo, origine mitica di tutti i film che la generano. Mito dell’autore. Ma in quanto opera for mata da più film diversi tra loro, sta anche dalla parte della serie e bisognerebbe parlarne con il linguaggio della musica classica: opus 1, 2, ecc.
14/9 Frédéric. Non mi sono più fatto vivo e ho trovato, sulla segreteria telefonica, due messaggi stupiti. Chiama questa mattina, con la sua voce squillante («sono io!»), e riesco tranquillamente a sorvo lare sul passato. Lo sento vicino, di nuovo. Ecco, questo è tipico della sceneggiatura: giocare coscientemente su risorse già note, quelle del "piacere che cresce quando l’effetto — l’FS’7 svanisce”. Mi dico che devo procedere con più spavalderia. L’eco suscitata dal pezzo di ieri (Per una àne-detuografìa) mi incoraggia. Non aspet tare nessun semaforo verde. Scrivere spingendo contemporanea mente su tutti Ì tasti. Assumersi. Ma assumersi che? L’idea di non avere per forza torto nel pensare che una cosa come IL CINEMA sia oggi all’ordine del giorno. E che il mio antropomorfismo (IL cine ma è qualcuno, UN film è anch’esso qualcuno) non è di mia sola competenza. Quelli intorno a me che mi parlano di cinema, mi Icariano meno dei film che hanno visto (ne sono regolarmente delu si) che del loro rapporto col cinema (ci vado, non ci vado più, non c'è mai niente, ecc). E più che mai, data la recrudescenza degli scip pi. Sempre il programma godardiano: mai il cinema è stato così presente nella testa delle persone e così fragile nei loro discorsi. Non ci fanno niente, ma ci tengono come a qualcosa di preistorico.
I lo trovato (mi ci sono voluti dei mesi) la risposta a Le grand blcu c ad altri film “brutti ma sintomatici”. Essa va presa per quel 101
che è. 1 veri buoni film da tempo hanno esplorato quel territorio che ora solo prodotti di massa possono occupare. Questi ultimi, da parte loro, portano con sé la questione e la riassorbono. La ren dono visibile, ma non ne vengono modificati.
Cinema d’autore, cinema di storie. Il mio unico desiderio è stato che questo cinema mi salvasse dall’altro, quello che mi fa paura, il cinema di sceneggiatura. Giocatore maldestro, da sem pre incapace di fare calcoli, con la paura di "contare”, ho subito riconosciuto in quel cinema il mio nemico. Ma c’era quello della Nouvelle vague e dei suoi maestri, che non hanno smesso di fug gire, di inventare del tempo in più, un tempo miracoloso di un po' di cinema in libertà. Lo sceneggiatore è un giocatore che fa previsioni sugli effetti cumulativi di ciò che mette in gioco. Io non sono tanto incline a godere masochisticamente di questo cumulo che riconduce sempre al punto di partenza e fa sì che si abbia vissuto senza vivere veramente, nella malinconica accesa del tomorrow is another day. Pocevo avere una scoria mia solo attraver so il cinema d’aucore, perché solo un aurore poceva parlarmi del mondo in cui ero naco nel 1944. Scoria incima e ricerca del padre ebreo che viveva attraverso la sua voce. La sceneggiacura è un gioco attivo. Con la scoria, invece, si è giocati. La sceneggiatura inventa attraverso combinazioni imprevedibili. La storia inventa dei modi di danzare. Danzare con l’aleatorio, l’imprevedibile, il dilettantismo del mondo, le nuvole, i volti... Nella storia si resta passivi, o si è cavie-vittima, ma solo in un primo tempo: più tardi, si sfoggia il talento deH’improwisazione, come nel jazz. I socio-critici hanno sempre inteso il "mito” come la produzio ne, soprattutto americana, di figure indistruttibili, da Zorro a Rambo. Ma queste figure tornano, si riproducono, diventano serie. Non sono quindi le nuove figure mitologiche del mio qua dro. Hanno a che vedere col carnevalesco, cioè con la fonte pri mordiale di salvezza di tutti i sottomessi che vivono la loro con dizione di sottomissione secondo una dialettica violenta dell'ako e del basso, dell’eroe che è talmente forte da diventare parodia. Non so se questo tipo di carnevalesco possa esistere nel cinema europeo. Credo di no. Il film di tipo mitologico (FTM) è costrui to piuttosto sull'idea di irripetibilità. Il film non "avanza”: si muove solo per rivelare la sua cifra di partenza, non è che un giro di parole per dire che non è necessario partire, dal momento che tutto è già dato. Il tema dell’“elezione” resta una prerogativa del 102
carnevalesco antico, ma questa volta riguarda chiunque. L’indivi dualismo ha operato la sua fusione con il mitico. Il tuffatore di la grand bleu non è una figura con cui identificarsi: non ha conti in sospeso col pubblico, né con altri, è interamente concentrato sul suo limite personale. Che è solo suo. L’imperatore della Cina è forse il bambino che anche noi siamo stati a quattro anni, ma è prima di tutto il solo personaggio del XX secolo che ha il diritto di chiamarsi imperatore della Cina. L'elezione è al tempo stesso riaffermata e svalutata: essa non implica altro eroismo se non quello di essere inchiodato per sempre a un’identità. Non crea più personaggi fuori dal comune o, se lo sono, non possono farci niente. Sono queste dunque le nuove mitologie dell’individuali smo attuale, non tragico, non eroico. Spielberg. L’individuo come limite vivente e non come atomo o emblema. Prima sono venuti star + folla, poi attore + attore, in questo caso eroe + cosmo.
Bisognerebbe considerare i due grandi film di successo del momento, quello di Étienne Chatiliez e quello di Coline Serreau (che non ho visto), dal punto di vista del loro tema. Se ho ben capito: una mancanza di funzione paterna, un anello difettoso nella filiazione, una difficoltà nel trasmettere le cose.
15/9 Ci vedremo domani. Verrà domattina con dei croissant... Mi chie do: sono in grado di interpretare la parte che tanto rimprovero agli altri: quella della santarellina pronta a dimenticare tutto, a non far l^esare niente, a non diventare la memoria vivente e mortale della coppia appena costituita, tenendo ben saldi i piedi (Ter terra? È solo un espediente (Ter ottenere da lui, per la seconda volta ma senza sorpresa, la meraviglia di un moto spontaneo verso di me. Una volta troppo presto, un’altra troppo tardi, è così che funziona? Un lieve disagio di fronte al nuovo Chabrol, Un affare di donne. Ecco un regista che appartiene alla categoria n. 1, quella della sce neggiatura a oltranza. Tradizionale, egli imbastisce più sceneggia ture incastrandole una dentro l’altra. O piuttosto colloca nello stesso film più tipi di ragioni di stato. Marie, che pratica aborti, ha una ragione di stato propria, brutale e ingiustificata quanto quella dello stato: ad essa subordina tutto. Alla fine, viene distrat tamente stritolata da una ragione di stato più grande, quella della giustizia pétainista. La ragione di stato mi sembra un buon punto 105
di approccio al cinema di Chabrol. Da incendere in tutti i sensi: “ragioni di uno stato” (descrizione sociale), “stato della ragione” (descrizione psichica),’aver ragione nel voler cambiare il proprio stato” (anarchia di base, contare sulle proprie forze). Chabrol è senza dubbio l’erede più rigoroso di Lang. L’inno cenza non esiste, quindi il meno colpevole è il più debole dei colpevoli e la più sproporzionata delle vittime. La vera colpa è quella di credersi innocenti. Per il resto (cfr. l’Hitchcock di La congiura degli innocenti), si può sempre condividere democratica mente la colpa con gli altri. Triste utopia del piccolo mondo riuscito intorno a Maria. I bambini sono, in ultima analisi, i più piccoli fra i colpevoli. Come in Lang (Il covo dei contrabbandieri) diventano il punto di arresto che ferma la deriva metafisica (tutti colpevoli). Ma solo perché non hanno ancora vissuto tanto, non perché sono degli angeli. Il film mi sembra un po’ accade mico, come tutti i film che fanno pesare sui destini individuali dei personaggi un'ombra più grande di loro. Si aspetta che l’ombra passi, il più lontano possibile, dal momento che il per sonaggio di Maria non è che il supporto di un eccesso di vuoto. È come un Verdoux assolutamente disarmato per affrontare il teatro sociale. Contemporaneamente, c'è qualcosa di atonale nel film che non è privo di nobiltà. Impossibilità di elevare il tono. Tutte le scene, molto pulite, sono costruite sull’idea di un pro getto ben saldo e di un costante disagio, sull’impossibilità di una pienezza, qualunque essa sia, sulla frustrazione riaffermata ad ogni dettaglio. La difficoltà di Chabrol deriva forse dalla sua incapacità di immaginare scene in cui i personaggi non siano solo boia (il ragazzino che vuol diventare boia perché mascherato) o vittime — e dal fatto che in entrambi i casi vi sia comunque un eccesso.
16/9 Verrà, porterà dei croissant? Presto la risposta.
Come collegare tutta questa riflessione sull'individualismo moderno con lo stato delle cose nel cinema? Non siamo sempli cemente passati da un mito all'altro? Il cinema aveva bisogno di eroi e questi eroi obbedivano a una logica da eroi (auto-genera zione, auto-legittimazione, ecc.). La nascita di un eroe (di un sole, diceva Jean Douchet) era uno dei soggetti dei film. L'eroe faceva da ponte tra collettivo e individuale, tra presente e futuro. 101
L’individuo non è l’eroe, ma neppure la persona. Eroe/Persona/Individuo: un altro modo di raccontare, sempre in tre stadi, la storia del cinema. La persona era multipla, popolata, mobile. Questo "personalismo” del cinema moderno rimanda al suo lato cristiano. L’individuo ha una sua consistenza, diversa da quella dell’eroe. L’eroe è emblematico ed esemplare, l’individuo no (è piuttosto un modello singolare). Nello stesso tempo, eroe e individuo hanno un elemento in comune: entrambi sono sempre — già — costituiti, mentre la persona (o il soggetto) è sempre in via di costituzione. Dall’eroe all’individuo passando per la crisi del soggetto: era questo il programma “umanista” del cinema (Hawks o Ford). Occorreva arrivare all’individuazione. Ma la si è raggiunta da così tanto tempo che ormai si sente il bisogno di farvi ritorno e mitologicamente. Date queste condizioni, Le granii bleu e L’ultimo imperatore non sono forse degli pseudo-racconti non dell’eroe come individuo ma dell'individuo come eroe, cioè avendo dei conti da rendere alla questione del soggetto (desiderio e morte, alleanza e filiazio ne) e dovendo costituire uno spettacolo? E questo spettacolo non ci riporta molto indietro, al tema dell’elezione? Io sono io/Perché io? Vedo già profilarsi il dibattito sul film di Scorsese, sul profetismo e sulla doppia natura di Cristo, eroe e individuo. Ma occorre che la chiusura dell’individuo su di sé sia legittimata da un’operazione mitologica che abbia avuto luogo a monte e riguardante la tautologia stessa. Il campione del mondo di immersione in apnea e l’imperatore della Cina hanno questo in comune: occupano un posto unico, dove c’è posto |ier una sola persona. Potrebbero essere degli eroi, ma tutto il lavoro del film consiste nel mostrare che loro non decidono niente e si accontentano di occupare quel posto. La vec chia miniera d’oro di Rio Lobo\ Eroi senza eroismo perché l'eroi smo non dipende da loro ma dalla loro definizione mitica: a metà strada tra gli uomini e le bestie, tra gli uomini e gli dei. L’individuo è generato da un limite che vale solo per lui, una sorta di linea di frontiera presso cui monta la guardia. Da qui, l’infinita pazienza, la buona volontà, la pigrizia che lo caratteriz zano. Non è possibile alcun proselitismo, perché ciò che vale per uno non vale per l’altro. Non c’è bisogno di comprendere la Storia o la storia, l’altro-donna o uomo. A che cosa assomigliano gli spettacoli della mitologia del l’individuo? A grandi campagne pubblicitarie, tanto la pub blicità rappresenta l’esorcismo del tempo e del degrado. Così si 105
spiegherebbe l’estetica di questi film, l’uso dello storyboard come in Spielberg & Co. Un pubblico molto numeroso può assistere alla passione priva ta di uno o due individui eccezionali che non sono più eroi per ché non hanno conservato nulla di prometeico. Ma questa “pas sione” è subita, come nella letteratura rosa sui re e le regine rivi sitata da Frédéric Mitterrand. Del resto, questo pubblico delle classi medie ha imparato a consumare ciò che lo conferma come individuo, a scegliere à la carte. Dice Musil da qualche parte: «l’individualismo non ha prodot to molti individui». Produce piuttosto delle singolarità alla ricerca di un corpo portante. È/non è affar mio/tuo/suo, potrebbe essere la definizione di queste singolarità. Nel cinema americano di Spielberg persiste una dimensione biblica di “elezione”. L’individuo emerge per il fatto che è stato scelto (dai piccoli uomini verdi). L’Europa crede meno a questo genere di cose. Ipotesi sull’immagine. Essa non è più un sentiero con un tempo per percorrerlo, una esperienza che contiene in sé la promessa di altre esperienze, essa ritornerà ad essere ciò che forse era tanto tempo fa: un segnale, un richiamo mnemotecnico, un blasone. I progressi della comu nicazione interattiva fanno sì che una trasmissione televisiva possa prolungarsi in tempo reale grazie a un dialogo in Minitei (esempio della messa e della predica). In queste condizioni diven ta strano pretendere che questa trasmissione sia la più giusta e la più "vera" possibile, dal momento che essa non è che l’anello di una catena di servizi, catena in cui l'immagine è forse il supporto più aleatorio e meno sicuro. La parola scritta l’avrà dunque vinta, ma sarà una parola codificata, semplificata, impoverita. La creazione di format di immagini sarà il grande affare della televisione; al suo confronto il cinema più strutturato del mondo — quello americano — sembrerà sfrenatamente libero. La riduzione dell’immagine al suo ruolo di invito o di richiamo ricorda le immaginetee sacre di un tempo. L’immagine “cammi no-verso” può sempre tornare ad essere l’immagine “ostacoloverso”. Credo che Umberto Eco dica più o meno le stesse cose. È in gamba. Non credo che verrà. Non ne soffro poi tanto. 106
17/9 Non è venuto, scusandosi tardi, con frasi del tipo “perché fìnge re?”. Venerdì notte, difficoltà a singhiozzare (il poeta di Gertrude lasciar fluire le lacrime e lasciar scorrere l’occhio sulla televisione senza audio nel momento in cui nella radiosa Seul, alle 10 di mattina ricominciano le gare dei giochi olimpici. Film souvenir sulle olimpiadi di Los Angeles. Sono già passaci quattro anni. Le sconfìtte di Mary Decker, Mary Lou Retton, Michael Gross, Edwin Moses, Joaquin Cruz e compagnia bella. Comunque, saba to pomeriggio lo richiamo (faccio male). Lunedì lo mostrerò a Frangoise H. e a Christian Lacroix?
CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT (ZemeckisSpielberg). Film abbastanza riuscito, molto simpatico, infarcito di idee e di energia, appassionante per la materia grigia che spri giona. Idea per un possibile articolo, di genere alto, sul tema della sofferenza (fìsica) vista da Spielberg e Scorsese, questi due poli americani (amici, del resto). Idea di partenza. I cartoni animati fìno ad oggi si caratterizza vano per l'assenza di una cosa fondamentale: la sofferenza fisica. È certamente questo il motivo per cui, bazinianamente, non li ho mai tanto amati. L'idea che a una creatura di fantasia (disegnata ma non registrata) possano accadere solo avventure di fantasia (gratuite) mi ha tenuto lontano dal disegno animato. L’impossi bilità di identificarsi fisicamente con queste creature (i toons) suscita nella migliore delle ipotesi il riso, prodotto dallo stupore, dall’idea folle e tuttavia possibile. I toons hanno un corpo che è anche la loro anima. Se per anima intendiamo una continuità trascendentale (fedeltà a se stessi?), nei cartoni animati è il corpo che gioca questo ruolo (mancanza del volto, da sempre sede privilegiata dell’anima per gli attori in carne ed ossa), un corpo che si fa materia in modo intermittente. Tutto ciò che distruggerebbe un corpo umano non ha effetto sul corpo del toon, che non smette di ri-formarsi. Nato dall’arbitrio e non da una co-produzione fra desiderio e realtà, il toon si basa suH'automaton e non sulla tyché. Il film di Spielberg e Zemeckis introduce un elemento essen ziale: i toons di Roger Rabbit non sono più gli stessi di sempre. Sono certamente indistruttibili e deformabili all’infinito (il film nel film della prima scena), ma la loro protezione non è più asso luta: uno di loro — travestito da umano — ha scoperto un intru107
gl io (la salamoia) che può distruggere i toons, spaventarli, tortu rarli, farli soffrire. In questo senso si può dire che i toons hanno fatto un passo in avanti verso gli umani, mentre gli umani, loro, hanno fatto un passo verso gii inumani. Come compatire la sofferenza di un disegno animato? Domanda nuova che non prende allo stomaco, ma alle meningi. Questo passaggio può essere letto in vari modi. Vediamone qualcuno, a caso. 1. La vecchia passione spielbeghiana esclusione-inclusione. I toons sono creazioni umane, ma vivono nel loro mondo, come dei giocattoli. Il loro mondo si è emancipato. Cartoonia è un ghetto e come tale è filmato. Facile dunque vedervi tutti i ghetti americani: ebrei, neri. Le possibilità sono tre: inclusione pura e semplice, esclusione pura e semplice, inclusione-esclu sione. La prima è impossibile, la seconda è fascista, la terza “umanista”. Consiste nel mostrare la separazione, nel procedere verso l’inclusione ma senza andare fino in fondo. Occorre che il grande tutto (società, specie umana) approfitti della frontiera divenuta interna tra lui e la parte reintegrata. Questa frontiera (una cicatrice) deve diventare un valore del “tutto”, e non fon dersi con esso. In questo caso, si tratta tanto dei valori dioni siaci (canto, danza, movimento) propri del jazz nero quanto dei valori dello humour nero, da circo masochista, propri dei ghet ti ebrei. In questo senso, Spielberg, dopo Woody Allen, Jerry Lewis e Chaplin, si colloca risolutamente dalla parte di coloro che inclu dono nella commedia umana la coesistenza di un clown e del peggio. Fantasma del clown che fa morir dal ridere nei campi di sterminio dove, comunque, si muore per davvero. Ma con alcune differenze. Spielberg non ha mai conosciuto — verificare — alcun ghetto ebreo e il suo modo di rapportarvisi passa attraverso una vera e propria lista di attesa di altre minoranze. La piò paradossa le, apparentemente, è quella dei toons della sua infanzia. Se si prende sul serio la frase di J.L.G. secondo cui il cinema è come un paese in più nella carta geografica del mondo, possiamo dire che questo paese è “di troppo", “in più”, spiato dal ghetto. Comprendiamo così come, al limite, ci possa essere concorrenza tra il cinema e quell’altra terra “in più” che è Israele. Se la popo lazione dei film è diventata un grande ghetto, allora la mia idea di cine-demografia funziona. Che cosa farne di loro, oggi? Che cosa gli dobbiamo? Dobbiamo salvarli dai loro demoni e, così 108
facendo, salvare noi stessi, che è poi, a grandi linee, l’avventura di Bob Hoskins nel film. Quali demoni? Se l’uomo è scivolato verso la disumanità fredda e vuota, il “toon" scivola verso una forma di umanità antica, quella che produceva anche sogni di fascismo. “Il sonno della ragione genera mostri”, mai come adesso. Il mostro, in questo caso, è colui che ha voluto barare con la legge fonda mentale dello spettacolo: il toon travestito da umano che ritor na toon e che deve essere distrutto due volte: come umano (schiacciato da un rullo compressore) e come toon (gettato nella salamoia). Non bisogna travestirsi da umano o da toon, bisogna condivide re — umani o toon — lo stesso desiderio: far ridere. Da un lato per ché le donne amano chi le fa ridere. Dall’altro, perché ci si può sbarazzare del nemico “facendolo morire dal ridere". Lezione che Hoskins, figlio d'arte, riscopre. Si tratta di un riavvicinamento: i toons hanno sperimentato la sofferenza umana, gli umani devono sperimentare la spensieratezza dei toon. Tutto questo accade nel momento in cui il corpo umano ha finito di servire da misura a tutto il resto, rendendo così più libe ra la rappresentazione. Una cosa è certa: si tende ad una maggio re velocità e i personaggi più negativi sono quelli che mirano alla ieraticità. Allo stesso modo, bisogna combinarne di tutti i colori, per essere sicuri di averne combinate abbastanza. E il parallelismo con Scorsese? Eccolo. Spielberg non cessa di muoversi lungo una cicatrice, rappresentata dall’essere uno in meno, quello che manca dalla lista, assente, dimenticato, ecc. Il suo problema non è l’individuo in sé, ma il movimento venuto dall’esterno che lo salva, lo sceglie, lo integra. Scorsese è esatta mente l’altra fàccia della stessa medaglia: ciò che lo affascina è l’essere in più, per eccesso, quello che oltrepassa la lista e che si rischia di non dimenticare mai. «Perché non io?» è la domanda democratica, semplice e piccolo-borghese di Spielberg. «Perché io?» è la domanda elitaria, religiosa, profetica di Scorsese, amante dei campioni. Quali le conseguenze a livello di sofferenza fìsica? Bisogna cer care. Scorsese senza dubbio ha fatto del suo Cristo un maso-bondage crocifìsso iperrealisticamente. Verificare. Da buon cattolico, egli fa della sofferenza un indice di verità, mentre per Spielberg la sofferenza rinvia solamente alla realtà. Più individualista, Scorsese lavora meno di Spielberg all'identità americana. Quest’ultimo procede per spartizione, e non, come Scorsese, per accumulo. 109
Domanda generale: perché gli americani? Essi, molto più degli europei, accompagnano il corpo umano nelle sue metamorfosi a livello di rappresentazione. Proprio per questo compongono la messa in scena a partire da queste metamorfosi, e non il contra rio. Hanno dei mostri veri, da filmare in modi diversi, se possibi le. Gli europei, invece, hanno erotizzato 1'inquadratura, il campo, più che il corpo. Da qui deriva il loro primato "morale” e il loro ritardo "mitologico”. Gag: il dibattito teologico sul film di Scorsese riguarda, a mio avviso, la doppia natura di Cristo. Sarebbe divertente metterlo in rapporto con quello relativo al film di Spielberg: sulla doppia natura dell’uomo (umano-ftwz). Forse era necessario che una tate sfaldatura apparisse perché, correlativamente, apparisse il tema della sofferenza: lacerazione uomo-dio, uomo-ftw.
22/9 SCORSESE. Film fastidioso. Impossibile vedervi altro che un ulteriore passaggio della serie: “difficoltà narrative dell'indivi dualismo avanzato”. Sotto l’apparenza di restaurare, al di sopra delle Chiese, il dialogo uomo/Dio, qui si tratta di illustrare l'isteria padre/figlio. È sorprendente come questo Cristo sia sempre-già-prelevato dal sociale e alle prese con un solo enig ma: ho un ruolo? sono proprio io? che cosa devo fare? Più vici no caso mai al problema detrattore (actor’s studio) desideroso di entrare in una parte che impara a conoscere solo a poco a poco. La tentazione, infatti, è quella di tentare altri possibili ruoli, anche in extremis, anche sulla croce. Recitarli tutti (non lasciare niente agli altri). L’egoismo del drogato: ecco il vero soggetto del film. Ci si può drogare di trascendenza. Cristo antipatico, combattuto fra la voglia di non comunicare niente e quella di avere almeno un con fidente che lo capisca (Giuda). Un film incredibilmente poco religioso, in cui gli unici esseri da "ricongiungere” sono il padre e il figlio, sullo sfondo decorativo degli altri, ebrei (interpretati da attori arabi) e romani (interpretati da attori americani). Dio padre, un elemento in più nella crisi della sceneggiatura. Le commedie di Scorsese (Re per una notte, Fuori orario) parlavano meglio della temporalità paradossale della “Riga in avanti”. In Fuori orario, quello che funziona di più è la struttura vuota. Non so dove vado (tutto mi sfugge) ma il solo fatto di essermi messo in cammino (in moto) non può che produrre senso. È il mettersi ilo
in cammino l’indice di verità, non il percorso o il punto d’arrivo. In generale, i film di Scorsese partono forte e finiscono un po’ a caso (finale aperto, vera conclusione, finale edificante). Il vero problema è come guadagnare tempo. Ma questo tempo non è più un flusso (un bagno in cui si galleggia insieme agli altri), è una serie di momenti-segni individuali che fanno apparire il resto del mondo (gli altri) come una scenografia costituita da bizzarre individualità. Bizzarre (o inquietanti) perché non collocate in una temporalità, foss’anche la loro. In questo senso Hitchcock, Tati o Fellini hanno aperto la strada a questo individualismo inteso come la storia di ciò che può accadere solo a una coscienza. Ma giustamente, non si tratta più di una “storia", bensì di una serie di sceneggiature possibili, di possibili biforcazioni. La bifor cazione è forse il vero soggetto dei film di Scorsese. Ma ciò che funziona nella commedia non funziona nei film di argomento serio. L’ultima tentazione ili Cristo è il braccio di ferro tra una storia e una sceneggiatura. La storia è basata sulla religio ne: storia di un uomo che fa la storia di altri uomini. La sceneg giatura poggia sulla credenza: credenza di un uomo nel suo ruolo e del suo ruolo come destino. Credenza di cui, fino alla fine (Fuori orario), egli non è certo. Lo spettatore è messo di fronte a un triplo film. La prima parte e la terza, se vogliamo, sono le più problematiche. Invece di partire a tutta velocità, Scorsese inizia in surplace. Languide esitazioni del falegname («sono proprio io?») e conclusione su un rimorso che è la tentazione stessa («era proprio questo il mio ruolo?»). Idea che un errore di casting, sempre possibile, avrebbe potuto rendere comica (poesia di Ponge). La seconda parte è la più brillante perché Scorsese può tanto meglio dedi carsi alla sua arte della fuga in avanti quanto più la storia è già nota a tutti. Ma questa brillantezza è un fuoco d’artificio inuti le e diseguale. Solita solfa: il film è più vicino a Le grand bleu di quanto non si creda. Un Padre lo si può cercare ovunque, in cielo o in fondo al mare. La trascendenza come droga, dal momento in cui l’imma nenza è perduta. Perduta per il cinema che non riesce più a ri unire dei corpi diversi in una sincronia e che ne segue solo uno in una diacronia essenziale. Questione sussidiaria: il Cristo è un buon personaggio per un film? Non va dimenticato che esso non smette di respingere i termini nei quali lo si vuole rinchiudere. Esasperato, trova delle formule, sostituisce il dialogo con la parabola, parla figurato, è ili
un po’ snob (figlio di papà). Poco simpatico. In questo senso, il film è fedele. F. da Fran^oise H. Più gente del previsto (Christian Lacroix, ecc.)? "Prima" segreta di “siamo in libera uscita”. «Comme un gar^on, j’ai les cheveux longs...»1”. Sulla mia segreteria. Viene da me, sorride, si lascia abbracciare a lungo. Non dico niente sui miei stati d’animo e sul passato. Vorrei tanto che fosse lui a par larne. Bovarismo. «Ti ho sognato, finalmente vivevamo più o meno insieme ma tu eri nella posizione di M. e io ero innamorato di Vecchiali, da cui aspettavo un figlio». Donnicciola, non ci sono abituato. Domani, Mosca.
11/10 CINEMA E PUBBLICITÀ. È una buona traccia ed ecco come potremmo raccontarne la storia. Il cinema "moderno” avrebbe rotto col modo di raccontare le storie del cinema classico (grandi studios, propaganda diversificata), vendendo sia mercanzie che modi di vita. Dal canto suo, la pubblicità si sarebbe automatizzata e riorganizzata. Per definizione, un “autore” si interpone tra i pro pri “oggetti” e il loro valore commerciale. Negli anni Settanta, rab biosamente Godard (Tutto va bene, crepa padane) o Ferreri (La grande abbuffata) dirottano alcuni celebri attori dalla loro immagine e gli fanno compiere un breve percorso a lato di essa. Ma, negli anni Ottanta, questa storia è essenzialmente chiusa e il film pubblicita rio è diventato esso stesso un genere, una retorica e un modo per campare. Ancora una volta, nel cuore degli anni Sessanta, incon triamo Godard, intento a scontrarsi brutalmente con la pubblicità (Due o tre cose che so di lei, i manifesti, i sedicenti collages) e col cine ma. In quel momento, forse, con un ultimo sussulto moralista, gli autori integrano e tengono a distanza la pubblicità. Ma ne vedono quasi esclusivamente l’aspetto commerciale e assai poco quello estetico. Questa estetica si sviluppa da sola e alla fine degli anni Ottanta la si ritrova sempre — già — assimilata da registi trentenni. Una volta terminata la parentesi (morale) del cinema moderno, il cinema (o ciò che ne rimane) riscopre una questione di fondo.* da dove vengono i corpi da sogno? Come se gli uomini e le donne (e i bambini) degli spot, una volta sganciati dal sociale e liberati delle storie comuni, fluttuassero in un etere senza storia e fosse necessario, essendone gli eredi, inventar loro una genesi, un mito, un’origine. Sarebbe questo il senso del sub di Legrand bleu, 112
gran bel ragazzo incapace di condividere una scoria con chicches sia e perciò bisognoso di trovare un mito-programma che lo distingua dai delfini. Al cinema, dunque, non rimarrebbe che andare avanti senza questa soluzione, mantenendo ad ogni costo un tessuto bucato e lacunoso, quello delle storie in cortocircuito, delle star problema tiche, del tempo “inventato". Il cinema deriverebbe la sua attuale serietà solo dal fatto di considerare l’individualismo come un enigma e non come un prodotto. Moretti, Stévenin, Alien, Scorsese, Rohmer e ultimamente Dupeyron offrirebbero informa zioni frammentarie su un mondo de-solidarizzato. Bisognerebbe chiamare "spettacoli audiovisivi” quei film che collocano altrove il loro oggetto e trattano, anch’essi, l’individua lismo non come una questione aperta ma come un ideale già incarnato (dalla pubblicità, giustamente, ma anche dal crescendo del turismo, della carità, della tossicodipendenza). Sarebbero l’equivalente attuale dello spettacolo incantato di un mondo con senziente e ideologicamente dominante, quello dei film accade mici del passato. Solo che alla società, al gruppo o alla nazione, bisognerebbe sostituire l’individuo solo. È anche il senso dell’ultimo Scorsese che, al di là dell’arianesimo proposto, si interessa solo al dialogo Dio-padre / Dio-figlio e non a quello Gesù-uomini. Mistica del padre come droga (importanza del padre assente in molti film attuali). L'epoca in cui si sono ricostituiti dei corpi da sogno per vende re prodotti è stata forse una semplice transizione. I prodotti ser vivano da scusa facile e triviale, ma il problema era piuttosto quello di procedere al salvataggio figurativo del mondo, laddove il cinema d’autore delle figure non sapeva più che farsene. Di colpo, è possibile calcolare le implicazioni di tutto questo. Perché questo mondo figurativo incantato è allo stesso tempo (questa è la sua forza) continuo e molto povero di legami e di capacità di integrazione. Si riesce a legare l’uomo, la donna, i loro corpi pubblicitari, qualche elemento naturale (l’acqua, ecc.) ma niente di più. Con frammenti simili non si può ancora raccontare niente, ma Le grand bleti dimostra che si è molto vicini a farlo. La scelta è tra un mondo continuo molto povero e un mondo discontinuo molto ricco. La povertà è quella di ciò che ha termine, la ricchezza quella di un tempo ancora “inventabile”, con dei buchi di reale, velocità diverse, rischi. Proseguire questa lista degli elementi di base del mondo pubblicitario. 113
10/11 Finita l'influenza, finita la storia Frédéric, finito l'appuntamento mancato di Cartagena e la maratona da giurato. Tirando le fila, che cosa accade ora?
L'idea che siamo entrati nell’era del dopo-crisi (o fine) del cine ma, che il peggio è passato, che il paesaggio si è stabilizzato, che solo quelli destinati comunque a scomparire (o a cambiare mestiere) prenderanno ancora qualche colpo ma che i più coriacei - grossi predatori o piccole macchine da guerra — hanno recupe rato le loro energie. Descrizione di un paesaggio da “dopo la bat taglia”, resa ancora più credibile dal successo incontrastato di un film come Lorso (non ancora visto) che prolunga le ipotesi di Le grand bleu. C’è un lato Enfants et les sortilèges19 in tutto ciò. Gli zimbelli del nostro universo pubblicitario si risvegliano e preten dono delle storie “a titolo personale”. Una umanità sognata dagli spot esige di essere celebrata mitologicamente. Laddove l’inventabile ha ancora la meglio sul programmabile, il cinema esiste ancora.
La programmazione è cambiata, certo. Oggi, nessun leone della MGM ruggisce più il suo «presents», nessun prodotto cinemato grafico serve più a pubblicizzare indirettamente una qualsiasi casa madre (se non nel caso di Spielberg, forse). Ogni prodotto dunque nasce contemporaneamente star e orfano, e nasce più dall’organizzazione che si occupa del confezionamento che dal capriccio demiurgico di un "autore”. Al prodotto capita la stessa cosa che capita a ciò che nei prodotto è raccontato: esso si autogenera per pura tautologia. Il prodotto-film non fa che legittima re gli altri, la sua verità non appartiene all’ordine della critica, ma a quello della verifica. È necessario che il prodotto finito giu stifichi la credenza in una leggenda di cui esso sarebbe, alla fin fine, solo un’intuizione. La vera storia dell’Orro sono, ben inteso, i quattro anni di riprese e di addestramento degli animali. Non aver fatto parte dell’équipe del film diventa allora altrettanto umiliante che passare una settimana a Hammamet quando altri fanno un mese di trekking in Nepal. Spesso mi viene in mente quanto avevo letto sulla moda in Giappone. I grandi magazzini, di comune accordo, stabiliscono le "stagioni” e i colori. Può capitare allora che un’ondata di verde, 114
per esempio, invada dolcemente tutti i prodotti in vendita a Tokyo, trasformando l’impatto visivo della città. Perché no? Il cinema non dà forse il la a grandi ondate decorative a base di significanti semplici (l’orso), offerti alla società intera come moti vo sul quale ricamare a suo piacimento (a condizione che i promo tori dell’idea ne percepiscano i diritti)? Il cinema come decorazio ne sociale, perché no? Si getta sul mercato un significante sempli ce (con una connotazione mitologica) e si incitano tutti quanti a farlo proprio. E questo non riguarda più solo gli appassionati di cinema, la sala diventa semplicemente il miglior veicolo pubblici tario per vendere tutta una serie di oggetti personalizzati.
Di colpo, l’impressione (rafforzata daH'unanimità fàcilmente raggiunta nella giuria di Cartagena: i buoni film sono rimasti a galla senza problemi) che non esista più nessuna battaglia da condurre per distinguere il buon cinema da quello cattivo, per ché una distinzione che un tempo provocò guerre — quella tra cinema e non-cinema - è ormai data per acquisita e non pone più alcun problema. C’è cinema là dove c'è incontro (viaggio, trip, esperienza), c’è audiovisivo là dove c’è programma (turismo chia vi in mano).
13/11 Folle intere possono andare a vedere le avventure di uno solo: ecco che cosa è cambiato (trionfo dell’individualismo). Ma, attra verso la pubblicità, questa solitudine è stata preparata a lungo e con cura per molti anni. La pubblicità ha finito così col produrre il sub di Le grand bleu e anche il bisogno di un racconto di cui egli sia protagonista. Un racconto difficile che si pone fin dall'inizio come rifiuto di tutti i racconti classici: il protagonista non fa che dire gentilmente, a tutti, non mettetemi in nessuna storia vostra (una donna lo ama nonostante tutto, un compagno d’infanzia gioca con lui a fare sfoggio di virilità) perché io ho già la mia, che mi basta e avanza. Ora, la sua storia è solo quella dell’immersione. Come se le storie che si potevano offrire ai cuginetti di pubblicità del sommozzatore fossero già difficili da immaginare. Il corpo pubblicitario è, nel suo attuale statuto, ina datto a qualsiasi connessione umana (inarticolabile attraverso il sesso o la morte) e tuttavia ha bisogno di trovare una storia, quel la della sua auto-legittimazione, della teoria che lo giustifichi. Siamo a questo punto e, in questo senso, Legrand bleu non è criti 115
cabile allo scesso modo di La mìa Africa. Mentre la pubblicità è lo sfondo di tutte le scene del film di Pollack, essa preesiste a quelle di Besson. Non è più l’estremità “clandestina” della scena, ma è addirittura nei suoi cromosomi. In questo senso, i film di questo genere non raccolgono tanto l’eredità della storia del cinema in quanto forma (quella di cui si occupa attualmente J.L.G.) quanto quella della sala cinematografi ca che è certamente parte di questa scoria ma non si riduce ad essa. Se occorre salvare la sala bisogna collocarvi i soli eroi da sogno che abbiamo, quelli che bascano a se scessi e alla contemplazione narcisistica. Immaginare la difficoltà di questo tipo di cinema: esso deve trovare l’interfaccia tra l’individualismo come atomizzazione di base e la radice mitica dei racconti, senza passa re per le folle e i loro eroi.
17/11 L’ORSO (finalmente). Film in definitiva abbastanza insignifican te. Senza dubbio molto complicato da realizzare ma privo di qualsiasi ambizione (molto facile da pensare). Senza neppure interpretarlo, chiedersi: «almeno funziona?». Non ne sono sicu ro. Avere il coraggio di ricordare cose semplici: il punto in comune tra l'uomo e l’orso (entrambi mammiferi) è troppo pove ro e non può che condurre a sceneggiature estenuanti (amore filiale, cibo, baci, paura, memoria e vendetta). Tanto che adde strare queste povere bestie a mimare davanti alla cinepresa questi sentimenti-istinti di base non fa che rimandare all’eccellente lavoro di addestramento degli animali. Film totalmente antropomorfo (checché ne dica quell’imbecille di Annaud), che inciampa sulle vecchie aporie baziniane. È la stessa operazione della Guerra del fuoco: si truccano accuratamente (tutto il lavoro si esaurisce lì) degli “esseri" (pre-uomini, pseudo uomini, (Tara-uomini) e li si immerge in sceneggiature e messe in scene specificatamente “umane". L’antropomorfismo è quello dei film intesi come gabbia umana in cui esseri truccati/travestiti recitano il ruolo dell'^/rra. Dibattito altrettanto vecchio (per me) di quello sulla pre-naturalizzazione dell’altro.
Ciò che è cambiato è che l’estetica pubblicitaria ha ormai smes so di fare la distinzione tra gli altri possibili e gli altri impossibi li. Fra gli altri possibili: i giocattoli degli uomini a condizione 116
che siano individualizzabili. Tra questi giochi: gli animali. Veri o a disegni animati.
L’antropomorfismo è una perversione. Una denegazione di massa (so bene/ tuttavia). Quello che non mi piace è, sia chiaro, la via di mezzo adottata da Annaud: egli lascia il suo pubblico “libero” di vedere la bestia come bestia o come pelle di bestia, a scelta. Che è poi un metodo, statistico, per trar profitto da entrambi gli scenari, lasciando il pubblico in bilico tra i momen ti in cui l’orso assomiglia all’uomo o quelli in cui è ridotto alla sua “orsità”. Trionfo deH’immaginario lassista e furbo, immagi nario da domatore. Il mio antropomorfismo è perverso. La denegazione vi è vissuta a partire dai poli, non come un ibrido tra i due. Qualche volta la bestia è altro ed è quindi impossibile umanizzarla. Qualche volta è al [tosto di un altro ed è questa funzione di “al posto di" ad uma nizzarla per forza. In Rossellini (India), il vero scandalo (i poli disgiunti) è costituito dal fatto che una scimmia fa la trapezista sotto lo sguardo di una bertuccia. Per mettere in scena gli sguardi, però, bisogna essere registi, non domatori. Per questo il montag gio tra l’orso che fa le coccole mentre gli adulti fanno l’amore è scandaloso.
Due momenti abbastanza belli nel film di Annaud. L’orso che si slega, di notte, beve il latte, fa il pazzo e sveglia le altre bestie, in particolare uno dei cani stravolti e feriti che si solleva, inquie to, si riaddormenta, si sveglia di nuovo e protesta. Perché? Questo cane ha una traiettoria narrativa (quasi una storia), il suo gesto è molto vicino ad un gesto umano (facile da interpretare); in quel luogo ci sono diverse specie animali (anche dei cavalli) e - come dice Bazin — la possibilità di farne apparire tra loro una più umana delle altre. L’interessante è che il cane, più familiare, è al posto dell’altro “altro”, perché l’orso, meno conosciuto, è l’altro per definizione. Cortocircuito che, stranamente, ci fa vede re il cane nella sua “canità”.
Individualizzare un animale. Dipende dalla sceneggiatura o dalla regia? L’altra scena buona nel film di Annaud è quella del puma, per ragioni simili: bellezza fredda del puma inespressivo, intelligenza delle velocità, delle corse e della trappola. Regia. È la regia, dunque, che fa emergere questo animale? Come il rituale 117
della corrida serve ad esaltare le personalità del toro e del torero? Vero problema. Solo raramente la regia individualizza l'animale. Che resta l’emblema della specie, emblema costretto nella gabbia umana del film. E nello stesso tempo, se la mia teoria è giusta, questo film lavora non in direzione della coppia specie/individuo, ma alla genesi mitologica ‘dell’individuo. Ora è vero che rispetto a Le grand bleu il film è del tutto coerente. Uscita di scena la madre, non rimane che il rapporto amoroso col padre. L’orso-eroe del film di Annaud, sembra essere un maschio: non si tratta quindi di istinto materno. Allo stesso modo, il trauma dell’eroe di Besson è l’annegamento del padre.
L’individuo non è l’eroe (auto-generato), né il soggetto (nato da una donna). Potremmo dire che ha a che vedere con la funzionepadre (padre adottivo). Approfondire questo punto. Un’altra cosa: (’alleanza tra uomo e bestia. Data in Besson, guadagnata in Annaud (la scena «pietà!» è comunque molto bella). L’uomo non si definisce più in quanto predatore ma in quanto individuo che rispetta un altro individuo. L’individuo non è necessariamente un essere umano (del resto, la parola indi viduo è usata anche in etologia). Pubblicità: viene in conseguenza di questo: il cinema "a misura d'uomo” non ha più senso (la cosa è davvero buffa, perché il suo inventore, Hawks, si è sempre interessato agli animali) ed è pos sibile filmare a qualsiasi misura, non per inserire le misure all’intemo di un mondo fisicamente omogeneo, ma per far emer gere gli oggetti-individuo all'interno di un mondo mentalmente omogeneo (filmare a misura di rana, di ape, di pesce, di palla di fucile). Scomparsa di un qualunque sentimento della natura, malgrado la bellezza del paesaggio. I sogni dell'orsacchiotto. Ridicolo e moralmente inqualificabi le. Detto questo: ciò che eleva il giocattolo a un grado di uma nità è che da oggetto-sogno diventa oggetto sognante. L'unico bel film che mi piacerebbe vedere sarebbe quello in cui la funzione "come l’uomo’’ vagabondasse attraverso le storie aggrovigliate di diverse bestie che condividono un grande spazio ma ognuna col proprio ritmo. Una specie di “commedia animale” o di vero “libro della giungla” senza Mowgli. lis
I personaggi dei disegni animati, i giocattoli vengono in aiuto all’uomo in difficoltà nel trovare una definizione (o che ha rinun ciato a trovarla in un “altrui" umano). Lo aiutano a ridefìnirsi come individuo. Ma potremmo anche dire: sono gli uomini che si servono delle specie in via di estinzione per 1) tirarsi su il morale, 2) sostituire queste specie con delle loro immagini. La pubblicità lavora proprio a questa ridefìnizione del buon funziona mento umano (nuova alleanza) sullo sfondo della scomparsa effet tiva o auspicata di certe specie. Questa nuova alleanza mediaticopubblicitaria rende possibile accostare l’eroe tecnologico aH'immagine di due balene in secca. Questa immagine televisiva delle balene ne nasconde altre due: 1) le balene reali scompaiono, 2) altri uomini sono ormai ’’off’ (rimpiazzaci dalle immagini di quelli che “cantano” per loro: band aid, ecc...). Nuova alleanza, nuova spartizione del “rappresentabile” a par tire da questi due imperativi: 1) lavorare ai grandi racconti miti ci dell'individualismo contemporaneo (versione democratica, non eroica); 2) lavorare partendo dall’estetica e dalla percezione pub blicitaria del mondo (la pubblicità lavora da sempre all’indivi dualizzazione dell'offerta, del prodotto e della domanda). Ciò che non rientra in questo meccanismo cade sotto i colpi dell’informa zione televisiva, cioè essenzialmente della ricerca del documento (immagine bloccata sull’altro in quanto esso non appartiene più all’ambito delle immagini che si muovono).
119
1989
Riprendiamo il cammino da qui. Questa cronaca dovrebbe chiamarsi II cinema, solamente. Dovrebbe parlare di ciò che solo il cinema ha il dovere di perseguire. Dovrebbe rappresentare l’usci ta dal periodo “immagini", quello degli incesti e di tutti gli espedienti furbi. In ogni caso, è questo il mio nuovo punto di partenza.
26/9 NOCE BLANCHE (Jean-Claude Brisseau). Il primo Brisseau che vedo e, cerco, il suo film meno riuscito. Noia opprimente, quasi elegante. Impressione, fin dalle prime inquadrature (del tipo a proposito deU'"inconscio”), che i tempi non siano buoni. Poi ti chiedi che cosa mai potrebbe ostacolare il procedere fata le della sceneggiatura (il professore di filosofia e la fanciulla troppo sensibile). Poi, una volta che essa ha assunto un'aria ine vitabile, speri che si capovolga, come se l’abito troppo comodo della fantasticheria esibisse all’improvviso il suo risvolto aspro e reale. Invece no. La fantasticheria trionfa. Fantasticheria che deve essere la stessa di ogni insegnante: che uno (a) dei suoi allievi lo seduca, poi cerchi di “salvarlo” rispe dendolo nel mondo suicida dell’amore, poi lo punisca per essersi tirato indietro, poi si lasci morire: senza dubbio, niente manca ai tormenti dell’anima bella che preferisce andarsene in pensione prematuramente, soffrendo, piuttosto che giocare i tempi sup plementari vivendo una scandalosa felicità. La fantasticheria è una cosa collettiva: intrisa di luoghi comu ni. Il modo in cui Mathilde esaudisce i desideri (prima pedago gici, poi sessuali) di Francois è stravista, tanto riguardo alla rap presentazione (il nudo all’alba) che alla scansione temporale. Ma, in fondo, ciò che non funziona nel film non è canto la banalità della fantasticheria (e dei suoi momenti rituali), quanto la sua chiusura, il suo eccessivo fare da scudo al reale. Come se Brisseau avesse scoperto il suo personale accademismo. Mathilde è qualcosa di più dell’oggetto del desiderio di Francois, ma qualcosa meno di un personaggio altro'. Mathilde. 123
C’è forse l’intenzione di fare, alla fine, un film transitorio, com merciale, utilizzando quel piccolo stock di immaginario colletti vo rappresentato da Vanessa Paradis (un po’ attrice, un po’ nuda, un po’ bambina, un po' donna, un po’ pura, un po’ puttana) e identificando lo spettatore nell’uomo? Senza dubbio nei film precedenti Brisseau è riuscito a giocare sulla doppia logica della fantasticheria dei personaggi (idea fissa) e dell’irruzione violenta - grazie al cinema, grazie alla regia - di ciò che dice no al fantasma, di ciò che "ritorna sempre allo stesso posto". Non mi spiego altrimenti il montaggio delle scene, con molte inquadrature brevi, all’inizio o alla fine di un’azione, che sembrano inutili, ma che si intuisce siano state appositamente volute come indici di un’altra realtà. Che attende la sceneggiatura per ritornare (la vetrina rotta della donna dell’eroe), ma non con la stessa intensità di un Truffaut in La signora della porta accanto (idea di F.S.). Stranamente, Truffaut era contemporaneamente più e meno ipocrita di Brisseau: mostrava nello stesso tempo una dipendenza fìsica che sfociava in passione e un insieme di cose “normali" che seguiva no il loro corso fino al momento — drammaturgicamente molto ori ginale — in cui le due logiche finivano per escludersi e tutto preci pitava. Il problema dei due personaggi di Brisseau è che essi sanno tutto di ciò che stanno vivendo, sono sotto il dominio della sceneg giatura fatale (la fantasticheria) e vivono la loro storia nello sdoppia mento di chi si vede andare incontro a un fatto di cronaca. Strana idea quella di assegnare i ruoli non fantasmatici a degli attori-citazione (Dasté, Silver, Négret). La mia esitazione davanti alle scene sessuali. Statuto dei cliché erotico (il momento in cui l’altro dice sì, cede, si offre, si risve glia al mattino, è infine nudo) rispetto ad un cinema del deside rio. In questo ambito, le cose più trite sono le più giuste, se poste al momento opportuno. Nel dialogo, rimasugli di un certo tipo di “parola d’autore”, del tipo Bresson che filma il botta e risposta di Giovanna d’Arco. Il professore pone delle domande e così facendo scopre che l’allieva si sta prendendo gioco di lui, per poi sedurlo.
27/9 Brisseau (seguito). Riparlandone con F.S., che è più semplice. Nel film ci sono dei (rari) momenti giusti, per esempio quando l’allieva Carpentier dice al professore: «Buone vacanze, comun que!...». Ma sono momenti presi in un movimento d’insieme 124
falso. Al contrario, possiamo immaginare un movimento d’insie me vero che convoglia dei momenti falsi (o deboli, o convenzio nali). Cfr. quanto scritto ieri sui cliché sessuali. Brisseau appar tiene senza dubbio a quel genere di registi che accumulano dei frammenti veri, ma in questo caso ha perso di vista il movimento d'insieme. La "giustezza" (o almeno quella che mi cocca di più) consiste nel fatto che, nel momento in cui si è immersi nel mondo dei personaggi principali, appaiono degli indici — immediatamente riconoscibili - che segnalano come il mondo lì di fianco, conti nui, con la sua musica e il suo “tono". Questa "naturalezza” sarebbe la nostalgia istantanea di un mondo che va, ma che è afferrato solo quando il desiderio vi ha già scavato delle gallerie.
30/9 VOGLIO TORNARE A CASA! (Alain Resnais). Che strano modo ha Resnais di rimanere "attuale”. La cattiva accoglienza riservata al suo film a Venezia, le spacconate di Karmicz, il noio so, esitante balletto dei critici che non hanno mai il coraggio di dire che Resnais è un regista importante-ma-sinistro, sembrano allontanare da questo film, che è da parte sua un ufo molto labo rioso, una commedia assai poco divertente, un atto masochista che non ha più neppure le giustificazioni della “ricerca”. E tuttavia, il film esce nella settimana in cui la stampa (i setti manali) punta i riflettori sulla storia di tal Francis Fukuyama e sulla scoperta stupita da parte degli americani del tema (così poco americano) della "fine della storia". E ancora, esce subito dopo quell’altra riflessione sui fumetti e sulla (fine di) storia americana che è Batman. Mi viene in mente un’ipotesi, questa: Resnais, da sempre, filma dopo la fine della storia (fine della storia che è forse il solo regista ad aver filmato fin dagli anni Cinquanta) e dopo la fine del cinema (o almeno, dell’immagine-movimento di cui parla Deleuze). Ha, in un certo senso, questo anticipo disastroso che proviene dal disastro e che consiste nel riconoscere che ciò che era nei corpi ora è solo nei cervelli e che questi, alla lunga, si anneb biano. Resnais è il prototipo del regista eternamente convale scente, in lotta contro l’anemia, l’anorressia, l’insufficienza. Ha preso atto di qualcosa (che ha visto) e cerca di mettersi in salvo senza aver saputo (o potuto) ricostituire un corpo dopo i campi di sterminio. La commedia potrebbe così essere la ricercatezza estre 125
ma di questo universo senza affetti (e così svuotato di desiderio che le sceneggiature possono procedere solo mediante qui pro quo), ma la commedia necessita di una cosa di cui Resnais è tra gicamente privo: il ritmo. Questo si vede molto bene nel divario tra la recitazione di Micheline Presle (che ha un tempo proprio) e quella degli altri attori (impantanati, inesistenti al di fuori delle immagini in cui appaiono). Il film è fiacco? Il rimbambimento senile, in tutti i casi, è il suo tema. Rimbambimento galoppante del vecchio americano, ma pre-rimbambimento di DepardieuGauthier. Idea di un’evoluzione bruscamente interrotta, di uno scivolamento verso la debilitazione.
La mia idea è questa: Resnais descrive mollemente la mollezza deil’epoca, in un momento in cui l’epoca - a causa della sua mol lezza — si riconosce solo in prodotti dopati. Se le immagini dei media (soprattutto la pubblicità) sono assimilabili a delle imma gini dopate (di cui è nota, in fondo, l’artificiosità), le immagini del cinema — quelle di Resnais — ricordano per esempio che i per sonaggi esistono solo per il fatto di essere tatto perfusione. Idea fìssa, idea precostituita, idea di sé. Tanto più che Resnais pratica da sempre un cinema ‘‘impuro’’, un cinema sotto perfusione. C’è qualcosa di incredibile in Resnais: come, per lui, il cinema non sia qualcosa di dato. E a qual punto egli si rivolga ad altre forme di movimento (fumetti, cinema muto, teatro di boulevard, lette ratura) o piuttosto — ora che ci penso — ad altre forme di ritmo. Il ritmo, in effetti, è ciò che manca ontologicamente a Resnais. Così, secondo me, spesso si rimprovera Resnais di non proporre un’immagine dopata del vuoto, e di lasciar emergere, fra i sonno lenti meandri del suo film, l’autismo degli uni e degli altri. Ma la fine della storia non significa che per certi personaggi del film non ci sia comunque un’evoluzione. Mi riferisco unica mente al padre e alla figlia americana. Lui esce un po’ da se stes so, lei rientra in sé: si incrociano. Ma per Christian Gauthier, improbabile flaubertiano (perché Flaubert?) maniaco dei fumetti, non c’è più storia possibile (paradossalmente è piuttosto sua madre - Presle - a pagarsene una). Strana idea che la Francia sia come “l'officina di riparazione” degli americani e narcisismo pro domo di questo personaggio che riconcilia in se stesso cultura bassa e cultura alta. Per il resto, tutto ciò che ho già scritto su Resnais persiste e riceve conferma. In questo film, è il turno dell'America di essere 126
in punto di morte, di produrre solo dei sogni sbiaditi, degli zìi d’America che sopravvivono a se stessi, degli esseri che confondo no i loro capricci con i loro desideri. Il mondo di Resnais trae la sua forza unicamente dal fatto di essere ormai da tempo popolato di imitazioni umane, ben fatte, regolate dall'esterno attraverso qualche teoria (Laborit, per esempio), perfettamente credibili; ma che, di fronte a certe prove, non possono che confermare il loro essere dei robot. È un mondo che, avendo smarrito la sua regola nei grandi massacri, non ha più eccezioni, dunque un mondo senza individualità, che può salvare solo un po’ di folclore. Per questo Resnais ha una visione essa stessa folclorica delle differen ze culturali. La sua passione per i fumetti è la (Missione per un mondo ritmato in cui l’umanità non è una questione di condizio ne. Ma poiché è francese e regista, si rifiuta di incarnare il fumet to, preferisce piuttosto rendere fumettistica la carne degli attori. BATMAN (Tim Burton). Attenzione a non partire troppo presto con le interpretazioni (come con Elizabeth R.), anche se è molto bello farlo con questo genere di film.
Vedo così pochi filmoni americani che i pochi che vedo mi fanno uno strano effetto. Tento di descriverlo. Impersonalità dello sguardo + iperrealismo dei personaggi. Che, in modo molto americano, sono subito a disposizione, operativi ma non funzionali. Nei vecchi film c’erano delle “funzioni”, oggi ci sarebbero piuttosto degli “operatori" di fiction: giornaliste giova ni e belle, poliziotti, politici, ecc. E ancora: schermi di computer, dossier, ecc. In breve, la panoplia dell’informazione. I movimenti in cui sono presi questi personaggi sono un misto di movimenti di macchina all’antica e zoom moderni. Si tratta soprattutto di zoom laterali. La loro essenza è di sapere dove vanno ma la loro direzione è cambiata: non è più tanto questione di sostituirsi al personaggio identificandosi otticamente con lui quanto piuttosto di prenderselo in carico — come si dice prenderselo sulle spalle o caricare in autostop — fisicamente, in un movimento diretto da qualche parte. Era così, mi sembra, il bellissimo inizio di Fuori orario di Scorsese, con un movimento di macchina lungo una fila di scrivanie della redazione di un giornale, ad altezza di schermi di computer, già dirigendosi verso il personaggio, e costringen dolo dentro la finzione. È il nuovo volto dell’antica efficacia nar rativa americana: non si costruiscono più, attraverso la regia, diversi spazi adiacenti (il vecchio cinema, Lang, per intenderci), 127
né si divora più un solo spazio (mentale-octico) mediante lo zoom, ma si precipita un personaggio attraverso degli ambienti “vettorizzati”. Spielberg, secondo me, sa farlo molto bene. E anche Coppola, Cimino, tutti. Tim Burton ci riesce abbastanza quando manovra la sua macchina da presa come un bolide che a volte frena o fa un leggero testa coda, per esempio nella scena del ricevimento in cui i due giornalisti venuti per vedere Bruce Wayne faranno effettivamente la sua conoscenza (più del dovuto), mentre il Wayne in questione è seguito come un’ombra dai fan tastico Alfred che raccoglie tutti gli oggetti dimenticati. Spazio vettorizzato (non più punteggiato, articolato o divorato) al quale nulla resiste, o piuttosto che non può trovare un limite se non nella figura inaudita che segna un punto d’arresto (il simbolo di Barman proiettato contro la luna, a vegliare su Gotham City). Universo in espansione, universo alla deriva (ma siamo in America, e ci si trascina un bel po’ di realtà residua). Altro aspetto di questa percezione: la monotonia. Gli america ni sembrano avere smarrito il senso del tempo forte e del tempo debole. I tempi "forti” del passato (i pezzi di bravura) passano al "molto forte”, i tempi “deboli” passano al “forte” (ma esprimono — è il contrario di Resnais — solo un sentimento di velocità for sennata e vuota). Manca, per permettere ad un po’ di poesia di aprirsi un varco, che i tempi forti ritornino deboli (senza dubbio accadeva in alcuni momenti di King Kong o, se ben ricordo, in una bella scena del primo Superman con Glenn Ford). Ma Batman non è una questione di poesia, quanto piuttosto un ulteriore epi sodio nella lotta intrinsecamente puritana tra lo spettacolo come male e l'anonimato come bene. Lo scompaginamento dello spet tacolo mediatico tramite un sovra-spettacolo cinico e davvero criminale. L’idea del dittatore come clown fallito, seguito di Chaplin (il ghigno come rictus viene da Un re a New York) e commento al keep smiling americano. I valori ascetici (il Bene) sono qui fortemente marcati dal vecchio mondo, i valori ludici (il Male) sono piuttosto dalla parte delle parate americane, di Disney, della cultura del giocattolo-che-uccide.
128
Appunti su Palombella rossa prima che questo film diventi da solo tutto il cinema. * Un film che si svolge ai bordi di una piscina in cui nessuno spinge nessuno ni cade per disattenzione o per far ridere. Siamo definiti vamente oltre il corpo burlesco (quello che cade e si rialza). Dopo Tati, Sellers e qualche altro, un passo in più in direzione del comico non basato sul corpo. Risultato: guarderemo in modo diverso qualcuno che corre sul bordo di una piscina dal momento che è chiaro che non ci cadrà dentro (così come l’arbitro in bian co, funambolo bello e ridicolo). Risultato: il corpo esibito è, sem plicemente, quello dello sportivo, al di là di ogni rilancio da body building e/o derisione. Il corpo di Moretti ha una strana bellezza (quella dei nuotatori: muscoli longilinei e assenza di peli). Il corpo, di fatto, è ridotto a un’autonomia relativa: funzio na piuttosto bene. Tutto si gioca a livello mentale (il corpo non ricorda le sue ragioni, obbedisce, fa ciò che può e sa ciò che può). Gran parte delle cose belle del film derivano da questa emanci pazione dal burlesco antico; le difficoltà dal tentativo di dar vita a un burlesco mentale. E anche quando, nel momento in cui non ce lo aspettiamo più, dentro la piscina finiscono delle persone vesti te di tutto punto, siamo ormai alla fine della partita ed è con un movimento comune (rituale?) che il pubblico si getta in acqua. Nel contempo, spostamento e generalizzazione della gag.
* Democrazia di base. Allo stesso modo noi siamo liberati dalla gerarchia dei personaggi (personaggi principali, secondari, com parse), dal momento che tutti vengono prima della prima immagine e quindi sono di diritto tutti uguali. Esempio: il modo in cui Moretti incontra sua figlia Valentina («ciao papà!») deriva un po’ da Ferreri o da Bunuel, altri adepti del cinema sempre-già-democratico. Ma contrariamente a Fellini, che tratta le sue “apparizio ni” come oggetti collocati per sempre in un solo cervello, Moretti le fa appartenere simultaneamente a due ordini di realtà: la sua e la loro. Non si può più parlare dell’autore e dei suoi fan tasmi perché i suoi fantasmi sono il risultato di una situazione in 129
cui bisogna essere in due per poter creare, in modo molto effìme ro, una figura. * Figura. Quando Moretti respinge il piccolo cattolico appic cicoso che lo perseguita, essi — per un breve istante — fanno un duetto e la cinepresa è là dove è la figura coreografica ad essere ripresa. La tentazione di “far corpo” con qualche cosa (la squa dra, l'acqua — il partito, il popolo «come un pesce nell'acqua») è tanto eterna quanto eternamente delusa. Con Valentina (colpo di cesta), la giornalista (lo schiaffo), il giovane giocatore (Gennaro), ecc., bisogna sempre trovare la figura adatta perché, stilisticamente, 1’incontro possa durare per un po’. Ma ciò che è ancora più forte è che Moretti fa ugualmente coppia (sempre improbabile) con personaggi fantasma (il vecchio "verme fasci sta”), ricordi di infanzia, parti di se stesso, ecc. È quindi, come dice Deleuze, «molto popolato all’interno di se stesso» e il bur lesco mentale ha senza dubbio a che vedere con questo intasa mento tipico dell’individuo moderno. * Niente dura. L’idea della partita di pallanuoto (scandita da una specie di conto alla rovescia) è evidentemente funzionale giacché permette di collocare tante mini-durate simili a bombe a fram mentazione. Ma queste durate non sono, come in Godard, dei ralenti-per-vedere-meglio o dei “miracoli prolungati per qualche secondo", sono delle ipotesi plastiche e poetiche, che frammentano l'idea di una coscienza che si intensifica tutta da sola. È il privilegio del comico che deve, fondamentalmente, confiscare e ri-distribuire.
♦ Innesti. È evidente che, a) contrario dei moralisti puritani, Moretti accetta la “legge dell’innesto” come inevitabile. È forse il primo a usarla con un’idea alle spalle. Chiamo legge dell’innesto quel procedimento, che mi ha sempre esasperato, che consiste nell’affìdare ad alcuni elementi (molto spesso alla musica, ma anche al ralenti) un diritto di prelazione sulla scena che segue, il che significa giocare sui nostri riflessi condizionati dalla pubbli cità o dalla pornografìa. Come in La messa è finita (il prete-il pallone-il dribbling-la caduta), abbiamo qui la serie ho paura-mi avvento-dribblo-perdo subito la palla. Questi effetti di innesto sono molto raffinati perché giocano sulla stessa risorsa ossessiva che spiega il rigore fallito (destra-(sinistra)-destra-sinistra): fun zionano per pochissimo tempo, un tempo conquistato sugli altri. L'esempio più bello, piuttosto pasoliniano, è quello della canzone 130
di Elvis Presley che impone il silenzio. Anche in quel caso: libertà, figura. * L’acqua. Filmata come mai prima. Si ha un bel sapere che la pallanuoto si gioca anche sott’acqua: la cinepresa di Moretti rifiuta di diventare sottomarina. Rifiuto della profondità, che fa di questo film la risposta del cinema all’audiovisivo (Le grand bleu). L’acqua è una superficie, spesso filmata dall’alto, ma una superficie speciale che bisogna ripercorrere di continuo, solcare con il proprio corpo (in un movimento bustrofédico). In Besson, l’ideologia è quella del "silenzio degli abissi”: egli si rivolge a un pubblico semplice che non saprebbe che mare = madre. In Moretti, è impossibile non saperlo: il rapporto con la madre, certo, ma non perché essa rappresenta un elemento di rifugio, ma perché non ha permesso al suo bambino di cambiare sport. Madre moderna, autoritaria, quindi, e non la "mamma" fonda mentale (così nel testo, ndt) o la Madre assente. Domanda inte ressante: visto ciò che sappiamo del freudismo, dobbiamo inter pretare le grossolane denegazioni dei personaggi in chiave psi coanalitica?
* Parlare/gridare/tacere/cantare. Come sfuggire al vuoto del linguaggio giornalistico? Bel soggetto. Moretti non è mai soddi sfatto dei linguaggi che attraversa. Gli eleganti parlatori lo esa sperano. Come il Chaplin del Dittatore — idea di P.K. - deve crea re dal nulla le condizioni alle quali può lanciare un messaggio. L'amnesia dell'inizio (relativa a ciò che è accaduto il martedì), lo sforzo per ricordarsi che cosa abbia potuto dire, il rifiuto del lin guaggio con cui è condotta l’intervista, la ripetizione maniacale di una frase (chesignifica oggi essere comunista? - così nel testo, ndt) che riacquista un po' di significato proprio per il fatto di essere ri|K-tuta, il canto come fuga salvifica.
* Individualismo. “Siamo uguali, siamo diversi" (così nel testo, ndt). Prima del secondo incidente (prima della fine, con la vera |ialumbella rossa), Moretti, al volante della sua auto, va fuori dai gangheri perché non riesce ad articolare i due termini dell’indivi dualismo moderno: da un lato, singolarità, dall’altro, uguaglian za dei diritti.
* Rapporto col cinema. Quando II dottor Zivago passa in tv, timi vanno — come alta messa — a vedere la fine del film e —come 131
nello sport — incoraggiano i personaggi. Rifiuto del cinema come feticismo di ciò che è fatalmente ripreso, compiuto. Volontarismo formidabile, folle ottimismo. Punto di vista che gira le spalle alle versioni malinconiche del “questo è stato” e che ricolloca il cinema al centro della cultura popolare. * Il comico. Era, prima, un essere particolare, “di troppo", capro espiatorio del gruppo, portatore della verità di quest’ulti mo, ecc. Moretti è nella scia dell’eroe di Hollywood Party, è fuori posto, ma va bene lo stesso. Giocatore di trentacinque anni, ingombrante e stabilmente ingombro di tutto il suo mondo, non impedisce il funzionamento normale delle cose. Vecchia idea: ormai, da noi, tutto funziona, ciò che è fatto per funzionare fun ziona, non si può più ridere (o piangere) del cattivo funziona mento del mondo. Al contrario, è il fatto che funzioni che ango scia e fa ridere.
132
Frammenti 1
Chang e Agassi. Perché, improvvisamente, il tennis è diven tato meno interessante? Perché questi ragazzini pregano e la cosa è entrata a far parte della loro immagine. Piccoli campioni di Dio e del melcing-pop americano: è un po’ troppo. I tornei, il Medioevo. Lo sport è interessante, perché è l’unico ambito che giustifichi la televisione (e viceversa) e perché ciò che vediamo accadervi (in primissimo piano) è forse il sintomo più evidente dell’epoca. (Esiste una ditta che gestisce l’immagine di Maradona). Fino ad oggi, i rapporti tra lo sportivo (ed ogni altra star) e la sua immagine erano visti in termini di alienazio ne. Una star è un’immagine del sociale al quale essa viene rego larmente sacrificata, non senza pathos (voglio essere me stesso, ecc.). Ma è sufficiente che tra la star e questo sociale intervenga una mediazione, perché essa sia liberata subito dal suo pathos. Fino a poco tempo fa, uno sportivo voleva dire un manager, un massaggiatore, due o tre persone, una famiglia. Oggi è una vera e propria azienda, con tecnici specializzaci in tutti i settori. Attorno ad Agassi scanno così un Signor Comunicazione, un Signor Immagine, un Signor Psicologo, un Signor Corpo e un Signor Anima. Quesco non significa che lui non conta più nien te, ma che è responsabile di tutto senza dover rispondere di nien te. Ora, ciò che faceva dello sportivo una bella figura dell’indi vidualismo eroico era il suo tentativo di "rispondere” (Marilyn che leggeva Platone, Delon appassionato di quadri, Bardot di animali). Invece di essere il luogo impossibile in cui convivono tutte queste dimensioni, la star diventa il punto di applicazione di tutte le tecniche (solo quelle religiose mancavano ancora all'appello). È senza dubbio questo sollievo che permette il lan cio economico del prodotto (che non è l’uomo ma l’immagine) e la creazione di un numero considerevole di mestieri-dellacomunicazione. Quanto al soggetto, egli è liberato da ciò di cui non è specialista, dal momento che ha a disposizione — addetti alla sua quotazione di mercato — i suoi specialisti per sonali. 133
PERSONA-"UOMO"-INDIVIDUO. Le tre rivoluzioni (ameri cana, francese, russa) hanno avuto bisogno di forti personalità per promuovere l'uomo-e-il cittadino. L'attuale individualismo ha bisogno del discorso umanista per consegnare l’essere umano a un’economia generalizzata. Spostamento obbligatorio (“ogni nuova idea avanza mascherata”).
VELI. La scuola è la questione centrale. Doveva essere neutrale affinché all’ombra di questo sociale neutralizzato un certo sapere fosse messo in circolazione. Neutralità relativa, quindi. Ma se questo sapere entra in crisi, anche la neutralità della scuola è rimessa in discussione. Alcuni vogliono reintrodurla per forza: la scuola come luogo sacro, “tempio del sapere”, ecc. La laicità come anti-religione o pseudo-religione. Altri si sono già schierati per una scuola intesa come luogo tecnico puro, sottomesso all’economia di mercato (scuole di differenti livelli, inserimento definitivo degli audiovisivi e dei computer, sostituzione dei “mediatori” di ieri: i professori, trattati come bestie). La scuola religiosa (Rassicura la persona, la scuola laica fabbrica l’“uomo", la scuola attuale anima l’individuo. Si comprende il panico di un Finkielkraut: alle nostre spalle, l’oscurantismo dell’appartenenza da sempre-già presente; davanti a noi l’oscurantismo di un’appartenenza-da-conquistare a viva forza.
NOCCIOLO DURO. Un “mediatore” che, mentre trasmette qualcosa, trasmette anche se stesso: ecco una delle cose che riguardano il nocciolo duro del cinema: Moretti. Soprattutto i comici. La scuola (Bianca), la Chiesa (La messa è finita), il PCI (Palombella rossa). Mediazione disoccupata, impazzita, ingombra del suo stesso corpo. Il corpo del prete, del professore, del depu tato-sportivo (due corpi). Trasmissione senza mediazione, o affinamento della mediazio ne, ridotta auna sfaccettatura, a una funzione (vedere più sopra: Chang, Agassi, ecc.).
Se la persona era un groviglio di forze in una rete e l’uomo un cerchio con un centro e una periferia, l’individuo è una specie di poliedro sfaccettato, esposto su più facce a più stimoli prove nienti dall'esterno, capace di più collegamenti ma più superficiali. Il nostro mondo è più superficiale perché ha più stiperfìci, che sono altrettante interfacce. Il cuore è sguarnito, il noc134
dolo non è duro ma vuoto (questa sarebbe) la giapponesizzazione delle nostre culture).
La persona è uno spazio interno di riverbero (per-sonare), una maschera più forte delle altre. L’uomo è un po’ come lo schema della nassa lacaniana in rapporto dialettico con l'ambiente (da una parte e dall’altra di interno/esterno). L'individuo è come una massa gelatinosa invertebrata che tutto attraversa e colora (mime tismo animale, economia virale, mode).
Tutti sono concordi se/ vedere le cose in questo modo, è dopo che tutto si complica: infatti, questa massa sociale gelatinosa che irradia da ogni parte per alcuni è estremamente vulnerabile di fronte a quanto proviene dalle culture personalistiche (integrali smi fàllici), per altri, al contrario, è dotata di una forza paradossa le dal momento che si ricompone sistematicamente e digerisce, come fosse del plancton, tutto ciò che l'aggredisce e che, obbliga toriamente, appartiene al terrorismo. Il problema di queste società gelatinose (fine della storia e dopo...) è che esse traggono la loro forza dall’interfacciarsi accelerato degli individui, cioè dai progressi esponenziali di un’economia virale che, ormai, deve controllare ogni cosa. Ciò che nelle culture personalistiche (comunitarie, religiose) sfuggiva all’economia di scambio e passava, come parte maledet ta, nell’economia d’uso (Bataille) deve oggi essere riciclato nell’ambito dello scambio. La religione, l’arte, la cultura (tutto ciò che risponde alla domanda: «che fare dell’eccesso?») passano così dalla parte dello scambio e perdono ogni rapporto con la verità. La religione non può che riunire attorno a sé dei perdenti (l’IsIam, religione dei diseredati del XXI secolo) che essa orga nizza ideologicamente, con l’aiuto di segnalazioni arcaiche (veli). L’arte, a sua volta, non è più legata ad alcuna idea di progresso umano ma all'idea di una possibilità individuale di conservare il proprio rapporto con l’eccesso (URSS). Anche la cultura è un’industria e nient’altro, dopo che ha perso il suo significato nel suo stesso trionfo. Le culture individualistiche mettono in scena una strana dialettica: ogni affermazione propriamente individualista è trasformabile in mercato. DÌ fronte al crollo degli ideali economici comunisti, sembra difficile fare altrimenti. L’economia capitalista è diventata ormai un’economia del virtuale e può fondarsi solo su bisogni inventati 135
(o che si inventano l’un l'altro), vale a dire su una semio-economia (valore commerciale dei segni) a base religiosa (mercato del significante, della marca, del nome — genere snobismo giappone se, o mercato impazzito della pittura). È anche vero (Le grand bleu) che l’industria del tempo libero offre enormi possibilità a piccoli mercati labili e personalizzati (mode come il surf, l’immersione in apnea, la vacanza, ecc.). Dopo l'epoca della stan dardizzazione, ecco quella della personalizzazione (trasformazione dell’antica “persona” in singolarità codificabile).
WENDERS-YAMAMOTO. Film un po’ inutile e tirato per le lunghe. Controllo astuto della televisione (Wenders + Yamamoto, Parigi + Tokyo, Cinema + Video). Debutto simpati co perché davvero forzato: con Wim che fa la parte di quello che non sa niente (della moda, di Yohji...) ma che un'irrefrenabile curiosità avrebbe spinto a scoprire il gentiluomo che ha confezio nato i vestiti in cui si trova così bene... Poi, molte porte aperte (anche per me).
Cinema/video. Evidentemente, ci sentiamo ormai in diritto di chiedere ad ogni regista che cosa pensi del video (che lo usi o meno). Wim forza un po’ troppo le cose e con un po’ troppe smancerie dichiara la sua resa graduale al fascino del video. Ne deriva, poi, degli effetti molto godardiani e che girano attorno all’idea di lavoro (le mani, gli schizzi, le prove). Per un regista il video è un momento di lavoro (il suo, dell’altro). Di fronte a Yohji, che articola l’eterno discorso sull’artigianato giapponese (quando lui ne è ben al di là), Wim si sente di piazzare la video camera nel cuore del villaggio, nel cuore dei gesti degli abitanti del vil laggio; forse perché il Giappone è tanto vicino a una cultura da villag gio? Autore = maestro + discepoli devoti (cfr. Ogawa). E se, in tutto questo, ci fosse decisamente il vecchio Heidegger con la sua capanna? Più Wenders sa ciò che vuole e chi è (più il suo stile lo precede), meno ha bisogno del cinema, dal momento che il cine ma è la ricerca di una frontiera immateriale tra due forze che premono, un’immagine necessariamente “tra", mentre il video offre un mondo, un altro mondo (non necessariamente umano} di ciò che sta “in mezzo". Vedere, con questo tipo di spirito: Kramer (Route One). La crisi del cinema è la crisi del “tra”. Non mi stupirei, d’altronde, che Vimmagine avesse presto ciò che si merita. Dal momento in cui cessa di essere una linea di 136
demarcazione, essa perde la sua grandezza di cinema. Finkielkrauc, che non ama il cinema, oppone il mondo dei prin cipi al mondo deH'immagine. Tutta la pedagogia godardiana non sarò dunque servita a niente. Il cinema: mi oriento in un mondo che non è (che) il mio. Il video: mi perdo in un mondo che è solo mio. Perdersi, annegare, il bagno amniotico del video.
DELL’ANALISI. L’idea di irradiazione (seguito). Parlando con qualcuno (Jousse?), collego - del resto è molto focile - ciò che ho scritto sull'informazione-come-irradiazione e la natura dell’immagine elettronica. In entrambi i casi si tratta di un fenomeno di analisi regolare di un campo prefissato. Dunque un misto di “sorveglianza + tempo”. La concezione antica (molto idealizzata) consiste nel concepire prima il reale (l’even to) poi lo sguardo su questo reale, il suo trattamento, la sua restituzione, la sua interpretazione (due tempi, quindi dialetti ca). La concezione attuale concepisce prima l’analisi e l’indivi duazione dei mutamenti tra due analisi. Questi mutamenti non sono per forza degli eventi ma, se opportunamente studiati come sintomi (indici di Peirce), creano l’evento che loro stessi richiedono e lo creano in un modo sempre più forale (impossi bile, ormai, fare della sintomatologia relativa, come Barthes o Godard, la scalata agli estremi è allo stesso tempo l’atto col quale ci si arrende al terrore e quello con cui lo si doma). Il parallelo tra informazione e immagine elettronica è quindi pro ponibile: si tratta di un’analisi del campo sociale, come una pulsazione regolare (è il senso di quel vecchio slogan che affa scinava tanto me e J.P.O., «succede sempre qualcosa alle Gallerie Lafoyette») che passa da un’immagine astratta ed eva nescente (sondaggio, sintomo spostato, indice) a un’immagine concreta e definitiva (quella destinata a restare). Gli attuali eventi mondiali, tutti dotati di una forte carica simbolica, con sentono di mettere a punto questo marchingegno di immagini. Tien-An-Men ha prodotto piuttosto rapidamente l’immagine davvero indimenticabile del piccolo uomo che fermava i carri armaci e anche oggi, giorno della fine del muro di Berlino, il tg di TEI si è aperto e chiuso su una stessa immagine: quella dei colpi di piccone contro il muro. Questa immagine è una “proposta”, nel senso della moda, che ha la possibilità di diventare l’emblema di un momento storico. Sulla scia di Godard, noi abbiamo sempre protestato contro la 137
confezione dell'immagine “unica”. «Sempre due immagini», diceva Godard (da cui la necessità del montaggio, cioè ancora della dialettica). Ma è forse più ragionevole dire che ci sono tre immagini: l'immagine 0, l’immagine 1 e l’immagine 2. L’imma gine 0 è la mancanza di immagini, cioè la mancanza di ogni pos sibile libertà collettiva (ma non della libertà individuale, da cui il ritiro mistico). L’immagine 1 è quella che ho descritto sopra. L’immagine 2 è ciò che servirebbe se, in qualsiasi occasione, volessi mo rispettare l’inevitabile complessità delle cose umane. Forse: godimento, piacere, desiderio. Confesso di essere più scettico di prima su quel “servirebbe” perché mi sembra, volontarismo puri tano, di girare le spalle a ciò che un’immagine è: una frontiera, un interfaccia, una striscia di Moebius da leggersi sui due lati perché scritta su entrambi.
L’immagine elettronica (seguito). Essa è dunque una funzione del tempo. Non il tempo dell’oggetto osservato (durata baziniana), ma il tempo della macchina osservante (stroboscopia). Il cinema "muore" quando il suo principio — la persistenza retinica — è applicato dall’universo mediatico a un mondo più vasto. Se il cinema captava ventiquattro volte al secondo una situazione simultanea (“in presentia”), quella della realtà posta davanti alla cinepresa, l’audiovisivo affronta la simultaneità assoluta del mondo. Ma siccome il mondo è troppo grande per costituire uno spettacolo generalizzato (fine dei fantasmi paranoici, da Vertov a Lang) bisogna ridefìnirne le unità pertinenti (quelle di “evento”, “commemorazione”, “programma", “visibilità", ecc.) per creare un’altra persistenza, non più retinica, ma cerebrale.
VITTIMOLOGIA. Letto su «Libération» un articolo sulla “vittimologia”, disciplina che eisterebbe già (negli Stati Uniti) e che avrebbe come oggetto lo studio dei comportamenti di quelle per sone che, a vario titolo, sono state delle vittime, innocenti natural mente. Genere: sopravvissuti (Bettelheim: Sopravvivere), ostaggi liberati, ecc. È un passo avanti o un passo indietro? In tutti i casi un segno. Domanda: c’è stato un momento nella storia umana in cui il diritto del più forte o l’appartenenza al campo del più forte sia stato vissuto come legittimo, fortunato, senza particolari stati d’animo? Si finisce per dubitarne. L’Inghilterra imperialista e vit toriana, per esempio, ha davvero prodotto questo tipo di atteg 138
giamento? Oppure la legittimazione ha sempre dovuto essere accompagnata da un’idea di elezione, di missione superiore, di millenarismo salvifico (le tre rivoluzioni "democratiche”, e anche le rivoluzioni "nazionali”)? Nella misura in cui ormai più nessu no può dirsi eletto, la forza è nuda. Il problema del Giappone sta diventando questo: la potenza senza contenuto, la tautologia (Giappone = Giappone) senza scopo. Quello dellTJRSS rischia di essere la sostituzione di una disastrosa "elezione” (il comuniSmo) con un'elezione più antica (la religione). E tra i due, battuti dai giapponesi in materialismo e dai russi in spiritualismo, gli americani finiranno per subire la prima grande umiliazione delia loro storia. L'Europa è un’ipotesi che vede riuniti dei vecchi avversari deH’"elezione” (forse, pro prio questo passato è la sua migliore salvaguardia). L’Islam è un’altra ipotesi ancora che, all’alba del XXI secolo, riunisce buona parte dei perdenti del XX.
«Vergognarsi della propria potenza» diceva Nietzsche, citato da Blanchot. Sembra davvero ciò che sta accadendo oggi. È pro prio in quanto vìttime che i popoli o le nazioni cercano di vivere la loro potenza. I più forti, poco fieri della loro forza e poco riso luti a darle un senso (Godard: «la democrazia è più forte della tirannia»), rubano la debolezza degli altri e ne fanno sfoggio. Per questo il razzismo è più force che mai, perché esso consiste nell’accusare i più deboli di godere al posto dei piò forti. Ed è per questo che, nella lista d’attesa delle "vittime” del mondo intero, bisogna inserire non solo quei gruppi che realmente hanno subi to un torto (ebrei, armeni, curdi...) ma anche quelli che sono spesso responsabili di questo torto. Il caso russo è il più preoccu pante perché, nello sfaldamento deH’Ifnpero degli zar, i russi bianchi si rivendicano come minoranza (esattamente come tutti i “piccoli bianchi” del mondo, a cominciare dagli americani). La lotta per figurare tra le vittime è quindi sanguinosa (neri ed ebrei negli Stati Uniti, armeni e azeri in URSS). In ultima analisi, tutto questo non deriva forse dal perdurare dell’ideologia cristiana rilevata dalla sinistra? (René Girard scrive che il colpo di genio del cristianesimo è stato quello di aver deci so che la vittima - il capro espiatorio - era innocente e che pro prio in questo sta la superiorità della religione cristiana sulle ni tre. Cosa vera, quantomeno politicamente). 139
L’idea che le vittime siano migliori, non è questa la trappola fatale? Non abbiamo forse avuto terribilmente bisogno di questa idea per giustificare il nostro “umanesimo” di facciata? Esattamente come quei film americani anti-razzisti che mostra vano dei neri sublimi? Il che significherebbe che l’umanesimo — come principio — non è mai veramente cominciato. Per esempio, non è carico di conseguenze il fatto di chiamare “olocausto” il massacro degli ebrei? L’olocausto non è forse il sacrificio di vite umane che una collettività si infligge con piena cognizione di causa (per calmare gli dei: aztechi, incas, ecc.)? Non è scandaloso dare una simile interpretazione al fatto che sono morte persone che volevano vivere? (Temo di ricadere in un dibattito antico, tra Nietzsche e Bataille, quello della sovranità. L'unico popolo sovra no sarebbe quello dei gitani, perché non rivendica niente in cam bio del male che ha dovuto subire).
Senza dubbio assisteremo presto a dei tentativi di risposta. Di certo ^umanesimo" ha raggiunto un limite. Quell’umanesimo per cui io riconoscevo all’altro, a qualunque altro, il diritto di procedere alla mia definizione. Più nessuno si aspetta di riceve re dai popoli dell’antico terzo mondo delle verità se|x>lte e dei saperi remoti (perché questo potrebbe essere l’IsIam, rescissio ne delle fanciulle). Al contrario, è la salvaguardia del pianeta (geocrazia) che rischia di prendere il posto del progresso dell’umanità. NON CI SI MASTURBA PIÙ. Collera un po' esagerata di fronte alla campagna pubblicitaria della nuova formula dei «Cahiers», che gioca con la loro immagine, quelfimmagine che contiene da sempre l’idea della masturbazione intellettuale. Ingenuità dei «Cahiers» rispetto alla pubblicità, che essi credono strumentale e che invece, già da tanto tempo e grazie al suo stesso trionfale suc cesso, è diventata molto più di una complice strizzata d’occhio, piuttosto (sono soddisfatto di questa definizione) una vera infor mazione su un desiderio. La cattiva pubblicità fa sì che l’informazio ne sia percepita immediatamente (e non saranno certo i ridicoli proclami a cambiare qualcosa) e così il basso desiderio di ordinata normalità e di tranquillità d’animo dei «Cahiers» sono stati rico nosciuti al primo colpo.
Sempre meno persone vogliono essere spettatori, sempre di più vogliono essere autori. Mo
SULLA RIGIDITÀ DEL PCE Volto tumefatto di Marchais in penombra: sta ancora mentendo o piuttosto sta tentando di arran giare le cose. Patetico e ributtante, ma non banale. Che cosa comporta, in fondo, l’essere comunisti? La forza di dire no. La cosa fastidiosa è che questo no è tanto un no all’ingiustizia o all'oppressione (resistenza) che un no all’evidenza, al buon senso, all’onestà intellettuale (collaborazione). E se la politca comunista è ormai da tempo screditata, l’atteggiamento (che va dal rifiuto dell’oppressione al rifiuto dell’evidenza) non lo sarà mai. La dignità comunista (di base) non sta forse in un “non ne voglio sapere” (davanti alla forza, alla ricchezza, al potere: una forma di stoicismo moderno) che degenera tragicamente in un “non voglio sapere niente”?
È questo che sta rapidamente accadendo. La liquidazione della politica comunista e la “liberazione” (come Aladino dalla sua lampada) di un ethos comunista. a) All'uscita del film di Rochant (Un mondo senza Jean N., sempre perspicace, sottolinea la presenza della figura vagamente commovente, in tutti i casi non negativa, di un proletario-tipo che affìgge «L’humanité». Ma ci sono cose simili (non ricordo bene) anche in Garrel e, certamente, nel Moretti girato quando Occhetto stava decidendo di rinunciare anche alla sigla PCI. b) Il testo di Peter Schneider, oggi (15 novembre). Che cosa ci garantisce, si chiede Schneider, che Ì valori comunisti dell’est svaniranno così? Serbatoio di morale, l’Est (perché è lì che gli individui sono stati i migliori quanto all’essere degni o indegni, nobili o ignobili, puri o corrotti).
RIVOLTARE IL MURO. Jean-Loup Rivière, al telefono, ha una bella idea: il muro, dice, andrebbe rivoltato. Così l’Est vedrebbe ciò che vedeva l’Ovest (i graffiti), e l’Ovest ciò che vedeva l’Est (niente, senza dubbio). Ci vorrebbe un Christo. Che cosa fare del muro? Si potrebbe farlo sparire. Ridotto in piccoli pezzi-feticcio, si potrebbe disseminarlo. Se ne potrebbe fare un museo. Rivoltarlo, perché questa idea è così forte? L’interfaccia, idea da approfondire. Ieri, scrivevo: perdita del reale (il buco nero), defaillance del simbolico (la grata), blocco del l’immaginario (il limite). Questo mi sembra improvvisamente evidente: non c’è immaginario se non del limite. Limiti umani. Limiti intra-umani. Sempre Bazin, in fondo. Ci sarebbe un ritor ni
no del limite all'interno dei gruppi (l’umanesimo, quindi, insieme al comuniSmo, avrebbe fallito in roto come pensiero dell’avventura umana), da cui le numerose insorgenze del passato (appartenenze etniche, nazionali, religiose).
Ma in questo blocco sul limite, forse è in gioco proprio il pas saggio da una linea immaginaria (e quindi tanto più deludente) a delle linee materiali: interfacce. Il muro divide e riunisce. Ma il muro è leggibile da entrambi i lati. Più è un oggetto artificiale (costruito in una notte, "di forza”) più alimenta l'immaginario (noi/loro). I limiti si ricompongono spontaneamente (dato un nuovo "noi" tedesco, che fine fa il “loro": i’URSS? l’Europa? Ma l’URSS si disfa — stesso processo russo bianco/sovietico allogeno - e l’Europa è lungi dall’essere fatta). Al limite, la pax sovietica, come la pace austro-ungarica, ottomana, fornisce un “altro” così smisurato che lo si odia senza attaccarlo e, soprattutto, senza attaccare i vicini.
Pubblico/Privato. Da un lato del velo la donna che dice: voglio restare nascosta (perché io mi offro a un altro che non siete voi: il mio uomo, il mio Dio). Dall’altro, il laico che dice: non voglio vedere quel velo (perché introduce nel mio rapporto con la donna un terzo elemento). L’immaginario del laico (lui è un uomo e lei una donna) poggia su una struttura simbolica (lei, lui e l’altro), che è un modo romanzesco per impazzire. Nel caso dei liceali, il laico fa entrare un altro “altro": lo Stato educatore, e poi se la prende per il fatto di ritrovarsi in una struttura religiosa. In tutti e due i casi, non si è sostenuto il confronto immaginario, non si è riusciti a costruirci sopra. Per il lacanismo in senso stretto, ciò è impossibile (sull’immagine non si può fondare niente, l’immagi ne permette caso mai di inventare delle distanze umane all’inter no di ciò che si è fondato). Allo stesso tempo, però, le nostre società hanno tutta l’aria di fare come se fosse possibile: se il reale è perduto e il simbolico indebolito, è all’immaginario che biso gna affidarsi. Per questo, ci vorrebbe una filosofìa dell’interfaccia: il velo (il muro) appartiene contemporaneamente all’uno e all’altro. Ma l’inter faccia non è un recto-verso, vale a dire che ciò che vi si inscrive può facilmente non essere dello stesso ordine (per esempio: le donne nascondono i loro capelli perché nella loro cultura i capelli sono considerati la parte del corpo più sensuale, ma ciò che 142
disturba il laico è che sia nascosta la bocca) e coesistere. Il limite sarebbe il luogo di incontro pubblico/privato. Questo vuol dire: se incontro una donna velata, devo restare sufficientemente "me stesso” (e nient’altro) per sapere se ciò mi disturba o no (perché ho il diritto di essere disturbato — a partire dal mio lato del velo), ma non posso dir niente sulle ragioni che io suppongo ci siano dietro la scelta del velo, (’integralismo, l’IsIam, ecc. Perché le ignoro. Sarebbe (molto improbabilmente) la risoluzione pura mente estetica e individuale di un incontro in cui non si farebbe intervenire nessun terzo elemento (è, dopo tutto, il senso della bella scena tra le due donne nel film di Garrel: esigenza assoluta di dialogo: per il semplice motivo che io ti parlo, che noi siamo qui insieme, tu devi rispondermi, anche male). Ma si tratta anco ra (si potrebbe dire) di un’astuzia del simbolico: l’immanenza pura (l’hic et nunc) gioca come “dovere”. La mia idea (un po’ estrema) dopo tutto questo “psicovelo”. La scuola è stata abbandonata, ma nessuno lo dice. Non si dice neanche più che è in crisi e che andrebbe riformata. Non esiste paese al mondo in cui la scuola non sia la disperazione di tutti. Gli insegnanti sono sostituibili (dalle macchine e dai “formatori” o dagli “animatori”) e il mercato del sapere è retto dall’economia. Lo chador rilancia la vecchia contestazione dell’insegnamento laico affidato ai religiosi. Inoltre, mette in luce che dell’ideologia laica resta un fondo più religioso del previsto. Ma nessuno mette in dubbio il contenuto dell’insegnamento, mentre il fatto che una ragazzina non impari a nuotare o (in America) sia privata della teoria darwiniana sono considerati fatti ben più gravi.
«Qualunque analista implacabile, chiunque denunci le appa renze, a maggior ragione ogni “nichilista”, non è altro che un mistico bloccato perché rifiuta di dare un contenuto alla sua luci dità, di indirizzarla nel senso della salvezza associandola a un fine che lo travalica» (Cioran). ESTETISMO LIBERTARIO? In che senso può esistere un esteti smo “libertario”? Qualche cosa che non si riduca al rapporto fol cloristico con l’altro (mascherato da se stesso per un soggetto che maschera la sua sessualità: Loti) e che soprattutto non sia fondato sulla gelosia del godimento dell’altro. L’esteta non sa niente di ciò che l’altro mette nella sua apparenza ma si arroga il diritto di giudicarla. Il moralista, in compenso, non vede neppure l’appa 143
renza e si interessa, fino alla vertigine, unicamente a ciò che essa indica del desiderio dell’altro (ma da questo desiderio egli si ritrae). L’essere etico, invece, si vede sempre come un partner separato (l’etica/l’interfaccia?). Ma tutto questo degenera quando ciò che è interminabilmente invidiato nell’altro (soprattutto se esso appartiene al campo dei dominati) è l’intimità del suo rap porto col suo Altro. Da qui hanno origine tutti i razzismi (“io non sono geloso, è stato lui, — lei — a provocarmi"). L’esteta è Minnelli quando scopre che l’uniforme tedesca rovina il paesaggio della Normandia, e quindi che i tedeschi hanno torto. Ma se, in nome di tale principio, egli si batte contro di loro, questo non è più forte delle ragioni delle anime belle? Bisognerebbe solo esserne sicuri, allo scopo di non innamorarsi come pere cotte dei boia solo perché sono belli (Cocteau, Sachs, Genet). In che momento le brutture sovietiche diventano parte del disastro? Esse non hanno forse fatto parte del contenuto posi tivo, etico, del comuniSmo? Non sono forse state volute, delibe ratamente, rabbiosamente?
SCHEMA V. Siano dati A e B. A (principale di Creil), B' (Samira)20. A appartiene al gruppo dominante, B al gruppo dominato. A non ha alcun rapporto con B se non attraverso A’ (la struttura “in nome di”... lo Stato, la laicità, lo spazio pubblico) che B subisce. Ma un bel giorno B decide di spostarsi di un posto e di far appello alla sua struttura B’ (“in nome di” Dio misericor dioso). Si crea così una figura nuova, un rombo. A»-A’ Il mio rapporto con i “miei” valori, trionfanti ma minac ciati da a) la privatizzazione economica della scuola (concezione puramente tecnica), b) il ritorno di vecchie concezioni private (religiose). A’*-B II rapporto di questi valori e di coloro che ne “beneficiano” automaticamente: integrarli (come gruppo) o fornire loro delle armi (come individui). B A’ Il loro rapporto con questi valori che interiorizzano come un’arma, sia per passare dalla parte di A, sia per rivolgerli contro A. B*-B' Davanti alle difficoltà di B, i valori rifugio di un bisogno di comunità (non per l’individuo, soprattutto se femmina) ritro vano una struttura “in nome di” (Dio). B’>- A Questa struttura attacca il soggetto A dove A non se lo 144
aspetta: nella sua insoddisfazione religiosa (conversione all'IsIam). B’*- A’ (e viceversa). Le due strutture "in nome di" entrano in conflitto perché da sempre esse si escludono l’un l’altra. Si mette il velo, si costruisce il muro. A-B È il rapporto che deve essere continuamente controllato. Allo stato puro, esso rappresenta il pericolo di una parte male detta (amore, santità, tradimento, gnam gnam). Troppo mediatizzato (da A’ e B’), riconduce alle guerre di religione. Bisognerebbe che fosse appena mediatizzato (ipotesi dell’interfac cia) per consentire alla linea A’-B’ di non essere più una punteg giatura (assurda e immateriale), una pura barriera (dei fili spina ti) ma un muro bifronte, con scritte diverse su entrambi i lati. Sarebbe meglio che la ragazza dicesse «sono io che...» (anche se la mia religione non me lo impone, a me piace così), cioè che ricon ducesse a sé un po’ di simbolico. Ma questo sembra davvero impossibile.
145
Frammenti 2
CATECHISMO AUDIOVISIVO. Ci sono segnali di una evolu zione della televisione verso ciò che mi ha sempre disgustato: la grettezza filistea e altisonante dell’ordine morale. In passato, tro vavo questa redditività spettacolare della drammaturgia del Bene solo nel cinema americano. Oggi, la televisione francese è completamente "americanizzata” e i De Closets e Zabel sono la versione laica dei telepredicatori, riparatori di torti e sociofunamboli all’americana.
Prendiamo la trasmissione (Mediations) dedicata al doping nello sport. Siamo ben lontani da quello che solo Polac seppe far vivere (Droit de riporne), dalla drammaturgia dell’inchiesta scot tante, diffìcile da istruire, nella quale, in mezzo a una gran con fusione, si finisce ugualmente per intuire le ragioni (e le menzo gne) di ognuno. In questo caso, siamo di fronte ad un esorcismo collettivo che segue questo copione: tutti gli sportivi si dopano - il pettegolezzo dice che tutti gli sportivi si dopano — il pette golezzo ha torto - non tutti gli sportivi si dopano - solo una piccola parte — Ben Johnson, per esempio. Al termine della tra smissione, dalla quale non si è appreso nulla di nuovo, si assegna un piccolo distintivo in più e si perdona la pecora nera. Non si tratta più di “comprendere” le ragioni del dopato né quelle di chi lo spinge a doparsi, e neppure di informare, si tratta di esibi re un’intera classe di sportivi buoni come angioletti, sani, puri, puliti, giovani e francesi, alla cui immagine l’esistenza del doping risulta nociva. È questa immagine che deve essere “salva ta” e cosi si chiama in causa un capro espiatorio (uno sportivo) e si lascia fluire il discorso "naturale” dei buoni sportivi. li noto: l’estetica pubblicitaria (con i suoi sogni pornografici di meccanismi ben oliaci e di corpi sani e puri) ha raggiunto lo sta dio di una drammaturgia al servizio del Bene. Non più il bene come valore o come ricerca, ma come immagine — immediata mente - riconoscibile. Come catechismo. È necessario che lo si mki, che lo si riconosca a prima vista. L’immagine non è più un momento di passaggio, un attrezzo, un mezzo, è un'immagine 147
pia, un logo, un emblema che libera istantaneamente flussi di passione adrenalinica, che permette di ricostituire artificialmente quello che, nella realtà, va disfacendosi: l’unità psicosomatica dell’uomo, la complessità delle motivazioni. Altri esempi: - lo spot contro la droga: un ragazzino si contorce elegantemente davanti a un muro pieno di graffiti, in bianco e nero (danza moderna); - le "bouton blanc" di TF1 (non ancora visto): la mia droga è la famiglia. Sono dei segni-vaccino, magici, che dispensano dall’onere della prova (e, per definizione, spalancano la porta all’inganno-versogli-altri, ancora più grave della menzogna-a-se-stessi). Segno, segnale, pubblica promessa, ritorno dell’idea “militan te’’? Qual è la differenza fra il segno "laico” e il segno "religioso”? Nessuna. Per lottare contro l’integralismo (appartenere a un segno), ci sono due strade: l’austera e la carnevalesca. L’austera (anni Sessanta?) sostiene che l'età adulta non è quella degli inuti li fronzoli, che l'identità è complessa, piena di buchi, che l’immagine è una frontiera verso l’altro e non verso se stessi, che non si devono più marchiare forzatamente le persone (bluse gri gie, stelle gialle), che l’aspetto esteriore non è che una indicazione. La strada carnevalesca (anni Settanta) dice che con i segni bisogna giocarci, che occorre scompaginarli, approfittarne senza credervi (la magia senza la credenza), che l'aspetto esteriore è ludico, forse provocante, ma pur sempre solo una indicazione.
FRUSTRAZIONE ISTANTANEA. Claire Denis, di ritorno da Berlino. Pur essendo là, è dalla televisione che ha saputo le cose. Emozione, brividi e poi, molto rapidamente, cosa fare? Va verso la parte orientale. Dal Parisbar (immutato) vede masse di persone passare per la Kantstrasse, la gente dell’Est fare la coda per otte nere i propri cento marchi. Niente di esaltante, in fondo. Impressione di questi giorni (nei quali sono rientrato in stretto contatto con l'attualità e il giornale) che tutto ciò acca da troppo rapidamente e non senza annoiare (per Praga, le ven dite si sono già fatte deludenti). La televisione — ipotesi — è ormai così rapida, onnipresente e performante che rischia di 14«
generalizzare la domanda (che noi, cinefili baziniani, abbiamo sempre posto): che cos’è dunque che ci si aspetta da questa presenta sui luoghi stessi? Nessuna immagine riesce facilmente a elimina re Varia da animale triste del coito televisione-storia. Ogni tanto una solitaria (l’uomo di fronte ai carri, in Cina, ma occor re sottolineare che egli arresta un flusso), altrimenti niente. Il muro, lo si varca una volta ed è finita. Una piazza (Venceslao), la si riempie una volta ed è finita. Ci si ritrova persino a fare una hit parade del simbolico (Jean Stem, ieri: Praga è più emo zionante, i tedeschi, in fondo, restano dei crucchi). È forse la chance del cinema: ereditare questo residuo di gusto per le immagini "personali”. 2/12 Dopo l’articolo (mal scritto) Catechismo audiovisivo, avrei dovuto aggiungere questo: quando si presenta IJdge d'or come un classi co, si dovrebbe ricordare che si parla di un eroe che tradisce una grande causa umanitaria (vittime di guerra da salvare, bambini) e che lo hi gridando il suo odio per i notabili vestiti a festa. Dopo la lunga tirata di Debray sul ' canagliesco (avvolto in grandi parole) crea un cameratismo il cui spettacolo mi esaspera perché non è amicizia e non ha neppu re il fascino delfamatorialità.
HALFAOUINE (Ferid Boughedir). Film grazioso, il cui merito è di non lasciare alcun dubbio sul fatto che in un certo quartiere di Tunisi tutti pensano solo al sesso. Primi film arabi che, da poco e con discrezione, procedono in quella direzione: Khleifi, Bouzid, Nasrallah. Qui l’eroe è un ragazzino con un’idea fissa (quand'è che si diventa uomini? Le “soglie” sono così tante che finisce per smarrirsi) che capisce quasi troppo tardi che il bagno turco delle donne era il solo posto in cui poter vedere la “cosa assoluta”: un sesso femminile. Ma viene cacciato e perderà la sua verginità alla line di una lunga e morbosa esitazione (nella quale non sa lette ralmente più dove mettere le mani) che costituisce la parte più curiosa (ma anche meno attraente) del film. Sfortunatamente, oltre a questo non c’è altro. Simili film hanno un problema di sceneggiatura. Essi tentano di dare della cultura del loro paese un'immagine più incarnata (a loro rischio e pericolo) e, per gli estranei, più precisa. L’aspetto cronachistico è il più riuscito per ché consente di far ruotare intorno al piccolo, normalissimo eroe le particolarità folcloristiche dell’ambiente familiare e popolare: donne frustrate, forti uomini di quartiere, ecc. Ma, quanto al soggetto, di esso non c’è traccia perché l’evento terribile che vive il ragazzo arabo — essere cacciato dal mondo delle donne — è la storia di tutti e di nessuno. In breve, si tratta di un cinema trop po sociologico che non riesce a cogliere, se non di passaggio, le tracce dell’esperienza singola.
IÌSKANDARAI KAMAN WE KAMAN (ALEXANDRIE, ENCORE ET TOJOURS) (Y. Chahine) * Alla rinfusa: inizio molto buono (mèlo sulla pederastia), tempo musicale giusto, dispersione nelle scene parodiche all’antica, profusione, emozione. Sul momento. L’indomani, sen 213
sazione, ammirata ma con un senso di vuoto, di aver più visua lizzato che visto un palazzo dalle mille entrate, tutte familiari, attraversate a tutta velocità. Di essere stato un po' ingannato dalla rapidità con cui questo sogno a occhi aperti si è presentato per poi disperdersi senza lasciare traccia. Ed ecco che trovo la giusta metafora: l’ologramma. * Dell’ologramma il film ha la precisione e la nitidezza un po' sospette. In effetti, l’ologramma non è mai più o meno niti do: o è iper-visibile o del tutto invisibile. Non un'immagine che si muove ma un’immagine che appare solo se ci muoviamo. Un piccolo spostamento e non si vede più niente. In questo senso, le immagini sono nella realtà ma visibili solo a condizio ne di essere noi stessi parte della realtà: in quanto più reale di tutti gli altri (perché portatore di più contraddizioni), Chahine è il filo conduttore del suo stesso film. Non come fuori-campo privilegiato o voce-off, ma nel solo modo che per lui vale: attra verso il suo corpo. Da cui l'importanza del tema: il mio corpo risponde, io danzo, scopo, sto sveglio come un giovane uomo. Narciso schiavo perché obbligato a far sfilare intorno a sé i pro pri ricordi e ad animarli artificialmente con il "movimento della vita”.
* L’ologramma è onesto, perché? Perché non è monumentale, perché non resta. Flotta che brucia, museo segreto sventrato, gigante dai piedi d’argilla, beffarda Croisette: un vero odio per l’arroganza munumentale. E onestà storica: il ruolo di Chahine nel cinema mondiale è atipico, ciò che fa vale solo per lui. Il suo modo di richiamare il cinema, tutto il cinema, di conoscerlo a memoria, come Shakespeare, come una lingua che si è appresa e che sta diventando una Lingua morta, una lingua in cui ci sono Fred Astaire, il “peplum’’ e lui, Chahine, in Gare centrale, tutto questo è in effetti aberrante. Nel senso in cui Ruiz trovava il castello di Chambord sbagliato. Aberrante che un solo uomo non soltanto rappresenti tutto il percorso del cinema egiziano, ma che parli quattro o cinque lingue e sia abbastanza presente sul mercato culturale da non fermarsi là dove si è arrestato il cinema arabo: il discorso in prima persona singolare. Questa aberrazione lo rende nello stesso tempo ineludibile e poco amato da qualunque notabile che si rispetti. Gli arabi lo dete stano. Perché egli è libero e soprattutto perché ha i mezzi della sua libertà. 214
* La modernità di Chahine è conseguenza di un certo mestiere. Egli procede in tre tempi: 1) introdurre, con molta rapidità, un momento già rapido ed intenso in un’azione qualunque; 2) met tere se stesso, o piuttosto insinuarsi nel centro di questa azione; 3) condurre la scena fino al punto in cui essa, come per effetto del proprio peso, precipita in un’altra dimensione. Il mestiere consi ste nel non perdere tempo e nel raggiungere subito il climax. L’avventura consiste nell’esplorare l'altra china del tempo, quella che si biforca (un buon esempio: quando egli, durante la notte, si sistema per lavorare, insieme a Nadia: rapidità con la quale dispone tutto per terra e inizia a maltrattare la donna perché cammina a piedi nudi. Arte di tendere una rete a tutta velocità, salto mortale e arte di cadere in un’altra).
* Stranamente, ho pensato a Passion di Godard. Forse per via del “mestiere”. Cosa farne oggigiorno? Il mestiere — nel senso di rapidità di esecuzione — va perduto perché non si sa che cosa si "esegue”. Chi ce l’ha non ne fa niente. In Passion, Godard si con fronta con la pittura e decide di cine-materializzarne le figure. In questo film, Chahine si confronta col teatro. I due, in certi momenti, ci offrono l'immagine rara di un grande esecutore che, messo a confronto con le proprie decisioni e con ciò che esse "producono”, si blocca per un momento su un dettaglio (una donna) come se questo gli suggerisse un’altra idea per un altro film. Il documentario al centro dell’esperienza. * L’esperienza (Agamben). Il film è nutrito non tanto della vita di Chahine quanto delle “esperienze” per le quali egli è passato ne) corso di due anni, esperienze che può rifare, che può rivivere a condizione di far scivolare il suo corpo nelle stesse situazioni di prima. Oggi, questa idea di esperienza è la più persa di vista.
12/4 Bella sorpresa: DRUGSTORE COWBOY di un certo Gus Van Sant Jr. Piacere di vedere i film come andrebbero visti sempre: senza alcuna immagine prestabilita, senza niente a cui attaccarsi a prio ri, senza dover lottare sordamente contro un’"idea di partenza”. Immaginare un mondo alla rovescia dove il film potrebbe conta re su una settimana di programmazione prima di veder apparire le prime critiche. 215
* Il cinema americano, quando cessa di sentirsi investito della "responsabilità dell’anima”, riscopre con moka semplicità una verità inevitabile, quella dell’America di tutti i giorni, quotidia na, complessa. Fascino del piccolo film dovuto al suo modo libe ro di trattare le cose più gravi. In questo caso, la droga.
* L’intelligenza del film: non trattare la droga come un pro blema sociale ma integrarlo in una storia che in definitiva è la storia di droga di quello lì. Bob Hughes è uno strano eroe, che ha scelto la droga come sistema di vita, che ne sperimenta tutti i benefici e che smette, ma sempre per delle ragioni un po’ più complesse di quanto previsto. La droga è presentata come uno stato di grazia che a un certo punto, semplicemente, diventa mera fatica e paura. A partire da quel momento, il film può permettersi di essere naturalista, senza grandi concessioni. L’astuzia suprema sta nell’aver invertito lo scenario sociologico rimpiazzandolo con uno autenticamente romanzesco. Lo scena rio sociologico mostra come in certe classi della popolazione (giovani proletari), fatalmente, la noia dell’esistenza diventa così intollerabile da far sembrare la droga un paradiso artificia le. Lo scenario romanzesco fa vedere come un giovane capoban da drogato, a un tratto meno sicuro di sé, opti per una vita regolare diventando operaio, e come questo diventare normale si trasformi nel vero problema posto al film e a tutti quanti. In modo così efficace che la fine del film ci lascia in apprensione (ce la farà?). * Il film formula — a partire dalla droga — un’autentica teoria cinematografica. È, a grandi linee, l’intuizione di quanto sta per accadere, l’arte di leggere i segni (la superstizione), la pratica della biforcazione. Buona definizione del film che, giustamente, ha questa libertà di movimento.
13/4 LA VOCE DELLA LUNA (Fellini). Subito senza emozione que sto mammouth fìlmico, rabbioso e vociferante, ode al silenzio dedicata al rumore. Come E la nave va, che non mi è mai sem brato riuscito pur conservandone un vivo ricordo, questo Fellini colpisce ma fino a un certo punto. Impressione di essere al cen tro di una battaglia che infuria, ma con la certezza di passare "fra” gli spari. 216
* Mira. Forse il tema stesso (dalla Terra alla Luna), che non è più quello di saper prendere la mira (essendo la Luna il bersaglio tradizionale), gioca in qualche modo “contro” il film. I due film precedenti avevano un “bersaglio" (la tv) che permetteva loro di respirare. Questo è più folle. Lunatico. * Tele-mondo. «È un film sulla televisione, o più precisamente su ciò che essa ha prodotto: sugli effetti di sgretolamento di una realtà che non può più ricomporsi». In questo senso, è il seguito di Ginger e Fred, ma radicale. Il cinema non è più uno sguardo sul mondo (uno sguardo che prende di mira il mondo) perché fra lui e il mondo si è insinuata la televisione che, a poco a poco, lo ha divorato, stravolto. Fare cinema dunque significa osservare i danni, produrre le immagini di un mondo in cui “mirare" non è più richiesto. * Cine-mondo. Le vecchie analisi su Fellini ci consegnavano un mondo retto dal desiderio e un desiderio retto dalle figure più universali. Il piccolo uomo (virile) osserva una donna bella piena in una vetrina, il movimento diretto verso di lei — romantico o triviale — la trasforma in oggetto evanescente. La regolazione delie distanze è la sola prerogativa umana (e il ritornello musicale costituisce una distanza). Eppure P.B., fin da Amarcord, aveva ben rilevato l'antagonismo fra gli occhi e gli ocelli, una funzionesguardo diversa dall'esercizio dello sguardo.
♦ Pieno e vuoto. Il mondo felliniano era un mondo “bucato". Canali, tubature, con un foro ad ogni estremità. Uno per l'occhio, uno per l’oggetto visto e vistoso che si sistema all'altro capo: la donna, o piuttosto ciò che vi è in lei di lunare. Non la mezza luna, ma la luna piena, le forme piene della donna, le sue rotondità, il suo culo. La donna è un buco (concezione cattolica pura e dura, esasperatamente eterosessuale) ed ogni passaggio all'azione troppo frenetico da parte del piccolo maschio espone quest’ultimo al rischio di essere inghiottito da questo buco avido (la storia di Marisa e Nestore). Ma fin qui eravamo nella normale situazione di ciò che non ha mai “funzionato” (diciamo l’imma gine della Gradisca in Amarcord e il suo correlativo: la marionetta sessuale in Casanova).
♦ Catastrofe. Mi sembra che questo film sia il primo di Fellini dopo la catastrofe (ma già E la nave va finiva sulla guerra). E la 217
catastrofe consiste nel volere un mondo completamente pieno, un mondo che ha perduto l'intima regolazione di un corpo di piace re (Lubitsch): un corpo che si riempie e si svuota, indefinitamente. L’aspetto "naturale” del riempimento (dell’inquadratura, della scena, della scenografia) e dello svuotamento costituiva il fascino folle della Dolce vita: una, due, cento, mille persone stanno là, sotto la pioggia, per vedere i bambini miracolati. Oggi, questo non è più per niente naturale: la luna imprigionata crea un malessere incredulo. L’effetto di aspirazione è scomparso o fun ziona male (la gnoccata, la discoteca): non si evacua più. Il buco — teoria fognaria - ridiventa merda. * Mirare (bis). Il mondo pieno è quello in cui non manca nien te (dunque fine del desiderio, nient’altro che sensazioni), in cui tutto è ugualmente certo. È soprattutto quello di cui parla Virilio: non lo si lascia più (scopo), da esso non si parte più per ché tutto vi arriva. È proprio della televisione rovesciare la realtà su di noi, fare arrivare ciò che non è mai partito. In fondo, Fellini è stato l’apprendista stregone di questi movimenti che ha com preso meglio di chiunque altro: lui rivendicava il diritto di fil mare sia la partenza che l’arrivo, ma mai i due contemporanea mente. Ed ecco che il tele-mondo costringe a non filmare altro che degli arrivi.
* Catastrofe (bis). È, a grandi linee, il passare all'atto. Viviamo in un mondo nel quale non sappiamo più perché dovrebbe essere vietato passare aU’atto ma, non appena lo facciamo, ci sentiamo delusi, inquieti, proviamo amarezza. Si è parlato molto di "fanta smi”, a proposito di Fellini, ma è oggi che occorre ascoltarlo lamentarsi del risultato a cui conduce la reificazione del fantasma. Se il fantasma si reifica, per esempio se la luna è a nostra disposi zione, il suo biancore opaco e lattoso procura angoscia. «Perché sono sulla terra?» è il grido della delusione metafisica. Ed è per questo, per uscire dall’impasse, che l’uomo spara alla luna, facen dovi — alé! — un buco. Quel buco rende incompiuto l’altro, la fognatura (e anche i pozzi), quello che va nella direzione opposta, sotto terra. Ma allora in Fellini c’è qualche cosa di frattale: il movimento del “mirare” fa passare per dei micro e macro paesaggi attraverso un buco dal quale ogni immagine dipende. * Romania. Pensavo al dibattito in corso sulle immagini tele visive della Romania e alla deflazione che nasce dall’accresciuta 218
possibilità di essere in contatto con l'avvenimento, cioè dalla sen sazione di vivere l’impossibile sincronismo della sceneggiatura (lo scritto, nel senso di "era scritto") e del film. Sensazione che è solo un’illusione, ma della quale noi riteniamo responsabili le immagini e non la sceneggiatura. Ora, le immagini non hanno colpa se attraverso di esse si opera una manipolazione. Manipolazione ottenuta con la mancanza di montaggio, l’omis sione e, soprattutto, il commento. Ma l’immagine (in quanto registrazione di qualche cosa, sia pure di un simulacro) implica una parte di innocenza inevitabile. Spariamo alla luna perché ci fa una gran rabbia aver domandato la luna. Più il mondo è a nostra disposizione, più gli serbiamo rancore.
* Resta l’altra parte del titolo. Non la luna, la voce. Strano regolamento di conti da parte di Fellini con la musica, il suono, i rumori. Nei suoi film non c’è mai musica, drammatizzazione musicale, ma un ritornello (leggere Deleuze). Qui, anche il ritor nello è divenuto malefico (Sim — attore in La voce della luna, ndt -, tema spielberghiano rovesciato), i mormorii inquietanti, ogni suono una oscena fanfara (il rock fra gli altri). * Doppiaggio. Nel trattamento del suono che si fa in Italia, così diverso da quello francese, nell’evitare la presa diretta, si potrebbe vedere una forma di rifiuto del terrore (la morte) a van taggio di una non coalescenza corpo-voce, garanzia di libertà car nevalesca. Si direbbe che questa soluzione non regga più, che scricchioli. Che ogni voce, forzatamente separata dal corpo, pren da questo come bersaglio. In altre parole, non si mira più con l'occhio (guarda un po’ quella) e da questa catastrofe nasce l'orrore: si è presi di mira da delle voci. Anche la luna si rivela un personaggio pubblicitario che parla. Mi chiedo se nel sistema ctero-normale di Fellini essere presi di mira da delle voci non equivalga ad essere consegnati al desiderio dell'altro senza poter lare alcuna opposizione (gli occhi si possono chiudere, le orecchie no, vecchia storia). Il piccolo uomo è femminilizzato e la grande luna virilizzata? La catastrofe sarebbe questa passività, intollera bile per un italiano.
lìN PASSANT. Quando ho compiuto dieci anni, mia madre mi ha regalato un piccolo microscopio da studenti, tutto nero, capa ce di ingrandire cento volte (x 100). Con dei vetrini già pronti in una scatola rossa. Senza dubbio, questo fu uno dei grandi 219
momenti della mia vita. Rimasi tuttavia sempre incapace di pre parare io stesso i vetrini, dipendendo da altri. Cinque anni più tardi, era per me del tutto normale privilegiare i registi del “vedere", quelli che guardavamo vedere, quelli dell'inquadratura e delle sue avventure: Bresson, Lang, Mizoguchi, Hitchcock, Hawks. Le cose erano più complicate con quei registi per i quali l'inquadratura non era altrettanto importante, con quelli che inquadravano frontalmente: Walsh, Bunuel, Rossellini, McCarey. E lo furono ancora di più con quelli che prima di tutto “mostra vano”, che esibivano qualcosa, spesso se stessi: da Chaplin a Fassbinder. Detto questo, io credo che il cinema si riduca a due scenari di base: vedere e!o mostrare. Con tutti i casi intermedi. Langlois dalla parte di chi mostra, Godard da voyeur. - Vedere. - Vedere ciò che si mostra. - Vedere che si mostra. - Mostrare ciò che si vede. - Mostrare che si vede. - Mostrare. Il puro “vedere" è la scienza. Il puro “mostrare", la scena. Impurità da entrambi i lati. Da una parte un microscopio, dall'altra un riflettore. Stranamente (vedere Virilio), si potrebbe collocare l'elettronica nel primo gruppo ma con qualche incertezza: l'elettro nica può “far luce” su un recesso qualsiasi del mondo, senza luce del giorno o della notte, che resta l’ipotesi Lumière del cinema.
14/4 ROUCH, DE VISU. Perfetta esibizione di Rouch alla radio. Cose che infastidisce? Il discorso del maestro. Come Rohmer, egli trae la sua forza dall’aver tirato una croce sopra tutto ciò che non appartiene alla sua giurisdizione, ignorandolo con superbia. Così bene da apparire ora onesto e lucido, ora egoista ed elitario. Vecchio problema della Nouvelle vague: i primi ad aver smesso di pensare che era dovere di un cineasta andare al di là della pro pria esperienza sociale. A parte Godard che, per questo, non è un maestro, piuttosto un analista. Rouch - da buon maestro — non sa niente del “soggetto" o di sé in quanto soggetto (sottomesso al desiderio, all'errore, alla morte) o della verità del soggetto.
* Nel suo caso, “cinema-verità” va inteso nel senso di verità "documentaria”, da celebrare, commemorare, conservare, far tor 220
nate: dò che aiuta a negate il tempo fissando dolio dato sia a monte che a valle. Egli non crede alla storia, agli apparati, sa soltanto — esteta anarchico - che, più o meno, il tempo lineare si fende e ospita un momento irrequieto e violento di libertà disordinata e anti-autoritaria, e che di questo bisogna conservare la traccia e il ricordo, tessere i fili che, da qualche parte nel mondo e in disprezzo delle frontiere, formano la trama di una “internaziona le'* ludica e parassitarla. Il gioco come contrario del rito (vedi Agamben), ma qui come “rito nonostante tutto" (ed è quando tenta di ritualizzare il gioco che Rouch perde la testa, perché tenta di fare del Mauss o del Datai Ile senza che la “parte maledet ta" sia veramente tale - è al massimo un'insolenza con delle vie d'uscita garantite). * Forse la perversione di Rouch è l'aver barato con ciò che è fuori-legge nello stesso modo in cui altri, Rohmer, barano con la legge. Il maestro infatti non stringe alleanze, il che significa che ha bisogno di servitori, di “negri", di "complici”, di sottomessi dei quali sa molto bene che non lo valgono ma che finge di considerare come “fratelli". C’è un momento in cui Rouch è troppo dentro il cinema per non incontrare davvero delle forti personalità, ma in seguito egli sa utilizzare quello che i suoi complici - da Arnold a Fulchignoni — estorcono alle istituzioni di cui sono i parassiti. Altrimenti, (’“alleanza catartica” (si & un regalo al proprio |)eggior nemico e a partire da quel momento ci si deve assistenza) consiste nel modo di disinnescare la violenza dell’altro, di convi verci senza negarla né soffrirne.
* Come combattere il razzismo? Con un altro razzismo, più sottile e meno pericoloso. Per Rouch (“Arnold"...), ci sono due |>esi e due misure perché per lui esistono almeno due categorie di persone: la diaspora eterogenea di quelli che fanno parte della "società segreta” (i complici), e l’altra, ai cui componenti non è dovuta alcuna verità (il fine giustifica i mezzi). La società segre ta non è un complotto: essa vuole “manifestarsi” attraverso azio ni rituali precise e spesso bizzarre non tanto per contribuire ad una presa di coscienza della società normale (scenario militante), quanto per 1) rinsaldarsi, rinforzare se stessa, 2) fissare l’incon tro con futuro e passato, 3) esercitare un'azione magica. Essa dunque ha bisogno della società come luogo di iscrizione di ope razioni il cui scopo è un altro e come luogo da poter sfruttare e comandare a piacere. 221
* Dopo la trasmissione, parlo a J.R. di questo tabù ben custo dito: i rapporti feudali, violentemente non egualitari, fra africa ni, e gli dico che anche lui, su quello, non è stato davvero loqua ce. Ne conviene, come se si fosse trattato di una dimenticanza da parte sua! Interesse a conservare l’immagine di Un’Africa unica e mitica o di qualche “africano” particolare, Damouré, Lam (in Jaguar, ndt), e soprattutto interesse a non dire niente delle differenze sociali fra africani. Ma, dopo tutto, come avreb be potuto farlo Rouch, che partecipa e approfitta di questo siste ma? Il suo odio del sociale lo conduce, come me, verso il cosmo gonico o verso l’individuale: mai qualcosa di collettivo (a meno che non si tratti di un gruppo del quale si possono contare e riconoscere i membri). Perché allora avercela con lui? Senza dubbio perché ciò che è proprio del maestro è di essere il solo ad esserlo e perché la maestria non si comunica.
* Durante il programma ho una buona intuizione. I grandi “documentaristi” — penso a Flaherty, Ivens, Rouch — hanno un punto in comune: un certo stato di “felicità permanente", un fiuto particolare che gli permette di sottrarsi alle prove e di evitare il peggio, un egoismo efficace che, a un tratto, rivolge la propria attenzione verso gli altri ma che gli impedisce di accedere a qualsiasi sofferenza. È il segreto dell’alleanza IvensLoridain. Per il documentarista — in quanto possessore di que sta innata attitudine alla felicità che nello stesso tempo attrae e scandalizza gli altri — l’altro è sì follemente interessante ma non è mai un “alter ego”. Insomma, in questo cinema non c’è nessuna cura della verità e per questo il pubblico lo rispetta ma senza averne bisogno per vivere. Sempre per questo, Godard è con le spalle al muro: egli possiede un tale senso cri stiano della sofferenza, dell’obbligo e del peccato, una propen sione alla santità (fanti-elitarismo per eccellenza), che il docu mentario per lui non è altro che una velleità teorica. La cru deltà, ecco ciò che coglie il documentarista, ma la sofferenza appartiene alla finzione.
* Chiaramente, dietro tutto questo c’è il mio regolamento di conti con quelli della Nouvelle vague. È evidente che essi non sono “di sinistra” (ma senza dubbio neanch’io). È evidente che hanno fatto i “maestri”, sebbene in tono minore. E che sono più rimasti a lato del mondo di quanto non lo abbiano affrontato. 222
1. LA SCONFITTA DEL PENSIERO (CRITICO). Per quale motivo persone come me, critici di cinema, vale a dire eredi tar divi di un mondo di ombre e di luci, si ritrovano così rapida mente disoccupati, in prepensionamento o nella posizione di ultimi dei Mohicani? È un interrogativo. Perché ho smesso di giocare al critico cinematografico quando potevo scrivere quello che volevo su un giornale spontaneamente “cinefilo”? È il mìo interrogativo. Ricordo che lasciando i «Cahiers du cinéma» per «Libération», nel 1981, ebbi per la prima volta la sensazione che il discorso sulla “crisi del cinema” - che mi aveva sempre lasciato indifferente — avrebbe finito per diventare vero e che un conto alla rovescia era indubbiamente già cominciato. Era l'anno di Diva, un film che inaugurò in modo abbastanza rappresenta tivo gli anni Ottanta, a un tempo leziosi e miseri, in definitiva senza grandezza. Dal momento che erano molte le cose che non avevo potuto o saputo scrivere ai «Cahiers», gli anni di «Libération» dapprima furono eufòrici: recuperavo il ritardo verso me stesso, riutilizzavo in differita tutta l’esperienza - abbastanza radicale e ruvida degli anni Settanta. Ero favorito dalle esigenze del giornale, dalla sua intelligenza e dalla libertà di manovra che all’epoca consenti va. Ma, a poco a poco, sono anche diventato una sorta di coscien za morale della defunta critica cinematografica, malinconico, serio e brontolone. È diffìcile, in effètti, mantenere l’idea di un filo rosso, di un “seguito”, di una memoria nel mondo volonta riamente amnesico dei media. Ho cominciato a chiedermi - era il mio lusso — se il posto accordato al cinema nei media (soprattutto in Francia) non fosse più grande del bisogno reale di cinema nella vita dello persone, bisogno divenuto in definitiva abbastanza debole. Era l’epoca in cui si parlava della “morte del cinema” così come oggi si parla della “fine della Storia”. Quel che è certo è che i film, ormai da tempo, non provocano più “discussione”, lasciano poche tracce, e gli stessi cinefili hanno nei loro confronti una fedeltà disincanta ta piuttosto che una passione vissuta fino agli estremi. In breve, nell’espressione "colpire al cuore”, così tipica del cinismo di que 223
gli anni, è la parola “colpo" che conta perché quanto al “cuore", si tratta piuttosto di leucemia. Passata l'euforia, ho dunque continuato a parlare di cinema, ma tentando di metterlo in rapporto con qualcos’altro, in grado di prolungarlo o anche di negarlo (non avevo le idee molto chiare): la televisione, la pubblicità, la comunicazione, l’idea stessa di informazione, ecc. Occorreva fuggire dall’autocompiacimento stantio della “grande famiglia del cinema" e dalle cattive abitu dini dei parvenu della comunicazione catodica. Questo mi ha per messo di fare, giorno per giorno, delle piccole cronache diverten ti, di diventare al tempo stesso professionista dello zapping, cri tico di film “in tv”, osservatore dell’informazione televisiva, ecc. Era un andirivieni abbastanza particolare nel quale ho finito per trovarmi un po’ troppo solo. Quando non si appartiene alla fami glia dei premi “Césars” o “Sept d’or", le persone che invece ne fanno parte provano piacere nel farti i conti in tasca senza consul tarti, o nel metterti su un piedistallo in fondo al giardino, dove non va nessuno. È normale, perché ci troviamo in un periodo in cui le famiglie — tutte le famiglie — si vendicano degli ultimi vent’anni durante i quali sono state un po’ maltrattate. C'è comunque una cosa molto semplice che alla fine ho capi to: la critica è giustificata solo quando risponde a un desiderio, eventualmente quello dell’autore del film. Di fronte a un desi derio abbastanza forte (e il desiderio è sempre violento), il criti co deve rispondere «presente». È come nel tennis: non tutte le palle si ribattono, ma si è obbligati a rispondere alle palle di servizio. Ora, il fenomeno caratteristico delle nostre società è che la frontiera fra desiderio, capriccio, passione, hobby, gioco di società è in corso di ridefinizione. Molti dei film di oggi non nascono più dal desiderio di fare un film ma da quello di essere stato regista almeno una volta nella vita. E perché no? Io capisco che J.-P. Toussaint faccia Monsieur, ma non so più molto bene né come né perché io debba fare la critica di quel film, che non implica alcun “seguito” per nessuno. Il critico era necessario quando nella società c'era un luogo in cui la violenza, il senso, il bisogno di dire o di fare rappresenta vano come un nodo, un grumo. Ma questa necessità viene meno a partire dal momento in cui il "diritto alla creazione”, come dicevano i comunisti, è aperto e riconosciuto a tutti. Il critico dava notizie di certi viaggiatori ad alto rischio personale. Gente come Tarkovskij, Godard, Cassavetes, Fassbinder. Quando tutto questo viene rimpiazzato dall’autoprogrammazione turistica 224
dell’individuo, il critico non serve più a niente. Un film come L'orso non si rivolge alla critica cinematografica, esso istituisce un grande concorso il cui primo premio sarà il diritto di assiste re alle riprese del film, senza dubbio l’unica cosa avventurosa del progetto. Il critico è un traghettatore fra due sponde, quella di colui che & e quella di colui che vede ciò che è stato fatto. Ciò che occorre sapere è l’ordine delle priorità. Per me, il critico invia all’autore una lettera aperta che in seguito viene letta dagli eventuali spettatori del film. Il critico rappresenta dunque gli interessi di chi “fa” presso coloro che non fanno. Una specie di avvocato. Questo mi sembra normale e morale. Ma secondo altri vale il contrario: rappresenta gli interessi del pubblico presso colui che crea. È piuttosto un giudice. Qualcuno agisce sul modello dei critici della moda, che distinguono "ciò che è da portare’’ da “ciò che non lo è”. È la guida del consumatore, anche illuminata o che finge illuminazione, anche irriverente o che finge irriverenza (nello stile attuale di Lefort su «Libération»). Questo conduce rapidamente al puro e semplice conformismo lacchè, per definizione, tutto il pubblico, pur illuminato o adul to, desidera consenso. Ma oggi è forse più redditizio vedere in un film solo l’aspetto "fenomeno di società” e correre in soccorso di ciò “che funziona", con la scusa di aggiungervi il proprio sale in zucca che si suppone "personale”. Certo, quanto sostengo è molto discutibile. Significa non stare mai dalla parte del gruppo contro l’individuo. Ma credo che per il XX secolo la bellezza del cinema sia stata quella di essere una gigantesca macchina asociali che, paradossalmente, ha insegnato a milioni di persone a vivere con gli altri, dunque in società, ma senza mai dimenticare che al mondo non c’è solo la società. Invece, quando non resta altro che l'orizzonte sociale, quando il mondo è scomparso, ci si ritrova imprigionati nella mediocrità del villaggio globale e anche se questo villaggio è ultracomunicnnte, resta sempre un villaggio. E un villaggio non ha bisogno di critica, ha bisogno di imbonitori, di ultras, di guardie campe stri, insomma di televisione.
2. IL CREPUSCOLO DEL CINEMA. Quando ero bambino, negli anni Cinquanta, all’inizio dei "gloriosi trenta”?0, il cinema era il lusso dei poveri. Ci diceva che eravamo poveri e, nello stes so tempo, ci mostrava i ricchi. Era un’arce strana, e forse nemme no un’arte, ma certamente un momento unico nella Storia: il giu 225
sto mezzo fra l'ombra e la luce, l’individuale e il collettivo, un’arte popolare e d’élite, la prosecuzione e la fine del XIX seco lo, con da un lato l’aspetto “scienza per tutti” e dall’altro i corpi provenienti dal circo. Il cinema ha molta difficoltà a seguire l’epoca attuale che egli stesso ha in parte voluto e nutrito. Forse è normale. L’individuo moderno vive in una società di “eccesso di offerte” e il cinema è soltanto una delle scelte possibili, prestigiosa certo ma un po' troppo pesante. Le società moderne sono diventate organismi labili, trasparenti a se stessi e il "sociale", grazie alla respirazio ne artificiale dei sondaggi, è ciò che noi consumiamo, fetta dopo fetta. Per quanto riguarda l’accostamento alla verità degli esseri e delle cose, l’arte ha cessato di rimpiazzare la religione. Così, da un lato l’arte torna ad essere decorativa, dall’altro la religione rivendica il suo vecchio ruolo in forme anch’esse post moderne (netv-age, tele-predicatori, integralismi vari e altre bas sezze). Il cinema era un modo collettivo di accamparsi tra fede e credenza, senza troppo struggersi nella fede e senza troppo abbrutirsi nelle credenze. Naturalmente, è stata la televisione che, nel corso della sua resistibile ascesa, si è vista obbligata a distruggere tutto questo. Il viaggiatore attento è roba di ieri. Oggi c'è il turista disincanta to. Basta prendere la Parigi-Dakar: ci fanno vedere qualche boli de rombante in mezzo al deserto e ci dicono: ecco, la prova che questa corsa esiste sta nel fatto che voi ne vedete qualche fram mento alla televisione, credeteci sulla parola ma non fate doman de sulla storia del bambino africano schiacciato, su Sabine padre e figlio, sul piccolo appassionato che risparmia tutto l’anno pur di partecipare: queste esperienze non devono più essere comunicate. Così, quando rivedo un vecchio film sulle corse d’auto come Uurlo della folla, con James Cagney, realizzato da Hawks negli anni Trenta, mi è ben chiaro come in esso fosse ancora presente un patto con il pubblico dell’epoca: Hawks, che faceva il pilota, tentava di trasmettere - attraverso il cinema - un po’ della sua esperienza. Era questo (’“accesso al mondo”, l'idea che le espe rienze, per quanto lontane, sono ugualmente comunicabili. Oggi, la sola esperienza che ci comunica la tv è quella del turista americano dentro la sua auto con finestrini fumé e aria condizio nata. Va bene, ma è un po’ poco ed è roba da CNN. 3. LA RAGAZZA, IL SUO MAGNACCIA E L’INGENUO. Mi si dira che i media sono i principali promotori del cinema. Non 226
proprio. Per funzionare, i media hanno bisogno di un "Signore”. Ci vuole un "Signor Libri”, un "Signor Meteorologia”, un "Signor Succo di pomodoro”, un “Signor Cinema”. Quando hanno il loro ometto, debitamente addestrato, tanto basta. Ricordo Godard che rimproverava a Claude-Jean Philippe di ridere sempre presentando i film in tv. Come se il cinema fosse una cosa talmente irrisoria, minore, futile da rendere obbligatorio dimenarsi sul proprio sgabello sotto lo sguardo ironico di Pivot*1, tanto convinto della propria superiorità da essersi sbaraz zato in fretta di quell'oggetto ingombrante che è “l'amore per la letteratura”. E io provavo vergogna per noi, ex topi di cineteca ormai definitivamente impresentabili di fronte alla gente norma le (e chi è più “normale" di Pivot?). Perché questa vergogna? Perché c'è una cosa che è tabù alla televisione e questa cosa è la familiarità con ciò che si ama e si conosce, l’idea che quando si ama e si conosce bene una cosa, si ha la possibilità di parlarne in modo giusto. Questo è particolar mente grave per il cinema che — in Francia soprattutto — non avrebbe mai potuto formare una cultura se non avesse alimentato una vera tradizione oralet una delle poche ancora esistenti. Come il sogno, la poesia, come tutto ciò che distilla tempo, il film è diffi cilmente riassumibile, dunque mediatizzabile. Questa tradizione arrivava ad inventare, a vivere come allucinazioni inquadrature e scene intere, ma preferiva sognarle collettivamente che ri-visio narie in modo solitario su una videocassetta. Le cose non migliorano. Oggi possiamo dire che Philippe è stato un’utile figura di transizione ma, considerando il modo in cui la televisione si evolve, credo che essa farà presto a meno di simili traghettatori e utilizzerà piuttosto il suo personale “di casa” - vale a dire gente ignorante - per coprire tutto. E tanto meglio quanto più essi saranno ignoranti, perché la loro ignoran za sarà la stessa di quella che si suppone del pubblico. Ho detto bene: «che si suppone», perché alla fine i presentatori vedette sono come dei magnaccia che riscuotono percentuali calcolate in base alla supposta soddisfazione del cliente, soddisfazione della quale non sanno niente (conoscono solo gli "indici di gradimen to"). È la ragazza a sapere, ma lei non parla più, altrimenti viene eliminata. Ebbene, questa ragazza — che porta i segni dell’antica bellezza e del vecchio talento — non è altri che il cinema e ormai serve solo ad adescare il cliente per condurlo verso la vetrina della boutique audiovisiva. E quando egli è entrato, non lo si informa, non gli si parla più di cinema, gli si vende un’altra cosa. 227
4. L’ARTE È MORTA, VIVA LA CULTURA? Forse, noi ci tro viamo alla fine di un processo, una sorta di braccio di ferro fra l’arte e la cultura iniziato nel corso degli anni Sessanta e che, nel 1968, molte persone della mia età hanno vissuto in modo attivo e ambiguo. Si considerava l’arte una seconda religione, ben supe riore alla religione tradizionale in quanto molto più capace di emancipare e si vedeva nella cultura un’attività di recupero di tutta l’emancipazione dovuta al Capitalismo. Nello stesso tempo, strana contraddizione, si sosteneva per tutti il diritto di accedere ai beni culturali. E alla fìne, la Cultura ha vinto e, sulla scorta dei Barthes e dei Bourdieu, schiere di semiologi, sociologi, animatori culturali, giovani rampanti, pubblicitari ed esperti di comunicazione si sono messi a disseminare di segnali il campo economico della cultura. Questo ha determinato lo sviluppo esplosivo del “merca to dei beni culturali”, come si dice con espressione orribile, e l’apparizione di questo nuovo eroe dei nostri tempi: il consuma tore. Non colui al quale dev’essere trasmessa un’esperienza, ma colui al quale si chiede soltanto di acquistare e che, nel migliore dei casi, può essere guidato nella gran massa di beni di consumo. Ciò che è vietato è mettere in discussione la reale "libertà di scel ta” del consumatore, ipotizzare che, dietro la finzione di cin quanta milioni di consumatori unici e singoli, continui ad esiste re (e a provocare in tutti insoddisfazione e malinconia) un auten tico, quantunque stagnante, conformismo.
5. L’IMMAGINE AMNESICA. Torno a quell'idea di “esperienza” che trovavo piuttosto antiquata quando ero più giovane e che per me ha ripreso importanza. La domanda che bisogna porre alle forme dell’espressione audiovisiva è: «cos’è che possiamo condivi dere con i personaggi?». In vita mia, non ho mai imbracciato un fucile ma, a forza di vedere dei polizieschi, ho un’intuizione abba stanza precisa dei momenti in cui “si deve fare proprio così” e dei momenti di evidente finzione, di stilizzazione. Il cinema mi ha regalato una seconda esperienza, né del tutto concreta, né del tutto onirica, che mi permette di distinguere fra il mentire-vero e il mentire-fàlso. Il cinema è dalla parte del mentire-vero, la televi sione da quella del mentite-falso. E sapere quando qualcuno ci sta mentendo è forse la condizione minima per essere definiti spetta tori. Non è sufficiente, ma è necessaria per farci rimanere umani. Ora, una delle esigenze di una società individualista fondata sul mercato è che le esperienze restino una proprietà personale, 228
patrimonio del singolo, e che questi non debba giustificarsene pubblicamente. Da un lato io, in quanto critico, non ho più il diritto di lamentarmi del diffuso ornamento decorativo dello spa zio pubblico; daU*altro, non ho neppure il diritto di intrometter mi nello spazio privato delle "esperienze personali”. Tuttavia, guardando Le grand bleu io non vedo il mare ma un concetto pubblicitario del mare, che lo ha definitivamente rim piazzato. Nello stesso tempo, quando Besson mi vende — pubbli citariamente - l'idea che lui si è immerso di persona e che è stata un’esperienza straordinaria, io sono tenuto a credergli sulla paro la. Al limite, la vera critica del film è rappresentata dall’elenco dei club di immersione in apnea. Si potrebbe dire: ecco qui gli indirizzi, andate, vi divertirete un sacco, noi non vi diciamo niente. Del resto, la tipica frase dei ragazzini di oggi è: «non ti dico...!», che in apparenza vuol dire: «potrei parlartene per ore» ma in realtà esprime bene questo: niente più racconto, niente più condivisione attraverso il racconto, attraverso il cinema parlato. Allora, la famosa “crisi della sceneggiatura” con la quale ci rom|x>no i timpani sta lì: nella privatizzazione dell’esperienza e nell’afa sia che essa determina, soprattutto nei giovani.
6. LA STORIA MUTA. Strano paradosso. Da un lato, la storia del XX secolo si confonde con la storia del cinema. Dall’altro, la storia del cinema comincia a non poter più essere raccontata. Ora, nonostante enormi lacune e profondi impasse, qualcuno come me poteva ancora — sebbene in extremis - avere la sensazio ne che questa storia fosse cominciata con i suoi nonni e che essi fossero ancora vivi. Mia nonna mi ha sempre parlato di un feuil leton del muto che, quando era bambina, l’aveva lasciata impie trita e che io ho finito per attribuire a Feuillade. Quando si anda va a Chaillot, da Langlois, andavamo forse a sognarci una storia ideale ma, nello stesso tempo, sognavamo anche quella di due generazioni prima di noi. Oggi questa storia è altrettanto pesante da sostenere quanto il secolo che sta finendo — e finendo, con i suoi milioni di morti, un po' alla “si salvi chi può”. Così, ben si comprende come la televisione, che ha cinquantanni, non giochi alcun ruolo nel processo di formazione di una qualunque memo ria collettiva. Così, accade che gli studenti universitari di cinema vadano pressoché supplicati di andare al cinema ogni canto, giu randogli che non se ne pentiranno. Qualcosa si è rotto nell’idea stessa di trasmissione, e non soltanto nel cinema. Prova ne sia che la grande tradizione francese della critica d’arte, iniziata nel XVIII 229
secolo e da allora mai interrotta, sembra stia venendo meno. È la tradizione dell’artista-critico, che va da Baudelaire a Berlioz, Delacroix, Proust, Malraux, Breton e che nel cinema è arrivata fino alla Nouvelle vague: Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette, ecc. Loro devono essere stati gli ultimi perché noi, anche se abbiamo tentato di proseguire degnamente su quella strada, non abbiamo aggiunto niente di decisivo a quanto già detto e oggi è ancora Godard l'unico che tenta di proporre una sconvolgente “Storia del cinema e della televisione” che non interessa a molti. Forse tutto ciò costituisce un peso eccessivo? Da qualche tempo, assistiamo in Francia alla ricomparsa del tipo di regista che non parla, non teorizza, non scrive e di questo va Gero. A me, questo elogio della lobotomia, nel paese che è stato la patria del talento critico, non dice niente di buono. 7. L’IMMAGINARIO OCCUPATO. Il cinema francese non è il cinema americano. È un cinema in cui la riflessione fluisce sem pre per prevalere sulla pratica. È così. Ed è proprio per questo che in Francia il cinema d’autore ha potuto resistere più a lungo al mercato internazionale. Oggi, ho piuttosto la sensazione pensate alla guerra del Golfo — che il mondo dell’immagine sia com pletamente caduto nelle mani del potere e nel desiderio di sottomissione ad esso. Oggi, qualunque tipo di potere (economico, militare, sportivo, religioso) ha la “propria visione” delle cose, e questa visione altro non è che un’immagine sottratta a qualsiasi rischio di incontro con l’esperienza dellW/ro, chiunque egli sia. Evidentemente, ci sono delle magnifiche resistenze, piccoli film (Ricordi della casa gialla) e anche grandi (Ilpadrino-parte IH), dei quali non si parla più. O se ne parla male, come fanno le nostre pedanti consorelle di Téléramucha (nomignolo per «Télérama», ndt) o di «Le Monde», con i loro turbamenti da signorine Verdurin impegnate a proteggere il coraggioso cinema d’autore nello stesso modo in cui si piange sui Curdi ripresi in tv. Ma in fondo è normale che in periodo di occupazione non si parli di chi resiste. E i media sono l’occupazione. Un’occupazione molto soft, assai tollerabile, che consiste nell’invadere gli schermi e le persone, nei metterle su un binario morto. Ricordando comun que la sola Occupazione che la Francia non ha mai dimenticato, quella del ’40-’45, che ritorna da ogni parte, nella sua forma "terza età" con Uranus, in quella "arte moderna" con Merci la vie, e in quella "look post-moderno” con Delicatessen. Non si può dire che tutto questo faccia venir voglia di esultare. 230
Il pezzo dedicato a Uranus, su «Libération», lo avevo scritto un po’ per divertirmi, per ricordare su questo giornale che era ancora |x>ssibile fare il proprio mestiere di critico cinematografico indi pendente. Sono stato un ingenuo. Non ero sorpreso dalla debolezza del film, ma esso rimetteva in circolo delle questioni con le quali la gente della mia generazione non si è mai del tutto riconciliata, pur trattandosi della biografia dei loro genitori. Storie di lutto, più o meno. Ancora una volta storie di trasmissione, e di trasmis sione attraverso il cinema. Perché il cinema non è un’arte come le altre. È la sola in cui un cineasta, quando ne ammira un altro, può chiedergli di venire a recitare in carne e ossa nel suo film. Quando Godard, che ha compiuto per primo tutti i passi decisi vi, chiama Fritz Lang per II disprezzo, quello è un momento straordinario (19631). Quando Bertolucci vuole il vecchio Sterling Hayden per Novecento (1972), è perché desidera la prova vivente di Johnny Guitar e del maccartismo. E Wenders, che nel 1930 (Nick's movie-Lampi sull’acqua) accompagna Nicholas Ray alla morte, chiude il cerchio. Tutto questo vuol dire che il cine ma ha un rapporto assolutamente originale con la filiazione, e se questo rapporto si interrompe, come accade oggi, anche il cine ma rischia di finire, rimpiazzato da un giorno all’altro da imma gini di un altro paese, da una visione prodotta geneticamente. Allora, amare il cinema significa amare l’idea di usare sempre dei corpi che sono già stati usati, che sono esistiti per altri. C’è forse una contraddizione insanabile fra le esigenze del mercato (che vuol fare di noi gli unici proprietari della nostra vita) e quel le del cinema che ci impedisce di avere il monopolio di ciò che filmiamo e di ciò che vediamo.
231
IL PERIODO NON LEGGENDARIO DEI «CAHIERS» (in preparazione del cinquantesimo anniversario) 1. Per lungo tempo ho conservato un fascicolo ciclostilato di "testi interni" prodotti, fino alla metà degli anni Settanta, da quei gruppi, circoli e nuclei militanti che i «Cahiers du cinéma» volevano allora "organizzare” in un fronte culturale rivoluziona rio. Si trattava di un povero insieme di critiche, autocritiche, andirivieni dalla teoria alla pratica, piattaforme, bilanci e citazio ni, risposte e buoni propositi, un po' sul modello cinese del "per fezionamento individuale” (linea Liu Shaoqi). Ero stato troppo vicino a tutto ciò per non trovare quei testi buffi, un po’ come si possono trovare buffi i film di GodardGorin dell’epoca (gruppo Dziga Vertov). Li conservavo con l’idea vaga di farne, un giorno, una commedia. Quale commedia più bella, infatti, di quella dell’ideale? Quale scacco più patetico di quello del militante, questo essere fragile che regolarmente si ritrova fregato e intento a lamentarsi e, quel che è più grave, spesso con le mani sporche di sangue? Quale cast di attori più spassosi, proprio a causa della loro serietà, di quello che hanno saputo filmare Oshima, i Taviani, Kramer e naturalmente Moretti? E, infine, quale compagnia più buffa di quella dei «Cahiers» anni Settanta, abbastanza “folle” per diventare grup puscolo, ma anche abbastanza scaltra da farlo in modo da per mettere a ciascun membro di sciogliere le proprie contraddizioni in quelle degli ultimi ribaltamenti parigini dell’idea comunista? Non avevamo forse deciso, un giorno, ai «Cahiers», di retribuirci secondo i principi della fabbrica modello di Da Zhai, vale a dire in base "al merito”? Mi ricordo anche di essermi assegnato 900 franchi (dell’epoca).
2. Il tempo passò e io persi il fascicolo. In ogni caso, chi avrebbe riso di quegli eccessi? Non noi, che, uno per uno, eravamo impe gnati a salvarci la pelle, e senza ridere tanto. Non quelli che, dopo di noi, fecero e avrebbero fatto i «Cahiers». Era prima che bisognava ridere, anche ridere amaro, anche da soli. In verità, l’impagabile serietà del teatro politico francese, il suo drappeg232
giarsi in abiti rivoluzionari e/o snob, decisamente non era un soggetto da commedia. Avrei dovuto saperlo, io che, nel 1968, sebbene non amassi il teatro, avevo fatto parte del comitato che "prese” l'Odeon (del resto spalancato). Ed è anche vero che quella generazione dei «Cahiers» non era davvero una generazione di cineasti e, più in generale, che le star sessantottine non avrebbero creato grandi cose, se non del savoir-faire comunicativo. La verità, infine, è che noi non abbiamo fatto altro che rivivere, in extremis e in vitro, il remake personale delle grandi passioni stantie che il PCF gestiva da cinquant’anni (il PCF era allora davvero stanco ed è per questo che ce l’abbiamo tanto avuta con lui). Dai colpevoli piaceri della cattiva fede all’utopia della con tro-società già realizzata nel gruppo, dai riti di esclusione al lin guaggio propagandistico: noi non abbiamo inventato niente. Tutto ciò non è durato molto (’72-’74) e non ha fatto molti morti. E ci ha perfino induriti («Occorre che il cuore si spezzi o si indurisca», diceva Corneille). 3. Quando, in occasione del 40° anniversario della vecchia rivi sta, mi è stato chiesto un testo su quegli anni, gli anni “non leg gendari” (per non dire “vergognosi”) della storia dei «Cahiers», prima ho detto sì, poi no, poi di nuovo sì, poi mi sono riletto tra sversalmente ottanta numeri e ho deciso di fare quello che si fa sempre in questi casi: un dizionario ellittico e divertente. Mi ci sono messo, ma non l’ho trovato così buffo. Non è focile infatti rispondere a una domanda (sull’eredità di quegli anni Settanta) che non viene posta da nessuna parte; ancora meno focile è conti nuare a dire, vent’anni dopo, "noi”, e di continuare a dirlo “io”. Li storia della quindicina di persone che per dieci anni hanno fatto dei «Cahiers» il loro salvagente, il loro scalpello e il loro lutto sarà lo storico (sarà Antoine de Baecque), se vuole, a raccon tarla. Quanto a me, se il presente testo è ancora scritto all’inse gna di un introvabile “noi”, che lo si prenda piuttosto come il mio estremo saluto alla prima persona plurale. ■1. E oltretutto c'è da considerare l’aria che tira. Recentemente, vedendo in televisione il pedante B.H.V. seppellire un secolo di maitre à penser dell’intellighenzia francese, sono rimasto atterrito da come, una volta di più, i quarantenni mediatizzati della mia generazione si comportano male quando devono promuovere pubblicamente una certa immagine di loro stessi intenti a "pen sare”. Gettar via il bambino con l’acqua sporca è una cosa, ma 233
che ci si arrampichi sulla vasca da bagno per passare in televisio ne e dire che non ci si è accorti di niente, questo è troppo. Da Lacan a Barthes, da Bataille a Foucault passando per Althusser, di tutto ciò gli anni "non leggendari” dei «Cahiers» recano l’impronta e non mi sembra che quel contesto teorico, con le sue seduzioni e la sua ferocia, non possa dirsi rimpiazzato da un altro, che è più normale e brioso, ma sempre più sconsacrato. È per questo che quando rileggo i «Cahiers» degli anni Settanta resto colpito non tanto dal gergo, dalla boria, dalle paro le d’ordine, dall’impaginazione non sempre bella, dalla carenza di foto e dall’eccesso di virgolette, grassetti e corsivi, quanto dalla convinzione (che vi si coglie e che mi manca) che il cinema fosse qualcosa a cui valeva la pena di pensare e di pensare profon damente. Allora, non mi va più tanto di scusarmi se in qualche caso, quindici anni fa, noi abbiamo un po’ trasgredito le buone maniere dell’arrivismo borghese. Per la prima volta, avrei piutto sto voglia di difendere la causa.
5. Perché quell'epoca è così difficile da comprendere? Nel 1970 venne pubblicata una lunga serie di articoli in cui ognuno espresse una densa e pensosa riflessione sul film di Jancsó Fényes Sztlek. Ora, non sono tanto quei testi ad essere scomparsi quanto i film che ad essi servivano come pre-testo comune. Chi si ricorda, infatti, dei film di Jancsó? Esistono al di fuori delle enciclopedie di cinema? Il problema è evidentemente più generale: la libertà del tono, il folle andamento del racconto, l’indifferenza garbata ma totale per il gusto del pubblico e il numero di spettatori, il desiderio di traccia re, con le buone o con le cattive, un percorso capace di allontanare il cinema dalla strada su cui lo aveva mantenuto il cinema ameri cano: tutto ciò non era rappresentato soltanto da Jancsó ma da tutti quei “nuovi cinema’’ mondiali degli anni post-Nouvelle vague. Un continente del quale non resta pressoché nulla. Ecco perché gli anni Settanta stanno in purgatorio: la maggior parte dei film che ci indussero a scrivere non si trovano più né nei ricordi, né nelle videoteche, né nei discorsi dominanti. Avevamo pensato a tutto tranne che a questo: quei film potevano scomparire. 6. Che il cinema non sia più là dove noi l’avevamo trovato, vale a dire “al centro del mondo”, non è per forza triste ma non è comunque una cosa da niente. A rileggere i «Cahiers» non leg gendari, ho la sensazione che noi fossimo come quelli che avendo studiato il latino, non sopportano, stizzosi zucconi ed eterni primi 234
della classe, che esso diventi una lingua morta, una cosa del passa to. Il cinema come arte del presente è, a grandi linee, ciò che dice va Bazin, e ci sono degli assiomi che, nel corso di quei dieci anni, si ritrovano dietro tutte le firme, dietro tutte le imposizioni teori che, in tutte le pubblicazioni e sotto tutte le vesti, fossero gli stracci del cinema militante o l’uniforme unisex della televisione corrente. E l’assioma «Cahiers» era che il cinema ha a che fare con il reale e che il reale non è il rappresentato, punto e basta. E che il reale non aspetta. E che il tempo non è dato ma occorre inventarlo, costruirlo, guadagnarlo. Anche il tempo sbilenco della rivista, quando Toubiana e io ci chiedevamo con gravità se aveva mo abbastanza cose "nostre” per far uscire in fretta un numero semplice o se non fosse meglio aspettare un altro mese e Gire un numero “doppio”. E nello stesso tempo, quando usciva un film inatteso che ci piaceva, si ricominciava daccapo, si rivedeva la teo ria, la grammatica, si lanciavano nuove parole d'ordine e si trac ciavano nuove linee, perché bisognava che da un lato ci fossero Straub, Godard, Syberberg o Kramer, e dall'altro, come sempre, Lang, Hitchcock, EjzenStejn e Rossellini. Tutto ciò sta a significa re un funzionamento caotico, un andirivieni non molto aggraziato in cui le rivelazioni erano sempre dirompenti, la nuova direzione subito impedita da linee di fuga, il tempo di darsi una calmata regolarmente mancante e l'impazienza un destino comune. 7. Grazie alla prospettiva storica, si vede chiaramente come, anche per quanto riguarda i «Cahiers», il decennio risulti diviso in due: prima e dopo il 1973. Fino al 1975, è alla politica che si crede di dover rispondere «presente». Ma dopo? Dopo la politica passa, il presente resta. Soprattutto alla luce della guerra del Golfo, non trovo indegno il nostro numero speciale Image de mar que WIG)* né i primi scritti sulla televisione (che graziosamente chiamavamo «segreterie telefoniche») e sul passaggio dei film in tv, né i pezzi di Rancière sullo spirito "programma comune” nel cinema, né la riflessione sulla cinefilia: tutto rientrava sempre in quell'idea del presente e, in definitiva, del giornalismo. Ed è senza dubbio per questo che non riesco a scrivere questo testo "al passato”. Perché anch’io ho dovuto rispondete «presente» quan do, alla fine del '73, la rivista fu abbandonata nelle mani di chiunque avesse voluto raccattarla. Per sette anni mi sono sentito come quegli eroi del burlesque che, non avendo neppure il bre vetto da pilota, tentano di atterrare con tutto il carico, senza per dere né dimenticare niente. 235
8. Ma c'erano anche dei lati buoni: noi non credevamo troppo alla divisione del lavoro, sapevamo che spesso i grandi registi avevano scritto ed eravamo felici di trasformare Duras, Godard e Syberberg in "caporedattori” dei «Cahiers» per il tempo di un numero. Le alleanze avevano vita difficile e, più di tutte, quella fra l’immagi ne e lo scritto, che era la nostra ragion d’essere, niente di meno. I «Cahiers» non leggendari si volevano scritti, e spesso lo erano. 9. Occorre infine tenere presente che quello fu un periodo duro. Gli anni Sessanta erano stati anni di grazia, gli Ottanta sarebbero stati anni di abbondanza, i Settanta furono duri e di vacche magre. Si avvertiva ovunque un furore aspro e un accanimento che nessuno pensava potesse essere terapeutico. In Francia, l’àge d’or della Nouvelle vague era dietro le spalle e pesava su di noi. Altrove, cerano dei personaggi intrattabili, terribili: Fassbinder tiene duro, Pasolini viene assassinato, Oshima eccita e stupisce, Cassavetes resiste in un angolo, Ferrari fa digrignare i denti, Syberberg provoca aspramente, Godard continua recto tono e lei et ailleurs credo sia il film che ho mostrato più volte (da New York a Damasco, da Oporto a Bruxelles). Non è difficile datare fra il '73 e il ’75 la cesura del decennio. Crisi del petrolio, inizio della disoccupazione, fine del FORTE*2, ritorno del consenso (non ancora "molle”) e, nel cinema, della Qualità Francese, dei professionisti con i loro Cesars: obiettiva mente non era un periodo allegro e c’era delta rabbia in giro. Anche il cinema, simile ad un battello che gratta il fondo del fiume, doveva aver toccato un limite e noi, nel nostro gergo par ticolare, lo abbiamo rilevato. In seguito, sotto la sorveglianza dei media, il cinema da un lato si è rifatto un corpo di leggenda, dall’altro si è trasformato in supplemento d'anima. È la storia degli anni Ottanta. Nei Settanta, noi fummo quelli che (lo chia mavamo materialismo) si sgolavano a dire che quest’anima aveva (avuto) un corpo, noi lo sapevamo. In tal senso, i «Cahiers» non leggendari assomigliavano al loro tempo che, della leggenda, se ne infischiava.
18/4 IL "PUBBLICO". Vecchia idea forse terrificante. Un’opera “consiste” non solo perché incontra un pubblico immenso, ma per il fatto che non sarebbe stata possibile se non avesse avuto un vero destinatario. Un destinatario “vero” dà 236
all’opera una forma propria (per questo accade che si continuino a leggere delle corrispondenze mentre molti bestsellers sono dimenticati). Dunque, ciò che fa consistere è il dialogo. Esistere dipende dal fatto che il dialogo avvenga con il maggior numero possibile di destinatari viventi e simultanei. Quello che si chiama successo commerciale. In altre parole: l'opera è una bottiglia nel mare che inizia a navigare solo perché da qualche parte c'è qualcuno in mancanza del quale non sarebbe stata lanciata. Richiamo: aneddoto di Silvina Boissonas. Io dubito che, per ciò che attiene alla finzione, si lancino real mente delle bottiglie in mare (il fatto stesso di "raccontate una storia" implica il rischio di non essere immediatamente ascolta ti), ma per quanto riguarda il documentario e tutte quelle forme che non siano narrazione pura, è un altra cosa. Per esempio, è chiaro che Rouch si serve del cinema non per offrire delle immagini e dei suoni "a chiunque e per ogni eve nienza" ma per tutt’altro scopo. Riguardo ai vivi: conservare, ali mentare una società segreta di "compagni" disparati, unici eroi, pubblico e beneficiari del film. Riguardo ai morti o ai non ancora nati: fissare con essi una data e un linguaggio, lasciargli come dei sassolini, scrivere per loro la versione ufficiate delle cose, quella che oggi appare confusa. Parlare del mito in quanto esso permet te di uscire dai tempo, e dalla nozione di "pubblico”. La stessa cosa vale per gli Straub se è vero quello che dice Marco M.: a Rotterdam, essi avrebbero dichiarato di fare film per t morti. Il pubblico più numeroso, ever. È necessario che, se non materialmente, almeno strutturalmen te "un" vero destinatario esista.
Se tu hai fatto il film per un misterioso signor “x”, questo dà a me il diritto e il desiderio di guardarlo, benché sia chiaro che il film non ha bisogno proprio di me, perché io appartengo alla stessa specie di "x": l’umanità. Tale sarà lo strano posizionamento che quei film (quelli del “vedere” piuttosto che del "mostrare”) determinano. Tanto più strano per il fatto che tutto funziona anche nell’altra direzione: un cerco B movie americano, davvero non facto pensando ad un intellettuale parigino, proprio da quest'ultimo viene adottato, indipendentemente dal suo succes so di pubblico. 237
28/4 PUBBLICO (seguito). Rohmer, molto gentile, alla radio. La niti dezza delle sue idee è di grande aiuto per noi che stiamo sempre lì a rimuginare. Per esempio (a proposito del film di Biette) l’idea che i film devono continuare ad essere fatti e dunque ad avere una possibilità di essere visti. E che dovrebbero essere visti perché trasmessi dalla televisione (vero servizio pubblico) o su videocassetta. La mia vecchia idea che i film fatti “comunque” per la sala risultino sbilenchi, strani quando su di essa non posso no contare, Rohmer proprio non la sottoscrive. Neppure se si tratta di Chariot! Lì si trova l’idea di base della nostra cinefilia. Esiste solo ciò che è materialmente inscritto una volta per tutte su un supporto che, al limite, può anche cambiare. Si tratta di una concezione a un tempo ontologica e strutturalista! Ciò che è stato prelevato, registrato una volta per tutte ha la sua identità anche in quanto sistema. Per questo E. R. ha potuto scrivere sul Faust di Murnau quell’analisi "in-sé”. Ed è questo corto circuito che, in fondo, mi piace in Rohmer. Da un lato, c’è soltanto la verità della registra zione (presente assoluto), ma dopo, ciò che è stato registrato si mette a significare, a creare riferimenti, a storicizzare. I! colpo di dadi è immediatamente seguito dal sistema di combinazioni (vecchio discorso della “differanza”^). È sufficiente che la regi strazione sia stata “pura" (fuori dal senso, dal voler dire) perché le sue tracce fossilizzate funzionino come testimonianze, anche se non si sa niente del pubblico che verrà e dei suoi criteri, anche se le condizioni materiali di fruizione dell’opera saranno cambiate. È un grazioso gioco di prestigio, fatto come se niente fosse. Rohmer (come Straub) è elitario non perché vuole nutrire un piccolo pubblico reale ma marginale e ricondurlo dentro i suoi riti, ma perché egli pensa che il grande pubblico attuale è dav vero poca cosa di fronte a tutti quegli spettatori che gli altri media possono garantire al suo lavoro. Il ragionamento che si poteva fare solo per una parte del cinema varrebbe ora per tutto il cinema: elitario sarebbe riempire solo le sale cinematografiche, che sono meno accessibili, meno pratiche della televisione e dei videoregistratori. Questo va molto bene a Rohmer che diffida a priori di ogni successo troppo grande, non sopporta il sentimen talismo e, al limite, accetta che si scoprano piene di sentimento opere che all’inizio sembravano astruse e cerebrali. Si scavalca il 238
pubblico reale (quello che si potrebbe incontrare) per rivolgersi a un altro, molto più esteso e sconosciuto (impossibile da incon trare) e, invece di apparire un vecchio nostalgico della sala, si procede nel senso della democratizzazione (alla quale si crede meno che a ciò da cui essa protegge: lo scambio-promiscuità con il pubblico). NO, LA FOLLE GLORIA DEL COMANDO (De Oliveira) * Idea: il cinema è un’avventura che, oggi, può ri-partire molto bene. Condizione sine qua non: la libertà di manovra dei cineasti. Quella di De Oliveira è stupefacente ed io, pur conoscendo già due o tre cose di questo folle progetto, ne sono rimasto sbalordito e, ripensandoci, ultra-sbalordito.
* Ci sono altri modi di filmare la guerra, oltre quelli america ni, e c’è una freschezza — è duro da ammettere — nel modo in cui un vecchio signore portoghese viene, senza alcun complesso, ad occupare un terreno che sembra diventato monopolio americano; un vecchio signore che, una volta portate a termine le operazioni, se ne va altrove. * Quantunque... Si tratta proprio di un altrove? Per un’ironia ulteriore, De Oliveira non ha i mezzi per porre seriamente una questione che gli americani possono solo sfiorare: che cosa faccia mo quando siamo lontani dal nostro paese? Ma può farlo ugual mente perché è portoghese, perché appartiene al piccolo, geniale paese che, primo nella Storia, ha affrontato quel problema. * Quello che ritorna in mente. La prima inquadratura (l’albe ro). La seconda (il camion). L’occhio della testa bendata (ipotesi Kubrick). La tirata sul carattere palindromo della parola “non". Il bagno. Vinato e il suo rogo. L’africano con le budella di fuori e il suo grido. * Segno dei tempi. Sebbene non si parli che di rivendicazioni di identità, di popoli, di nazionalismo, sciovinismo e integrali smo di ogni genere - tutte cose poco buone per il cinema -, ecco un film che, senza scherzare, ha come soggetto... il Portogallo. Questo paese intatti non è come gli altri. La prova: esso ha pro dotto un grande regista che prende a "soggetto” il Portogallo stesso. Soggetto in tutti i sensi della parola: figurativo, narrativo, enigma irrisolto, ecc. 239
* Primo paese europeo partito alla scoperta del mondo, il Portogallo trasmette al mondo le Scoperte. La cosa più sorpren dente è che, pur non facendo più parte delle grandi potenze, esso resiste a fianco della Spagna in una eterna non riconciliazione con essa e con una coscienza esasperata del proprio “ruolo nella Storia”. Il ruolo degli anticipatori, se così si può dire. Di coloro che si sono messi in cammino (navigare necesse est) e che hanno sentito che il movimento era ciò che restituisce il mondo nella sua evanescenza, non nella sua materialità. * Le numerose sconfitte presenti nel film sono strane. Forse il Portogallo è una di quelle nazioni masochiste e sofferenti che fanno tutto male (un Messico, un Iran?). Il film non dice esatta mente questo: dice piuttosto che la realtà risponde regolarmente “NO" al Portogallo, gli sbarra la strada del ritorno alia gloria e alla conquista. E che, in una sorta di sogno ad occhi aperti, con un coraggio triste e idiota, il Portogallo va incontro al discono scimento della realtà stessa: la battaglia di Alkacer-Kebir, con l’assenza (rohmeriana) di re Sebastiano e con il mito del sebastianesimo (c’è un qualcosa di sciita in questo: stranamente, non ci si schiera dietro un capo morto e invincibile, si sposa la causa di un capo tradito, tradito da se stesso, vulnerabile). * Nel film, il ruolo della religione è misterioso. La Chiesa Cattolica sembra una parte aggiunta. Le motivazioni hanno un'aria fondamentalmente pagana e il sentimento di essere stra niero sulla terra è il più importante. Il sebastianesimo appare come un mito quasi africano, pagano. * Lo statuto del realismo. Si tratta di una sensazione abbastan za oscura che provo anche davanti a Kubrick (Barry Lyndon). Il facto è che una parte dei problemi del cinema moderno (imma gine-tempo) sono forse dovuti alla necessità di una stessa per centuale di realismo nelle diverse epoche ricostruite. Da cui la soluzione Rohmer, per esempio. Chiamo “realismo” il rendersi conto materiale di ciò che già sappiamo: per esempio, se le spade (o le armature) del Medio Evo sono quelle, un uomo che le porta deve per forza camminare in un certo modo. È l’effetto Lancillotto: effetto comico nato da una materializzazione senza compromessi. Kubrick ha ottenuto qualcosa di simile con le candele di Barry Lyndon. Il cinema registra una sorta di simula zione audio-visiva di ciò che sappiamo ma che non abbiamo mai 240
“visto". Lo fa "per vedere". In tal modo, torce il collo alla stiliz zazione hollywoodiana o di altro tipo, oppure la riporta al suo statuto di stilizzazione. * Questo conduceva agli effetti corrosivi o buffi del "così stava no le cose", a detrimento degli accomodamenti da studio. Ma forse è qualcosa che appartiene a un periodo ormai trascorso del cinema. La forza del film di Manoel deriva dal fatto che egli non sembra per niente condizionato dai cambiamenti di tempo, di epoca, di stile (ivi compreso l'incredibile modo di mettere in scena i Lusiadi!), e questo non perché lui abbia scoperto un qual che principio generale, ma perché, in generale, il realismo (l’effetto di letteralità) non è più una macchina da guerra contro la stilizzazione ma uno stile fra gli altri, acquisito. 6/5 IL GÈLE EN ENFER (Mocky). Visto in uno stato di debolezza esasperata. Evidentemente, dato che è sempre così minimale, la vitalità di Mocky ha qualcosa di scandaloso. Come nel film di Chahine, un altro dalla vitalità incrollabile, il minimale è di tipo compulsivo: io sono sempre là, la prova è che tengo duro e vi seppellirò tutti. La politica degli autori raggiunge qui uno dei suoi limiti estremi: l'autore — il corpo dell'autore — diventa l’alpha e l’omega del film. E il film funziona come una sfida: al buon senso, ai buoni costumi, alla buona forma, e trae la sua forza solo da questa tautologia.
Occorre classificare Mocky, come Mullet o altri del genere (il genere ragazzini agrodolci), fra i registi "a metodo” il cui lavoro è corrosivo. Ma più igienico che gioioso. La loro "piccineria” (una lira è una lira, ecc.) è ciò che li rende intransigenti. In altre paro le: là dove, nei dettagli, un regista mediocre sceglie senza pensar ci la soluzione più convenzionale, Mocky è capace di trovare una soluzione più economica, dunque meno convenzionale e senza dub bio più giusta. Tirchieria, invenzione, poesia.
Del film, conservo alla fine una sola scena: l'arrivo della coppia protagonista alla piccola città dello Jura, il bambino stupido dal । si riare lento, l'automobile rossa, l'idea di fermarsi lì: tutto insieme, in un disordine chiaramente più autentico che se lo avesse filmato Corneali. Forse, è per voler sempre occuparsi di più cose insieme 241
che Mocky arriva a sfiorare la poesia, o almeno la banalità autentica delle cose che “capitano” e, subito, appaiono insignificanti.
L’altro talento di Mocky è l’idea di “figura”. Mocky è il solo “personaggio” dei suoi film (sempre lo stesso perdente collerico), gli altri sono figure. La sua idea portante è: 1) non menare il can per l’aia; 2) sprofondare immediatamente le "comparse” nel cen tro dell'azione; 3) screditarle subito dopo. In che modo? Giocando di “montaggio”, come un pazzo: nessuna tipizzazione classica e, per maggior sicurezza, voci che non aderiscono ai corpi. Qualcosa di abbastanza vicino a Godard. Esempi: il secon dino con i capelli lunghi e la voce aspra della prima scena, i due poliziotti il secondo dei quali è un ragazzone maldestro. E anche il sacrificio di qualsiasi “personaggio” a vantaggio del movimen to del film che, in effetti, ne esce rafforzato: un movimento che non produce niente, che non prende respiro, che ha la stessa monotonia dei fatti di cronaca e che spesso risulta così simile alla vita. (Il motivo per cui tutto questo non ha molto successo, essendo la vita, nella sua indifferenza, ciò che al cinema mal si sopporta: Rozier). Discussione, ieri, a casa di Marion S., con Elizabeth R. e Romain Goupil. È molto semplice: parliamo (io per primo) solo dei film di cui tutti parlano (Weir, Besson) e nemmeno più ne parliamo “da cinefili” ma ci fissiamo sul loro contenuto come su un testo di Rorschach. All’opposto, riguardo ai film che amiamo e consideriamo degni di un dibattito “estetico", restiamo muti come pesci (l’ultimo Moretti è l’esempio più recente, eppure, improvvisamente, mi sembra ancora ben poco comprensibile ad un pubblico giovane). Stessa discussione a mezzogiorno, con Jean-Jacques M. Problema del “gusto”. In breve: noi siamo molto disorientati.
LEITMOTIV. La parola desoggettivazione mi sembra riassumere ciò che in questo momento mi spaventa. Frase di Legendre, non ricordo dove: «Noi non abbiamo più accesso ad alcuna umana soggettività. Dove sono finiti i nostri diritti poetici?». La trasmissione di Paul Amar sul cinema francese aveva, secon do Goupil, un leitmotiv: facciamo del cinema di evasione. La sensazione di invasione continua a ripresentarsi e a stabilizzarsi. La Francia si è attestata sul 15% di voti a Le Pen. Spersonalizzazione/Desoggetivazione/Disindividuazione. 242
ECOLOGIA. Tutto torna con troppa precisione per non essere inquieti. La ricomparsa, all’Est, di un pietoso "nazionalismo” non è l’affermazione di un valore, di un’idea, di uno stile di questa o quella "nazione", è la riaffermazione di ciò che, nel corso dei secoli, non ha mai smesso di imporsi attraverso innumerevoli odi campanilistici, debiti inestinguibili e insopportabili lutti. Ma oggi, ciò, in nome dei quale, tutto questo appariva di scarso valore non esiste più: non l’uomo nuovo del comuniSmo, e neppure la pax turca, austriaca, sovietica. E così, alla maniera dell’IsIam, questo mediocre nazionalismo è diventato inevitabile e di tipo ecologico. Protesta-protezione senza alcun valore di creazione. Non ci sono ragioni, infatti, per impedire ai Lituani di essere padroni in casa propria, ma ciò non porterà alcun vantaggio (economico, |X)litico, culturale) a nessuno, nemmeno a loro. Il fatto è che essi sono assimilabili a una specie in via di estinzione e non c’è alcun motivo che essa scompaia. Se, di fronte a un potere economico scatenato, è solo l’ecologia ad esercitare un ruolo di regolamentazione, non si può non essere preoccupati. L’ecologia infatti preserva le speci in quanto ette si divorano l'una con l’altra. Applicata all’uomo, perde di senso. La rivendicazione "diritti dell’uomo” non può dunque essere fondata su questo e neppure può esserlo sulla distinzione (in base "al merito”) fra un uomo e l’altro. È strano pensare a tutto ciò scrivendo sul film di De Oliveira. Ecco almeno un popolo che sa in che cosa egli ha dato il suo apporto alla Storia e che in questa consapevolezza va avanti, con temporaneamente compresso e vitale.
26/5 DOPO LA ROMANIA * La mia saga di cinefilo è iniziata con Hiroshima o con Notte e nebbia? Con entrambe, senza dubbio. Due film di Resnais, sullo sfondo del disastro. Nei miei ricordi, era Agel^ che, con regola rità, ci imponeva il film-trauma. Forse Agel pensava che per noi, venuti al mondo nel momento in cui i campi di sterminio erano stati chiusi, vederlo e rivederlo fosse necessario? Cera forse della perversione in questo suo scioccarci (cosa che del resto faceva anche con i cortometraggi di Franju)? * Strano questo sentimento di avere immediatamente capito di che cosa si era trattato, al punto da non aver avuto bisogno né di 243
supplementi di informazione, nè di commenti. Sentimento dop pio di un orrore che, fatalmente, esisteva. Più che per l’errore commesso, per il momento indefinito in cui l’umanità stessa arri va a due dita dal proprio suicidio, si accorge del baratro e cambia strada, per sempre traumatizzata e, in qualche modo, “guarita”. Dunque, è proprio quello che è capitato all’umanità intera (non solo agli ebrei o ai tedeschi) che io, in quel momento, in modo nitido e indimenticabile, appresi. * Sorprendente anche il modo in cui i problemi di “sostanza" e di “forma" mi sembravano, sempre nel film di Resnais, indis solubilmente legati e risolti, e il modo in cui sentivo, senza aver letto niente di Brecht, che la distanza trovata, sia per l’immagi ne che per il suono, era non soltanto quella giusta ma la sola pos sibile. La storia del "carrello di Kapò", che sarebbe venuta subito dopo, era per me sottintesa. La condanna di Hollywood — o almeno della Hollywood che affronta i "grandi soggetti” — sarebbe stata sempre una conseguenza di questa interdizione: no al plusvalore estetico o decorativo. Al punto che oggi mi chiedo se la sola "bellezza" cinematografica alla quale io abbia aderito non sia stata quella morale. Ci assillano con la storia degli inizi cinefili legati all’aspetto salutare della felicità e del sogno. Per me, il cinema non è il luogo di conservazione dei miei affetti infantili (come è oggi la televisione), non è il sogno collettivo che mi ha consegnato il socia le e un posto da occuparvi, è l'appartenenza di diritto e di fatto ad una umanità della quale sono arrivato appena in tempo per vedere l’immagine negata. Oggi mi chiedo se un cinema che sembra non si occupi più di (e non essere più occupato da) questo mi interessi ancora. Forse perché i campi di sterminio sono esisti ti attraverso l’immagine e solo grazie a questo tutte le immagini avevano un peso, una consistenza morale possibile.
* Un’immagine è valsa per tutte le altre, perché essa aderiva al concetto non edulcorabile di crimine contro l’umanità, vale a dire la possibilità per l’umanità di suicidarsi. Nel momento in cui si vuole eliminare la precisione del dettaglio, questa immagi ne non può più giocare il suo ruolo di comune denominatore, cessa di valere per tutte le altre. È un'immagine che ha resistito per più di trentanni. Ma quando gli americani hanno deciso di raccontare anche loro questa storia a tutto il mondo, non hanno potuto che americanizzarla. Ne hanno il diritto, ma questo dirit244
co è anche quello di chiunque di ritenete questa scoria un argo mento "di dominio pubblico".
* Ancora la frase di Godard. Se finzione » ciò che capita a me, allora documentario = ciò che capita all’altto. Dunque, Notte e neb bia (la realtà supera la finzione) continuava ad accadere all'altro e manteneva questa idea dell’altro. Quando si entra nella finzione (vale a dire in un sentimento di obbligo verso i sopravvissuti e dopo che, in una certa maniera, "questo accade anche a loto"), l’idea di un diritto di prelazione dell’altro su di me viene meno e, di nuovo, tutte le identificazioni (anche quelle con i carnefici) sono possibili.
GODARD/EASTWOOD * Da dove mi viene la sensazione che i due film {Nouvelle Vague e Cacciatore bianco cuore nero, ndt) abbiano lo stesso “tenore"? Breve lisca dei punci comuni. * Crimine/Peccato. È forse il più profondo. Uccidere un elefenre è un crimine o un peccato? Wilson non vuol essere un crimi nale ma un peccatore. L'ironia (quasi bunueliana) della cosa è che egli si ritrova ad essere proprio un criminale non per aver ammazzato l’elefante, ma per aver provocato — indirettamente — la morte di Kivu. In che modo? Come in L’orso di Annaud, l'ani male gli è arrivato così vicino che lui lo ha visto come un volto, e non si dà la caccia a un volto. Si tratta dunque del naufragio dei faccia a feccia, figura regina dell’immaginario, relazione duale in cui il cacciatore è perfèttamente cosciente di sparare a se stesso (certo si potrebbe dire: guardate questo tarato, si è sopravvaluta lo e così provoca l’incidente). In J.L.G. II doppio volto di Delon, il doppio feccia a feccia con la donna.
* Delon/Eastwood. I due si assomigliano un po' nella loro volontà distruttiva, puritana-sarcastica. Persone che, al culmine della storia in cui si sono messe, arrivano a trovarsi molto diver tenti, ma comunque non abbastanza per fer ridere gii altri. L'accento “inglese" di Wilson. Il capo non fe ridere nessuno a parte se stesso. La magnifica frase di Delon: «Faccio pietà». * Tempo perduto, "non saremo mai pronti". Eastwood realizza il suo strano Disprezzo inventandosi su misura - e in omaggio a I lus con - un tournage di La regina d?Africa. Idea comune ad 245
entrambi: tutti si strappano i capelli tranne l'autore che segue i suoi capricci o i suoi umori. Il prodotto sarà alla fine consegnato ma nessuno sa di che cosa sarà fatto. ♦ Tempo non conclusivo. Riuscire a inventare del tempo (digressione, intermezzo, fantasia) e a riassorbirlo senza aver risolto niente. Scena dell’aereo “impazzito” e delle rapide (ma come hanno fatto?). Scena antisemita e scena antiafricana, di seguito. Il tempo non alimenta la storia, obbedisce a delle idee fìsse, perfino a delie serie. ♦ Cattivo umore. I rapporti fra le persone sono retti dalla ferrea legge della schiavitù economica aggravata da quella, altrettanto rigida, del cattivo umore sistematico. Umiliare i deboli è — alme no in Godard — un obbligo assoluto. Un mondo in cui nessuno “si vergogna dell’autorità” perché essa è contemporaneamente indifferente e personalizzata. Idea dei domestici, della servitù. Grande famiglia svizzera, nobiltà coloniale inglese senza titoli, grandi dimore. * Il corpo non compie niente. Immagini di star-elefanti. Sono i veicoli (aereo, battello, cavallo, automobili) che permettono ai corpi di esprimere, di rendere im-mediata la propria rabbiosa violenza: il balletto delle auto in Godard, sempre più un misto fra le bagnarole di Mack Sennett e oggetti dotati, quasi fossero persone, di cattivo umore. Ugualmente: Delon non sa nuotare. * Si preferirebbe non parlare. I colpi dell’enunciazione: Wilson e la razzista inglese («non vi dico che...»).
♦ I personaggi che non sono né ruoli secondari, né comparse: stanno lì, in attesa che qualcosa accada (Hod, il pilota inglese). Modernità.
31/5 DOPO IL DISFACIMENTO. Ormai so fare soltanto questo: tro vare dei punti in comune ai rari film che vedo, come se essi mi facessero tutti segno allo stesso modo. All’ultimo Cannes ho visto i film di: Fellini, Kurosawa, Godard (due volte), Eastwood, Chahine, De Oliveira. Mi sembra che questi film di registi anzia ni, e anche molto anziani, abbiano qualcosa in comune. Che non 246
è più il fatto indiscutibile di essere opere d'autore e di non rispondere a nessun altro desiderio all’infuori del capriccio perso nale. Ma che non è neanche una non si sa bene quale sovranità nel!’esercì tare il diritto a disfare che ci si è riconosciuti. In altre l>arole: tutti quei registi sono, alla stregua del cinema, oltre il disfacimento. Adopero di proposito una parola che abbiamo molto usato sia di recente che in passato. Tutto è cominciato negli anni del nostro amore per il cinema americano, quello di Ray e di Welles, quello che si dis-foceva. Per poi continuare in due modi: gli americani non potevano far altro che disfare i corpi delle loro star (da Bogart a Eastwood), gli europei se la prendono con le consuetudini del racconto, con il linguaggio (da Antonioni a tutti gli altri). E tutto ciò è andato avanti per vent’anni, durante i quali la televisione ha consolidato il suo potere. E oggi? Nessuno dei registi sopracitati desidera aggravare ciò che è già abbastanza fragile così com'è. Tutti, a un certo punto della loro carriera, sono passati per un momento di “gioco al massacro". Il disfacimento era nel modo in cui Godard accompagnava le star nel loro tramonto, in cui Fellini non racconta più niente e Chahine solo se stesso, in cui Kurosawa fa Dodes'ka-den e fallisce il proprio suicidio e Eastwood ironizza incredibilmente su di sé con Honkytonk Man o Bronco Billy, e Mon cas è forse il film di Oliveira più “mercatino delle pulci”. Ma non sono sicuro che, nonostante questo, essi vogliano “rico struire” qualcosa. Da cui la stranezza di tutti quei film, film che non rispondono ad alcuna domanda sociale forte, continuando semplicemente un lavoro che è piuttosto un ri-assemblaggio di qualcosa che occorre “far stare in piedi”.
DEBILITAZIONE. I film che hanno molto successo: Le grand ble/f, L’attimo fuggente, Zia Angelina. Non c’è in essi l'idea di una debolezza, di una infermità, perfino di una onesta debilitazione costitutiva del personaggio? Con la quale ci si identificherebbe (qualcosa dunque di molto, molto lontano dagli eroi o anche dagli anti-eroi di una volta)?
CON GLI PSICOLOGI. Su una radio ebrea, ancora un dibattito ion Moskovitz, Anne-Marie Houdebine e qualche altro “puntuaI izza tore" a proposito dell’inevitabile Le grand bleu. Un’idea in pili: quando i bambini ammettono (mi si dice) di “non capire tutto” del film di Besson, non lo fanno per andare contro il film, piuttosto riconoscono che ciò che c’è da capire è importante. Ma 247
che cosa? Io vi vedo una sola cosa: la morte, la possibilità e la scelta della morte. Questo film, che noi troviamo narcisistico e mortifero, è prima di tutto il film attraverso il quale degli adole scenti scoprono che esiste la morte (un po’ come I quattrocento colpi mi aveva messo in guardia sul fatto che forse la vita non è altro che un cumulo di delusioni). * Stessa cosa con Sibony che fa notare come la presa di potere del professore deU’Attò»» fuggente avvenga attraverso il confronto degli allievi con le foto dei loro predecessori, morti da molto tempo. Forse, per un bambino di oggi, la morte è quella cosa che egli non vede né incontra ma che non cessa di mettersi in mostra alla tv esclusivamente sotto forma di notizie brutali e film gore. (Per non parlare di quei cadaveri il cui ricordo tanto ossessiona i loro genitori e i loro nonni).
Tutto ciò sarebbe terribile perché fra questo e i film “post distruzione” di cui parlavo prima, non resta niente. Il film di Fellini, grande lasagna ripiena di odio depositata sul bordo della strada, film piuttosto anti-giovani, è semplicemente ignorato da tutti. Ci si chiede che cosa unisca i film di grande successo del momento con i film d’arte. Meno di niente. Nessun ponte, nes sun collegamento. Perché i film post-distruzione sono sostenuti da una vitalità che non è quella della giovinezza ma quella del vecchio che è sopravvissuto a tutto e parla, con molta veemenza, di ciò che interessa a lui e soltanto a lui.
* Altra idea (al termine di una discussione molto intensa con S.T., T.J. e O. Assayas, divenuto irriducibile e straubiano nel suo condannare l’epoca e difendere l’arte): quei cineasti hanno un punto in comune, il territorio. E, perché no, la nazione, il popolo. Godard torna nel suo paese, non lontano dalla culla europea del grande capitale puritano. Kurosawa parla solo del Giappone, De Oliveira del Portogallo. Eastwood “dimentica” l’America nella sua riscoperta dell’Africa. Chahine non è che un uomo di Alessandria e Fellini continua a percorrere le strade che portano a Roma. In tutti, l’assenza dell’America non è un’eclisse ma una vera scomparsa. La morte del cinema è decisamente sincronica al declino americano.
GIUGNO. Ritorno dalla Cambogia. Quand’anche mi sforzassi di percorrere la strada della disillusione, incontrerei comunque 248
lamenti, bilanci e smarrimenti. Esempi a caso: Biette (in crisi, “finalmente”), Noureddine (di passaggio a Parigi), Amina Danton e un certo Yan (due giovani che invitano a parlare J.Dt. e me a Censier), Jean N. (che vuol venire alla radio a “discutere con me” ma che non ha niente da dire), Bernard Cohn (incontrato alla proiezione dell’inenarrabile Crépuscule del principe Sihanouk), Olivier Assayas (al telefono), Claire Denis (preparando il nostro Rivette33) e anche S., il “piccolo” cambogiano rimorchiato a Parigi. Il triste piacere del lutto (del “niente è più come una volta”) è dietro le spalle. Il lutto, oggi, pesa. Si compie. In un certo senso, ognuno è tenuto a sapere di che cosa è fatto il suo lutto. Godard è l’unico a dire in che cosa ciò che è stato avvicinato (e fallico) dal cinema è di indescrivibile importanza.
Noto che da qualche tempo il mio discorso sul cinema ha inver tito la rotta. Per anni è suro soprattutto la presa di coscienza infeli ce che il cinema, in quanto dispositivo, aveva ripreso e qualche volta raddoppiato le politiche del secolo, che aveva "accompagnato” il peggio o quanto meno era stato in prima fila. Chiamavo “cinema moderno” i trentanni del dopoguerra in cui i registi, senza rinun ciare a un certo tipo di impegno (morale), avevano rinunciato a dar forma alla politica. In qualche modo, un cinema dei riscatto. Un braccio di ferro postumo con la precedente propaganda (Syberberg è l'espressione più sulfureamente onesta di quel “lavoro”). Oggi (ma, ancora una volta, J.L.G. è arrivato prima) direi piut tosto che il cinema rappresentava anche una libertà. La libertà di andare a vedere, di avvicinarsi o di allontanarsi, di aprirsi alle cose in una luce da alba del mondo, di avere il coraggio di rappresenta re c raccontare. Insomma, la mia idea attuale (che mi commuove) mi è venuta scrivendo un pezzo su un vecchio film di Vadim: c’è un'emozione dell’inizio che consiste nel veder apparire, emergere, nascere qualcosa, qualcuno che, un attimo prima, non esisteva (o non era mai stato visto). Una storia, un personaggio, un modo di litre, un attore. È questa l’emozione più vicina alla vita. L’amore per la vita infatti non è l’ideologia vitalista, è piuttosto l’attenzio ne a ciò che non smette di ritornare sotto forma di “prima volta”. Questo amore può essere eterno ma forse i suoi oggetti non sono infiniti. La malinconia cinefila verrebbe dal fatto di aver incontrato dei film che ci hanno permesso di vedere quello che 249
non conoscevamo (di cui non eravamo pratici), il volto di un'esperienza a venire, l'anticipazione di ciò che un giorno ci avrebbe guardato. In questo senso, la cinefilia somiglia alla teoria della fetizzazione di Bolle ripresa da Lacan. Il piccolo dell’uomo è come un bambino prematuro: egli codifica delle esperienze fon damentali senza potervi rispondere fisicamente. La sala cinemato grafica sarebbe stata questo secondo utero in cui noi avremmo riconosciuto in anticipo delle immagini dotate di una sorta di diritto di prelazione sulla nostra vita (Schefer). Per quanto mi riguarda, ad esempio, Un dollaro d’onore e Pickpocket costituirebbe ro le due versioni possibili della mia omosessualità. Il problema non è accettare che una nuova generazione abbia le sue immagini formative (diciamo Diva), ma essere certi che quel le immagini verranno sempre e necessariamente dal cinema. La domanda è: non è forse vero che noi abbiamo vissuto un momen to storico intenso, eccessivo, in cui il cinema è stato la principale macchina di registrazione e identificazione? Momento superato, ma il cui ricordo — sempre più pallido e fluttuante — tormenta ogni nuova generazione di mezzo?
Sì, il cinema ha avuto a che fare con la paura («Prima di tutto, certo, la paura»), ma anche, mi viene da dire oggi, con il corag gio, con il desiderio di superare la paura, di andare “a vedere se io ci sono", e di andarci "a qualunque costo”. Con la libertà di insi nuarsi fra i mostri e di addomesticarli. Per me, in questo momento, le tre grandi oscillazioni che definiscono il cinema, vicino/lontano, piccolo/grande, prima/dopo, hanno permesso ai soggetti di fare la doppia esperienza del coraggio e della fuga (escapismo).
Perché a un tratto è così facile pensare queste cose? Perché l’evoluzione della tv, e dell’audiovisivo in generale, è chiaramente tutPaltra cosa. I media, come dice il loro stesso nome, scelgono sempre la via di mezzo, ci collocano “nel mezzo” e ci sottraggono il prima e il dopo, l’emergere dell’avvenimento, l’emozione dell’inizio. Forse perché nel sistema di quotazione istantanea della Borsa ogni cosa deve nascere già matura, perfetta, riuscita, dal momento che non avrà il tempo di crescere, non benefìcetà del tempo (del credito) che si concede a un bambino prima di giudi carlo. Alla tv (les Nuls o il Bébète show), anche ciò che è inaspetta to e di talento viene riconosciuto e giudicato in una sola volta. 250
Il cinema “ha corpo” perché i film sono concepiti come bambini. Per farli ci vuole tempo, occorre accompagnare i loro primi passi, capire ciò che tentano di dire (i critici) ed è commovente scoprire fino a che punto "assomiglino” a qualche cosa (i genitori, l'aria che tira, la Storia), ecc. Ma queste metafore organiche sono sostenute dalla consapevolezza di un’altra metafora di base: la registrazione di immagini e suoni è assimilabile a un atto sessuale magico (macchi na da presa fallica/mondo passivo o mondo fallico/pellicola passiva). SINTESI mi sembra essere l’attuale parola dominante. Le imma gini, come i bambini, non sono più il frutto di questi processi e di queste durate organiche, non costituiscono necessariamente la materializzazione di un desiderio (bambino desiderato, film «l’autore). Non hanno niente a che five con l’emozione dell’inizio (chi c’era ’’prima”?). Le immagini cinematografiche funzionavano in modo formidabile come famiglie di adozione per piccoli orfani della società. Quelle dell’audiovisivo, non avendo alcuna storia alle spalle, sono loro stesse orfane. Da un film ci si poteva far adottare. L’audiovisivo lo si adotta. Il tempo che manca ormai fa sì che le immagini o i segni lasci no il posto a dei segnali. Le copertine de «L’Evénement du jeudi» mi affascinano perché sono concepite come cartelli di segnalazione o ’’itinerari consigliati”. Mentre le immagini dovevano essere viste (c ciò che si vedeva era sempre ambiguo) e i segni interpretati, i segnali devono essere decodificati (e il codice è una cosa che si impara). Un segnale non è né vero né falso, è "recepito” o no.
LEGGERE/VEDERE. È una questione che continua. Non c’è più cinema senza un minimo di scopofilia: vedere il mai visto, l’effetto sbalorditivo e pietrificante, quello che non si può coglie re nella lettura. Ma questo effetto sembra allontanarsi sempre più, solo gli animali continuano a resistere. E ancora, si potrebbe dire che ciò che noi vogliamo vedere oggi non è più il mondo esplorabile ma quanto del mondo già risulta minacciato: gli orsi, le grandi belve. Perché tutto ciò rischia di non sopravvivere alla propria immagine. Ciò che vi è di realistico nel cinema (quello che gli rimane di registrazione) riguarda ormai solo la parte tote mica dell’umanità, la presa di coscienza della propria irresponsabilirà di fronte ai suoi grandi antenati, ai "pilastri” del mondo. È attraverso gli animali che il cinema ha ancora a che fare con la rappresentazione ed è grazie alla presenza del pericolo (baziniano) nel filmarli se ha ancora a che fare con la registrazione. 251
1991
22/5 Faccio la conoscenza di Agamben e parliamo un po' di cinema. Ha rivisto La signora di Shanghai e si chiede da dove venga la forza di film come questo. Film "che avevano un appuntamen to”. Ma con chi, con che cosa? Con la Storia, col pubblico? Film che, in ogni caso, hanno fatto la nostra infanzia. E se il cinema è l’infànzia (infànzia dell’arte, emozione dell'inizio, ecc.), che ne è stato di quella nostra idea di “cinema adulto”? O forse siamo come quei vecchi bambini sfioriti, rabbiosi che si chiamano Monteiro, Moretti e altri (che mettono in gioco il loro corpo, la stranezza del loro corpo) e che non diventano mai adulti? Il cine ma adulto è Blier, un cinema dell'inquietudine, non dell'emo zione. La nostra cinefilia ci ha resi dei vecchi bambini egoisti, sempre pronti a sottoscrivere un contratto per giocare. Solo che ormai giochiamo da soli. I lati buoni e cattivi del mito. L’idea che tutto è già comincia to quando il film (la vita) comincia va contro l’idea del mito come origine offèrta in forma di spettacolo.
Su «Libération», articolo dedicato agli zoo che, dappertutto, vanno a rotoli: la sfilata delle varietà animali non diverte né istruisce più. Come i contadini, i guardiani degli zoo devono riciclarsi come conservatori di specie in via di estinzione, respon sabili della loro riproduzione. Avevo ragione di considerare LIorso di Annaud il film che veniva a “rimpiazzare” gli orsi veri. Rapporto fra l'immagine di una cosa e la scomparsa della cosa stessa. Composizione “genetica” di questa immagine: misto di vero e falso, di trucchi e addomesticamento. Addomesticamento dell'uomo ad opera dell’uomo. Visione ottimista: forse, l'umanizzazione delle cose (e di quelle cose para ti mane che sono animali, immagini e robot) non è più nuova della reificazione degli umani (tutta la storia delle utopie del XX secolo). Questa umanizzazione-addomesticamento non ha più bisogno di tecniche magico-scientifìche di registrazione 255
audiovisiva: essa si appella al disegno, alla programmazione, all’immagine genetica. I «Cahiers du cinéma» hanno quarant’anni. Tristezza dello spettacolo di Cannes. I «Cahiers» rappresentano una decina d anni di leggenda e trenta di oscurità, prima appestata quindi piatta. La televisione ha il triste vantaggio di svuotare le cose di ogni vita e di stabilire a quali condizioni un significante può funzionare fra gli altri significanti. S.T. sembra un padrino. Un Monsieur Loyal*5 spedito dalla tv ai «Cahiers», eterna rivista di giovani oscuri e foruncolosi, eternamente preposti alla dignità del cineclub ermetico.
23/5 Umano, non umano, troppo umano, ecc. Che cos e la "modernità” nel cinema? Al momento della guerra, qualcuno decide di seguire il corpo umano e le sue attività nella loro successione meccanica. Ogni azione è mostrata in uno “svolgersi” che implica il riflesso, la ripetizione, {'automazione, insomma il non umano nel cuore dell'umano. La specificità umana è l’uscita da questa "successione”, è la rottura significante: miracolo, incontro, salvezza, evento. Senza dubbio, è stato Bresson a rendersi conto con maggiore lucidità che la "parte del diavolo” è quella della macchina, di ciò che è mecca nico (il contrario del “gioco”). Per compiere un’azione ci vuole anche della tecnica, dell’automatismo, dell’impensato. E la stessa consapevolezza c’è in Rossellini, Hawks e altri registi moderni. Questi autori hanno rivelato non l’“uomo" ma {'umano, ed è pro prio per questo che hanno tutti avuto a che fare con l’oscenità, essendo l'umano visto come una febbre, una rovina. È perché hanno l’umano come orizzonte enigmatico che essi esplorano tutto ciò che è presente di inumano. Nella registrazione di immaginidurata lasciano affiorare l’angoscia di “ciò che va avanti da solo”, indipendentemente dall’Uomo e dalle sue credenze. Ma questa angoscia è anche un piacere che essi hanno l’onestà di non reprime re. Per me, sebbene non coevi, sono loro i contemporanei del pen siero del “soggetto” freudiano: intreccio lacunoso di linee di fuga e di nodi. Forse, quell’avventura è terminata e non avrebbe più senso continuare a torturare i corpi di fronte alla macchina da registra zione. Forse, la lugubre gag di Salò, a metà degli anni Settanta, ha segnato un limite. L’improvvisa visibilità di un corpus normal mente sommerso come quello del cinema pornografico è un altro segno: c’è una realisticità che, improvvisamente, risulta sfinirà. 256
Il paradosso del cinema moderno è di aver filtro emergere l'umano attraverso l'assurdo, costringendoci a diventare testimo ni della tecnica impensata e della grazia che illumina. In Renoir, è ancora l’idea del lavoro dell'uomo, del mestiere. In Bresson, è già quella della gestualità clandestina, asociale. Renoir non avrebbe mai filmato un borsaiolo, né Bresson un operaio. Melville fa quasi girare a vuoto questa idea (camminare, parlare, aprire una porta), Godard la rende sperimentale, Rivette e Rohmer filmano degli sfaccendati. Ecc. Non si può andare piò lontano. E, nello stesso tempo, basta rivedere il sublime Perfìdia (Les dames du Bois de Boulogne, ndt) alla tv per sentirsi paralizzati per sempre dalla crudeltà quando Paul Bernard apprende la “spiegazione finale della storia" nel momento in cui, per tre volte, inchioda la sua auto. "Chi ben ama, ben castiga” è il programma sado-maso di questo cinema della metà del secolo. A cosa corrisponde {'inversione di questo schema? Al fatto che la connivenza dei corpi (nello spazio) e della macchina da presa (nel tempo) cessa di rappresentare la fatalità per la quale ci si trova faccia a faccia con il non umano. È dunque necessario che ci sia un altro tipo di "successione”, o anche nessuna. Che il movimento sia di diritto “esterno” rispetto alle figure che esso anima: che sia il movimento del disegno, del programma informatico, dell’"animazione” intesa come perfusione di energia. Al posto della terri bile dialettica umano-non umano, si avrà tutta una varietà di “piò o meno” umano. L’umano non è piò ciò verso cui si va ma l'elemento nel quale tutto è già immerso, un elemento dove il soggetto-oggetto si è molto messo da parte a vantaggio di un animismo post-moderno, giapponese.
25/5 Lynch. Visto, un po’ a caso, con S.P., un episodio di Twin Peaks alla televisione. Ne avevo già visto uno e mi aveva positivamente intrigato. Stesso sentimento ieri. Stesso piacere nel lasciarsi "incatenare" dal film, sia (vagamente) in relazione all’intreccio, sia nei passaggi, sempre stimolanti, da una scena (da un’inqua dratura) all’altra. Guarda un po’, ci diciamo, è cinema, vale a dire che “articola” continuamente qualcosa. Questo mi fit (un po’) dubitare di alcune delle mie piò rigide convinzioni. Un certo numero di cose sembrano improvvisamen te !>crrorrìbili, un po’ come il movimento lo si dimostra cammi nando. Per esempio, si scopre il possibile utilizzo della bellezza 257
pubblicitaria in una scoria, vale a dire al di fuori delle sceneggia ture brevi degli spot. Dico proprio “pubblicitaria" per non dire "artificiale". Il mio vecchio odio per le star artificiali all’americana (da Lana Turner a Dallas) si trasforma qui in una intensa curiosità per il modo in cui, sotto i nostri occhi, degli esseri gio vani e seducenti, ragazzi e ragazze, riescono a passare dal défilé di moda al feuilleton psicologico. Ciò che in essi è singolare, è che il loro look resiste alla distanza, nello stesso modo in cui si dice che un maquillage o un lifting “tengono”. È la "perseveranza nell’apparenza” a costituire fessere” di questi personaggi, ed è forse la libertà del feuilleton aperto (e della sceneggiatura persa di vista a forza di de-moltiplicazioni) che gli permette di "essere credibile”. Trovo che queste "apparenze" si rifacciano a due tradizioni. Quella di Hitchcock e quella di un certo tipo di clonazione pro pria del cinema di serie B (Tourneur). Da qualche tempo, David Lynch mi dà tutta l’aria di essere un erede molto serio di Hitchcock. I punti comuni sono evidenti: stessa ossessione ses suale fra la licenziosità e la fobia, stessa oscillazione fra l’organico poco gradevole e la patinatura di una superficie liscia, stessa coe sistenza di una logica stringente e dell’irrazionale destinato a rimanere tale, stesso gusto per il pubblico tenendo conto del posto in cui si trova (davanti alla tv), stesso talento da chirurgo plastico prodigo di “idee” formali, perfino formaliste, stessa cul tura da designer di moda, stessa ironia, qualche volta stravagan te, presente nella forma stessa (è la forma che si ironizza — attra verso un leggero eccesso, un’esibizione misurata che si arresta un attimo prima di diventare sgradevole —, non è lo spettatore ad animarla, dall’esterno, con il suo sapere culturale). Il poliziotto ha gli stessi tempi di recitazione di Cary Grant e mi piace molto il modo in cui il suo dialogo poco definito risulta quasi incom prensibile per tutti. Mi piace anche nella versione doppiata in francese (non si sente alcun desiderio particolare di ascoltarlo nell’inglese originale). Dalla serie B, il film trae l’aspetto Dana Andrews presente nello stesso personaggio (il poliziotto, simile a un minerale, ultra leccato) e una certa clonazione dei corpi. Come se tutto fosse visto attraverso le top-model di un unico défilé, costrette ad inventare del tempo, a durare, a recitare per durare. Questa durata è sotto messa al ricatto di una suspense che non deve essere troppo dilui ta anche se, per esempio, mi piace molto che i flashback servano non tanto come spiegazione delle cose quanto come note a pie’ di 258
pagina o parentesi nel procedere del cesto e che, grazie all’elettro nica, appaiano e scompaiano quasi fossero delle velleità di mon taggio ejzenStejniano o vertoviano. Si entra nel manierismo quando si preleva (dall’interno), se ne esce quando si anima (daU’esterno). Il manierismo è un gioco in quanto assai vicino al piacere del bambino che gioca a sventrare le sue bambole o a sfasciare i suoi giocattoli. Il manierismo è dunque votato ad una certa delusione (non saper riaggiustare ciò che è rotto), è il momento in cui, da un acquario-brodo di cultu ra e catalogo di effetti già prodotti, si estrae qualche pesce lasciando il tempo di vederlo muoversi Riori dal suo ambiente naturale. La televisione e la forma remota del feuilleton sono forse il luogo dove questo è possibile. La prova è che quello che non mi convince nei film di Lynch è proprio ciò che mi piace in Twin Peaks. Lo spettacolo del tempo è forse migliore quando la gente perde il suo tempo davanti alla tv. Quei movimenti sono molto particolari: convulsi, parodici, auto-prodotti e infine mortali. Quando non c'è più movimento, non rimane che restituirlo ai personaggi dall’esterno, trattandoli come giocattoli inerti, marionette, fermi-immagine (ed è forse questa l’arte pompier). Mi vengono in mente due esempi. Quello che avevo scritto su Ran di Kurosawa: l’energia immagazzinata nei corpi è rivelata nella loro caotica agonia (l’energia tecnico-malefica accumulata nel pianeta lo minaccia). E quello che avevo scritto di Rusty il sel vaggio film manierista, precisamente con i due pesci, uno rosso e uno blu, tirati fuori dal loro acquario.
4/6 (47 anni) * Einfhìilung. Crudeltà-Empatia-Simpatia-Identificazione. Ad una estremità, l'alterità in quanto tale (e in quanto piacere dell'altro). All’altra, la celebrazione dello "stesso’’ attraverso oggetti transizionali più o meno collettivi. Fra le due, una parte cipazione relativa alle figure e alle azioni proposte. La simpatia è una sorta di “affetto ideologico” (quel personaggio secondario, in se stesso poco lavorato ma utile alla macchina film: Asagara*7). L’empatia è un affetto “sperimentale": dimensione di esperienza nei due sensi del termine: ciò che è stato vissuto (attraverso sé, attraverso l’altro), ciò che potrebbe esserlo (la sperimentazione da fare, attraverso sé, attraverso 1’altro). La simpatia è dovuta alle figure, ai corpi, ai personaggi: è come un'empatia bloccata, accu mulata. L'empatia, al contrario, si produce nel corso del tempo e 259
solo se messa in gioco attraverso la messa in scena. Rispetto alle altre modalità di relazione, l'empatia ha di “superiore” il fatto di esistere solo nello spiegamento di un certo "hic et nunc”, e solo in determinati momenti. L’esperienza che essa permette di condi vide/^ non è completa, non più di quanto essa non sia garantita dille esperienze della mia stessa vita. Quello non è per forza me e non è sempre me. L'empatia mi dà dei frammenti, delle velleità, degli “impulsi” di identificazione che però resta incompiuta. Dunque la messa in scena è il dispositivo logico, coerente quanto basta, che mi permette di essere assolutamente nel firn grazie al solo espediente, dal funzionamento intermittente, di una complicità fisica (corpi, velocità, riflessi, ecc.). Essa è "universalizzante" per il fatto che io posso riconoscere delle fasi di un gioco che nel suo complesso non conosco e non sono tenuto a conoscere. La mia cinefilia ha funzionato così. Fare dei pezzi di strada con delle figure estranee, ma farli abbastanza brevi in modo da non restare prigioniero di nessuna immagine adorabile, definitiva. Da qui la mancanza, fin dagli inizi, di “normali” identificazioni e l’importanza di chi, come Bresson, coglie sempre quel tanto di impensato presente nella gestualità. La parte lasciata incompiuta dall'empatia è l’informazione sull'altro. * Godard a Marsiglia. Incontro ben organizzato (Bellour, Roger, Bergala ed io) dell'I.G. (Internationale Godardienne, ndt) di fronte ad un pubblico attento ma che certamente consi dera Godard qualcosa di ormai irreversibile. In effetti, si ha la sensazione che l’effetto Godard, nella sua materialità più bruta, comunque ci sfugga. Davanti ai suoi film, ci si rifiuta di fare ciò che lui stesso evita: l’analisi psicologica, la descrizione piatta. Vediamo bene in che cosa i dispositivi teorici o formali risultano stimolanti per la mente, ma non sappiamo dire niente dell’accento svizzero, del suono disturbato, del sottofondo, delle posture fìsiche sempre improbabili, ecc. Certo, questo costitui sce la prova che in Godard è sempre presente una materia biogra fica personale, coriacea e in definitiva mal distinguibile. * Idea di Bellour: “sofferenza e digitalità”. Una retorica audio visiva nata da una gestualità altra (quella che colpisce l’immagi ne, la tocca, la accarezza) può ritrovare, da qualche parte, l’idea di una sofferenza (che non sarebbe più {'esposizione ottico-chimica, l’interruzione vittimizzante)? Kramer, forse, ci si avvicina. Per Bergala, Nouvelle Vague è il primo film di Godard in cui "il 260
tempo presente del lavoro di regia” è cancellato a vantaggio di un tempo assai misterioso (eterno ritorno?). * Comment fa va come mio film pre-titoli di testa (prima di «Liberation»), interessante da rivedere oggi. È un piccolo film sinistro e ascetico, ma molto divertente per quei pochi che hanno un po' vissuto il femminismo sado-teorico (la donna senza volto che dice «non va bene»), il machismo maso-pratico (il sindacalista del Livre che, all'improvviso, ‘‘capisce” qualcosa), la storia dell’impossibile rapporto fra i due che si rifà alla relazione padre CGT-figlio rivoluzionario5”, il Portogallo come idilliaco luogo di sperimentazione, il falso poliziesco grenoblese. Forse, è a partire da questo film che Godard sancisce il divorzio fra leggere e vedere.
* Ciò che in Godard non torna (il prezzo della mancanza di immaginazione) è che il mondo "migliore” all'idea del quale egli introduce (più democrazia, più divisione del lavoro, maggior visione collettiva) non dà luogo ad alcuna valorizzazione. Se ci si fosse comportati "così”, si sarebbe forse evitata qualche catastro fe, ma poco altro. Una visione sinistra, sinistra come un mondo senza gioco. Rivisto oggi, Comment fa va risulta un po’ più ambi guo che all’epoca. In altre parole, Odette è una “rompiscatole” e del resto, una volta fallito il suo tentativo, essa scompare per seguire il suo bambino ai corsi di sci (ho pensato a Pak radon ni). Il sindacalista, al contrario, è una delle rare immagini, anche solo un po' commoventi, di proletario brontolone, bonzo e di buona pasta. Comunque, la donna tradisce. (Nella Nouvelle vague, sempre questa immagine della donna: sostanzialmente estranea agli occhi dei ragazzini, alle loro credenze, alle loro ingenuità).
* Discussione con J.H.R. riguardo all’insegnamento del cine ma. Gli studenti — che hanno scelto il cinema — non sanno niente e manifestano una scarsa bulimia cinefila. Di fronte a loro, noi siamo come quei poveri professori di musica del liceo costretti a sopportare che ragazzini si rompessero le scatole mentre gli si diceva che Bach era grande. Sofferenza di quei poveri "traghetta tori", lasciati soli con i loro turbamenti musicali, obbligati a far ascoltare Pierino e il lupo per tenere calma la classe. J.H.R. insorge all’idea che i professori di cinema si lamentino, ma per me sareb be intollerabile dover urlare perché una classe sghignazzante guardi un mèlo di Sirk. L'arte popolare e l'arte erudita avevano in comune il fatto di essere molto serie: l’‘‘arte” delle classi medie 261
ha smarrito questa serietà, da entrambi i lati. Lo spettatore astuto-malizioso di oggi non si mette davanti al film ma esige di stare dalla parte del potere che ha prodotto il film stesso: più quel la di chi concepisce il progetto che quella dell’autore.
9/6 Articolo paradossale su «Rebonds», che dà prova di buon senso. Il collegamento, via telefono e computer, di tutti con tutti è sempre meno inconcepibile. Per qualcuno sarà piu facile faxare il proprio diario da una favela di San Paolo che essere ammesso alla presenza dei potenti del mondo o alla gestione delle proprie condizioni di vita. Così come la televisione ha potuto essere considerata un bene di sostituzione, un incantamento del mondo a favore degli “svan taggiati”, la comunicazione universale può ben essere ritenuta il balocco ipnotico-ludico che consente ai poveri di abitare comun que il mondo. Niente dice che, di fronte ai simulacri, la presenza piena (dell’altro, dell’oggetto) non continuerà a costituire un valore. Il mondo della inter-mediazione è forse un mondo re-incan tato paragonabile a quello del Medio Evo, abitato da tutta una popolazione di esseri para-umani, angeli custodi, macchine intel ligenti, animali domestici, protesi indipendenti, ecc. Questo mondo di facili credenze sarà di nuovo allontanato dai luoghi in cui si prendono le decisioni e dalla sfera religiosa (integralismo di una presenza promessa, piena e bastevole). Ma nei paesi ricchi, la stessa sfera religiosa deve funzionare come un montaggio sincretico, come un videoclip costituito di diversi prelievi.
20/6 Idee bizzarre, forse misogine, sulle donne e il cinema. Non è forse vero che il cinema è diventato moderno, vale a dire adulto, quando ha cominciato a rinunciare allo star-system per far appa rire questo personaggio in definitiva inedito: la donna? Ancora Rossellini, Antonioni, Bergman, ecc. E non è che, nel momento in cui la donna appare, questo significa: adesso “non si gioca più”? Perché quelli che giocano sono gli uomini o la parte di infànzia con la quale essi sono ancora in comunicazione. In pre senza dell’eterno duo uomo castrato/donna feticcio si ha subito una divisione del lavoro che garantisce agli uomini uno spazio di gioco, gioco con lo strumento-cinema, masturbazione cinefila, il tutto sulle spalle della donna-oggetto. 262
Ma cosa succede quando le donne cominciano a fare film sem pre più di frequence? Succede che si esce da quell'ecerno duo e non semplicemence che i ruoli si invercono. Messa al posto di comando, la donna, in mancanza del parcner, non gioca, non accinge alla propria infanzia, non fecicizza l’uomo, non scherza. Cerci film di Akerman, Varda e, più recenci, gli ulcimi Muratova, Campion e Breillat non barano e rappresentano un cinema irrimediabilmente adulto. Questo cinema illustra il para digma lacaniano: la donna è la causa del desiderio dell’uomo e l’uomo è il simbolo di quello della donna. L’uomo è sempre nell’oggetto parziale (condizione di ogni “gioco"?), la donna nella totalità. Un oggetto ne chiama un altro mentre la totalità si scambia per una totalità più grande. Il bambino o Dio. Di questo parla Breillat in Sale camme un auge, un film bello e strano sul gioco della “mano calda”*9 che mette in contatto uomo e donna (lui le impone il “suo” desiderio, lei gli ruba il “suo” pia cere) e li ricongiunge - strierò sensu — solo nel momento che vede “uniti” desiderio e piacere. Breillat ha l’impudenza di filma re quel momento da più vicino possibile: sul volto e nelle parole (mentre fanno l’amore) dei personaggi. Si può dire che la donna faccia il suo ingresso nel cinema (come soggetto) solo dopo che il cinema ha rinunciato sia alle emozioni virili che al gioco-contratto con il pubblico? Esattamente come accade in questo film che parte da un’indagine poliziesca (sullo sfondo di un’amicizia poliziotto-delinquente) per poi abbando narla quando nella storia compare una donna. Twin Peaks (seguito). A un certo punto ho pensato: ecco la tanto sperata rivincita: la pubblicità ha cominciato a sviare il cinema, ma si direbbe che Lynch e Frost sviino la pubblicità sottraendole delle figure ancora capaci di assomigliare a quelle del cinema da feuilleton delle origini. Metafora: lo spazio pubblico diventa paragonabile a una strada pedonale o a un corridoio di grand hotel in cui, davanti a ogni vetri na e a ogni porta, un’immagine-logo sintetizza, segnala o vende l’esperienza che si presume abbia luogo all’interno. Ma per vedere bisogna pagare. Per contro, lo spazio privato è ciò che accade — o non accade — dentro i negozi o le camere ma del quale non si può più pretendere di vedere tracce, ricadute, racconti perché sarebbe con trario alla logica di mercato. Il primo spazio è pubblicitario, dunque non critico. Il secondo è privatizzato, anch’esso dunque non critico. 263
21/6 Discussione con Selim. Tema del “cattivo senso di infinito” che si insinua fra noi e le nostre vite. Perdita delle proporzioni, delle dimensioni, della prospettiva, ecc. Ipotesi: l’individuo (a metà strada fra il consumatore e il cittadino), nel momento in cui cessa di costituire il polo romantico dell'opposizione individuosocietà, perde ogni possibilità di grandezza ma “guadagna", all'opposto, una potenzialità di grossezza. La personalizzazione, la privatizzazione, il possesso di “esperienze” presunte producono un'ipertrofìa dell’io. Ciò che è grosso non è grande e ciò che è grande non ha cominciato dall’essere piccolo. Sono molto arrabbiato per non aver ritagliato una notizia dell’ultima ora di «Libération», pagina intera pagata da una fon dazione Yoplait (sic) e che parla di una Carta cofìrmata da giova ni sportivi di tutto il mondo. Articolo 1: la Terra appartiene a tutti. Articolo 2: la Terra è naturalmente bella. Seguono appelli ai governi “mondiali” e all’equa ripartizione dei beni. Abbiamo a tal punto fallito nel rimpiazzare il Dio padre con (’Uomo fratello da far ritornare il terribile matriarcato di nostra madre Terra? Si direbbe di sì. La “Terra” ridiventa il soggetto della Storia senza nessuna garanzia che i cattivi ricordi legati a questa ideologia siano spazzati via. Una Terra che non invoca alcun “sangue impuro” per irrigare i suoi campi, un ovile umani tario in cui l’uomo non è più il soggetto della Storia ma il servi tore della Terra stessa. Perché la preoccupazione ambientalista, che sembra ormai inevitabile, si traduce in questo nuovo appello alla mitologia folclorica e igienista, perfino fascista? È straordi nario come, in quella “Carta” fasulla, le contraddizioni fra gli uomini siano considerate così poco complesse e interessanti da essere cancellate con un tratto di penna, attraverso la finzione di un governo planetario. Ciò significa esporsi a tale delusione da poter stabilire in anticipo che questa ideologia universalizzante ricadrà molto presto nel candore dello yoghurt Yoplait. Dimostrazione che la fine della Storia non è un’espressione campata in aria. Comincerà (o rz-comincerà) la Storia della Terra, la storia naturale dell’umanità e del suo ambiente: catastrofi, guerre, epidemie, demografìe, varietà delle specie, in breve tutto ciò che venti o trent’anni fa era definito come estrema destra. I film di Karlin sulla giustizia in Francia. Evidentemente molto “istruttivi”. Dovrebbero essere mostrati nei licei, far parte della cultura familiare di ogni piccolo Francese sottoponibile a 264
giudizio. Il caso scelto è abbastanza anodino da non impedire di cogliere il funzionamento del rituale in quanto tale, vale a dire in quanto routine. Strano voyeurismo quello che consentirebbe una televisione “adulta” e “utile”: un doppio voyeurismo che contiene contemporaneamente un “richiamo all’ordine” (la realtà è tal mente semplice e banale da risultare insolita) e l'apertura erratica suir'umano" in quanto tale. E, nello stesso tempo, questo voyeu rismo non riesce a commuovere. Ci sono momenti (per esempio il furgone cellulare, dopo il verdetto) che se fossero stati in un film di finzione (naturalismo alla Pialat) sarebbero sembrati straordinariamnete giusti e terribilmente veri e che qui appaiono solamente ultraplausibili. C’è da augurarsi che i registi lo vedano e sappiano rifarlo, sappiano trasferirlo su un’altra scena, quella in cui si parla del soggetto e "dell’altro”. La forza sociologica del film di Karlin sta nel mostrare che la grande maggioranza dei crimini è commessa da esseri disgraziati e allo stremo che, in momenti di panico, uccidono altri esseri disgraziati e scremati. È chiaro che l’apparato giudiziario si accontenta di contare i colpi messi a segno in una guerra di classe che si svolge all’interno di una classe sola, quella delle vittime. Da qui il disgusto, espresso da Karlin con precisione e con un linguaggio personale. E noi, di colpo, ci ritroviamo ad essere gli osservatori di questa storia inte ressati unicamente a titolo di cittadini. Tutto ciò per dire che non c’è immagine se non in presenza delfaltro” e che questo altro è presente solo se c'è una scoria. In qualsiasi concesto, a introdurre l’alterità è la struttura di fondo che tiene separato chi racconta da chi ascolta, vale a dire un grado zero di transfert. 25/6 Ieri sera, alla televisione, trasmissione dal titolo Je zappe, done je suìs, in cui appaio quattro volte, con quattro frasi. Oggi vengono ad installate il cavo a casa mia. Strana sensazione che, quali che siano i discorsi tenuti dagli uni e dagli altri, l’attitudine sia la stessa: sorridente rassegnazione, impossibilità di tornare indietro, descrizione divertita o ironica delle possibilità future. La televisio ne è un’epidemia talmente diffusa da lasciare il mondo nello stes so tempo mutato e immutato. Come “video” (e un tempo “cine”), “tele” è una modalità del mondo e non un contenuto, uno scopo o uno strumento. Un po’ come Rinoceronti di Ionesco, in versione più soft. Contrariamente a quanto deve essersi verificato agli inizi del cinema, della radio e della cv, oggi non si riscontra più nessu 265
na fascinazione utopica, nessuna visione beata. Senza dubbio è in gioco la ricomposizione del legame sociale a partire dall’individuo e dal suo egoismo, nell’hic et nunc del presente. Il fatto sorprendente è che la frivolezza della televisione, tutti Ì giochi più o meno perversi che essa consente, la sua leggerezza ludica non sono proposti come argomenti e neppure li si ascolta nei discorsi telefagici: con assoluta, sorridente malinconia ognu no accetta di essere alleggerito del proprio corpo e del proprio tempo reale. Più che di una magica soluzione o di un’emancipa zione dal contingente, sembra trattarsi di un nuovo apprendista to: come vivere con quelle entità di intermediazione che sono le immagini e i programmi? Come ridefinire lo spettacolo del mondo una volta che si sono eliminati tutti i vecchi spettacoli e si è allargata l’idea di spettacolo non a degli spettacoli nuovi (come il cinema moderno) ma al funzionamento semi-oggetti va ro e semi-soggettivante del nostro mentale* Alla fine, è con la più grande serietà che si accetta di essere trattati come cavie in questa sperimentazione di massa, sotto la direzione degli americani e sul modello (temuto e invidiato) dei bambini inesperti. De Caunes40stesso, che è giovane, si interroga sull’avvenire di un bambino nato oggi e fa zapping su di sé tro vandosi già troppo vecchio. È la stranezza della tecnica dominan te: ci promette una riconversione ogni vent’anni e mette in cassa integrazione i quarantenni. Allora, o non si tratta proprio di riconversione oppure questa accelerazione deH’accantonamento ci costringe a ridefìnire ciò che chiamiamo “una vita”.
1/7 Idea semplice, ieri. Bisogna abbinare il cinema alla fotografìa e chiamare cine-fotografìco il secolo e mezzo (la modernità?) che ha visto l’umanità lavorare per l’autosufficienza dell’individuo attraverso terribili utopie collettive. L’individuo non è forse nato, “esteticamente”, il giorno in cui per ottenere il proprio ritratto ha dovuto fare quello dell’ambiente a lui stesso direttamente cir costante? Perché, riguardo alla tecnica di scrittura attraverso la luce, questo ambiente è dello stesso ordine? Diritto di prelazione della tecnica di registrazione sulla composizione iconica, leggero sfalsamento che “immortala”, a lato dell’oggetto mirato, ciò che il mirino ha "visto”. Tutto ciò ha comportato delle resistenze se si tiene conto che si è continuata a Hire la foto di identità con i soggetti a cavallo di un biciclo bianco, su fondo neutro o stilizza266
co, davanti al drappo da cabina per fototessere. La riproduzione del contingente non è soltanto il supplemento involontario delTatto fotografico, la placenta (il tessuto fecale) espulsa nell'acto della nascita di ognuno al “diritto” di essere rappresen tato, è anche ciò attraverso cui io compaio nell'immagine come il tal individuo. Coesistenza obbligatoria del soggetto (registrato) e degli oggetti (contigui, frattali?) in un blocco impuro in cui ciò che è stato voluto e ciò che potrà essere visto si incontrano. Il nostro umanesimo è di quel tipo («l'abito senza cuciture» del reale): non separare l’umano dal suo ambiente spazio-cemporale (in una certa idea di presente). Che cosa accade oggi? Il passaggio dal soggetto all’individuo è una vera mutazione e non una logica conseguenza. Le parole dominanti nello scenario attuale sono prelievo, autosufficienza, sepa razione, humour. La pubblicità ha costituito l’apprendistato collet tivo di quei processi perché ha permesso a larghe masse di acce dere a quel grado secondo che baratta la piatta contingenza di ciò che è con degli immaginari fra virgolette che permettono di rici clare, ma in vitro, un autentico stock culturale (tesoro) di effetti già prodotti, di emozióni standard, di esperienze segnalate (ma non restituite). La separazione chirurgica di quanto la cine-fotografìa aveva unito per sempre libera i componenti dell’immagine rendendoli compatibili con gli infiniti giochi del mondo mediatico (in cui la struttura del rimando è talmente generalizzata da perdersi). In questo senso, i bimbetei di Goude41, “ladri di colori’’, sono una bella immagine, molto poetica, di questo paesaggio in cui il colo re può essere separato dal suo supporto e vivere le proprie avven ture (avventure commerciali: un furto che deve essere punito). Certo, i modi di registrazione tradizionali possono aderire a questo movimento che li nega e le immagini tornare verso l’ico nografia. È quanto avevo tentato di dire con la distinzione immagine/visivo. L’immagine è ciò che ospita necessariamente la con tingenza dell’altro, il visivo è autonomo. Beinex, Besson, Annaud sono, negli anni Ottanta, persone che girano le spalle al cinema che li ha preceduti perché il loro desiderio è di essere i servitori artigiani di una iconografìa di massa (che ha ancora bisogno di una “immagine del cinema" come leggenda). In questo mondo, l’immagine non è più la traccia materiale di un incontro ma un essere geneticamente codificato che lavora per gli uomini. Se, per qualcuno come me, la prima cosa era il tempo (tempo guadagnato, inventato) e la seconda l’immagine, oggi è il 267
contrario: l’immagine è al primo posto ed è lei che guadagna tempo. L’immagine monta la guardia davanti al luogo opaco in cui “si opera”: il suo lavoro consiste nel divertire e distrarre il pas sante e nel proteggere provvisoriamente coloro che prendono le decisioni. In tal senso, le immagini all’avanguardia sono le imma gini di marca delle grandi aziende. Bisognerebbe studiare il ritmo con cui queste immagini si rinnovano, il loro confronto con le altre e le reali decisioni di quelli che se le fanno fare su misura. Ultima idea (lancinante): il soggetto (s maiuscola vietata) è tale in rapporto a certe cose: lo Stato, la Storia, il desiderio, il lavoro, il linguaggio. La sua grandezza gli è sempre derivata dal confron to, talvolta tragico, con quelle entità. Da cui il senso critico, la volontà di vederci chiaro, l'assunzione dei propri limiti, Montaigne per esempio. È così per l’individuo di oggi? Lo Stato non è più un buon nemico, la Storia è finita, il ciclo ininterrotto del piacere ha la meglio sul desiderio “che produce", il lavoro è astratto, il linguaggio meno rischioso. Noi non potremo continuare a lungo sulla strada del disincanto. Il re-incantamento del mondo avverrà a partire dal trio indivi duo-mercato-democrazia? Se sì, esso ha bisogno di un mondo in qualche misura de-soggettivato (dove il soggetto cessa di essere un nocciolo duro, un irriducibile del desiderio). Ma questa perdi ta di esperienza propria (“il libero disporre di ciò che ci è pro prio") va di pari passo con una ri-’’soggettivazione" di tutte quel le sfere ormai raggiunte dall’attività umana (logosfera, mediasfera, atmosfera, zoosfera, tecnosfera). La sfera del quasi-umano si ingrandisce ogni giorno, tanto sul suo versante ecologico (“i diritti del pianeta”), tanto nella crescente familiarità con le pro tesi (dall'animale al computer, dalla cavia al robot). In altre parole, è il pratico-inerte ad essere condannato (le “cose” in quanto possedute) mentre viene incoraggiato un certo animismo discreto. I giapponesi sono allineati con questo smus samente della coppia soggetto/oggetto e la loro cultura degli oggetti, dei giocattoli, della cortesia e della premura sembra meglio adattarsi ai nostri tempi di quelle che si trascinano il monoteismo come una palla al piede (i russi sono i più irrecupe rabili). Così, è possibile che la democratizzazione di massa consi sta nel permettere al maggior numero di individui di fare, uno per uno, “(’esperienza” individuale di un cliché collettivo e non nello scegliere, fra soggetti presunti uguali, quelli che “si espri mono” in modo personale e gli altri, moutons de Panurge*2. Tutto ciò si accorderebbe con il mio bilancio della guerra del Golfo: 268
moki individui hanno dovuto rivedere l’immagine di loro stessi, ma ciascuno per sé e contemporaneamente, così che questo non ha avuto un’incidenza collettiva. La guerra dunque non ha avuto luogo collettivamente ma, senza dubbio, “in privato’’. Comunque non siamo più obbligati a parlarne.
6/7 Visto Borderline di Danièle Dubroux. Film molto impressionan te. Così come mi sembrava che Breillat proponesse un “contro campo” della visione di Pialac, Dubroux mi fa pensare a Truffaut, al Truffaut monomaniaco di certi film e al Truffaut che spende molte energie per ottenere la continuità narrativa del suo racconto cinematografico a forza di “piccoli fatti veri”, nello stes so tempo osservati con esattezza e inquietanti. Seguito del capi tolo: le donne dietro la macchina da presa. “Cinema d’autore” non significa più niente, e nemmeno “cinema personale”: occorre dire “cinema alla prima persona singolare” poiché esso si occupa degli interessi molto privati di un individuo: la donna-autorepersonaggio-attrice Dubroux. Quando il film finisce, si è piutto sto sorpresi nel rendersi conto che non soltanto il racconto ha una sua compiutezza (un po’ alla Bunuel, come un sogno labo rioso dal quale si esce con uno strano sorriso) ma che accade la stessa cosa a livello del contenuto. Dubroux infatti “difende” la causa di Hélène e ottiene la sua assoluzione (anche se è permesso pensare che sia pazza). Il film non è costruito dal punto di vista dell’uomo che guarda una donna scivolare verso la follia (Repulsion, citato) ma da quello di una donna già folle che osserva la tela di ragno in cui ha intrappolato i suoi "compagni” e la trova perfetta. Dubroux, critico cinematografico, conoscitrice dell’inconscio e dei suoi percorsi circolari, si serve di questo sapere per fare la sua arringa e, anche a livello di interpretazione, ha partita vinta. La protagonista non soltanto “passa all’azione” ma, ventanni dopo, forse per effetto di un senso di colpa, innesta una “marcia superiore”, forse un effetto di contraccolpo, e “con cretizza” il fantasma all'interno di un intrigo. Il fantasma è di essere stata l'amante del proprio figlio, ripetizione di Edipo dal punto di vista di Giocasta. Un autentico atto di sfida, una forza tura simbolica davvero stupefacente.
Visto anche l’ultimo film di Manoel De Oliveira (La divina commedia, ndt), che mi ha lasciato più perplesso. Ancora la follia. 269
Un manicomio in cui ciascuno rivive degli episodi (soprattutto) dostoèvskjiani, sotto lo sguardo degli infermieri e del medico. Mira all’essenziale ma ha un ritmo strano (come se un cattivo infinito fosse in agguato) ed è leggermente noioso nei momenti statici. Non appena si muove, anche di un niente, è subito De Oliveira, cioè un regista del lato comico intinseco al movimento. Il movimento è sempre gag della “messa” in movimento, imme diata anamorfosi. La sola idea che ho avuto riguarda questo aspetto, presente, ad esempio, nella resurrezione di Lazzaro (con la propria bara sotto braccio) o nella scena, che ha fatto molto ridere J.C.B. e me, in cui una fresca fanciulla si getta dalla fine stra. Subito dopo, ripresa dall’alto, la vediamo distesa su un prato molto verde. Poi si alza e, come un bambino che viene scoperto e “non gioca più”, si allontana. La comicità di De Oliveira: lo sguardo mette in movimento e il movimento infrange la consistenza dei corpi. Bella scena in cui Manoel stes so (al posto di un attore morto durante le riprese), tutto ilare con una parrucca biondastra, ruba la scena ai suoi personaggi (Ivan e Aliocha Karamazov) e, quasi fosse a una conferenza stampa, risponde a domande sui temi più gravi. Egli dice di non “credere né a Dio né agli uomini”. Stranamente, per un regista cristiano, io lo trovo molto poco religioso, troppo diver tito dalla pura contingenza per rinunciarvi a vantaggio di una trascendenza qualsiasi.
16/8 ECHI DALLE VACANZE * A Taormina, cinema contro video. Dopo il festival, qualche giorno di incontri video. Tento di farmi notare. Prima, nel corso di una chiacchierata su Debord che muta in commedia all’italia na quando uno spettatore insorge all’idea che nessuno, neppure fra Ì partecipanti, ha potuto vedere i film di Debord. Subbuglio in sala. Valentina Valentini, anima della manifestazione e nemica immediata, fa fronte alla situazione. Viene mostrato un montag gio di immagini tratte da un libro di Debord. Uno dei presenti, giovane e nordico, mi viene a parlare. Gli nomino Straub. Non lo ha mai sentito. Sono esterrefatto (e di cattivo umore). Impressione che il video sia un’impostura, almeno in questa forma festivaliera istituzionale in cui chiunque può vendere fumo a scatola chiusa, senza dover dar prova della propria conoscenza e della propria passione. E, in questo caso specifico, impressione 270
che non ci sia alcun rapporto fra Debord e il video e che egli si sia accontentato di guardare con ironia e fissità degli spettacoli di cinema, da Ford a Riefenstahl, contemporanei dell’idea e dell’immagine di massa (e) secondo Elias Canetti. L’indomani, stesso discorso con dei video di Godard, fra i quali una buona parte di Histoire(s) du cinéma, messa a disposizione da TofFetti. Comincio a parlare fino a quando la Valentini, quella zotica, mi interrompe. Questioni di orario, ecc. Anche in quel caso, Godard ha usato il video come lo strumento del momento per interrogare una cosa diversa dal video: il cinema. In entrambi i casi, trovo del tutto insignificante e inadeguata l’irregimentazione di questi due cinefili francesi nei freddi meandri del video. Alla fine, al ristorante del Duomo, il piccolo gruppo restante di appassionati di cinema ricrea uno spirito di connivenza.
* India di Rossellini. Stessa copia di qualche anno fa a Pesaro. Riformulo la mia idea di Rossellini. Da un lato, egli è stato un geniale anticipatore riguardo all’evoluzione dei supporti e all’apparizione nel cinema dell’idea di trasmissione ripresa poi in televisione. In tal senso Rossellini è come un campione automo bilistico che taglia il traguardo con diversi giri di vantaggio. Ma dall’altro, gli è completamente sfuggita l’idea forte del cinema delle nouvelles vagues, o piuttosto il suo soggetto, che è, credo, l’assurgere a dignità estetica dell’idea di minoranza (categorie che non coincidono più con le classi sociali). Senza dubbio, è questa idea a costituire la grandezza di Fassbinder negli anni Settanta: i giovani, le donne, i bambini, gli omosessuali, gli immigrati, ecc. Rossellini è rimasto (un po’ come Godard) alla contrapposizione fra generale e particolare e ha optato per il generale, cioè per il progresso globale del genere umano. Per questo, in India, gli amori paralleli degli elefanti e dei loro custodi sono di un pater nalismo disgustoso. Più affascinante la storia della scimmia che si ritrova ad esibirsi su un trapezio sotto gli occhi di un’rf/rtw scim mia. L’antropomorfismo di Rossellini è così assoluto che mi chie do come è stato possibile non notarlo. * Rivisto alla tv (a Locamo) L’amore fugge di Truflàut, che ha qualcosa di davvero straordinario. Un tale virtuosismo che nem meno ci si fa piu caso. Il materiale figurativo di Truffaut è così brutto (nessun senso dell'estetica) che finisce per sfuggirci ciò che è bello, vale a dire il funambolismo dello sguardo (e, in qual che misura, del personaggio Doinel). Ogni scena, in Truffaut 271
(regista della scena, non dell’inquadratura), è un gioco logico che obbedisce ad una sola legge: da dove si esce? Tutto è filmato dal punto di vista della porta, del passaggio, dello spiraglio, della via di fuga. Il tema del passage, nel senso attribuitogli da Benjamin, è onnipresente nella pittura della Parigi del XIX secolo. E c’era già in / quattrocento colpi. Fino alla spiaggia finale. La verità umana di una simile scenografìa è dovuta semplicemente al fatto che il seduttore prima di tutto si preoccupa di individuare il modo di fuggire dal luogo in cui penetra. Ed anche alla voce interiore (e all’intonazione un po’ marcata) di chi non smette di “fare il punto della situazione’’ e cerca solo delle vie d’uscita. * L’bomnie qui a perdu son ombre, di Tanner. Un po’ contestato a Locamo. Si comincia a temere il peggio e poi qualcosa “prende’’, ma cosa? Immergere dei personaggi contemporanei in un ambiente chiuso e attendere il sorgere da quel luogo di una forza d'attrazione. Immergerli con i loro discorsi, il loro linguaggio particolare, i loro tic, i loro compiacimenti. In questo caso, l’ambiente è la Spagna del sud, bianca e ventosa, capace di imporre il suo spazio-tempo.
* Trois jours en Grece, di Pollet. Punto comune con il film di Tanner: un personaggio del Nord va a farsi dare lezioni (di vita, di saggezza) da un “vecchio amico” del Sud, un filosofo di strada. Civetteria masochista? Pollet, come sempre, senza il carattere naif di Mediterraneo e con più affettazione. Debolezza viscerale e ostinazione. Gran bel pezzo di cinema “puro”: la macchina da presa come in assenza di gravità (la Louma?) per le strade e nel metro di Atene. Pollet: l’unico regista ad aver sempre filmato solo dal punto di vista del fantasma.
* Incontrato Mizrahi in due occasioni: per la conferenza stampa di Negulesco e per scortare Freda. Per la prima volta (era ora) ci parliamo e ascoltiamo un po’. Io guardo quelli che, come me, hanno vissuto di cinema e mi sorprendo che essi abbiano potuto vivere cose diverse dalle mie. Mizrahi, spietatamente fedele al cinema di genere e di studio della sua infanzia, non ha visto o non ha voluto vedere che quel cinema stava morendo quando noi arrivavamo. Ha dunque deciso di accompagnare personalmente non le opere ma gli uomini, oggi ottantenni, in veste di super addetto stampa, scagnozzo, galoppino, erudito esaltato. Il treno successivo, quello del cinema moderno, lui non l’ha né visto né 272
preso. Ha impiegato un'energia che incute soggezione nel difen dere dei registi che erano, tutti, asserviti e fieri di esserlo. Non ha provato ammirazione per la difficile indipendenza dei moderni e non ha capito che Freda o Negulesco non continuano a fare dei buoni film da artigiani /w lui. Questo carattere è uno dei modi di essere omosessualmente cinefili: esteriormente tonitruante, interiormente sottomesso. Oggi, noi possiamo discutere sul tema "è tutto finito", con la differenza che io ho tentato di aderire al mio tempo (un treno in più) e lui no, ma quello che è buffo è che questo non ha più molta importanza. Ed è ancora più buffo che Freda e Cottafavi, che a Locamo si sono abbandonati a uno show comune e velenoso, ritengono di essere sulla buona strada per seppellirci.
* Il nostro cinema. Intendo quello della gente dei «Cahiers» o ad essi molto vici na, gente che ha cominciato dopo la Nouvelle vague. Chi ha rea lizzato, a mio parere, dei film convincenti? Garrel, Moullet, Jacquot, Biette, Téchiné, Dubroux. Questi registi (solo Téchiné là un po' eccezione) hanno un punto in comune: descrivono una certa grandezza nella piccolezza. La grandezza è quella del simbolico puro (obbligo morale di filmare e di raccontare attenendosi a un punto di vista) mentre la piccolezza è il corto circuito dell'imma ginario che non soltanto concede poco allo spettatore ma esibisce questo “poco". Nei loro film, c’è una contabilità significante nello stesso tempo buffa, meschina e implacabile (letteralità di Moullet, corpi-giochi di parole in Biette, corruzione in Jacquot, regolamento di conti in Dubroux): l’esibizione del valore d’uso al posto del valore di scambio. Che allegria!
21/8 * Malgrado tutto, è Atlantis il film che vedo per primo, tanto ho la sensazione che Besson sia il pesce pilota decerebrato che introduce con maggior sicurezza a questo dopo-cinema che si prepara. Malgrado tutto, più curiosità presto delusa che fascina zione zen, il colmo per chi, come me, ha un’infinita tolleranza di fronte al défilé delle bestie. Forse Besson è dotato di una reale intuizione per i luoghi "dove le cose accadono”, ma manca trop po di idee e quelle che sembra avere sono quasi tutte dei cliché. Quello che gli riesce meglio è senz'altro la messa a punto del pro zìi
dotto, vale a dire un film "privativo": senza trama, senza parole, senza esseri umani. Quanto occorre per assicurargli la visibilità mediacica. Visto più da vicino, questo prodotto fluttua fra diffe renti modi già visti di organizzare il mai visto e non fa che met tere uno dopo l’altro diversi spot senza conservare niente a mano a mano che procede. Ho pensato a lungo (mi tranquillizzava) che il film evitasse del tutto di parlare della predazione e della ripro duzione. Ma no. Salvo che gli atti di predazione sono riservati agli squali (davvero sorprendente!) e la riproduzione è trattata nella maniera disgustosa della ripetizione seriale (le razze, le tar tarughe, le murene...). Si sente che i paradossi del regno animale non sono più di moda. Il film oscilla fra due poli. Da un lato, le avventure della perce zione (la perdita dei punti di riferimento, il "barcamenarsi", let terale), dall’altro, il défilé di moda (il “numero” più impressio nante dei quali è la sfilata delle razze giganti). Stessa musica invadente e volgare dei défilé, per far risaltare la strana sofistica zione delle forme e la loro eventuale eleganza. È comunque questo secondo aspetto che domina, con le ridicole metafore dei banchi di pesci-pubblico d’opera (musica di Bellini, voce della Callas) e, infine, una presenza indiretta, ma fobica, di quella umanità che si è presuntuosamente evitata fin dalla prima immagine. Il riferimento a // mondo del silenzio si impone. Ma il film di Malle e Cousteau si compiaceva di alzare il sipario su esperienze inaudite e desiderabili: esplorare il fondo dei mari, immergersi, incontrare i pesci. È questo ad essere scomparso (a vantaggio di un'atmosfera mortuaria da misantropi), neppure sostituito da un altro sentimento. In quel film c’era una promessa, in questo no. È anche vero che dopo Cousteau si sono viste molte immagini sot tomarine e sempre più gente comune si è immersa: il mai visto è dunque diventato più difficile da ottenere. A parità di cose, se negli anni Cinquanta Cousteau e Malie sono un po’ degli avventu rieri (ansiosi di aprire le porte della percezione), Besson, quasi quarantanni dopo, filma con più mezzi tecnici ma con l’occhio del turista. Il modo in cui le creature marine sono incontrate, seguite e presto abbandonate deriva soprattutto dall'indifferente folclore visivo delle società contemporanee. Nei confronti di tutti questi animali non si prova alcun senso di banale identificazione ma neppure il sentimento di una ottusa alterità. Essi risultano altrettanto vicini e casuali degli umani che se ne stanno là in alto, sulla costa sovrastante. Tutto ciò è dunque lontano dall’essere quel luogo di rifugio primario e amniotico che potrebbe. 274
Besson va là dove è in gioco qualcosa: della forma e del rappre sentabile. Qualche volta arriva a un passo dal ('incontrare l'enigma della forma in quanto tale. Ma tutto viene ricoperto troppo presto o è soffocato dalla musica. Più che ri-scoprire gli abitanti del fondo marino “così come sono”, si ha l’impressione di vederli prestarsi di buon grado a degli spot pubblicitari dei quali essi sono gli eroi narcisisti. Dunque, il grado zero dell’alterità conti nua, ma passa per una casella di partenza lontana, quella degli inizi del cinema e delle teorie della fotogenia. Si prova molta paura nel vedere le razze giganti o gli squali, ma non perché sono brutti, perché la loro bellezza è sempre-già-poetica. Siamo un po’ più tranquilli di fronte al procedere della piovra dal color rosa spento perché quella bellezza è meno conosciuta e abbastanza spaventosa. Ma si sente che Besson, per montare tutta questa massa di pesci, non ha previsto alcun principio logico né poetico. P.S. Il film è stato mostrato e distribuito a lato del mondo del cinema, contro di lui. Besson, rabbiosamente, si colloca da solo nella categoria “fenomeno di società” ed evita di aver a che fare con i critici. Pois-son et lumière 25/8 Il buco di Becker è un film straordinario, che non assomiglia a niente. Lo rivedo con i due Jean-Claude (e parecchia eccitazione). L’inizio è affascinante. Il film non perde niente della sua enigma tica violenza fino al momento in cui tutto rifluisce verso la figura di Gaspard e precisamente nella scena del parlatorio, con la ragazza che a noi suona falsa (ma we are prejudiced) perché ci sem bra chiaro che Gaspard è omosessuale. La lettura del film ne risente. 1)0 Gaspard, "checca eterosessuale”, tradisce perché non riesce a liberarsi del suo inconscio desiderio omosessuale; 2) oppure, omosessuale “travestito”, tradisce perché il mondo in cui viene introdotto è quello degli uomini veri, ma così veri da essere degli angeli, figure laiche di una favola religiosa, intercessori fra il mondo materiale e l’anima di Gaspard (riguardo al mondo, al “sociale”, questo funziona piuttosto bene), certamente dei resi stenti anche se non si sa bene a che cosa e a chi. L’omosessualità è al centro di questo film, ma in un maniera davvero strana, qualcosa fra Hawks e Melville, fra l’ideale della fra tellanza e la semplicità dei corpi intatti. Quello che a me e a J.C.B. sembra straordinario è che lo sguardo di Becker, alla fine degli anni Sessanta, fosse il più aperto possibile, il più attento, il meno 275
didascalico. Il buco non è un film sul paradigma prigione-evasione, non è Bresson, è un film che lavora (non trovo una parola migliore) con l’idea di libertà. Così bene che la tecnica dell’evasione pone meno problemi delle ragioni di evadere: è la libertà ad essere presa di mira (e conquistata, per il tempo di una sublime inquadratura, passando attraverso le fogne) e non la salvezza individuale (attra verso la liberazione). In questo senso, si tratta forse di un’immagi ne tardiva ma pura della resistenza politica, della guerra. Ciò che mi ha colpito è il ritmo davvero inconsueto di questo film. Lo spettacolo dell’evasione non è soltanto di una fotogenia che si taglia col coltello, ma si svolge con uno strano timing', ho avuto l’impressione che le cose accadessero /vr la seconda volta, vale a dire né attraverso la ripetizione (a forza di, ecc.), né attraverso l’improvvisazione. Quando il film comincia, senza una parola, senza avvertimenti, i preparativi, le motivazioni, le decisioni, i dispositivi sono già stati decisi e si è dovuto procedere a una sola ripetizione. Siccome i personaggi sono dei professionisti, dei genia li inventori toccati dalla grazia, essi passano di successo in successo e noi non abbiamo diritto ad alcuna psicologia (conflitti, litigi, demoralizzazione) e la storia finisce male non per loro ma solo per Gaspard. La loro droga è la libertà, il problema di Gaspard la libe razione: questo li fa appartenere a due mondi diversi e la loro mano tesa lo era forse solo per lui, al contrario della metafora kafkiana della porta aperta qui sostituita da un buco da aprire. Infine, enigmaticamente, un'immensa emozione quando cominciano a scavare, con il conseguente rumore, fracasso subli me che ha forse la virtù di far scomparire tutto il resto.
30/8 Formulazione semplice di un’idea che mi gira per la testa. I film che trovano con sicurezza il pubblico, che lo appagano e soddisfa no, appartengono a una specie particolare. A differenza di quelli che amiamo noi, che sono al presente, questi film sannno dosare passato e futuro. Il futuro è sempre una certa mutazione, un divenire dell’immagine, una sua ridefinizione tecnologica. Diciamo dunque che, fin dagli inizi, il cinema di Besson è un cinema dell’epoca in cui l’idea dell’immagine di sintesi — ancora nient’altro che un'idea, una velleità — fa precipitare tutte le altre immagini nel passato. L’immagine di sintesi non proviene dallo sguardo (imprimere ciò che si è visto), in essa lo sguardo viene do|x> (vedere ciò che si è impresso, vedere “ciò che questo produ 276
ce”). Un mondo, dunque, in cui è vano aspettarsi che un cineasta abbia uno "sguardo personale", una “visione”. Se l'immagine di sintesi è quello verso cui si va, i film che avranno successo saran no quelli verso i quali si andrà, certo, ma rinculando. Benché l'immaginario di Besson sia già pieno di cliché visivi dovuti più ad una programmazione collettiva (dell’imagine e del pubblico) che ad una esperienza individuale, ciò non impedirebbe al film Atlantis di giocare un ruolo ideologico (un ruolo di “cinema puro” giacché privativo) di cinema, di resistenza del cinema ai media o alla televisione se esso non [traducesse l'immagine di domani servendosi delle tecniche di ieri. È perché Besson, immergendosi di persona, porta la tecnica di ripresa ad un livello impressionante che gli si è grati di produrre un’immagine sostanzialmente sinte tica del mondo. L'effetto Besson non esisterebbe se egli fosse più onesto, come era Cousteau ai suoi tempi, e mostrasse con chiarez za la capacità dei computer di produrre immagini paragonabili a quelle cinematografiche. Per il momento, invece, tutto questo non deriva che dalla tecnologia applicata e non beneficia di alcun “surplus" mediatico. Si può generalizzare quest’idea? In ogni caso, essa permette di distinguere i film realmente innovativi dai film come questo. Già all’inizio del dopoguerra, Rossellini fa delle anticipazioni sulla futura immagine televisiva, ma egli trova immediatamente i soggetti, i corpi e gli approcci che già corrispondono a questa immagine. A sua volta, Kubrick, in 2001, va in modo diverso verso qualcosa di ancora differente. ALLEMAGNE NEUF ZÈRO. Non molte idee, ma un piacere autentico nel vederlo e nel riattraversare, una volta di più, le figu re godardiane, qui al massimo della loro limpidezza ed efficacia. Il suo miglior film da molto tempo a questa parte, che riprende le cose buone di Histoire(s) du cinéma e di Nouvelle Vague, evitandone gli errori e gli effetti più fastidiosi. Se dovessi scriverne, partirei da una parola: film abitato. Senza vuoti né tempi morti. Abitato dal suo soggetto, la Germania (secondo film su un Paese, dopo No, la folle gloria del comando di De Oliveira), vista nello stesso tempo come il buco nero e la frontiera dell’Europa. Qui, il mon taggio è come un viaggio in cui con calma si organizzano tutti i livelli: suoni, musiche, immagini, cultura, cinema: si può andare da Est a Ovest, dal passato al presente, percorrendo indifferente mente tutte le strade (“che non portano da nessuna parte”). II passato è l’Est, prima nazista, poi comunista. L’oggi è l’Ovest dei mercanti. Il passato è il cinema. L’oggi, la televisione. 277
Dunque, il cinema — che è immagine — è frutto dell'amorosa testimonianza di un passato gelido, lugubre, sconnesso (il pae saggio dell’Est). Bellezza da togliere il respiro delle immagini di partenza, banale inesistenza delle immagini d’arrivo. Non ci sono due Berlino, due paesaggi che si oppongono, c’è il cinema, dopo il quale non viene niente. Dal momento che di questo paesaggio comunista non abbiamo visto che immagini parziali, circoscritte, tecnicamente schifose, nulle dal punto di vista sonoro, proviamo il folle sentimento di vederlo per la prima e ultima volta: sven trato, patetico, mezzo russo. Senza dubbio, Godard rimprovera di più alla Svizzera di non aver giocato alcun ruolo nella partita della Storia, da cui è stata solo sfiorata, che di non essere stata capace di giocarlo bene. Adesso è chiaro che la Svizzera non aveva molti anticorpi antina zisti (non più dell'Austria). A un tratto, il piacere dell’autocritica e del senso di colpa viene negato agli svizzeri. J.L.G. preferisce i tedeschi dell’Est che hanno sempre sbagliato a scommettere (da cui deriva oggi un’eccedenza di "coscienza storica” malata che stona con la beata tranquillità dell’Ovest). L’anti-americanismo. L’Europa. Il vecchio mondo (al quale è stato preso tutto).
5/9 CARAX. Eroismo — Volontarismo — Contro-allegoria — Riscatto. Stessa distinzione che per Mauvais sang. Due evidenze: il talento irriverente ma con qualcosa di forzato (una forzatura dell'emozione), un rullo di tamburi stilistico ma una certa fragi lità quanto a convinzione, una contraddizione fra lo stile (la sce nografia come laboratorio, i personaggi come cavie) e il tema (l’amore), una sproporzione fra mezzi e fine. Carax sembra il solo regista della sua generazione ad installarsi con spavalderia fra passato e presente, romanzesco e romanticismo, in fine ed ex nihilo. Il suo debito nei confronti del cinema moderno (soprat tutto Godard, vale a dire il ribaltamento del topos ragazzoragazza) mi sembra meno importante della sua filiazione GanceDemy: intimità estrovertita. Per non parlare di Minnelli, Coppola. In tutti loro, stessa concezione di un’arte che salva. Concezione romantica. Non si tratta comunque del ritorno di Carnè, dal momento che il tema del destino (l’uomo con le chiavi) vi è pre sente in misura minore. 278
Perché è necessaria tanca energia per affrontare i soggetti più semplici? Domanda già posta per Un sogno lungo un giorno. Perché questa dicotomia fra il soggetto e la scenografia? Problema oggi abbastanza generalizzato, dato che i nuovi registi sembrano obbligati a svuotare i luoghi prima di ri-adibirli, ri-offrirli al movimento anonimo del mondo. Nel caso del Pont-Neuf, esem pio di Christo. Carax ostenta l’eroismo ostinato di un programma: salvare il cinema per mezzo dell’arte. Ciò che salva, in extremis, la coppia è che la prima scena del film (Alex investito. Michèle lo crede morto e ne disegna il volto) si riallaccia ad una delle ultime. Interessante, perché contrario, se confrontato a quanto avveniva in La bella scontrosa. Rivette non fa assegnamento su alcuna azione dell’arte sulla vita e “fa sparire" la donna, non offrendola allo spettatore. Concezione romanzesca. Il romanticismo di Carax, più vicino a Godard, consiste nel far coincidere due movimenti. Quello attraverso il quale egli offre la bellezza della donna che ama al pubblico, ma al termine di una serie di prove in cui essa è stata sfigurata. E quello in cui, grazie a questo per sonaggio (che dipinge), il salvataggio della vista, dunque dello sguardo, della possibilità dell'altro, dell’amore, del cinema, diventa possibile. Il film può essere visto come la genesi di questa immagine (che noi non vedremo) a partire da un mondo visivamente sregolato, esploso, certo pirotecnico, ma senza grazia (drogato, piuttosto: lo sci nautico, il mangiatore di fuoco sono nello stesso tempo veri e falsi “momenti di cinema"). Navigare verso Le Havre su un bat tello carico di sabbia degno di Vigo è come partecipare alla costruzione della spiaggia, come dei bambini con il proprio castello, e non come dei campeggiatori di una notte (Alex si guarda la punta dei piedi). Per una volta, l'immagine che conta non è quella della ragazza (essendo il ragazzo un artista), ma proprio quella del ragazzo. Finché non è pronto a vedersi nello sguardo dell’altro, il suo amore è mortifero e non sopporta nessuna immagine (il fuoco). Questo significa dare molta importanza al personaggio di Michèle (la scena più bella, esattamente alla Gance, nel metrò, quando lei appare rassegnata). Probabilmente, è impossibile avvicinarsi all'amore in una sce nografia dalla quale è stato innanzitutto escluso il mondo profa no. In Ray o McCarey è presente il sociale. La differenza con il Godard di Bande à part sta da una parte nella visita di venti 279
secondi al Louvre (bambini viziaci dell’arce, provocacori) e dall’altra nella encraca noccurna clandestina al museo per guarda re un solo Rembrandt (e toccarlo). Siamo passati da più immagini a una sola. E forse è questo il problema. 7/9 Alla radio, quesca mattina, la trasmissione dell'untuoso Finkielkraut che invita Beineix e Desplechin a parlare di cine ma. Desplechin è uno che non dice stupidaggini. Beineix fa la sua solita parte da cui viene fuori che lui è molto sfortunato e si considera uno che fa della resistenza. Il colmo, ma che dimostra come la qualifica di resistente sia assai ambita. Non è che Beineix abbia del tutto torco, piuctosco il suo errore è di credere che ciò che in lui resisce è Vartista, l’arte in generale e non, in particolare, il cinema. Ci sono registi che resistono perché pen sano che la pratica cinematografica in se stessa garantisce un minimo di continuità umana. In questo senso, la Nouvelle vague ha resistito. Proprio perché essa aveva due o tre convin zioni teoriche e morali sull’atto del filmare (significativamente, Beineix cica male la frase di Godard: il carrello come problema morale divenca per lui problema “policico”). Ma si può resiscere in nome dell’arce in generale e della figura scucchevole e roman tica dell'artista in particolare? È perché deve avere dei comples si di inferiorità nei confronti di questo “mondo deil’arte" (come dice Garrel), e per non essere mai stato riconosciuto da esso ma solo dal pubblico (sociologicamente, come uno dei suoi) che Beineix è così a disagio ed è obbligato ad assumere rabbiosa mente la posa e a prendere il partito dell’artista (puro) contro la società (corrutrice). Ma quesca concezione è essa stessa dominante. L’opposto, che finisce per essere complice, dello stra potere mediatico è infatti la concezione romantica dell’artista come isola di purezza. Anche in questo caso, l'errore è quello di confondere purezza e innocenza. La purezza è roba da acqua minerale, l’innocenza è un modo di non “pensare male” senza tuttavia essere buoni. Ridiventare marxista? Desplechin parla abbastanza bene del “lavoro” come tabù assoluto di un mondo in cui si lavora più che mai. L’attuale alienazione è rappresentata da un laco da società in cui i giovani non vedono ciò che li potrebbe sottrarre alla giungla moraleggiante dei mercato, cioè, come dice ancora Garrel, alfideologia del lavoro" (giovani che hanno visibil mente paura di “non essere all’altezza”, da cui il loro gusto per 280
le profondità di Le grand bleu)t dall'altro da una organizzazione delle immagini e degli ambienti in cui l’idea e lo spettacolo del lavoro sono tabù. Alla fine, ciò che resiste è il lavoro, non per ché esso sia l'essenza dell'uomo o altre sciocchezze cristiane, ma perché costituisce l’unico vettore oggettivo di empatia e di comunicazione. Sempre il problema di come impiegare il tempo. La resistenza di Beineix o di Besson è falsa in quanto consolazio ne romantica e decorativa compresa nel pacco-dono complessivo. Per come siamo stati nutriti, è impossibile che noi, un giorno, si possa amare tutto questo, anche se per esso si può provare la stes sa simpatia che si ha per il proprio supermercato. Più complesso, ma comunque della stessa pasta, è Carax. Questo discorso solleva inoltre una questione più ampia: stori camente, quali sono stati i rapporti fra “arte’’ e “resistenza"? L'arte ha potuto essere fatta da dei resistenti, ma ha saputo resi stere da sola? In tempi diversi, artisti di corte, politicanti roman tici, avanguardisti “che non potevano fare altrimenti", impiegati di industria hanno fatto “dell’arte”. È molto fastidioso che l’arte si consideri in sé come resistenza. Per «Trafic» non ce ne sarebbe alcun bisogno. Ieri, un documentario su “La generazione Grand bleu". Volti graziosi e musetti da adolescenti accompagnati dal rumore di fondo di sciabordìi oceanici. Difficile da confrontare con ciò che questo sarebbe potuto essere nella nostra generazione. Nel I960 c’era il rock, il desiderio di emanciparsi, la provocazione sessua le, la brama del mondo da abitare, e soprattutto non c’era l’effet to-re trovi so re istantaneo dei media-specchio. Dunque, è la prima volta che tanti giovani, attraverso un film, parlano della loro paura come se appartenessero ad un fan club molto serio, niente affatto divertente. Lo fanno con una onestà opprimente, senza alcuna voglia di approfittare della loro giovane età per sedurre-cazzeggiare. L’individualismo non è il loro orizzonte, è ahimè il loro fardello e questo li rende molto conformisti e terri bilmente sinceri. Forse, siamo stati noi, (potenziali) genitori ses santottini che non hanno rinunciato alla loro antica immaturità, a creare questi bambini che sanno di essere giovani e immaturi ma che già si fanno carico del loro piccolo “Io s.r.l." e che hanno paura di impantanarsi, vista la scarsità di vie di fuga tanto nel loro mondo che nell’universo mediatico nel quale stancamente slalomeggiano. 281
8/9 CARAX (seguito). Risucchiato dalla macchina! Carax come uno che si muove su due piani: il suo e quello del cinema. Dimostrazione della bellezza del cinema parallela a quel la del talento del regista. Strana ridondanza. Esempio: la caduta nella Senna dal Pont Neuf. Non più o/o, ma e/e. E la continuità della scena sott'acqua e il punto di vista dalla superficie. E il bacio sottomarino e la micro-suspense: riemergono? Tutti e due? In che ordine? E dove?
Discussione con P.B.: il romanticismo (l’artista eroe puro in un mondo sudicio) come attuale passaggio obbligato in un mondo troppo indifferente. Rovesciamento complice o male necessario? Non è ancora troppo ideologico? 10/9 FINO ALLA FINE DEL MONDO (Wim Wenders). Come per il film di Carax (in cui sopravvive l’immagine dei due ragazzi per duti), sensazione confusa che non si dovrebbe abbandonare il film, che farlo significherebbe un po’ abbandonare se stessi. E anche sensazione che i difetti del film non debbano essere né taciuti né messi alla gogna.
Doxa. Formidabile tutta la parte iniziale (un videoclip che crea intimità), poi sorta di Intrigo intemazionale trent’anni dopo, con l’esaltazione dei mezzi di locomozione e del “MacGuffin” (un film di Wenders cosmopolita ma non abbastanza “comme dia” né abbastanza Arkadiri), in seguito un episodio molto bello da film di avventure (l’Australia come Heimaf), infine una rifles sione assai rischiosa sulla malattia delle immagini. Più film in uno. Entropia. Volontà di fare bilanci sempre più esaustivi quando Wenders rimane il cine-fìglio docile e sentimentale che è sempre stato. Cinefilia. La sceneggiatura ne offre una buona versione. La Storia sono i viaggi di Mamma e Papà. Viaggi che rappresentava no una diaspora. Il cinema sono i viaggi del Figlio. Facoltativi (e relativizzati dalle macchine che garantiscono l’ubiquità). Il Figlio aiuta Papà a controllare i poteri di una macchina “per vedere ciò che è stato visto". Questo apparecchio funziona solo se fra colui che vede e colui che ha visto c’è amore. Altrimenti, ciò che è stato visto può essere rubato e può far impazzire la persona che 282
attinge ai suoi sogni. Mercato impazzito e individualismo soli psistico sono i due pericoli. Il cinema è il maschile (il padre in quanto scienziato pazzo che effettua l'innesto) e il femminile (la madre cieca che lo subisce). Il cinefilo è colui che presta il suo corpo affinché l’innesto sia possibile. Il mediatore fra due poli, che da solo riconcilia Padre e Madre. Storia. «Gli uomini fanno la storia, ma questa non gli appartie ne», oppure «La storia fa i genitori, ma è solo cinema». In un certo senso, Kubrick contro Wenders. Wenders che trovo piutto sto debole e convenzionale di fronte a 2001. La nevrosi contro la schizofrenia?
Gance. Decisamente, ho scoperto il regista di riferimento per Carax e Wenders: Gance. Punti comuni: il tema della cecità (La venere cieca, quanto meno), la scienza e gli scienziati pazzi (Mauvais sang), l’idea di "fine del mondo”, La folie du docteur Tube, ecc. L'idea che solo l’arte può salvare, il messianesimo della figura dell’artista, il romanticismo. Ma anche un sentimento molto par ticolare di estroversione e di intimità (che non è osceno). Debolezza. L’ultima parte del film di Wim. Non la trovo cre dibile. Anche perché la sua concezione del sogno mi sembra falsa: il sogno sarebbe qualcosa di visivo senza il linguaggio. Concezione ben poco freudiana. Inoltre, è una strana idea pensa re che si possa voler "vedere i propri sogni”. È come una nega zione dell’inconscio. Volontarismo. È il difetto di tutti questi film. Nessuno di essi è limpido. Nel caso di Wim, ritengo che anche qui ci siano due film: il suo e quello del cinema. Il suo termina allorché egli ha mitologicamente ricucito questa famiglia tedesca e sacrificato il suo alter ego alla “causa dell’occhio”. Ma ne segue un altro, più accademico e approssimativo, che vuol essere un avvertimento indirizzato al mondo. Ormai, non vedo come egli possa evitare di tornare indietro: il destino di Wim Wenders è di ri-simbolizzare le cose attraverso la mediazione del solo “altro” possibile: la fami glia. È la famiglia edipica che egli non osa rivendicare fino alla fine dell’amore. A colui che nel trio edipico rappresenta il terzo elemento (il figlio, il cinefilo) egli assegna l'incredibile ruolo di cavia, la macchina del padre (fallo), la superficie di iscrizione della madre, gli occhi di lui come grembo! Il fallimento 283
dell’esperienza dell’aldilà è, in ultima analisi, il fallimento dell’edipo, l’impossibilità di vivere solo fin dal momento in cui egli si trova ad essere confrontato, senza intercessioni, con la pro pria mente. Stranamente, viene salvato da un’altra intercessione (quella, magica, degli aborigeni dormienti che gli sottraggono il suo sogno), mentre la donna è salvata da quella dell’arte — e, più precisamente, da ciò che manca alle immagini interiori, cioè le parole, la letteratura. Ma il problema è che tutto questo io non lo trovo credibile. Mi sembra, come sempre in Wim, l’anticipo dell’allievo promettente sui suoi progressi effettivi.
14/9 C’è materiale per un grande articolo che ricolleghi l’avventura cinefila a una questione più comunemente identificabile e attua le: il ruolo dell'arte in questa fine secolo.
Si può partire da La bella scontrosa, che non è |>er niente un film sull’arte (o sull'artista, figura piuttosto vergognosa in Rivette) ma sul lavoro in quanto durata. L’artista non ha privilegi (non è un santo, né un eroe, né un bambino) ma ha forse un dovere, una funzione, quella di mantenere desta la percezione. È il lavoro (eventualmente artistico), è l’assunzione e lo spettacolo di questo lavoro a costituire la garanzia di un progresso, di un qualsivoglia miglioramento da parte del pubblico. Si tratta, in parole povere, della politica straubiana, rigidamente marxista, che consiste nel salvaguardare solo il lavoro dell’artista (da ritrovare nella farragi ne della cultura) e nel dichiarare guerra ad ogni figura di Artista. La cosa è già più romantica in Godard o in Garrel in quanto (ragioni di classe sociale), come dice bene Garrel, loro sono nati nel “mondo dell’arte” e non se ne sono mai vergognati. La que stione godardiana non è quella dell’artista (anche se lui tenta di rimpiazzarlo con il sapiente o il politico) ma quella del cinema. Sempre al centro di tutto. Godard ha nello stesso tempo pensato come un moderno progressista (il miglioramento del grado di umanità dell’uomo in veste di “pubblico”) poi, e sempre di più, come un malinconico cinefilo. Così, in Histoire(s) du cinéma, il problema è diventato: perché il cinema - e lui soltanto - non ha sal vato il XX secolo dalla barbarie? Godard rimprovera un po’ tutti e non gli artisti o il pubblico in particolare. Il rimprovero è di non essersi impossessati del cinema come dell’unico strumento che trasformava l’atto del “vedere" in memoria e progetto. Ma con 284
Godard si tratta ancora del Cinema, della sua capacità singolare di “redimere” il mondo. Come può la figura dell’artista tornare ad essere eroica (in una dissidenza romantica con la società) quando quella del Cinema va sfumandosi e diluendosi? Da qualche tempo, meno film sul cine ma, meno mises en abyme del cinema, con la figura dell’artista in crisi, qualcosa che ha avuto il suo momento forte fra II disprezzo e 8 1/2 e di cui gli stessi Effetto notte e Lo stato delle cose appaiono prodotti tardivi. A sostituire tutto questo è di nuovo un altro tipo di arte, più chic, più antica: la pittura, il disegno, la lettera tura. Molto meno la musica. Il passaggio dal romanzesco duro e progressista-rivoluzionario (la Nouvelle vague che inventa la “politica degli autori” ma rifiu ta l'enfasi pompieristica del culto della personalità) al romantici smo molle e reazionario è dato da questo movimento che si chiu de con Beineix e Besson. Il giovane pubblico di Beineix ha anco ra rapporti con (’Arte, ma quello di Besson si trova in un senti mento oceanico, senza presa di distanza e propriamente religioso: davanti a lui si vacilla. Beineix filma dei piccoli francesi “artisti” della domenica e si erge al ruolo di resistente a tutta la sporcizia del mondo. Vuole per sé questa gloria e questa funzione di dissi denza perché vuol diventare un eroe del nostro tempo. È convin to che grazie ad Artisti come lui il mondo può conservare la pro pria anima. Quanto a Carax e Wenders, credo che si trovino a mezza strada fra l’idea rivettiana del lavoro infinito e l’idea bessoniana di evento assoluto: entrambi sviluppano il discorso necessa rio a far riflettere sul fatto che la storia di un’immagine, di una sola, può salvare tutto e che occorre strapparla al mondo e soprat tutto alle altre immagini, false e inessenziali. Rivette o Godard puntano sul tempo del Cinema, Wenders e Carax sul punto di incandescenza di un’immagine (legata all'amore, alla coppia), Beineix e Besson sull’autoproclamazione di se stessi come Artisti autentici che si fanno carico del pubblico e dell’anima. Il Cinema-l’Immagine-1*Artista, ecco il trio in successione.
2/10 BARTON FINK. Brillante, avvincente, ma inconcludente. La sceneggiatura ha delle parti magiche (il rapporto con Charlie Meadows-Karl Mundt), sostenute da un attore formidabile (Goodman). Le idee plastiche, l’immaginario sono più piatti, più impacciati. La disponibilità di mezzi con cui i fratelli Coen 285
hanno lavorato impedisce definitivamente la leggerezza un po’ casuale del cinema di serie B (ricordo, confusamente ma con simpatia, Arizona Junior). Simmetria della sceneggiatura: l’idea di un piccolo uomo preso fra due montagne di carne non fun ziona molto bene e la parte hollywoodiana prima attrae, poi delude. Al contrario è bella la figura dell’ ’’angelo sterminatore", il vicino che diventa l’amico più prossimo ma che si rivela assai "lontano". Il film si inscrive nella serie di quelli in cui la narra zione tenta di aderire a dei processi mentali. Lunga tradizione inaugurata molto tempo fa dagli scrittori (Kafka, evidentemente) e nella quale, da una ventina d’anni, si sono inseriti anche i regi sti. Ma per riuscirci, occorre sapersi mantenere a uguale distanza dal racconto classico (diciamo Hawks, l’osservatore behavioristico) e dal racconto moderno (diciamo una linea paranoica che si sviluppa da Lang a Hitchcock ma che arriva al culmine con Kubrick). Se essi non si ha il loro genio (entrare direttamente nella macchina, nella scatola nera), ci si deve accontentare di un’“apparenza” di racconto e di suspense classica. Da ciò deriva l’aspetto un po’ distaccato, accademico di un film come Barton Fink che sfiora spesso la stranezza autentica ma che alla fine sci vola in un certo esotismo. Il contenuto del nostro cervello e l’esotismo di questo contenu to (lo struzzo di Bunuel, per esempio). Vedi il factotum dell’hotel o il vecchio lift, personaggi assai ben tratteggiati (felli niani) ma dei quali si finisce per sentire l’esotismo. Questo vale per Moretti, Scorsese, Alien, Dubroux (citando a caso): un certo sapere banalizzato sull’inconscio messo al servizio di una narrazione che in definitiva si rivela essere un’arringa. L’individualismo come arringa folle, folle racconto. Se il racconto classico (ma è davvero esistito?), diciamo Intrigo intemazionale, è A...B...C...Z, il racconto-arringa sarà A...Z...B...Y...C...X. C’è un tema presente un po’ dappertutto (e che ossessiona anche me), quello della tentazione. Si direbbe che la narrazione classica perseguiti il racconto moderno come una tentazione alla quale occorre rispondere no. Si pensi, ad esempio, all’incontro fra i due vicini di stanza. Messo in scena come minaccia di un fatto di cronaca nera (l’uomo grosso spacca la faccia a quello pic colo), esso fa una rotazione di 180° e si ribalta nella situazione contraria (i due diventano molto amici). Qual è il racconto giu sto? Quello promesso all'inizio o quello che un attimo dopo ne prende il posto? Senza dubbio, l’astuzia sta nel rispondere: 286
entrambi. Perché è solo molto più tardi, in mezzo alle fiamme, che il grosso fa al piccolo il rimprovero che avrebbe [totuto fargli subito', «because you don’t listen!». In altre parole: alla minaccia non concretizzata si è sostituito (gag) qualcosa di troppo bello per essere vero. Noi abbiamo accettato (come l’eroe) questo qualcosa (la mansuetudine dell’uomo grosso) e, in un certo senso, la paghiamo perché si tratta invece di un assassino che si fa beffe di noi. Tutto consiste allora nell’andare verso Z prima di passare per B, come se il film non potesse più avanzare linear mente ma piuttosto con un movimento a spirale e come se con tenesse da subito (autentico oggetto genetico) tutte le sue false piste. In fondo, è quello che Douchet scriveva a proposito di Hitchcock già nel I960: punizione dello spettatore (cosceneggiatore) colpevole di aver preferito il proprio desiderio alla realtà, trasformazione di questo desiderio in paura, paura catar tica, ritorno al mondo “oggettivo" e adibito ad altri scopi. Barton Fink ricorda un po’ Shining ma pone di colpo la questio ne Kubrick. Quello che si può rimproverare ai fratelli Coen è il trattamento esotico del mondo mentale. Essi tentano di esprime re l’idea di interiorità facendo il vuoto intorno al loro eroe e allo spazio quasi unico dell’azione. Rivendicano (cosa molto attuale) una certa idea di mondo interiore (orecchio interno, ecc.) che è ciò attraverso cui oggi il cinema risponde e lotta contro l’inva denza della mediasfera (immagini pubbliche). Invece, la forza di Kubrick è stata quella di essere sempre riuscito a far saltare la contrapposizione dentro/fuori. Shining non lascia la sensazione di un luogo unico e opprimente, ma di una favola capace di appro priarsi, di divorare qualunque luogo. Stessa cosa per il rapporto col denaro. In Kubrick, il costo delle immagini non va mai a loro discapito: in esse ce qualcosa di inalterabile. Un vero mistero. Perversione, nevrosi, psicosi. La gente, davanti al proprio tele visore, diventa un perverso polimorfo. Il cinema, di fronte alla tv, srotola interminabilmente il suo programma di salvataggio cine filo-edipico. Qualche raro film, lontano da tutto questo, ha sapu to rinunciare a qualsiasi semplificazione. In Barton Fink (o in La bella scontrosa) c’è invece la complicità nevrotica sufficiente per essere incoronati a Cannes. Bene. Ma questo non ci basta.
287
NOTE
1) In originale: «Devant la recrudescence des vols de sacs à mains» che è anche il titolo del volume di Daney pubblicato da Alias nel 1991.
2) Questi due termini possono essere tradotti con “necessità” (tyché) e "caso” (automaton). Per ulteriori approfondimenti si rimanda a J.-C. Beaune, L’automate et set mobiles, Flammarion, Parigi, 1980. 3) La Rampe, Cahiers du cinéma/Gallimard, Parigi, 1983, p. 17. 4) j^lois Riegl (1858-1905), storico dell'arte austriaco di impostazione storicistica, esponente della scuola di Vienna.
5) Nell'originale Le passe-muraille, titolo di una raccolta di racconti di Marcel Aymé (1902-1967) pubblicata nel 1943. Il protagonista che dà il titolo all'intera raccolta è un impiegato che si accorge di avere il dono di passare attraverso i muri. 6) Prince Eric è il personaggio di un romanzo per adolescenti degli anni Cinquanta a forte connotazione omosessuale inespressa.
7) Les Nuls è un gruppo di comici satirici francesi. 8) Denominazione di vari tipi di spettacoli notturni all'aperto, caratte rizzati da un uso pirotecnico di luci, suoni e scenografie, e spesso incen trati su rappresentazioni in costume affollate di comparse. 9) Vaclav Belohradsky, L’Amiricanisation, «Le Messager européen», Editions P.O.L., Parigi, 1988.
10) Alain Finkielkraut, intellettuale parigino esponente dei nouveaux philosophes, molto noto per i suoi editoriali sulla carta stampata, e le sue frequenti apparizioni televisive e radiofoniche. Autore di saggi sul nazismo, sugli ebrei e sui nazionalismi europei. 11) Da Jean-Luc Nancy, La comunità inoperosa, Edizioni Cronopio, Napoli, 1992.
12) Bébete Show è un programma di satira i cui protagonisti sono dei pupazzi (simili a quelli del Muppet’s Show) che assomigliano caricatu ralmente a famosi uomini politici. 13) Da Peter Handke, L’ora del vero sentire, Garzanti, Milano, 1980, p. 136.
291
14) Trasmissione radiofonica settimanale condotta per diversi anni da Serge Daney su France Culture. 15) Francois Truffaut, Corrapondance (a cura di Gilles Jacob e Claude de Givray), Paris, Hatier, 5 Continents, 1988; tr. it. parziale Autoritratto. Lettere 1945-1984, Einaudi, Torino, 1989.
16) In «Cahiers du cinema», n. 145, luglio 1963. 17) In originale: «où l'effet — l'FS — se recule». Gioco di parole tra le iniziali di un amico di Daney e fessa, e con un verso di Corneille in Poliate', «et le désir saccroTt quand l'effet se tecule».
18) Strofa di una canzone di Sylvie Vartan.
19) L’enfant et la sortileges è il titolo di una fantasia lirica di Maurice Ravel.
20) Crei! è una città nei dintorni di Parigi e Samira è un nome di ragaz za musulmana. 21 ) Giorgio Agamben, Infanzia e storia, Einaudi, Torino, 1978.
22) Guy Lux, famoso presentatore della televisione francese, paragona bile al nostro Mike Bongiorno. 23) Verso di La legende da siala di Victor Hugo.
24) Darty, catena di grandi magazzini sul genere dei gruppi Standa o Rinascente. 25) Louma: macchina da presa cite consente piani sequenza acrobatici grazie ad un lunghissimo braccio snodabile.
26) Qui Daney fa molto probabilmente riferimento al "gioco del roc chetto" di cui parla Freud all’inizio di Al di là del principio di piacere. Analizzando il comportamento di un bambino di circa un anno e mezzo Freud scopre il suo gioco di gettare lontano un rocchetto di filo emet tendo un suono prolungato, «o-o-o-o», che starebbe per fort (via), per poi recuperarlo pronunciando questa volta la parola da (qui). Un’alter nanza dunque di assenza e presenza, appunto di sparizione e ri-appari zione. 27) Ritornello reso popolare dal brano de I Miserabili di Victor Hugo in cui Gavroche lo canta sulle barricate.
28) A questo punto si interrompe il testo originale di Serge Daney. 29) Termine americano che significa omosessuale nascosto/a.
292
30) L'espressione “i gloriosi trenta" indica gli anni dello sviluppo indu striale, prima della crisi petrolifera: gli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta.
31) Bernard Pivot, presentatore della trasmissione televisiva settimana le Apostrophes, dedicata ai libri, al termine della quale andava in onda Le cineclub, a cura di Claude-Jean Philippe e introdotto dallo stesso Pivot. 32) Sigla della radio e televisione francese di stato prima che questa si scindesse in più reti nazionali. 33) Nell'originale: diffirance e non différence. Per l'etimologia e il signi ficato di questo termine si rimanda a Jacques Derrida, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino, 1971, p. 78, nota n. 1. 34) Henri Agel, critico cinematografico, professore di lettere di Serge Daney al liceo Voltaire (cfr. il testo di Daney Lo sguardo ostinato, Il Castoro, Milano, pag. 25-26).
35) Riferimento a Jacques Rivette le veilleur (1989), documentario-inter vista dedicato al grande regista francese e realizzato da Claire Denis e Serge Daney per la serie Cinima, de notre temps. 36) Presentatore degli spettacoli al circo. 37) Asagara è un personaggio di La tigre di Eschnapur e // sefmlcro indiano di Fritz Lang.
38) Livre e CGT sono due organizzazioni sindacali francesi. 39) Gioco in cui due o più persone sovrappongono alternativamente le loro mani in modo che quella che viene a trovarsi sotto passi sopra, c così via. 40) Antoine De Caunes, ideatore-presentatore di trasmissioni tv, molto innovative e dal ritmo serrato, dedicate a musica e spettacolo.
41)Jean-Paul Goude, autore di famosi spot pubblicicari. Qui Daney fa riferimento a quello per la Kodak in cui dei bambini, facendo fotogra fie, rubano i colori alla realtà e vengono inseguiti da un poliziotto che ricorda quelli del burlesque americano. 42) I “montoni di Panurge”: questa espressione deriva da un episodio di Gargantua e Pantagruele di Rabelais e indica le persone la cui condotta e le cui opinioni ricalcano quelle del loro ambiente.
43) Gioco di parole fra poisson (pesce) e son et lumière.
293
INDICI
Nell'indice dei nomi si è scelto di non includere le persone citate unicamente con le iniziali o con il nome proprio, non essendo in grado di decidere quando Serge Daney desiderava mantenere lanonimato o semplicemente velocizzare la scrittura. Nel caso in cui la persona è citata sia con il nome per intero sia con le iniziali, tutti i rimandi alla pagina si trovano in corrispondenza del
nome.
Indice dei nomi e dei film
A caro prezzo, 73 A idade da terra, 70 Un affare dì donne, 103 Agamben G.» 180, 184, 203, 215,221,255, 292 Agassi A., 133,134 L’àge d’or, 71, 149 Agel H., 243, 293 Akerman C., 70, 263 Alaouie B., 70 Alba di gloria, 74 Aldrich R., 70 Le ali delle aquile, 74 L’alibi era perfetto, 69 Allegret Y., 70 Allemagne neuf ziro, 277 Allen W., 30, 36, 67, 70, 108, 113, 190, 191, 192, 193, 194,198,199,200,201,286 Allio R., 70 Alouette, je te piunterai, 57 Althusser L., 234 Always, 193 Amanti perduti, 72 Amar P., 242 Amarcord, 56, 74, 217 Ambara Dama, 39 America America, 163 Le amiche, 69, 71 L’amico di famiglia, 72 Ammar A.B., 71 L’amorefugge, 271 Un amore splendido, 69 Anatomia di un omicidio, 14, 69 Anderson M., 70 Andersson H., 14 Andrade Da J.P., 70 Andrews D., 258 Angel in Exile, 73 L’angelo sterminatore, 71 Aniki-Bobo, 69
Annaud J.J., 78, 116, 117, 118, 245, 254, 267 Un anno con tredici lune, 73 Antonioni M., 4l, 42, 55, 71, 154,161, 247,262 Apache Drums, 74 Apocalypse Now, 72 Arcand D., 71 Arcobaleno, 73 Arendt H., 38 L’Argent, 71 Arizona Junior, 286 Arkadin, 282 Arnold J., 71 Arnold J.M., 221 Arquette R., 79, 84 As-Salam S.A., 74 L'assassinio di un allibratore cinese, 72 Assayas O., 248, 249 Astaire F., 214 Atlantis, 273, 277 L’attimo fuggente, 247, 248 Aubert J.P., 51 Aurora, 69 Auteuil D., 95, 96 L'awentitra, 71,82, 152 Aymé M., 31, 291 Bach J.S., 261 Baciala per me, 73 Un bacio e una pistola, 70 Bancroft A., 14 Bande à part, 279 The Barber Shop, 74 Bardot B., 55, 133 Barnet B., 71 Barr J.M., 89 Barry Lyndon, 240 Barthes R., 21, 23, 52, 53, 60, 62, 137, 164,228,234 Barton Fink, 285, 286, 287
297
Bacalile G., 46, 135, 140, 151, 175,221,234 Batman, 125, 127,128 Baudelaire C., 180, 230 Baudrillard J., 39, 40, 44, 184, 202 BavaM., 71 Bazin A.. 20, 27, 68, 116, 140, 182, 234 Baecque de A., 233 Beaune J.C., 291 Beauvoir de S., 50 Becker J„ 71, 275 Beechoven L.V., 192 Behindert, 73 Beineix J.J., 77, 87, 89, 280, 281,285 Bella di giorno, 71 La bella scontrosa, 279, 284, 286 Bellini V., 274 Bellocchio M., 71 Bellon Y., 71 Bellour R., 260 Beimondo J.P., 89 Belohradsky V„ 37, 38,40,291 Bene C., 70 Benjamin W., 272 Bergala A., 89, 260 Bergman Ingrid, 41,190, 212 Bergman Ingmar, 14, 35, 36, 41,71, 262 Berlioz H., 230 Bernard P., 257 Bernard R., 71 Berri C., 93 Bercolucci B., 71, 83, 84, 88, 92,162, 231 Besson J.L., 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93. 116, 118, 131, 187, 188, 190, 203, 207, 208, 229, 242, 247, 267, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 285 Beccelheim B., 138 Bianca, 134 Biberman H., 71
298
Biecce J.C., 77, 83. 159, 160. 182, 186, 204, 205, 209, 238, 249, 270, 272,275 Blade afSatan’s Dagbog, 73 Blain G., 159 Blanchot M., 37, 139,150 Blasecci A., 71 BlierB.,71,96, 254 Blum R., 39 Bogarc H., 247 BoissetY., 71,89 Boissonas S., 237 Bolognini M., 194 Bongiorno M., 292 Bonjonr tristesse, 69 Bonnaire S., 96, 152 Borderline, 269 Borowczyk W., 71 Borzage F., 71 Boughedir F., 213 BouiseJ., 85 Bourdieu P., 228 Boucang P., 68 BouzidN.,213 Boyer, 39 Braulc M.,71 Brecht B., 36, 244 Breillat C., 23, 24, 25, 262, 263, 269 Brennan W., 14 Brenta M., 152 Bresson R., 13, 48, 55, 66, 70, 124, 174, 190, 200, 202, 220,256, 257,260,276
Breton A., 230 Breugnoc P., 175 Brisseau J.C., 123, 124, 125.
152 Broadway Danny Rose, IQ Broca P. de, 71 Bronco Billy, 247 Brooks M., 71 Brooks R., 71 Browning T., 71, 204 Bruckner A., 76 Bruckner P., 29 Brusini, 39 Bryant A., 211
Il buco, 71, 274, 276 Buffer freddo, 71 BuKuel L.» 58, 62, 70, 95, 129, 220, 269, 286 Burton T., 127, 128 C’era una volta il West, 70 Il cacciatore, 72 Cacciatore bianco cuore nero, 245 Il cacciatore del Missouri, 40 Caecedo, 75 La cagna, 74 Cagney J., 226 CainJ.M.,85 Callas M„ 274 La camera verde, 13 Camille Claudel, 160 La Campagne de Ciceron, 208 Campion J., 177,178, 262 Canetti E., 271 Cantando sotto la pioggia, 73 Capra F., 23, 34,43, 58, 72 Les carabinieri, 66, 165 Carax L., 77, 89, 185, 278, 281, 282,285 Carnè M„ 72, 185, 278 La carovana dei mormoni, 74 Carrie — Lo sguardo di Satana, 73 Cartouche, 71 Casanova, 217 Cassavetes J., 72, 185, 224, 236 Caunes A. de, 266,293 Cavalcarono insieme, 69, 74 Cavalcata, 34 Cayatte A., 72 Ceausescu N., 164, 165 Chabalier, 174 Chabrol C., 58, 72, 96, 103, 104,159 Chahine Y., 72, 213, 214, 241, 246,248 Une chambre en ville, 73, 81 Le champignon des Carpathes, 204 Chancel J., 161 Chang M., 133,134 Chaplin C., 43, 72, 76, 108, 128,131,191,200, 220 Charef M., 66 Chatiliez E.,65,67, 103,156
Chenguelaia G., 72 Chéreau P.» 53 Chi ha incastrato Roger Rabbit,
107, 188 Chiedo asilo, 74, 152 Chocolat, 63,64 Choulcchine V., 72 Christian-Jaque, 72 Christo, 141, 279 Chytilova V., 72 Il cielo sopra Berlino, 78 Ciment M., 51,88 Cimino M., 72, 128, 163, 179 Cioran E., 143 Cissé S., 75, 83 La città delle danne, 34 Clement R., 72 Clift M., 14 Closets F. de, 147 I clowns, 56, 74,99 Cocteau J., 72, 144 Coen E.e J., 285,287 Cohn B., 249 Colors — Colori di guerra, 93, 94, 95 Com’era verde la mia valle, 74 Come sono buoni i bianchi, 74, 161, 181 Comencini L., 72, 161 Comment fa va, 32, 260 Un condannato a morte è fuggito, 71 Il conformista, 71 La congiura, 70 La congiura degli innocenti, 104, 177 Connors J., 27 Coppola F.F., 36, 72, 94, 128, 163,179, 278 Corbucci S., 72 Comeau A., 89, 241 Corneille P., 233, 292 Cottafavi V., 72, 273 Cousteau J.Y., 72, 274, 277 Il covo dei contrabbandieri, 30, 31, 69, 104 Crépuscute, 249 Crimini e misfatti, 190
299
Cronaca familiare, 69 CruzJ., 107 Cukor G., 72 Cuore di madre, 73 Cura la tua destra, 96 Curtiz M., 72 Dalle B., 89 Daney S., 291,292,293 Daniel J., 160,161 Danton A., 249 Darrieux D., 81 DassinJ., 72 DastéJ., 124 Dattnbailò, 80 Davila J., 183, 208 De Bosio G., 72 De Mille C.B., 72 De Palma B., 73, 178, 179, 180 De Vito D., 201 Debord G.,270, 271 Debray R., 149,150 Dechavanne C., 184 Decker M., 107 Delacroix E., 171, 230 Delannoy J., 72 Deleuze G., 27,125,130,181,219 Delicatessen, 230 Delitto d’amore, 72 Delitto in pieno sole, 72 Delon A., 96, 133, 199, 204, 245, 246 Delvaux A., 68, 72 Demy J., 73, 80, 81, 82, 156,
160,278 Deneuve C.. 82 Denis C., 63, 64, 89. 148, 187, 249.293 Depardieu G., 126 Depardon R., 152. 153,154 Derrida J„ 54. 293 Des gens etranges, 72 DesmaretsS., 155 La Desna incantata, 73 Desplechin A., 280 Destinitos fatales, 75 Deville M., 75,96 / diavoli del Pacifico, 74 Il diavolo i femmina, 69,72
300
Il diavolo in calzoncini rosa, 72 // diavolo nella carne, 73 Il diavolo probabilmente..., 71 Il diavolo zoppo, 69 Dies trae, 73 Dinev P., 155 Dionysos, 212 Diptyque, 71 Il disprezzo, 55, 69, 82, 90, 181, 231.245,285 Distruggete Frankenstein!, 74
Diva, 223, 250 Dmytryck E., 73 Dodes’ka-den, 69, 247 Doillon J., 73, 90, 183 La dolce vita, 56, 69, 74, 218 Un dollaro d’onore, 68, 69, 70, 92,250 Donen S., 73 La donna che visse due volte, 69 La donna del miracolo, 59, 72 Donna pagana, 72 Donne facili, 72 Donskoj M., 73, 75 li dottor Zivago, 131 Double messieurs, 79 Douchet J., 19. 104, 287 Douglas M., 201 Dovzenko A., 73 Doxa, 282 Dreyer C.T., 73 Dreyfuss R., 193 Drucker M., 50 Drugstore Cowboy, 215 Druon M., 161 Dubroux D., 269, 273, 286 DudowS., 73 2001: Odissea nello spazio, 75, 154, 277, 283 Due o tre cose che so di tei, 27,112, 86 Le due orfanelle, 74 Dupeyron F., 113 Dupont Lajoie, 71 Duras M„ 47,73. 236 Duvall R., 93 Duvivier)., 73, 198 Dwan A., 73
Dwoskin S., 73 E.T. I’extra-terrestre, 78 Eastwood G, 245,246,247, 248 Eberhardt I., 161 Eco U„ 106 Eden Mùtria, 161 Edwards B., 73 Effetto notte, 285 Einieitung, 69 EjzenStejn S., 34, 37, 69» 73, 76, 235 Él,62,l\ E la nave va, 216, 217 Ellington D., 155 Empty quarter, 152 Les enfants, 73 Entusiasmo, 86 Epstein J., 73 Ercole alla conquista di Atlantide,
72 Erice V., 73 Eskandarai Kaman We Kaman (Alexandrie, tncore et tojours), 213 Estasi di un delitto, 71 Europa 51, 152, 181 Eustache J., 73 Exodus, 64 Falbalas,7\ Fanny e Alexander, 71, 193 Fantasia statomarina, 65 //fantasma del palcoscenico, 73 // fantasma della libertà, 71 Farrow M., 192 // fascino discreto della borghesia, 70 Fassbinder R.W., 35, 36, 73, 200, 220, 224,236,271 Fatal Glass of Beer, 74 Faust, 238 Favio L., 73 La favolosa storia di Pelle d’asino, 73,81 La febbre dell'oro, 72 Fellini F., 20, 34, 54, 56, 57, 74, 88, 111, 129, 200, 216, 217, 218, 219, 246, 247, 248
La femme de mon potè, 11 La femme en Afrique, 152 Fényes Szelek, 234 Ferreri M., 74, 112, 129, 152, 161,181,236 Feuillade L., 74,99, 229 Fields W.C., 74 ZZ figlio di Giuda, 71 Finkielkraut A., 44, 134, 137, 150, 280, 291 Fino all'ultimo respiro, 55, 68, 89 Fino alla fine del mondo, 282 Fisher T„ 74,175 Flaherry R., 74, 222 Fleischer R., 74, 179 Foldes P., 74 La folie du docteur Tube, 283 Fonda H., 14 Ford G„ 128 Ford H.» 53 Ford J., 14, 22, 36, 74, 104, 154, 183, 200, 206, 211, 212,271 La fossa dei disperati, 74 Foucault M., 150, 234 Francesco giullare di Dio, 69, 99
Francesco I, 72 Franju G., 74,99, 243 Frantic, 38,46,47, 49 Freaks, 69,70,71 Frears S., 25 Freda R., 74, 272,273 Fregonese H., 74 Freud S., 183, 292 Frost M., 263 Fukuyama F., 125 Fulchignoni E., 221 Fuller S., 39,74,75 Fuori orario, 110, 111, 127, 181 Furore, 74 Gable C.,40 Gadamer H.G., 38 Gance A., 42, 278, 279, 283 Gare centrale, 214 Garrel P., 141, 143, 273, 280, 284 Gauchet M., 26, 183 Geldof B., 39
301
Il generale, 34 Genet J., 144 Germania anno zero, 185, 188 Germania in autunno, 73 Gertrud, 69,72, 107 li gigante, 34 Gingere Fred, 57,74,217 l giorni del vino e delle rose, 73 Giorni interi tra gli alberi, 73 Un giorno a New York, 69, Ti I giovani leoni, 73 Giovanna D’Arco al rogo, 194 Girard R., 139 Girardot H., 185 Il giro del mondo in ottanta giorni, 70 Il giuramento dei forzati, 72 li giuramento dei quattro, 74 Givray C. de, 292 Godard J.L., 13, 20, 24, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 75, 77, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 108, 112, 130, 137, 138, 139, 158, 172, 185, 189, 191, 199, 200, 201, 204, 212, 215, 220, 222, 224, 227, 230, 231, 232, 235, 236, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 257, 260, 261, 271, 278, 279, 280, 284, 285 Goemons, 71 Good is D., 60 Goodman J., 285 Gorin J.P., 232 Goude J.P., 267, 293 Goupil R., 242 Legrand bleu, 75,77, 78, 80, 82, 83, 84, 91, 93, 101, 103, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 131, 136, 172, 187,188, 209, 247, 281 La grande abbuffata, 74, 112 Il grande cielo, 69 Il grande dittatore,!!, 131 Il grande silenzio, 72
302
Grandperret P., 185 Granier-Deferre P., 89 Grant C., 14, 53, 258 Gregorio abate, 212 Gross M., 107 Guerman A.G., 171 La guerra dei Roses, 201 La guerra delfuoco, 78, 116 Gueule d’amour, 69 Guiguet J.C., 77 Guillaume M., 150 Guitry S., 61, 98 Halfaouine, 213 Ramina L., 161 Handke P„ 53, 291 Hassan II, 160,161 Havel V., 170 Hawks H„ 26, 42, 43, 76, 100, 105, 118, 190, 200, 203, 211, 220, 226, 256, 275, 286 Hayden S., 231 Heidegger M., 136 Heimat, 282 Heston C., 68,100 Hiroshima mon amour, 69, 195, 243 Histoire(s) dii cinema, 86, 271, 277, 284 Hitchcock A., 26, 43, 53, 104, 111, 177, 179, 188, 190, 207, 211, 220, 235, 258, 286,287 Hitler A., 44 Ho camminato con uno zombi, 64 Hollywood Party, 73, 132 L’homme qui a perdu son ombre, 272 Honkytonk Man, 247 Hopper D., 93 Hoskins B., 109 Houdebine A.M., 247 Howard e il destino del mondo, 91 Hugo V., 292 Huillet D., 202 Huppert I., 64 Las Hurdes, 71 Huston J., 245
lei et ailleurs, 28, 34, 41, 42, 69, 164,199,236 Il gèlo en enfer, 241 Il ne suffit pai que Dieu soit aver lei
pawns, 70 In nome di Dio, 74 In riva al mart piè azzurro, 71 Un incendio visto da lontano, 156, 181 India, 117,271 India song, 73 Indiscreto, 73 L'infanzia di Gofkij, 73 L'inganno, 39 L'intendente Sansho, 99 L’intervista, 57 Intrigo internazionale, 43, 69, 193, 207, 282, 286 Gli invincibili, 72 Io e Annie, 70 lo, tu, lui, lei, 70 Ionesco E., 265 Ioseliani O., 156, 157, 160, 162, 171,172,175,181 Iskandariah leh?, 72 L’isola della donna contesa, 69, 76 L’isola nuda, 68 Ivan il terribile, 73, 154 IvensJ.,222 Jacob G., 292 Jacobs E.P., 155 Jacques H., 177 Jacquot B., 31, 87, 273 James H., 60 Jancsó M., 234 Jarmush J., 80 Jean de Fioretto, 63,92 Un jeu d"enfant, 197 Johnny Guitar, 231 Johnson B., 147 Josephine, 7ò, 80, 81 Jouhandeau M., 97 JousseT., 137, 171,248 Judex, 74 JungJ.F., 175 Jwe contro Pantomas, 74 Kafka F., 29, 286 KanéP., 131, 197
Kapd, 65, 66, 84, 171, 172, 244 Karina A., 36,212 Karlin P., 196,264, 265 KarmitzM., 125 Katz R., 36 Kazan E., 14, 163 Keaton B., 30, 37, 155,200 Kelly G., 81 Kerr D., 14 Khayati, 184 KhleifìM., 195, 197,213 King Kong, 128 Klossowski P., 59 Koleva M., 86 Kramer R., 136, 158, 210, 232, 235, 260 Kubrick S., 38, 75, 78, 79, 88, 101, 179, 210, 239, 240, 277, 283, 286, 287 Kuhle Wampe, 73 Kurosawa A., 246, 247, 248, 259 Kusturica E., 163,169 La Bruyère J. de, 161 Laborit H., 127 Lacan J., 62, 234, 250 Lachenay R., 56 Lacroix C„ 107, 112 Il ladro di donne, 69 Lainé P., 196 Lancillotto e Ginevra, 70 Landau M., 191,192 Lang F., 31, 56, 58, 104, 127, 138, 159, 220, 231, 235, 286, 293 Langlois H., 220,229 Lassalle M., 13 Laurent C., 161 Lavanant D., 96 Lavant D., 89, 185 Le Pen J.M., 60,61,242 LéaudJ.P., 13,14,89 Lefbrt, 225 Legendre P., 32, 62, 184, 186, 242 La legge, 72 Le legioni di Cleopatra, 72
303
Leland D.» 25 Lelouch C., 87 Leone S., 80, 163 Lewis J., 108,191,210 Liberti, igalitl, fraternità et après?, 211 La ligne d'ombre, 74 La linea generale, 69, 73 Lipovetsky G., 26,46 Loin du Vietnam, 44 Lola, donna di vita, 64, 73 Loridain M., 222 Loci P., 143 Lubitsch E., 35, 36, 218 Lucas G., 91 Luci Jet circo, 69, 72 Luci della città, 72 Luci della ribalta, 72 Luigi XIV, 29 Lumet S., 24, 25, 30 Lumière A. e L., 20,68, 220 La luna, 70 Il lupo dei mari, 72 Lutero M., 202 Lux G., 292 Lynch D., 257, 258, 259,263
Mac Mahon P., 68 Magnani A., 54, 66 Il magnifico scherzo, 42 Maieoi, 151,152,162 La Malibran, 97, 98 Malle L.. 171,274 Malone D., 14 Malraux A., 230 La maman et la putain, 7 3 Mamardachvili M., 175 pericolosa, 74 Maradona D.A., 133 Marcelle P., 164 Marchais G., 141 Marielle J.P., 96 Marie-Octobre, 73 Mark of the Vampire, 71 Marshall T.» 155, 159. 209
Marx K., 183 La maschera del demonio, 71 Maschio e femmina, 72 Mason J., 14, 25
W4
Il mastino dei Baskerville, 175 Mauss M., 221 Mauvais sang, 283 McCarey L.» 220, 279 Mediterraneo, 272 Mégret fì., 60 Méliès G., 68 Melville J.P., 257, 275 Let mendiants, 30, 31 Menjou A., 40 Merci la vie, 230 Merleau-Ponty M., 20 La messa è finita, 130, 134 Il Messia, 190 Mezzogiorno e mezzo di fuoco, 71 La mia Africa, 116 Mm bella pollastrella, 74 La mia droga si chiama Julie, 89 Miéville H., 86 Mill J.S., 151 Minnelli V., 26,144, 278 I miserabili, 71 Missika J.L., 39 Missione impossibile, 48 Missione in Manciuria, 69, 74 Mitchum R., 14 Mitry J., 20 Mitterrand Francois, 60 Mitterrand Frédéric, 106 Mizoguchi K.» 56,78, 220 Mizrahi M., 272 Mocky J.P., 241, 242 La moglie dell'aviatore, 184 Mosse et Aaron, 202 Mon cas, 247 Mona et moi, 185 Il mondo del silenzio, 72, 274 Un mondo di marionette, 70 Un mondo senza pietà, 141 Il mondo va avanti, 74 Monica e il desiderio, 71 Monroe M.» 35,43, 133 Monsieur, 224 Monsieur Ripois, 72 Monsieur Verdoux, 72 Montaigne M.E. de, 268 Monteiro J. C., 255 Moore M., 210, 211
Moretti N„ 75, 79, 113, 129, 130, 131, 134, 141, 172, 175, 181, 184, 194, 232, 242, 275,286 Morlet B., 100 La morte corre sul ftume, 22, 30, 63,69,76,98,154 Moses E., 107 Moskovitz J., 247 Moullet L., 54, 273 Mourlet M., 68 Mrr. Muir, 34 Muerte de un delicuente, 74 Mullet L., 241 El tnumìaa, 70 Muratova O., 263 Murnau F.W., 54, 238 Musil R., 37, 106 Nancy J.L., 44,48, 291 Nanuk l’eschimese, 74 Nasrallah Y.,213 Nathalie Granger, 72 Négret F., 124 Negulesco J., 273 Newman P., 25, 30 Nich's movie-Lampi sull’acqua, 231 Nietzsche F.W., 24, 54, 55, 61, 139,140 Nikita, 198, 203, 205, 207, 187 No, la folle gloria del comando, 239,277 Noce bianche, 123 Non toccare la donna bianca, 74 Notre histoire, 96 Notre-Dame de Paris, 62 La notte, 181 Notte e nebbia, 44, 69, 243, 245 Notti del Decamerone, 74 Le notti di Cabiria, 74 Nouvelle Vague, 199, 245, 260, 277 Nouwas A., 62 Novak K., 14 Novecento, 231 Nuovi racconti del Clan Taira, 69 Nuytten B,, 160 Oasis, 70
OcchettoA., 141 Occhi senza volto, 69, 74 Occhio per occhio, 72 L’oeuil du malin, 72 Ogawa A., 136 Oliveira M. de, 239, 241, 243, 246, 247, 248, 269, 270, 277 Olmi E., 152 Onorio di Autun, 180 Ordet — La parola, 22,67, 69, 73 Gli ordini, 71 L’oro dei mari, 73 L’Orso, 78, 114, 116 Orwell G., 169 Oshima N., 232, 236 8 1/2, 25, 285 Oudart J.P., 77 Ouedraogo I., 158 El ousfour, 7 2 Ozu Y., 23 //padrino-parte Ili, 230 Paini D., 65 Paisà, 36, 41 Pakradouni, 261 Palombella rossa, 129, 134, 184, 185 Le paltoquet, 96 Panico, 73 Paradis V., 124 Il paradiso dei barbari, 69 Paradiso perduto, 24 Les parapluies de Cherbourg, 76 Parillaud A., 188 Partner, 70, 71 Pasolini P.P., 236 Pasqua C., 161 Passion, 27, 57, 64, 215 La passione di Giovanna d’Arco, 73 Patachou, 159, 204 PaulhanJ., 50 La paura mangia l’anima, 73 Le paysan eloquent, 70 Peirce C.S., 137 Pel di carota, 198 Pelechian A., 199 Penn S., 93, 94 305
Pentimento, 156, 162 Per favore non toccate le vecchiette,
71 Perceval, 184 Perfidia (Les dames du Bois de Boulogne), 70,71, 257 Petition P.Y., 172 Le petit garfon, 69 Peyton L., 203 The Pharmacist, 74 Philippe C.J., 227, 293 PialatM.,90,265,269 Pickpocket, 13, 22, 64, 69, 70, 250 Pierre S., 52,257 Pinocchio, 72 La pirate, 183 Pirosmani, 72 La piu grande avventura, 74 II più grande spettacolo del mondo, 72 Pivot B., 227, 293 Platone, 133 Playtime — Tempo di divertimento, 70, 99 Poe E.A., 85 PolacM., 147 Polanski R., 38, 53.88 PollackS.» 116 Pollet J.D., 272 Pons M„ 60 Il posto delle fragole, 69, 71 Il prato di Bezin, 73 Preminger O., 64 Preste M., 126 Presley E., 131 Prévert J., 212 La prigioniera del deserto, 151, 152 Il processo di Giovanna d’Arco, 71 Professione reporter, 71, 161, 181 ProkofevS., 175 Proust M., 230 Psyco, 69 Qualche giorno con me, 95 Qualcosa d’altro, 72 / quattrocento colpi, 13, 34, 69, 89,248,272
306
QuéauP., 33, 172 Quell'oscuro oggetto del desiderio, 71 Rabelais F., 293 I racconti della luna pallida d'ago sto, 69 Racconto di primavera, 181, 183 Radiazione BX distruzione uomo, 71 La ragazza con la cappelliera, 71 Ramonet I., 39 Ran, 259 Rancière J., 235 Rapport Darty, 199 Ravel M., 292 Ray N., 64,90, 231,247, 279 Un re a New York, 69,72, 128 Re per una notte, 110, 210 Reagan R., 211 La regina d'Africa, 245 Il regno di Napoli, 69 La regola del gioco, 69 Reichenbach F., 194 Rejeanne Padovani, 71 Rembrandt H.V.R., 280 Remick L., 14 Renan E., 199 Renoir J., 35, 36, 66, 160, 186, 190, 200,211, 257 Repris de justice, 72 Repulsion, 269 Resnais A., 125, 126, 127, 128, 243,244 The Restless Breed, 73 Retton M.L., 107 Ricordi della casa gialla, 230 Riefenstahl L, 271 Riegl A., 26,65,68,75, 291 Rilke R.M., 180 Rimbaud J.N. A., 180 Rio Lobo, 105 Il rito, lì Ritorno alfuturo parte II, 173 Rivette J., 36,47,86,159,179, 204, 206, 230, 257, 279, 284, 285 Rivière J.L., 141 Robin Hood principe dei ladri, 72 Rocco e i suoi fratelli, 69
Rochant E., 141,185 Roché H.P., 60 Roger & Me, 210 Rohmer E., 21, 23, 89, 113, 155, 163, 181, 182, 183, 184, 192, 205, 220, 221, 230, 238, 240, 257 Roma, 56,74 Roma città aperta, 69, 165, 185 El romance del Aniceto y de la Francisca, 73 Rorschach H., 242 La rota purpurea del Cairo, 69 Rossellini R., 29, 34, 35, 36, 37, 39. 41, 42, 44, 45, 54, 65, 68, 75, 76, 83, 90, 98, 117, 160, 175, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 194, 198, 200, 211, 212, 220, 235. 256, 262, 271,
277 Rouch J., 37 , 38, 39, 68 , 83. 211, 212, 213, 220, 221, 222,237 Rouillé A., 32, 33 Route onelUSA, 136,210 Rozier J., 242 Rude joumfe pour la nine, 70 RuizR., 58,79,214 Russell J., 43 Rusty il selvaggio, 72, 94, 259 Ryan R.» 14 Rybczinski Z., 68 Sabine, 226 Sabouraud F., 35 Sacharov A.D., 170 Sachs M., 144 Sacrifìcio, 78 Sale contme un ange, 263 ll sale della terra, 71 Une sale histoire, 73 Salò, 256 Salami, 71 Sanders G.» 98 Sangue misto, 72 Sauter C., 89. 95. 96 Sbatti il mostro in prima pagina, 71
Scarpetta G., 65 Schefer J.L, 67,79, 250 SchlbndorfFV., 39 Schneider P., 141 Schonberg A., 22, 202 Schroeder B., 75 Schumann R., 183 Scola E., 66 Lo sconosciuto, 70, 71 Lo scopone scientifico, 72 fyors, 73
Scorsese M., 79, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 127, 181, 210, 286 Sebastiano re, 240 Seguila J., 60 Sejnane, 71 Sellers P„ 129 Selvaggina di passo, 73 Sennett M., 246 Senso, 70 Sentieri selvaggi, 69, 74 // sepolcro indiano, 30 Serreau C., 103, 190 Serres M., 212 Sessualità, 72 I sette magnificiJerry, 210 Sette spose per sette fratelli, 7 3 Sfez L., 49,66 Shakespeare W., 205, 214 Shangai Express, 69 Shaoqi L., 232 Shining, 210, 287 A short vision, 74 Si salvi chi può (la vita), 24, 54 Sibony D., 67,77,248 La signora della porta accanto, 124 La signora di Shanghai, 255 Sihanouk, 249 ll silenzio, 69, 71, 82 Silver V., 124 Sim, 219 Simon S., 185 Simon del deserto, 71 Sinuhe l’egiziano, 72 Sirk D., 261 Ski P.,51 Smihi M., 44
307
Smith R., 210 Sobborghi, 71 Sogni d’oro, 194 Sogni di donna, 71 Un sogno lungo un giorno, 72, 279 Soldati a cavallo, 69, 74 Lo sparviero del nutre, 72 Lo specchio a duefacce, 72 Lo specchio della vita, 69 Spielberg S., 53. 79. 83, 85. 91, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 128, 187, 188, 193 Lo spirito dell’alveare, 73 Losqualo, 85, 154, 173 Stalin, 44 Stalker, 69 Lo stato delle cose, 285 Steamboat Round the Bell, 74
Steps, 68 Stern J., 149 Stévenin J.F., 75, 79, 113, 185 Stewart J., 14 StirboisJ.P., 60 La storia, 161 Storia degli anni di fuoco, 73 Storia di Piera, 74 La strada, 74 Le strane licenze del caporale Dupont, 69 Straub J.M., 22, 39. 75, 76, 80, 83, 172, 202, 206, 235, 237, 238, 270 Stromboli terra di Dio, 68 Sua altezza si sposa, 7 3 Superman, 128 Sweetie, 177, 178 Syberberg H.J., 66, 235, 236,
249 Il tagliagole, 72 Tanner A., 272 Tarkovskij A., 68, 75, 83, 171, 172,224 TatiJ., Ili, 129,181 Taviani P. e V., 232 Téchiné A., 53, 273 Til&om, 85 Tempo dei gitani, 163
308
Tennessee’s Partner, 73 Teodora, imperatrice di Bisanzio, 74 Il terrorista, 72 Il testamento di Orfeo, 72 Théatre des matiires, 204 Thome, 156 Till gladio, 71 Tintoretto, 59 Toflfetti S., 271 Torga M., 50 La tortura della freccia, 69, 74 Toubiana S., 38, 51, 199, 200, 248,256,235 Tourneur J., 64, 159, 160, 204, 258 Toussaint J.P., 224 Toussaint-Louverture, 212 La tragedia di un uomo ridicolo, 71 Tre camerati, 71 l tre della croce del sud, 74 Tristana, 71 Trois jours en Grice, 272 Truffimi F., 13, 14, 20, 40, 59, 61, 124, 194, 230, 269, 271, 292 Turner K.» 201, 202 Turner L, 258 Tutto va bene, crepa padrone, 112 Uccellarci e uccellini, 69 Ukigumo, 69 L’ultima caccia, 71 L’ultima donna, 74 L’ultima tentazione di Cristo, 111 L’ultimo eden, 74 L’ultimo imperatore, 84, 105 Gli nomini preferiscono le bionde, 42 L’uomo che amava le donne, 194 L’uomo che uccise Liberty "Valance, &), 74 L’uomo dal cranio rasato, 72 L’uomo dall’impermeabile, 73 Uranus, 230, 231 L'urlo della folla, 226 Uwasa no onna, 69 Vadim R., 249 Valentini V., 270, 271
Vampyr, 72 Van Sant Jr. G., 215 Varda A., 261 Vartan S., 292 Vecchia guardia, 71,189 Vecchiali P.» 112,155 La venere cieca, 283 Veneri raise, 73 20.000 teghe sotto i mari, 74 24 ore a Scotland Yard, 74 Verboten, Forbidden, Proibito, 39, 74 Il verdetto, 25 Vergine taglia ì6, 24 Veronika Voss, 73 Vertov D., 42, 56,86, 138, 232 Vestito per uccidere, 7 3 La via lattea, 71 Viaggio a Tokyo, 69 Viaggio in Italia, 63,69,98 I vichinghi, 74 VigoJ., 13, 279 Violenza per una giovane, 71 Virilio P., 218, 220 Visconti L., 36,41 La vita è meravigliosa, 34, 70, 72 La vita è un lungo fiume tranquillo, 65 La vita trionfa, 69 Una vita. Il dramma di una sposa, 71 Vittime di guerra, 178 Vittoria amara, 69 Vivaldi A., 171 La voce della luna, 216, 219 Vogler R., 159 Voglio tornare a casa!, 125 Vorrei che tu fossi qui, 25 Walesa L, 170 Walsh R., 211, 220 Warhol A., 35 Warren, 154 Wat A., 170, 171 Wayne J., 14, 15, 128 Weekend, un uomo e una donna dal sabato alla domenica, 188 Weir P., 242
Welles O., 79, 247 Wellman W.A., 40,41 Wenders W., 20, 67, 80, 136, 190, 200, 206, 231, 282, 283, 284, 285 Wiazemsky A., 86 Yamamoto Y., 136 Yeleen — La luce, 78 Zabel R., 147 Zelig, 69 Zemeckis R., 107,173 Zia Angelina, 247 Zinov’evA., 170 Zucca P., 57, 58,59.96 Zwischler, 164
309
Indice generale
Presentazioni
7
IL CINEMA, E OLTRE.
11
1988
17
1989
121
1990
167
1991
253
Questo libro raccoglie testi inediti scritti da Serge Daney tra il 1988 e il 1991. Sono analisi, riflessioni, ipotesi, ricordi. Parlano di cinema, soprattutto, e di immagini. Di coloro che le fanno o le distruggono. Ma parlano anche della vita, del passato e del presente. Pagina dopo pagina si delinea un pensiero libero e irriducibile, sempre pronto ad andare oltre, a muovere lo sguardo per seguire il movimento del mondo. O, forse, per crearlo. Serge Daney, redattore capo dei «Cahiers du cinéma», responsabile della pagina di cinema e quindi editorialista per «Liberation», ha fondaco nel 1992 la rivista «Trafic». Tra le sue opere La Rampe (1983) e Le salaire du zappeur (1988). In questa collana è apparso Lo sguardo ostinato ( 1995). È morto a quarantotto anni il 12 giugno 1992.