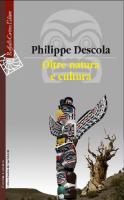Cultura e utilità 8841750154
723 68 7MB
Italian Pages [304] Year 1994
Polecaj historie
Citation preview
MARSHALL SAHLINS CU LTU RA E UTILITÀ
MARSHALL SAHLINS CULTURA E UTILITÀ
Cultura e utilità sviluppa una critica antropologica dell'idea che le culture umane siano espressione dell'attività pratica e dell'interesse utilitario. Per Sahlins, questa concezione disconosce il fondamentale carattere simbolico della cultura. L'opposizione tra un paradigma che sottolinea la funzione simbolica della cultura (quello di Boas e Radcliffe-Brown, per esempio) e un paradigma che insiste sulla dipendenza della cultura da determinazioni ecologiche, pratiche e utilitarie (si pensi a Morgan o a Malinowski) attraversa la storia dell'antropologia. Sostenendo che la cultura non solo media il rapporto uomo/mondo, ma costituisce i termini essenziali del rapporto, Sahlins si situa apertamente all'interno della prima tradizione. L'esame di questa controversia offre la cornice argomentativa per una serrata critica del marxismo, interlocutore privilegiato di Cultura e utilità. Con la corrente utilitaristica dell'antropologia, il marxismo condivide un'epistemologia presimbolica del rapporto soggetto/oggetto e una nozione di cultura come strumento di un progetto naturale e materiale di soddisfacimento dei bisogni. Subordinando la logica simbolica alla logica strumentale, il materialismo storico non solo si preclude la comprensione delle società primitive, ma non coglie la dimensione significante della produzione capitalistica di merci. Anche la produzione capitalistica, infatti, essendo mezzo di un modo di vita complessivo, è produzione di significato simbolico. La società occidentale non si differenzia da quelle primitive in quanto sarebbe interpretabile a partire da un complesso di forze materiali, ma per un diverso codice di integrazione simbolica. M a rs h a ll S a h lin s è uno dei principali protagonisti del dibattito e della ricerca antropologica contemporanea. Tra le sue opere ricordiamo L'economia dell'età della pietra (Bompiani 1980), Una critica antropologica della sociobiologia (Loescher 1981), Isole di storia (Einaudi 1986), Storie d'altri (Guida 1992).
ISBN 88-417-501
Lire 35.000
9 788841 7501
MARSHALL SAHUNS CULTURA E UTIUTÀ
A ANABASI
TITOLO DELL’OPERA ORIGINALE CULTURE AND PRACTICAL REASON © 1976 BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO. ALL RIGHTS RESERVED. TRADUZIONE DALL’INGLESE DI BRUNO AMATO © EDIZIONI ANABASI SPA MILANO PRIMA EDIZIONE MARZO 1994 ISBN 88-417-5015-4
Tutto ciò che è esiste in modo de terminato, ha proprietà distintive. Représentations individuelles et représentations collectives,
E m ile D u r k h e im ,
1898.
\
RINGRAZIAMENTI
Devo ringraziare particolarmente quanti si sono accollati il peso di affrontare in tutto o in parte una delle versioni datti loscritte di questo libro e che mi hanno offerto i loro rilievi e il loro incoraggiamento: Firthjof Bergmann, James Boon, Vern Carroll, Remo Guidieri, Paul Kay, Raymond Kelly, Julius Kirschner, Barbara Sahlins, David Schneider, Bob Scholte, Judith Shapiro, Michael Silverstein, George Stocking jr., Stanley Tambiah, Michael Taussig e Terence Turner. Grazie al generoso invito da parte del dipartimento di an tropologia del Lehman College della City University di New York, ho potuto esprimere pubblicamente le idee contenute in questo libro in una serie di conferenze tenute nell’aprile del 1973. Sono riconoscente al professor Lucy Saunders per la gra dita occasione e la gentile ospitalità che mi sono state offerte.
Prefazione
Il libro sviluppa una critica antropologica dell’idea che le cul ture umane siano espressione dell’attività pratica e, al di là di questa, dell’interesse utilitario. Definisco questa concezione “teo ria della prassi”, se l’accento cade sulle forme dell’attività eco nomica, e “teoria dell’utilità”, se si mette in rilievo la logica del vantaggio materiale, inteso come regolatore della produzione. Con “prassi” voglio cogliere soprattutto il significato di azione produttiva, che è il senso principale nella terminologia marxi sta, e, come fa il marxismo, riferisco il termine sia agli aspetti oggettivi sia a quelli soggettivi del processo: da una parte i mez zi e i rapporti di produzione storicamente dati, dall’altra l’espe rienza che di se stessi e degli oggetti della loro esistenza han no gli uomini mentre, producendo, trasformano il mondo me diante una dotazione strumentale determinata. Analogamente il termine “utilità” può essere inteso nelle sue dimensioni sog gettiva e oggettiva, sebbene molte teorie preferiscano specifica re ulteriormente la natura della logica pratica che assumono come base dell’ordine culturale. Per alcuni, comunque, la cul tura è senza dubbio la sedimentazione dell’attività razionale de gli individui che perseguono i loro interessi. Questo è l’utilita rismo propriamente detto, la etti logica consiste nel massimiz zare i rapporti mezzi-fini. Le teorie dell’utilità oggettiva sono naturalistiche o ecologiche; per esse la sopravvivenza della po polazione umana o dell’ordine sociale dato costituisce il sape7
re materiale determinante, che si sostanzia in forma di cultura. La logica corrispondente è quella del “vantaggio adattivo”, ov vero del mantenimento del sistema entro i limiti della sua ca pacità di riprodursi. Contro tutti questi generi e specie di ra gione pratica, questo studio propone una ragione di altro tipo, simbolico e significante, identificando il carattere distintivo dell’uomo non col fatto che deve vivere in un mondo materia le (circostanza comune a tutti gli altri organismi), ma che lo fa secondo uno schema significante di sua invenzione; in tale atti tudine il genere umano non ha uguali. Il libro inoltre ricono sce nella qualità decisiva della cultura - e cioè nell’attribuzione a ogni modo di vita di proprietà che lo caratterizzano - non l’inevitabile adeguamento alle necessità materiali, ma il fatto che la cultura si adatta secondo uno schema simbolico che non è mai il solo possibile. E quindi la cultura a fondare l’utilità. L’argomento del libro, come suggerisce questo rapido sunto, implica un complesso dialogo di teorie, tra loro e in rapporto ai tipi dei sistemi culturali che esse intendono spiegare. La sce na è allestita nel primo capitolo con la descrizione di alcune difficoltà incontrate dal materialismo storico nell’analizzare le società cosiddette primitive. Da questa esposizione sembra ra gionevole concludere, almeno provvisoriamente, che il marxi smo e gli strutturalismi antropologici tradizionali rappresenta no spiegazioni teoriche parziali, applicabili a specifici universi culturali o a particolari epoche storiche. Ma nel secondo capi tolo si suggerisce che i punti che dividono il marxismo dalla teoria della cultura abbiano precise corrispondenze nella storia del pensiero antropologico applicato alla società “primitiva”. Questa esplicazione della controversia tra ragione pratica e cul turale nell’ambito dell’antropologia, in seguito rende possibile sottoporre a critica il materialismo storico (cap. 3), e situare la società borghese nel campo dell’ordine simbolico (cap. 4). Il ti tolo di quest’ultimo capitolo, Cultura e ragione pratica, richiama il duplice punto di vista che pervade l’intera opera, il costante rimando tra l’opposizione delle teorie e il confronto fra la teo ria e il suo oggetto; e infatti il capitolo 4 intende suggerire la presenza di una struttura simbolica all’interno dell’utilità ma teriale. Il capitolo finale fornisce le prime conclusioni dell’intero lavoro: sull’utilità rispetto al significato, a livello di teoria 8
culturale, e sulla società occidentale rispetto a quella “primiti va”, a livello di fatto. Il libro cosi prende posizione - a favore del significante - in una disputa con il pensiero pratico, che è classica non solo nell’antropologia ma in tutte le scienze sociali, per non parla re della filosofia. E un dibattito, d’altronde, che riguarda il sa pere di ogni società o di ogni fase storica. Chiaramente, non è nelle mie speranze (né nelle intenzioni) sottrarmi alle critiche sulla documentazione che fornisco; né mi aspetto, purtroppo, che la soluzione proposta sfugga alle etichette, alla rigida op posizione di “idealismo” e “materialismo”, da cui abitualmente prende le mosse la discussione. Per quanto riguarda la docu mentazione, vorrei solo difendere la scelta che privilegia le teo rie e le scoperte dell’antropologia quale campo per tale dibat tito. Questo perché è il concetto antropologico di cultura a lan ciare la sfida più efficace alla ragione pratica - e anche perché, come cercherò di dimostrare tra poco, questo stesso concetto mette da parte antichi dualismi quali mente e materia, ideali smo e materialismo. All’interno della stessa antropologia, ho scelto determinati autori e determinate società per esporre ed esemplificare i principali argomenti. Naturalmente la scelta è stata guidata da ciò che, a mio parere, poteva favorire la rea lizzazione di questi scopi; ma non escludo che i limiti e le idio sincrasie di un percorso personale abbiano avuto il loro effet to. Per questa ragione non si può che accogliere favorevolmente una critica basata su altre fonti e altre discipline. Potrebbe con fermare il punto essenziale, e cioè che l’opposizione tra prati co e significante è lo sbocco inevitabile del pensiero sociale con temporaneo. Quanto all’accusa di “idealismo”, che un’insistenza sul signi ficante potrebbe sollecitare, mi pare che trovi il suo terreno pro prio nel tipo di epistemologia preantropologica, presimbolica, del rapporto soggetto/oggetto, il cui superamento era condi zione storica per la formulazione del concetto di cultura. Tor nare a questo linguaggio adesso sarebbe impoverire il concetto delle sue proprietà determinate. Significherebbe ricondurre il problema della cultura nel quadro dell’antinomia, tipicamente occidentale, di un soggetto senza mondo e di un oggetto sen za pensiero: tra i termini dell’opposizione irreducibile di men te e materia, sono trascorsi duemila e cinquecento anni di fi9
losofia; ogni posizione immaginabile ha cercato di tracciare i li miti plausibili della realtà, dall’idealismo del vescovo Berkeley al materialismo di Vladimir Il’ic. Impegnare la cultura nello stes so ordine di problemi è come domandare se essa rappresenti la “reale” esperienza del soggetto o le sue concezioni ideali; quando, in realtà, la cultura è condizione sociale della possibi lità di ognuna e di entrambe le ipotesi. Boas, come vedremo, avrebbe formulato la moderna nozione di cultura mosso pro prio dalla sensazione che questa struttura concettuale, in cui il rapporto soggetto/oggetto restava non mediato, fosse insuffi ciente. Passando successivamente dalla fisica alla psicofìsica, e poi alla geografia, alla linguistica e all’etnologia, avrebbe sco perto in ogni stadio lo stesso tipo di frattura tra il soggettivo e l’oggettivo, e a ogni stadio avrebbe individuato anche un fon damento più generale, collettivo (più culturale che kantiano) di questa discontinuità. Infine, sul piano etnologico, il termine medio divenne la tradizione collettiva, che impregna la perce zione soggettiva di una concezione storica. In questo consiste il contributo originale dell’antropologia al dualismo costituito: un tertium quid, la cultura, che non solo media il rapporto uomo/mondo per mezzo di una logica sociale di significanza, ma costituisce con quello schema i termini essenziali - soggettivo e oggettivo - del rapporto. In questo saggio, sostengo che il significato è la proprietà spe cifica dell’oggetto antropologico. Le culture sono ordini signi ficanti di persone e di cose. Poiché questi ordini sono dei si stemi, non possono essere libere invenzioni della mente. Ma l’antropologia deve consistere nel portare a evidenza il sistema: come spero di mostrare, infatti, non ci si può più contentare dell’idea che il costume non sia altro che utilità feticizzata.
10
1.
Il marxismo e due strutturalismi
La prima domanda che ha ispirato questo libro è stata: è pos sibile utilizzare senza intoppi la concezione materialistica della storia e della cultura - cosi come Marx l’ha formulata in teoria - per lo studio delle società tribali? E poiché mi sembra che fosse impossibile, la domanda si trasformò in un’altra: qual è la vera natura della difficoltà? Aggiungo subito che, discutendo il sistema materialistico, mi ri ferisco agli enunciati metodologici presenti in passi dei Manoscritti economi co-filosofici del 1844, dell’Ideologia tedesca, delle ‘Tesi su Feuerbach”, di Perla crìtica dell’economia politica, dei Grundrisse, del Capitale e di altre opere di Marx che verranno citate in seguito. La teoria sociale complessiva esposta in questi lavori è indicata co munemente come “materialismo storico”. E risaputo che Marx non ha mai usato l’espressione "materialismo storico” (né “mate rialismo dialettico”) per designare la sua filosofia. La necessità di tali etichette sorse in seguito - e questo può essere sintomatico per il problema che ci interessa. Seri studiosi di Marx hanno af fermato che egli ha mancato di sistematizzare in modo adeguato i procedimenti effettivamente seguiti nelle analisi più concrete della storia e della società capitalistiche. Questo studio dunque potrebbe essere considerato una risposta su due livelli a quella di sparità, dal momento che utilizza lo scarto epistemologico tra pra tica e teoria come occasione per riflettere sull'adeguatezza della prassi materiale a spiegare l’ordine culturale. 11
Una tale riflessione necessariamente conduce anche a una critica interna della teoria antropologica. Credo, inoltre, che rin contro con società tribali o agricole abbia prodotto qualcosa di nuovo e di valido nell’antropologia, in particolare nel suo con cetto di cultura, qualcosa che vale la pena difendere. Sarebbe ben triste per la nostra supposta scienza - anche se non in concepibile - scoprire che l’interpretazione materialistica, cosi come Marx l’ha sviluppata a metà del diciannovesimo secolo, può essere applicata senza problemi al mondo tribale. Cento an ni di pensiero e di lavoro sul campo, tutti i disagi mentali e fi sici affrontati, sarebbero stati sopportati praticamente per nul la - un’immensa deviazione tra quelle periferie dell’umanità che non compaiono su alcuna mappa, per ritrovarci semplicemen te al punto di partenza. Quello che abbiamo imparato sulla cul tura dell’uomo nei villaggi dell’India, dell’Africa, della Poline sia, non conterrebbe nessuna vera novità. Anzi: l’antropologia, lacchè dell’imperialismo, oltre ad aver contribuito alla diffusio ne dell’ideologia e del sistema politico occidentale, si rivele rebbe nient’altro che un gigantesco giochetto intellettuale, un innocuo passatempo per la società borghese. Può anche darsi. D’altra parte il materialismo classico ha avu to le sue difficoltà con il sapere antropologico. Determinarne la causa sarebbe di enorme utilità sia per la teoria antropolo gica sia per il marxismo. Infatti, a parte il dato di fatto incon trovertibile che l’antropologia è una creatura della società bor ghese - nelle cui supposte superiori virtù essa non crede - il suo scopo più alto deve essere lo stesso che muove il materia lismo critico: “liberare gli uomini dalla gabbia del ferreo de terminismo economico, che essi stessi hanno forgiato” (Schmidt, 1966, ed. it. p. 36). Questo è lo spirito del libro. La resistenza che la società tribale oppone alla lettura mate rialistica si è manifestata in vari modi. Chiare anticipazioni del problema erano già nelle opere di Marx e di Engels: cautela sulla pertinenza della dialettica materiale là dove i mezzi di pro duzione non si contrappongono ai produttori come forze reifi cate e alienate; circospezione sui poteri formativi della base eco nomica rispetto ai vincoli “naturali di sangue”; osservazione dell’immutabilità dei villaggi arcaici (vedi in particolare: Marx, 1857-1858b; 1867, ed. it. voi. I, p. 402; Engels, 1884; Marx e Engels, 1935). Attualmente, si può dire che a ogni rivendica*
12
zione dell’universalità dell’interpretazione materialistica corri sponde una controrivendicazione della sua relatività. Per ogni asserzione della sua applicabilità a tutta la storia (Althusser e Ba libar 1965; Terray 1972) c’è una limitazione della sua specifi cità all’interpretazione della crescita e del declino del capitali smo (Petrovic 1967; Schmidt 1966). Il disaccordo verte sullo sta tuto teoretico del materialismo storico: è la scienza della storia oppure - come la civetta di Minerva che prende il volo al cre puscolo - l’autocoscienza critica del capitalismo maturo? Intanto, all’interno dell’accademia antropologica propria mente detta, il materialismo storico non ha certo avuto un suc cesso incondizionato. Naturalmente ci sono resistenze di tipo ideologico, ma ci sono anche critiche serie. Questo capitolo ri prende alcuni dei principali temi in discussione nei recenti di battiti tra il marxismo e i due strutturalismi antropologici, quel lo inglese e quello francese. Ma prima, alcune regole generali per affrontare la discussione. Sarebbe puro “terrorismo” da parte marxista liquidare gli ar gomenti dell’antropologia come idealismo borghese (cfr. Sartre, 1960). Ma sarebbe poco costruttivo da parte dell’antropologia controbattere adottando lo stesso terrorismo, descrivendo la sfi da marxista come “volgare determinismo economico”, come in genua interpretazione “per rispecchiamento” dei rapporti tra ba se economica e sovrastrutture politico-ideologiche. Ci sono esempi in Marx, per non dire delle ben note spiegazioni con tenute nelle lettere di Engels, abbastanza concreti da permet terci di non prendere in considerazione questo genere di criti che. La questione emersa dal dibattito con lo strutturalismo in glese ha un peso notevole: riguarda la pertinenza dell’impian to analitico marxista applicato a una società che non conosce una distinzione organica tra base e sovrastruttura; cioè, a una società in cui le due strutture siano formalmente una sola. A sua volta questo problema morfologico-istituzionale è solo un aspetto del più profondo oggetto di controversia tra marxismo e strutturalismo francese. “Controversia” forse non è la parola giusta. In qualche caso si verifica un sofferto accomodamento. La relazione di amore e odio tra strutturalisti e marxisti attesta l'accuratezza del rappor to etnografico di Lue de Heusch dal Quartiere Latino nel di mostrare che l’intelligencija francese è la più vivace d’Europa. 13
Inoltre, i termini classici della divergenza tra i due orientamen ti, la sincronia dello strutturalismo e la diacronia del marxismo, l’idealismo del primo e il materialismo del secondo, rendono difficile immaginare perché mai essi dovrebbero anche solo pro porsi una sintesi. E vero che alcuni militanti condannano senza appello lo strutturalismo per il suo apparente quietismo; ma Lé vi-Strauss dice di essere in un certo senso marxista (1955 1962a), cosi come Godelier (1966) scopre che Marx era strutturalista. Inoltre, un’analoga attrazione tra contrari esiste all’interno dell’antropologia propriamente detta: si pensi al fascino che Lé vi-Strauss esercita sugli etnologi anglosassoni, nonostante il lo ro abituale testardo empirismo. Ciò che lo strutturalismo sem bra offrire, anche al di là della concezione di una continuità storica, che Marx riconobbe in alcune società precapitalistiche, è un’affermazione esplicita della presenza della cultura nella prassi, dell’ordine simbolico nell’attività materiale. Anche di questo Marx fu tra i primi ad accorgersi. Ma, per usare una distinzione di Althusser, riconoscere un fatto impor tante, vederlo, non è lo stesso che svilupparne il concetto. Le for mulazioni generali della teoria della cultura in Marx tendono a subordinare la logica sociale della produzione alla logica stru mentale del lavoro, e contemporaneamente a porre come con seguenza dell’essere sociale quelle che invece sono le sue coordi nate simboliche. Il rapporto tra l’azione produttiva nel mondo e l’organizzazione simbolica dell’esperienza: è questo il punto di discussione tra il marxismo e lo strutturalismo francese; ed è pure il tema controverso nei dibattiti interni dell’antropologia su ragione pratica e culturale. Il disaccordo verte sull’adegua tezza della prassi a fondare l’ordine umano. La discussione che segue cerca di stabilire il quadro di que sto disaccordo e di tutti i suoi corollari, egualmente fondamentali, sulle relazioni tra struttura ed evento, cultura e natu ra, ideologia ed economia. Forse l’importanza del problema, come pure le difficoltà che marxismo e strutturalismo incon trano nello sfuggirsi a vicenda, è riassunta nell’osservazione che la visione marxista di un futuro socialista —la padronanza da parte della società del dominio sociale sulla natura - è molto simile all’idea che Lévi-Strauss, e Boas prima di lui, aveva con cepito del passato primitivo. Che altro è questo se non l’essen za della visione antropologica della cultura? 14
MARXISMO E STRUTTURALISMO INGLESE: LA CONTROVERSIA WORSLEY-FORTES
Quando Peter Worsley (1956) sottopose gli studi di Fortes sui Tallensi (soprattutto 1945, 1949) a una critica marxista, la strategia adottata sembrava essere più analitica che dialettica. “E necessario,” scrisse, “suddividere un sistema di parentela, che è un sistema unitario di rapporti tra persone, nei singoli sistemi finalizzati che lo compongono (di tipo economico, riproduttivo, ri tuale ecc.) ed esaminare le relazioni tra questi sistemi” (1956, p. 64; corsivo mio). Ma qui c’è un allontanamento ancora più sorprendente dal materialismo classico. La dissezione analitica che Worsley opera sul sistema di lignaggio tallensi, è piuttosto il contrario del procedimento usato da Marx per smascherare il capitalismo occidentale. Worsley si impegna a smembrare un’unità apparente per mostrare l’esistenza di relazioni nasco ste tra le sue parti; per Marx il problema era scoprire l’unità tra parti - economia, diritto, stato - che si presentavano distin te e autonome. Questa differenza nel metodo mi sembra corrispondere, sul piano teorico, a una differenza nell’oggetto culturale. La sintesi materialista compiuta da Marx è stata un trionfo sulla pecu liare e ingannevole apparenza della società borghese. Spiega Lukàcs: “Economia, diritto e stato appaiono qui come sistemi in sé chiusi, che dominano a proprio arbitrio 4’intera società con leggi proprie, in essi immanenti.” Nel materialismo storico, con clude Lukàcs, “l’aspetto che fa epoca consiste nel riconosci mento del fatto che questi sistemi apparentemente del tutto in dipendenti, definiti ed autonomi, sono meri momenti di un in tero ed è perciò possibile sopprimere la loro apparente auto nomia” (Lukàcs, 1923, ed. it. pp. 286-287). Ma i Tallensi, se condo la descrizione di Worsley, presentano ribaltato il problema: Abbiamo visto che le persone rispetto alle quali si sta in una par ticolare relazione, per esempio politica, sono poi le medesime per sone rispetto alle quali si sta in altre relazioni - morale, religio sa, educativa ecc. I legami che uniscono gli individui nella società tallensi non sono soltanto i legami dell’interesse comune; c’è una complessa, intricata rete di vincoli che lega le persone. Questa molteplicità di legami viene espressa principalmente dalla no15
t
menclatura di parentela. Le relazioni politiche tra gruppi trova no analogamente espressione nei termini della parentela, anche se il contenuto di tali relazioni è ovviamente di natura diversa dal contenuto delle relazioni tra parenti veri e propri. In tal modo la parentela è l’intelaiatura dell’intero sistema sociale: i legami prin cipali che uniscono le persone coincidono con quelli della pa rentela diretta, ed essa modella le strutture dell’intera società. [1956, p. 63] In questo m odo Worsley è spinto a trovare u n a m olteplicità n ell’assetto istituzionale unitario - p u r avendo com e m odello un m etodo p er scoprire l’unità nella differenziazione delle istitu zioni. Per dare u n ’idea più chiara di questo ribaltam ento teo rico, riporto la più n ota esposizione di Marx del principio del materialismo: Il risultato generale a cui arrivai e che, una volta ottenuto, mi sem' fla filo conduttore nel corso dei miei studi, può essere, in poche parole, cosi formulato: nella produzione sociale della lo ro esistenza gli uomini vengono a trovarsi in rapporti determi nati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, cioè in rapporti di produzione corrispondenti a un determinato livello di svi luppo delle loro forze produttive materiali. Il complesso di tali rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e a cui corrispondono determinate forme di coscien za sociale. Il modo di produzione della vita materiale è ciò che condiziona il processo sociale, politico e spirituale. Non è la co scienza degli uomini che determina il loro essere, ma, al con trario, è il loro essere sociale che determina la loro coscienza. [Marx, 1859, ed. it. p. 31] Marx prosegue, naturalm ente, delineando la dialettica della trasformazione: il conflitto tra lo sviluppo delle forze m ateriali e i rapporti di produzione vigenti, che conduce alla rivoluzio ne sociale, alla trasform azione della base econom ica e, di con seguenza, a u n a più o m eno rapida trasform azione dell’“intera im m ensa sovrastruttura”. Sia la dinam ica che la localizzazione teorica, sia il m ovim ento diacronico che i rapporti sincronici, presuppongono un ordine culturale diversificato. La società pre figurata dalla teoria m aterialista è divisa nei "sistemi finalizzati che la com pongono” - econom ia, politica, ideologia - e ognu16
no è organizzato in istituzioni specializzate (mercato, stato, chie sa ecc.). La formulazione marxiana del materialismo storico con tiene un preciso a priori strutturale - ma di un genere che l’an tropologia ha ravvisato come particolare e storico. Infatti, l’assenza proprio di quella differenziazione tra base e sovrastruttura, presupposta dalla concezione materialistica, è il marchio di garanzia del “primitivo” nell’esposizione delle cul ture umane. Il termine non ha avuto una grande fortuna in an tropologia, se non per indicare una struttura generalizzata. Nel le culture tribali, economia, politica, ritualità e ideologia non appaiono come “sistemi” distinti, e i rapporti sociali non pos sono essere attribuiti con facilità all’una o all’altra di queste sin gole funzioni. Per volgere il concetto in positivo, la società è ordinata in un unico compatto sistema di rapporti - le cui ca ratteristiche ce li fanno riconoscere come rapporti di “parente la” - il quale si dispiega proiettando i suoi contorni sui vari pia ni dell’azione sociale. Gruppi e rapporti tribali sono “polivalenti” o “multifunzionali”: ordinano tutte le attività che nella civiltà occidentale sono ascritte a speciali diramazioni istituzionali. La parentela, che è in Occidente una di queste specializzazioni, ri servata all’aspetto privato della vita sociale, è la struttura di una società come quella dei Tallensi. Eppure la parentela è “sovra struttura”, dal punto di vista del materialismo classico, persino quando è base nella struttura della società tribale. Per i Tal lensi, i rapporti di parentela tra padre e figlio, tra marito e mo glie, tra fratello e fratello, costituiscono i rapporti primari di pro duzione. Essi sono anche rapporti di tipo giuridicopolitico e ri tuale. La religione è il culto degli antenati, come l’organizza zione politica è il lignaggio e quella produttiva è il villaggio pa triarcale.1 Di qui la necessità avvertita da Worsley di segmentare la pa rentela nei "sistemi che la compongono”. Cosi, mettendo insie me la totalità di una società con le divisioni di un’altra, Worsley disfa con un lavoro della mente il lavoro fatto dalla storia. Ma allora 1’“analisi materiale” deve tenere in poco conto il caratte re di relazioni economiche della parentela, e cosi ridurre la fa mosa "determinazione da parte della base economica” a un’eco logia dell’interesse pratico e a una psicologia del movente eco nomico. L'antropologia delle società tribali deve trarre un im portante insegnamento: questa spiegazione che prende le mosIV
se dalla necessità materiale non è intellettualmente accidentale. In parte, il carattere della critica di Worsley è stato imposto dal la teoria dominante nell’antropologia inglese. Il tipo di mate rialismo che intende la parentela come “idioma” del pratico è anche un adattamento alle condizioni teoretiche esistenti all’in terno della disciplina. La posizione di Worsley è l’antitesi della tesi strutturalista sviluppata da Radcliffe-Brown e seguita da Fortes, e in quanto pura negazione condivide le premesse del suo opposto teorico. Soprattutto, mantiene la concezione della for ma sociale come “espressione” di un “principio” sottostante, che è centrale nell’opera di Radcliffe-Brown. Si limita a sostituire il principio di interesse economico a quello di solidarietà sociale, considerando il primo principio come “base oggettiva” del se condo, ma facendo in tal modo del materialismo un altro tipo di sentimentalismo. Mi riservo di approfondire in seguito que sta influenza teorica sul materialismo di Worsley. L’implicazione più importante della controversia con Fortes è di tipo ontologico: riguarda la natura dell’oggetto in questio ne, la società tallensi. Se il materialismo di Worsley era da una parte indotto dal clima teorico, d’altro canto era imposto pro prio dai Tallensi. Questo stesso riferire la parentela alla ragio ne pratica rappresenta una trasformazione logica del materiali smo storico di fronte a un ordine culturale generalizzato che originariamente non era stato previsto. Nella controversia, la forma materiale della società tallensi solo indirettamente è parte in causa, ma costituisce la forza prin cipale del suo sviluppo. Le fasi della trasformazione che Wor sley fa del materialismo storico sono connesse tra loro secondo il modo in cui il sistema tallensi è costituito. In uno stadio ini ziale dell’analisi, Worsley è portato a scambiare il contenuto reale delle relazioni tallensi per la loro forma astratta (per esem pio, la cooperazione); l’intenzione è interpretare il contenuto come “idioma” della forma. I rapporti di produzione addotti da Worsley sono dei fatti tecnico-formali: la collaborazione e l’au torità necessarie nella produzione agricola; i limiti demografici alla misura e densità nel villaggio; le implicazioni della fusione e della scissione sulla ripartizione differenziata delle risorse agri cole; la necessaria scala sociale nella ripartizione del cibo e quin di nella solidarietà; le relazioni di cooperazione e competizio ne che si instaurano tra le persone a causa della loro comune 18
dipendenza da risorse collettive (campi permanenti); e cosi via. Da queste condizioni tecniche Worsley fa discendere il contenu to delle relazioni corrispondenti o, a volte, più modestamente, il “significato obiettivo” (p. 42) di questo contenuto. All’età di nove o dieci anni, per esempio, i bambini tallensi cominciano a prendere parte all’economia domestica sotto la guida del pa dre; è “durante questo periodo”, scrive Worsley, “che prende a svilupparsi quell’identificazione tra padre e figlio che dà forma e forza al sistema di lignaggio” (p. 42; corsivo mio).2 Analoga mente, è nei fatti tecnico-formali della divisione del cibo e del lavoro comune che i fratelli sviluppano quella “solidarietà di fratellanza" che costituisce il legame del lignaggio (p. 42). La “base pratica” dell’obbedienza e dell’attaccamento filiali è il va lore economico della terra, che è anche la base del distacco quando la terra è insufficiente (pp. 42 e sgg.). Cosi, da nume rose osservazioni di questo tipo, Worsley conclude: “Il sistema di parentela è il sistema unificatore nella vita tallensi. Ma è an che la forma d'espressione delle attività economiche... Io sosten go che il sistema di significazione determinante è il sistema eco nomico, nei suoi aspetti di produzione, distribuzione e consu mo” (p. 64; corsivo mio). Cosi, nella prima fase dell’analisi di Worsley, il sistema di parentela che ordina la produzione è di sciolto nei “sistemi finalizzati” che lo compongono - e la cui realtà a livello economico è un’astratta dimensione tecnica ma solo per ricomparire più tardi come “espressione” di relazioni economiche di cui costituisce il contenuto.3 In ultima analisi, dunque, il materialismo è diventato una va rietà di “economicismo”. Le dinamiche della struttura di li gnaggio tallensi sono ricondotte a motivazioni economiche, concepite come ovvia derivazione dalle condizioni oggettive di produzione. I figli rimangono sotto l’autorità del padre dopo la maturità (residenza patrilocale) per conservare l’accesso alla fattoria familiare allargata; oppure la carenza di terra, il desi derio di mantenere il controllo sul proprio lavoro, o la preoc cupazione per le proprie famiglie che crescono, li spingono ad allontanarsi dalla fattoria paterna (pp. 48, 54 e sgg.). Le com pattezze e le sfaldature strutturali a cui Fortes dà tanta impor tanza sono più sostanzialmente un fatto di sentire economico. La logica del lignaggio è l’interesse economico. 19
Tra il primo e l’ultimo stadio di questo sviluppo teoretico, Worsley interpreta gli altri “sistemi finalizzati” interni al sistema di parentela, come il culto degli antenati, per mezzo della strut tura economica che aveva in tal modo analizzato. Ogni singolo momento funzionale di una relazione di parentela polivalente, dunque, è considerato come effetto di un altro momento, quan do ognuno è di fatto presente nell’altro. Worsley afferma, per esempio, che il rapporto giuridico o rituale tra padre e figlio tallensi dipende dal loro rapporto nell’ambito della produzio ne (pp. 41-49, 62). Ma è evidente che il loro rapporto nell’am bito della produzione dipende a sua volta dall’autorità del pa dre in una struttura patrilineare e dalla devozione rituale del fi glio (Fortes, 1949, p. 204). Ma l’intoppo fondamentale in que sto punto, come in tutta l’analisi, è che non è possibile deter minare gli aspetti che nella relazione dipendono dalla parentela servendosi delle coordinate economiche dell’interazione. Nulla delle condizioni materiali o degli interessi economici può pre cisare le caratteristiche della parentela in sé. Gli agricoltori tal lensi non sono in relazione di padre e figlio per il modo in cui entrano nella produzione: essi entrano nella produzione in un determinato modo perché sono in relazione di padre e figlio. Questo è ciò che rende inattaccabile la replica di Fortes (1969, pp. 220 e sgg. ). Fortes replica semplicemente che la forma strutturale del si stema di lignaggio tallensi non è determinata dalle proprietà obiettive della produzione. Si potrebbe aggiungere che la pa rentela è per definizione un’attribuzione simbolica - una “ca tegoria fondamentale del pensiero tallensi” (1949, p. 339) - e non una relazione di natura oggettiva. Il lignaggio è un istitu to sui generis, nel senso che i suoi stessi termini, in quanto cul tura, non sono in nessun modo immanenti alle condizioni ma teriali, e allo stesso tempo esso è dominante sopra queste con dizioni per il fatto che le ordina secondo i suoi propri termini. Fortes è pronto ad ammettere che può essere nella natura del la produzione agricola che padre e figlio cooperino, ma non è nella natura della produzione agricola che padre e figlio coope rino - in quanto opposti a madre e figlia, fratello della madre e figlio della sorella o don Chisciotte e Sancio Panza. Fortes ha dato atto che nell’etnografìa dei primitivi la necessità materia le è un irriducibile dato di fatto, ma giustamente insiste, con20
tro questo fatto, che la logica della situazione è l’insieme delle relazioni di parentela, un insieme che Worsley dissolve analiti camente. Quindi l’effetto della necessità materiale è determi nato dal carattere di parentela delle relazioni - anche se la de finizione di un’esistenza umana in termini di lignaggio mette al primo posto le necessità economiche.4 Ma se questa è la forza della posizione di Fortes, la sua vul nerabilità dipende dal modo di esporla. La debolezza sta nella distinzione, tipica dello strutturalismo inglese, tra forma socia le e principio soggiacente. Worsley prende le mosse citando ab bondantemente un significativo passo dell’ultimo capitolo di Web of Kinship di Fortes. L’essenza della parentela tallensi, sug gerisce qui Fortes, consiste “nella sua funzione di meccanismo principe attraverso cui gli assiomi morali di base di una società del tipo rappresentato dai Tallensi vengono tradotti nel con creto dare e avere della vita sociale” (1949, p. 346) - la cita zione è riportata da Worsley proprio all’inizio della sua critica (1956, p. 38). Era dunque complessivamente troppo facile per Worsley dimostrare, servendosi della citazione di Fortes, che il “concreto dare e avere della vita sociale” era inteso in senso economico, e che sia la morale che la parentela sono soggette alle condizioni ambientali e alle spinte economiche. Dove For tes aveva visto la tendenza alla residenza patrilocale, oppure l’in clinazione dei figli a tornare nella tenuta del padre dopo la sua morte, come un indice della solidarietà del lignaggio paterno, Worsley poteva controbattere in maniera persuasiva che tale comportamento può essere spiegato con l’esistenza di campi fer tili e concimati solo nel territorio del villaggio tradizionale. E il lignaggio che “traduce” il dare e avere della vita economica; il concime è più denso del sangue. E pur essendo economica mente desiderabile, né solidarietà né culto del lignaggio valgo no a stornare la tendenza dei figli ad allontanarsi dal padre, o dei fratelli dai fratelli. La differenza nel trattare la scissione del villaggio è partico larmente istruttiva: è come se due navi passassero nella notte. Fortes aveva esposto gli stadi successivi del ciclo domestico dei Tallensi in una serie di diagrammi (1949, p. 76; le fasi iniziali di segmentazione sono riprodotte in forma semplificata nella fig. 1). Per Worsley, comunque, i diagrammi dimostravano a pri ma vista 1’“inesattezza dell’analisi [di Fortes] della scissione nel 21
lignaggio in termini di conflitto tra i “principi” di matricentra* lità e patricentralità” (1956, p. 57). L’obiezione si riferiva all’affermazione di Fortes che “il concetto di discendenza paterna si contrappone al concetto di discendenza materna in tutti gli aspetti della vita familiare” - e che questi due concetti di ori gine “funzionano come poli opposti nella struttura di questo campo”.5Ma secondo la lettura di Worsley la vera “fonte” della scissione del villaggio non può essere un conflitto tra principi sociali; deve piuttosto essere una separazione di famiglie su una base economica. La secessione dei figli rappresenta un urto tra interessi di proprietà, motivato dalla crescita delle singole fa miglie derivate, dal desiderio di indipendenza e dalla scarsità della terra, in parte naturale e in parte causata da un sistema ereditario che rende impossibile l’assunzione diretta della pro prietà da parte dei figli. La differenziazione economica è cosi “la forza che opera al di sopra di altre differenziazioni quali l’età, il sesso, e le sfaldature nella struttura del lignaggio” (Worsley, 1956, p. 60; corsivo mio). Ma, naturalmente, data l’impostazione generale di Fortes, questi argomenti non toccano il suo ragionamento. Fortes non nega l’esistenza di costrizioni ambientali o di interessi econo mici, anzi li mette in rilievo. Però insiste sul fatto che gli effetti sociali dell’interesse pratico - per non parlare della natura di tale in teresse - dipendono dalla struttura in atto. Inoltre, la logica econo mica è fondata socialmente: per quanto riguarda il dato di fat to dei campi permanenti concimati, essa può spiegare il desi derio della gente di accedervi, ma non spiega perché i figli stia no con i padri, o perché la terra sia trasmessa per via patrilineare. Per quanto riguarda la scissione della famiglia, Fortes ne aveva già sottolineato l’aspetto economico (1949, p. 262 e pas sim; rilevato da Worsley, 1956, pp. 46-49). Il suo punto di vista è che “le pressioni economiche... non opererebbero proprio in quel modo se non esistesse la dicotomia interna alla struttura della famiglia e del lignaggio”. Tutte le pressioni economiche messe insieme non spiegherebbero la particolare progressione della segmentazione. Proviamo a ridurre il problema alla sua forma più elemen tare, supponendo con Worsley che la divisione della famiglia unita dalla fase 1 alla fase 2 sia dovuta a forze economiche de mografiche. Ma, in termini materiali, il solo effetto di questa 22
23
Figura 1 Schema della scissione della fattoria tallensi (da Fortes, 1949, p. 76).
“pressione” sarebbe stato che, grosso modo, due terzi della fa-, miglia originaria avrebbero continuato a vivere nello stesso sito mantenendo il livello economico iniziale. Ma la “pressione” eco nomica, per la sua indeterminatezza, non specifica quando l’ef fetto sarebbe stato di intensificazione, di privazione o di seg mentazione, e, in quest’ultimo caso, quale terzo della popola zione sarebbe dovuto andarsene. Da differenti società ci si aspet ta differenti reazioni. Per quanto riguarda i Tallensi, la logica sociale della scissione è proprio ciò che Fortes aveva esaminato nell’analizzare l’ordine patrilineare. I figli si differenziano, pri ma, in base ai matrimoni del padre, poi, in base ai matrimoni loro propri. E un fenomeno ben noto all’antropologo che si in teressa di sistemi patrilineari: il lignaggio è diviso internamen te da alleanze e obblighi esterni, tali che le mogli e le madri, indispensabili alla continuità del gruppo, diventano al tempo stesso i punti focali della sua segmentazione genealogica. Una tale logica, comunque, è strutturale e culturale: le sue proprietà non sono conseguenza della “pressione” economica. Al contrario, sarebbe facile dimostrare, con il ragionamento e con gli esempi, che la natura della pressione materiale è una funzione della logica sociale tallensi (per esempio, Fortes, 1949, pp. 182-8S). Gli squilibri demografici vissuti dai Tallensi non sono espressione diretta e intrinseca delle forze produttive, ma del modo in cui queste forze sono organizzate culturalmente. In particolare, sono espressione del modo di accesso alle risorse, qui governato dalle regole della patrilocalità: l’incorporazione del possesso della terra ai livelli bassi della segmentazione del lignaggio, e l’esclusione dei figli (anche adulti e padri essi stes si) dal diritto di possedere terre in proprio mentre il padre è ancora in vita. In queste condizioni lo scarto tra crescita e mor talità nelle famiglie si dimostrerà una fonte inesauribile di pres sione microecologica - di un genere e di un’intensità che sem plicemente non esisterebbero se, per esempio, la terra fosse ge stita dal livello più alto del lignaggio o se le unità territoriali con libero accesso fossero utilizzate da tutti i membri della fa miglia.6 Da tutto ciò si può concludere, in favore di Fortes, che le forze economiche come tali non hanno significato o inciden za sociali. E possibile che non ci sia un rapporto di causa e ef fetto tra rirrilevanza della funzione materiale rispetto alla for ma in cui si realizza e le specifiche proprietà dell’ordinamento 24
patrilineare. Ma, d’altra parte, nella misura in cui le forze ma teriali sono costituite socialmente, i loro effetti specifici sono de terminati culturalmente. Il nodo fondamentale tra Worsley e Fortes non è stabilire se la situazione materiale oppure la strut tura sia la forza sociale, ma piuttosto quale sia la logica sociale. Fortes sembra prevalere nella discussione, ma è possibile che ciò non dipenda dalla bontà della sua teoria. La teoria strutturale-funzionale, come abbiamo visto, giustifica la critica di Wor sley - finché egli rimane all’interno dell’analisi della forma e del “principio” che Fortes stesso adopera. Forse vale la pena fa re una breve digressione sulla natura di questa teoria. La debolezza del punto di vista di Fortes coincideva con una caratteristica originaria dell’antropologia sociale inglese. Radcliffe-Brown credette di poter fondare una “scienza naturale del la società”, teoretica e comparativa, sulla scoperta dei principi generali che le pratiche sociali specifiche manifestano (vedi per esempio, Radcliffe-Brown, 1950, 1952, 1957). Il mondo sociale procede su due livelli: gruppi e rapporti concreti sono 1’“espres sione” di sentimenti più astratti; la forrha fenomenica è una rap presentazione accidentale dei principi soggiacenti. I “principi” addotti da Radcliffe-Brown, tuttavia, erano precisamente le rifor mulazioni in astratto dei costumi che egli cercava di spiegare. L’equazione tra padre e fratello del padre nel lessico di paren tela, per esempio, veniva interpretatà'come “principio di equi valenza tra fratelli”. L’interpretazione è evidentemente una tau tologia, e come tale fallisce l’obiettivo che si era dato: appiatti ta sull’uso a cui si riferisce, la spiegazione manca della profon dità che Radcliffe-Brown avrebbe voluto darle. Si potrebbe dire che la rivalutazione materialistica fatta da Worsley dei Tallensi abbia riempito un vuoto intellettuale nella scuola britannica. Ma la situazione teorica, in realtà, presentava aspetti ben peg giori, e la critica di Worsley corrispondeva con precisione a una difficoltà più grave. Il difetto del procedimento di RadcliffeBrown si fece del tutto chiaro solo quando fu applicato com parativamente. Se in un singolo caso il “principio” rappresenta la manifestazione asU'atta della forma, la generalizzazione del principio per servire diverse forme distinte diventa un esercizio di classificazione. Cosi, per Radcliffe-Brown l’equivalenza di pa rentela tra un uomo e suo fratello, tra levirato e sororato, tra poliandria adelfica e poliginia sororale, cosi come l’avunculato 25
nei sistemi patrilineari, sono tutti esempi del principio di “iden-, tità di fratellanza”. Impantanato in questa confusione tra gene ralizzazione e classificazione, il progetto di Radcliffe-Brown ha corso il rischio di cadere nell’assurdo. Sul modello delle scien ze naturali, aveva voluto spiegare il particolare col generale, comprendere la forma concreta come caso specifico di una re gola più ampia. Vide se stesso come colui che aveva scoperto le leggi naturali della vita sociale, definendo la legge naturale “l’esposizione delle caratteristiche di una determinata classe di sistemi naturali” (1957, p. 63). Ma se la legge diventa una clas se tassonomica, più essa è ampia, meno numerosi e più gene rali devono essere i criteri di inclusione. Perciò, più grande è la “generalizzazione”, o “legge”, meno essa dice su alcunché in particolare. Raggruppando forme sempre più diverse sotto prin cipi sempre più ampi, Radcliffe-Brown spiegò sempre meno su ognuna di esse. I “principi” non possono sperare di spiegare il particolare: lo distruggono.7 Una delle principali reazioni della scuola inglese alla vacuità della generalizzazione tassonomica è consistita nell’invertire il procedimento: rendere le classi più ristrette anziché.più ampie. Un rapporto soddisfacente con la realtà empirica potè essere recuperato suddividendo tipi e principi sociali in varietà sem pre meno inclusive, secondo la loro presenza in particolari so cietà. Questa “caccia alle farfalle”, come giustamente l’ha chia mata Leach (1966), può essere vista come un ripercorrere le tracce della generalizzazione di Radcliffe-Brown, mettendo, al posto della vuotezza del principio generale, la sua variazione in rapporto al caso specifico, senza mettere in discussione le no zioni formali insite in quel progetto. Riguardo all’idea di “prin cipio”, comunque, si tendeva a enfatizzare un aspetto di queste nozioni, pur nella consapevolezza che ci si trovava di fronte a una situazione di stallo “scientifico”. I principi sociali venivano sempre più interpretati come valori soggiacenti e sentimenti mo rali. Anche questo era implicito nella concezione originaria. Le radici di tale atteggiamento risalgono almeno alfllluminismo, da cui furono trasmesse, attraverso Saint-Simon e Durkheim tra gli altri, a Radcliffe-Brown (Evans-Pritchard, 1954, pp. 21 e sgg.). “Principio”, in questo caso, era la forza attiva che sta dietro al la forma, le “passioni umane che la fanno muovere”. La frase è 26
tratta da un passo fondamentale dello Spirito delle leggi (libro 3°, cap. 1): Fra la natura del governo e il suo principio vi è questa differen za, che la natura è ciò che lo fa essere quello che è, e il suo prin cipio ciò che lo fa agire. L’una è la sua struttura particolare, e l’altro le passioni umane che lo fanno muovere. [Montesquieu, 1748; nota di Montesquieu: “Questa distinzione è molto impor tante, e ne trarrò molte conseguenze: è la chiave di un’infinità di leggi.”]8 Il principio è la condizione umana indispensabile per resi stenza della forma sociale, è ciò che dà una forma alla sua ra gione distintiva. Una struttura sociale è dunque una sorta di cristallizzazione in relazioni oggettive di un valore soggettivo proprio come, per Montesquieu, ogni tipo di governo ha il suo principio particolare: il governo repubblicano la virtù, la mo narchia l’onore, il dispotismo la paura. E qui allora l’origine del concetto di Fortes della parentela come “traduzione” degli assiomi morali fondamentali della società tallensi nei termini di dare e avere della vita sociale.9 Anche per Worsley la parentela è una “forma di espressione”, ma intesa fondamentalmente co me espressione di attività economiche. L’assunto teorico dell’an tropologia inglese, che ritiene la parentela traduzione di una qualche realtà più profonda, era fatta apposta per provocare una critica materialista dello stesso peso. Molto della reciproca in comprensione, nel loro dibattito, derivò dal fatto che Worsley attaccava l’idea secondo la quale la parentela esprime il valore sociale, laddove Fortes stava sostenendo che la parentela orga nizza le attività economiche. Se questo è il dato osservato nella società tallensi, cosa dobbia mo concludere sull’adeguatezza del materialismo storico? Può darsi che la controversia sui fatti fosse talmente sentita da preclu dere ogni chiarimento sulla validità della teoria. Worsley dà una versione della teoria materialista soggetta a un duplice condizio namento: da parte della natura della teoria strutturalista a cui si oppone e da parte della struttura della società che interpreta. Può darsi che il suo economicismo fosse dovuto al primo condiziona mento, ma in questo caso il suo fallimento non prova nulla sul se condo; per lo meno, non prova che il tipo di società in esame sia intrinsecamente resistente a un marxismo autentico. Secondo 27
me, d’altra parte, la metamorfosi del marxismo in un determini smo economicistico era l’inevitabile conseguenza del suo impatto con un sistema generalizzato come quello tallensi.10Ma per il mo mento può bastare questo suggerimento, senza pensare che sia stato provato. Nello stesso modo vorrei esporre il corollario che ne segue: appena richiamando la correttezza della posizione di Lukàcs, e di molti altri marxisti, sul fatto che la verità del mate rialismo storico è essa stessa storica. Non si sbaglia, scrive Lukàcs, se si applica il materialismo sto rico “rigidamente e incondizionatamente alla storia del dician novesimo secolo”. Infatti, nella storia di questo secolo, tutte le forze che hanno agito sulla società hanno di fatto operato unicamente come forme fenome niche dello “spirito oggettivo”. Ora, questo non accade affatto nel le società precapitalistiche. In esse non vi è ancora quella auto nomia, quel porre-se-stesso-come-fine, quell’essere chiuso in sé e quell’autodominio, quell’immanenza della vita economica che è stata raggiunta nella società capitalistica. [Lukàcs, 1923, ed. it. pp. 295-296] Ma per la stessa ragione, e cioè che la teoria è “l’autoco scienza della società capitalistica”, essa ha uno specifico statuto storico. E una brillante prise de conscience di un particolare tipo di sistema, in cui le relazioni tra uomo e uomo, come quelle tra uomo e natura, sono reificate in relazioni economiche. In ultima istanza, continua Lukàcs, il materialismo storico realizza un’antropologia tra quelle possibili: non perché ha u n ’applica zione meccanica alle società precapitalistiche, ma proprio per ché consente di evitare u n ’identificazione ingenua del passato con la struttura del presente. Tuttavia, se il materialismo stori co viene trasferito senza modifiche all’analisi della società più antica, “si nota allora una differenza metodologica importante ed essenziale che non è venuta alla luce nella critica del capi talismo”. Questa difficoltà, spesso rilevata da Marx e da Engels, “risiede nella differenza strutturale tra l’epoca della civiltà e le epoche ad essa anteriori” (1923, ed. it. p. 288; corsivo di Lukàcs). Seguendo Lukàcs si è tentati di concludere che il materiali smo storico e lo strutturalismo inglese sono entrambi, nel bene e nel male, teorie speciali, applicabili a differenti universi cul28
turali. La stessa conclusione, come vedremo, emerge dal dibat tito tra il marxismo e lo strutturalismo francese. Ma questo di battito va anche al di là delle differenze istituzionali fra società - e al di là di tutti gli eventuali "revisionismi” nella forma e nell’applicazione del materialismo di Marx. Questo dibattito sol leva il problema piti fondamentale sul rapporto tra prassi e or dine simbolico. E una volta sollevato il problema, non si tratta più di sapere se la cultura tribale non sia anche determinata dal la necessità materiale, ma se la società borghese non sia anche una cultura.
MARXISMO E STRUTTURALISMO FRANCESE
La struttura istituzionale delle culture tribali è solo uno dei problemi antropologici che il materialismo storico deve affron tare. Un altro è la resistenza apparente di tali sistemi a fare espe rienze nel mondo, una certa immunità dell’ordine esistente nei confronti della contingenza storica. Questa resistenza a sua vol ta si trasforma in una più fondamentale proprietà delle forme socioeconomiche tribali: il dominio sull’azione pratica da parte della concezione culturale piuttosto che da parte dell’azione sul la concezione. Poiché questi sono punti essenziali dello strutturalismo fran cese, è chiaro il motivo per cui questo strutturalismo, che ha suscitato un grande interesse nei marxisti, è quello più sotto posto a critica da parte dei rivoluzionari. Veramente, durante i giorni caldi del maggio 1968 a Parigi, sembrò che la pratica aves se composto il giusto necrologio a questa diffusa passione filo sofica del Quartiere latino. Come si disse, “lo strutturalismo è sceso in piazza” (cfr. Epistemon, 1968; Turkle, 1975). Era que sta la parola d’ordine che correva sulle barricate intellettuali. E se si osservava che le barricate stesse sembravano più nostalgi che del 1789 che efficaci per il 1968, la risposta era: “Mais en fiti, il nemico è sempre lo stesso.” Lo strutturalismo era davve ro sceso in piazza. Mi si consenta un altro esempio che evidenzia lo stesso pa radosso. Poco prima degli avvenimenti del maggio 1968 ebbi l’opportunità di assistere a un dibattito informale tra un mem bro americano del tribunale Russell - di passaggio a Parigi da 29
Copenaghen, dove aveva avuto notizia della moda strutturalista da colleghi francesi - e un antropologo parigino. Dopo lunghe discussioni l’americano riassunse il suo punto di vista in questo modo: “Ho un amico,” disse, “che sta facendo uno studio so ciologico sui monumenti equestri di Central Park. Una specie di strutturalismo. Lui trova che ci sia un rapporto diretto tra lo statuto culturale del cavaliere e il numero di zampe che il ca vallo tiene sollevate da terra. Una zampa alzata ha una conno tazione storica diversa da quella del cavallo che si impenna sul le zampe posteriori o quella di un altro lanciato al galoppo. Ov viamente è anche la dimensione a stabilire una differenza. Il guaio è,” concluse, “che la gente non va più a cavallo. Le cose che in una società sono obsolete, fuori di discussione, quelle possono essere viste come struttura. Ma gli aspetti economici e politici sono ancora in discussione, e la decisione dipenderà dal le forze e dalle risorse reali.”11 L’antropologo parigino ci pensò su un attimo. “E vero,” dis se alla fine, “che la gente a cavallo non ci va più. Ma di statue ne costruisce ancora.” Era implicito qualcosa di più del fatto che il passato non è morto - poiché, come è stato detto dell’America del Sud, non è nemmeno passato. Era anche sottinteso che economia e po litica hanno modalità diverse dalla “reale” lotta per il potere. Come Durkheim contestava a Spencer l’idea che il contratto for mi la società, giacché la società è già presupposta nelle regole non stipulate da cui derivano gli accordi, nello stesso modo la competizione sociale deve essere fondata sulle concezioni co muni delle risorse, dei fini e dei mezzi - valori che non sono mai gli unici possibili. La competizione non evolve necessaria mente verso una eterna e formale razionalità di massimizzazio ne; si sviluppa secondo un sistema di rapporti culturali, che com prende le complesse nozioni di autorità e sottomissione, di ge rarchia e legittimazione. E fra gli altri mezzi è con la concre tizzazione - alla lettera - di questo codice nei monumenti che la storia è portata nel presente, sia direttamente sia attraverso un lavoro dialettico di riappropriazione e rivalutazione.12 Invero, la replica nel suo insieme era un’applicazione con creta dell’argomento di Lucien Sebag che, in Marxismo e strut turalismo, scrive:
30
È comunque vano ricercare una realtà che sia a un tempo d'or dine culturale e non possa essere tradotta in termini d'attività in tellettuale; giacché gli individui o i gruppi sociali che lottano l’uno contro l’altro, che trasformano la natura e organizzano la loro vi ta in comune, mettono in gioco un sistema di concetti che non è mai il solo possibile e che definisce la forma stessa della loro azione. A questo livello la distinzione tra struttura e sovrastruttu ra si annulla, giacché i rapporti economici, sociali, politici, come pure le teorie che ne rendono conto neH’ambito di una società determinata, sono altrettanti prodotti dello spirito. [Sebag, 1964, ed. it.. p. 185] Rimando l’analisi dell’“idealismo” che sembra implicito in ta le posizione per concentrarmi sul suo apparente “conservatori smo”, derivante, in ogni caso, dallo stesso principio: la posizio ne di privilegio riservata alla costruzione simbolica della pratica. 1,'ondata di delusione nei confronti dello strutturalismo, per la sua celebrazione dello status quo, ha origine dalla convinzione che la rivoluzione sia un bene. Ma questa semplificazione poli tica tralascia troppe cose. Le pure opposizioni sincronia/diacronia o stasi/cambiamento, non descrivono adeguatamente le differenze attuali tra strutturalismo francese e marxismo cor rente. Anche i semplici aneddoti che ho raccontato sul loro con frontarsi suggeriscono un curioso paradosso della coscienza sto rica. Privilegiando i condizionamenti dello stato preesistente ri spetto alle modificazioni derivanti dalla pratica, lo strutturalismo si appella all’azione del passato laddove il marxismo richiede solo la presenza deH’azione. Lo strutturalismo - apparentemente un’elaborata conseguenza dell’espressione plus (a change, plus c’est la mime chose - ha per la storia un rispetto senza pari. Sin cronico nei principi, offre gli strumenti più raffinati per lo stu dio della diacronia. Ma, in verità, lo strutturalismo non è tanto una teoria della riproduzione semplice, quanto è stato una teo ria delle strutture che cosi si riproducono. La questione di principio per lo strutturalismo è che la circo stanza di per se stessa non genera una forma a meno che il si stema vigente non le fornisca significato ed efficacia. La sup posizione che non resti spazio per l’azione umana o per l’even to contingente, non è giustificata da niente. Il punto è che Fazio si
ne - come le parole pronunciate in una situazione che si pre senta per la prima volta - acquista significato coinè proiezione dello schema culturale che dà forma al suo contesto specifico, e dà efficacia dalla relazione di significanza che si instaura tra questo riferimento contingente e l’ordine esistente. Un evento si trasforma in una relazione simbolica. Il processo è ben noto e utilizzato nell’appropriazione linguistica dell’esperienza. Cosi lo descrive Sapir: Spesso esperienze culturali nuove rendono necessario l’ampliamento delle risorse di una lingua, ma tale ampliamento non ha carattere di aggiunta arbitraria ai materiali ed alle forme già pre senti; esso rappresenta semplicemente un'ulteriore applicazione di principi già in uso, e in molti casi è poco più che un'esten sione metaforica di termini e di significati preesistenti. E molto importante rendersi conto che la forma di una lingua, una volta affermatasi, può rivelare a coloro che la parlano significati che non è possibile far risalire sempre alla qualità dell’esperienza da ta, ma devono in larga misura venire spiegati come la proiezione, nel materiale grezzo dell’esperienza, di significati potenziali. Un uomo che nel corso della sua vita non abbia mai visto più di un elefante parla tuttavia senza la minima esitazione di dieci elefan ti, di un milione di elefanti, di un branco di elefanti, di elefanti che camminano a due a due o a tre a tre, o anche di intere ge nerazioni di elefanti: è evidente che il linguaggio ha la facoltà di analizzare l’esperienza riducendola ad elementi teoricamente dis sociabili e di creare quel mondo di,.,potenzialità sviluppatesi gra do a grado accanto a quello della realtà che consente agli esseri umani di trascendere f immediatamente dato delle loro esperienze individuali per congiungersi in una più ampia comprensione co mune. Questa comprensione comune costituisce appunto la cul tura. [Sapir 1933. trad. it., p. 148]15 Per lo strutturalismo, il significato è la caratteristica essenziale dell’oggetto culturale, cosi come l’attività simbolica è la speci fica facoltà dell’uomo. Naturalmente non è il significato a crea re le forze reali e materiali, ma nella misura in cui esse vengo no utilizzate dagli uomini, .il significato le circoscrive e governa la loro specifica influenza culturale. Inoltre le forze non sono prive di efficacia reale; solo che non hanno un'efficacia parti colare, come non hanno effettiva esistenza culturale, al di fuo ri della loro integrazione in un dato schema storico e simboli32
co. Il mutamento ha inizio con la cultura, non è la cultura a es sere attivata dal mutamento. Per la teoria della prassi, al con trario, il momento decisivo e autosufficiente è l’atto. Esso stes so soggetto alla costrizione della necessità materiale, l’atto ge nera necessariamente forma e significato culturali sulla base del le caratteristiche date del reale - il famoso processo dell’autoproduzione dell’uomo attraverso il lavoro. La “visione comune” di cui parlava Sapir, in questo caso non è ciò che crea il signi ficato, ma è la sua condizione antecedente o la sua susseguen te rappresentazione. La costruzione specifica della cultura è il prodotto di un’attività concreta che trascende il sistema per ap propriarsi la novità e la realtà del mondo materiale.14 In questo momento creativo dell’atto, l’ordine culturale esistente perde la sua storica (ossia costitutiva) funzione. L’eredità del passato, non più viva, svolge un ruolo teoretico di impedimento alle strutture emerse dalla logica produttiva; oppure è “docile” e sot tosta alla sua stessa obsolescenza, come una brava “variabile di pendente” dell’antropologia empirista. Di qui il paradosso del la coscienza storica: il ruolo assegnato alla storia dalla conce zione materialistica rischia un doppio impoverimento, da un la to a residuo e dall’altro a momento di origine. La “storia” en tra nella teoria come sopravvivenza, come nome di un’effimera eccezione al potere costitutivo della pratica. Oppure, si fa astra zione dal contenuto storico reale, ridotto a quel potere costi tutivo delle forze produttive, cosi che l’analisi può svilupparsi come una sorta di situazione originaria —come se si avesse l’op portunità, dice Malinowski, di essere presenti alla creazione (ve di oltre pp. 80-81). Simbolo e atto, parola e mondo: le due pro spettive differiscono nei punti di partenza epistemologici. E l’ap parente conservatorismo dello strutturalismo altro non è che il concetto di ciò che ognuno riconosce come un fatto: che la sto ria comincia con una cultura già presente.15 Che peso dare allora all’opinione del marxista francese Char les Parain, che dopo lunga riflessione sull’opera di Lévi-Strauss conclude che quanto vi si può trovare “c’est l ’embarras du structuralisme face à Vhistoire”? Se è vero, c’est un embarras de richesse. Lo strutturalismo si è sviluppato in primo luogo dall’incontro con un tipo di società, la cosiddetta società primitiva, contrad distinta dalla particolare caratteristica di assorbire le perturba zioni introdotte dall’evento con un minimo di deformazione del 33
sistema. Con la comprensione di questa caratteristica, lo strut turalismo intraprende la spiegazione del funzionamento della storia nella sua forma più alta, la continuità della struttura per mezzo dell’evento. E dopo tutto - sembra di vederla la gallica alzata di spalle di Jean Pouillon mentre ci ricorda che - “non sono gli strutturalisti a mettere le strutture nella storia” (1966, p. 785). Cos’è questa “particolare caratteristica” della società tribale di riprodursi in modo più o meno stereotipato di fronte alle vi cissitudini storiche? E che genere di luce speciale getta su que ste società l’analisi strutturalista? Senza voler avanzare nessuna profonda competenza di strutturalista, azzarderei una risposta ripensando, attraverso quella griglia interpretativa, un’espe rienza etnografica che ho già descritto altrove in altri termini (Sahlins, 1962).16 L’esempio riguarda il sistema delle metà e la sua resistenza alla variazione demografica nelle isole Moala e Lau delle Figi orientali. Solleva quindi un problema già noto an che a Marx: il cosiddetto carattere stazionario delle comunità arcaiche (cfr. B. Turner, 1974). Inoltre ha una notevole utilità in rapporto al dibattito tra marxismo e strutturalismo, al quale dedichiamo u n ’attenzione che può forse giustificare la lun ghezza di questa digressione etnografica. E inevitabile che l’esempio prenda in considerazione l’organizzazione simbolica della pratica economica, ed ecco il famoso “idealismo” dello strutturalismo. Aggiungo subito che la descrizione di Moala e di Lau sarà tanto semplificata, trascurerà a tal punto la loro com plessità, che non meriterebbe alcuna attenzione se non fosse un’illustrazione cosi efficace di questa tematica. “Ogni cosa si muta in due cose,” disse a A. M. Hocart un amico di Lau, “altrimenti i pescecani morderanno.” Ugualmente per i moalani la loro isola e ognuno dei suoi villaggi sono es senzialmente costituiti da due “razze”: la Gente di Terra (hai vanua) e i Capi ( turagn). La Gente di Terra è nota anche co me “i proprietari” ( taukei), termine che ha lo stesso significato di “primi occupanti” o “popolazione originaria”. I Capi arriva rono più tardi, dal mare, per prendere il comando su una gen te numerosa che aveva popolato l’interno dell’isola - cosi la Gente di Terra è detta anche “le Migliaia” ( Udolu) o la “Gente Animale” ( Yavusa Manumanu). Essendosi sottomessa ai Capi, la Gente di Terra li serviva nelle pratiche rituali, soprattutto come 34
maestri di cerimonia e nella distribuzione del cibo ( matanivanua). Già si comincia ad avvertire la produttività simbolica del dualismo. La differenza tra gruppi sociali corrisponde alla di stinzione tra terra e mare sul piano geografico, che a sua volta è un esempio di una differenziazione spaziale generale tra in terno e periferico, correlata con le opposizioni indigeno/straniero, primitivo/recente, e anche animale/culturale; gli stessi gruppi sono inoltre inferiori o superiori politicamente, e asse gnati a funzioni rituali o secolari. Il mito di origine è, per cosi dire, una traduzione in termini di tempo di queste distinzioni di base, è la sovrapposizione di una logica binaria al tempo, per riprodurla sotto forma di racconto (cfr. Thompson, 1940). Ma sarebbe insufficiente considerare i contrasti solo come serie di opposizioni congruenti. Le leggende locali sull’arrivo dei Capi, cosi come molte consuetudini tradizionali rivelano una precisa struttura di reciprocità. Nei suoi termini più generali la logica di reciprocità consiste nel fatto che ogni “razza” fa da media tore alla natura dell’altra, è necessaria alla realizzazione e re golazione dell’altra, cosi che ogni gruppo contiene necessaria mente l’altro. La configurazione che ne deriva non è tanto una semplice opposizione, come in un sistema quadripartito costi tuito dal raddoppio di una dicotomia principale, come avviene nella rappresentazione che Hocart fa della “tribù” di Moala e delle isole vicine (fìg. 2). Questo schema, come vedremo, fun ziona bene da descrizione dell’organizzazione moalana intesa come sistema di discendenza dei gruppi o come quadro terri toriale. Ma lo stesso codice a quattro classi lo si può scorgere “Tribù”
Nobili [Tt/raga]
Nobili
Terra [Vanua]
Terra
Nobili
Terra
Figura 2 Modello generale della “tribù” nel gruppo moalano (da Hocart. 1929. p. 233). 35
nelle relazioni di parentela e di matrimonio, nel rito e nella pro duzione, nei valori dei beni e nei concetti di spazio.17 Seguen do fino in fondo le connessioni significanti tra gli usi a questi differenti livelli, siamo in condizione di riprodurre il processo nel quale una dimensione culturale riceve la sua forma da un'al tra per creare un ordine globale che è allo stesso tempo di for ma, di contenuto - e di azione. In tutta Lau la pretesa della Gente di Terra di essere i veri “proprietari” e uomini dell’isola è riconosciuta come legittima; ma le loro coltivazioni non prospererebbero senza l’influsso dei Capi. Il diritto del Capo dominante sui prodotti della terra, spe cialmente sulle primizie ( sevu), è stato sempre riconosciuto dai “proprietari” come una garanzia di fertilità, senza implicare un diritto di proprietà da parte del Capo intesa in senso occiden tale. Ci si avvicina di più pensando l’intervento del Capo come una modalità del diritto paterno. La caratteristica specifica del potere del Capo (kaukawa o maria) nelle Figi, è la potenza viri le, una virilità che ha più di una rappresentazione nel costume. Si manifesta apertamente, per esempio, nell’accesso privilegia to del sovrano presso le donne nubili del suo dominio; simbo licamente, nella corrispondenza tra i riti dell’investitura a Capo e l’iniziazione dei giovani alla sessualità e allo status di guer rieri mediante la circoncisione. Entrambe queste cerimonie so no contrassegnate dall’adozione della veste di fibra vegetale (masì), il più pregiato dei “beni femminili” (yaya vakayalewa). Il pas saggio quindi al più alto status maschile è mediato da un ele mento femminile - come contrario logico della concessione di fertilità alla terra da parte del Capo.18 Per mostrare la generalità del sistema basta collegare le don ne al lato di terra delle cose. Le tradizioni di Moala forniscono un’altra testimonianza paradigmatica - preparata, inoltre, dal l’idea della fecondità della popolazione originaria delTinterno, le “Migliaia”. Arrivando nei diversi insediamenti locali gli uo mini della razza dei Capi si assicurarono il comando quando ottennero in moglie le figlie primogenite dei maggiorenti del la Gente di Terra. L’effetto politico di questo dono può essere valutato solo alla luce delle importanti pratiche di parentela, per le quali esso funge a sua volta da leggendario atto istitutivo: 1) la superiorità del “lato dell'uomo” o di chi riceve le donne, il “lato forte”, rispetto a quello dei donatori di donne o “lato de36
bole”; 2) la superiorità del primogenito (maschio o femmina) e dei suoi discendenti rispetto alla linea cadetta; 3) i ben noti privilegi rituali ed economici del vasu, il figlio della sorella, sul fratello di sua madre - per questo nei racconti tradizionali l’au torità dei Capi è moltiplicata dalla loro funzione di vasu nei con fronti della gente comune.19 Adesso prendendo in esame un altro registro culturale, quel lo delle regole che governano la spartizione familiare del cibo e delle proprietà personali, si possono sviluppare ulteriori det tagli delle relazioni tra Capi e Terra, tra uomini e donne, tra famiglia paterna e famiglia materna. Primo: le regole impon gono determinate precedenze tra queste categorie. Gli uomini della famiglia mangiano prima e separatamente dalle donne, che servono il cibo; e inoltre il padre viene prima dei figli, e i fratelli più anziani mangiano prima dei minori. Secondo: esi stono delle interdizioni sorprendenti che riguardano Futilizza zione degli avanzi del cibo di un uomo da parte dei suoi di scendenti, o di proprietà come gli indumenti che sono stati a contatto diretto con il suo corpo. Il familiare più giovane ver rebbe colpito da un eccesso di potenza, che provocherebbe un rigonfiamento della parte del corpo toccata dall’oggetto proi bito. Mangiare il cibo del più anziano, per esempio, provocherà un abnorme ingrossamento della gola o dello stomaco. A Moala questo effetto va sotto il nome di fula-, ma l’espressione figiana più antica è precisamente bukete vatu, “diventare gravido di pie tra” (Deane, 1921, p. 94) ,20 Propriamente, dunque, il solo membro della famiglia moalana che sia esente dal tabù e dai suoi effetti è la moglie più anziana del capofamiglia. U n’analoga immunità la godono le cugine incrociate, che sono i partner sessuali e matrimoniali pri vilegiati - e contrapposte in tutte queste modalità del consumo alimentare alle sorelle di un soggetto maschile. Infine, per i Ca pi dominanti, il privilegio si estende al maestro di cerimonie ( matanivauna, “di fronte alla terra”), lo stesso che nella tradi zione rappresenta la Gente di Terra, i donatori di donne ai Ca pi. Il diritto qui simboleggiato, però, è qualcosa di più dell’ac cesso di questi “capi parlanti” ai beni del Capo, e anche più della conseguente pretesa di superiorità dei donatori di donne - o stirpe materna - sulla discendenza paterna - reciproco del la pretesa del vasu. Grazie alla sua immunità dai pericoli della 37
virilità del Capo, il capo parlante (come pure la moglie del Ca po) diventa l’indispensabile intermediario di tutte le recipro che relazioni tra il maggiore e il minore della stessa discendenza, perché quest’ultimo non venga colpito dalla potenza del pri mo. Senza questa libertà dal tabù sul lato femminile - che può ora essere intesa come più generale negazione della funzione di capo, come corollario del concetto di vera gente della terra, “autentici proprietari” (taukei dina) - la gerarchia si dissolve rebbe nella discontinuità. Ma, stando cosi le cose, ogni ban chetto dato da un Capo è ricevuto cerimoniosamente dalla ma no sovrastante di un capo parlante. Analogamente, nelle isole Tokelau i “discendenti dell’uomo” procurano, mentre i “discendenti della donna” distribuiscono (Huntsman, 1971). Lo schema delle Figi è collegato a struttu re ben note nella Polinesia occidentale, che possono essere complessivamente definite, a livello superficiale, dalla regola che assegna il grosso del controllo economico e politico alla linea paterna, mentre i “discendenti della donna”, pur esclusi dalla successione, mantengono un’autorità rituale che è al tempo stes so indispensabile e ostile a quelli che comandano.21Il sistema è costruito su un doppio asse: da un lato, la relazione patrilaterale di autorità, rappresentata soprattutto come distinzione tra il fratello più giovane e il più anziano. Questa è l’armatura per la formazione dei gruppi sociali, tipicamente raffigurata come una relazione reciproca in cui il più giovane serve il più anzia no, il quale a sua volta si prende cura del suo cadetto. Dall’al tro lato c’è l’asse della complementarità, codificato come lega me fratello-sorella; esso riguarda in modo particolare l’alleanza fra i gruppi, in quanto costituisce l’elemento di mediazione tra la famiglia di origine della donna e i suoi parenti acquisiti. Il sistema figiano di Lau è una variante del medesimo dualismo, ma trasformata in un più complesso insieme di rappresentazio ni triadiche o quadripartite.22 A Lau, veramente tutto deriva dal quattro. Il quattro è il con cetto lauano di totalità. Occorrono quattro gruppi per fare un’isola, quattro giorni di scambio (o quattro tipi di beni) per perfezionare un matrimonio, quattro notti di cure per portare a termine una guarigione. Tradizionalmente, Moala era orga nizzata esattamente nel modo in cui Hocart descrisse la “tribù”: era divisa in Grande Moala e Piccola Moala, e ogni metà era gui38
Generazione di EGO
Figura. 3 Relazioni' dì parentela nel matrimonio tra secondi cugini incrociati (da Fox, 1967, p. 196; si noti che i moalani non praticano lo scam bio di sorelle, ma le implicazioni strutturali sono essenzialmente quel le qui schematizzate). data da un gruppo dtJJapi che comandavano sulla Gente di Ter ra.23 La menzione di tali sistemi quadripartiti, suggerirà imme diatamente all’antropologo un tipo classico di sistema di ma trimonio; egli a ragione può immaginarne 1’esistenza a Moala. I moalani prescrivono matrimoni tra cugini incrociati (cioè discendenti di fratelli di sesso opposto). La pratica tende a sta bilizzare una dualità del genere di quelle che abbiamo visto in altre relazioni - una combinazione di base di opposti, valutati in maniera differenziata - che qui divide la parentela in “diretta” (parenti paralleli) e “acquisita” (parentela incrociata). Ma esi ste un ulteriore patto matrimoniale che comprende l’intera se rie di quattro categorie: il matrimonio tra cugini primi incro ciati è vietato; il coniuge potenziale più prossimo diventa uno dei cugini incrociati di secondo grado (per esempio MMBDD, 39
FMBSD,* sono classificati come cugini primi incrociati nella no menclatura di parentela). Tecnicamente, il sistema che ne de riva è “Aranda” nei confronti dei suoi quattro segmenti intermatrimoniali, pur mancando l’elaborazione terminologica in un sistema a otto sezioni. L’eccellente diagramma di Robin Fox (fig. 3) e la disamina del sistema Aranda (1967, pp. 195-99) aiuterà a sviluppare le implicazioni strutturali. Il modello logico del ma trimonio tra cugini incrociati di secondo grado è costituito da quattro linee di discendenza - ognuna rappresentata per uno specifico ego da uno dei suoi quattro nonni - combinate in de terminate relazioni matrimoniali. Le linee sono raggruppate a due a due in metà esogamiche, ogni linea è unita, in ogni da ta generazione, a una delle due dell’altra metà, e nella gene razione successiva all’altra delle due linee opposte. Le relazio ni tra familiari sono in tal modo analoghe nella forma alla strut tura complessiva della “tribù” (fig. 2); e viceversa l’esposizione delle categorie tribali, come quelle dei Capi o della Gente di Terra, in termini di matrimonio rende omologhi nel contenu to questi differenti livelli. È importante sottolineare, comunque, che la formazione so ciale è contemporaneamente ternaria, binaria e quaternaria. Queste modalità“dell’ordine sociale sono soltanto diverse pro spettive di una medesima struttura. Sono altrettante proiezioni di un’unica architettura sociale - ciascuna delle quali è un mo dello utilizzabile per una realizzazione autonoma nel costume. Preso nel suo insieme, il campo della parentela è composto di due “generi” di persone: parenti e affini. Per la regola del ma trimonio, questo dualistico universo di parentela è differenzia to al suo interno in quattro linee. Le regole del matrimonio, comunque, vietano la ripetizione delle unioni tra due linee pa terne in generazioni successive, cosi che in breve tempo ogni famiglia è legata a due opposte serie di parenti acquisiti, stan do in rapporto di donatrice di donne con alcuni e di chi rice ve le donne con altri. Questo è l’elemento triadico. Da un cer* Si ricorda che, nella codificazione tradizionale della nomenclatu ra di parentela F (father) = padre, M (mother) = madre, B (brother) = fratello, Z (sister) = sorella, D (daughter) = figlia, S (son) = figlio. La lettura della sigla procede da destra verso sinistra, per cui FMBSD è la figlia del figlio del fratello della madre del padre. (N.d.T.) 40
Figura 4 La fondamentale relazione triadica nell'ordine di parentela moalano (■», direzione dei principali obblighi economici; A>B>C, rango rituale, basato sul sangue sacro"). to punto di vista interno al sistema la struttura quadripartita di coppie complementari è più essenzialmente una serie di tre, e consiste in: parentela diretta del padre del soggetto; gruppo dei fratelli della madre, rispetto ai quali il soggetto è vasu o “san gue sacro” (dra tabu)-, e gruppo che comprende il figlio della sorella, soggetto di corrispondente rispetto (fig. 4). Questa par ticolare configurazione è in un certo senso difficile da mettere a fuoco. Si sposta continuamente dall’ordine triangolare cen trato sulla linea propria del soggetto alla serie gerarchica delle relazioni del figlio della sorella, vasu, che pone chi riceve le don ne nella posizione più alta. La difficoltà è solo l’effetto di una instabilità costituzionale del sistema à trois. Al confronto, la struttura quadripartita è durevole e domi nante. In primo luogo, è condizione necessaria della struttura triadica. Ma, ancora di più, per il fatto di venire continuamen41
te cancellato e poi riprodotto dal codice quaternario, il sistema ternario assume u n ’esistenza effimera all’interno di una con traddizione endemica tra gerarchia e reciprocità. Niente nella regola bilaterale del matrimonio tra cugini incrociati (di se condo grado) vieterebbe un ribaltamento dell’ordine di suc cessione tra le linee effettuando uno scambio di direzione tra chi riceve e chi dona le donne nella terza generazione - per esempio, col matrimonio con una FFZSD (come di b' con c nel la fig. 4). Intanto, i rapporti economici tra chi riceve e chi do na le donne hanno prodotto, con l’andare del tempo, lo stes so effetto equilibratore. Infatti, presi nel più ampio contesto de gli obblighi di scambio tra gruppi collegati da legami matri moniali, e nel più lungo periodo di due generazioni, i diritti del vasu, ossia del figlio della sorella, giungono a pareggiare i conti che in uh primo momento erano a favore del fratello del la madre. In occasione del matrimonio della sorella di quest’ul timo, la parte del marito avrebbe dato qualcosa in più in ban chetti e beni di quello che aveva ricevuto, e specialmente alla nascita del figlio della sorella i congiunti dal lato paterno de vono garantire i suoi diritti di vasu con un regalo molto gene roso ai parenti della madre (vakalutulutu). In seguito all’eser cizio dei diritti del vasu, quindi, i rapporti economici tra linee collegate da vincoli matrimoniali vengono pareggiati; e, di con seguenza, i cugini incrociati - un uomo e i figli del fratello di sua madre - hanno dei forti ma reciproci obblighi di aiuto ma teriale (fig. 4). Ora, i figli di questi uomini sono ancora i part ner privilegiati per il matrimonio. Ma dal momento che il rap porto tra cugini incrociati è stato reso uguale e reciproco, non c’è nessun obbligo di ripetere nella terza generazione la dire zione del “passaggio della donna” stabilita nella prima. Quindi il codice triadico è una configurazione prodotta in continua zione da quello quadratico e quasi con la stessa frequenza can cellata. Infine, a questa soluzione della gerarchia negli schemi familiari di reciprocità si rifanno molte altre forme figiane di centralizzazione politica.24 Ammettiamo che l’abbozzo che precede, per quanto incom pleto e frammentario, rappresenti lo schema generale della cul tura delle Figi orientali. Rimane il problema di estendere tale spiegazione di struttura all’ambito dell’azione, e in particolare all’azione pratica e storica rivendicata da certo marxismo come 42
suo territorio di analisi esclusivo. Un buon modo di comincia re è prendere in esame la costruzione della casa moalana, os servando che questa costruzione, per quel che riguarda la for ma materiale e la divisione del lavoro, è una rappresentazione tangibile della stessa struttura già descritta, completa di proie zioni binarie, ternarie e quaternarie. La casa di un uomo è il suo castello, o, come dicono i moalani, “ogni uomo è un capo nella propria casa”. Se è cosi, allora la casa della società è la sua cultura.25 Di pianta ellittica, l’edificio di abitazione moalano è diviso dall’asse maggiore in una “parte del capo”, tradizionalmente po sta in parallelo al mare, e una “parte comune” verso terra. A ogni parte è collegata una sezione terminale: l’arco posteriore della casa (tra i pali d’angolo principali) è il limite “superiore” e “si accompagna” alla parte del capo; l’ingresso di fronte, tra dizionalmente orientato sottovento, è il limite “inferiore” e “si accompagna” alla parte comune. Queste associazioni (in un tì pico sistema lauano a quattro classi) sono insieme pratiche sim boliche, nella misura in cui la sovrastruttura della comunità del villaggio è tradizionalmente l’infrastruttura della costruzione do mestica. Lo schema esterno della casa - simbolico esoscheletro della vita familiare che nello stesso tempo rappresenta in scala ridotta la comunità politica - media le relazioni tra famiglia e villaggio e fonda i rapporti di produzione del villaggio. La casa è costruita in comune. Ma la forma della cooperazione non de riva semplicemente dalla dimensione tecnica dell’impresa. Per consuetudine rappresentava, sul piano dell’azione, un esempio sintetico della corrispondenza significante tra pubblico e priva to, dato che sezioni della comunità erano responsabili di sezio ni della casa conformemente alla correlazione delle strutture. E, come è implicito nella descrizione che segue della costru zione tradizionale di una casa, questo insieme di accordi si esten de alle strutture culturali della natura: Il lato della casa volto al mare era detto il lato nobile (yasa turaga) e a esso si accompagnava l’estremità orientale della costruzione, op pure, se la casa era perpendicolare alla riva, la parte orientale era quella nobile e a essa si accompagnava l’estremità più vicina al ma re. Se la costruzione avesse impegnato il solo villaggio di Tumbou, Katumbalevu [la sezione del capo della metà del capo] avrebbe la vorato al lato nobile, e Valelailai [la sezione di terra della metà del 43
Figura 5 Rappresentazione schematica degli spazi tradizionali della casa mon
tana. capo] all’estremità che si accompagna a quel lato; nella costruzio ne di una casa, Valelailai si accompagna a Katumbalevu, e questo perché sono legati insieme come Tai [metà del capo]; gli apparte nenti a Tumbou [metà di terra del villaggio Tumbou] si sarebbero occupati del lato e dell’estremità rimanenti. Se la costruzione impegnava l’intera Lakemba, alla Città [Na Koro, la metà territoriale di rango superiore] spettava il lato no bile; Wathiwathi e Waitambu si sarebbero occupati dell’estremità orientale per conto di Wathiwathi [villaggio di rango superiore della sezione di terra della Città, con Waitabu quale “terra” con nessa]; Natakolau [o Daku ni Lau, la seconda metà territoriale dell’isola] avrebbe lavorato al lato e all’estremità rimanenti... [Hocart, 1929, p. 126; per una trasformazione della struttura nella pe sca collettiva delle donne, vedi pp. 113-14]26
L’estremità della casa è suddivisa seguendo il sistema a quat tro classi della società su cui si affaccia. La proiezione delle stes se linee di distinzione interne produce innanzitutto uno spazio tripartito, che integra con precisione la vita di famiglia entro le categorie della più ampia società (fig. 5).27 Le estremità “supe riore” e “inferiore” di questo spazio tripartito, rispettivamente 44
loqi e sue, sono opposte quanto ai tipi di socievolezza che pre vedono cosi come hanno differenti valori di rango. L’estremità superiore, separata dal resto della casa da una tenda di fibra vegetale, contiene la piattaforma rialzata della zona sonno del la famiglia più anziana e il suo magazzino di beni, armi e at trezzi agricoli. Il suo uso è generalmente riservato ai membri della famiglia (che possono anche tenervi beni personali), ma principalmente al turaga e alla mamma della casa (il “capo” e il “capo donna”). Il valore relativo dell’estremità superiore è evi denziato non soltanto dall’altezza, ma anche dalla qualità su periore delle stuoie utilizzate qui, rispetto alle stuoie scadenti del lato d’ingresso e di quelle, migliori ma sempre andanti, che coprono la sezione centrale. L’estremità inferiore dell’abitazio ne è più pubblica che privata ed è per consuetudine associata al focolare delle donne, agli utensili di cucina e alla cottura del cibo più che al sonno (e al sesso) e agli oggetti sacri dei ma schi.'28 La serie di opposizioni cosi stabilita è anche più genera le di questa polarizzazione familiare e mette in gioco impor tanti e complessi aspetti della divisione del lavoro tra i sessi. Il focolare delle donne, situato nella casa, presenta molteplici con trapposizioni con i forni sotterranei in cui cucinano gli uomi ni, tradizionalmente situati al limite del villaggio. Schematica mente, abbiamo l’equazione donne: uomini = interno: esterno, che abbiamo già rilevato nell’opposizione a livello mitico tra Terra (lato della donna) e Capi (lato dell’uomo). E ugualmente coerente che i forni sotterranei siano in genere riservati a oc casioni particolari - oggi, per esempio, alla domenica - mentre i focolari delle donne sono utilizzati per il cibo di tutti i gior ni. Ma vanno sottolineati anche i ribaltamenti logici: l’attività di cottura degli uomini è asciutta, sotterranea, e si svolge nell’elemento “inferiore”, la terra; le donne bollono il cibo in pentole, la loro attività di cottura avviene in superficie e usa co me elemento l’acqua salata o il latte di cocco (entrambi “ma schili”). Torneremo in seguito su questo complesso scambio esa minando i rapporti di produzione. Ma prima completiamo la sociologia tripartita della casa. Con l’eccezione dei capi di rango, che, come i membri della fami glia, possono usare le porte laterali, tutti i visitatori devono en trare dall’estremità inferiore e rimanere rispettosamente seduti o accovacciati, a meno che non siano invitati nel settore cen45
trale. Questo è il territorio comune del pubblico e del privato, e, analogamente, è comune a uomini, donne e bambini della casa. Tale sezione è inquadrata, comunque, dalle coordinate longitudinali e laterali del rango, rappresentate dalle opposi zioni di valore dei lati e delle estremità dell’abitazione (fig. 5), cosi che in ogni atdvità ritualizzata, come bere kava o mangia re insieme, la gente è distribuita spazialmente secondo la posi zione nella comunità o nella famiglia. L’isomorfìsmo delle ca tegorie architettoniche e culturali in genere è, dunque, qualcosa di più di una singolare analogia. Tale divisione simbolica della casa diventa la costituzione di una corrispondente differenzia zione di comportamento. Come “modello di” e come “modello per” la società - per usare i termini di Geertz (1973, p. 93) la casa funziona da medium attraverso il quale un sistema di cultura si realizza come ordine di azione. Ciò che nell’analisi è una serie di classificazioni parallele, o un’unica struttura che opera su diversi piani, nell’esperienza è una totalità indivisa. Il codice a quattro classi involge la pratica non meno della for ma. Sviluppandosi in una abitazione cosi strutturata, i rapporti tra persone sono essi stessi “abitati” dalla medesima struttura. Questi rapporti si estendono necessariamente agli oggetti del la vita domestica. Al suo interno, categorie culturali e beni eco nomici sono definiti in termini di reciprocità: la qualità della stuoia indica il valore dello spazio culturale; viceversa, la raccolta di oggetti differenti in un solo luogo significa che condividono lo stesso valore culturale (“Intimamente associato alla testa, che è il centro del mana, il poggiatesta è proprietà privata soggetta a tabù. Non può essere toccato da persona di rango inferiore a quello del proprietario. I poggiatesta vengono tenuti nella par te superiore [posteriore] della casa” [Thompson, 1940, p. 171].) E un processo di reciproca valorizzazione. Ciò implica che il va lore economico sia di tipo saussuriano: è la posizione differen ziale di un dato oggetto in un sistema di relazioni significanti. (Questo è tranquillamente sostenibile, poiché Saussure intese il valore linguistico attraverso quello economico.) Il processo ha l’effetto di stabilire strutture di differenziazione tra beni che so no omologhi alle distinzioni di categoria tra gli uomini, in quan to ne sono la cristallizzazione. La permutabilità di certi beni dunque appare come parteci pazione a una medesima sostanza sociale, come un attributo sim46
bolico per cui essi sono anche non commensurabili e non scam biabili con beni di valore diverso. Tutte le principali opposi zioni della cultura lauana sono riprodotte come classi di beni materiali e come possibilità di sostituzione o scambio. Descri vere questo sistema di oggetti vorrebbe dire riscrivere l’intera etnografia, poiché anche i beni sono mare o terra, maschio o femmina, capo o comune, rituale o arbitrario. Poiché tutto pro viene da due, essendo ogni gruppo una combinazione comple mentare di superiore e inferiore, cosi ogni pasto deve contenere un elemento marcato di carne, pesce o verdura (i coi), e un piat to ordinario principale a base di amido (“cibo vero”, kakana di na). I denti di delfino sono “la principale di tutte le cose”. La loro sola misura sociale è l’essere umano: danno diritto, in guer ra o nel lavoro, ai servigi di quelli che li accettano in dono; as sicurano la moglie al marito, risarciscono il guerriero per il suo tributo di vittima dei cannibali, il suocero per la morte della mo glie, la famiglia della madre per la nascita del figlio. Oggigior no i denti di delfino si possono anche trovare esposti sui pali superiori della casa, ma normalmente sono nascosti nella se zione posteriore, e occupano con gli altri oggetti della potenza ( mana) il posto del sonno dell’uomo più anziano. Per il loro alto valore, i denti di delfino non possono essere scambiati con alcun utensile o cibo ordinario - non più, si potrebbe dire, e per analoghi motivi, di quanto il fratello minore possa mangia re il cibo del primogenito. Solo due cose possono costituire una opposizione ammessa ai denti di delfino: la testuggine e il maia le, il “principale di tutti i cibi di mare” e il “principale di tutti i cibi di terra”. Ma proprio per questo, il maiale può sostituire l’uomo nel sacrificio; e dato che la testuggine è il “pesce che vive” ( ika lulà) o 1’“uomo-pesce” ( ika tannata), se il pescatore del capo dovesse mancarla nella caccia, sarebbe obbligato a sosti tuirla lui stesso. Esiste un’equivalenza transitiva tra i denti di del fino, il maiale e la testuggine, basata sulla loro comune inter cambiabilità con gli uomini.29 Ora gli antropologi spesso sco prono nelle economie tribali “sfere di scambio”: l’allocazione di beni tra classi non convertibili, dove ognuna è un circuito separato di articoli isolato dagli altri a causa del divario dei va lori sociali (Firth, 1965; Steiner, 1954; Bohannan, 1955; Salisbury, 1962). Ma queste famose sfere di scambio, che altro so no se non il momento funzionale di un sistema di oggetti? E 47
che altro è il sistema di oggetti se non la trasposizione su un altro piano dello schema della società? Una “base economica” è uno schema simbolico dell’attività pratica - non si limita a essere lo schema pratico dell’attività simbolica. E la realizzazione di un dato ordine significante nei rapporti e nelle finalità di produzione, nella valutazione dei be ni e nella determinazione delle risorse. Consideriamo l’opposi zione “terra/m are” a Moala. Più che un discorso sull’interazio ne tra gruppi sociali o tra uomini e donne, quest’opposizione rappresenta l’organizzazione culturale di una distinzione natu rale. I rapporti concreti di produzione su mare e terra sono co stituiti in accordo con le strutture di reciprocità vigenti tra le categorie cosi designate, e attraverso mare e terra, quali elemen ti naturali, ricevono un ordine culturale. Per Moala le relative strutture di reciprocità sono di due tipi. Primo, lo scambio sem plice che corrisponde all’essenziale dualismo di complementa ri della società moalana: Gente di Terra e di Mare - quest’ultima comprende sia i Capi sia i gruppi di maestri pescatori (kai wai dina) addetti al loro servizio - si forniscono a vicenda i pro dotti che derivano dagli elementi con cui hanno affinità natu rale. La Gente di Terra non è, come si dice, “molto felice sull’ac qua”. Infatti, i villaggi dominati dalla Terra non fanno molta pesca d ’alto mare al giorno d ’oggi, nonostante la facilità di ac cesso ai territori di pesca. Il loro ruolo è coltivare, soprattutto colocasia, e fornire il pasticcio di colocasia e cocco e il maiale per i banchetti. D’altra parte, l’uomo di Terra non mungereb be di questo maiale in presenza di quello del Mare, come que st’ultimo non deve mangiare pesce davanti a quello di Terra poiché pesce e testuggine è quanto la Gente di Mare procura alla Gente di Terra.30 La seconda forma di reciprocità è un in terscambio più complesso, che corrisponde più strettamente al sistema a quattro classi, e che perciò suddivide terra e mare. Qui ogni lato, per cosi dire, fornisce la sostanza o nutrimento che costituisce l’altro, e quindi deve produrre nell’elemento dell’al tro. Questo è il modello essenziale della divisione familiare del lavoro, ricorrente in tutte le Figi quando, a un certo momento degli scambi matrimoniali, il lato dell’uomo, nonostante il suo status superiore e di mare, offre un banchetto a base di maia le alla famiglia della moglie in cambio di un banchetto a base di pesce.31 Lo stesso accade per il lavoro ordinario: se (qualche) 48
uomo di Moala pratica occasionalmente la pesca in alto mare, è la quotidiana cattura con la rete effettuata dalle donne nell’area della laguna che costituisce la fornitura principale di cibo marino. Oltre a ciò le donne intrecciano stuoie e fanno tessuti di fibra vegetale nel villaggio, mentre ogni attività di rac colta nell’interno della boscaglia è compito dell’uomo. Situan do questa divisione del lavoro nel paesaggio si riconosce una configurazione già nota: le attività femminili sono “interne”, nel villaggio e nel mare adiacente, e confinano da entrambe le estre mità geografiche con le zone maschili: l’alto mare e la foresta profonda. La ripartizione triadica trasforma cosi l’opposizione terra-mare in una tipica struttura in quattro parti (fig. 6). In fatti la terra, da un punto di vista sociale, è suddivisa in villag gio ( koro) e boscaglia (veikau), mentre il mare è parimenti dif ferenziato in wai tui o “mare del Capo” degli uomini, al di là della scogliera, in opposizione alla laguna o lato interno del mare, luogo di attività femminili, chiamato con lo stesso nome (dranu) dell’acqua dolce.32 Come dice Marx, la natura nota all’uomo è una “natura umanizzata”. D’altra parte, si comincia a vedere la ragione della ricorren te critica del marxismo allo strutturalismo: esso sarebbe u n ’im mobile logica di strutture equivalenti, completamente privo del senso dell’influenza o del condizionamento tra i vari livelli di un ordine culturale - e quindi della consapevolezza del cam biamento o dell’evento (Terray 1972, pp. 39-41). E una sorta di ciò che Kuhn chiama “divergenza di paradigma”, dal momento che per lo strutturalismo la distinzione classica tra substrato e sovrastruttura non ha più molto significato. Non è facile capire nemmeno la “preponderanza del fattore economico”, utilizzan do il concetto strutturalista di fattore economico. Il cosiddetto substrato appare come la manifestazione di un sistema globale di significati che agiscono sul mondo, un processo secondo il quale anche il significato dell’esperienza pratica è da intende re come rapporto interno a quel sistema. Il substrato incorpo ra una sovrastruttura: una logica concettuale che né appartiene al mondo in sé - nel senso di una efficacia meccanica intrin seca né esprime le sue proprietà materiali se non come valuta zione specifica in senso culturale. Ogni ordinamento culturale prodotto dalle forze materiali presuppone un ordinamento cul turale di queste forze. 49
50
Figura 6 Divisione del lavoro e divisione della natura.
D iv isio n e d el lavo ro
Vorrei aprire una breve parentesi sull’uso istituzionale delle categorie concettuali fìgiane. A parte le evidenti banalizzazioni, forse il difetto principale di questo tipo di spiegazione del te sto culturale, è che continua, in un certo modo, a inventare Fantropologia senza servirsi delle conquiste già acquisite dell’etno logia. Ma in questo frangente, con gli esempi dello strutturali smo francese e inglese contemporaneamente davand a noi, ap pare chiaro che la forza di ciascuno integra l’altro. Non pre tendo di farne la sintesi, voglio solo osservare che la trasposizione di un dato schema simbolico su piani diversi rappresenta un complemento dell’interpretazione classica della società tribale come ordine istituzionale generalizzato. A queste condizioni, e cioè disponendo di una consistente serie di rapporti (princi palmente la parentela) applicati a varie funzioni, la generaliz zazione delle relazioni simboliche diviene anch’essa valida. Ne deriva anche che l’isomorfismo tra codici diversi sociale, geo grafico, mitico ed economico - non è né arbitrario né è il pro dotto di un puro interesse speculativo; è una condizione reale della vita sociale. Se le distinzioni nelle condizioni ambientali sono connesse per via metaforica alle differenze nell’ordina mento politico, ciò accade perché i rapporti che organizzano la produzione sono i medesimi che organizzano la sfera politica. Nella misura in cui le relazioni istituzionali permangono coe renti, gli accordi simbolici non sono mai arbitrari. Mediati dall’ordine sociale, sono sempre giustificati dall’esperienza cul turale del soggetto pensante. E la loro determinazione da par te dell’etnologo è idealismo non più di quanto lo sia la loro uti lizzazione pratica da parte della gente. Se nel senso stretto di attività pratica “praxis” è uno schema concettuale, anche nel sen so più ampio lo schema concettuale è una prassi culturale. Ci sarà ancora molto da dire su questo. Per il momento chiu do la parentesi per occuparmi delle implicazioni che il nostro esempio etnografico ha relativamente a struttura ed evento, cul tura e storia. Il testo chiave per quanto riguarda Moala è fornito da un poe ta messicano che commenta l’opera del maestro francese. In un lungo saggio su Lévi-Strauss, Octavio Paz trae la conseguenza che “nei sistemi di classificazione, nei miti e nei riti, la storia entra nel ciclo dei fenomeni ricorrenti e in tal modo perde la sua virulenza” (1970, p. 88). Proprio cosi: poiché le coordinate 51
simboliche della cultura moalana sono tradotte in diversi mo di, il sistema sembra sviluppare u n ’immunità nei confronti del le circostanze che mutano. Il villaggio di Nuku, per esempio, ha la solita organizzazione dualistica delle sezioni terra e mare, anche se, a rigore, non c’è mai stato nella comunità un singo lo gruppo di Terra. Nuku fu fondato alla fine del diciannove simo secolo da maestri pescatori al servizio dei capi, Gente di Mare per eccellenza emigrata dal villaggio principale di Navucinimasi, e successivamente dalle isole di Bau e di Gau. Ma per la concezione locale, alcuni gruppi di Nuku erano Gente di Ter ra. Se si suggerisce agli abitanti di Nuku - cosa che ho fatto spes so - l’idea che tutti i gruppi locali sono Gente di Mare, questo viene prontamente concesso. Ma poi vi spiegano anche che un gruppo di persone fu il primo ad arrivare a Nuku dal villaggio dei capi, che essi ricevettero il pesce dal mare e che erano guer rieri (bati) per i gruppi che seguirono; ossia, essi sono ‘T erra” in rapporto alla vera “Gente di Mare” che arrivò dopo. Questo è un esempio lampante di “riproduzione stereotipata”, secondo l’espressione di Godelier (1966). L’esempio è particolarmente importante perché illumina il meccanismo della riproduzione culturale nonostante la man canza di continuità storica. Mutilato dalla storia, il sistema del le metà si rigenera trasferendo sulla popolazione restante le cor rispondenze simboliche con gli ambiò a esso connessi. La divi sione dualistica dei gruppi in “Terra” e “Mare” è ripristinata mediante la corrispondente opposizione tra popolazione origi naria e immigrata. A livello concettuale, questo particolare pro cedimento non presenta problemi: per quanto la distinzione temporale rimanga insensibile - se occorre, il mito dell’inse diamento può essere ritoccato e reso conforme - in un modo o nell’altro la distinzione sociale può essere sempre rappresen tata. Ma questa è solo la meccanica del processo. Più fondamentale è il fatto che l’opposizione tra la metà è sempre pre sente nella vita del villaggio, anche in mancanza di una sua esi stenza storica, poiché la distinzione tra Gente di Terra e Gen te di Mare è continuamente praticata in mille e mille dettagli del rito e del mito, della vita pubblica e privata. Che il villag gio abbia queste componenti trova conferma in ogni cerimonia nuziale, in ogni scambio di cibi complementari, nel modo in cui uomini e donne pescano e nel luogo in cui lo fanno, nella 52
«istruzione dell’abitazione e nella vita familiare che quotidia namente vi si svolge. Terra e mare compongono un asse indi spensabile per ogni gruppo e ogni attività effettivi. La dualità sociale non è solo concepita; è vissuta. Tuttavia, la ricostruzione della struttura a spese dell’evento non viene raggiunta senza residui (cfr. Lévi-Strauss, 1962a; Sebag, 1964, p. 184). Se lo schema simbolico sembra manipola bile senza errori o omissioni, la storia continua a esistere in una certa opacità del reale: non c’è possibilità di sfuggire alla con traddizione di un villaggio composto nello stesso tempo di Gen te di Terra e Gente di Mare, e soltanto di Gente di Mare. Il punto ha un grande significato potenziale per una teoria dina mica della struttura. Hocart ha osservato che il dualismo nelle Figi è ormai inflazionato, e che il suo abuso necessariamente fi nirà per indebolirlo e oscurarlo (1952, pp. 57-58). Cosi nel ca so di Nuku, l ’opposizione tra struttura ed evento è superata, ma a prezzo di una complicazione della vita sociale che nega la struttura proprio mentre questa è irremovibile. Un dualismo nega l’altro, interseca l’altro, e sembra ragionevole supporre che ogni sistema tenda a scoprire i limiti della sua capacità di ac cumulare simili contraddizioni storiche, o, almeno, a diventare vulnerabile a determinate trasformazioni. Queste, da un punto di vista naturalistico, possono apparire come i movimenti “di adattamento”. Ma nei fatti la struttura resta l’origine del sape re storico. La storia non è semplicemente un aprirsi a qualco sa di nuovo —e meno che mai a qualcosa di più positivo. Co me suggerisce Greimas, il cambiamento può anche rivelarsi una chiusura: la selezione definitiva di uno solo fra tutti gli svilup pi latenti in ogni determinata struttura (1966, p. 823). Da questo punto di vista la società figiana non è statica: con tiene l’embrione di un altro ordine culturale. Il fatto che il dua lismo classico sopravviva a una gran quantità di minacce da par te della storia, significa solamente che non ha ancora subito l’attacco decisivo - quello che surdetermina le sue contraddi zioni per suscitare il futuro già prefigurato. “Infatti anche in un tipo di struttura sociale simmetrica (almeno in apparenza) co me l’organizzazione dualista, la relazione tra le metà non è mai statica, e neppure reciproca come saremmo tentati di rappre sentarcela” (Lévi-Strauss, 1958, ed. it. p. 155). Complementare ma disuguale, simmetrico eppure asimmetrico, il dualismo fi53
giano contiene una contraddizione endemica: un conflitto, co me si è visto, tra reciprocità e gerarchia. Questo conflitto deri va dalla posizione centrale assunta dalla triade nei sistemi bi lanciati a due e a quattro classi. Nella sua forma più lineare esprime l’incompatibilità matrimoniale tra cugini incrociati e la superiorità di chi riceve le donne su chi le dona; infatti, se quest’ultima indica una differenza di status basata sulla cessione del la donna, la prima implica che ogni vantaggio di questo gene re è perfettamente reversibile. La reciprocità domina, ma sullo sfondo delle sue forme strutturali si muove un altro ordine, asimmetrico: un sistema classico di “scambio generalizzato” (il matrimonio con la figlia del fratello della madre), che rappre senta la visione di una società che ha saputo abbandonare il pre testo dell’uguaglianza a favore di un aperto sviluppo dell’auto rità e della gerarchia (cfr. Lévi-Strauss, 1962a; Leach, 1951). Secondo il principio dello “scambio generalizzato”, un dato gruppo riceve regolarmente le donne da una linea e dà le pro prie figlie a un’altra; esso, quindi, richiede un minimo di tre componenti per fare il sistema. E una coerente gerarchia può essere mantenuta tra loro purché le donne della linea più alta non passino direttamente alla più bassa. Per le Figi forse que sto e già avvenuto, come esiste tra le stirpi dei loro vicini dell’ar cipelago delle Tonga, dove, secondo molti studiosi di preisto ria, una popolazione proveniente dalle Figi si era insediata for se duemila anni fa. I Tonga, inoltre, hanno risolto il problema delle figlie del capo supremo continuando a considerare “stra niere” le linee degli immigrati - compresa una “Casa di Figi” (Fale Fisi) - a cui sono destinate le donne di più alto rango, mentre le donne delle linee native di grado inferiore si sposta no in alto verso il capo supremo. Se il secondo espediente per mette al capo supremo di accrescere la sua supremazia di an ziano nella genealogia, per mezzo della sua condizione di figlio della sorella (fahu), rispetto alla linea cadetta, il primo espe diente permette di allontanare dalla competizione politica chi prende in moglie la figlia del capo, in quanto, come straniero, è un elemento considerato estraneo al sistema. Per tradizione questi estranei servono i capi come assistenti del rituale ( matapule)-, un mutamento delle correlazioni donatori/prenditori di donne, nativo/straniero, banditore/capo, che abbiamo visto in funzione a Lau. Questa trasformazione è accompagnata da una 54
serie di altre; la loro necessità può essere giudicata assumendo come termine di confronto la logica delle categorie figiane del la parentela. Nelle Tonga, l’asse geografico della distinzione capo/comune subisce una rotazione dal piano orizzontale a quello vertica le. Invece di arrivare dal mare - qui luogo di provenienza degli stranieri che assistono il capo - il fondatore della stirpe domi nante tongana, figlio del dio Tangaloa, discende dal cielo e si unisce con una donna della popolazione indigena anteriore (a sua volta discendente, secondo una tradizione, dal verme). Dun que, il cielo circoscrive mare e terra: è un’appropriata rappre sentazione cosmologica del sistema triadico. Ma questo sistema sviluppa anche un’immagine di dualismo, seppure come sfondo e in forma subordinata allo schema tripartito che ribalta la con figurazione del rapporto propria delle Figi orientali. Il dualismo delle Tonga, inoltre, è trasferito dall’opposizione tra “lato dell’uomo’’ e “lato della donna” alla distinzione tra linea pri mogenita e linea cadetta; un trasferimento compiuto essenzial mente con l’emergere dei due contrasti all’interno di un siste ma di scambio generalizzato. Vista in un altro modo, la codifi cazione della relazione tra primogenito e cadetto come rappor to tra colui che riceve le donne e colui che le dona, sussume il legame fratello-sorella alla classificazione fratello più anziano-fra tello più giovane. Una conseguenza è che viene sottolineata la superiorità rituale delle donne sugli uomini, dal momento che politicamente ciò corrisponde anche alla superiorità della linea del fratello più anziano (che riceve la donna). A un altro livel lo scopriamo lo sviluppo dell’inviolabilità del capo supremo, il Tui Tonga, il capo che si conserva immobile e all’interno, ver so cui affluiscono tutte le donne, che combina il potere domi nante materno col supremo maìia paterno. Il dualismo tenga no è dunque rappresentato da una tipica autorità duplice, sa cra e profana; quest’ultimo titolo, assegnato formalmente a un ramo cadetto della linea dominante, abilita all’esercizio di una funzione esecutiva. Questa segmentazione è in realtà lo schema di una divisione in metà che si estende idealmente a tutte le Tonga, con le due parti comandate rispettivamente dai capi, anziano-sacro e giovane-profano. Ma poiché il primo sta al se condo come il “lato dell’uomo” sta al “lato della donna”, e co me la donna è l’“interno” rispetto all’“esterno” dell’uomo, c’è 55
nella divisione in metà un ribaltamento finale dei concetti spa ziali figiani, con il superiore ora posto all’interno: “I nomi del le due divisioni si riferiscono alle loro collocazioni geografiche. Il Kauhala’uta [metà del Tui Tonga] viveva nella parte interio re (’uta) della strada, mentre il Kauhalalalo [metà del capo pro fano] viveva sul lato più in basso della strada, verso l’oceano per poter proteggere il Tui Tonga e la sua gente.” (Kaeppler, 1971, p. 192; vedi anche Gifford, 1924, 1929; Bott, 1972; Leach, 1972; Biersack, 1974). Tutti gli elementi di questo sviluppo si ritrovano anche nel le Figi orientali, ma senza che vi sia una sintesi o una prevalenza. Esso comprende i gruppi anomali “stranieri”, assegnati alle li nee dei capi, la cui origine esterna resta una qualità fondamentale della loro identità geografica nonostante ogni accultu razione. Nelle Moala essi sono i carpentieri del capo - vengo no identificati come “i samoani” - e i gruppi di pescatori ve nuti da Bau e da Gau. Gli uni dunque sono Terra e gli altri Mare, ma insieme sono “gente diversa”, ovvero estranei rispet to alla Gente di Terra indigena, ed esperti nelle funzioni pra tiche più che in quelle cerimoniali (entrambi i tipi di attività, comunque, vanno sotto il concetto di “lavoro” [cakacaka]). Men tre la Gente di Terra era per tradizione donatrice di donne ai capi, questi esperti stranieri confermano il loro attaccamento alla linea del capo con il matrimonio dei loro antenati immi grati con le figlie del sovrano moalano. Il sistema insito nel dua lismo moalano è quello dello scambio generalizzato. Nello stesso modo i villaggi accolgono un dualismo concen trico all’interno di quello simmetrico, un aggiustamento triadi co della diade. Divisa tradizionalmente da un ruscello o da un sentiero in due metà complementari, una delle quali è la metà del capo, la comunità ha allo stesso tempo un centro, che è nello spazio pubblico dove stanno la casa del capo dominante e il tempio del villaggio. Ma questa distinzione tra centro e pe riferia, sacro e profano, implica anche un terzo elemento, an cora un grado oltre, costituito dalla residenza esterna degli “stra nieri del capo”. Nella storia, come si è visto, la collocazione pe riferica può essere interpretata come movimento centrifugo; pei esempio: la migrazione dei maestri pescatori di Nuku dalla fa scia esterna del villaggio di capi di Navucinimasi, alla loro sede attuale nelle Moala occidentali. E l’effetto può essere, come nel 56
caso delle Moala, la riproduzione dell’ambiguità tra il modo duale e quello triadico all’interno del sistema territoriale dell’isola nel suo insieme. Nelle Moala occidentali i gruppi di pesca di Nuku raggiunsero il vicino villaggio di carpentieri “samoani”, e formarono una divisione geopolitica chiamata “il la to sotto” (Yasana i ra), che segue una logica discontinua rispetto alla principale divisione in “Grande Moala” (Moala Levu) e “Pic cola Moala” (Moala Lailai), e trasforma le antiche metà terri toriali in una dissonante struttura a tre.33 La questione generale è che quando esiste una simile con traddizione strutturale, esiste anche una direzione storica. Il dua lismo fìgiano può essere resistente a molti tipi di circostanze contingenti. Ma da una parte il buon esito può indebolire quel dualismo attraverso l’accumulazione di incoerenze storiche; dal l’altra parte, c’è la contraddizione interna: se gli eventi sono continuamente reinterpretati da una struttura privilegiata, gra zie al medesimo processo la struttura conserva una eventualità privilegiata - che è solo apparentemente discontinua con se stes sa. Il sistema fìgiano è incline a, o almeno suscettibile di, una certa differenziazione e centralizzazione del potere. Possiede già in anticipo, per cosi dire, un codice adatto a rappresentare al cune differenze in vigore come i rapporti di rango e le regole di matrimonio. Tutto ciò che in Polinesia ha origine dal cro giuolo fìgiano (e ovunque se ne conservano le tracce) è testi mone di questa potenzialità. Gli osservatori più attenti sono riu sciti a vedere, nel presente fìgiano, la struttura che sarebbe su bentrata in futuro: Una singola formula non può mai riassumere una società; infatti, prima che un nuovo modo di essere abbia sostituito completamen te i più antichi, ne sta nascendo un altro per soppiantarlo. [...] Possiamo vedere qualcosa del genere accadere nelle Figi. Non possiamo dire quale interesse prevalente assorbisse la mente dei figiani prima che essi fossero catturati dalla passione di suddivi dersi in squadre contrapposte, poiché questa passione ha cattu rato la loro mente cosi radicalmente che è difficile riconoscere le strutture precedenti al di sotto della forma della dicotomia. Nel 1912 era ancora tanto lontana dall’essere esaurita che ancora po teva fornire il modello per nuove situazioni. La scuola di Lau fatalmenle si organizzò in due “case”, Nord e Sud. Una volta man dai i ragazzi in gruppo, senza organizzarli, a tuffarsi per pescare 57
il corallo. Un maestro riferì che stavano solo giocando. “Dividili in squadre,” suggerì. Furono divisi in Nord e Sud. Immediata mente cominciò un’intensa competizione [...] fino a che le squa dre esauste chiesero che fosse dato l’alt. Questo episodio è anche un indizio della decadenza, poiché la dicotomia stava diventando così diffusa da essere inflazionata. Si stava estendendo a tutte le occasioni. [...] Non soltanto l’abuso esaurisce, ma inoltre la proliferazione del le suddivisioni si stava avviando, come ho evidenziato, a oscurare l’intero dualismo. Un nuovo e più profondo interesse sembra aver già preso pie de a scapito del vecchio dualismo indebolito dagli eccessi. Que sto più recente entusiasmo consiste nel servire il capo. Lui e la sua famiglia sono a tal punto esaltati al di sopra degli altri da ro vesciare l’antico equilibrio dei gruppi appaiati; è un processo che può essere in larga misura rintracciato nelle tradizioni narrative di Lakemba. I due lati che solitamente si fronteggiavano, uguali in tutto tranne che nella precedenza, hanno cominciato a spez zettarsi in unità tutte rivolte verso il capo, come pianeti intorno al sole. [Hocart, 1952, pp. 57-58]34
Ho cercato di indicare alcuni dei modi in cui lo strutturali smo può essere portato nel mondo, per cosi dire, avvicinando si alla storia e alle altre antropologie. Non si può negare che questa sia stata una particolare lettura del testo .strutturalista. Né c’è la minima pretesa di fare dello strutturalismo una spe cie di teoria scientifica generale da cui la storia possa essere de dotta o predetta. Si può parlare di contraddizioni e potenzia lità, di resistenze e suscettibilità, e perfino di genesi della va riazione nell’esperienza. Ma i principi di classificazione me diante i quali una società ha a che fare con gli eventi sono es si stessi specifici e storici; non possono essere letti direttamente nelle caratteristiche date del mondo, ma devono essere scoperti empiricamente (Lévi-Strauss, 1972). E, ammesso che i mezzi sim bolici con cui un dato gruppo organizza le sue esperienze sia no legittimi e logici, la rappresentazione della storia è ugual mente arbitraria, poiché è difficile che il mondo sia costretto a conformarsi a quei principi con cui una porzione dell’umanità lo concepisce. Una teoria generale dei sistemi culturali da cui si possa dedurre la storia non sembra possibile.35 Naturalmente, anche se questa conclusione fosse accettabile in linea di principio, rimarrebbe un disaccordo di base tra strut58
turalisrao e marxismo contemporaneo a proposito della “prei storia della società”. Più precisamente, rimarrebbero irrisolti i punti controversi per quanto riguarda i rapporti tra struttura e azione materiale, e la capacità delle loro rispettive logiche di rendere conto della forma culturale. Inoltre, ci si potrebbe chie dere se Marx stesso non abbia stabilito alcune distinzioni es senziali tra la forma borghese e quella precapitalistica nel mo do di organizzazione e di funzionamento storico. Per un marxi smo moderno rifiutare lo strutturalismo sul piano del suo “im barazzo di fronte alla storia” può indicare in qualche modo un imbarazzo analogo. Non sarebbe la prima volta che il marxi smo ignora Marx. Se, come dice Pouillon, “non sono gli strut turalisti a mettere le strutture nella storia”, non furono gli strut turalisti neppure i primi a scoprirle: “Gli uomini fanno la pro pria storia, ma non la fanno in modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi... La tradizione di tutte le generazioni scom parse pesa come un incubo sul cervello dei viventi” (Marx 1852). Marx era perfettamente cosciente della capacità delle società arcaiche di strutturare le circostanze della storia. Il passo del Capitale sul permanere delle comunità di villaggio indiane è un’esposizione classica del concetto di “riproduzione stereotipa”: Quelle piccole comunità indiane antichissime, che in parte conti nuano ancora ad esistere, poggiano sul possesso in comune del suo lo, sul collegamento diretto fra agricoltura e mestiere artigiano e su una divisione fissa del lavoro, che serve come piano e modello dato quando si formano le nuove comunità. Esse costituiscono comples si produttivi autosufficienti il cui territorio produttivo varia da cen to acri a qualche migliaio. [...] Se la popolazione cresce, viene im piantata in terreno vergine una nuova comunità che segue il mo dello dell’antica. Il meccanismo della comunità dimostra che c’è una divisione del lavoro secondo un piano; ma vi sarebbe impossi bile una divisione del lavoro di tipo manifatturiero, perché il mer cato del fabbro, del falegname ecc., rimane inalterato [...]. Qui la legge che regola la divisione del lavoro della comunità opera con l’inviolabile autorità di una legge naturale, e ogni particolare arti giano, come il fabbro, il falegname ecc., compie tutte le operazioni pertinenti alla sua arte secondo i modi tramandati, ma indipen dentemente e senza riconoscere nessuna qual si sia autorità entro la sua officina. L’organismo produttivo semplice di queste comunità autosufficienti che si riproducono costantemente nella stessa forma e, quando per caso sono distrutte, si ricostruiscono nello stesso luo59
go e con lo stesso nome, ci dà la chiave per capire il segreto dell’tmmutabilità delle società asiatiche, che fa un contrasto cosi forte con la costante dissoluzione e il costante riformarsi degli Stati asiatici e con l’incessante cambiare delle dinastie. [Marx, 1867, ed. it. voi. I, pp. 400-402]
Marx riconosce la riproduzione stereotipa delle comunità asiatiche, benché paragonata all’antropologia moderna la sua teoria in proposito non sembri molto penetrante.36 Secondo l’ot tica più generale utilizzata in Forme economiche precapitalistiche, la relativa stabilità della società più antica, era connessa a una pro duzione orientata ai valori d’uso - a un’economia in cui “l’uo mo è l’obiettivo della produzione e non la produzione l’obiet tivo dell’uomo”. Controllata dai produttori nella loro qualità di membri della comunità proprietaria, la produzione era orga nizzata come riproduzione degli individui all’interno dei loro rapporti determinati di amicizia e parentela (Marx, 1857-58b; 1857-58a). La meta non era l’accumulazione illimitata di un’a stratta “ricchezza” parallela a una nuova creazione dei produt tori semplicemente come “lavoratori”. Per l’individuo era la rea lizzazione concreta, l’auto-oggettivazione, di un’esistenza socia le. Tali scopi sono limitati. Marx poteva accordare al mondo che li conobbe lo stesso genere di rispetto che l’antropologo strut turale ha verso la ricerca di “un’immagine compiuta, una for ma, e una delimitazione oggettiva” e verso la “soddisfazione da un punto di vista limitato” (Marx 1 957-58a). Ma Marx differi sce da tutte le antropologie successive per l’idea che la comu nità antica, che in tal modo mediava i rapporti dei produttori con la natura e tra loro, non fosse di diritto un prodotto sociale. Essa apparteneva piuttosto all’ordine della natura: era frutto del lo sviluppo spontaneo dei vincoli “naturali” di parentela o di sangue, e, inoltre, produceva servendosi degli strumenti che era no, in modo più o meno naturale, a portata di mano. Da una parte, dunque, la classica causalità strutturale del ma terialismo storico è qui sospesa, il suo campo di applicazione è re lativizzato e ritenuto adatto esclusivamente alle forme capitalistiche. Ma l’ordinamento sociale delle culture antiche non può es sere considerato una sovrastruttura eretta sul fondamento con creto dei rapporti economici. Infatti, come Marx ha ripetuto in sistentemente, in forme come la comunità organica del clan 60
Fordinamento sociale è il “presupposto” della produzione, com’è pure il suo scopo finale. A questo stadio, le irriducibili condizio ni che gli uomini incontrano nella produzione, condizioni pre cedenti e indipendenti dalla loro volontà, alle quali essi devono dunque sottoporre la loro attività materiale, sono i loro “vincoli naturali” del sangue, del linguaggio e della consuetudine. Da pun ti di vista rilevanti, nella società antica i “fondamenti concreti” e le “sovrastrutture” si scambiano il posto. Ma, d ’altra parte, la so spensione della causalità classica lascia l’interpretazione della so cietà precapitalistica in una specie di assenza, a un tempo, di cul tura e di storia. La “semplicità dell’organizzazione produttiva”, che Marx concepì come la chiave dell’immutabilità della comu nità arcaica, non solo era una condizione non alienata in con fronto alla società borghese, ma mancava, in particolare, delle dif ferenziazioni strutturali che danno alla società borghese il suo movimento dialettico: la separazione dei mezzi di produzione dai produttori, dei produttori dai prodotti, della produzione dai “bi sogni” dei produttori, e degli individui dalla collettività. Senza questa frattura ciò che resta è per Marx un tipo di continuità che l’antropologia delle comunità tribali non accetterà facilmente: una continuità fra cultura e natura. Marx rimane fedele alla qua lificazione di “naturalismo” che egli dà al suo metodo; rispetto al la formazione della cultura, egli è un gradualista - ed è coerente con la sua posizione sul linguaggio, visto come qualcosa che non comporta una rottura decisiva in rapporto all’esperienza pratica (v. oltre, pp. 139-146). Per Marx la società antica era il naturale alfinterno del sociale stesso. Questo gli permise di relegare le condizioni sociali di produzione al ruolo di precondizioni - ossia costrizioni fondamentali ed esterne. Benché in tale stato la società sia capace di rispondere alle forze naturali, o anche di negare se stessa per utilizzare queste forze, essa non ha un vero movimento storico nel senso di un movimento autoprodotto socialmente. Non conosce le forze sociali. Come spiega Alfred Schmidt: Il carattere propriamente astorico dell’evoluzione preborghese di pende dal fatto che in essa le condizioni oggettive del lavoro - il suo strumento come il suo materiale - non sono esse stesse il pro dotto del lavoro, bensì sono terra-natura già date, dalle quali in fon do anche il soggetto attivo e la comunità cui esso appartiene non esulano; mentre queste condizioni soggettive ed oggettive diven tano con il capitalismo qualcosa che è prodotto dagli agenti del61
la storia. Tutti i rapporti non si presentano più come determina ti dalla natura, bensì come posti dalla società.!...] Mentre le forme precedenti della mediazione della natura era no in fondo forme della sua “auto-mediazione” e ciò in quanto il soggetto mediatore (sia come individuo che come unità) restava una parte dell’immediatezza naturale, ora [col capitalismo] inve ce la mediatezza della natura si fa rigorosamente storica perché sociale. [Schmidt 1966, ed. it. pp. 172-173]
Anche per Marx, dunque, la storia può trovarsi in imbarazzo di fronte alla struttura. Nelle culture arcaiche la prassi batte in ritirata di fronte ai rapporti sociali che sono essenzialmente rap porti di parentela. Dobbiamo concludere che il dibattito con lo strutturalismo francese implica la stessa frattura culturale del di battito con lo strutturalismo inglese? Dobbiamo occuparci di due generi differenti di società, una che struttura se stessa median te gli eventi e un’altra che struttura gli eventi da se stessa? E se è cosi, il marxismo e l’antropologia sono destinati a rimanere separati, ciascuno la verità di un differente ordine sociale?
DUE TIPI DI SOCIETÀ: DUE TIPI DI TEORIA?
Lévi-Strauss sembra soddisfatto di stare sul suo lato della linea divisoria. La ragione la trova in Marx: le differenze di classe nelle società moderne (“calde”) azionano un movimento sconosciuto ai sistemi egualitari (“freddi”) del mondo tribale. (La metafora termodinamica si riferisce alla macchina a vapore [Lévi-Strauss, in Charbonnier 1961].) Nel Pensiero selvaggio, Lévi-Strauss illustra il contrasto corrispondente nell’azione storica servendosi di un esempio apparentemente banale: le gare competitive. La singolarità delle partite tribali sta nel fatto che sono giocate come riti, con il risultato, quindi, stabilito in anticipo. Quando il calcio fu introdotto tra i Gahuku-Gama della Nuova Guinea, suc cedeva che due clan avversari giocassero per giorni senza inter ruzioni: per tutto il tempo necessario a raggiungere il pareggio. Questo è il paradigma generale del rito, eseguito in modo da so migliare “piuttosto a una partita privilegiata, scelta tra tutte quel le possibili poiché è la sola a risultare in un certo tipo di equilibrio tra i due campi” (1962a, trad. it. p. 43). Analogamente, durante i 62
riti funebri degli indiani Fox la metà “vivente” sfida quella a cui apparteneva il defunto a u n ’ultima partita, che la seconda metà vince sempre. “Vincere”, nella simbologia indiana, significa “uc cidere”; cosi al morto è data la soddisfazione di essere ancora vi vo, mentre è il vivo a morire (ibid.). Al contrario, i giochi compe titivi, come li conosciamo noi, iniziano con una simmetria pre stabilita (regole e numero di giocatori sono uguali per entrambi i campi), ma sviluppano mediante eventi contingenti una di sgiunzione sociale. Vincitore e perdente sono risultati di diffe renze di talento, risorse e opportunità. I giochi rituali sono l’esat to contrario: ordinando gli eventi secondo un piano preesisten te, congiungono i gruppi che inizialmente erano asimmetrici e se parati. Nel rito, scrive Lévi-Strauss, si stabilisce un’asimmetria preconcetta e postulata fra profano e sacro, fedeli e officiante, morti e vivi, iniziati e non iniziati ecc., e il “gioco” consiste nel far passare tutti i partecipanti dal lato della vittoria, in virtù di eventi la cui natura e la cui disposizione hanno un vero carattere strutturale. Simile alla scienza [...] il gio co produce eventi muovendo da una struttura: è logico dunque che i giochi competitivi fioriscano nelle nostre società industriali, mentre i riti e i miti, proprio come il bricolage (che queste stesse società industriali non tollerano se non come “hobby” o passa tempo) scompongono e ricompongono insiemi d’eventi e se ne servono come di tanti pezzi indistruttibili in previsione di costru zioni strutturali che fanno alternativamente da fine e da mezzi [ibid., trad. it. p. 45] Naturalmente il professore di una “grande università del Middle-West” (diciamo l’università del Michigan o quella dell’Ohio) che va regolarmente alle partite di calcio sarà suffi cientemente distaccato e attento per notare che l’analogia è esagerata, che alcune somiglianze non sono messe in risalto. Chiunque osservi spassionatamente una tale partita sa che anch’essa è un rito: è strutturata non solo nell’inizio ma anche nel risultato. Proprio nel momento in cui le regole sono ugua li per tutti, l’esito è stabilito. Non necessariamente nel senso che è “prefissato”. Ma per quanto seriamente i Gahuku-Gama gio chino per il pareggio, il caso preferito nel football americano è che ci sia un vincitore. Una partita pari è gravata di tutta la disapprovazione del tabù dell’incesto; come diceva il celebre so63
ciologo Duffy Daugherty, “un pareggio - è come baciare la pro pria sorella”. Inoltre ai vincitori sono concessi determinati pri vilegi cerimoniali che vanno dall’uso da parte della squadra di portare il berretto rovesciato, all’insultare i perdenti, allo sman tellare le porte del campo. E alla fine del campionato si è rea lizzata una gerarchia tra le squadre, che offre ai “Campioni del West” una gita di fine d’anno al Rose Bowl - e certo tanta pom pa è u n ’esagerazione di pura marca californiana. Non si può certo dire che non abbiamo una cultura. Tuttavia la differenza tra i rituali (o fra le gare) esiste, ed è sufficiente a giustificare la convinzione che esiste una differen za tra gli ordini culturali. Dove per i Gahuku-Gama o per i Fox il risultato sociale è un equilibrio prodotto assiomaticamente, essendo ogni disparità di abilità subordinata a questo fine, ab biamo un tipo di società empirica che spinge l’organizzazione fuori dal gioco delle forze reali. Anche la nostra può essere una cultura, ma la sua forma è costruita dagli eventi, poiché il sistema autorizza la gente a usare i mezzi che ha per massimizzare i pro pri vantaggi e riconosce nel risultato una genuina società. Cosi la natura umana sembra un “perpetuo e incessante desiderio di potere e di potere ancora, che cessa solo con la morte”, e la so cietà nient’altro che l’effetto collettivo delle dispute private, mi racolosamente ordinate “come da una mano invisibile”. L’orga nizzazione è la realizzazione socializzata del desiderio. E tale è non soltanto come appare a noi, ma spesso anche alle nostre varie scienze sociali. La descrizione che ne ho fatto ha il sapore di una rozza imitazione dell’economia accademica, ma la problematica è comune alla scienza politica, alla sociolo gia - e a una certa antropologia (cfr. Macpherson, 1962; 1973). Troppo spesso la storia è scritta in forma utilitaristica, come se fosse decisa dalla distribuzione delle risorse e dall’abilità che la gente dispiega nel manipolarle. Il contenuto dell’attività eco nomica varia, ma tutte le nostre scienze sociali condividono la concezione corrente secondo cui la società è prodotta dall’in traprendenza. La società è l’insieme delle relazioni empirica mente costituite dal perseguimento degli interessi privati con i mezzi a disposizione. Forse quésiò-àiuta a spiegare il rapporto con la natura tipi co della cultura occidentale. Anche il precedente riferimento a Hobbes non era casuale. Per quanto ne so, siamo l’unico po64
polo che pensa di derivare dai selvaggi; qualunque altro crede di discendere dagli dei. Questo può rappresentare una chiara dimostrazione della differenza. In ogni caso, di quell’idea ne fac ciamo sia un folclore che una scienza, e a volte distinguiamo a stento l’uno dall’altra. Lo sviluppo da uno stato di natura hobbesiano è il mito deH’origine del capitalismo occidentale.37 Ma proprio come Hobbes non pensava che la socialità abolisse nel l’uomo la natura di lupo per gli altri uomini, ma soltanto che gli permettesse di esprimere se stesso in relativa tranquillità, co si noi continuiamo a credere nel selvaggio che è dentro di noi - e di cui ci vergogniamo un po’. Nel primo periodo fu Homo oeconomicus con una naturale propensione per lo scambio e il baratto, e quest’idea ha reso la società borghese razionale ai suoi propri occhi. Impiegò solo due secoli per evolversi in un’altra specie, VHomo bellicosus. cosi si può chiamare quella litigiosa scimmia umana resa popolare da un gran numero di autori mo derni per spiegare tutto quello che non va oggi. Non che la ri duzione alla biologia non sia scientifica, è anzi un metodo che caratterizza il meglio dell’antropologia dell’evoluzione. Ma da questo punto di vista la nostra scienza può essere la forma più alta di totemismo. Se è totemismo, come dice Lévi-Strauss, spie gare la società umana per mezzo delle distinzioni tra le specie, allora noi ne abbiamo fatto una scienza empirica. Effettivamente, il paragone con i procedimenti del pensiero totemico può essere seguito nei particolari. Infatti, in primo luo go, come osservava Marx, la spiegazione biologica della diffe renza tra le specie, fu modellata sulla società borghese; dopo di che, una volta elaborata, la teoria fu rovesciata per spiegare il mondo umano. Una lettera di Marx a Engels descrive la proie zione iniziale dalla cultura alla natura: E singolare come Darwin riconosca, dietro bestie e piante, la so cietà inglese del suo tempo, con la sua divisione del lavoro, con correnza, apertura di nuovi mercati, “invenzioni” e malthusiana “lotta per l’esistenza”. È il “bellum omnium contra omnes” di Hob bes e ricorda la Fenomenologia di Hegel in quel punto dove la so cietà borghese figura come “regno animale dello spirito” mentre in Darwin il regno animale figura come società borghese. [Cit. in Schmidt, 1966, trad. it. p. 42]
65
La seconda fase, il ripresentarsi della cultura a se stessa in forma di natura, è descritta in una lettera di Engels a Lavrov: Tutta la teoria darwinista della lotta per l’esistenza è semplicemente il trasferimento della teoria di Hobbes del “bellum omnium contra omnes” e della teoria economica borghese insieme con quella malthusiana della popolazione, dalla società alla natura vi vente. Dopo che è stata realizzata questa bravura, si trasferiscono di nuovo quelle stesse teorie dalla natura organica alla storia e si afferma che si è dimostrata la loro validità come leggi eterne del la società umana. [In Schmidt, 1966, trad. it. p. 42] Ma, a parte le corrispondenze con il (có'siddetto) totemismo, ciò che sembra emergere dall’incontro del materialismo stori co con i due strutturalismi antropologici è una distinzione tra l’Occidente e il resto del mondo. La situazione attuale è que sta: un secolo di scienze umane converge su questa disdnzione. Ma il risultato poteva essere previsto, da quando, fin dall’inizio, l’antropologia ha accettato la specificità del “primitivo” come suo settore accademico specifico, sebbene ciò significasse un’am putazione delle sue competenze, drastica almeno quanto la relativizzazione del materialismo storico. Ho cercato di dimostra re qui la plausibilità del punto di vista “due società-due scien ze”. Ma solo per negarlo in un capitolo successivo, come forma di falsa coscienza: un tradurre differenti integrazioni tra Codice e prassi in una distinzione radicale riguardante la natura delle so cietà, come se una non conoscesse assiomi concettuali e l’altra non conoscesse conseguenze pratiche. Questa è “falsa coscien za” perché, secondo me, la distinzione in discussione rende l’ap parenza della società occidentale legittimamente interpretabile come la sua spiegazione esatta. La derivazione dell’organizza zione dall’attività pratica, e della coscienza dai rapporti fra le persone, ignora l’aspetto simbolicamente costituito delle nostre istituzioni. Ma se ne consegue che la determinazione della co scienza da parte dell’essere sociale, com’è generalmente intesa, necessita di una certa rivalutazione, ne consegue anche che es sa rimane proprio quello che è, la migliore spiegazione della scienza sociale occidentale. Poiché gran parte di questa scienza rappresenta la concezione che il capitalismo ha di se stesso. Il vero punto in discussione tra marxismo e antropologia si riduce al rapporto tra la prassi e l’ordine simbolico. E la mi66
gliore spiegazione di questo problema è data dalla storia dell’an tropologia stessa - proprio perché la storia dell’antropologia è una prolungata conseguenza della contraddizione insita nella sua esistenza come scienza occidentale che si occupa di altre cul ture. La contraddizione nasce da una condizione originaria: l’antropologia è una scienza dell’uomo sorretta da una società che, in modo non diverso dalle altre, definisce umanità solo se stessa e cultura solamente il proprio ordinamento. Tuttavia cre do che grazie all’antropologia questa società abbia appreso da gli altri qualcosa che riguarda se stessa.
67
2.
Cultura e ragione pratica Due paradigmi della teoria antropologica
L’opposizione recentemente messa in luce da Lévi-Strauss (1972) tra ecologia e strutturalismo, alt in terno della più ampia unità del naturalismo (o forse si tratta di un materialismo tra scendentale), non è nuova. Nelle sue linee generali è anzi pe culiare dell’antropologia anglosassone. Questo conflitto tra l’at tività pratica e le costrizioni della mente si inserisce in un’ori ginale quanto fondamentale contraddizione, tra i cui poli la teoria antropologica ha oscillato fin dall’Ottocento come un pri gioniero che conti i passi tra le pareti più lontane della sua cel la. Molte delle premesse che fanno dello strutturalismo qualcosa di diverso da una spiegazione basata sul concetto di adatta mento, rappresentano anche la differenza tra Boas e Morgan, tra Radcliffe-Brown e Malinowski, o anche tra i diversi aspetti di uno stesso progetto teoretico, come accade per l’opera di Leslie White, in cui l’accento viene posto contemporaneamen te sulla funzione simbolica della cultura e sul suo determini smo tecnologico. In questo annoso contrasto tra utilitarismo e spiegazione in termini di cultura, le alternative possono essere in linea di massima espresse in questo modo: per il primo in dirizzo, l’ordinamento culturale va inteso come la codificazione dell’azione concreta, intenzionale e programmatica dell’uomo; per l’altro, viceversa, l’azione umana nel mondo è da vedere come mediata da un progetto culturale, che dà ordine all’espe rienza pratica, al comportamento consuetudinario e, insieme ai 68
rapporti tra loro. La differenza non è da poco, e non si risolve con la bella trovata, del tutto astratta, che la risposta sta nel mez zo, o meglio che comprende - dialetticamente - entrambi gli estremi. Di fatto non c’è possibilità di un vero dialogo tra si lenzio e discorso: da un lato le leggi e le forze di natura, “in dipendenti dal volere dell’uomo”; dall’altro la varietà di sensi che gli uomini associati in gruppi danno a se stessi e al proprio mondo. L’opposizione dunque non può essere composta; co me dice Louis Dumont, il rapporto tra i due termini può ser vire solo a circoscriverli. In ultima analisi, il concetto di cultu ra - nel suo significato specifico - verrà riferito all’una o all’al tra logica dominante: a quella “oggettiva” del vantaggio mate riale, o all’altra, quella che diventa significante attraverso lo “schema concettuale”. Nel primo caso la cultura è un sistema strumentale; nel secondo l’aspetto strumentale dipende da si stemi di altro genere. La relazione tra questa controversia settoriale e il richiamo di Marx alla praxis è evidente - anche se, come vedremo, la po sizione di Marx non può essere identificata completamente con il materialismo empirico utilizzato in antropologia. Tuttavia è proprio con una misurata presa di distanza dal marxismo “se non proprio da Marx”, che Lévi-Strauss espone in breve il suo punto di vista: Se noi affermiamo che lo schema concettuale impone e definisce le varie pratiche, è perché queste ultime, che sono oggetto di studio per l’etnologo come realtà a parte, localizzate nel tempo e nello spa zio e distintive di generi di vita e di forme di civiltà, non si confon dono con la praxis la quale - almeno su questo punto siamo d’ac cordo con Sartre - costituisce per le scienze dell’uomo la totalità fondamentale. Il marxismo - se non proprio Marx - ha ragionato troppo spesso come se le pratiche dipendessero immediatamente dalla praxis. Senza mettere in causa l’incontestabile primato delle in frastrutture, noi crediamo che tra praxis e pratiche si inserisca sem pre un mediatore, che è lo schema concettuale, per opera del qua le una materia e una forma, prive entrambe di esistenza indipen dente, si adempiono come strutture, ossia come esseri al tempo stes so empirici e intellegibili. [1962a, ed. it. pp. 145-146] Continuando nella spiegazione del contrasto, Lévi-Strauss lo presenta come materia di studio interdisciplinare: 69
Ciò che noi desideriamo è proprio dare il nostro contributo a quel la teoria delle sovrastrutture, appena abbozzata da Marx, che riser va alla storia - coadiuvata da demografia, tecnologia, geografia sto rica ed etnografia - la cura di sviluppare lo studio delle infrastrut ture propriamente dette, che non può essere il nostro in modo spe cifico, dato che l’etnologia è prima di tutto psicologia. [Ibid.] La gravità della critica di Lévi-Strauss appare appena dissi mulata da questo discreto tirarsi indietro. E forse egli dà un’im magine fin troppo riduttiva della sua scienza. Se lo schema con cettuale circoscrive la materia nei termini di un’esistenza uma na, ciò nonostante esso non viene fuori dal nulla, nel bel mez zo dello scenario dell’azione pratica, solo per sovrapporre l’in terpretazione corretta a fatti materiali o a relazioni strumentali. Né l’azione di decodifica che lo schema svolge può essere con finata nell’ambito della “sovrastruttura”. Questo schema è pre cisamente Vorganizzazione della produzione materiale: analizzar lo significa trovarsi nel centro stesso della base economica. La sua presenza qui scioglie l’antinomia classica tra struttura e so vrastruttura, dove una sarebbe “materiale” e l’altra “concettua le”. Ovviamente, lo schema non dissolve il “materiale” come ta le. Ma le cosiddette cause materiali devono essere, per quanto ri guarda questa specifica caratteristica, il prodotto di un sistema sim bolico il cui carattere è nostro compito analizzare; infatti, sen za la mediazione di questo schema culturale, non può essere evidenziata alcuna precisa relazione tra una data condizione ma teriale e una specifica forma culturale. Le determinazioni ge nerali della praxis sono soggette alle specifiche formulazioni del la cultura; ossia di un ordine che gode, per il fatto di essere un sistema simbolico, di una sua fondamentale autonomia.
MORGAN
Le implicazioni della scelta tra la logica della pratica e quel la del significato hanno, per cosi dire, lottato su una dozzina di campi di battaglia diversi, in una guerra antropologica che du ra da oltre cento anni. La riflessione su questa storia procederà a lungo prima di chiarirle. Ma devo avvertire che da questa escursione emergerà una storia “per noi” - un modo per pren70
dere coscienza di noi stessi nella storia - che non ha alcuna pretesa di essere l’autentica spiegazione diacronica. Utilizzerò la contrapposizione tra Henry Morgan e Franz Boas come oppo sizione paradigmatica, senza far riferimento alle altre figure del contesto e dell’ambito culturale, la cui influenza fu pure certa mente importantissima per la controversia che ho voluto così personalizzare. Inoltre trascurerò, o considererò brevemente, molti seri studiosi più recenti, sia nel campo dell’antropologia sia nelle discipline collegate, che altri potrebbero a buon dirit to giudicare più importanti e indicativi. Un tale trattamento di sinvolto può forse essere giustificato se lo si paragona al tipo di storia con cui gli antropologi hanno preso familiarità: una ver sione del passato vissuto da una parte della società come l’atto costitutivo della sua condizione presente (vedi Pouillon, 1975). Comincio da Morgan - e aggiungo subito che la scelta è in certa misura ambigua. Come tutti i padri fondatori, Morgan ten de a generalizzare più di quanto non facciano gli indirizzi de rivati per differenziazione dal suo pensiero, che conteneva al suo interno i “germi” di quasi tutte le posizioni successive. Que sto vuol dire che l’uomo può essere sottoposto a molte inter pretazioni teoriche ognuna delle quali, non appena diventa un punto di partenza per la disputa di cui stiamo parlando, può essere accusata di scarso rispetto per il principio originario. Co sì Morgan è stato classificato dalle correnti successive come un “idealista” per l’accento posto sul dispiegamento dell’originale “germe di pensiero”; come un “materialista” perché ha basato l’evoluzione sociale sul miglioramento delle tecniche di sussi stenza; e inoltre come “dualista filosofico” per aver utilizzato contemporaneamente i due punti di vista. Un suo cenno alla “logica naturale della mente” ha portato qualcuno a conside rarlo un “mentalista”, mentre altri lo hanno accusato di “razzi smo” per aver riferito la cultura all’organismo (compresa la fa mosa trasmissione di abitudini “attraverso il sangue”). Senza pre tendere di risolvere tutte le controversie, credo sia importante non lasciarsi fuorviare da una certa somiglianza tra la termino logia di Morgan e gli argomenti del moderno strutturalismo, come il richiamo al germe di pensiero originario che si dispie ga in risposta ai bisogni e alle necessità dell’uomo, ma secon do la “logica naturale della mente”. La mente appare nella teo ria di Morgan più come strumento dello sviluppo culturale che 71
come suo generatore (cfr. Terray, 1972). Passiva più che attiva, puramente razionale più che simbolica, l’intelligenza risponde riflessivamente a situazioni che non è lei a produrre né a or ganizzare, cosi che, alla fine, ciò che viene realizzato nelle for me della cultura è una logica pratica - biologica nei. primi sta di, tecnologica negli ultimi. Lo schema concettuale non è la co struzione dell’esperienza umana, ma la sua verbalizzazione, co me avviene per le classificazioni delle relazioni di parentela, ohe sono soltanto i termini di una preesistente rete di rapporti, isti tuita in vista di un vantaggio economico o biologico. Per Mor gan il pensiero è ricognitivo; l’attività concettuale è percettiva; e il linguaggio è il riflesso di differenziazioni che hanno in sé la propria ragione. Il carattere simbolico della cultura non com pare nello schema di Morgan; le parole sono, qui, soltanto no mi delle cose. Consideriamo, in Ancient Society, le argomentazioni di Morgan sullo sviluppo del matrimonio punaiua, sulla gens e, su queste basi, sulla nomenclatura della parentela turanica. Il matrimo nio punaiua rappresentava per Morgan il trionfo della biologia nella società, una grande riforma rispetto alla pratica dell’in crocio tra consanguinei (fratelli e sorelle) all’interno del grup po, pratica che aveva contrassegnato un livello di civiltà più ar retrato. L’indicazione decisiva di questo progresso proveniva dal contrasto con il modello di matrimonio e con le classificazioni di parentela tra gli hawaiani contemporanei. La nomenclatura di parentela degli hawaiani testimoniava l’esistenza di uno sta to originale di consanguineità, infatti tutti gli uomini di una ge nerazione erano “fratelli”, tutte le donne “sorelle” e i bambini “figli” e “figlie” senza una precisa attribuzione. Ma la pratica del matrimonio punaiua indicava l’esclusione delle proprie so relle dal gruppo di donne a disposizione dei fratelli, e dei pro pri fratelli dagli uomini a disposizione delle sorelle. Morgan con cludeva che la contraddizione tra matrimonio e parentela nel le Hawaii contemporanee ricapitolava i primi momenti dell’emancipazione dallo stato di consanguineità. Morgan non è in grado di descrivere con precisione la nascita della proibi zione del matrimonio tra fratelli; parla dei primi passi come di “casi isolati”, un po’ sul modello delle variazioni accidentali, i cui vantaggi venivano riconosciuti lentamente: 72
Una volt^ data la famiglia consanguinea, che coinvolgeva nel rap porto matrimoniale i fratelli e le sorelle carnali, oltre ai fratelli e alle sorelle collaterali, bastava escludere dal gruppo i primi e con servare i secondi per mutare la famiglia consanguinea in famiglia punalua. L’esclusione dell’una classe e la conservazione dell’altra furono attuate attraverso un difficile processo, che comportava un radicale mutamento nella composizione familiare, oltre che nell’antico sistema di vita domestica; e che in più richiedeva l’ab bandono di un privilegio sessuale, cosa piuttosto lenta a realiz zarsi da parte di selvaggi. Si può supporre che tale processo abbia avu to inizio in casi sporadici e isolati, e abbia conservato il carattere di esperimento per un tempo infinitamente lungo, mentre lentamente venivano riconoscendosi i suoi vantaggi; introdotto dunque dappri ma parzialmente, venne poi generalizzandosi e si fece infine uni versale fra le tribù selvagge in più avanzato sviluppo, all’interno delle quali tale movimento aveva avuto inizio. Esso fornisce un’ot tima illustrazione di come opera il principio della selezione na turale. [Morgan, 1877, ed. it. p. 325; corsivi miei]
E importante capire bene il concetto di pensiero umano che Morgan propone qui. L’esempio del punalua è particolarmen te utile poiché fa parte della più comune strumentazione dell’antropologia illustrare l’arbitrarietà del simbolo con l’os servazione che nessuna scimmia è in grado di afferrare la dif ferenza tra “moglie” e “sorella” più di quanto possa esprimere la differenza tra acqua santa e acqua distillata.1 Invece quello che Morgan sostiene qui è esattamente il contrario. E cioè che la differenza tra “marito” e “fratello” o tra “moglie” e “sorella” non è una costruzione simbolica sovrapposta al mondo, ma la conseguenza razionale di una differenza obiettivamente esi stente nel mondò; cioè una differenza tra uomini biologicamente superiori e inferiori. E una percezione dei vantaggi biologici derivanti dalla differenziazione, e dunque una rappresentazio ne in termini sociali di una logica estranea a questi termini. La riforma rappresentata dal punalua era la prima di una lunga se rie culminata nella monogamia, una serie nel corso della qua le l’umanità si è districata progressivamente dalla sua originaria promiscuità e dai conseguenti danni dell’incrocio tra affini. E questo primo passo riassume la visione che Morgan ha dell’in tero percorso. Questo fu compiuto per mezzo dell’osservazione e dell’esperienza: attraverso l’attenzione alle deleterie conse guenze dell’endogamia - “i cui nefasti risultati non potevano 73
sfuggire indefinitamente all’attenzione dell’uomo” (Morgan, 1877) - e l’esperienza del vantaggio mentale, e quindi istitu zionale, dell’esogamia. “Non è difficile dedurre che la pratica punalua si fece strada verso l’adozione generalizzata grazie alla scoperta della sua influenza benefica” (ibid.). Dunque, il pen siero è riconoscimento, e la mente un veicolo attraverso il qua le la natura si realizza come cultura. La successiva spiegazione di Morgan della gens (clan), come sviluppo sulla base della famiglia punalua e come codificazione dei suoi vantaggi, porta a un livello più alto precisamente la stes sa concezione. In quanto matrilineare, la gens originaria rap presenta lo sbocco naturale della famiglia punalua nel corso del tempo, data l’impossibilità di accertare la paternità in quelle condizioni matrimoniali. Il concetto sociale di discendenza rap presenta ancora una volta la formalizzazione di rapporti già so lidamente affermatisi (ibid.). (Più tardi, secondo lo schema di Morgan, la discendenza diventerà patrilineare sotto l’influenza della crescita della “proprietà” - termine generale che Morgan usa per indicare il possesso di “ricchezza” strategica che rap presenta il punto nodale in cui l’interesse economico e l’attivo sviluppo dei mezzi di sussistenza subentrano al vantaggio bio logico come determinazioni pratiche della forma sociale.) Pro prio come la famiglia punalua , le cui funzioni da questo puntò di vista dovevano essere duplicate e generalizzate, l’istituto del la gens si impose progressivamente mediante i “vantaggi che comportava” - e cioè il miglioramento della razza che dovette risultare dalla regola dell’esogamia: Era evidentemente un obiettivo primario dell’organizzazione quel lo di isolare una cosiddetta metà (moiety) dei discendenti da un supposto capostipite, e di impedire, per ragioni di consanguineità, che si sposassero tra di loro... La gens, la cui apparizione è pro babilmente dovuta all’ingegnosità di un piccolo gruppo di sel vaggi, deve aver rapidamente rivelato la sua capacità di produrre uomini superiori. Il dominio quasi universale della gens nel mon do antico è la migliore testimonianza dei vantaggi da essa offer ti. [Ibid, ed. it. p. 55] A sua volta il sistema di parentela turanico riflette l’organiz zazione sulla base del matrimonio punalua e della gens. Con la sua distinzione tra parentela parallela e incrociata, trasforma in 74
parole differenze già esistenti nei fatti. La parentela turanica non è altro che la fedele articolazione delle distinzioni sociali instaurate dalla selezione naturale. La teoria può essere riassunta in questo modo: gli uomini all’origine svilupparono determinate abitudini, forme di com portamento come l’esclusione dei propri fratelli e sorelle dal gruppo all’interno del quale avvenivano le unioni sessuali; e ciò si dimostrò naturalmente utile e vantaggioso. I vantaggi venne ro apprezzati e i comportamenti formalizzati entro modi di or ganizzazione (come la famiglia punalua e la gens) che furono a loro volta soggetti a una riflessione di secondo grado o codi ficazione mediante la nomenclatura di parentela. La direzione della linea di forza generale del processo, l 'orientamento dell’ef fetto logico, va dalla spinta naturale verso la pratica e dalla pra tica verso l’istituzione culturale: circostanza -*• pratica “*• organizzazione e codificazione (istituzione) La comprensione di ogni singolo segmento della catena di effetti è affidata alla ragione del segmento che precede: come la codificazione è espressione dell’organizzazione, cosi la strut tura istituzionale nel suo insieme trova la sua ragione di essere nella pratica, e questa nell’esperienza del mondo; in tal modo l’intera sequenza rappresenta la sedimentazione nella cultura della logica della natura (vantaggio adattivo).2 Ma allora, la teoria di Morgan va bene per una cultura non umana - o anche per un’umanità non-culturale. Infatti, proprio come il pensiero è riconoscimento di un significato esterno, co si le parole degli uomini sono non il concetto di realtà ester ne, ma il loro segno. Poiché l’intelligenza consiste esclusivamente nella capacità di agire razionalmente sulla base dell’espe rienza, Morgan deduce che quella umana non è diversa nella sostanza dall’intelligenza delle altre specie di mammiferi, e in particolare del castoro. Nella celebre monografia The American Beaver and His Works (1868), Morgan asserisce con forza l’uni cità del “principio del pensiero” nell’uomo e nell’animale. Le qualità mentali del castoro, scrive, sono “essenzialmente le me desime di quelle dimostrate dalla mente umana” (p. 252). La differenza tra queste qualità e il pensiero dell’uomo, “e, per con seguenza, tra i principi che rispettivamente rappresentano, è di 75
quantità e non di qualità” (ibid.). La somiglianza specifica sta nella capacità di fare un “uso razionale” delle percezioni con vogliate dai sensi, di agire pragmaticamente sulla base dell’espe rienza. Perciò, secondo Morgan, la fonte del significato mate rializzato nelle produzioni della specie, si tratti della casa di un africano o di un castoro, risiede nella natura stessa. Morgan tornò ripetutamente sulla psicologia animale, sempre impegna to a dimostrare che “tutte le specie, compresa quella umana, sono direttamente guidate dalla natura” (Resek, 1960, p. 51; corsi vo mio) ,s La sua teoria della conoscenza era dunque caratteriz zata dall’assunto - per usare la definizione generale di Cassirer - che il “reale” sia dato “nella sua esistenza come nella sua strut tura, e che si tratti, per lo spirito umano, di prendere sempli cemente possesso di questa realtà data. Ciò che esiste e sussiste “fuori” di noi deve in qualche modo “essere trasportato” nella coscienza, essere trasformato in qualcosa di interno, senza che questa trasformazione gli aggiunga nessun carattere veramente nuovo” (Cassirer 1933, ed. it. p. 55). Morgan riduce il linguag gio, dunque, all’atto di nominare le differenze che si manife stano nell’esperienza. Preferisce salvare la continuità dell’intel ligenza a spese della creatività del linguaggio, sostenendo che il castoro è soltanto “muto” e non stupido, proprio mentre af ferma che la facoltà linguistica dell’uomo è appena rudimenta le allo stato selvaggio e si sviluppa gradualmente nel lungo pe riodo. Morgan è un antropologo pre-simbolico.4 Ma la stessa nozione di concetto si ritrova in molte recenti antropologie della prassi. È u n ’implicita quanto decisiva pre messa della filosofia. L’analisi deve trascurare la fondamentale arbitrarietà della parola - riconoscendo magari che non c'è una relazione intrinseca tra il suono e il concetto (idea), ma sup ponendo che ce ne sia una tra il concetto e la realtà obiettiva a cui si riferisce.5Il linguaggio, dunque, è simbolico solo nel sen so che rappresenta il mondo in u n ’altra forma, ma non ha sen so in sé indipendentemente dal mondo; nell’uso, quindi, se non neH’origine, è comportamento segnico. Ma l’arbitrarietà del simbolo è la condizione propria della cul tura umana.6 E non è semplicemente che la combinazione di suoni “sheep” non ha nessuna connessione necessaria con l’ani male cosi designato, più di quanto ne abbia la parola “mouton”, ma che anche il concetto di pecora varia nelle diverse società. 76
Alludo, è inutile dirlo, al celebre esempio di--Saussure, in cui egli usa la differenza di significato tra sheep e mouton per illu strare la differenza tra valore linguistico e significazione. Sia la parola francese che quella inglese si riferiscono alla stessa spe cie, ma lo fanno, per cosi dire, “in termini differenti”: ciascuna di esse, grazie alle differenziazioni semantiche delle rispettive lingue, veicola una distinta concezione della (e relazione con la) specie. La parola inglese non si applica all’animale nel suo stato cucinato, alimentare, per cui esiste un secondo termi ne, “mutton”; ma il francese non è ancora riuscito a entrare nel la più alta distinzione tra crudo e cotto: Il francese mouton può avere la stessa significazione dell’inglese sheep, ma non lo stesso valore, e ciò per più ragioni, in particola re perché parlando di un pezzo di carne cucinato e servito in ta vola, l’inglese dice mutton e non sheep. La differenza di valore tra sheep e mouton dipende dal fatto che il primo ha accanto a sé un secondo termine, ciò che non è il caso della parola francese. AH’interno d’uria stessa lingua, tutte le parole che esprimono delle idee vicine si limitano reciprocamente [...]. Cosi il valore di un qualunque termine è determinato da ciò che lo circonda; per fino della parola che significa “sole” non è possibile fissare im mediatamente il valore se non si considera quel che le sta intor no; ci sono delle lingue in cui è impossibile dire “mi seggo al so le" [Saussure, 1916, ed. it. pp. 140-41], Per quanto riguarda il concetto o significato, una parola è ri feribile non soltanto al mondo esterno, ma prima di tutto al suo posto nella lingua - cioè alle altre parole correlate. Dalla sua differenza con le altre parole risulta la sua valutazione dell’oggetto, e in un sistema di tali differenze si verifica una co struzione culturale della realtà. Nessuna lingua è pura nomen clatura. In nessuna i suoi termini stanno in una semplice cor rispondenza univoca con “le” distinzioni oggettive. Ognuna con ferisce un certo valore alle distinzioni date e quindi costituisce la realtà oggettiva attribuendole una qualificazione diversa, pro pria di quella società.7 In realtà, come progetto sociale totale, l’attività simbolica è al tempo stesso sintetica e analitica, por tando l’intera logica culturale a poggiare sul concetto. Infatti, se da un lato le differenze di valore linguistico provocano un particolare decoupage del mondo esterno segmentandolo secon77
do alcuni principi, dall’altro lato gli elementi cosi spezzettati vengono nuovamente riuniti dalle loro reciproche corrispon denze di significato. Non sto parlando solo di distinzioni se mantiche, ma di proposizioni culturali. E l’arbitrarietà simboli ca di queste ultime è anche maggiore di quella delle prime. Al meno in teoria esistono dei limiti naturali al campo semantico di un singolo lessema: nessuna singola parola, per esempio, può significare contemporaneamente ed esclusivamente le due specie bue e aragosta. Ma lo stesso esempio suggerirà agli americani, presso i quali la particolare combinazione “steak and lobster” in dica un determinato genere di pranzo, che la cultura non è soggetta a simili costrizioni. Qui appare evidente come non ci siano limiti teorici, assegnabili a priori, che stabiliscano quali og getti potrebbero appartenere a una stessa classe nello schema culturale. La logica proposizionale è straordinariamente flessi bile, e altrettanto lo sono, anche alfinterno di questa logica e dello stesso mondo, le culture.8 In breve, mediante la valutazione simbolica e la sintesi della realtà oggettiva, noi creiamo un nuovo tipo di oggetto, con pro prietà distinte: la cultura. Il linguaggio è un mezzo privilegiato di questo progetto. Ma per Morgan il linguaggio non è altro che percezione articolata. Per cui il momento del passaggio dalla na tura alla cultura, secondo Morgan, non è più fondamentale, di ciamo, della trasposizione dell’Odissea dalla forma orale a quel la scritta. Quello che recentemente un importante marxista ha scritto di Kautsky può essere ripetuto per Morgan: che per lui “la storia umana... è u n ’appendice della storia naturale, la sua legge di movimento costituisce solo un riflesso della legge bio logica” (Schmidt, 1962).9
BOAS
Su questo sfondo l’odissea di Boas “dalla fisica all’etnologia” acquista significato in quanto istituisce una opposizione all’in terno della quale l’antropologia si è mossa ciclicamente in tut ti questi anni. Come George Stocking (1968) ha cosi ben det to, in un viaggio durato molti anni Boas è passato da un mate rialismo monistico alla scoperta che “l’occhio che vede è l’or gano della tradizione”; un viaggio di molte tappe in cui ha sco78
perto che per l’uomo non è l’organico che deriva dall’inorga nico, il soggettivo dall’oggettivo, la mente dal mondo - e, in definitiva, la cultura dalla natura. I primi passi furono fatti pro prio all’interno della fisica. Nella sua dissertazione sul colore del mare, Boas sottolineò la difficoltà di cogliere l’intensità relativa di luci che differiscono di poco nel colore. La variazione quan titativa nell’oggetto non suscita una corrispondente variazione nel soggetto.10 Boas doveva più tardi ripetere l’esperienza a li vello linguistico quando, con informatori della costa nord oc cidentale, scopri che suoni considerati uguali da un parlante di una lingua potevano essere intesi come completamente diffe renti da parlanti di u n ’altra lingua, e viceversa, poiché ciascu no percepiva nella parlata dell’altro le distinzioni tipiche della propria.11 Più tardi attraversò un periodo ugualmente impor tante di interesse per la psicofisica fechneriana: esperimenti sen soriali sui fenomeni di “soglia” che non solo confermarono la conclusione che differenze oggettive nello stimolo non genera no parallele differenziazioni di risposta - che la reazione uma na alla quantità è di per sé stessa qualitativa - ma anche che la risposta dipende da fattori situazionali e dallo stato mentale del soggetto. La percezione nell’uomo è appercezione; dipende, si potrebbe dire, dalla tradizione mentale. Ma questo di per sé non è determinante, specifico dell’uomo. Per ogni dato gruppo uma no la tradizione in oggetto è un insieme di significati accumu lati: una teoria collettiva e storica che fa della percezione un concetto.12 Vorrei ora fare una breve digressione e un paragone appa rentemente curioso. E affascinante l’idea che sia Boas che Marx all’inizio della loro vita intellettuale siano giunti esattamente al lo stesso punto nodale. A un certo punto entrambi furono spin ti a rifiutare un materialismo meccanicistico arrivato fino a lo ro daH’Illuminismo. Scelsero possibili alternative, che differiva no tra loro non enormemente, ma abbastanza da condurli fa talmente per strade diverse. Marx doveva reagire al materiali smo contemplativo e sensista di Feuerbach, un materialismo in cui l’ipotetico soggetto individuale risponde passivamente alla realtà concreta; ma la reazione di Marx era anche condiziona ta dall’idealismo hegeliano che si era impadronito del soggetto storico attivo. La soluzione, cosi come Marx la espose nella pri ma tesi su Feuerbach, stava nell’utilizzare l’attivismo proprio 79
dell’idealismo per rimediare all’insufficienza del materialismo che concepiva “l’oggetto, la realtà, la sensibilità [...] solo sotto la forma de\Y obietto o dell’intuizione, ma non come attività uma na sensibile, prassi-, non soggettivamente” (Marx, 1845). “Feuer bach, non soddisfatto de\Y astratto pensiero", scrive Marx nella quinta tesi, “vuole l’intuizione, ma egli non concepisce la sensi bilità come attività pratica umana sensibile.” Marx sottolineò che tale prassi deve essere intesa come sociale e, nella sua specifi cità storica, non come l’azione di un individuo astratto e isola to. Ma il riconoscimento del sociale, comune a Marx e a Boas, si distingue per la differenza di accentuazione. Marx giunse al la pratica e alle strutture di realtà costruite dall’azione concre ta e presente, in modi storicamente determinati, degli esseri umani forniti di sensi. Boas affrontò lo stesso problema del ma terialismo meccanicistico per gli eschimesi e più tardi per la co sta nord occidentale, allo scopo di scoprire la determinazione storica del soggetto agente. La scelta di Marx condusse al ma terialismo storico; quella di Boas alla cultura. Questa conclusione del viaggio di Boas nel potere strutturante della tradizione sembra adesso, a posteriori, coerente con le con dizioni del suo inizio. Boas cominciò col mettere in discussio ne l’essenza delle tesi di Morgan: l’esprimersi della natura nel la cultura con la mediazione della riflessività della mente. In una serie di lettere allo zio in America nel 1882-83, descrive le cir costanze del suo progetto eschimese: Mentre all’inizio la mia intenzione era di considerare la mate matica e la fisica come obbiettivo finale, fui condotto, dallo stu dio delle scienze naturali, a occuparmi anche di geografia, e que sto campo catturò il mio interesse a tal punto che infine lo scel si come mia occupazione primaria. Tuttavia, la direzione del mio lavoro e studio fu fortemente influenzata dalla pratica che avevo nelle scienze naturali, e in particolare nella fisica. Nel corso del tempo mi convinsi che la mia precedente Weltanschauung mate rialistica —ben comprensibile in un fisico - era insostenibile, e arrivai cosi a un nuovo punto fermo che mi rivelò la necessità di studiare l’interazione tra l’organico e l’inorganico, soprattutto tra la vita di un popolo e il suo ambiente fisico. Cosi nacque il pro getto di considerare compito della mia vita la seguente ricerca: fi no a che punto possiamo considerare i fenomeni della vita orga nica, e particolarmente quelli della vita psichica, da un punto di 80
vista meccanicistico, e quali considerazioni possono essere tratte da un tal modo di considerare? [Citato in Stocking, 1968, p. 138] In un certo modo la carriera antropologica di Boas può essere caratterizzata come un processo in cui l’assioma originale, la co struzione umana dell’esperienza, sia trasposto dal livello psicolo gico a quello culturale. Stocking sceglie lo scritto giovanile (1889) “Sui suoni alternati” in quanto contiene i germi di quello svilup po, e quindi del moderno concetto di cultura. Più che un eserci zio critico o metodologico, scrive Stocking, questo scritto prefigura tanta parte della interpretazione antropologica moder na della “cultura” che, almeno implicitamente, vede i fenomeni culturali come Vimposizione di un significato convenzionale al flusso dell’esperienza-, li vede come storicamente condizionati e trasmessi attraverso il processo dell’apprendimento. Li considera come ciò che determina nel modo piu preciso le nostre percezioni del mondo esterno. E li considera in termini relativi più che assoluti. Molta parte del la voro successivo di Boas, e quello dei suoi allievi dopo di lui, può essere ritenuto come l’elaborazione delle implicazioni presenti in questo articolo. [Ibid., p. 158, corsivi miei] Di fatto, i sentieri attraverso cui Boas giunge al concetto di cultura erano diversi e talvolta tortuosi (cfr. Stocking, 1968, pp. 195-223; 1974, pp. 1-20). Uno di questi ha qui rilevanza parti colare, in quanto si sviluppa dal diretto confronto con Morgan sul problema delle leggi generali dell’evoluzione sociale. La mo derna antropologia, tutto sommato, tende a considerare questa particolare controversia infelice, poiché la frammentazione no minalistica operata da Boas sul contenuto delle culture per pro vocare la diversità dei processi di sviluppo, conteneva quella con cezione “a pezzi e a strisce” dell’oggetto culturale, per liberarsi della quale l’antropologia americana avrebbe faticato per de cenni. Invero, Radin da subito e con vigore criticò la nozione “quantitativa” del tratto culturale isolato che Boas aveva svilup pato spinto dalla preoccupazione ossessiva di confutare la teo ria evoluzionista (Radin, 1933). Ma questo negativo smembra mento della cultura doveva produrre un risultato contradditto rio e sintetico. Distinguere tratti apparentemente simili, nella lo ro concreta esistenza in varie società, per Boas era giustificato dalle differenze di significati e di usi determinati localmente. 81
Se questi significati comportavano processi di sviluppo dissimi li, e quindi provavano che Morgan sbagliava, ciò accadeva per ché essi comportavano anche un contesto totale e orientato: una cultura che forniva il modello a quei tratti secondo il proprio particolare spirito. Boas, da quando ebbe dimostrato che le ma schere di una società A, usate per ingannare gli spiriti, non era no comparabili con le maschere di una società B, che le utiliz zava per onorare gli antenati - e analogamente che clan, totem o organizzazioni dualiste variavano in tutto il mondo - allora arrivò a dedurre l’esistenza di culture: di totalità le cui “idee do minanti” o modelli creano queste differenziazioni (Boas, 1940, pp. 270-89, e passim). In un celebre articolo, “Storia ed etnolo gia”, Lévi-Strauss osserva l’applicazione concettuale del metodo: Si cercherà allora, esasperando il nominalismo boasiano, di stu diare ciascuno dei casi osservati come altrettanti individui? Biso gnerà constatare che le funzioni assegnate all’organizzazione dua lista non coincidono, e che, d’altra parte, la storia di ogni grup po sociale rivela come la divisione in metà proceda dalle origini più diverse.13 Cosi, l’organizzazione dualista può risultare secon do i casi: dall’invasione di una popolazione da parte di un grup po di immigrati; dalla fusione, per ragioni variabili (economiche, demografiche, cerimoniali), di due gruppi territorialmente vicini; dal cristallizzarsi, sotto forma di istituzione, di regole empiriche destinate ad assicurare gli scambi matrimoniali in seno a un da to gruppo; dalla perequazione all’interno del gruppo, su due par ti delfanno, due tipi di attività, o due frazioni della popolazione, di comportamenti antitetici, ma giudicati ugualmente indispensa bili al mantenimento dell’equilibrio sociale ecc. Si sarà cosi por tati a denunciare il concetto di organizzazione dualista come co stitutivo di una falsa categoria e, estendendo questo ragionamen to a tutti gli aspetti della vita sociale, a negare le istituzioni a esclu sivo beneficio delle società. [Lévi-Strauss, 1958, ed. it. p. 23] La problematica complessiva di Boas, così, differisce radical mente da quella di Morgan. Dove Morgan aveva inteso la pra tica e la sua cristallizzazione nel costume secondo la logica del le circostanze obiettive, Boas interpolò un elemento soggettivo indipendente tra le condizioni obiettive e il comportamento or ganizzato, tale che quest’ultimo non derivasse meccanicamente dal primo. A livello psicologico, nel cui campo Boas ebbe per la prima volta la rivelazione, il termine mediatore può essere 82
definito grosso modo come u n ’operazione mentale, generata dal contesto e dall’esperienza precedente, che, guidando la per cezione, specifica i rapporti tra stimolo e risposta (fig. 7). A li vello culturale, nel cui ambito il pensiero di Boas ha subito una continua evoluzione, il termine mediatore è la tradizione, il Vòlkergedanken o modello dominante, che dà ordine nello stes so tempo alla relazione con la natura, alle istituzioni esistenti, e all’interazione tra queste e quella (fig. 8). La somiglianza tra queste due formule e quella di Lévi-Strauss è inequivocabile (v. sopra pp. 56-57). In effetti i termini in cui Lévi-Strauss espone la sua posizione - in opposizione a un cerFigura 7
2) livello psicologico stimolo
risposta
ambiente
istituzione
Figura 8
3) livello culturale
Figura 9
4) Boas prassi
5) Morgan
pratiche
prassi — ►pratiche— ►schema concettuale (codice) 83
to marxismo - descrivono altrettanto esattamente la posizione di Boas, fin nella definizione del tertium quid esistente tra praxis e pratiche come “schema concettuale” (o codice). Adottando questi termini, il contrasto tra Boas e Morgan potrebbe essere posto nelle sue linee generali come mostra la figura 9. S’intende che “schema concettuale” ha un valore diverso in queste due prospettive. Per Boas è il codificatore, mentre per Morgan è la codificazione, di distinzioni che gli sono esterne. Per Boas la significanza dell’oggetto dipende da una proprietà del pensiero, laddove per Morgan il pensiero è la rappresenta zione della significanza obiettiva. Se la teoria di Morgan attri buisce dunque al pensiero e al linguaggio funzioni di segno, quella di Boas è essenzialmente una concezione problematica del piano simbolo. Infatti la struttura del simbolico sviluppata da Boas, avrebbe spiegato i punti di vista empiristi e razionali sti alla Morgan: intendendoli, cioè, come una forma caratteri stica di autoriflessione culturale, un appello a posteriori alla ra gionevolezza delle pratiche la cui logica autentica è poco chia ra e le cui vere fonti sono sconosciute. Boas dimostrò che la formazione di una cultura, come pro cesso mediante il quale l’esperienza viene resa significante, pro cede necessariamente su una teoria - dell’uomo, della natura, dell’esistenza umana nella natura. Questa teoria comunque re sta non formulata dal gruppo umano che la vive. Il linguaggio è un esempio privilegiato di questo processo inconscio, ma al tri costumi, pratiche, credenze e proibizioni sono ugualmente basati sul pensiero irriflesso e su idee che giacciono al di sotto della memoria. Tutti sono fondati sulla categorizzazione dell’esperienza, sull’appropriazione del percepito per mezzo del concetto, nello stesso modo in cui nell’etimologia o nella sin tassi di una data lingua, l’esperienza non è semplicemente rap presentata, ma vi è classificata. E come ogni classificazione de ve avere il suo principio, cosi ogni lingua è “arbitraria” al tem po stesso dal punto di vista di ogni altra lingua e rispetto al rea le, in quanto raggruppa sotto un unico significato una serie di cose o di eventi che in u n ’altra lingua sarebbero concepiti o denotati separatamente. Boas spiega: Le lingue si differenziano non solo nel carattere dei loro elementi fonetici costitutivi e gruppi di suoni, ma anche nei gruppi di idee 84
che trovano.espressione in raggruppamenti fonetici fissi [...]. Poi ché l’intera gamma dell’esperienza personale da esprimersi me diante la parola è infinitamente varia e dev’essere espressa in tut ta la sua ampiezza da un numero limitato di radici nominali, ogni linguaggio articolato deve implicare una vasta classificazione del le esperienze. Il che coincide con un carattere fondamentale del pensiero umano. Nella nostra esperienza concreta non ci sono due im pressioni sensoriali o stati emotivi identici. Li classifichiamo, a se conda delle loro analogie, in gruppi più ampi o più ristretti, i cui limiti possono essere determinati in base a criteri diversi [...]. In varie culture queste classificazioni possono basarsi su prin cipi fondamentalmente distinti [...]. Per esempio: è stato osserva to che i colori sono stati-classificati in gruppi affatto distinti a se conda delle loro analogie, senza tenere alcun conto della diffe renza di capacità nel distinguere le sfumature del colore [...]. E difficile sminuire l’importanza del fatto che nel linguaggio e nel pensiero la parola evoca un quadro differente se verde e giallo, o verde e blu, sono classificati insieme. [Boas 1911, ed. it. pp. 172-173; vedi anche Boas 1911a]14 Più tardi Boas spiegò - con un’osservazione diventata classi ca - che, anche se la lingua e altri costumi sono organizzati tut ti secondo una logica irriflessa, esiste una differenza tra loro nel fatto che le classificazioni della prima non giungono nor malmente alla coscienza, mentre le categorie della cultura vi giungono, e sono tipicamente soggette a una interpretazione di secondo grado (191 la). Essenzialmente la differenza nasce dal modo di riproduzione. Imprigionate in regole inconsce, le ca tegorie della lingua vengono riprodotte automaticamente nell’atto del parlare. Invece la continuità di un costume è sem pre suscettibile di interruzione, anche solo in seguito al contatto con modi di vita diversi o per la tendenza a socializzare dei gio vani. Il costume quindi diventa oggetto, oltre che fonte, di pro gettualità, e a una ragione convenzionale che rimane inespres sa diamo u n ’espressione convenzionale che sembra perfetta mente ragionevole. La logica culturale ricompare dunque in for ma mistificata - come ideologia. Non più come principio di clas sificazione, ma in risposta a una richiesta di giustificazione. Non è più, allora, una logica arbitraria rispetto a una realtà oggetti va, ma motivata dalla realtà culturale. Le conseguenze implicite in questa interpretazione per il pro85
getto antropologico non sono ancora risolte; per certi aspetti non sono state neppure ben comprese. Da una parte, quanto di ciò che consideriamo istituzioni e credenze fondamentali, dovrebbe essere analizzato in termini di etimologia popolare? E, viceversa, non sembra più possibile condividere l’ottimismo di Boas sulle ca tegorie antropologiche, poiché, secondo alcune ripetute contro prove positiviste condotte sulla formazione delle idee e del costu mi a cui queste categorie si riferiscono, esse potrebbero davvero essere “derivate da, coerenti con, e in un certo senso interne a, i fenomeni stessi” (Stocking 1974, p. 4). In ogni caso non sarebbe difficile sviluppare la critica, implicita nella nozione di coscienza di secondo grado, dell’analisi razionalista di Morgan. Se “l’origi ne delle usanze dell’uomo primitivo non deve essere ricercata nei processi razionali”, come scrive Boas (191 lb, ed. it. p. 197), l’ori gine di certi processi razionali invece può essere trovata nelle usanze. La ragionevolezza delle istituzioni, e soprattutto la loro utilità, è l’argomento di principio con cui spieghiamo noi a noi stessi. La razionalità è la nostra razionalizzazione. Boas porta l’ef ficace esempio del tabù dell’incesto, a cui una volta ci contenta vamo di dare una giustificazione religiosa, mentre adesso, “si ad duce come ragione dei nostri sentimenti un concetto utilitario: la paura che il matrimonio tra parenti stretti produca una prole de generata” (1911b, ed. it. p. 191).15 Il fatto è che quando spieghiamo ciò che è convenzionale come utile, questo diventa per noi anche “naturale”, nel dupli ce significato di inerente alla natura e normale nella cultura. Ec co, Morgan ha fatto di questa contraddizione una teoria etno logica, la cui situazione può essere definita come l’appropria zione delle realtà significanti della vita di altri popoli per mez zo delle nostre proprie razionalizzazioni di secondo grado.
VARIETÀ ANTROPOLOGICHE DI RAGIONE PRATICA
Emerso per la prima volta nell’opera di Morgan e di Boas, il fondamentale disaccordo sulla natura dell’oggetto antropologi co continua ancora oggi a percorrere, in ogni forma possibile, altre controversie teoriche. Questo non per sottovalutare l’im portanza di celebri antinomie quali “storia/scienza”, “cultu ra / società”, “diacronia/sincronia”; ma queste opposizioni si so86
no susseguite e sviluppate da un momento teorico al successi vo, non facendo altro che riprodurre, a ogni stadio, la con traddizione irrisolta alla base. Nei risultati, le più recenti pro spettive che sembrano segnare delle rotture a livello teorico, si trovano in interno contrasto lungo le stesse linee che separano il punto di vista di Morgan da quello di Boas. Un funzionali smo è in tal modo distinto dall’altro, come pure uno storicismo lo è dall’altro, e una metà dei funzionalisti o degli evoluzioni sti trova un imprevisto alleato nell’altra tribù. E poi cosi para dossale raggruppare insieme certe accentuazioni teoriche di Lé vi-Strauss e di Leslie White? (v. oltre p. 104). L’accordo sui prin cipi tra l’ultraevoluzionista Morgan e l’ultrafunzionalista Malinowski è ben più completo. Malinowski e il “neofunzionalismo”
Anche più esplicitamente di Morgan, Malinowski considera va la cultura come realizzazione strumentale* di necessità biolo giche: come costruita dall’azione e dall’interesse pratici, quasi guidata da una specie di superrazionalità, a cui il linguaggio of fre solo il contributo di un supporto tecnico (cfr. Leach, 1957). Dobbiamo prendere posizione, scrive Malinowski, su due assio mi: “Primo, che ogni cultura deve soddisfare il sistema biologi co di bisogni, quali i bisogni dettad dal metabolismo, dalla riproduzione, dalle condizioni fisiologiche della temperatura.” E, secondo, “che ogni realizzazione culturale che implica l’uso di mezzi materiali e simbolici è u n ’intensificazione strumentale dell’anatomia umana e si riferisce direttamente o indirettamente al soddisfacimento di un bisogno del corpo” (Malinowski, 1944, ed. it. p. 177). Per usare una frase del sociologo francese Bau drillard, è come se la cultura fosse un prolungamento metafo rico delle funzioni fisiologiche della digestione. In ultima ana lisi, la cultura si può riferire a una utilità pratico-organica. Sem plice o complessa, essa è “un vasto apparato, in parte materia le, in parte umano e in parte spirituale con cui l’uomo può ve nire a capo dei concreti, specifici problemi che gli stanno di fronte” (Malinowski, 1944, ed. it. p. 44). Sarebbe soltanto ripetere un luogo comune fare un raffron to punto per punto tra il testo di Morgan e quello di Malinowski. Poiché è cosi esplicito, Malinowski diventa molto più interes87
sante per alcujte implicazioni teoretiche della discussione sulla praxis che sono solo accennate in Morgan, sebbene in realtà la sua opera le contenga, cosi come compaiono in molte altre suc cessive versioni, fino alla più recente ecologia “neofunzionalista”. Analizzerò molte di queste implicazioni, che potrebbero sommariamente essere intitolate: “la hybris etnografica”, “i ri corsi riduttivi alla spiegazione funzionalista”, “terrore”, “fetici smo dell’ecologia”, “dualismo utilitario”, e “la scomparsa della cultura”. La prima ha a che vedere con la particolare relazione soggetto/oggetto implicita nell’aspetto pragmadco messo in evi denza da Morgan, quello che contrasta radicalmente con il re lativismo di Boas. Il senso primario del progetto di Malinowski era ricondurre tutti gli aspetti di usi apparentemente eccentrici, dall’Intichiuma australiano al totemismo delle Trobriand, al valore pratico (leg gi: biologico). Chiaramente Malinowski era guidato da senti menti particolarmente comprensivi nei confronti degli aborigeni (cfr. Jarvie, 1964). Voleva dimostrare come la ragione soggia cente alle “stramberie apparentemente senza senso di quelli che allora chiamavamo ‘selvaggi’” (Richards, 1957, p. 18) fosse qual cosa che qualsiasi europeo era in grado di comprendere: il van taggio materiale. Era nei fatti il ribaltamento del relativismo boasiano, anche se improntato allo stesso spirito di tolleranza. Sot to le apparenze, VIntichiuma è vantaggioso; perciò l’aborigeno australiano è nostro fratello: Per prima cosa [...] un interesse verso l’utilità delle stramberie ap parentemente senza senso di quelli che allora chiamavamo “selvag gi”, era dominante nella sua [di Malinowski] opera. Il suo primo ar ticolo pubblicato si proponeva di mostrare che le cerimonie Intìchiuma degli aborigeni australiani, con le loro danze selvagge, i cor pi dipinti e gli scudi istoriati con incisioni simboliche, svolgevano una funzione concreta nella loro vita economica. [...] Dopo il viag gio alle Trobriand pubblicò il suo primo articolo importante sulla vita economica degli isolani, che mostrava la stessa determinazione di provare che ciò che agli occhi di un europeo sembrava un inuti le, rituale scambio di beni, giocava in effetti una parte importante nella loro organizzazione economica. [Richards, 1957, p. 18]16 In questo c’è qualcosa di più dell’ovvia implicazione che se l’interpretazione risulta accettabile all’europeo, essa dà più 88
informazioni su di lui che sui “selvaggi” - e più in generale che l’“etico” dell’antropologo è l’“emico” della sua società.* C’è qualcosa da dire ancora sulla relazione soggetto/oggetto impli cita nell’impulso a trarre un “senso” pratico da un costume eso tico intricato e anche, a prima vista, privo di necessità pratica. E ciò che solleva l’antropologo alla altezza divina di un sogget to costituente da cui promana il disegno della cultura. Invece di rimettersi alla comprensione di una struttura con u n ’esistenza indipendente e autentica, egli interpreta quella struttura me diante la comprensione del suo fine - e cosi facendo fa in mo do che 1’esistenza di quella dipenda da lui. Per Malinowski era un punto importante del metodo etno grafico “afferrare il punto di vista dell’indigeno, il suo rappor to con la vita, rendersi conto della sua visione del suo mondo” (1922). Questo fu un dogma fondamentale del suo “empirismo radicale” come lo chiama Leach. Ma evidentemente c’è con traddizione tra un tale empirismo e l’impulso a risolvere costu mi curiosi in nozioni utilitarie. “Empirismo” deve dunque con sistere nell’applicazione radicale di una teoria, quella dell’inte resse pratico e del calcolo personale, secondo cui il modo di agi re apparentemente particolare della gente non ha speciali di ritti alla nostra attenzione. Una volta Kroeber domandò, avendo chiaramente Malinowski in mente: “Perché uno Yurok non man gia in canoa mentre naviga sull’oceano?” A questa domanda “non c’è nessuna risposta ovvia paragonabile a quella che si può dare se ci si chiede perché le frecce terminino con una piuma o che uso abbia una rete da pesca” (Kroeber, 1948, p. 307). Malinowski - era il sottinteso di questa critica - rifiuta di am mettere qualsiasi oscurità nel sistema culturale, e tantomeno cer ca di comprenderne la logica interna. Intere aree di cultura sfuggono in questo modo a una spiegazione funzionalista, dal momento che non hanno un senso pratico evidente. Leach lo mette in rilievo, a proposito della stregoneria: “Si accorda con il dogma di Malinowski, secondo il quale la ragionevolezza è un elemento naturale del genere umano, il fatto che le credenze * I termini etico ed emico (etic e ernie), tratti da Kenneth L. Pike dalle desinenze di «fonetico» e «fonemico», indicano rispettivamente gli elementi oggettivi e quelli soggettivi o pertinenti nella pratica lin guistica e, in senso più lato, nel comportamento umano generale. 89
nella stregoneria - che non sono né sensibili né razionali - non furono mai incorporate completamente nello schema funzionalista” (Leach, 1957, pp. 128-129; cfr. Nadel, 1957). Ci sono molti altri campi nella vita delle Trobriand - paren tela, magia, vita pubblica - di cui Malinowski ha lasciato una spiegazione incompleta e asistematica a causa di alcune incer tezze derivanti dal medesimo approccio teorico. Egli riteneva secondari i testi e le affermazioni della gente, quasi fossero me re formulazioni di ideali, in confronto ai concreti motivi prag matici che governano i rapporti degli uomini con le norme e tra loro (cfr. Malinowski, 1926). In tutto questo, Malinowski ri baltò non solo le premesse dell’antropologia boasiana, ma an che il rapporto originale tra l’antropologo e le popolazioni che studia. Vero è che Boas avrebbe finito col non capire la paren tela kwakiutl più di quanto Malinowski avesse capito il sistema delle Trobriand. Nei fatti, Boas era molto più incoerente - a par te un certo rispetto verso l’incomprensibilità dell’indiano. Boas pensava che i fatti “parlassero da soli”: al giorno d’oggi questo è comunemente considerato il segno di un empirismo ingenuo. Ma l’intenzione era quella di privilegiare un atteggiamento ri cettivo verso la cultura in se stessa, il mandato di trovare l’or dine nei fatti più che di mettere i fatti in ordine (cfr. Smith, 1959). L’empirismo ingenuo di Boas consisteva nell’illusione che l’ordine apparisse come rivelato, nel testo di mille ricette per il salmone, senza l’aiuto di alcuna interpretazione da parte sua.17 In lui il rapporto con l’oggetto era completamente diverso. L’an tropologo era ridotto al rango di uno strumento di registrazio ne: neppure alla sua perspicacia era permesso entrare in gioco. Ma per Malinowski il “selvaggio” era negatività pura. Non esi steva; e Malinowski l’avrebbe creato: “Sento la parola ‘Kiriwana’ [...]. Mi preparo; piccole capanne grigiorosate [...]. Sta a me descriverle, oppure crearle” (Malinowski, 1967, p. 140). L’utilitarismo funzionale è una sorta di funzionale cecità nei confronti del contenuto e delle relazioni interne dell’oggetto culturale. Il contenuto è considerato solo per il suo effetto stru mentale, e la sua consistenza interna viene in tal modo fatta passare per utilità esterna. La spiegazione funzionalista è una specie di patto stipulato con la realtà etnologica, in cui il con tenuto viene scambiato con la sua “comprensione”. Eppure una teoria dovrebbe essere giudicata tanto dall’ignoranza che ri90
chiede quanto dalla “conoscenza” che fornisce. C’è una dispa rità enorme tra la ricchezza e complessità di fenomeni quali 1’/ntichiuma e la nozione banale che l’antropologo ha della loro utilità economica. Solo una parte infinitesimale di quella realtà cosi ricca si spiega con la sua funzione, ma nulla del suo con tenuto specifico.18 Quando Malinowski si propose di dimostrare che “le cerimonie Intichiuma degli aborigeni australiani, con le loro danze selvagge, i corpi dipinti e gli scudi istoriati con in cisioni simboliche, svolgevano una funzione concreta nella loro vita economica” - e cioè che essi aumentavano la produzione in previsione delle cerimonie (Malinowski 1912) - noi, in pra tica, che cosa impariamo da queste danze selvagge, corpi di pinti e mille altri aspetti dell 'Intichiuma? Un tale impoverimento concettuale è il modo di produzione teorico del funzionalismo. Esso si aggrava ulteriormente quan do la funzione è ricercata a livello biologico - come accade spesso non solo a Malinowski, ma anche a più recenti edizioni dell’antropologia ecologica (cfr. Vayda, 1965, p. 196; Vayda e Rappaport, 1967). Questo perché più il fatto culturale è lonta no dalla sfera di utilità a cui si riferisce (l’organico, l’economi co, il sociale), necessariamente minori e più mediate sono le relazioni tra il fatto e i fenomeni di quella sfera; e di conse guenza minori e meno specifiche sono le coazioni funzionali sul la natura del costume in questione. E cosi meno determinata sarà la spiegazione basata sui caratteri funzionali; o, reciproca mente, più grande sarà il numero delle pratiche culturali al ternative che possano ugualmente (o anche meglio) servire al lo stesso scopo. Ci sono certamente molti modi per incentivare la produzione, oltre alla messa in scena di una cerimonia Intichiuma. In verità, la spiegazione manca di molto l’obiettivo di rendere comprensibile il costume, quando ci si occupa in un modo cosi singolare degli affari degli altri. Per persuaderci dell’indeterminatezza di ogni spiegazione di questo tipo, basta rovesciare l’argomento: è vantaggioso aumentare la produzione - di qui VIntichiuma} L’interpretazione funzionalista di Mali nowski sarebbe stata più efficace se egli, à la Radcliffe-Brown, avesse riferito la cerimonia al livello dei fatti sociali. Le relazio ni prevalenti tra clan totemici, tra uomini e donne, tra iniziati e non iniziati devono essere seguite a lungo prima che possa no rendere intellegibili le danze selvagge e gli scudi dipinti. Non 91
serve molto addurre i vantaggi economici. E ancora meno si sa rebbe ottenuto qualora Malinowski avesse spinto il suo proget to fino ad affrontare il livello biologico. In questo caso il con tenuto culturale, la cui specificità sta nel suo senso, si perde in teramente in un discorso di “bisogni” privo di significato. Si è tentati di formulare una regola generale dei “ricorsi ridut tivi alla spiegazione funzionalista”: quanto più distante e separata è la pratica culturale dal registro della sua pretesa funzione, tan to meno questa funzione sarà in grado di specificare il fenomeno. La regola potrebbe essere concepita come un’espressione di co me opera 1’“autonomia relativa” dei diversi campi culturali (cerimoniale/economia), e in particolar modo dell’irriducibilità dell’ambito culturale ai livelli costitutivi di integrazione fenome nica (superorganico/organico). Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’origine complessiva dell’inadeguatezza delle spiegazioni che ri corrono alla funzione naturale, è riferibile con precisione alla valutatività insita nell’attività simbolica: è ancora la natura arbitraria del segno, che fissa la dimensione effettiva solo selettivamente, a sottoporre ciò che è naturale a una specifica logica culturale. Lucien Sebag lo dimostra in maniera convincente: per definizione, ogni rifrazione di una determinata realtà attra verso il linguaggio implica una perdita di informazione, potendo quel che viene abbandonato diventare a sua volta oggetto di un trattamento del medesimo tipo. L’attività linguistica appare dun que come uno sforzo continuo per sottomettere a un insieme di forme un dato che sempre supera il loro limite. Ma ciò non è proprio solo del linguaggio; la cultura, nella sua intierezza, è ap punto definibile nello stesso modo. La relazione del dato natu rale illumina ciò pienamente: si tratti della sessualità, dei ritmi del lo sviluppo corporale, della gamma delle sensazioni e degli affet ti, ogni società appare sottomessa a un principio di organizzazio ne, che non è mai il solo concepibile, una realtà che si presta a molteplici trasformazioni. Si comprende perciò come mai la spie gazione naturalistica sia sempre inadeguata; giacché l’essere dell’esigenza svelata al di qua delle diverse modulazioni culturali non può mai darci altro che l’abbozzo della forma stessa della cultura, mai il suo contenuto: e si tratta appunto di comprende re quest’ultimo. [Sebag, 1964, ed. it. pp. 159-160] È il contenuto a dover essere compreso. Questo è il nostro oggetto. Ma la pratica funzionalista, come abbiamo visto, con92
siste nel considerare mera apparenza le proprietà culturali. Il reale-concreto culturale diventa un astratto-apparente, una sem plice forma di comportamento assunta dalle forze più fondamentali dell’economia o della biologia. Sartre parla in un con testo analogo di “bagno di acido solforico”. Inoltre, poiché le presunte forze fondamentali sono in realtà astratte - sopravvi venza umana, bisogni umani e cosi via - all’astrazione del sim bolico proprio dell’oggetto si è assegnato, come complemento, la simbolizzazione di un’astrazione che appartiene all’antropo logo. La battuta di Sartre era rivolta a un certo marxismo di moda, soddisfatto di trascurare la logica propria di un “fatto sovrastrutturale”, quale u n ’opera d ’arte o un atto politico, e del le determinazioni specifiche del suo autore, a favore delle de terminazioni generali di classe e relative alla produzione. Da questa posizione di superiorità la poesia di Valéry è liquidata come una specie di “idealismo borghese”. La critica di Sartre sembra potersi applicare punto per punto alla classica pratica funzionalista: Il formalismo marxista è un impegno di eliminazione. Il metodo si identifica al Terrore per il suo rifiuto inflessibile di differenzia re, il suo fine è l’assimilazione totale al prezzo del minimo sforzo. Non si tratta di realizzare l’integrazione del diverso, in quanto ta le, conservandone l’autonomia relativa, ma di sopprimerlo... Le determinazioni specifiche destano nella teoria gli stessi sospetti delle persone nella realtà. Pensare, per la maggior parte dei marxi sti attuali, è pretendere di totalizzare, e, con tale pretesto, sosti tuire la particolarità con un universale; è pretendere di ricondurci al concreto e presentarci in tale forma determinazioni fondamentali ma astratte. [...] Il marxista crederebbe di perder tempo se tentasse, ad esempio, di capire un pensiero borghese nella sua originalità. Per lui importa soltanto dimostrare che è un modo delfidealismo. [...] Il marxista è dunque indotto a considerare apparenza il contenuto reale di un comportamento o d’un pen siero e, quando dissolve il particolare nell’universale, ha la sod disfazione di credere di ridurre l’apparenza a verità. [Sartre, 1960, ed. it. pp. 114-115] Nello stesso modo Malinowski ripetutamente dissolve l’ordi ne simbolico nell’acido della verità della ragione strumentale. Quale che fosse l’ambito culturale in discussione, il suo esame poteva avere inizio solo dopo averlo sbarazzato da ogni consi93
stenza simbolica. Si trattasse della parentela o del totemismo, del mito o della magia, della credenza negli spiriti o della si stemazione dei morti, fin anche dell’analisi del linguaggio stes so, il primo passo di Malinowski è sempre stato negare qualsia si logica interna, qualsiasi struttura significante, al fenomeno in sé (vedi, per esempio, le analisi in Magic, Science and Religion [1925]). Ne consegue che l’intellezione umana, la “speculazio ne”, come la giudica Malinowski, non può avere un ruolo co stitutivo. La consuetudine trova origine nella pratica, nella vita - nell’attività non del pensiero, ma dell’emozione e del desi derio, dell’istinto e del bisogno. Da questo punto di vista, era possibile sostenere che la natura suscitasse nel “selvaggio” uno scarso interesse, a parte quello dettato dalla fame, e non fosse aspetto di alcuna concezione oltre alla razionalizzazione di quel desiderio. Di qui la famosa affermazione di Malinowski sul fun zionamento mentale che emerge nelle classificazioni totemiche: “La strada dall’ambiente alla pancia del selvaggio, e quindi al la sua mente, è assai corta, e per lui il mondo è uno sfondo in differenziato contro cui spiccano le specie di animali o di pian te utili, soprattutto commestibili” (1925, ed. it. p. 53). Parimenti, “c’è solo un piccolo spazio per il simbolismo nelle sue idee e nei suoi racconti”. Quanto al mito, esso non è “una vana ra psodia... ma una forza culturale di estrema importanza”: Studiato dal vivo il mito [...] non è simbolico, è un’espressione diretta del suo contenuto materiale; non è una spiegazione fatta per soddisfare un interesse scientifico, è una ricostruzione narra tiva di una realtà primordiale, in cui si manifestano profondi bi sogni religiosi, desideri morali, subordinazioni sociali, sicurezze, perfino esigenze pratiche [ibid., p. 101]. Possiamo con sicurezza lasciare da parte ogni interpretazione esplicativa o simbolica di questi miti dell’origine. I personaggi e gli esseri sono ciò che ap paiono esternamente, non simboli di realtà nascoste. Qualsiasi fun zione esplicativa questi miti possano avere, non c’è problema che risolvano o curiosità che soddisfino, né teoria che contengano. [Ibid., p. 126] E questo è anche il famoso approccio di Malinowski alla lin gua. Con buona pace di Boas, la lingua non contiene teoria: non contiene nulla, e null’altro è che u n ’espressione verbale, “una ‘presa’ sulle cose”, il cui significato sta nell’effetto provo94
calo su chi ascolta. “Le parole sono parte dell’azione e sono equivalenti dell’azione” (Malinowski, 1935). E poiché le parole sono azioni, il significato è la reazione prodotta: le prime sono 10 stimolo, il secondo la risposta; l’uno è lo strumento, l’altro 11 suo prodotto: Il significato di una singola espressione, che in tali casi è spesso ridotta a una singola parola, può essere definito come il muta mento prodotto dal suono nel comportamento delle persone. Ciò che costituisce il significato e la maniera in cui un suono emesso in modo appropriato è correlato agli elementi spazio-temporali e ai movimenti corporei dell’uomo; e ciò è dovuto alla risposta cul turale prodotta dall’esercizio, o “condizionamento”, o educazione. Una parola è lo stimolo condizionante dell’azione umana e di venta, per cosi dire, una “presa” su cose che sono al di fuori del la portata del parlante, ma all’interno di quella di chi ascolta. [Ibid., p 59]19 È anche implicito che il significato è limitato all’esperienza a cui è connesso: cioè a un’originale referenza con funzione in dicativa, che rimane il concetto base di espressione nelle sue successive elaborazioni. Più che classificare l’esperienza, il lin guaggio per Malinowski è esso stesso ripartito dall’esperienza. Una parola è differenziata dall’altra quanto il contesto del mon do reale, in cui la prima è situata, è percettibilmente distingui bile dal contesto della seconda. “Il linguaggio nella sua struttu ra rispecchia le categorie reali derivate dagli atteggiamenti pra tici del bambino o dell’uomo primitivo o selvaggio verso l’am biente che lo circonda” (Malinowski, 1923, ed. it. p. 370). Que sta sorta di rifiuto definitivo del simbolico, della parola come categoria, conduce Malinowski ad alcuni errori grossolani. Uno è quello della “teoria degli omonimi”: dal momento che ogni riferimento, empiricamente distinto, di una data parola costi tuisce un significato distinto, Malinowski fu costretto a conclu dere che la “parola” in questione è in realtà un certo numero di parole differenti, una serie accidentale di omonimi.20 Se la situazione è questa, ovviamente, né parole né comunicazione co me noi le conosciamo, potrebbero esistere, nella misura in cui 1 contesti di due usi differenti della stessa parola non sono mai gli stessi; per cui ciascuno di tali suoni è una differente “unità” per ognuno degli altri - il che equivale a dire che non esisto95
no parole ma solo una miriade di fuggevoli segnali contestuali. Simili difficoltà sono poste dal fatto che due persone non pos sono mai avere esperienza della stessa realtà nell’identico mo do, se sono in un qualsiasi modo diverse esse stesse. Inoltre, poiché- “in definitiva ogni significato delle parole è derivato dall’esperienza corporea”, Malinowski avrebbe insistito sul fatto che anche i concetti più astratti, come quelli della scienza, in pratica derivano da luogo comune o prassi infantile. “Perfino il matematico puro, che ha a che fare con la branca più inutile e arrogante della sua disciplina, la teoria dei numeri, ne aveva avuto probabilmente una qualche esperienza contando i suoi penny e scellini o le sue caramelle e ciambelle” (1935, 2, p. 58). Malinowski qui trascura il fatto che il sistema numerico deve pre cedere il contare; ma questo è il genere di errori che egli fa sempre nelle sue argomentazioni ontogenetiche (come quelle sulla pratica di classificazione della parentela), confondendo il modo in cui l’individuo è integrato nel sistema sociale con la spiegazione - propriamente l’“origine” - del sistema (cfr. Mali nowski, 1930).21 Infine, il concetto di significato di Malinowski non è in grado di spiegare il suo progetto etnografico, che vo leva spiegare in termini funzionali il costume esotico. Infatti, poiché la forma apparente di questi usi è strana, o anche non funzionale, Malinowski non può farsi guidare dall’esperienza per la sua-'interpretazione; o per lo meno deve operare selettiva mente, inserendo in catégorie e valorizzando le attitudini ra zionali sovrapposte al comportamento irragionevole delle per sone, seguendo un principio che non emerge dall’incontro et nografico. Malinowski riteneva che la parola non incarni alcu na idea, che il suo significato, esterno, si trovi nei suoi effetti empirici. Ciò che un abitante delle Trobriand avrebbe dunque scritto, sarebbe stata proprio u n ’etnografia “del suono”, gene rata da una prolungata socializzazione nella vita di quelle isole. Ma se Malinowski deve “crearli”, bisogna che organizzi la sua esperienza etnografica per mezzo dei suoi concetti. E questo è quanto fa per sua stessa ammissione, pur se in contraddizione con il suo principio secondo il quale la parola non contiene al cuna idea: Non esiste alcunché di simile a una descrizione completamente priva di teoria. Sia che si ricostruisca un evento storico, si effettui 96
un’indagine sul terreno di una tribù selvaggia o in una comunità civilizzata [...] ogni giudizio e ogni argomento deve essere for mulato in parole, cioè in concetti. Ciascun concetto, a sua volta, è il risultato di una teoria che dichiara che alcuni fatti sono rile vanti e altri trascurabili, che alcuni fatti determinano il corso de gli eventi, e altri sono meramente fortuiti, che le cose accadono come accadono perché personalità, masse e agenti materiali dell’ambiente le producono. [Malinowski, 1944, ed. it. p. 17] Ricoeur osserva che nel caso estremo della parola come pras si, quello della “parola imperativa”, 1’“effetto” richiede la pre senza di esseri dotati di capacità di simbolizzare in un contesto dotato di un aspetto simbolico, poiché la “comprensione” in clude a un tempo un progetto e un sistema di valutazioni che rendono differenziato il mondo e le azioni degli uomini nel mondo.22 Si può fare la stessa osservazione da un altro punto di vista. E facile vedere, nell’interpretazione di Malinowski della lingua come lavoro e del significato come risposta provocata nell’ascoltatore, la stessa riduzione del soggetto umano all’og getto manipolato, caratteristica della sua tecnica etnografica. L’Altro, in questa concezione, è solo un mezzo per un fine, un materiale informe come qualsiasi altro su cui lavorare. Ma inol tre, insiste Ricoeur, la conseguenza dell’attenzione per il com portamento di un altro non è dello stesso genere del rapporto che c’è tra un attrezzo e la forma che questo dà a un oggetto; non è “prodotta” com’è prodotto un bene materiale (1955). Non solo perché l’Altro è un essere fornito di volontà come me, ma, in modo più determinante, perché la comunicazione implica una comunanza, e quindi la necessità di esercitare u n ’in fluenza sull’“effetto” di tutte le concezioni comuni su uomini e cose che, nell’ordinare le loro interrelazioni, determinano la specifica “influenza” della parola. L’eliminazione compiuta da Malinowski del simbolo e del si stema dalle pratiche culturali, questo cannibalismo esercitato dalla funzione sulla forma, costituisce u n ’epistemologia per l’eli minazione della cultura stessa come oggetto specifico dell’an tropologia. Privata delle sue proprietà distintive, la cultura non ha più titoli per essere analizzata come una cosa in sé. Il suo studio degenera in uno dei due naturalismi volgari: l’economi cismo dell’individuo razionalizzante (natura umana) e l’ecolo gismo del vantaggio selettivo (natura esterna). Malinowski ov97
viamente non può essere ritenuto responsabile di aver inventa to l’una o l’altra problematica, o di averle portate a pieno svi luppo; eppure la prima ha un posto preciso nella sua opera, mentre la seconda vi è prefigurata. L’economicismo, o utilita rismo, si sviluppa dalla distinzione che Malinowski fa tra norma culturale e atteggiamento soggettivo, e dalla subordinazione, nella sua teoria, dell’“ideale” a un interesse personale pragma tico - subordinazione che attribuisce a quest’ultimo la funzio ne di autentico operatore della vita sociale. Malinowski poteva “vedere le cose come le vedevano gli in digeni” purché, per cosi dire, si adattassero loro a vederle a mo do suo. Avrebbero dovuto essere propensi a u n ’analisi che va lutasse l’azione pratica al di sopra della norma culturale, e an cora, riguardo all’azione, l’interesse soggettivo al di sopra della forma esteriore. Secondo le nozioni di Malinowski, le regole so no una cosa e l’azione u n ’altra, e più autentica - le prime so no solamente espressione della “realtà” di quest’ultima, avendo le norme minori diritti all’esistenza e all’analisi di quanti ne ab bia un comportamento mosso da un illuminato interesse per sonale. Tuttavia l’atto - le “danze selvagge”, gli scambi kula di ornamenti che non possono essere posseduti - rimane peculia re nelle sue proprietà osservabili, e privilegiarlo rispetto alla re gola in nome dell’interesse razionale richiederebbe! una secon da distinzione: tra la forma esteriore, incoerente, e le attitudi ni pratiche che la gente vi immette. I dati più autentici dell’et nografia consistono non nei fatti dell’ordine culturale ma nel modo in cui quell’ordine è vissuto soggettivamente: i famosi “im ponderabili della vita quotidiana”. Gli antropologi, insiste Mali nowski, sono troppo spesso invischiati nelle dettagliate relazio ni che gli indigeni fanno su “finzioni legali” quali la solidarietà di clan, le regole dell’esogamia e simili, che rappresentano so lo 1’“aspetto intellettuale, pubblico, completamente convenzio nale dell’attitudine dell’indigeno”. Ma “il codice di condotta na turale, istintivo, le deviazioni, i compromessi e gli usi illegali so no rivelati solo a chi, lavorando sul campo, può osservare di rettamente la vita degli indigeni, registrare fatti, vivere a cosi stretto contatto con il loro “materiale” da comprenderne non solo la lingua e le espressioni, ma anche i motivi occulti del com portamento, e le linee di condotta che quasi mai vengono for mulate spontaneamente” (Malinowski, 1926, pp. 120-121). L’im98
portanza di questo “codice naturale, istintivo”, sta nel fatto che alla fine prevale su quello convenzionale: alla fine, la forma cul turale si sottomette alla prassi “spontanea”. “Il problema vero non è studiare come la vita umana si sottoponga a regole - per ché non è cosi: il problema vero è come le regole si adattino alla vita” (ibid., p. 127).23 Con questa separazione tra ordine culturale e soggetto uma no, analoga a quanto la finzione è separata dalla vita reale, Malinowski introduce una sorta di schizofrenia ontologica nell’et nologia, a cui tocca di essere il pensiero scientifico tipico del nostro tempo. La vita dell’uomo è presa e divisa contro la sua volontà tra due differenti specie di oggetti che stanno tra loro in rapporto di contrapposizione e competizione. Da una parte ci sono le regole convenzionali e le forme che costituiscono “la cultura” della situazione. Esse soltanto hanno diritto a questo status poiché esse soltanto sono definite da proprietà specificamente culturali: discendenza matrilineare, esogamia del clan, riti funebri, scambi di preziosi, produzione di patate dolci, pa rentela classificatoria. In teoria esse potrebbero essere compre se anche in questo modo; cioè secondo una logica a un tempo di significato e di azione, sviluppata a partire dagli attributi sim bolici - al modo in cui la valutazione dei beni e la divisione del lavoro, per esempio, possono essere riferiti alle classificazioni di parentela o agli usi matrimoniali. Ma f identificazione degli attributi culturali con la “norma” o con 1’“ideale” in contrap posizione con la “vita reale”, deve condannare come metafisico un tale sforzo. La cultura è piuttosto subordinata a u n ’altra lo gica - che se non ne preserva le proprietà simboliche, non è neppure in grado di spiegarle.24 All’opposto della norma cultu rale, dall’altra parte, c’è il “comportamento reale” della gente. E questo, in quanto specificamente umano, deve essere descritto e compreso in termini tratti da un altro universo di discorso: i bisogni della gente, le pulsioni, le motivazioni, i desideri, le emo zioni e i sentimenti. A questo punto, in una sorta di ribalta mento totale dei principi di Durkheim, seppure ancora in ac cordo con la premessa che “l’uomo è duplice”, Malinowski spo sta la dinamica sociale a livello del naturale, cercando di spie garla con le forze che promanano dall’interno dell’organismo. Dobbiamo occuparci delia lotta del soggetto individuale per rag giungere i suoi scopi di fronte alle contrastanti convenzioni cul99
turali. L’analisi del significato in questo modo si arrende di fron te alla razionalità trasformatrice, all’analisi formale delle rela zioni mezzi/fìni, basate sull’eterna teleologia della soddisfazio ne umana. Da questo punto di vista, la cultura appare come sem plice medium o come ambiente della dinamica costitutiva dello scopo dell’uomo. E medium nel senso di un complesso di mez zi a disposizione del soggetto, attraverso il quale raggiunge i fi ni che egli stesso si pone. Ed è ambiente non soltanto come complesso di costrizioni esterne all’individuo, ma come qualcosa su cui egli fa operare le sue intenzioni, attribuendo cosi un or dine alle caratteristiche di tale ambiente.25 Cosi concepita, l’in terazione tra “vita” e “cultura” è necessariamente squilibrata: la direzione del rapporto è da soggetto a oggetto, da attivo a pas sivo, da costituente a costituito. Agendo con l’unica preoccu pazione di massimizzare i propri interessi, la gente formula e riformula il suo ordine culturale (cfr. Firth, 1963). Ma l’effica cia della cultura come ordine significante è in tal modo sospe sa. La cultura è ridotta a un epifenomeno di intenzionali “pro cessi decisionali”. Questa espressione non è, ovviamente, di Malinowski, ma sta bilisce un preciso rapporto con l’attuale scienza sociale. L’as siomatica adozione della problematica del soggetto calcolatore, che ordina il mondo sociale razionalmente secondo desideri ugualmente assiomatici, questo utilitarismo rappresenta la co scienza istintiva che abbiamo degli altri come di noi stessi. Mol ti di quelli che potrebbero criticare il funzionalismo di Mali nowski, sono ciò nonostante soddisfatti della sua fondamentale contrapposizione tra interessi personali e ordine sociale (per esempio, Jarvie 1964; Kuper 1973; o anche Wolf 1964). E vero che Malinowski è stato il primo antropologo a negare l’univer salità dell’“uomo economico” (1921; 1922). Ma questo non si gnificava forse semplicemente dare allo stesso concetto un cam po ancor più grande? “Nelle pagine sugli Argonauti e in quel le successive,” aveva scritto Leach, “il ‘selvaggio’ cessa di essere una marionetta. [...] E un essere umano vivente che mette in opera un bizzarro sistema di organizzazione sociale esercitando scelte naturali tra mezzi alternativi per alternativi fini” (1957, p. 127). Nello stesso spirito Bateson giudicava che il metodo funzionalista di Malinowski “è probabilmente completo, e nella sua ricerca accurata potrebbe produrre un sistema antropologico 100
coerente, alleato ai sistemi economici basati sull’‘uomo calcola tore’” (1958, p. 27). Infatti, come Malinowski stesso riferi, “Ogni qualvolta l’indigeno ha l’opportunità di evadere i suoi obblighi senza perdere prestigio, o senza la prospettiva di rimetterci, lo fa, esattamente come farebbe un uomo d’affari civile” (1926, p. 30). L’ottica in questione è ancora quella delle attività economizzatrici del privato nel mercato, qui trasposta dall’analisi dell’economia borghese alla spiegazione della società umana. Lo spazio analitico cosi lasciato alla società è stato brillantemente descritto da Dumont: Nella società moderna [...] l’Essere Umano è visto come l’uomo indivisibile, “elementare”, insieme essere biologico e soggetto pen sante. Ogni uomo particolare in un certo senso incarna l’intera umanità. E la misura di tutte le cose (in un senso pieno e rin novato). Il regno dei fini coincide con i fini legittimi di ogni uo mo, cosi che i valori subiscono una rotazione dall’alto in basso. Ciò che è ancora chiamato “società” sono i mezzi, la vita di ogni singolo uomo è il fine. Ontologicamente la società non esiste più, non è che un dato irriducibile, che in nessun modo deve ostaco lare le esigenze di libertà e di uguaglianza. Naturalmente, quan to precede è una descrizione di valori, un’ottica mentale [...] Una società come è concepita dall’individualismo non è mai esistita in nessun luogo per le ragioni che abbiamo portato, e cioè per il fatto che l’individuo vive su idee sociali. [Dumont, 1966, pp. 9-10; per altre importanti discussioni sull’utilitarismo (economicismo, individualismo) vedi Dumont, 1965; Macpherson 1962; Parsons, 1937; Polanyi, 1944] La separazione economicista della struttura normativa dall’azione pragmatica, se non bandisce interamente la cultura dalla sfera antropologica, la impoverisce riducendola allo stato di interesse secondario. Solo accennati da Malinowski, questi effetti appaiono molto più chiaramente in u n '“antropologia eco logica” che rende omaggio alle sue origini intellettuali qualifi candosi come “funzionalista” o “neofunzionalista” (cfr. Collins e Vayda, 1969). Ma, come giustamente disse Marx, la chiave dell’anatomia della scimmia sta nell’anatomia dell’uomo. Il si stema economico più sviluppato distingue nettamente catego rie che nei sistemi meno sviluppati rimangono indifferenziate, ambigue, e solo potenziali. Nello stesso modo, le implicazioni 101
adombrate in una data prospettiva intellettuale diventano espli cite solo nelle versioni più evolute. Il nuovo funzionalismo eco logico dimostra che l’effetto dell’operazione con cui Malinowski riduce il contesto culturale alla funzione biologica, e in par ticolare il contesto simbolico alla funzione strumentale, rap presenta una “soluzione finale” per il problema della cultura. Infatti diventa esplicito che la cultura non richiede alcuna in terpretazione speciale, distinta cioè dalla spiegazione biologica. Se questo accade, la cultura sparisce. Come nel funzionalismo di Malinowski, il processo dipende dall’appropriazione teoretica delle qualità culturali come effetti organici: un trasferimento che non solo dissolve le specificazio ni culturali ma permette loro di ricomparire in forma più scien tifica (quantificabile). La spiegazione di Rappaport è questa: Mentre le domande riguardano i fenomeni culturali, le risposte vengono date in termini di effetti del comportamento, culturalmente organizzato, sui sistemi biologici: organismi, popolazioni ed ecosistemi. La caratteri
stica peculiare dell’antropologia ecologica non è solo che prende in considerazione i fattori ambientali cercando di spiegare i fe nomeni culturali, ma anche che dà un significato biologico ai ter mini chiave - adattamento, omeostasi, funzione di adeguamento, sopravvivenza - delle sue formulazioni. [1971, p. 243] La pratica teoretica si potrebbe chiamare “feticismo dell’eco logia”. Niente nella cultura è ciò che sembra; tutto è travestito da fatto naturale che ha l’apparente capacità di essere fondamentale ed esatto pur essendo essenzialmente astratto. Il ma trimonio diventa un “interscambio di materiale genetico”, men tre la caccia è un “interscambio di energia con l’ambiente”, granturco, fagioli e frutti di squash sono una “dieta non equi librata”, la società una “popolazione” di organismi umani, e il cannibalismo un’“attività di sussistenza”. (“Studiando il canni balismo siamo partiti dalla premessa che tutte le attività che rendono utilizzabile il cibo da parte dei membri del gruppo cibo effettivamente da essi consumato - sono ‘attività di sussi stenza’ e che possono dunque essere considerate individual mente e /o prese insieme come attività costituenti un reperto rio comportamentale complessivo denominato ‘modello del procacciarsi-cibo’” [Dornstreich e Morren, 1974, p. 3],) Lo stesso modo di pensare applicato alla scoperta dei valori igienici dei 102
tabù alimentari, è stato chiamato dalla Douglas (1966) “mate rialismo medico”. E solo una particolare versione antropologi ca o ecologica dell’abitudine di scambiare il contenuto signifi cativo per verità funzionale, che Sartre definiva marxismo vol gare.26 Questo meschino commercio metafìsico di dettagli et nografici non avrebbe nessun interesse se non fosse per la sua dichiarata intenzione di rappresentare il concetto di cultura. Malinowski opponeva “cultura” a comportamento; per l’eco logia quella è “comportamento”. Può essere comportamento ap preso, ma non per questo merita un trattamento diverso dal “comportamento specifico della specie” di ogni altro gruppo di organismi. Si può pensare a esso come un “repertorio cultura le” (Collins e Vayda 1969, p. 155). Cosi interpretato, il feno meno come tale non distingue l’uomo da ogni altra specie, né l’antropologia dalla biologia. Come “comportamento” o, anco ra più astratto, come “movimenti corporei” - la cultura può es sere studiata allo stesso modo delle azioni di .ogni animale, os sia come bene per la specie o male per lui, sotto le condizioni selettive quali si sono naturalmente costituite: L’attenzione verso le idee, i valori o i concetti culturali non può, comunque, essere considerata una condicio sine qua non dell’ana lisi degli ecosistemi che comprendono l’uomo. Si può scegliere di porre l’accento piuttosto sul comportamento effettivo fisico o sui movimenti corporei con cui l’uomo modifica direttamente il suo ambiente. [...] Invero, un approccio possibile, come suggerisce Simpson [...] tra gli altri, è considerare la cultura umana semplicemente come il com portamento, o parte del comportamento, di una particolare specie di pri mati. Da quest’ottica, noi siamo messi in grado di studiarla e in terpretarla come facciamo col comportamento di ogni altra spe cie: per esempio, non solo rispetto alla sua interazione con le va riabili ambientali, ma anche rispetto agli effetti di questa intera zione sulla selezione naturale. Il fatto che il comportamento umano sia complesso, vario, variabile e, in misura considerevole, specifico della popolazione, può rendere l’osservazione e la de scrizione un compito improbo, ma ciò non vuol dire che nello stu dio del comportamento umano debbano essere usati principi so stanzialmente diversi da quelli usati per le altre specie animali. [Vayda, 1965, p. 4; corsivi miei] Il funzionalismo ecologico mette la cultura due volte in pe ricolo. È minacciata di estinzione da un lato perché non può 103
essere definita come tale da ragioni naturali; e dall’altro per ché il riconoscimento della sua qualità specifica porterebbe a una ragione di natura diversa. La crisi cosi diventa di propor zioni ontologiche. La cultura è scambiata per “comportamento”. Le sue qualità concrete sono solo l’apparenza di “movimenti cor porei” la cui scienza deve volgersi all’effetto biologico che pro ducono. L’ontologia in tal modo riepiloga la metodologia. E l’antropologia smarrisce il suo oggetto. Si presume che le pro prietà della cultura, ignorate nel corso della sua spiegazione, non abbiano autonomia o validità di per sé - ma si tratta di una razionalizzazione del fatto che la spiegazione non può es sere utilizzata per loro: Parrebbe che una scienza unificata dell’ecologia abbia dei con tributi specifici da portare alla realizzazione degli obiettivi dell’an tropologia e non comporti alcun apprezzabile sacrificio dei tra dizionali interessi antropologici. Tuttavia può comportare un sa crificio di diverso genere, della nozione, cioè, dell’autonomia del la scienza della cultura. [Vayda e Rappaport, 1967, p. 497] Questo sacrificio dell’autonomia della cultura (e della scien za della cultura) sarebbe la conseguenza della sua subordina zione all’interno di un più ampio sistema di costrizione natu rale. Nella misura in cui quest’ultimo è concepito come un or dine cibernetico, come spesso accade negli studi ecologici, che include la cultura in una “scienza unificata”, comporterebbe an che il trasferimento della proprietà della “mente” dal genere umano all’ecosistema. In quanto sistema autoregolantesi di re lazioni termodinamiche, sensibile all’“informazione” o altera zione significante dei suoi componenti, l’ecosistema nel suo in sieme è ora il luogo di u n ’“attività mentale” che deve logica mente (nell’interesse dell’autorità suprema di Behemoth) esse re negata in ogni sua singola parte. Un simile sistema è cosi spie gato da Bateson: “Si può affermare che qualunque insieme dinamico di eventi e oggetd che possegga circuid causali op portunamente complessi e in cui vigano relazioni energetiche opportune, mostrerà sicuramente caratteristiche proprie della mente. Tale insieme eseguirà confronti, sarà cioè sensibile alla differenza [...] ‘elaborerà l’informazione’ e sarà inevitabilmente autocorrettivo, o in direzione delTottimalità omeostatica ovvero 104
in direzione della massimizzazione di certe variabili” (1972, ed. it. p. 346). Chiaramente, se ognuno dei componenti di questo sistema autoregolantesi fosse in grado di imporre il proprio pro getto alla totalità, il sistema si ridurrebbe a una catena di con seguenze, governata solo in negativo dai limiti della possibilità di funzionamento. Quindi, per preservare il sistema, la mente può essere proprietà solo dell’insieme: “Quindi non è possibile che in un sistema che manifesti caratteristiche mentali una qual che parte possa esercitare un controllo unilaterale sopra il tut to. In altre parole, le caratteristiche mentali del sistema sono imma nenti non in qualche sua parte, ma nel sistema come totalità” (ibid., ed. it. p. 347). All’interno dell’ecosistema, il centro dell’interazione o subsi stema che circoscrive l’uomo e il suo ambiente immediato, sa rebbe caratterizzato da relazioni di feedback reciproche ed equi librate quanto quelle tra tutti gli altri elementi del circuito, ben ché il rapporto uomo-natura sia mediato dalla cultura. La cul tura in questo contesto è solo l’automediazione della natura. È solo il modo di rispondere dell’uomo, e perciò è sistematicamente controllato: nella misura in cui l’uomo non è che una variabile funzionale del sistema - un componente reattivo, nel le reciproche determinazioni, con le variabili ambientali, a lo ro volta soggette al loro oggetto, e viceversa. Uno degli esempi preferiti di Bateson è quello dell’interazione tra uomo e pian ta nell’abbattimento di un albero: Si consideri un individuo che stia abbattendo un albero con un’ascia; ogni colpo d ’ascia è modificato o corretto secondo la for ma dell’intaccatura lasciata nell’albero dal colpo precedente. Que sto procedimento autocorrettivo (cioè mentale) è attuato da un sistema totale, albero-occhi-cervello-muscoli-ascia-colpo-albero; ed è questo sistema totale che ha caratteristiche di mente immanente. [Ibid., ed. it. p. 349]
Il problema è che non succede mai che gli uomini sempli cemente “abbattano alberi” come tali. Tagliano tronchi per far ne canoe, incidono figure di divinità su mazze di guerra, o an che fanno legna per il fuoco, ma entrano sempre in relazione con il legno in un modo specifico, un modo culturale, secon do un progetto significativo la cui finalità definisce i termini dell’interazione reciproca tra uomo e albero. Se lo scopo è una 105
canoa, la risposta a una modificazione dell’albero è diversa da quando il fine è procurarsi legna da ardere. La risposta al col po precedente dipende da un obiettivo che non è dato all’ope razione come un processo naturale; quel colpo, e ogni colpo prima di quello fino al colpo iniziale, dipendono dall’intenzio ne significativa. L’interazione determinata di albero-occhio-cervello-ecc. è stata istituita grazie a un ordine simbolico; è un esempio modello della natura imbrigliata al servizio della cul tura. L’alternativa cibernetica prevista dalla teoria dell’ecosiste ma, è un estremo feticismo ecologico, perfettamente adeguato al contesto culturale che le è proprio - il capitalismo industriale e burocratico - il cui progetto ugualmente consiste nel ridurre uomini e cose alle loro specificazioni funzionali come elemen ti di un processo produttivo autodeterminantesi.27 G.P. Murdock
Il fine del “terrore” è la morte della cultura aristocratica. In George Peter Murdock l’antropologia forse ha già trovato il suo Robespierre. Murdock trovò l’occasione adatta per annunciare il decesso della cultura alla conferenza in ricordo di Huxley nel 1971. È interessante notare in che modo sia giunto, alla fine, a questo grado di autocoscienza metodologica. L’argomento cen trale della sua Social Structure (1949) aveva già ripetuto in tutti gli elementi essenziali l’interpretazione di Morgan sulle relazioni tra circostanza pratica, azione utilitaria e ordine culturale. Murdock probabilmente è stato il primo a dissentire da Morgan, sia sulla so stanza del metodo che sui particolari dell’interpretazione; ma la sua visione della struttura sociale è sulla stessa linea della teoria della prassi. Per Murdock la formazione di “gruppi di parentela consanguinea” - e di conseguenza la classificazione dei congiun ti - equivale al reperimento sul terreno di sistemazioni di fatto, di rapporti di parentela depositatisi da pratiche residenziali, rispon denti a loro volta a esigenze concrete. La pratica residenziale vie ne cosi a essere la chiave dinamica. La determinazione della com posizione reale di raggruppamenti sociali gioca nello schema di Murdock un ruolo analogo a quello che avevano le unioni esogamiche nei primi stadi dello schema di Morgan: rappresenta il mezzo con cui la costrizione oggettiva o naturale è concretizzata in forma culturale. Le relazioni di parentela sono costituite dalla 106
coscienza riflessa della composizione del gruppo cosi stabilita. Es se sono chiaramente l’espressione degli assestamenti residenzia li, e gli assestamenti residenziali a loro volta riflettono le “condi zioni fondamentali di vita”: In tutte le società le condizioni di esistenza sono sempre in cor so di mutamento, talvolta rapido, talvolta lento: in conseguenza di eventi naturali come le carestie e le epidemie, di eventi socia li come le guerre e le rivoluzioni, delle influenze biologiche co me l’accresciuta densità demografica, di adattamenti interni co me le invenzioni tecnologiche e di contatti esterni che possono stimolare il trapianto culturale. Molti mutamenti delle condizioni fondamentali di vita possono esercitare una pressione verso una modifica della regola di residenza. Cosi diversi sono i fattori cau sali del mutamento sociale, e cosi poche sono le alternative nel campo delle regole di residenza, che quasi ogni società, qualun que sia il suo livello di cultura e le forme esistenti di organizza zione sociale, ha la probabilità di incontrare delle particolari con catenazioni di circostanze che favoriscono lo sviluppo a turno di ciascuna delle regole alternative di residenza. [Murdock 1949, ed. it. pp. 173-174] Così, per esempio, La residenza patrilocale sembra essere promossa da tutti i muta menti nella cultura o nelle condizioni di vita che accrescono in modo rilevante lo status, l’importanza e l’influenza degli uomini in rapporto al sesso opposto. Particolarmente importante è ogni modifica nell’economia di base, per cui le attività maschili nella divisione del lavoro per sesso finiscono per offrire i mezzi princi pali di sussistenza. [Ibid., ed. it. p. 176] Tali pratiche residenziali danno origine agli schieramenti spe cifici dei parenti,28 il “riconoscimento” dei quali - riconoscimen to che può essere rifiutato - istituisce gruppi di parentela quali i lignaggi e le classificazioni consuetudinarie delle persone: La residenza unilocale non produce direttamente i lignaggi o sib. Favorisce soltanto lo sviluppo di famiglie estese e di demi esogamici con il loro caratteristico schieramento unilineare di parenti, e gli uni o le altre possono a loro volta portare al riconoscimento di grup pi parentali non localizzati. Ciò cui pervengono la residenza matrilocale e quella patrilocale è di riunire fra loro in prossimità spazia107
le un gruppo di parenti dello stesso sesso connessi unilinearmente, insieme con i loro coniugi. [Ibid., ed. it. p. 179] Murdock riassume l’intero argomento in una storia indiscus sa dello sviluppo di un sistema patrilocale-patrilineare da una organizzazione dualista di clan matrilineari. L’esempio è im portantissimo da diversi punti di vista, e forse non viene da ul timo il fatto che Murdock è portato a dare la sua spiegazione sotto forma di mito di origine. Allo stesso tempo il metodo di Morgan ne esce indenne, non solo in generale, ma nei parti colari dello sviluppo della discendenza patrilineare da quella matrilineare (sebbene, è ovvio, Murdock non ritenga che que sta sia stata una successione evolutiva valida universalmente). Più tardi nella storia, compaiono entro la situazione matrilineare fat tori che “premiano la residenza patrilocale”, come l’introdu zione del bestiame (lo stesso “fattore” di Morgan), degli schia vi o delle conchiglie come moneta, insieme alla nozione che il prestigio aumenta con la poligamia (ibid., ed. it. p. 186). Ora un uomo dopo l’altro, “man mano che acquisisce ricchezza”,29 è in grado, con l’offerta di un prezzo della sposa, di convince re altri uomini a permettere alle loro figlie di trasferirsi in ca sa sua. E un uomo dopo l’altro comincia a lasciare parte della sua proprietà ai propri figli. Cosi “pezzetto a pezzetto” i legami con la “stirpe patrilineare” sono rinforzati a spese di quella “ma trilineare” finché la gente infine scopre di aver parlato di di scendenza patrilineare senza saperlo: Prima quasi che la popolazione del villaggio si renda conto che è cambiato qualcosa di particolarmente importante, si scopre che le case da un lato della strada sono occupate adesso dai maschi imparentati patrilinearmente insieme con le loro mogli e i loro figli e che un gruppo simile abita dall’altra parte della strada. La residenza patrilocale è ormai fermamente accettata e cosi la suc cessione ereditaria patrilineare, e i precedenti matri-clan sono sta ti trasformati in patri-clan incipienti. La situazione è matura per lo sviluppo della discendenza patrilineare, fatto che può produr si abbastanza rapidamente se ci sono delle società patrilineari nel le vicinanze che possano servire da modello. [Ibid., ed. it p. 185] La posizione fondamentale di Murdock può essere illustrata in un altro modo da un classico disaccordo con Leach, in cui 108
la concezione di Murdock della relazione tra l’ordine vissuto e l’ordine pensato emerge con chiarezza dall’incomprensione. In un certo senso l’errore di Murdock era fondato, poiché egli con siderava una deviazione dal paradigma strutturale-funzionale, analogo a quello da lui stesso adottato, la preminenza data da Leach alla scelta individuale rispetto alla regola giuridica.30 Ri ferendosi al villaggio singalese di Pul Eliya, Leach aveva detto: “Le strutture sociali a volte sono meglio comprese come risul tato statistico di una molteplicità di scelte individuali che come riflesso diretto di regole giuridiche” (1960, p. 124). Per Mur dock dunque era del tutto logico trovarsi d’accordo con Leach - capovolgendo il senso dell’affermazione nell’idea che le re gole giuridiche sono meglio comprese come il risultato di una tendenza statistica nella scelta individuale (Murdock, 1960, p. 9). Questo è quanto doveva affermare almeno dal 1949. E nel 1971 la logica conclusione gli si mostrò. Quell’anno, davanti agli antropologi riuniti di Gran Bretagna e Irlanda, in un contesto la cui irrilevanza scientifica era pari solo alla sua solennità, Murdock rinunciò all’adesione ai concetti di “cultu ra” e “sistema sociale”. Questi, come egli disse, non sono che “illusorie astrazioni concettuali” dei “concretissimi fenomeni” dell’interazione degli individui tra loro e con l’ambiente nella realizzazione dei loro interessi. Murdock era diventato infine conscio della teoria che si celava nella sua pratica. Questa nuo va concezione della cultura non era nient’altro che un’“illuso ria astrazione concettuale” del metodo che aveva sempre usato: Adesso mi pare dolorosamente ovvio che la cultura, il sistema so ciale, e tutti i similari concetti superindividuali, come la rappresen tazione collettiva, lo spirito di gruppo e l’organismo sociale, sono il lusorie astrazioni concettuali desunte dall’osservazione dei concre tissimi fenomeni dell’interazione degli individui tra loro e con il lo ro ambiente naturale. Le circostanze della loro interazione presen tano spesso delle somiglianze nel comportamento di individui diversi, somiglianze che noi siamo portati a reificare col nome di cultura; esse, inoltre, fanno in modo che gli individui si pongano nei confronti degli altri in modi ripetitivi, che noi siamo portati a reifi care come strutture o sistemi. Ma la cultura e la struttura sociale so no in realtà meri epifenomeni prodotti derivati dall’interazione so ciale di pluralità di individui. [Murdock, 1972, p. 19] 109
Non bisogna dedurre, però, che una tale derivazione dell’on tologia dalla metodologia costituisca u n ’eccezione, almeno per le scienze sociali, alla nostra tesi generale che il concetto non deriva dalla pratica. L’apparenza empirica dell’affermazione che la cultura è 1’“epifenomeno” di un’altra realtà è essa stessa u n ’il lusione. Ciò che era celato all’interno del metodo, e che emer ge qui come la vera origine dell’affermazione, è la società bor ghese. Quindi Murdock non fa che effettuare per l’antropolo gia lo stesso genere di riduzione solipsistica che Max Weber ave va cercato di applicare alla sociologia, con la stessa sospensio ne del concetto di collettivo, o di oggettivato, in favore delle intenzioni individuali. Oppure consideriamo la nozione che Murdock avrebbe in seguito messo al posto della cosiddetta cul tura, e cioè, secondo la definizione di Frederick Barth, “l’ap proccio decisionale allo studio dei fenomeni sociali”, un ap proccio che “mette a fuoco gli eventi della vita sociale più che la sua configurazione morfologica o statistica, e considera il com portamento sociale dal punto di vista delle decisioni prese da gli individui nella ‘distribuzione di tempo e di risorse’ fra le al ternative a loro disposizione” (ibid., pp. 22-2S). L’anatomia dell’uomo e della scimmia: il paradigma definitivo di Murdock è una forma evoluta di quello implicito nel funzionalismo di Malinowski - anche se qui l’incrocio delle linee filogenetiche è più complesso, poiché, come dice Kuper del modello di Barth, “la visione di Radcliffe-Brown della struttura sociale come rete di reali relazioni bivalenti è diventata, ironia della sorte, la salvez za dell’uomo manipolatore di Malinoswki” (1973, p. 230). Ma l’“uomo manipolatore” rivela la comune discendenza di tutte le teorie utilitarie. L’idea generale di vita sociale qui proposta è il particolare comportamento delle parti nel mercato. Ora tutto ciò che è parte della cultura è inteso come l’effetto originario del risparmio sistematico dell’individuo. La cultura è “gli affa ri” su scala sociale. Il concetto di cultura di Murdock non è una lezione che viene dall’esperienza antropologica: il concetto an tropologico è già un’esperienza culturale. E, in più, questa conclusione, tratta dall’“esperienza”, che la cultura non esiste, è una duplice illusione. Essa infatti prende come modello di tutta la vita sociale non la realtà della società borghese, ma il concetto che questa società ha di sé. Crede che l’apparenza della cultura occidentale sia la sua verità, alimen110
tando in tal modo l’illusione che questa sia veramente il pro dotto socializzato dell’attività pratica senza tener conto della consistenza simbolica dell’attività pratica. La scienza sociale sol leva a livello di principio teoretico ciò che la società borghese produce come ideologia operativa. La cultura è dunque mi nacciata da u n ’incuria nel campo dell’antropologia pari soltan to alla consapevolezza che di essa ha la società. E in qualche modo consolante pensare che nella linea della teoria della prassi iniziata da Julian Steward questa incuria ab bia prodotto un po’ di rammarico. Julian Steward
La prospettiva di Steward fondata sull’“ecologia culturale” è in linea generale la stessa della problematica aculturale di Mor gan, e nei dettagli del suo articolo-manifesto sulle bande patrilineari (1936) corrisponde precisamente all’idea di Murdock di struttura sociale. Cosi non varrebbe la pena di esporla se non fosse per il contesto paradossale in cui Steward, e più tardi Murphy (1970), situa la sua ecologia culturale in opposizione a quella biologica. Il paradosso è istrutdvo. La sua risoluzione mo strerà come il travestimento della logica culturale da a priori dell’azione economica attribuisca alla logica pratica la funzione di determinare la forma culturale. Nel preambolo alla sua principale discussione ecologica sul le “bande primitive”, Steward in un modo o nell’altro si dedica alle principali condizioni tecniche e sociali dei cacciatori e dei raccoglitori - riferendo alcune di queste al vantaggio economi co, altre alla natura umana e altre ancora semplicemente al fat to empirico. La proprietà del territorio è interpretabile sulla ba se del fatto che “ogni animale può assicurarsi cibo e acqua più efficacemente in un territorio che utilizza abitualmente”; i grup pi familiari si spiegano sulla base di “una eccitabilità sessuale cronica” nella specie umana; e la banda di famiglie col fatto che “praticamente in tutti i gruppi umani cooperano diverse fa miglie. [...] Questo fornisce una specie di assicurazione di sus sistenza” (Steward, 1936, p. 332). I principali rapporti di pro duzione - la divisione del lavoro secondo il sesso - vengono am messi per la loro empirica diffusione generale fra i cacciatori. In questo modo è posta anche la semplice tecnologia, non solo co lli
me insieme di strumenti in sé, ma come insieme-di scopi lapa lissiani: procurarsi la “sussistenza”. Questa tecnologia è dispiegata in aree di limitate risorse di cibo; per cui i cacciatori sono in grado di aggregarsi solo in piccole bande, dalle venti alle cin quanta persone, e hanno una bassa densità di popolazione. Da queste condizioni l’argomentazione si sviluppa determi nando le varie forme di banda: “patrilineare”, “matrilineare” e “mista”. Come nell’analisi di Murdock, il legame critico tra am biente e struttura sociale è la pratica residenziale. Steward si con centra sul tipo più diffuso di banda, quella patrilineare, che egli vede come la formalizzazione della residenza patrilocale. Nella prima versione dello studio (1936) la patrilocalità è giustificata dall’innato predominio maschile e dall’importanza economica degli uomini nelle culture di caccia (p. 333). In una versione successiva, la patrilocalità è riferita in particolare ai suoi vantaggi economici in aree in cui le risorse animali sono scarse ma stan ziali: “un ambiente in cui il principale alimento è una selvaggi na dispersa e non migrante, rende vantaggioso per gli uomini rimanere nel territorio in cui sono nati” (1955, p. 135). Con la patrilocalità cosi stabilita sulla base dei suoi vantaggi economi ci, la struttura della banda segue come riconoscimento e articolazione - secondo un modello che ci è ormai familiare. La residenza patrilocale deve aggregare parenti “patrilineari”. Per cui il tabù dell’incesto è imposto a livello di banda, e il grup po è organizzato come lignaggio paterno esogamico. Riassu mendo in termini generali: in un complesso di circostanze tec niche e ambientali dato, l’efficacia economica richiede deter minate pratiche e relazioni sociali (residenza patrilocale) che so no a loro volta formulate e codificate come struttura sociale (banda patrilineare). Puro Morgan.31 E anche pura praxis. Infatti sono specificamente i “modelli di comportamento del lavoro”, quali sono “richiesti” dal conte sto ecologico, a essere realizzati in forma culturale. Murphy il lustra la prospettiva di Steward: L’ambiente per sé non è il fattore critico: gli elementi chiave so no i “modelli di comportamento” richiesti per la sua utilizzazione con l’uso di determinati “espedienti economici”. Questi modelli di comportamento sono il lavoro, e gli “espedienti economici” la tecnologia. Molto semplicemente, la teoria dell’ecologia cultura l i
le è connessa con il processo lavorativo, la sua organizzazione, i suoi cicli e ritmi e le sue modalità [1970, p. 155]. I modelli di lavoro sono direttamente derivati dagli attrezzi e dalle ri sorse a cui sono applicati, e questi due fattori servono a limitare le attività umane a cui si riferiscono. [...] Ed è dall'analisi dell'atti vità, piu che delle istituzioni e dei valori, che la teoria è derivata. Queste attività sono quelle che attengono al ciclo di lavoro e da esse emerge la struttura della società shoshone [p. 156], II punto che voglio sottolineare è che il regno dell’azione so ciale insito nella produzione materiale, e cioè il lavoro, è alla ba se dell’intero sistema sociale shoshone. Le risorse sono l’obietti vo del lavoro, e qui sta la loro importanza per la comprensione della società e della cultura. [...] Come obiettivi del lavoro, esse hanno determinate caratteristiche immodificabili a cui il lavoro deve adattarsi perché si rendano accessibili all’utilizzazione. Gli attrezzi debbono la loro posizione centrale nell’analisi della so cietà al fatto di essere strumenti e mediatori di lavoro. L’uso di attrezzi richiede determinati modi di comportamento, e l’applicazio ne di questi strumenti ai materiali provoca successivi adattamen ti nel comportamento [p. 157], La teoria e il metodo dell’ecologia culturale non è una sorta di determinismo ambientale, e non è neppure centrata partico larmente sull’ambiente. E una teoria culturale, senza essere “cul turologica” o “superorganica”. Inoltre è una teoria dell’azione, nel senso che il termine ha in sociologia. Pur riconoscendo che il comportamento è in buona parte regolato da norme, l’ecolo gia culturale vede anche le norme soprattutto come derivate dall’azione sociale e come cristallizzazione del comportamento che, a sua volta, con serva questi modelli di comportamento [...]. Strumenti e risorse richiedono [corsivo di Murphy] un certo tipo di comportamento se sono stati efficacemente integrati, e tali richieste, che derivano dal processo lavorativo, pongono ulteriori domande alla struttura sociale generale, [p. 163; tutti i corsivi sono miei tranne dove di versamente specificato]’2 Murphy continua la sua appassionata perorazione a favore di questa “ecologia culturale” e contro le riduzioni biologiche del la “nuova ecologia” (che si incarnerebbe in Vayda, Sweet e Leeds).33 Ma la difesa non è senza contraddizione, e in ultima analisi è difficile distinguere le due posizioni se non per le sfu mature sentimentali. Secondo Murphy, Steward vedeva la società come un modo caratteristico di integrazione, e come tale non soggetta alla na113
tura. Ordinata da idee e attività, la società gode di una relativa autonomia. Ma, per esporre la contraddizione in due parole, le idee sono idee sulle azioni, mentre la ragione propria delle azio ni è l’efficacia pratica nelle circostanze date, Cbsi che il princi pio dell’ordine culturale rimane quello naturale del vantaggio adattivo. Come osserva anche Murphy nel passo citato, la teoria di Steward si sofferma sull’attività del lavoro “più che sulle isti tuzioni o sui valori”. Queste istituzioni e questi valori, d ’altron de, non organizzano le connessioni umane con la natura ma fan no il loro ingresso sulla scena post festum sotto forma di cristal lizzazione di relazioni che sono state poste nella situazione di la voro. D’altra parte i modelli di lavoro sono “derivati direttamente da attrezzi e risorse”; e lo sono in quanto sono “richiesti” per l’effettiva integrazione di attrezzi e risorse nel processo produt tivo (cfr. Steward, 1938, pp. 260-61). Tutto dunque conduce al la nozione di “richiesta”; e la “richiesta” in questione è quella puramente oggettiva dell’affrontare con successo l’ambiente. Le conclusioni di Murphy sui rapporti tra cultura e natura sono esat te, ma purtroppo non pertinenti all’ecologia stewardiana: I fenomeni di ordine superiore adattano i fenomeni di ordine in feriore ai loro scopi, anche se non possono cambiare le loro pro prietà. Corrispondentemente, sono i sistemi sociali umani a esten dersi fino ad abbracciare gli ecosistemi e non viceversa, e la cul tura dà un ordine differente alla natura e assimila le parti di que sta che hanno rilevanza per la condizione umana. [1970, p. 169] Proprio cosi. Ma tutto nella filosofia di Steward va esatta mente in direzione opposta. La morfologia culturale è resa intellegibile proprio dalle stesse basi che rendono intellegibili le ali di un uccello o le branchie di un pesce. La cultura non rior dina la natura per i suoi scopi - perché, per Steward, ogni sco po tranne quello pratico scompare nel momento della produ zione. Il sapere ecologico consiste nel tralasciare l’ordinamen to culturale della natura a ogni nodo decisivo. L’interazione tra la tecnologia e l’ambiente secondo determinati rapporti di pro duzione - su cui è edificata tutta una morfologia culturale - è presa da Steward per un fatto strumentale. Per cui l’ordine tra smesso attraverso l’azione nella struttura è l’ecologica dell’adat tamento efficace. 114
La problematica di Steward è un modello di quanto nel prin cipio teorico dell’ecologia sia stato trascurato il sistema culturale. In parte si tratta di u n ’omissione, di un mancato sviluppo con cettuale di ciò che si è riscontrato nella realtà. Steward è perfet tamente cosciente che il carattere particolare della tecnologia sta bilisce il carattere dell’ambiente - cioè, dà significato alle risorse secondo un criterio di rilevanza culturale. Ma nel modo di argo mentare di Steward questo è un dato, insieme alle relazioni fami liari e produttive (divisione del lavoro secondo il sesso: gli uomi ni a caccia, le donne alla raccolta). L’ordinamento culturale del la natura è cosi travestito da premessa a un ordinamento natura listico della cultura. In pratica, poi, l’intera intenzionalità del pro cesso produttivo è messa da parte, poiché riassume che questa è un’economia di “sussistenza”, condannata dalla scarsità dei mez zi tecnici a contentarsi di una magra esistenza. Una tale naturalizzazione dell’economia di caccia e di rac colta è certamente accettata come sapere antropologico.34 E si trasforma direttamente in una spiegazione “ecologica” della cul tura totale. Infatti, ignorando i caratteri storici degli obiettivi economici, la loro qualità e quantità, il fatto che sono richiesti beni particolari, e con quale intensità avviene il processo, si per de il senso dell’organizzazione culturale del rapporto con la cul tura.35 Non sempre i cacciatori sono impegnati in un’economia di pura sussistenza. Ognuno di questi gruppi distingue ciò che è commestibile da ciò che non lo è, non solo per la popola zione nel suo insieme, ma per specifiche classi di età e di ses so, e secondo condizioni rituali che variano da luogo a luogo. Inoltre, una quantità di esempi tra gli aborigeni australiani ba stano a mostrare come differenti tipi di scambio tra i gruppi abbiano corrispondenti implicazioni sull’intensità e i modelli so ciali di lavoro. Gli australiani sono anche capaci di una forma di totemismo concreto, in cui gruppi confinanti si specializza no nella produzione di diversi oggetti di uso pratico per lo scam bio, usando materiali che sono accessibili a tutti allo stesso mo do, duplicando in tal modo sul piano economico i riti di cre scita e l’interdipendenza di gruppi raffigurati nel sistema tote mico. In breve, ciò che Steward trascura è l’organizzazione del lavoro come processo simbolico che opera in rapporto sia con la produzione sia con le finalità. L’attività produttiva è invece 115
privata della sua produzione culturale, per far luogo alla costi tuzione della cultura da parte dell’attività produttiva. Il problema principale posto all’antropologia da questi diversi dpi di ragione pratica riguarda l’esistenza della cultura. Le teo rie dell’utilità hanno recitato cambiando molti costumi, ma so no sempre giunte allo stesso epilogo della vicenda: l’elimina zione della cultura come oggetto specifico della disciplina. Si possono scorgere nella varietà di queste teorie due tipi princi pali, che procedono lungo due strade diverse verso la stessa me ta. Un dpo è quello naturalistico o ecologico - diciamo, ogget tivo - mentre l’altro è utilitario in senso classico, o economici stico, e si appella al noto calcolo mezzi/fini del soggetto uma no razionale. Il naturalismo intende la cultura come il modo umano dell’adattamento. La cultura in quest’ottica è un ordine stru mentale, concepito (secondo la particolare scuola ecologica) co me tendente a riprodursi come cultura o a mantenere la po polazione umana all’interno dei limiti della sua capacità di ri prodursi. In entrambi i casi, la praxologia è “oggettiva” nel sen so che la spiegazione consiste nel determinare i valori materia li o biologici di determinati tratti culturali; non c’è la richiesta teorica che gli agenti calcolino direttamente in termini di uti lità per l’adattamento - al contrario, i più trionfali “eureka!” sa ranno riservati alle dimostrazioni secondo le quali lo fanno malgré eux. L’atto con cui si fa scomparire la cultura consiste nel suo assorbimento, in un modo o nell’altro, nella natura. E que sto sia che la pratica culturale venga intesa come modo in cui si presentano nel comportamento le leggi della selezione natu rale, proprio come in qualsiasi “comportamento specifico di spe cie”; e sia che essa venga sussunta all’interno di un più gene rale ecosistema che - da solo e come totalità - gode di capa cità di autoregolazione (o “mente”) e le cui costrizioni si attuano in forme culturali. Più che essere una pragmatica delle forme culturali, l’utili tarismo soggettivo è connesso, per contrasto, con l’attività fina lizzata degli individui che perseguono i propri interessi e le pro prie soddisfazioni. Si potrebbe dire che questo secondo tipò’di teoria pragmatica presuppone un Uomo Economico universa le, benché relativizzi l’insieme delle sue preferenze, ossia sup116
ponga che l’uomo proceda razionalmente in direzione di obiet tivi, i quali, comunque, variano da società a società. La relativizzazione rappresenta in questo modo un adattamento alla va riazione culturale, ma significa anche utilizzarla come premes sa da parte di u n ’interpretazione che mostra di considerarla una conseguenza. In questa praxologia, la cultura è vista come am biente, o come l’insieme dei mezzi a disposizione dell“’individuo manipolatore”, e anche come sedimento delle sue interes sate macchinazioni. L’analisi della cultura ha dunque una for ma tipicamente solipsistica. Solo gli attori (e i loro interessi con siderati a priori come loro) sono reali; la cultura è l’epifenomeno delle loro intenzioni. Tutti questi tipi di ragione pratica hanno anche in comune una concezione immiserita dell’attività simbolica dell’uomo. Per ognuno di essi, lo schema culturale è il segno di altre “realtà”, quindi, alla fin fine obbedisce, nel suo ordinamento, ad altre leggi e ad altre logiche. Nessuno di essi è stato capace di uti lizzare fino in fondo la scoperta antropologica che la creazione di significato è la qualità distintiva e costitutiva dell’uomo, 1’“es senza umana”, come si diceva una volta - cosi che le relazioni tra gli uomini, e tra gli uomini e la natura, sono organizzate da processi di valutazione e di significazione differenziali.
RAGIONE CULTURALE
Nei paragrafi iniziali di questo capitolo, ho descritto i rap porti tra spiegazione pratica e spiegazione culturale come un’op posizione ricorrente e ciclica a cui l’antropologia non è stata capace di sottrarsi in questi ultimi cento anni. Eppure, proprio come nella società americana, dove quanto vi è di più fonda mentalmente convenzionale è considerato tanto più naturale, la lotta per il riconoscimento della prospettiva culturale è co minciata da un punto di svantaggio, e può essere descritta me glio come il tentativo di liberare l’antropologia dalla prigione del naturalismo. Questo tentativo è continuato in Europa, do ve è stato segnato non solo da una maggiore consapevolezza antropologica del campo simbolico, ma anche dalla sua cre scente penetrazione nell’analisi del pratico. Da parte americana, il concetto di Boas di cultura come strut117
tura significante frapposta tra la circostanza e la consuetudine è stato sostenuto dai suoi allievi. Il concetto ha dato luogo a va ri sviluppi, soprattutto con l’idea di Ruth Benedict di una logi ca orientativa che riuniva le “strisce e ritagli”, che Lowie aveva lasciato sparpagliati, e li sistemava in solidi modelli di cultura. Nella concezione della Benedict, l’ordine derivava dall’infusio ne, in tutte le pratiche culturali, di significati e attitudini con frontabili. Non si trattava certo di un codice differenziale, ma di un operatore universale, che organizzava l’ambiente, le rela zioni sociali e, soprattutto, la storia: uno schermo selettivo che riduceva il caos potenziale dell’adozione culturale (diffusione) mediante un principio di consenso e u n ’assegnazione di signi ficato (Benedict, 1934). Nell’opera di un altro notissimo antropologo americano, Le sile White, il paradigma boasiano convive con quello morganiano, senza tuttavia che si raggiunga l’unità delle opposte teo rie. Quest’ambivalenza nella filosofia di White forse non è una caratteristica sua particolare; è facile dire che la ragione prati ca e quella simbolica coabitano senza tanto scalpore in molte teorie antropologiche. Per White, le idee sono, da una parte, il riflesso della base tecnologica, diretto o mediato dai rapporti sociali parimenti determinati. Qui White lavora direttamente sull’epistemologia di Morgan. Le idee che gli uomini hanno del mondo possono derivare soltanto dal modo in cui essi ne han no esperienza, e la loro esperienza necessariamente dipende dal modo in cui essi sono tecnicamente articolati con il loro mondo: I sistemi ideologici o filosofici sono organizzazioni di credenze in cui l’esperienza umana trova la sua interpretazione. Ma tale espe rienza e tali interpretazioni sono potentemente condizionate dal la tecnologia. C’è un tipo di pensiero per ogni tipo di tecnologia. L’interpretazione di un sistema di esperienza in cui un coup de poing è un tratto caratteristico, rifletterà, come deve, questo tipo di esperienza - non sarebbe improprio parlare di un tipo di pen siero come di una tecnologia coup de poing. [...] Un tipo di tec nologia si esprimerà nel totemismo, un’altra nell’astrologia o nel la matematica dei quanti. [White, 1949, ed. it. p. 331] Dal momento che le idee derivano dalle condizioni tecniche della percezione, l’evoluzione della filosofia è risolta da White 118
essenzialmente negli stadi successivi della coscienza, da falsa a vera, dove il passaggio dall’una all’altra è effettuato tramite un breve periodo di metafisica. Con i mezzi sempre più efficaci che abbiamo per affrontare tecnologicamente il mondo, la pri mitiva preminenza del soprannaturale, che rappresenta la con cezione antropomorfica di una fondamentale ignoranza, deve necessariamente far posto a una filosofia scientifica basata sul la conoscenza oggettiva. Dall’altra parte, c’è l’insistenza di White sull’unicità del “com portamento simbolico”, ossia di un sistema di significati specifi catamente non legato alla realtà fisica. Di conseguenza il modo in cui il mondo è “oggetto di esperienza” non è un semplice pro cesso sensoriale che possa derivare direttamente dall’osservazio ne tecnologica della realtà. Il potere umano di conferire signi ficato - di vivere l’esperienza come significante - costruisce un mondo di altro genere: L’uomo si differenzia dalla scimmia, e naturalmente da ogni altra creatura vivente, per quel che ne sappiamo, perché è capace di com portamento simbolico. Con le parole l’uomo crea un nuovo mon do, un mondo di idee e di filosofie. In questo mondo l’uomo vive al trettanto realmente che nel mondo fisico dei suoi sensi. In verità, l’uomo sente che la qualità essenziale della sua esistenza consiste nel fatto che egli fa parte di questo mondo di simboli e di idee - o, co me talvolta lo chiama, del mondo della mente o dello spirito. Que sto mondo di idee viene ad avere una continuità e una permanen za che il mondo esterno dei sensi non potrà mai avere. Non è fatto solo di presente, ma anche di passato e di futuro. Dal punto di vista temporale non è una successione di episodi scollegati, ma un con tinuum che si estende all’infinito in entrambe le direzioni, dall’eter nità all’eternità. [White, 1942, p. 372] Ma allora da questa prospettiva simbolica - opposta alla co scienza positivista e utilitaria basata sulla scoperta tecnologica l’attrezzo è esso stesso un’idea. E “non soltanto un oggetto na turale, e neppure un’immagine sensoriale come può esserlo per una scimmia. Esso è anche un’idea” (White, 1942, p. 373). Se un’ascia di pietra genera un tipo specifico di filosofia, nondi meno l’ascia stessa è un concetto il cui significato e il cui im piego - come per tutti i concetti - sono definiti non dalle sue proprietà oggettive ma dal sistema di relazioni tra simboli. In 119
tal modo la determinazione tecnologica della cultura nella teo ria evoluzionistica di White convive con la determinazione cul turale della tecnologia nella sua teoria del simbolo: Un’ascia ha una componente soggettiva; sarebbe priva di senso senza un concetto e un’attitudine. D’altro canto, un concetto o un’attitudine sarebbero privi di senso se non potessero essere espressi in modo evidente dal comportamento o dalla parola (che è un’altra forma di comportamento). Ogni elemento culturale, ogni tratto culturale, inoltre, ha un aspetto soggettivo e un aspet to oggettivo. Ma le idee, le attitudini, e i sentimenti - fenomeni che hanno una loro posizione all’interno dell’organismo umano - possono essere presi in considerazione ai fini di un’interpreta zione scientifica in un contesto extrasomatico, ossia nei termini della relazione che hanno con l’organismo umano. [... in tal mo do un’ascia può essere presa in considerazione nei termini della sua relazione] con le altre cose e gli altri eventi simbolizzati, co me frecce, zappe e consuetudini che regolano la divisione del la voro nella società. [White 1959a, p. 236]“ Contro il paradigma fondamentalmente pratico e tecnologi co che lo collega a Morgan, White cosi è in grado di avere una prospettiva simbolica - che lo pone in una diversa compagnia. Vorrei mettere a confronto un passo di Lévi-Strauss, già citato, con un testo preso dal messaggio presidenziale di White alla se zione di antropologia dell’American Association for thè Advancement of Science: Lévi-Strauss
White
Se noi affermiamcrche lo schema concettuale impone e definisce le varie pratiche, è perché queste ul time, che sono oggetto di studio per l’etnologo come realtà a par te, localizzate nel tempo e nello spazio e distintive di generi di vi ta e di forme di civiltà, non si confondono con la praxis la qua le [...] costituisce per le scienze dell’uomo la totalità fondamenta le. [...] Senza mettere in causa l’incontestabile primato delle in-
In questo modo [con i simboli] l’uomo si è costruito un nuovo mondo in cui vivere. Natural mente ha continuato a calpestare il terreno, a sentire il vento sul vi so, a udirlo soffiare tra i pini; ha continuato a bere ai ruscelli, a dormire sotto le stelle e a svegliar si salutando il sole. Eppure, non era più lo stesso sole! Nulla più era uguale a prima. Ogni cosa era “immersa in una luce celestiale”; e c’erano “presagi d’immortalità” 120
frastrutture, noi crediamo che tra praxis e pratiche si inserisca sempre un mediatore, che è lo schema concet tuale, per opera del quale una mate ria e una forma, prive entrambe di esi stenza indipendente, si adempiono co me strutture, ossia come esseri al
dappertutto. L’acqua non era più qualcosa con cui togliersi la sete; poteva conferire la vita eterna. Tra uomo e natura era sospeso il ve lo della cultura, ed egli non poteva ve der nulla se non attraverso questo mezzo. Egli usava ancora i suoi sensi. Spaccava le pietre, cacciava i cer vi, si accoppiava e generava pro le. Ma a permeare ogni cosa era l’es senza delle parole: i significati e i va lori che giacevano al di sotto dei sen si. E questi significati e valori lo gui davano - aggiungendosi ai suoi sensi - e spesso prendendo il sopravvento su di essi. [1958 ms.; corsivi miei]37
tempo stesso empirici e intellegibili. [1962a, ed. it. pp.. 145-146; corsivo mio]
Sembra che dovunque ci si giri nell’antropologia americana si incontri, se non proprio l’ambivalenza di White, una certa incompletezza nell’appropriazione dell’oggetto culturale da par te del significato. L’imponente etnoscienza sviluppata da Goodenough, Lounsbury, Conklin e altri, soprattutto al di fuori dell’eredità linguistica della scuola di Boas, è stata scossa dal concetto positivista di cultura come pertinenza comportamen tale, o etnografia, e quindi di significato come funzione signi ficante referenziale, e di analisi come traduzione - nei termini di un codice apparentemente oggettivo, la cui “oggettività” co difica una teoria. O, per fare degli esempi completamente di versi (anche se ugualmente imponenti per qualità intellettua le), i tentativi di Geertz o di Schneider, ciascuno per suo con to, hanno ugualmente dato vita a una specifica limitazione del campo simbolico, in quanto costruito sulla distinzione tra azio ne e ideologia, società e cultura. Questa particolare distinzione è specificamente europea ed esprime più da vicino la dottrina della scienza sociale inglese che di quella americana. Dal mo mento che le sue implicazioni riportano a Durkheim, e di li di nuovo al moderno strutturalismo francese - che accoglie anche la tradizione boasiana attraverso Lévi-Strauss - mi è parso di grande interesse dare la massima attenzione al modo in cui la 121
relazione fra utilitarismo e cultura ha agito in questa tradizio ne. Cominciamo con Durkheim. Benché sia l’eroe di un certo successivo “funzionalismo”, Durkheim sviluppò la sua concezione della società differen ziandosi proprio da quel genere di economicismo e di indivi dualismo radicale che abbiamo visto implicito nel progetto di Malinowski (cfr. Parsons, 1937; Lukes 1972). Durkheim scelse Spencer come suo antagonista diretto su questo punto, partico larmente in La division du travail social (1893). Di conseguenza, si potrebbe formulare, in parallelo al contrasto tra Morgan e Boas, una comparazione paradigmatica tra Spencer e Durkheim; questo dibattito era imperniato suH’utilitarismo propriamente detto o azione economicistica, e quindi sull’opposizione tra in dividuo e società; mentre il primo riguardava la logica materia le della produzione e quindi l’opposizione complessiva tra cul tura e natura. Per svariati motivi, comunque, quest’esercitazio ne su Spencer e Durkheim risulterebbe poco utile. Un motivo è l’ampia somiglianza residua tra il “superorganico” di Spencer e la “società” di Durkheim. Un altro, e più importante, è che Durkheim strutturò il suo concetto di “sociale” dal confronto complessivo con l’economia politica classica, e non solo con Spencer, cosi che quel concetto è visto più utilmente come un’ampia critica dell’immagine di sé del capitalismo che si pre senta come teoria della società. Esso era u n ’opposizione com plessiva all’adozione della formula razionalista dell’individuo economico come modello della produzione sociale, un model lo che avrebbe posto la società in posizione di predicato rispetto ai presunti bisogni e fini umani. Contro tale volontarismo e l’ec cessivo peso dato all’intenzionalità, Durkheim pose il fatto so ciale. Le proprietà e i poteri schiaccianti che aveva attribuito al fatto sociale in rapporto all’individuo rappresentano una diret ta confutazione dell’idea liberale della società come risultato pubblico dell’interesse privato. Cosi il celebre invito, in Les Règles de la méthode sociologique, a “trattare i fatti sociali come cose” era qualcosa di più di una le zione di reificazione positivista. Sottolineare la fluttualità del fatto sociale significava esattamente rimuoverlo dall’ambito del la produzione individuale: “Poiché tutto ciò che è reale possie de una natura definita che si impone, della quale bisogna te ner conto e che - anche quando si riesce a neutralizzarla - non 122
è'm ai completamente vinta” (1895, ed. it. p. 19). Ma tutte le espressioni che affermano la socialità nello schema di Durkheim allo stesso tempo negano l’individualità. Non semplicemente perché il fatto sociale è collettivo. Ma anche perché è coscienza opposta a desiderio, convenzione opposta a spontaneità; e più che trovare origine nelle necessità, che sono interne, impone se stesso come costrizioni, che sono esterne. “Infatti il caratte re distintivo di una cosa è il fatto che essa non può venire mo dificata con un semplice decreto della volontà” (ibid., ed. it. p. 45). Analogamente, l’origine autentica dell’atteggiamento criti co di Durkheim nei confronti della psicologia sta nel suo attacco all’economia. Secondo lui, l’origine reale del riduzionismo era l’ideologia dell’uomo calcolatore: Infatti, se la società non è che un sistema di mezzi istituiti dagli / uomini in vista di certi scopi, questi ultimi devono essere indivi/ duali, dal momento che prima della società potevano esistere sol[ tanto gli individui. Dall’individuo derivano quindi le idee e i bi sogni che hanno determinato la formazione della società; se tut to proviene da lui, egli deve essere il principio di ogni spiegazio ne. D’altronde, nelle società vi sono soltanto coscienze particola ri; in queste ultime si trova perciò la fonte di tutta l’evoluzione sociale. Di conseguenza le leggi sociologiche non potranno essere al tro che corollari delle leggi più generali della psicologia. [Ibid., ed. it. p. 97] Fin dall’inizio, come osserva Lukes, la posizione di Durkheim fu di considerare l’economia politica una fase da superare nel lo sviluppo della scienza sociale. Spinta a pensare che “non c’è niente di reale nella società tranne l’individuo”, una tale scien za non avrebbe dato alcuno spazio teorico alla sociologia. E ver so questo eterno individuo da cui la società era stata astratta, Durkheim non poteva non provare lo stesso tipo di disinteres se provato da Marx. Questo “individuo” era esso stesso u n ’astra zione. Privato di tutte le coordinate di tempo, di luogo e di sto ria, quanto rimaneva era “il triste ritratto dell’egoista puro” (Durkheim, 1888, citato in Lukes, 1972, p. 80). Né Malinowski né Weber: Durkheim rifiutò di concepire la società come un oggetto esterno della manipolazione umana o di spacciarla per l’unica realtà del soggetto intenzionale. Come 123
mai, allora, Radcliffe-Brown? Sicuramente le stesse considera zioni avrebbero dissuaso Durkheim dal soffermarsi sull’utilitari smo appena velato del funzionalismo sociologico. Neppure il suo entusiasmo per la “solidarietà” gli permise mai di supporre in via di principio che la funzione di una consuetudine, o il suo ruolo nel soddisfacimento dei besoins sociaux, costituisse una spie gazione della sua natura specifica.38Tuttavia i lineamenti del fun zionalismo di Radcliffe-Brown si intravedono all’interno dell’on tologia di Durkheim. Negando l’economia politica, Durkheim fu costretto a riprodurre a livello di società, vista come una spe cie di supersoggetto, lo stesso economicismo che aveva rifiuta to come elemento costitutivo a livello individuale. Si può se guire molto bene questa unione di opposti in uno dei primi scritti (1887) sulla scienza morale in Germania, in cui Durkheim difende i punti di vista sociali degli storici dell’economia G. Schmoller e A. Wagner contro i liberali della “scuola di Manche ster”. Per questi ultimi, scrive Durkheim, L’economia politica consiste nel soddisfacimento dei bisogni dell’individuo e in particolare dei suoi bisogni materiali. In questa concezione l’individuo esiste cosi come unico scopo dei rapporti economici; da lui e per lui ogni cosa è fatta. Per quanto riguarda la società, essa è un’immagine del pensiero, un’entità metafisica che lo studioso può e deve ignorare. Ciò che va sotto questo nome è so lo la raccolta di tutte le attività individuali; è un intero non più gran de della somma delle sue parti. [...] Si vede che fondamentalmente gli economisti liberali sono inconsapevoli discepoli di Rousseau, che essi commettono l’errore di ripudiare. Veramente, essi riconoscono che lo stato di isolamento non è l’ideale, ma, come Rousseau, nel contratto sociale non vedono altro che un accostamento superficia le, determinato dal fatto che gli interessi individuali coincidono. [Durkheim, 1887, p. 37. Ma, per un’opinione modificata, vedi il suo tardo saggio su Rousseau (1953)] Ma allora, l’argomento contro l’essere individuale è esatta mente l’esistenza di un essere sociale - e contro il potere ordi natore del bisogno individuale, il bisogno sociale. Il rifiuto dell’idea che una data pratica, per esempio economica, derivi dal desiderio individuale, si trasforma nell’insistenza sulla sua utilità sociale: 124
Per essi [Wagner e Schmoller], viceversa, la società è un essere reale, niente, senza dubbio, di più degli individui che la com pongono, ma nondimeno ha una natura e una personalità sue proprie. Espressioni del linguaggio corrente quali “coscienza col lettiva”, “mente collettiva”, “il corpo della nazione”, non hanno un valore puramente verbale ma esprimono fatti che sono eminente mente concreti. E sbagliato dire che l’intero è uguale alla somma delle sue parti. Per il semplice fatto che le parti hanno relazioni definite tra loro, sono collegate in un certo modo, qualcosa di nuo vo risulta dall’assemblaggio: un essere composito, certamente, ma dotato di proprietà particolari, e tale da potere, almeno in deter minate condizioni, diventare cosciente di se stesso. [...] Poiché l’es sere sociale ha bisogni suoi propri, e tra questi il bisogno di cose materiali, esso istituisce e organizza, per soddisfare questi bisogni, un’attività economica che non è l’attività di questo o di quell’in dividuo, né l’attività della maggioranza dei cittadini: è l’attività del la nazione nel suo complesso. [Ibid., pp. 37-38] La società dunque ha i suoi propri fini, che non sono quel li dell’individuo, ed è per mezzo della prima, non del secondo, che l’attività sociale può essere compresa. “Perché un fatto sia sociologico, esso deve interessare non solo tutti gli individui pre si separatamente, ma la stessa società. L’esercito, l’industria, la famiglia, hanno funzioni sociali in quanto hanno come obietti vo il primo di difendere la società, la seconda di nutrirla, la ter za di assicurarle rinnovamento e continuità” (Durkheim, 1866, p. 66). In tal modo, la teleologia utilitaria non poteva essere evitata. L’intero modello mezzi-fini era insito nell’idea di fatto sociale, in quanto tale fatto era definito da\Y opposizione al biso gno individuale. Soltanto così la vita della società era la finalità importante. Ma, in più, proprio perché era stata definita come esterna e in contrapposizione al benessere individuale, questa nozione di sopravvivenza sociale aveva una notevole incidenza sull’idea dell’oggetto sociale. Uno degli effetti era il punto di vista secondo il quale la società era continuamente minacciata dall’interno da una guerra di tutti contro tutti e si era costitui ta per evitare questo pericolo: questa concezione influenzò profondamente molti lavori del gruppo dell’Année Sociologique, e stava anche alla base dell’interesse di Radcliffe-Brown per la “coaptation” e in generale per l’ordinamento giuridico (cfr. Sahlins, 1972, cap. -4). Può darsi che questa nozione di conflitto 125
sotterraneo e i problemi funzionali che presenta alla società sia no la più importante eredità che l’ideologia capitalisdca lascia alla scienza sociale. In modo più evidente, l’accento sulla vita della società in quanto opposta al fine individuale forniva il fon damento logico per l’appropriazione dell’intera metafora orga nica come idea base della costituzione sociale. La visione tradi zionale della società come organismo fu naturalmente conser vata da Radcliffe-Brown, e con essa l’adozione da parte dell’an tropologia sociale, o sociologia, delle suddivisioni proprie delle scienze naturali in morfologia, fisiologia ed evoluzione. Occor reva solo la proposizione che la “funzione sociale” di un’istitu zione, o il suo contributo alla continuità sociale, è anche la sua raison d ’ètre (Radcliffe-Brown, 1950, p. 62), per compiere in un sol gesto il ribaltamento della posizione di Durkheim - e spo stare l’utilitarismo dall’individuo al soggetto di formato grande, uno spostamento che l’impostazione stessa del problema da par te di Durkheim aveva reso inevitabile. Il concetto di Durkheim di attività simbolica, compresa la fa mosa “epistemologia sociologica”, cadde infine vittima dello stes so genere di dualismo - e nelle mani dei discepoli antropologi si trasformò in un’altra specie di logica strumentale. Lukes e al tri avevano dimostrato, contro le critiche di Lévi-Strauss alla de rivazione della rappresentazione collettiva dalla morfologia so ciale, come Durkheim si fosse reso conto con sempre maggior chiarezza dell’autonomia e universalità del significato. Forse questo è un altro esempio di differenza tra il rendersi conto di un fatto e il sapere qual è il posto teoretico che gli spetta. I te sti che potrebbero essere citati a sostegno di entrambe le tesi in questione rappresentano uno solo dei tanti paradossi presenti nell’interpretazione del maestro sul rapporto tra pensiero e mondo. Un altro è il problema (proprio come in Malinowski) della differenza tra l’approccio sociologico alla conoscenza e il modo in cui la conoscenza si costituisce nell’infanzia e nella so cietà - processi a tal punto divergenti nella teoria di Durkheim da renderlo incapace di circoscrivere il proprio programma po sitivista. Infatti quel programma sostiene che i fatti sociali, pro prio perché sono “cose”, possono essere penetrati solo dall’ester no, con la guida della percezione e senza preconcetti. Ma Durkhéim non ha mai creduto che la nostra conoscenza, in quanto membri della società, e i fatti sociali abbiano un’origi126
ne dello stesso tipo. Il dilemma cosi posto potrebbe essere esem plificato da due brevi passi delle Règles. Da una parte, Durkheim scrive che “ogni educazione consiste in uno sforzo continuo per imporre al bambino modi di vedere, di sentire e di agire a cui non sarebbe pervenuto spontaneamente” (1895, ed. it. p. 28). Ma, qualche pagina dopo, dice: “Si tratta di sapere in che cosa consista l’idea di diritto e l’idea di morale, non già quale sia la natura della morale e del diritto considerati di per sé. I mora listi non sono ancora giunti alla concezione semplicissima che, come la nostra rappresentazione delle cose sensibili proviene dalle cose stesse, e le esprime più o meno esattamente, cosi la nostra rappresentazione della morale proviene dallo spettacolo stesso delle regole che funzionano sotto i nostri occhi” (ibid., ed. it. p. 48). Durkheim considera il rapporto tra soggetto e og getto allo stesso tempo mediato e immediato. Se quest’ultimo tipo si adatta al progetto scientifico, il primo rappresenta il de stino dell’uomo nella società. La contraddizione, comunque, era certamente più complessa e non priva di una qualche possibi lità di essere sciolta. Infatti, in caso di rapporto mediato la so cietà affronta l’uomo alternativamente come supersoggetto, il cui concetto del mondo domina e riordina le sue sensazioni in dividuali, oppure come oggetto la cui esperienza difetta dà con to empiricamente di quél processo di imposizione concettuale. Quale luogo di questo dualismo antagonistico tra società e sen sibilità, l’uomo è “duplice” nella teoria di Durkheim, e la du plicità del suo essere corrisponde a un1’opposizione tra perce zione (individuale) e concezione (sociale) come pure tra grati ficazione egoistica e moralità collettiva.39 Se segnalo queste circonvoluzioni dialettiche è perché aiuta no a spiegare sia il valore che i limiti della problematica di Durkheim come teoria della cultura. Tale valore è solo parzial mente documentato dall’influenza del concetto durkheimiano di fatto sociale sulla formulazione di Saussure della distinzione tra langue e parole (Doroszewski, 1933). In De quelques formes primitives de classification (scritto con Mauss) e in Les foràies éUmentaires de la vie religieuse, Durkheim aveva già per conto suo svi luppato una nozione di segno, soprattutto riguardo alle “cate gorie” di classe, numero, spazio, tempo, causa e simili, che nei punti essenziali era molto vicina a quella di Saussure. Ancora un paradosso dal punto di vista del carattere arbitrario del se127
gno, dal momento che per Durkheim le categorie rappresen
tavano la morfologia sociale de facto - su cui ci soffermeremo in seguito. Ma poiché i concetti promanano dalla totalità sociale, essi specificamente trascendono l’esperienza individuale. Più che articolare tale esperienza, essi rappresentano un metalin guaggio da cui essa è organizzata.40 E dal momento che le ca tegorie non sono i particolari dell’esperienza ma piuttosto le idee generali dei particolari (tali da rendere l’esperienza un par ticolare), esse nello specifico non riflettono la percezione ma se ne appropriano afl’interno di un sistema culturale pertinente.41 Infine, Durkheim riconosce il carattere arbitrario del segno im mediatamente, come conseguenza logica della distinzione tra fat to individuale e fatto sociale - proprio perché la sensibilità in dividuale è un fatto transitorio che, come esseri sociali, abbia mo i mezzi e la libertà di rappresentare in altri termini: Una sensazione, un’immagine, si riferisce sempre a un determi nato oggetto o a una serie di oggetti di quel genere, ed esprime lo stato momentaneo di una coscienza singola: è essenzialmente individuale e soggettiva. Possiamo, quindi, disporre con relativa libertà delle rappresentazioni cosi originate. Certo quando le no stre sensazioni sono in atto si impongono a noi in fatto-, ma in di ritto restiamo padroni di pensarle diverse da quelle che sono, di rappresentarcele come svolgentesi secondo un ordine diverso del reale. Di fronte a esse nulla ci lega, fino a quando non interven gono considerazioni di altro genere [e cioè di genere sociale]. [Durkheim 1912, ed. it. pp. 28-29]42 Ne deve seguire, che per Durkheim il fatto sociale, soprat tutto la coscienza collettiva, non è semplicemente il riconosci mento della circostanza materiale. L’opposizione a questa ri duzione porterebbe Durkheim, almeno temporaneamente, al di là del suo stesso riflessionismo sociologico. Dalla definizione dello schema significante per mezzo della morfologia sociale, Durkheim si è mosso verso una definizione della morfologia so ciale come significante - e del carattere sui generis della sin tassi significante. “La società ideale,” insiste, “non è fuori dalla società reale, ma ne fa parte. [...] Perché una società non è co stituita semplicemente dalla massa degli individui che la com pongono, dal suolo che occupano, dalle cose di cui si servono, dai movimenti che compiono, ma in primo luogo dall’idea che 128
si fa di se stessa” (1912, ed. it. p. 421). In contrasto con il ma terialismo storico volgare, Durkheim contrappone “tutto un mondo di sentimenti, di idee, di immagini che, una volta nati, ubbidiscono a proprie leggi. Essi si richiamano, si respingono, si fondon-e, si segmentano, proliferano senza che tutte queste combinazioni siano direttamente comandate e imposte dallo sta to della sottostante realtà” (ibid., ed. it. p. 422; cfr., comunque, le più antiche notazioni su Labriola, in Lukes 1972, p. 231). Si noti che perfino all’interno dell’epistemologia sociologica com parve un nodo fondamentale, nella relazione tra società e na tura, che avrebbe potuto condurre lontano da qualsiasi tipo di riflessionismo. La società, era solito dire Durkheim, compren de gli “stampi” in cui si sono formate le esperienze umane. Di conseguenza, il mondo noto all’uomo era un mondo sociale precisamente non un riflesso ma proprio dentro la società. La storia del mondo era il racconto dell’esistenza della tribù, pro prio come lo spazio geografico veniva a essere l’allargamento del punto centrale del villaggio^ E gli oggetti di questa esisten za sociale non erano semplicemente classificati come isomorfi dell’uomo: a essi veniva anche dato un posto all’interno dei gruppi umani. (“Per l’Australiano anche le cose, tutte le cose che,popolano l’universo, fan parte della tribù: ne sono elementi costitutivi e, per cosi dire, membri regolari; perciò hanno, pro prio come gli uomini, un posto determinato nei quadri della società” [Durkheim, 1912, ed. it. p. 161].) Se, come dice Durkheim, l’universo non esiste se non nella misura in cui è pensato, allora esso è stato circoscritto all’interno di un più am pio ordine; cosi che non è più possibile pensare a esso come operante semplicemente dall’esterno, in un modo solamente na turale. E in questo senso della teoria, l’opposizione al marxi smo era eccessiva. Proprio perché Durkheim sarebbe stato d ’ac cordo con Marx sull’assunto che “l’uomo non è un essere astrat to, piazzato fuori dal mondo”, essi devono giungere assieme al corollario di una natura socializzata o umanizzata. La descri zione di Lukàcs va bene per tutti e due: “La natura è una ca tegoria sociale. Ciò che vale come natura a un determinato gra do dello sviluppo sociale, la struttura del rapporto tra uomo e natura e il modo in cui l’uomo si misura con essa, quindi il senso che la natura deve avere in rapporto alla sua forma e al 129
suo contenuto, alla sua estensione e alla sua oggettualità, è sem pre socialmente condizionato” (1923, ed. it. p. 291). Questo concetto di appropriazione sociale della natura, dell’ordine naturale come ordine morale, continua a informa re la migliore antropologia strutturale, inglese e francese. Era un concetto essenziale nell’opera giovanile di Radcliffe-Brown sulle credenze e sui cerimoniali nelle Andamane, come pure nei suoi studi sul totemismo, il tabù e la religione in generale. E stato un punto centrale anche per l’impresa etnografica di Evans-Pritchard e dei suoi allievi, e anche per le più recenti analisi della classificazione fatte da Douglas, Leach, Bulmer o Tambiah. Inoltre, si può rintracciare in questo problema-matrice dell’antropologia sociale inglese la stessa visione generale del rapporto tra consuetudine e natura che distingue Boas da Mor gan. Se il funzionalismo inglese riproducesse un certo tipo di economicismo e anche lo ingrandisse trasferendo una teleolo gia utilitaristica al supersoggetto sociale, eviterebbe con questa stessa operazione il naturalismo volgare o l’ecologismo. Ne I Nuer ( 1940) Evans-Pritchard discute la questione in tutti i suoi aspetti, e nei celebri passi sulla costituzione sociale del tempo e dello spazio, collega i termini del contrasto tra le determina zioni generali dell’ecologia e la specificità del sistema di li gnaggio. Ma allora Evans-Pritchard aveva già sviluppato i carat teri essenziali di. un'autentica ecologia culturale nell’opera sul la stregoneria Azande (1937). Perché mai, si chiedeva in quel libro, un popolo essenzialmente razionale come l’Azande, pur sapendo benissimo che l’orto è stato devastato dagli elefanti che lo hanno calpestato, e che la casa è stata distrutta dal fuoco, in colpano i vicini di casa e i parenti, e intraprendono pratiche ma giche di difesa o di ritorsione? La sua risposta è che l’effetto so ciale non proviene da una causa naturale. Anche se può essere proprietà del fuoco bruciare una casa, non è proprietà del fuo co bruciare la tua casa. O, ancora, la risposta potrebbe essere trovata specificamente al livello culturale: non è nella natura del fuoco bruciare una casa: il fuoco brucia soltanto legna. Una volta incorporata nel regno umano, l’azione della natura non è più un fatto meramente empirico, diventa un significato socia le. E tra il potere del fuoco di bruciare legna e la perdita del la sua proprietà da parte dell’uomo, non esiste rapporto ade guato. Né esiste una reazione adeguata. Non c’è alcuna logica 130
naturale secondo la quale a un processo di combustione con segue una azione magica contro un particolare tipo di persona. Se un fatto naturale è circoscritto dall’ordine culturale, certo non abbandona le sue proprietà fìsiche, ma d ’altra parte non presiede più alle loro conseguenze. Il particolare “risultato” cul turale non è predicato direttamente della causa naturale. In un senso critico è tutto l’opposto. L’epistemologia sociologica di Durkheim trovava i suoi limi ti come teoria di significato, limiti che comunque sembrano ri petersi nelle migliori opere moderne. Non parlo del sentimen talismo presente nella spiegazione di Durkheim del totemismo australiano, la derivazione della forma logica dall’affetto indi stinto per cui lo criticava Lévi-Strauss - problema posto anche dal ruolo assegnato da Durkheim e Mauss (1901-2) alla “con fusione” nella genesi delle categorie concettuali. Intendo piut tosto riferirmi alla inevitabile differenziazione tra morfologia e rappresentazione collettiva - differenziazione posta oggi di nuo vo dagli studiosi in termini di società (o sistema sociale) contro cultura (o ideologia) - che arbitrariamente ha limitato l’appli cazione del simbolico e lasciato aperto il campo al solito duali smo funzionalista. “La società”, ha scritto Durkheim, “suppone un’organizzazione cosciente di sé, che non è altro che una clas sificazione” (1912, ed. it. p. 439). La difficoltà stava nel fatto che Durkheim faceva derivare le categorie che la società “pre suppone” dalla sua costituzione già compiuta lasciando cosi la forma della società in sé senza una spiegazione tranne che si trattava di qualcosa di “naturale”. Ed ecco il dualismo di strut tura sociale e contenuto culturale, che oltretutto minaccia con tinuamente quest’ultimo di riduzione funzionale ai modelli uti litari e agli scopi della prima. Nella teoria di Durkheim, come abbiamo visto, i fondamen tali concetti umani —di classe, tempo, numero e simili - non erano innati o acquisiti in modo trascendente ma erano repe riti proprio nell’organizzazione e nell’azione della vita sociale: Le prime categorie logiche sono state delle categorie sociali; le pri me classi di cose sono state delle classi di uomini nelle quali le cose sono state integrate. E poiché gli uomini erano raggruppati e si pen savano sotto forma di gruppi, essi hanno idealmente raggruppato gli altri esseri, e i due modi di raggruppamento hanno cominciato col confondersi al punto di essere indistinti. Le fratrie sono state i 131
primi generi, i clan le prime specie. Le cose erano pensate come parti integranti della società, ed era il loro posto nella società che determinava il loro posto nella natura. [Durkheim e Mauss, 1901-2, ed. it. p. 73; cfr. Durkheim, 1912, ed. it. pp. 427 sgg.] Ma le fratrie sono a loro volta delle categorìzzazioni (di uo mini), per cui rappresentano le operazioni mentali di cui sono il presunto modello originale. Rodney Needham pone l’obie zione in modo stringente; La nozione di spazio doveva già esistere perché fosse possibile co gliere nell’assetto dei gruppi sociali tutte le relazioni spaziali che potevano poi essere applicate all’universo; le categorie di quan tità dovevano esistere perché una mente individuale potesse rico noscere l’uno, il molteplice e la totalità delle divisioni della so cietà; la nozione di classe necessariamente precede l’acquisizione che i gruppi sociali, in accordo con i quali sono classificati i fe nomeni naturali, sono essi stessi classificati. In altre parole, il “mo dello” sociale deve essere esso stesso percepito per possedere le caratteristiche che lo rendono funzionale a classificare le altre co se, ma ciò non può avvenire senza proprio quelle categorie che Durkheim e Mauss fanno derivare dal modello (1963, p. XXVII).43 Durkheim formulò una teoria sociologica della simbolizza zione, ma non una teoria simbolica della società. La società non era vista come costituita dal processo simbolico; sembrava inve ce vero solo il contrario. Che dire allora della fondazione delle categorie, e della società stessa? Il problema della sua natura di ventò pardcolarmente acuto a livello epistemologico, in quanto Durkheim doveva affrontare la questione del come le categorie derivate da una particolare formazione sociale potessero dimo strarsi in grado di spiegare il mondo. La risposta in un certo senso era del tutto soddisfacente in quanto risolveva (tout à coup) tutti i paradossi del superorganicismo di Durkheim - combi nandoli, per cosi dire, in un superparadosso con cui le genera zioni successive si sarebbero trovate a combattere. Al problema: come possono le categorie derivate dalla società essere applica te alla natura, la risposta era: la società stessa è naturale. Ma se le categorie non traducono in origine che stati sociali, non ne segue che siano riferibili al resto della natura solo metafori camente? [...] 132
Interpretare in questi termini una teoria sociologica della co noscenza significa perder di vista che, se la società è una realtà specifica, non rappresenta però un impero entro un impero. Es sa fa parte della natura; ne è la più alta espressione. Il dominio sociale è un dominio naturale, che differisce dagli altri solo per la sua maggior complessità. [...] E cosi nozioni elaborate sul mo dello delle entità sociali possono aiutarci a pensare entità di altra natura [si noti il ribaltamento totale dell’idea di Lévi-Strauss del “cosiddetto totemismo”]. O almeno, se queste nozioni, dirottate dal significato originario, funzionano in un certo senso da simboli, restano pur sempre dei simboli ben fondati. Se, per il solo fatto di essere concetti costruiti, contengono dell’artificio, è artificio che tallona la natura per ridurre sempre di più il distacco. [Durkheim, 1912, ed. it. pp. 32-33] Non è il caso di insistere su questo recupero della società da parte della natura, o sulla naturalizzazione del segno e sulle al tre contraddizioni che Durkheim dimostra qui. Ciò basta per indicare alcune conseguenze della distinzione tra struttura so ciale e concetto mentale, conseguenze emerse nell’antropolo gia successiva. Infatti la stessa valutazione incompleta del sim bolo, cioè come semplice rappresentazione di realtà sociali, con tinua a perseguitare il funzionalismo strutturalista sviluppato da Radcliffe-Brown e da altri su una base durkheimiana.44 Il “sim bolico” è stato preso per la maggior parte nel senso secondario e derivato di modalità ideale del fatto sociale, di espressione ar ticolata della società, con funzione di supporto per le relazioni stesse formate dai processi reali, politici o economici. Cosi in corporato nel dualismo classico, l’ordine simbolico diventa l’ideologia dei rapporti sociali più che la loro qualità. Lo stes so effetto è prodotto dalla differenziazione arbitraria tra “cul tura” e “sistema sociale” nella scuola inglese, come se i rappor ti sociali non fossero anche composti e organizzati dal signifi cato. In realtà, finché il significante è preso per mero “conte nuto culturale” di rapporti la cui struttura formale è il conte nuto vero, l’assetto simbolico è soltanto una variabile o condizione accidentale dell’oggetto antropologico e non la sua proprietà determinante. Anche l’opera più importante sulla con cettualizzazione della natura, quella di Mary Douglas, per esem pio, tende a scambiare il valore semantico delle categorie con i loro effetti sociali. Più precisamente, il primo tende a venire 133
Identificato con i secondi - il contenuto significante con il va lore sociale (nel senso di Radcliffe-Brown) - seguendo una tra dizione che “dà per scontata l’idea che il pensiero umano ser va gli interessi umani e di conseguenza porti dentro di sé in ogni momento dato le configurazioni sociali di quel tempo e luogo” (Douglas, 1973b, p. 11). Il risultato è un punto di vista unila terale del significato come segno diacritico sociale, e dell’ordi ne culturale totale come progetto utilitario. Facendo riferimento agli insegnamenti epistemologici di Les formes élémentaires de la vie religieuse, la Douglas ricostruisce.il cul to di Terminus, dio delle pietre di confine. Per lei, l’ordina mento della natura è un’oggettivazione, o anche un’espressio ne secondo le regole con cui si trattano gli oggetti, della diffe renziazione dei gruppi umani. Il significato è perciò sacrificato al contrassegno sociale. E i codici culturali delle persone e de gli oggetti, come le corrispondenze tra loro, vengono nullifica ti in astratte implicazioni di inclusione ed esclusione. Infatti nel progetto teoretico totale, il simbolo non è nulla più che un se gno: non produce funzione significante in virtù del suo posto in un sistema di simboli ma è empiricamente riferito a realtà sociali esistenti - che a loro volta hanno la proprietà di sfuggi re a qualsiasi spiegazione significante, al pari degli “interessi umani” che si presume le costituiscano.45 Ma allora non ci si può aspettare che la logica del simbolico sia qualcosa di più si stematico dei “modi tortuosi in cui le persone usano la logica per aver a che fare tra loro” (Douglas, 1973a, p. 41). Dalla par te sia degli oggetti che dei rapporti sociali, questa riduzione simbolica comporta un progressivo svuotamento del codice se miotico e disinteresse per la sua struttura a favore di proprietà puramente formali come la distribuzione e la categorizzazione. Solo in parte una presentazione del significato con un’atten zione particolare ai segni diacritici del sociale lascia la libertà analitica di apprezzare quanto è simbolicamente variabile e pro blematico - diciamo, una divisione tripartita delle specie tra cie lo terra e acqua - e al tempo stesso quanto è a priori e nor male. Più importante è che, in un modo parallelo al dualismo di Malinowski, il “culturale” non ha in sé una logica necessaria, in quanto il suo ordine autentico è un riflesso dei gruppi e dei rapporti sviluppati nella pratica sociale. Prima di esistere per gli scopi della differenziazione dei gruppi, gli elementi di un 134
codice di oggetti, come quello delle differenze nel cibo, hanno solo la coerenza di un “flusso ambientale di simboli” (Douglas, 1971, p. 69). Ma dopo il processo per cui vengono tratti dall’“ambiente culturale” in modo che a essi sono assegnati una classificazione e delle interrelazioni, tali elementi non sono poi più ricchi semanticamente, dal momento che il loro significato non è nulla di più che l’intenzione sociale che li governa. “Se il cibo è trattato come codice”, scrive la Douglas, “i messaggi che codifica si troveranno nel modello dei rapporti sociali che so no espressi. Il messaggio riguarda i diversi gradi di gerarchia, inclusione ed esclusione, limiti e scambi attraverso i limiti. [...] Le categorie del cibo, dunque, codificano eventi sociali” (ibid., p. 61). Nello stesso modo, non sono le caratteristiche di oppo sizione delle specie contigue a richiamare l’attenzione, dando il via in tal modo a una discussione su come il .mondo è costruito culturalmente rispetto agli uomini, ma solo più astrattamente se la specie sia vista con benevolenza, con malevolenza o am biguamente, dal momento che questo può essere collegato ai rapporti- tra i gruppi - purché si sia preparati a definire tali rap porti con lo stesso grado di indeterminatezza. E si noti che per prestarsi a un tale impoverimento, anche il sociale deve sotto porsi a una decomposizione strutturale. Un buon esempio è il tentativo della Douglas di porre in relazione l’attenzione per le specie anomale con tipi di scambio matrimoniale, per via che le diverse regole - come lo scambio generalizzato, l’esclusione Crow-Omaha o il matrimonio con la figlia del fratello del pa dre - introdurrebbero una persona intermedia, ossia l’affine. La Douglas compie un tale collegamento tra attenzione verso l’affine e rapporti tra specie interstiziali, ma solo grazie a una duplice operazione sulla struttura di scambio che la trasforma (a volte in modo falso) in un coefficiente di integrazione tra gruppi. Per prima cosa la Douglas Sceglie di ignorare le speci fiche e ben note strutture delle relazioni tra gruppi, quali sono derivate dalle regole dello scambio matrimoniale elementare e complesso. Secondo, traduce queste regole e forme specifiche in implicazioni di distanza sociale, ancora una volta non consi derando le regole ma richiamandosi a pratiche di fatto che le permettono di ignorarle. Per esempio, secondo il suo ragiona mento, dal momento che è possibile sposare membri classifica tori della categoria di parentela privilegiata, le strutture ele135
limitari (compreso lo scambio generalizzato dei Lele) permet tono un assorbimento degli stranieri non meno radicale di quanto facciano le proibizioni Crow-Omaha (che vietano di ri petere il matrimonio reciproco tra le stesse linee).46 In breve, l’analisi della Douglas di “come sono costituiti i significati” (1973a, p. 31) tende a diventare un feticismo della socievolezza, si mile a quello ecologico grazie alla sostituzione che compie tra gli effetti sociali astratti e le forme concettuali specifiche, ove queste ultime sono trattate come pura apparenza delle prime, con l’analogo risultato di risolvere una definita logica struttu rale in interessi funzionali incipienti. Con ciò non voglio negare l’acuta sensibilità della Douglas per la costruzione umana dell’esperienza. E ancor meno con futare l’importanza critica delle corrispondenze esistenti nelle società umane tra categorie di persone e categorie di cose, o tra le rispettive differenziazioni di queste classificazioni. Voglio solo evidenziare i limiti di un’analisi che mira a far precipitare la struttura concettuale di un codice di oggetti in un messaggio funzionale, come se le cose della cultura non fossero altro che versioni concretizzate di* solidarietà sociali, considerate qui sia privilegiate che pratiche.47Cosi alla fine l’autentica logica dell’in tero socio-culturale si rivela di tipo utilitario. E questo è il ri sultato dell’adesione alla fatale separazione di Durkheim tra morfologia sociale e rappresentazione collettiva. Il rifiuto di Lévi-Strauss di attribuire un carattere ontologico a questa distinzione, d ’altronde - alludo alla sua appropriazio ne del sociale mediante il simbolico -, è stato un passo decisi vo nello sviluppo di una teoria della cultura.48 E vero che que sto non ha depurato completamente l’opera di Lévi-Strauss de gli interessi funzionalistici (cfr. Boon e Schneider, 1974), ma quanto meno ha dato a questi interessi molto meno spazio per agire, precludendo ogni riflessionismo banale tra società e ideo logia. E anche vero che Lévi-Strauss portando l’impresa di Durkheim a una conclusione coerente, con l’inclusione dei rap porti sociali all’interno del sistema generale delle rappresenta zioni, giunge durante questo processo a un naturalismo più al to. Si può anche rilevare u n ’apparente chiusura del cerchio teo retico: dall’insistenza di Morgan sull’idea che la crescita delle istituzioni è predeterminata e limitata dalla “logica naturale del la mente umana”, all’analisi strutturalista la cui “coda” è costi136
tuita da una proposizione analoga (Lévi-Strauss, 1971; 1972). Ma il tragitto è stato più una spirale che un cerchio, dal momento che tutte le appropriazioni del simbolico sopravvengono strada facendo; e, come abbiamo visto, sarebbe un errore assimilare l’appello di Lévi-Strauss alla mente al “principio pensante” di Morgan, che non farebbe altro che reagire razionalmente ai va lori pragmatici insiti nell’esperienza. “Non si può mai dire che il modo in cui l’uomo è a diretto contatto con la natura sia quel lo concepito dal materialismo volgare e dal sensualismo empi rico,” scrive Lévi-Strauss. Il suo appello all '“esprit humain”, dun que, non metterebbe in corto circuito il simbolico quanto piut tosto trarrebbe le conseguenze della sua ubiquità. L’argomen to procede dalla semplice premessa che fin tanto che il mondo umano è costituito simbolicamente, ogni somiglianza nelle ope razioni con cui i differenti gruppi costruiscono o trasformano il loro progetto culturale può essere attribuita al modo in cui la mente stessa è costruita. Secóndo la stessa premessa, “somi glianza” in questo caso non indica il contenuto di quel proget to ma solo il modo di ordinarsi. Non è mai questione di signi ficati specifici, che ciascun gruppo elabora secondo le proprie capacità, ma dei modi in cui i significati sono collegati siste maticamente, che in forme quali 1’“opposizione binaria” posso no mostrare la loro applicazione generale. Né, di conseguenza, è mai questione di “riduzionismo biologico”, un’accusa che può essere suggerita d’altronde dal fatto che si discute di cultura in un contesto mentale. Nessuna usanza particolare potrà mai es sere spiegata dalla natura della mente umana, per la duplice ragione che nella sua particolarità culturale essa sta alla mente come una differenza sta a una costante e una pratica sta a una matrice. La natura umana, a cui Lévi-Strauss fa riferimento, non consiste in un accatastarsi di strutture già pronte e immutabili, ma nelle “matrici da cui si generano certe strutture che appar tengono tutte a un medesimo insieme” (1971, ed. it. p. 591).49 Cosi l’oggetto culturale, nella sua interezza simbolica, rimane interamente ed esclusivamente all’interno della prospettiva dell’interpretazione significante. Solo la comune attività strut turante può essere riferita alla mente, includendo in particola re i sensi e la comunicazione sensoriale, che sembrano funzio nare secondo gli stessi principi dell’opposizione binaria (cfr. Lévi-Strauss, 1972). Al di là di questo sta il più alto naturalismo, 137
in cui Lévi-Strauss congiunge Marx a Durkheim mediante il suo metodo che unifica mente e natura; e cioè: nella misura in cui la natura usa nelle sue costruzioni lo stesso tipo di processi per esempio, il codice genetico, la stereochimica degli odori che la mente usa per comprenderle, c’è tra loro una fondamentale complicità che è la condizione perché si verifichi la comprensione.50 Sembrerebbe comunque che il problema cardine del “ridu zionismo” che assilla lo strutturalismo moderno sia consistito in una forma di discorso che, attribuendo alla mente tutti i pote ri di “legge” e “limitazione”, ha invece situato la cultura in po sizione di sottomissione e dipendenza. Tutto il vocabolario del le leggi “soggiacenti” della mente attribuisce ogni forza di co strizione al lato mentale, a cui il lato culturale può solo ri spondere, come se il primo fosse l’elemento attivo, il secondo solo passivo. Forse sarebbe meglio dire che le strutture della mente non sono tanto gli imperativi della cultura quanto i suoi attrezzi. Esse compongono un insieme di possibilità organizza tive a disposizione del progetto culturale dell’uomo, progetto che comunque governa il loro impiego secondo la sua natura, nello stesso modo in cui governa il loro investimento con un contenuto significante mutevole. Come spiegare altrimenti la presenza nella cultura di strutture universali che tuttavia non sono universalmente presenti? E, a un diverso livello, in che al tro modo affrontare, escludendo il riferimento a un superorganismo, contraddizioni in termini quali “coscienza collettiva”, “rappresentazione collettiva” o “pensiero oggettivato”, che at tribuiscono a un’entità che è sociale una funzione che noi sap piamo essere individuale? Per rispondere a tutte queste do mande sarà bene vedere l’attrezzatura mentale umana come lo strumento della cultura e non come ciò che la determina. Ci siamo allontanati molto, di fatto, dal “principio pensante” di Morgan. Ma ci rimane da fare una critica specifica alla posi zione di Morgan contenuta nella prospettiva strutturalista. Vor rei illuminare questa critica con la notevole opera di Lucien Sebag Marxismo e stmtturalismo, in cui è possibile rintracciare una tesi che è fondamentale anche nel pensiero di Boas. Qui l’oc chio che vede è preso nella sua particolarità culturale. E im possibile dedurre il campo culturale direttamente dall’espe rienza o dall’evento in quanto la pratica si sviluppa in un mon138
do già reso simbolico; cosi l’esperienza, anche nell’atto di in contrare una realtà esterna al linguaggio da cui è interpretata, è costruita come realtà umana dal concetto di esse (cfr. Berger e Luckmann, 1967). La tesi non è nient’altro che una deduzione immediata dalla natura del pensiero simbolico. Il significato è sempre arbitrario rispetto alle proprietà fisiche dell’oggetto si gnificato; ne deriva che il concetto si riferisce in primo luogo a un codice di distinzioni proprio della cultura in questione. Sebag sviluppa l’idea nel contesto dell’alternativa marxista cor rente, che, obietta, riferisce al soggetto la totalità dei significati, senza tuttavia forni re i mezzi per tematizzare effettivamente questa costituzione del senso. In direzione appunto di questa tematizzazione tendono le di stinzioni che noi, dopo altri, abbiamo ripreso; esse escludono la possibilità di una genesi storica o logica della società nel suo in sieme a partire dalla prassi costitutiva degli individui e dei grup pi, giacché questa prassi si sviluppa in un universo già simboliz zato e una scaturigine primaria di tale simbolizzazione non è con cepibile. [1964, ed. it. p. 136] Ma il suo commento sull’esperienza della natura ha un’im portanza diretta anche per l’antropologia della prassi conven zionale: L’interferenza tra natura e cultura non nasce quindi dal loro es ser posti in relazione, ma da una culturizzazione della realtà na turale. La natura diviene cultura non in virtù dell’esistenza di un sistema di equivalenze che farebbe corrispondere a ciascuna unità di un certo campo un’unità tratta da un altro campo,51 ma attra verso l’integrazione di un certo numero di elementi naturali in un tipo d’ordine che caratterizza la cultura. Ora, questa caratte ristica è propria di ogni sistema simbolico, e più propriamente di ogni discorso, dato che il messaggio che esso comunica presup pone una codificazione supplementare rispetto a quella della lin gua; essa può venir definita nel modo seguente: utilizzazione di una materia attinta da un registro diverso da quello in cui fun ziona il sistema, materia che può essere naturale (colori, suoni, gusti ecc.) o culturale (quella fornita da sistemi semiologici già 139
costruiti); applicazione a questa materia autonomamente ordina ta, di un principio di origine che la trascenda. L’arbitrarietà del segno, risultato dell’associazione di due piani distinti del reale, viene a essere raddoppiata in forza dell’integra zione di ciascuna unità significante (integrazione che è la legge stessa di tale associazione) in un sistema differenziato che solo con sente il prodursi dell’effetto del senso. [Ibid., ed. it. pp. 102-103] Le ripercussioni del primo viaggio di Boas tra gli eschimesi si avvertono con chiarezza. Più che un interesse pratico o “eco nomico” verso l’ambiente, la società porta alla luce i significati sviluppati dall’intero ordine culturale. Per gli uomini, -non può esserci interesse o significato pratico.negli oggetti di consumo; questa è caratteristica propria degli animali, la cui relazione con l’oggetto è relegata proprio alle cose cosi come sono: La fecondità nella geografia umana non è mai indubbiamente tan to grande come quando si ha la possibilità di studiare in che mo do, sulla base di condizioni naturali globalmente identiche, certe società dello stesso tipo organizzano lo spazio, il ciclo delle attività produttive, la divisione del territorio, i ritmi di utilizzazione del suolo, ecc. I determinismi individuali sono allora di un ordine di verso da quello imposto dall’ambiente, giacché ogni società avreb be potuto fare la stessa scelta di quella vicina, e non l’ha fatta per ragioni che costituiscono il segno dei suoi intenti essenziali. E chiaro quindi da che punto di vista la nozione di struttura può ritrovare un suo relativo senso; si tratta sempre del limite del lo spirito, di ciò che è irriducibile a un certo livello di funziona mento della società. L’allevamento di una certa specie di anima li, la pratica di una determinata coltura, sono il prodotto d’un la voro continuo dell’intelletto che si esercita su un certo ambiente naturale; la fabbricazione di strumenti, il lavoro della terra, l’uti lizzazione ordinata e regolata del mondo animale presuppongo no una massa di osservazioni, di ricerche, di analisi, che, se con dotte in maniera frammentaria, non possono in alcun caso dare buoni risultati; esse non prendono forma se non attraverso la me diazione di un sistema di pensiero ben più vasto, che supera il piano teorico o semplicemente economico. In questo senso que sti ultimi non sono più “naturali” di qualsiasi altro aspetto della cultura di una società. [Sebag, 1964, ed. it. p. 207]
140
Mettendo a confronto il più recente strutturalismo con Mor gan e con Boas, ho cercato di mostrare la, continuità della lot ta dell’antropologia con il suo stesso naturalismo - e quindi an che con la natura culturale di cui è erede. Allo studio di qua le apporto possa avere per il marxismo questa controversia di indirizzi, è dedicato interamente il prossimo capitolo.
141
3.
L’antropologia e due marxismi Problem i del materialismo storico
A prima vista sembra che questo dibattito tra ragione prati ca e teoria antropologica della cultura non presenti implicazioni dirette per Marx. O, per lo meno, Marx non sembra essere coin volto in prima persona. La concezione materialistica della sto ria non è certamente un riduzionismo funzionalistico; non con cepisce la società come u n ’espressione dei processi biologici (darwinismo sociale). Questa concezione non è estranea al marxismo, ma a Marx si (cfr. Schmidt, 1966, p. 42). Né quello di Marx è un ingenuo materialismo sensistico che consideri il pensiero e la coscienza come il semplice riflesso della perce zione. Anche questa posizione è stata di famosi marxisti, non di Marx (cfr. Lenin, 1909; Cornforth, 1963; Avineri, 1971, pp. 6567; Schmidt, 1966, pp. 52 e sgg.). Inoltre, quello di Marx non è il volgare economicismo dell’individuo intraprendente, con trapposto all’ambiente sociale che egli manipola per realizzare i propri interessi. Per Marx “l’individuo è l ’essere so c ia le l’uomo è uomo solo come membro della società - mentre l’ipostasi deH“’individuo” economico, con cui la società occidentale si rap presenta a se stessa, è il prodotto alienato di quella società, la sua autocoscienza ideologica.1 Proprio riferendosi a queste idee Marx avrebbe ripetuto che se questo era marxismo, allora lui non era marxista. Il suo naturalismo è, come si è spesso nota to, una sintesi dell’attività di Hegel, senza il suo idealismo, e del materialismo di Feuerbach, senza il riflessionismo contem142
piativo. La formulazione di Habermas è molto chiara: “Il ‘lato attivo’ che l’idealismo aveva sviluppato in contrapposizione al materialismo, deve essere concepito in modo materialistico” (1968, ed. it. p. 29; cfr. Livergood, 1967). L’uomo costruisce se stesso, compresa la sua coscienza, con l’attività pratica nel mon do - attività che, comunque, anche nei suoi aspetti più solitari rivela (mediante l’uso del linguaggio) la presenza degli altri. Trasformando il mondo per la necessità di produrre nel mon do, l’uomo è trasformato nel proprio io e nei suoi rapporti con gli altri.2 Questa dialettica si origina nella produzione poiché, nel soddisfare i propri bisogni, l’uomo produce nuovi bisogni; proprio mentre agisce con i mezzi e le risorse a sua disposizio ne, modifica le condizioni materiali della sua attività. Modifi cando le sue condizioni oggettive, egli deve necessariamente mo dificare le sue concezioni, in quanto queste derivano dalla co scienza del suo essere che si oggettiva nelle modificazioni pro dotte, non meno che dai rapporti stretti con gli altri in questa produzione. Sviluppando nuove forze produttive e corrispon denti rapporti di produzione, l’uomo sviluppa una natura sto rica che determina per lui il carattere della natura vivente e della sfera spirituale cosi come il carattere politico della società. La natura, quindi, è “natura umanizzata”: la sua realtà cosi co me la concezione di essa sono in rapporto alla costituzione del la società. “Ma... la natura, astrattamente presa, per sé, fissata nella separazione dall’uomo, non è per l’uomo un bel nulla" (Marx, 1844, ed. it. p. 185). Il rapporto tra società e circostan ze oggettive è mediato da un soggetto storico. In un modo as solutamente fondamentale, quindi, la posizione di Marx su cul tura e natura - la sua visione della cultura umana come inter vento nella natura fisica - è parallela alla più recente interpre tazione antropologica.” Ma il paradigma non era mai pienamente simbolico. Per ri levare questa incompletezza si può notare che, determinando il concetto (l’idea, la categoria) come rappresentazione dell’espe rienza concreta, come la realtà del mondo trasformato dal la voro, Marx ritenga che il significato scaturisce da una proprietà del tutto opposta alla sua qualità simbolica; e cioè di “impulso indipendente”. Il processo dell’esperienza attraverso cui, nella concezione di Marx, il concetto prende vita è esattamente il con trario di ciò che caratterizza la sua esistenza come significante 143
che non è connesso ad alcuna situazione oggettiva. Quando Marx si volse, nelle sue opere più tarde, all’analisi concreta del la società e della storia, quando elaborò la sua concezione ma terialistica della storia, questa teoria della conoscenza poteva costituire un serio inconveniente. Infatti il significato si sareb be cosi trasformato in una molteplicità di nominazioni, e i con cetti culturali sarebbero stati riferiti da una parte a una logica dell’efficacia strumentale e dall’altra a una prammatica dell’in teresse materiale (ideologia di classe). Di conseguenza ci fu una seconda fase nella teoria di Marx, la fase del materialismo sto rico, che, pur sviluppandosi gradualmente dalla prima fase del la sua opera, da questa si differenziava nello stesso modo in cui la teoria della prassi all’interno dell’antropologia è diversa da una interpretazione culturale. Ora, la cultura fa la sua appari zione nella mediazione tra uomo e natura solo per farsi dissol vere da quella mediazione, naturalisticamente - nel famoso “me tabolismo” del processo. L’ordine culturale della produzione, cioè, era, per certi aspet ti fondamentali, naturalizzato, per generare le sovrastrutture quali forme culturalizzate di un ordine naturale. Marx natural mente non ha mai pensato che la natura, per quanto variabile fosse il rapporto dell’uomo con essa, potesse per questo perdere la sua autonomia. La natura rimane in-sé, refrattaria, irriduci bile. Ma il problema specificamente antropologico della conce zione materialistica era che il lato umano del rapporto tendeva anch’esso a porsi dalla parte della natura - in un certo modo a scapito della cultura. La mutevolezza storica dell’ordine cul turale era il problema che bisognava risolvere, e nel tentativo di far ciò esso fu trasformato due volte da soggetto della sua so luzione a predicato. La prima volta astraendo la storia dal sog getto umano. Nei momenti critici della teoria, l’uomo compa re nella sua essenza: come creatura di bisogni e con la necessità evidente di agire in modo finalizzato nella natura con i mezzi materiali a disposizione. Nello stesso tempo, le risorse econo miche sono assunte come un “dato” - uno stadio determinato delle forze produttive. Ma questa è u n ’astrazione positivista del la costruzione culturale esistente che ha la funzione di render la neutrale e inerte. L’organizzazione culturale diventa né più né meno che i “mezzi” di un progetto naturale-materiale per il soddisfacimento di un bisogno. Ne deriva la seconda trasposi144
zione della cultura nello status di predicato. L’ordine sociale e il pensiero sono conseguenze del finalismo pratico della produ zione, non fanno che tradurre nella loro forma propria “la lo gica obiettiva della situazione del lavoro” (Schmidt, 1966, p. 25). Allora l’attività produttiva, naturalizzata, sfugge a una determi nazione simbolica e dialetticamente la supera, per determinare per proprio conto il sistema simbolico. L’infrastruttura è analo ga al più profondo sapere della cosa-in-sé; e l’antropologia di Marx viene dopo la produzione, non si trova al suo interno. Il resto di questo capitolo elabora nei particolari questi pun ti, ma, potenzialmente, è già stato detto tutto.4
MOMENTO CULTURALE E MOMENTO NATURALE NELLA TEORIA MATERIALISTA
La pura e semplice realizzazione della natura oggettiva nella cultura umana - si tratti di realizzazione diretta o mistificata, di natura esterna o umana (biologica) - è stata considerata fin dall’inizio impossibile nel pensiero di Marx. I Manoscritti di Pa rigi già ritengono impossibile qualsiasi materialismo meccanici stico di questo tipo. Come essere autocosciente e intenzionale, l’uomo diventa oggetto del suo stesso intelletto, conosce se stes so negli oggetti naturali trasformati dalla sua attività; e cosi co nosce la natura come natura trasformata o “umanizzata”: Ma l’uomo non è soltanto un essere naturale; è anche un essere naturale umano, cioè è un essere che è per se stesso, e quindi un essere che appartiene a una specie, come tale egli si deve attuare e con fermare tanto nel suo essere che nel suo sapere. Perciò gli og getti umani non sono gli oggetti naturali, come si presentano in modo immediato; e, d’altra parte, il senso umano, come esso è in modo immediato, in modo oggettivo, non è sensibilità umana, og gettività umana. Né la natura, oggettivamente, né la natura, sog gettivamente, è immediatamente presente all’essere umano in for ma adeguata. [1844, ed. it. p. 174] Il concetto di cultura sottostante a questa problematica non è propriamente semiotico, ma il suo senso è quasi lo stesso di quello di un’antropologia autenticamente culturale. Per Marx, come per Boas (se pure grazie a differenti biografie intellet145
mali), la natura nota a ogni gruppo umano è un concetto sto rico.5 Boas giunse alla conclusione che l’occhio che vede è l’or gano della tradizione; ma solo dopo che Marx ebbe scritto che “Veducazione dei cinque sensi è un’opera di tutta la storia del mondo sino ad oggi” (1844, ed. it. p. 119). Lévi-Strauss ha po tuto definire il “pensiero selvaggio” come il tipo di pensiero che “non distingue il momento dell’osservazione da quello dell’in terpretazione” (1962a, ed. it. p. 243); ma solo dopo che Marx ebbe scritto di una società futura - che come la “primitiva” sa prà vivere senza la proprietà privata - in cui i sensi “sono di ventati immediatamente nella loro prassi, dei teorici ’ ( 1844, ed. it. p. 117). Anche nel corso di questo sviluppo i sensi sono dei teorici - ma di natura ottusa e unilaterale: “il trafficante in mi nerali vede soltanto il valore commerciale, ma non la bellezza e la natura caratteristica del minerale; non ha alcun senso mi neralogico” (ibid., ed. it. p. 119). Marx cosi continua a ripete re che la natura esterna è in rapporto con la società, dipendente dalla condizione raggiunta e dalle finalità della società. Il qua dro in cui la natura è costituita per l’uomo è fornito dai modi e dagli obiettivi storici con cui ci si rapporta a essa. Habermas osserva: Sebbene dobbiamo presupporre da un punto di vista gnoseologi co la natura come un essente-in-sé, noi stessi abbiamo accesso al la natura solo all’interno della dimensione storica aperta dai pro cessi lavorativi, in cui la natura in forma umana si media con sé come natura oggettiva che crea il terreno e l’ambiente del mon do umano. La “natura in sé” è quindi un astratto che siamo co stretti a pensare; ma noi incontriamo la natura sempre soltanto nell’orizzonte del processo di formazione storica universale del ge nere umano. [Habermas, 1968, ed. it. p. 36]6 Marx aveva abbandonato un certo tipo di “materialismo con templativo” - basato sulla nozione di un individuo astratto che riflette passivamente un mondo immutabile - per volgersi a un’epistemologia fondata sulla pratica, e a una pratica situata nella storia. La conoscenza del mondo è raggiunta agendo al suo interno e, soprattutto, trasformandolo spinti dalla necessità (e cioè con la produzione). (L’interazione tra soggetto e oggetto ha qualcosa della “secondità” di C. S. Peirce: si conosce la por ta dalla resistenza che oppone ai nostri sforzi; si raggiunge la 146
coscienza di sé attraverso la forza occorrente per aprire la por ta.) Corrispondentemente, i mondi umano e naturale devono modificarsi nella coscienza degli uomini con successive (e dia lettiche) modificazioni nelle loro attività mondane. Feuerbach, scrive Marx in un celebre passo dell’Ideologia tedesca, non vede come il mondo sensibile che lo circonda sia non una cosa data immediatamente dall’eternità, sempre uguale a se stes sa, bensì il prodotto dell’industria e delle condizioni sociali; e pre cisamente nel senso che è un prodotto storico, il risultato dell’at tività di tutta una serie di generazioni, ciascuna delle quali si è appoggiata sulle spalle della precedente, ne ha ulteriormente per fezionato l'industria e le relazioni e ne ha modificato l’ordina mento sociale in base ai mutati bisogni. Anche gli oggetti della più semplice “certezza sensibile” gli sono dati solo attraverso lo sviluppo sociale, l’industria e le relazioni commerciali. [Marx e En gels, 1845-46, ed. it. p. 16] Sottolineo la definizione sociale non soltanto della natura ma anche del “bisogno” e dello scopo, e quindi la definizione sociale della funzione tecnologica. Nulla più della natura presa per se stes sa esiste poiché l’uomo fa in modo che la tecnologia riveli il suo concetto mediante la sua forma obiettiva. Marx mantenne questa opinione nelle opere economiche successive, sostenen dola in due differenti modi; in uno di questi, polemizzando con altri economisti sulle qualità eterne delle categorie borghesi, Marx osservò che le categorie economiche con cui la tecnolo gia viene compresa - nella società in questione e dai suoi irri flessivi “economisti volgari” - costituiscono un linguaggio indipendente dall’oggetto tecnico come tale. Queste categorie non rappresentano le proprietà dell’oggetto, ma il modo in cui è usa to in una data situazione storica: l’inglobamento dei mezzi tec nici in un determinato sistema di relazioni sociali. Ciò faceva par te di un’interpretazione generale di Marx secondo la quale le categorie coscienti sono forme manifeste (modi di evidenziarsi) del loro stesso contenuto; in pratica l’intera sovrastruttura cul turale partecipa alla produzione delle categorie economiche.7 Lo sganciamento delle categorie economiche dalle proprietà tecnologiche, operato da Marx, conseguiva dal suo discorso complessivo contro la determinazione per mezzo del concetto - cioè contro l’idealismo. Ma al contempo avrebbe anche pro147
vato il contrario: che neppure la tecnologia come tale può es sere ritenuta responsabile delle categorie, dal momento che tra loro non esiste alcuna corrispondenza o conformità specifica. L’esempio più noto di questa separazione è la demistificazione della nozione di “capitale” come insieme dei mezzi della pro duzione materiale, dal momento che “capitale” è soltanto una particolare forma d ’esistenza storica di quei mezzi: Un negro è un negro. Soltanto in determinate condizioni egli di venta uno schiavo. Una macchina filatrice di cotone è una mac china per filare il cotone. Soltanto in determinate condizioni es sa diventa capitale. Sottratta a queste condizioni essa non è capi tale, allo stesso modo che l’oro in sé e per sé non è danaro e lo zucchero non è il prezzo dello zucchero. [Marx, 1847, ed. it. p. 46; 1894, ed. it. voi. Ili, pp. 927 e sgg.] Ma proprio come il “capitale” non è la macchina, cosi la “mac china” può non essere nulla di sociale indipendentemente dal la sua integrazione in un sistema dato. “La macchina non è af fatto una categoria economica”, osserva Marx, “come non lo è il bue che tira l’aratro. L’applicazione attuale delle macchine è una delle condizioni del nostro sistema economico attuale, ma il modo in cui le macchine vengono utilizzate è qualcosa di to talmente diverso dalle macchine medesime” (lettera di Marx ad Annenkov, del 28 dicembre 1846). Le implicazioni di questa di sgiunzione tra i mezzi produttivi e la loro concezione sociale ri chiedono di essere messe in evidenza, anche solo per la loro ap parente contraddizione con altre celebri affermazioni del mate rialismo storico (v. oltre pp. 176-78). In questo caso, comunque, la posizione di Marx è che l’ordine sociale (compresi i rappor ti di produzione) non è determinato dalla natura dei mezzi tec nologici. La società non è specificata dalla tecnologia, né può essere vista come una sua “espressione”. Da certi punti di vista, fondamentali, è tutto il contrario. E questa subordinazione del la tecnologia alla cultura, se cosi si può dire, può essere inseri ta nella più ampia trattazione di Marx - su cui oggi si insiste mol to - delle mediazioni tra base e sovrastruttura. “Infatti se l’eco nomia è il ‘determinante ultimo’,” come ci ricorda Mészàros (1970, ed. it. p. 141), “è anche un ‘determinante determinato’: non esiste al di fuori dell’insieme sempre concreto, storicamente mutevole delle mediazioni concrete, incluse le più ‘spirituali’.” 148
Gli obiettivi concreti della produzione sono allo stesso modo una specificazione generale dell’ordine storico-sociale. Questa è la seconda tesi, presente negli studi economici di Marx, che testimonia a favore dell’inclusione dell’infrastruttura materiale. L’argomentazione sostiene che non è possibile determinare la natura di ciò che è prodotto - cioè il carattere di valore d ’uso - semplicemente dalla natura dei bisogni umani o'dal fatto che la produzione li soddisfa. Infatti tali bisogni “umani” sono astrat ti e astorici. Ma, “i nostri bisogni e i nostri godimenti”, osserva Marx, “sorgono dalla società; noi li misuriamo quindi sulla ba se della società, e non li misuriamo sulla base dei mezzi mate riali per la loro soddisfazione. Poiché sono di natura sociale, essi sono di natura relativa” (1847, ed. it. p. 54). Ne deriva che gli attrezzi rispondono nel loro uso a u n ’intenzione sociale: Dunque, nel processo lavorativo, l’attività dell’uomo opera, attra verso il mezzo di lavoro, un cambiamento dell’oggetto di lavoro che fin da principio era posto come scopo. Il processo si estingue nel prodotto. Il suo prodotto è un valore d’uso, materiale naturale appropriato a bisogni umani mediante cambiamento .di forma. [Marx 1867, ed. it. voi. 1, p. 215] In realtà, poiché non è semplicemente la riproduzione di u n ’esistenza fisica umana ma la riproduzione di un “definito modo di vita ’ (Marx e Engels, 1845-46), l’intero sistema di pro duzione è attraversato dall’intenzionalità culturale. Nel primo momento della teoria materialista, l’etnologo del ventesimo secolo si ritrova su un terreno familiare. Egli rico nosce nella concezione materialistica della storia una media zione tra cultura e natura che non si ritrova, per esempio, nell’esposizione che fa Morgan dei primi stadi della società nonostante l’ammirazione di Marx per quest’esposizione. Egli riconosce, nella concezione di Marx, una coscienza generata dal la struttura della società, un dato storico entro il quale si svi luppa l’interazione materiale. Si può anche notare che il rifiu to che Marx fa delle riduzioni, tra loro connesse, del sapere a natura, della società a tecnologia, e della produzione a bisogno, in positivo comporta la scoperta del simbolico, poiché gli resta da spiegare una struttura di persone e cose che non può esse re riferita alla loro natura fisica. E infine, questo si potrebbe 149
applicare anche al modo in cui Marx sfugge a tutte le altre trap pole ben sistemate deH’utilitarismo, compreso il “popolazionismo” zoologico e l’individualismo economicisdco. Quanto a quest’ultimo - robinsonate sociologiche con cui i teorici hanno cercato di far derivare l’ordine sociale dal perse guimento dell’interesse individuale - la cridca di Marx va dirit ta al cuore dell’antropologia. Non è soltanto che questo “indi viduo” calcolatore, rappresentato come distaccato dalla società e operante su di essa, è una figura storica, relativa; ma lo stes so vale per i suoi famosi “interessi”. Opposti in teoria al risul tato sociale, come il privato è opposto al pubblico e la premessa alla conseguenza, di fatto questi interessi sono prodotti dai pro cessi sociali rispetto ai quali sono considerati degli a priori: L’interesse privato stesso è già un determinato interesse sociale e può essere raggiunto soltanto nell’ambito delle condizioni che la società pone e con i mezzi che essa offre; quindi è legato alla riproduzione di queste condizioni e di questi mezzi. Si tratta di in teresse dei privati; ma il suo contenuto, come la forma e i mezzi della sua realizzazione, sono dati da condizioni sociali indipen denti da tutti. [Marx, 1857-58a, ed. it. voi. I, p. 97] D’altra parte, agli individui, presi come astratto aggregato di “popolazione”, non sarebbe stato accordato lo status teorico nor malmente attribuito a quella nozione dell’antropologia utilita ristica, che intende la “popolazione” come quantità che deter mina meccanicamente la forma della società, o come finalità la cui sopravvivenza biologica rappresenta il sapere segreto delle forme sociali. Adottando una posizione più prossima a quella di Fortes che a quella di Worsley, Marx ribadisce che la “po polazione” può essere compresa solo nel suo agire o reagire co me organizzazione. La popolazione è un’astrazione, se tralascio a esempio le classi di cui si compone. E le classi sono a loro volta una parola priva di senso, se non conosco gli elementi su cui esse si fondano, per es., lavoro salariato, capitale ecc. E questi presuppongono scambio, divisione del lavoro, prezzi ecc. Il capitale, per es., non significa nulla senza il lavoro salariato, senza il valore, il denaro, il prezzo ecc. Se incominciassi quindi con la popolazione avrei una rap presentazione caotica dell’insieme. [Ibid., ed. it. voi. 1, p. 26] 150
In tutti questi aspetti - e senza approfondire la funzione del la pratica come elemento costitutivo del mondo - il moderno etnologo riconoscerà in Marx un fratello in antropologia. Ma c’è un secondo momento o aspetto nella concezione ma terialistica, che dimostra essere sbagliata la supposizione che il concetto di Marx della mediazione storica tra uomini e natura sia costituito da una logica culturale interposta, come nella teo ria boasiana. La vera mediazione è la logica razionale e mate riale della produzione che la ragione piega al servizio delle pro prie intenzioni, quale che sia il carattere storico di queste in tenzioni. A questo punto la promessa di un’anUopologia cultu rale sembra sciolta. Il paradigma di Marx si è trasfigurato nel l’opposto di un paradigma culturale. Ora l’organizzazione si sviluppa dal comportamento, e il linguaggio degli uomini è la voce della loro esperienza concreta. Il concetto di cultura ap pare la conseguenza più che la struttura dell’attività produttiva. Il valore d’uso - quei desideri e piaceri che scaturiscono dalla società - perdono i mezzi obiettivi della loro acquisizione. E la “storia” è di conseguenza disciolta dall’acida logica della prati cità, e scambia la sua posizione teorica di ente sedimentato con un passato superato o uno sfuggevole divenire. Il fatto che il ma terialismo storico si basi fondamentalmente sul concetto di la voro, e che il lavoro si basi sulle sue specificazioni materiali, priva la teoria delle sue proprietà culturali e la abbandona allo stesso destino del materialismo antropologico. L’esperienza pra tica degli uomini non è superabile; con questa essi costruisco no un mondo. I loro pensieri e i rapporti sociali in genere de rivano dal “sistema di comportamento dell’azione strumentale”. La dimensione più ampia di questa sospensione della cultu ra nella concezione materialistica, della sua sottomissione a una logica del mondo che la trascende, può essere illustrata dal]’Ideo logia tedesca. Ci sarà l’occasione di approfondire le ripercussio ni su altre opere, ma è opportuno cominciare di qui, poiché i seguenti passi di critica a Feuerbach suonano come bordate con tro la posizione simbolico-boasiana. Qui l’organizzazione è con cepita come codificazione dell’esperienza empirica, che risulta “evolvere... dal processo della vita di individui determinati” proprio nel modo in cui, si potrebbe dire, la nostra società ci appare, ma assolutamente non nel modo in cui è ordinata con is i
cettualmente. Infatti alla concettualizzazione si contrappone una “realtà” più dura: Il fatto è dunque il seguente: individui determinati che svolgono un’attività produttiva secondo un modo determinato entrano in questi determinati rapporti sociali e politici. In ogni singolo caso l’osservatore empirico deve mostrare empiricamente e senza al cuna mistificazione e speculazione il legame tra l’organizzazione sociale e politica e la produzione. L ’organizzazione sociale e lo Stato risultano evolvere costantemente dal processo della vita di individui de terminati; ma di questi individui, non quali possono apparire nella rap presentazione propria o altrui, bensì quali sono realmente, cioè come operano e producono materialmente, e dunque agiscono fra li miti, presupposti o condizioni materiali determinate e indipen denti dal loro arbitrio. [Marx e Engels, 1845-46, ed. it. pp. 12-13; corsivo mio] L’esperienza, dunque, non è organizzata come situazione sim bolica. Il linguaggio stesso è ridotto a un altro discorso, non so lamente non-simbolico ma muto: l’irriducibile razionalità della prassi. Da questo “linguaggio della vita reale” viene il parlare degli uomini, che all’inizio può essere solo l’articolazione di un codice silenzioso preesistente: La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in primo luogo direttamente intrecciata all’attività materiale e alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uo mini appaiono qui ancora come emanazione diretta del loro com portamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la produzio ne spirituale, quale essa si manifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione, della metafisica ecc. di un popolo. Sono gli uomini i produttori delle loro rappresenta zioni, idee ecc., ma gli uomini reali, operanti, cosi come sono, condizionati da un determinato sviluppo delle forze produttive e delle relazioni che vi corrispondono fino alle loro formazioni più estese. La coscienza non può mai essere qualche cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale della loro vita. [Ibid., ed. it. p. 13] Ma questa destituzione dell’ordine concettuale da parte del la produzione produce disordine nell’attività concettuale degli 152
uomini. Nello sviluppo del discorso di Marx, l’ordine simboli co è eliminato dalla produzione per riapparire come “fantasmi” formati nel cervello degli uomini, “sublimazioni del processo materiale della loro vita”. Inoltre, senza alcuna logica interna, alcun sistema in essi, i concetti non hanno né indipendenza né storia; il che equivale a dire che anche lo schema significante non ha energia in sé, ma solo la forza riflessa di ciò che è es senziale: i mezzi e i rapporti di produzione. Esattamente all’opposto di quanto accade nella filosofia tedesca, che discende dal cielo sulla terra, qui si sale dalla terra al cielo. Cioè non si parte da ciò che gli uomini dicono, si immaginano, si rappresentano, né da ciò che si dice, si pensa, si immagina, si rap presenta che siano, per arrivare da qui agli uomini vivi; ma si par te dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo rea le della loro vita si spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici di questo processo di vita. Anche le immagina nebulo se che si formano nel cervello dell’uomo sono necessarie subli mazioni del processo materiale della loro vita, empiricamente con statabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza la mo rale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica, e le forme di coscienza che a esse corrispondono, non conservano ol tre la parvenza dell’autonomia. Esse non hanno storia, non han no sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione ma teriale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con que sta loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pen siero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che de termina la coscienza. [Ibid., ed. it. p. 13] Non voglio qui entrare nel merito della controversia che in furia tra i marxologi sul “giovane Marx” umanista contro il “Marx maturo”, scientifico. Il problema è quello della pretesa rottura (“coupure”) del 1844-45, subito prima dell’Ideologia tede sca, quando Marx, allontanandosi da Hegel e dall’interesse per l’alienazione umana in favore dell’analisi concreta della storia e della società borghese, abbandonò definitivamente l ’antro pologia” tradizionale, la spiegazione che assume il soggetto uma no come punto di partenza (Althusser, 1965; Althusser e Balibar, 1965). Chiaramente, come molti studiosi di Marx hanno sostenuto, ci sono delle continuità insieme alle rotture. Per prendere un esempio pertinente al problema che stiamo trat tando, quando Marx si dedicò agli studi economici e storici, il 153
nemico “idealista” necessariamente mutò: non fu più lo Spirito Assoluto di Hegel, ma le categorie ideologiche con cui una so cietà - e i suoi economisti - prende coscienza della sua azione. Ma proprio perché il problema era lo stesso, la derivazione del mondo dal concetto, così la critica dello Spirito Assoluto pote va applicarsi anche all’ideologia economica: l’“idea” si sviluppa sempre dall’esperienza della vita reale, dalla pratica nel mondo reale - tuttavia l’origine di questa critica sta in primo luogo nell’idealismo hegeliano. In una lettera a Engels, in cui critica u n ’opera di storia economica, Marx espone u n ’epistemologia delle categorie logiche - degna, oltre tutto, di essere parago nata a quella di Durkheim - che compendia questa complessa dialettica. Ma che cosa direbbe old Hegel se sapesse nell’al di là che l’Uni versale [Allegemeine] in tedesco e in nordico non significa altro che la terra comune [Gemeinland], e il particolare, das Sundre, Besondere, null’altro che la proprietà particolare separata dalla terra co mune? Ecco che davvero, maledizione, le categorie logiche pro vengono dal “nostro commercio” [i rapporti di produzione]. [25 marzo 1868, in Marx e Engels, 1935, ed. it. voi. V, p. 166] E infine, nel contesto dell’analisi concreta dell’ordine socia le, la nozione prammatica di significato in Marx sarebbe di ventata positiva e funzionale. Le categorie, come i rapporti di produzione, incarnano la logica strumentale di un dato stadio delle forze produttive, una logica che ha anche una reincarna zione di secondo grado come ideologia funzionale a un dato ti po di dominazione di classe. Questo gioco combinato di conti nuità e discontinuità aiuta a spiegare ciò che ho chiamato “mo mento culturale e momento naturale” nella teoria di Marx e, soprattutto, la contraddizione palese tra la costituzione sociale della logica materiale, derivante dalla concezione, stabile in Marx, di una natura umanizzata, e la costituzione materiale del la logica sociale - che diventò la nozione predominante del “ma terialismo storico”.8 Per completare questa documentazione preliminare del “se condo momento” della teoria materialistica, riporto per esteso il commento di Marx ad Annenkov sulla Filosofia della miseria di Proudhon. Il contrasto evidente con il momento culturale di mostra anche il disaccordo a livello antropologico: 154
Che cosa è la società, quale che sia la sua forma? Il prodotto dell’azione reciproca degli uomini. Forse che gli uomini sono li beri di scegliersi questa o quella forma sociale? Niente affatto. Pre supponga un determinato stadio di sviluppo delle capacità pro duttive degli uomini e Lei avrà una forma corrispondente di com mercio e di consumo. Presupponga gradi determinati di sviluppo della produzione, del commercio e del consumo, e Lei avrà una forma corrispondente di ordinamento sociale, una organizzazio ne corrispondente della famiglia, dei ceti e delle classi, in una pa rola avrà una società civile corrispondente. [...] Non c’è bisogno di aggiungere che gli uomini non sono i li beri arbitri delle loro forze produttive, la base di tutta quanta la lo ro storia; infatti ogni forza produttiva è una forza acquisita, è il prodotto di un’attività precedente. [...] La necessaria conseguenza è: la storia sociale degli uomini è sempre e soltanto la storia del loro sviluppo individuale, ne siano essi coscienti o no. I loro rapporti materiali formano la base di tutti i loro rapporti. Questi rapporti materiali non sono altro che le forme necessarie, nelle quali si realizza la loro attività materia le e individuale. Quando il loro commercio non corrisponde più alle forme sociali, prosegue Marx, essi ne cambiano le forme, per non essere privati del risultato ottenuto, per non perdere i frutti della civiltà. [...] Le forme economiche sotto le quali gli uo mini producono, consumano, scambiano sono dunque transitorie e storiche. Con nuove capacità produttive acquisite gli uomini cambiano il loro modo di produzione, e col modo di produzio ne essi cambiano tutti i rapporti economici i quali non erano che relazioni necessarie di quel determinato modo di produzione... Cosi Proudhon, soprattutto per mancanza di nozioni storiche, non si accorge: che gli uomini, sviluppando le loro capacità pro duttive, cioè vivendo, sviluppano determinati rapporti tra loro, e che il modo di questi rapporti si trasforma necessariamente col trasformarsi e il crescere di queste capacità produttive. [...] Proudhon ha capito molto bene che gli uomini producono pan ni, tele, sete; aver capito una tale inezia è davvero un grande me rito! Invece Proudhon non ha capito che gli uomini, a seconda delle loro capacità, producono anche le relazioni sodali nelle qua li producono panno e tela. Ancor meno Proudhon ha capito che gli uomini, i quali producono le relazioni sociali corrispondente mente alla loro produttività materiale, producono anche le idee, 155
le categorie, cioè le espressioni astratte ideali di queste stesse rela zioni sociali. Le categorie sono altrettanto poco eterne quanto le relazioni che esse esprimono. [Lettera di Marx ad Annenkov, 28 dicembre 1846 in Marx e Engels, 1936, pp. 7-14]
Rispetto all’idealismo hegeliano, Marx aveva avanzato una ri vendicazione a favore dell’uomo: non è lo Spirito che prende coscienza di sé come esistenza, ma piuttosto è l’uomo che mo della uno spirito ideale sulla base della sua esistenza concreta; e non occorre che l’uomo si umili davanti a esso, sua propria creatura. Trasposta alla teoria della cultura, la rivendicazione suona cosi: non sono le idee coscienti che gli uomini hanno, la loro “immaginazione”, a ordinare la loro attività reale-produtti va; ciò di cui essi sono coscienti è solo un’apparenza o espres sione di questa attività. Questa concezione della storia, scrivo no Marx ed Engels “non deve cercare in ogni periodo una ca tegoria, come la concezione idealistica della storia, ma resta sal da costantemente sul terreno storico reale, non spiega la prassi partendo dall’idea, ma spiega le formazioni di idee partendo dalla prassi materiale” (1845-46, ed. it. p. 30). Cosi in contrasto con la fondamentale valutazione di Marx secondo la quale l’uo mo trasforma la natura, produce cioè, secondo un progetto (ve di anche sopra, pp. 129-132), ora ogni attività concettuale ten de a essere eliminata dall’infrastruttura per riapparire come co struzione delle sue trasformazioni materiali. L’obiezione antro pologica sarebbe che Marx giunge in tal modo a una visione monca del processo simbolico. Lo vede solo nel suo carattere secondario di simbolizzazione - la “formazione secondaria” di Boas - come modello di un dato sistema a livello cosciente, igno rando che il sistema cosi simbolizzato è a sua volta simbolico. C’è inoltre l’errore, condiviso da Marx con alcuni funzionalisti-dualisti, di limitare il simbolo dell’“ideologia”, lasciando scivolare cosi l’azione nel regno del prammatico. Affrontando il signifi cato solo nella sua capacità di esprimere rapporti umani, Marx lascia sfuggire dalle maglie della teoria la costituzione signifi cativa di questi rapporti. Questo tipo di semiotica aiuta a situare il ruolo del linguag gio nella teoria generale del materialismo storico.
156
G E N E A L O G IA D EL P E N S IE R O C O N C E T T U A L E
Abbiamo visto che Marx fa una distinzione tra due tipi di di scorso, il “linguaggio della vita reale” e le parole con cui gli uo mini concepiscono la loro esistenza sociale; e che le seconde sono considerate dipendenti dal primo. L’accento posto sul ruo lo della prassi nella storia, in tal modo privilegia le forze reali sperimentate nella produzione rispetto al modo in cui gli uo mini se le raffigurano. Le condizioni materiali della produzio ne diventano decisive nella misura in cui gli uomini, se davve ro vogliono soddisfare i propri bisogni, devono venire a patti con queste condizioni cosi come esse sono. Il soggetto e l’oggetto possono essere entrambi poli atdvi nella teoria marxiana della conoscenza (Livergood, 1967), ma non è l ’oggetto ad aver bisogno del soggetto. E l’uomo l’essere “limitato” e “sofferente”. Di con seguenza la reciprocità implicita nell’idea di dialettica viene nel la pratica sussunta da una più efficace logica lineare dell’obiet tivo soddisfacimento. La logica prammatica del work forma una griglia di costrizioni materiali a cui tutti i rapporti e i concetti sono sottoposti funzionalmente. Che questa prassi prenda posto in un mondo già simbolizzato, in una costruzione sociale della realtà, si può anche riconoscerlo, ma ciò non può resistere di fronte alla vera natura delle cose più di quanto la produzione possa crescere efficacemente senza fondarsi sulla ragione mate riale. In questo caso la determinazione simbolica dei bisogni cioè il relativo sistema culturale di oggetti - è dissolta dalla teo ria nell’atto assoluto e obiettivo del loro soddisfacimento. L’in tenzione storica è travestita da premessa pratico-naturale - e cioè: i bisogni devono essere soddisfatti. In questo modo la cul tura è eliminata dall’atto della sua stessa riproduzione. Più in particolare, parola e pensiero brillano di luce riflessa. Per ogni scopo teorico, derivante da ogni scopo pratico, il lin guaggio non è in gioco nel momento dell’esperienza concreta ma deve uniformarsi di riflesso e in modo prammatico a quell’esperienza. L’esperienza è in primo luogo, e in maniera preminente sempre, la produzione di beni necessari; “il vivere implica prima di tutto il mangiare e bere, l’abitazione, il vesti re e altro ancora. La prima azione storica è dunque la creazione dei mezzi per soddisfare questi bisogni, la produzione della vi ta materiale stessa” (Marx e Engels, 1845-46, ed. it. p. 18; cor157
sivo mio). Questa tesi è particolarmente distante da quella se condo cui l’uomo si distingue dagli altri animali per la co scienza, e simili; quello che è importante è che gli uomini ini ziano a distinguersi dagli animali quando iniziano a produrre i propri mezzi di sussistenza (ibid., ed. it. p. 20). La coscienza prende forma come conseguenza di questa produzione, e il lin guaggio come “coscienza pratica” che sorge dalla necessità dei rapporti tra gli uomini nel corso della produzione (ibid., ed. it. pp. 20-21). Quindi soltanto dopo aver considerato le “relazioni storiche primarie” - produzione dei mezzi di sussistenza, di nuo vi bisogni, della famiglia e modi di cooperazione - soltanto al lora “troviamo che l’uomo è in possesso di una coscienza” (ibid.; cfr. Schaff, 1966, ed. it. pp. 73 e sgg.). Engels, che partecipò al la formulazione della tesi, la riprese quasi alla lettera e, su que sta base, forni una spiegazione della transizione dalla scimmia all’uomo: Il dominio sulla natura iniziatosi con lo sviluppo della mano, con il lavoro, ampliò, a ogni passo in avanti che veniva fatto, l’oriz zonte dell’uomo. [...] D’altro lato, lo sviluppo del lavoro ebbe co me necessaria conseguenza quella di avvicinare di più tra di loro i membri della società, aumentando le occasioni in cui era ne cessario l’aiuto reciproco, la collaborazione, rendendo chiara a ogni singolo membro l’utilità di una tale collaborazione. [Si noti la logica utilitaria.] Insomma: gli uomini in divenire giunsero al punto in cui avevano qualcosa da dirsi. [...] In primo luogo il la voro, dopo di esso e con esso il linguaggio. [Engels, 1873-86, ed. it. pp. 460-462] La pseudostoria non fa altro che drammatizzare una caratte ristica fondamentale del sistema: che il linguaggio è strumen tale, molto più di quanto pensasse Malinowski. Nato nello sfor zo di dominare il mondo, le sue classificazioni sono traduzioni delle distinzioni utilitarie poste dalla prassi, segni il cui valore determinato è in funzione dell’utilità.9 Cosi in uno degli ultimi scritti (1881), le glosse al testo di eco nomia politica di A. Wagner, Marx espone una vera e propria teoria della pensée sauvage - una teoria che interessa l’antropo logia non solo perché tratta direttamente del “primitivo”, ma perché lo fa in un modo che è puro Malinowski. Il passo in questione è stato recentemente citato ampiamente come esem158
plifìcazione della teoria fondamentale della conoscenza in Marx. La sua esposizione come mito di origine è ancora interessante. Schmidt la chiama “una specie di genealogia del pensiero con cettuale” - e non ha certamente più rapporti col passato reale di quanto Evans-Pritchard non ne abbia scoperto nelle genea logie dei lignaggi Nuer. Ma, ciò che per il momento più importa è che qui Marx, mostrando roriginaria identità tra la parola e “il linguaggio della vita reale”, ci spiega la sua idea sulla loro connessione fondamentale: che la parola è sempre collegata al le condizioni dell’azione, poiché entrambi hanno una radice comune e un comune significato nell’utilità materiale. Conti nuità e discontinuità nel concetto sono introdotte dalle diffe renziazioni nel mondo esterno che, come l’esperienza ha inse gnato, sono di ordine pratico. Marx non concederà al profes sore idealista - qui si tratta di Wagner, ma la critica ripete quel la già rivolta a Feuerbach, per non dire della critica di Malinowski a E.B. Tylor - che gli uomini cominciano nel momento in cui stanno in relazione teorica con gli oggetti del mondo: es si cominciano coll’agire, col mangiare, con l’appropriarsi que sti oggetti. Arriviamo cosi al nodo antropologico: ciò che Marx trascura è che gli uomini cominciano come uomini, a differenza de gli altri animali, esattamente quando hanno esperienza del mon do come concetto (simbolicamente). Non si tratta di una que stione essenzialmente di priorità, ma del fatto che la qualità specifica dell’esperienza umana è il suo essere esperienza si gnificante. Né è in discussione la realtà del mondo; ma quale dimensione del mondo diventi pertinente, e in che modo ciò avvenga, per un dato gruppo umano, grazie alla costituzione si gnificativa dell’oggettività degli oggetti. Marx, comunque, è un teorico sociale presimbolico. Il linguaggio, per lui, è un processo di nominazione, il punto di concordanza tra testo sociale e te sto materiale. La prima classificazione che gli uomini fanno è la distinzione tra cose piacevoli e spiacevoli, commestibili e non commestibili. Nel linguaggio è la natura stessa che parla, e all’origine senza metafora. Il potere umano di assegnare un va lore a differenze naturali è ridotto a un’eco del significato pra tico-intrinseco. La “genealogia del pensiero concettuale” di Marx è il totemismo di Malinowski:
159
TOTEMISMO
tìl'.NKAUHilA
DEL PENSIERO CONCETTUALE
Per un professore pedante i rap porti dell’uomo con la natura non sono aH’inizio rapporti pratici., cioè rapporti fondati sull’azione, ben sì teoretici. [...] L’uomo sta in rap porto con le cose del mondo esterno come con mezzi per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Ma gli uomini non cominciano af fatto “a stare in questo rapporto teoretico con cose del mondo esterno”. Gli uomini cominciano come ogni animale a mangiare a bere ecc., e dunque non a stare in un rapporto, bensì a compor tarsi attivamente, a impadronirsi di certe cose del mondo esterno mediante l’azione e così a soddi sfare il loro bisogno. (Essi comin ciano dunque con la produzio ne.) Con la ripetizione di questo processo, la proprietà di queste cose di “soddisfare” i loro “biso gni” si imprime nel loro cervello; gli uomini come gli animali im parano a distinguere anche “teo reticamente” da tutte le altre quel le cose esterne che servono al sod disfacimento dei loro bisogni. A un certo stadio dell’evoluzione, quando si sono moltiplicati e svi luppati ulteriormente i bisogni e le attività per soddisfarli, gli uo mini daranno un nome a intere classi di queste cose, che l’espe rienza ha insegnato loro a distin guere dal resto del mondo ester no. Questo fenomeno ha luogo ne cessariamente, poiché nel proces so di produzione - cioè nel pro160
[Per la teoria di Tylor sull’animi smo, l’uomo primitivo era con templativo e razionale; il lavoro dei campi mostra il selvaggio in teressalo alla pesca e all’orticoltu ra ...] Nel totemismo vediamo quindi non il risultato delle specu lazioni dell’uomo primitivo su fe nomeni misteriosi, ma un misto di inquietudine utilitaristica verso gli oggetti più necessari del suo am biente e una certa preoccupazione verso quelli che colpiscono la sua immaginazione e attirano la sua at tenzione, come uccelli bellissimi, rettili e animali pericolosi. [...] [Il totemismo] esprime l’inte resse dell’uomo primitivo per ciò che lo circonda, il desiderio di re clamare un’affinità con le cose più importanti. [...] La strada che va dall’ambiente alla pancia del selvaggio e quindi alla sua mente è assai corta, e per lui il mondo è uno sfondo indif ferenziato contro cui spiccano le specie di animali o di piante uti li, soprattutto commestibili. Abbiamo così trovato la rispo sta alle nostre domande: l’inte resse selettivo dell’uomo per un numero limitato di animali e di piante e il modo in cui questo in teresse è ritualmente espresso e socialmente condizionato appare il risultato naturale dell’esistenza primitiva, dell’atteggiamento spontaneo del selvaggio verso gli oggetti naturali e verso le proprie occupazioni prevalenti. Dal punto di vista della sopravvivenza, è vi-
cesso di appropriazione di queste cose - gli uomini stanno conti nuamente in rapporti di lavoro tra loro e con le cose stesse, e ben presto entreranno anche in con flitto con gli altri uomini per il possesso di queste cose. Ma que sto dar nome alle cose esprime soltanto sotto forma di rappre sentazione ciò che una ripetuta verifica ha reso esperienza, e cioè che a uomini che vivono già in un certo contesto sociale - e questo è un presupposto necessario già per 1’esistenza del linguaggio certe cose esterne servono al sod disfacimento dei loro bisogni. [Marx, cit. in Schmidt, 1966, ed. it. pp. 102-103]10
tale che l’interesse dell’uomo per le specie praticamente indispen sabili non venga mai meno, che la sua credenza nella propria ca pacità di controllarle gli dia forza e resistenza nelle sue attività e sti moli la sua osservazione e cono scenza delle abitudini e della na tura degli animali e delle piante. Il totemismo appare cosi una be nedizione accordata dalla religio ne agli sforzi dell’uomo primitivo nei suoi rapporti con l’ambiente utile, alla sua “lotta per l’esisten za” [Malinowski, 1925, ed. it. pp. 32, 53, 55]
Vorrei far notare - riservandomi oltre un’esposizione più ap profondita - che questa teoria della conoscenza era implicita nel punto di partenza di Marx, e che ha sempre rappresentato una base d ’appoggio del suo progetto intellettuale, dalla fase “umanista” fino a quella scientifica. Ci si potrebbe qui rifare al la testimonianza di Kolakowski. Senza conoscere, pare, il testo su Wagner, Kolakowski trova “in embrione” nei primi scritd di Marx, soprattutto nei Manoscritti di Parigi, u n ’idea della cogni zione che conduce direttamente alla “genealogia del pensiero concettuale”. Infatti, su questa base, lo stesso Kolakowski ripro duce tale genealogia in un passo che ha stretta somiglianza a un tempo con Marx e con Malinowski: La coscienza umana, il pensiero pratico, pur non producendo l’esistenza, la produce in quanto composta di individui divisi in specie e in generi. Dal momento in cui l’uomo nella sua filoge nesi e ontogenesi comincia a dominare con l’intelletto il mondo delle cose - dal momento in cui inventa strumenti che possono organizzare il mondo e poi esprime quest’organizzazione me diante le parole - egli trova quel mondo già strutturato e diffe renziato, non secondo una qualche pretesa classificazione natu rale, ma secondo una classificazione imposta dal bisogno pratico 161
di orientarsi nel proprio ambiente. Le categorie in cui questo mondo è stato diviso non sono il risultato di una convenzione o di un accordo sociale volontario; sono create invece dal tentativo spontaneo di vincere la resistenza delle cose. È questo sforzo di mettere sotto controllo il caos del reale che determina non sol tanto la storia del genere umano, ma anche la storia della natu ra come oggetto dei bisogni umani - e noi possiamo compren derla solamente in questa forma. Le segmentazioni del mondo in specie e in individui dotati di tratti particolari atti a essere per cepiti separatamente, sono il prodotto del pensiero pratico, che rende risibile l’idea di opposizione e anche di ogni genere di dif ferenza tra pensiero pratico e teorico. [Kolakowski, 1969, p. 46] Secondo le parole di un moderno linguista marxista, “Les hommes parlent comme le -leur suggère la vie, la pratique” (Schaff, 1964). Non che Schaff e altri sofisticati linguisti che si muovono in un quadro marxista credano - più di quanto lo credesse Marx stes so - che le parole o le categorie grammaticali siano la semplice copia delle proprietà sensibili del mondo. Al contrario, per i membri di una data comunità linguistica la loro lingua contie ne classificazioni del mondo che organizzano l’esperienza che es si ne hanno. Volosinov scrive: “Non è l’esperienza che organiz za l’espressione, ma viceversa - l’espressione organizza l’esperienza. L’espressione è ciò che per prima dà all’esperienza la sua for ma e la sua specificità di senso” (1929, ed. it. p. 158). Il punto allora diventa: da dove vengono le categorie dell’espressione? La risposta è: dalla pratica sociale in quanto emergente dalle di stinzioni presenti nell’azione della base economica - in altre pa role, dalla logica dell’esperienza concreta. Scrive Volosinov: Questo è l’ordine che segue l’effettivo processo generativo della lingua: il rapporto sociale è generato (risalendo dalla base); in esso sono generate l’interazione e la comunicazione verbale; e in quest’ultima, sono generate le forme degli atti di parola; infine, questo processo generativo è riflesso nel mutamento delle forme linguistiche. [1929, ed. it. p. 174]11 Due parole sulla storicizzazione del materialismo, esemplifi cata da delimitazioni quali: “il primo atto storico”, ossia sulla cosiddetta genealogia del pensiero concettuale. Da una parte, la “storia” qui consiste nella trasformazione speculativa del rap porto strutturale tra base e sovrastruttura in un ordine di pre162
cedenza temporale. Il processo in realtà comporta diverse fasi logiche, che essenzialmente hanno origine in un a priori fun zionale. Marx prima trasforma la necessità dell’uomo di assicu rarsi i mezzi di sussistenza nella predominanza strutturale della produzione, e poi pone il primato della produzione come con cretamente antecedente nel tempo. In tal modo dall’imperati vo funzionale per cui “l’uomo deve essere in grado di vivere per poter fare la storia” Marx trae la conclusione che “la vita si gnifica prima di ogni altra cosa mangiare e bere”, e su questa base proietta questa sequenza temporale in un evento storico reale: “il primo atto storico è cosi la produzione di mezzi per soddisfare questi bisogni”. In breve, Marx trasforma uno spazio teorico in un tempo ipotetico. La storia, o quanto meno la teo ria della storia, è dedotta da una stima di funzioni; cioè dalla premessa che il soddisfacimento dei bisogni biologici e fisici dell’uomo è la più incessante e stringente tra tutte le attività umane; ed è quindi il prerequisito per tutte le altre. Tra pa rentesi, è abitudine di certi strutturalisti opporsi a questo at teggiamento fin dalla sua premessa - ma, cosi facendo, vengo no meno al loro proprio procedimento. L’obiezione si basa sul fatto che ci sono altri “bisogni” altrettanto stringenti del man giare - e non soltanto il sesso, ma, per esempio, la necessità di classificare, sia pure solo per fissare quelle continuità e discon tinuità tra gruppi di uomini che rendono possibile la società. Ma questa confutazione non è mai definitiva, perché accetta il quadro funzionalista dell'avversario. Subordina la classificazio ne simbolica, che è la condizione che definisce e denota la cul tura, al discorso della praticità funzionale. Chi può allora deci dere tra “bisogni” che sono allo stesso modo indispensabili? Co me si possono attribuire priorità tra funzioni, se la mancanza di una qualsiasi di esse renderebbe impossibile l’umanità? Lo strutturalismo farebbe un errore scendendo sul terreno degli argomenti del funzionalismo. Può solo trasformare una posi zione di vantaggio in uno stallo. C’è già u n ’idea migliore a por tata di mano: il concetto incontestabile, che si può sostenere anche con il ricorso ai testi di Marx, che neanche l’infrastrut tura corrisponde direttamente ai “bisogni” biologici. Il sistema simbolico è una condizione ineliminabile anche per la prassi, finché il termine si applica a una qualsiasi società storica. Esiste, d ’altra parte, un altro tipo di imperativo teorico im163
plicito nella identificazione di un “primo atto storico” o nel ten tativo di tracciare una preistoria speculativa del concetto. Chia ramente, la via che conduce alle origini è costruita all’interno dell’esposizione delle teorie scientifiche della storia: “Presup ponga un determinato stadio di sviluppo delle capacità pro duttive degli uomini e Lei avrà...” La formula positivista è un’au torizzazione a concepire ogni condizione storica come tabula ra sa; proiettare questo metodo su un “primo tempo” è solo la for ma nella sua essenza della stessa coscienza. Ma, soprattutto, i diritti concessi da una teoria scientifica della storia qui si ag ganciano con le pretese di una teoria della conoscenza ugual mente empirica, pretese di fare di ogni tempo un’origine. Per lo calizzare il concetto come formazione secondaria dell’esperien za, Marx deve adottare lo stesso genere di approccio arbitrario all’azione significante, lo stesso genere di chirurgia analitica, im pliciti nel richiamo scientista a un “determinato stadio delle for ze produttive”. Cioè, l’atto che nella realtà esiste in un partico lare contesto - in uno schema particolare e storico delle forze produttive - viene isolato, astratto e premesso al contesto. Le specificazioni simboliche della realtà storicamente effettive ven gono sospese per far luogo alle realtà materiali eterne e gene riche. Lasciando da parte le orìgini immaginarie del genere umano, perfino la dialettica della storia reale conoscerà un si mile momento di creazione pratica - quando cioè l’intero or dine culturale è ristrutturato lungo le linee di una ragione ma teriale rivelata. Il momento analitico decisivo interviene quan do la società precedente è distrutta, allo scopo di risorgere, e in modo tale da trarre significato dalle sue necessità. Infatti an che se - stando alla descrizione che fa Marx del processo nel le Forme economiche precapitalistiche - la sua propria riproduzione è il fine di ogni società, nel riprodursi per mezzo dell’azione nella natura la società è in grado di cambiare quella natura e quindi la natura sua propria. Essa si riorganizza su una nuova base materiale. Il carattere trasformatore della dialettica non è in tal modo per Marx una forza metafisica, come qualcuno ha sostenuto, ma corrisponde a una capacità più fondamentale: la forza di una razionalità obiettiva che deve impadronirsi delle condizioni “cosi come sono”, pena la distruzione sociale da par te della contraddizione materiale. Il “linguaggio della vita rea le” trionfa sopra ogni costruzione derivata sovrapposta al mon164
do, e “nuove concezioni, nuovi modi di rapportarsi, nuovi bi sogni, e una nuova lingua” seguono allora nella scia del cam mino storico della società. Il pensiero “storico” cosi opera una spaccatura nell’insieme simbolico, per ritrovare le origini in un discorso di cose, pratico e universale, che la società ha già con cepito nei suoi propri termini.12
NATURALIZZAZIONE DELLA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA
La società può organizzare un discorso di cose, ma poiché il materialismo storico subordina i significati, mediante i quali una data società ha a che fare con l’obiettività, alle coordinate del le situazioni lavorative, essa non sviluppa un concetto generale né delle proprietà significanti dei beni né della concreta razio nalità del lavoro. La prima domanda, come rendere conto del tipo di beni che una società produrrà, della loro precisa forma e contenuto, è una domanda che, nella teoria di Marx, non tro va risposta. “Ma qual è la sede in cui vanno trattati questi pro blemi concernenti il sistema dei bisogni e il sistema dei lavori?” (Marx, 1857-58a, ed. it. voi. II, p. 166). E in effetti, come dare ragione di cosa un certo gruppo umano consideri un “soddi sfacimento”? Nulla è altrettanto variabile, arbitrario dal punto di vista naturale, o analiticamente fondamentale, quanto il “si stema di bisogni”. Ma la teoria antropologica della produzione voleva essere una teoria speciale o comparativa? Il materialismo storico ha mancato di rispondere sulla natura del valore d’uso, o, più precisamente, sul codice culturale di persone e oggetti che organizzano i “bisogni” di tali valori d ’uso (cfr. Baudrillard, 1968; 1972). Lo sviluppo di finalità produttive, e quindi del “si stema dei lavori”, è lasciato senza spiegazioni, come un buco teo retico: è attribuito a una variabilità storica non approfondita, o anche ridotta, insieme con i rapporti di produzione, alle ne cessità naturali del mangiare e del bere. L’assenza di una logi ca culturale nella teoria della produzione diventa un invito per manente a ogni sorta di naturalismo. Eppure bisogna sottolineare che dobbiamo a Marx il rico noscimento di ciò che si è perso. Nonostante tutta l’enfasi con cui ha ripetutamente detto che l’uomo deve mangiare innanzi 165
tutto, e quindi che ogni analisi dell’uomo deve essere “empiri ca”, iniziare, cioè, “al posto giusto - dai bisogni materiali dell’uo mo” (McLellan 1970, p. 180) - malgrado tutto ciò, è stato Marx a insegnare che i contenuti del bisogno umano non si esauri scono con questi riferimenti alla necessità fisica. Il “bisogno” nel la società umana è un prodotto storico; paragonato a esso l’im perativo biologico si mostra indeterminato, astratto. Comunque, Marx ha solo esposto il concetto del bisogno di mangiare: non ha sviluppato il concetto delle sue caratteristiche storiche. In pratica, ha compreso quest’ultimo nel primo, nella misura in cui ha ritenuto che il valore d’uso corrispondesse in maniera tra sparente ai bisogni umani. Ciononostante, è stato Marx a os servare che la produzione dell’uomo è universale, al contrario di quella degli animali, che si appropriano solo “quanto è stret tamente necessario”. Un animale, scrive, produce solo sotto l’impero del bisogno fisico immediato, mentre l’uomo produce anche libero dal bisogno fìsico, e produce vera mente soltanto quando è libero da esso; l’animale riproduce sol tanto se stesso, mentre l’uomo riproduce l’intera natura; il pro dotto dell’animale appartiene immediatamente al suo corpo fisi co, mentre l’uomo si pone liberamente di fronte al suo prodotto. L’animale costruisce soltanto secondo la misura e il bisogno del la specie, a cui appartiene, mentre l’uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e sa dovunque predisporre la misura ine rente a quel determinato oggetto; quindi l’uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza. [Marx, 1844, ed. it. pp. 78-79]13 Non mi riferisco alla bellezza, ma alla definizione di una pro duzione che viene intrapresa all’interno di un ordine simboli co, all’interno della cultura. Marx impiega molte pagine del Ca pitale per spiegare perché una certa quantità di frumento equi vale in valore a x libbre di ferro. Mentre la risposta che spiega il tasso di equivalenza sulla base del lavoro sociale medio oc corrente è certamente acuta, non ci dice perché il frumento e perché il ferro; perché certe merci sono prodotte e scambiate e altre no. In tutto il Capitale queste domande non trovano ri sposta, nella certezza che le risposte siano per sé evidenti. La determinazione dei mezzi di sussistenza dei lavoratori, scrive Marx, “contiene un elemento storico e morale”; ciononostante, “per un determinato paese, in un determinato periodo, il volu166
me medio [!] dei mezzi di sussistenza necessari è dato” (1867, ed. it. voi. I, p. 204; corsivo mio).14Se la merce, come dice Marx, è una cosa misteriosa “che abbonda di sottigliezza metafisica e di capricci teologici”, questo mistero non si estende alle sue pro prietà esteriori. Come valore d ’uso, la merce è perfettamente intellegibile: soddisfa i bisogni umani. Finché un oggetto
è valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in esso, sia che lo si consideri dal punto di vista che esso soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. E chiaro come la luce del sole che l’uomo, con la sua attività, cambia in maniera utile a se stesso le forme dei ma teriali naturali. [Ibid., ed. it. p. 103; corsivo mio] Ma si noti che per raggiungere questa trasparenza di signifi cato in confronto al feticismo della merce, Marx è stato costretto a scambiare la determinazione sociale del valore d ’uso con il fatto biologico che esso soddisfa i “bisogni umani”. E ciò in con trasto con la sua stessa idea fondamentale che la produzione non è la riproduzione della vita umana semplicemente, ma di un determinato modo di vita. Da una tale idea (culturale) deriverebbe che tutte le merci sono simboliche. Finché Inutilità” costituisce il concetto di “bi sogno” proprio di un determinato ordine culturale, questo de ve comportare una rappresentazione, in luogo delle caratteri stiche concrete dell’oggetto, delle relazioni differenziate tra per sone - nello stesso modo in cui le opposizioni di colore, mo dello o tessuto tra gli abiti da uomo e da donna attestano la va lutazione culturale dei sessi. Il “sistema di bisogni” deve essere sempre relativo, non spiegabile come tale con le necessità fisi che, e quindi simbolico per definizione. Ma per Marx solo nell’astratta forma-merce i rapporti tra persone si mostrano co me rapporti tra cose, ed egli distingue tale “feticismo” dal va lore d ’uso esattamente come il socialment'è’ significante è di stinto dal ciò che è percettivamente evidente, il simbolico dal “naturale”. “Finora nessun chimico ha ancora scoperto valore di scambio in perle o diamanti” (Marx, 1867, ed. it. voi. I, p. 115). Solamente al carattere misterioso della forma-merce è ap plicabile una definizione che equivale alla nozione saussuriana di segno - “cose sociali le cui qualità sono allo stesso tempo 167
percettibili e impercettibili ai sensi” (ibid., ed. it. voi. I, p. 104) - proprio come l’attribuzione di significato a una cosa in for ma di valore di scambio è assimilabile solo alla formazione del linguaggio (ibid., ed. it. voi. I, p. 106). Per Marx, dunque, la merce ha una duplice natura: il suo va lore in opposizione a se stessa, ovvero il suo valore di scambio in opposizione alla sua utilità; il primo è funzione imposta dal la società e non data nell’oggetto come tale, l’utilità invece cor risponde ai bisogni umani ed è intrinseca all’oggetto in quan to oggetto. Queste distinzioni sono poste ripetutamente nei Grundrisse. Il valore (di scambio) di una merce, scrive qui Marx, necessariamente ha un’esistenza separata dalla merce stessa, e nello scambio reale questa possibilità di esistere separatamente deve diventare una separazione reale, perché la naturale diversità delle merci deve entrare in contraddizione con la loro equivalenza economica, e l’una e l’altra possono sussistere una accanto all’al tra solo in quanto la merce acquista una esistenza duplice, ossia, accanto alla sua naturale, un’esistenza puramente economica nel la quale essa è un mero segno, una lettera che sta al posto di un rapporto di produzione, un mero segno per il suo proprio valo re. [...] Come valore, la misura della sua [della merce] scambia bilità è determinata da essa stessa; il valore di scambio esprime appunto il rapporto in cui essa sostituisce altre merci; nello scam bio reale essa è scambiabile soltanto in quantità connesse alle sue qualità naturali e corrispondenti ai bisogni di coloro che scam biano. [Marx, 1857-58a, ed. it. voi. I, pp. 76-77] La misura in cui l’economia è stata naturalizzata da questo complesso di problemi emerge solo in parte dalle implicazioni del brano riportato: che la dimensione sociale (significante) del la produzione di merci poggia su un sottostante sistema di bi sogni naturali e di proprietà obiettive dei.beni che possano sod disfarli (cfr. ibid., ed. it. voi. I, p. 82). Marx trae anche la con clusione logica che il sistema dei valori d’uso, proprio perché è universale e naturale, cade tutto al di fuori dell’ambito dell’eco nomia politica. Per cui ciò che differenzia un’economia e una società storica dall’altra, il suo particolare “sistema dei bisogni” e “sistema dei lavori” non trova posto nella teoria del materiali smo storico. Per la mancanza di u n ’adeguata teoria del significato, il lato materiale del processo è assente dall’analisi di Marx dell’economia-. 168
La merce stessa si presenta come unità di due determinazioni. Es sa è valore d’uso, ossia oggetto della soddisfazione di un sistema qualsiasi di bisogni umani. Questo è il suo lato materiale, che può essere comune alle epoche di produzione più disparate, e la cui analisi trascende perciò l’economia politica. [Ibid., ed. it. voi. II, p. 645]15 Marx in un passo dei Orundrisse spiega la produzione di un genere di lusso, la seta. In quest’occasione risolve ogni con traddizione tra produzione di generi di lusso e produzione di generi di prima necessità, come pure tra la creazione di biso gni mediante la produzione e l’origine naturale dei bisogni, fa cendo derivare la produzione della seta dal bisogno indotto di concime: L’artigianato stesso non compare necessariamente accanto all’agri coltura autosufficiente che pratica la filatura, la tessitura ecc. co me occupazione domestica accessoria. Ma quando per esempio l’agricoltura si basa su una condizione scientifica - ha bisogno cioè di macchine, di concimi chimici forniti dal commercio, di se menza dai paesi lontani ecc., [...] allora la fabbrica meccanizzata, il commercio estero, l’artigianato ecc. diventano un bisogno per l’agricoltura. Può capitare per esempio che il concime possa es sere procurato solo esportando articoli di seta. Ed ecco allora che la manifattura delle sete non figura più come un’industria di lus so, ma come un’industria necessaria all’agricoltura. Se dunque ciò che prima figurava come un lusso è ora una necessità, e i co siddetti bisogni di lusso per esempio figurano come una necessità per l’industria più elementare, sorta per soddisfare le necessità più puramente naturali, ciò è dovuto principalmente e sostanzial mente al fatto che, in questo caso, l’agricoltura non ritrova più in sé, spontaneamente, le condizioni della propria autonomia. [Ibid., ed. it. voi. II, p. 165; non è detto perché gli esportatori di concime avessero bisogno di seta] Avineri ha visto con chiarezza il problema nell’analisi della base economica. I “bisogni” a cui Marx si riferisce non bastano a spiegare il loro oggetto, che è sempre particolare e storico. Marx cosi non riesce a esporre il processo attraverso il quale i “bisogni” sono formulati. Secondo Avineri, Marx era “consape vole” di questo “dilemma filosofico”: 169
Se i bisogni umani sono mediati dalla coscienza e dall’attività uma na, bisogna che la mente degli uomini abbia una capacità inten zionale di soddisfare questi bisogni, che di per sé non sia un pro dotto di questi bisogni stessi. A volte Marx è stato accusato di non aver approfondito abbastanza il problema del bisogno, affidando si a una simile capacità intenzionale autonoma. Questa obiezione è seria, ma nel Capitale Marx, consapevole di essa, attribuisce alla mente umana la capacità di elaborare un modello del prodotto fi nale anteriore all’esistenza materiale del prodotto stesso. Il modo in cui Marx tratta questo problema induce fortemente a pensare che non abbia perso di vista il dilemma filosofico che esso com porta, per quanto non mostri chiaramente il processo attraverso * cui il modello ideale si forma nella mente dell’uomo, prima che venga realizzato materialmente. [Avineri, 1971, ed. it. pp. 106-107] In verità, Avineri mostra che la consapevolezza di Marx del “processo attraverso cui il modello ideale si forma nella mente dell’uomo prima che venga realizzato materialmente” era più acuta di quanto potè essere giudicato dai lettori dell’edizione inglese del Capitale. La traduzione sovietica taglia dal famoso paragone tra lavoro umano e lavoro animale la frase chiave con cui si chiude. Avineri (ibid.) riporta quella frase in una nota (qui aggiunta tra parentesi): Noi supponiamo il lavoro in una forma nella quale esso appartenga esclusivamente all’uomo. Il ragno compie operazioni che assomi gliano a quelle del tessitore, l’ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin dal principio distingue il peggiore architetto dall’ape migliore è il fat to che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del lavoratore [che quin di era già presente idealmente]. [Marx, 1867, ed. it. voi. I, p. 212] Il lavoro con cui Marx trasforma la precedente immagine del la produzione nella sua conseguenza obiettiva è spiegato nei par ticolari nell’introduzione critica dei Grundrisse, dove Marx im posta i rapporti tra produzione, distribuzione, scambio e con sumo. Lo scopo di questa disamina è stabilire l’unità organica di questi diversi elementi della produzione, elementi che appaio no atti separati all’individuo in situazione, e derivanti da cause 170
indipendenti all’economista. Marx dimostra che essi sono aspet ti complementari di un unico processo materiale, necessaria mente interdipendenti, in uno stato di reciproca interazione. Dall’analisi dei loro rapporti reciproci, comunque, Marx con clude che la produzione, nel senso stretto di processo lavorati vo, è il “punto di partenza reale” e il “fattore predominante” nella forma-produzione presa nel suo insieme. Gli altri elementi, soprattutto il consumo, assumono il ruolo teorico di fattori di questo fattore. Althusser giustamente, da un certo punto di vi sta, si è felicitato con Marx per aver qui realizzato la “sparizio ne” dell’antropologia - più giustamente, forse, di quanto non sia stato interpretato, poiché il riferimento era all’antropologia ingenua (Homo oeconomicus) degli economisti classici (Althusser e Balibar, 1965). La parte del testo che spiega l’interazione tra produzione e consumo è del più grande interesse per un tipo di antropolo gia che ancora esiste. In aggiunta al consumo di materiali che si realizza nella produzione (produzione consumatrice) e alla produzione di persone, per esempio, che si realizza nel consu mo (consumo produttivo), Marx spiega in tutta la sua com plessità la relazione tra i due momenti. Il consumo completa la produzione fornendole il soggetto, che usando un prodotto lo rende tale. Un vestito non diviene realmente un vestito che per l’atto di portarlo: “il prodotto, quindi, a differenza del sempli ce oggetto naturale, si afferma, diviene prodotto soltanto nel suo consumo” (Marx, in McLellan, 1971a, p. 25).* Inoltre, il con sumo sta alla produzione come la sua necessità, “in quanto il consumo crea il bisogno di una nuova produzione e quindi quel motivo ideale che è lo stimolo interno della produzione e il suo presupposto” (ibid.). Segue un passo molto simile a quello trat. to da Avineri dal più tardo Capitale. Il consumo crea la propensione alla produzione; esso crea anche l’oggetto, che determina finalisticamente la produzione. Se è chia ro che la produzione offre esteriormente l’oggetto del consumo, è perciò altrettanto chiaro che il consumo pone idealmente l'oggetto della produzione, come immagine interiore, come bisogno, come * Per le citazioni da Marx in McLellan si è utilizzata la trad. it. di Marx, 1857-58a. (N.d.T.) 171
propensione e come scopo [Marx, 1857-58a, ed. it. pp. 15-16, cit. in McLellan, corsivi miei]. Le parole chiave sono, come vedremo, “propensione” e “bi sogno”, in quanto, opposte alla specificità di “immagine inte riore” e di “oggetto posto idealmente”, le prime implicano una indeterminatezza di forma e di contenuto che permette a Marx di trovare la definizione autentica di oggetto, e l’inizio reale del processo, nella produzione più che nel consumo. Fornen do al consumo il suo oggetto, la produzione ora non solo com pleta il consumo, ma determina anche la sua forma reale - e cioè gli dà un bene concreto che definisce il modo e il conte nuto del consumo. Per il resto, il consumo ha solo l’aspetto informe di una necessità biologica. E la produzione che crea il desiderio specifico con la mediazione di una forma-oggetto - un po’ come gli economisti moderni intendono 1’“effetto di dimo strazione” ovvero il provocare la domanda mediante l’offerta: ma non è soltanto l’oggetto che la produzione procura al consu mo. Essa dà anche al consumo la sua determinatezza, il suo ca rattere, il suo finish. [...] Insomma, l’oggetto non è un oggetto in generale ma un oggetto determinato, che deve essere consumato in un modo determinato, in un modo che a sua volta deve esse re mediato dalla produzione stessa. La fame è fame, ma la fame che si soddisfa con carne cotta, mangiata con coltello e forchet ta, è una fame diversa da quella che divora carne cruda, aiutan dosi con mani, unghie e denti. Non è soltanto l’oggetto del con sumo ad essere prodotto dalla produzione, ma anche il modo di consumarlo, non solo oggettivamente, ma anche soggettivamen te. La produzione crea quindi il consumatore. [...] La produzione fornisce non solo un materiale al bisogno, ma an che un bisogno al materiale. Quando il consumo emerge dalla sua immediatezza e dalla sua prima rozzezza naturale - e l’attardarsi in questa fase sarebbe ancora il risultato di una produzione imprigio nata nella rozzezza naturale - esso stesso come propensione è me diato dall’oggetto. Il bisogno che esso ne avverte è creato dalla percezione dell’oggetto stesso. [...] La produzione produce perciò non soltanto un oggetto per il soggetto, ma anche un soggetto per l’oggetto. [Marx, 1857-58a, ed. it. p. 16, cit. in McLellan; corsivo mio] Il brano è notoriamente difficile: cerchiamo di fare chiarezza su quello che sta succedendo. Essenzialmente quello che sta suc172
cedendo è uno spostamento del rapporto tra produzione e con sumo dallo stato di reciprocità a quello di gerarchia. Il consumo, che ha origine in una reciproca interdipendenza con la produ zione, è alla fine subordinato alla produzione: un mutamento di status a cui corrisponde un mutamento di tempo, da Timmagine che era già presente idealmente” a conseguenza obiettiva. Questa ridefinizione del rapporto avviene con l’assegnare al con sumo tutta la vaghezza di una “propensione”, lasciando al con tempo alla produzione tutta la definitezza dell’oggetto. Qui, dun que, abbiamo un simbolo condensato dell’insidia antropologica che è nel programma di Marx: la ricaduta dall’“immaginazione” alla “percezione”, e cosi dalla cultura alla natura. Come “bisogno” o “propensione”, il consumo è in questo momento situato nel re gno del naturale; mentre, in quanto fonte della forma-oggetto, so lo la produzione è storica. Inoltre, è la percezione dell’aspetto a rendere conto del contenuto del bisogno-senza-forma; e cosi tut to ciò che è consumo, compresa la sua influenza sulla produzio ne, dipende dal movimento storico della produzione. Sottolineo “percezione”. L’occhio che vede non è qui l’organo della tradi zione, ma lo strumento del desiderio. La mente, di conseguenza, non organizza l’esperienza ma la segue. La produzione è “l’effet tivo punto di partenza”: La cosa più importante da mettere in rilievo è che produzione e consumo, considerati come attività di un soggetto o di più indi vidui, si presentano in ogni caso come momenti di un processo in cui la produzione è l'effettivo punto di partenza e perciò anche il momento egemonico. Il consumo come necessità, come bisogno, è esso stesso un momento interno all’attività produttiva. Ma que st'ultima è il punto di partenza della realizzazione e, quindi, anche il suo momento egemonico, l’altro nel quale l’intero processo riprende il suo andamento. L’individuo produce un oggetto e, consuman dolo, fa di nuovo ritorno a se stesso, ma come individuo produt tivo e che produce se stesso. Il consumo si presenta quasi come un momento della produzione. [Marx, 1857-58a, ed. it. pp. 18-19; corsivi miei] Questa sezione dei Grundrisse sull’unità organica degli ele menti della produzione ha ricevuto grande attenzione negli stu di recenti su Marx. Habermas ci vede la tendenza filosofica di Marx - contrapposta alla sua pratica effettiva - a ridurre i rap173
porti di produzione al processo lavorativo stesso, ignorando le dimensioni culturali dell’organizzazione economica (1968). Per Althusser, come si è già notato, lo stesso brano illustra l’abilità di Marx a schivare u n ’antropologia del genere in uso tra gli economisti del tempo: il fondamento del processo economico nel soggetto umano e in un ambito autonomo di “bisogni” in vece che nella produzione stessa. I rilievi dei due studiosi sono legati tra loro, e rappresentano anche una transizione verso una diversa visione antropologica dell’economia. Althusser spiega in questo modo la fuga di Marx dall’antropo logia di vecchio tipo: Primo, la struttura della produzione deter mina la porzione destinata al consumo individuale (opposto al consumo produttivo). La struttura del consumo della gente, da parte sua, naturalmente varia storicamente. Al di là di questo, es sa dipende in parte dalla “domanda effettiva”, cioè dal potere d’acquisto. Il potere d ’acquisto dipende a sua volta dalla distri buzione del reddito, questa rimanda alla proprietà, che è espres sione giuridica dei rapporti di produzione. Ma ovviamente, in questo modo, i rapporti di produzione non daranno conto della natura di quanto è prodotto, ma solo della domanda differenzia ta da parte della classe. Di conseguenza un secondo fattore gene rativo di bisogni compare nella spiegazione di Althusser, e preci samente “la natura dei prodotti disponibili, che sono, in un mo mento dato, il risultato delle capacità tecniche di produzione” (Althusser e Balibar, 1965, ed. it. p. 155). Da ciò Althusser con clude che il problema non aveva alcun bisogno di un soggetto con un bisogno, visto che “la natura non meno che la quantità” del prodotto può trovare origine nella produzione stessa. Ma ovvia mente niente è stato realmente chiarito sul carattere della pro duzione oltre al riferimento a non spiegate differenze storiche a meno che la natura del prodotto non sia da vedere come speci ficamente e meccanicamente corrispondente alle “capacità tec niche” delle forze produttive. In questo caso siamo nel pieno di u n ’antropologia della prassi, che è nei fatti ciò che, secondo Ha bermas, Marx istituisce nei Grundrisse facendo precipitare i rap porti di produzione nello stesso processo lavorativo e quindi la lo gica culturale in quella strumentale.16 Habermas sostiene che l’eliminazione della cultura da parte di Marx avviene nell’ignoranza della determinazione storica dei rapporti di produzione, e che invece Marx farebbe derivare i 174
rapporti dall’aspetto tecno-logico della situazione lavorativa. In parte, sostiene Habermas, questo abbassarsi dei rapporti socia li alla praticità è un “equivoco terminologico” nell’importante passo dei Grundrisse: il concetto di produzione è cosi ampio da dare a Marx “la possibilità di insistere sul fatto che la produ zione produce anche il quadro istituzionale nel quale viene pro dotta” (Habermas, 1968, ed. it. p. 57n). Ma celato nell’“equi voco” c’è un particolare tipo di ragionamento, e la cosa inte ressante per noi è che esso riassume esattamente ciò che ab biamo appena evidenziato riguardo alla caduta del consumo nel la produzione. I rapporti di produzione vengono ugualmente ridotti a dipendere dalle forze produttive, rendendo naturali i primi e storiche le seconde. E tutto dipende ancora dall’espres sione pseudostorica di questa priorità teoretica. I rapporti di produzione appaiono in una forma originale, naturale e rudi mentale, al di fuori della quale essi sono sussunti e organizzati in una nuova forma dalle forze produttive. I rapporti sono po sti dalla teoria come pre-economici; la loro specificazione è ope ra del processo lavorativo: Se si dovesse poi sostenere che, poiché la produzione deve parti re da una certa distribuzione degli strumenti di produzione, al meno in questo senso la distribuzione precede la produzione, e ne è il presupposto, potremo rispondere che la produzione ha in effetti le sue condizioni e i suoi presupposti, che ne costituisco no i momenti. Questi all’inizio possono anche presentarsi come momenti di origine naturale. [Dice Habermas: “Con questo Marx ha in mente proprio qualità naturali deH’interazione sociale co me sesso, età e relazioni di parentela.”] Ma attraverso il processo di produzione stesso essi vengono trasformati da momenti naturali in momenti storici, e se per un periodo si presentano come pre supposto naturale della produzione, per un altro essi ne sono sta ti un risultato storico. All’intemo della produzione stessa, essi ven gono continuamente modificati. L ’impiego delle macchine, per esem pio, ha modificato la distribuzione tanto degli strumenti di pro duzione quanto dei prodotti. La stessa grande proprietà fondia ria moderna è il risultato tanto del commercio e dell’industria moderni quanto dell’applicazione di quest’ultima all’agricoltura. [Marx, 1857-58a, ed. it. p. 22, cit. in McLellan, 1971a; corsivi miei] La tecnica teoretica di Marx qui consiste nel rendere natu rali i rapporti di produzione culturali per poter postulare la lo175
gica naturale di produzione come il fatto culturale (storico) pri mario. A giudicare dalla somiglianza del procedimento con quel lo delle teorie naturalistiche dell’antropologia, questo sembra essere il principale segreto di ogni tipo di interpretazione ba sata sulla prassi. In ogni caso, il “nucleo razionale” del mate rialismo storico è il lavoro.17 Il processo lavorativo, facendo da mediatore tra la soggettività umana (i “bisogni”) e il mondo og gettivo, mette in gioco u n ’inevitabile fatticità della natura e dei mezzi tecnici, un fondamento concreto su cui è eretto il resto dell’architettura culturale. L’obiezione di Habermas è che con argomentazioni come quelle dell’Introduzione dei Grundrisse, Marx fa della cultura nel suo insieme una conseguenza della natura delle cose. Il metodo fa derivare il mondo umano dall’in teresse per il controllo tecnico dei processi naturali, dalle ne cessità sociali e pratiche a esso immanenti, e dalle trasforma zioni del mondo oggettivo che lo sviluppo di tale controllo pro duce.18 Quali che siano gli “scopi”, le “immagini ideali” e simili che si possono presupporre, il processo lavorativo applica co munque una ragione più forte dell’immaginazione e indipendente dalla volontà. Finché i bisogni umani materiali sa ranno primari, la logica intrinseca della produttività sarà fon damentale e sostanziale, evolvendosi la struttura sociale dal pro cesso della vita degli individui “quali veramente sono”. In ulti ma analisi, perciò, come appare in molte esplicite affermazioni di principio di Marx, la logica storica è pienamente tecno-logi ca. Il mulino a braccia dà un tipo di società, il mulino a vapo re un altro: I rapporti sociali sono intimamente connessi alle forze produtti ve. Impadronendosi di nuove forze produttive, gli uomini cam biano il loro modo di produzione e, cambiando il modo di pro duzione, la maniera di guadagnarsi la vita, cambiano tutti i loro rapporti sociali. Il mulino a braccia vi darà la società col signore feudale, e il mulino a vapore la società col capitalista industriale. Quegli stessi uomini che stabiliscono i rapporti sociali conforme mente alla loro produttività materiale, producono anche i prin cipi, le idee, le categorie, conformemente ai loro rapporti socia li. Cosi queste idee, queste categorie sono tanto poco esterne quanto le relazioni che esse esprimono. Sono prodotti storiò, e tran-
O ancora: Il Darwin ha diretto l’interesse sulla storia della tecnologia natu rale, cioè sulla formazione degli organi vegetali e animali come strumenti di produzione della vita delle piante e degli animali. Non merita eguale attenzione la storia della formazione degli or gani produttivi dell’uomo sociale, base materiale di ogni organiz zazione sociale particolare? E non sarebbe più facile da fare, poi ché come dice il Vico, la storia dell’umanità si distingue dalla sto ria naturale per il fatto che noi abbiamo fatto l’una e non abbiamo fatto l’altra? La tecnologia svela il comportamento attivo dell’uo mo verso la natura, l’immediato processo di produzione della sua vita, e con essi anche l’immediato processo di produzione dei suoi rapporti sociali vitali e delle idee dell’intelletto che ne scaturi scono. [1867, ed. it. voi. 1, p. 414 n.] E ancora, un altro passo dell 'Ideologia tedesca degno di atten ta riflessione: Il modo in cui gli uomini producono i loro mezzi di sussistenza dipende prima di tutto dalla natura dei mezzi di sussistenza che essi trovano e che debbono riprodurre. Questo modo di produ zione non si deve giudicare solo in quanto è la riproduzione dell’esistenza fisica degli individui; anzi, esso è già un modo de terminato dell’attività di questi individui, un modo determinato di estrinsecare la loro vita, un modo di vita determinato. Come gli individui esternano la loro vita, cosi essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque con la loro produzione, tanto con ciò che pro ducono quanto col modo come producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle condizioni materiali della loro pro duzione. Questa produzione non appare che con l'aumento della popola zione. E presuppone a sua volta relazioni fra gli individui. La for ma di queste relazioni a sua volta è condizionata dalla produzio ne. (Marx e Engels, 1845-46, ed. it. pp. 8-9)19 Questo passo dell 'Ideologia tedesca è un altro testo chiave in cui i “due momenti” del materialismo storico sono di nuovo riu niti. Ho già fatto riferimento a questo brano - e nel prossimo capitolo ci tornerò - per la sua affermazione esplicita che la pro duzione degli uomini, come produzione storica, non è riferibi le semplicemente alle necessità fìsiche (biologiche). In questo caso, ne segue che ciò che gli uomini producono, e come lo pro li77
ducono, dipende dallo schema culturale di uomini e cose. Il con tenuto e la modalità della produzione non seguono da ciò che gli uomini “sono veramente”, ossia separati da questo attributo culturale. Le ultime frasi del brano potrebbero essere facilmente prese per una rottura logica con le prime. Infatti, mentre pri ma Marx aveva identificato le coordinate culturali della produ zione, l’organizzazione della produzione con il “modo di vita”, alla fine egli identifica il modo di vita, compresa l’organizzazio ne della produzione, con le coordinate materiali. La “forma del le relazioni” che include i rapporti di produzione è ancora il ri sultato sui generis del processo di produzione. E cosi torniamo alla critica di Habermas. La critica di Habermas si basa sull’osservazione che la for mulazione filosofica di Marx non è coerente con le sue ricerche storiche. In queste ultime - nel Capitale, per esempio - i rap porti di produzione godono di uno status teorico distinto da quello delle forze produttive, e, in definitiva, altrettanto im portante. Ma la riflessione astratta di Marx dedica una partico lare attenzione alle forze. In via di principio egli riduce “l’atto di autoproduzione del genere umano al lavoro”. Il risultato è una “atrofia positivista dell’epistemologia”. La ragione stru mentale viene privilegiata a spese dell”’interazione simbolicamente mediata”, poiché organizza i rapporti di produzione e attraverso questi agisce cognitivamente all’interno del processo lavorativo stesso. L’obiezione di Habermas è che la cultura è trascurata dalla filosofia: Per l’analisi qualitativa dello sviluppo delle formazioni economi che della società, Marx ricorre a un concetto del sistema di lavo ro sociale che comprende più elementi di quanti siano dichiara ti nel concetto di genere umano autoproducentesi. L’autocostituzione mediante il lavoro sociale viene concepita sul piano cate goriale come processo della produzione; e l’agire strumentale, la voro nel senso dell’attività produttiva, indica la dimensione in cui si muove la storia naturale. Sul piano delle sue indagini materiali Marx tiene invece sempre conto di una prassi sociale che comprende lavoro e interazione; i processi storici naturali sono fra loro me diati dall’attività produttiva del singolo e l’organizzazione delle sue relazioni. Queste sono subordinate a norme che, con il potere del le istituzioni, decidono su come vengono distribuiti fra i membri competenze e risarcimenti, obblighi e oneri del bilancio sociale. 178
Il medium in cui sono regolate normativamente queste relazioni dei soggetti e dei gruppi, è la tradizione culturale; essa forma il contesto linguistico di comunicazione con il quale i soggetti in terpretano la natura e se stessi nel loro ambiente. [Habermas, 1968, ed. it. p. 55]
MATERIALISMO STORICO E UTILITARISMO
Ci si può chiedere se Marx abbia mai abbandonato - come è stato sostenuto da qualcuno - la sua visione dell’uomo come “essere che appartiene a una specie” portato a manifestarsi con l’appropriazione del mondo sensibile. O forse questo modo di vedere la natura umana non è essenziale per il naturalismo pro prio della teoria sviluppata dal materialismo? Nei Manoscritti di Parigi Marx aveva in realtà definito la sua posizione - in con trasto a un tempo con l’idealismo e col materialismo - “natu ralismo” o “umanismo”. Vale la pena di analizzare brevemente l’idea di uomo che ne viene fuori. Poiché potrebbe trattarsi di un’altra continuità, la più impalpabile, che vive come un’ombra dentro il tardo materialismo storico - ma che vi opera, come opera nella società occidentale in genere, come un potente “fan tasma nel cervello degli uomini”. La continuità consisterebbe in pratica nella razionalità dell’utilitarismo, stabilizzatasi prima co me struttura di discorso sulla natura umana, poi entrata nell’ana lisi della storia - dove si è presentata al contempo con l’aspet to obiettivo della massimizzazione delle risorse nell’interazione tra società e natura, e con la forma soggettiva della motivazio ne materialistica, rivelata quale verità dell’ideologia sociale. La continuità è l’attività economizzatrice borghese. Sto facendo u n ’affermazione molto ampia; che la specie a cui l’“essere che appartiene a una specie” di Marx appartiene è la specie homo oeconomicus. Si tratta, comunque, di Una varietà particolare. La visione di Marx della condizione umana nei Ma noscritti di Parigi somiglia a una “mentalità di mercato” spiri tualizzata, che combina i bisogni umani (di autoaffermazione), le scarsità naturali (di mezzi oggettivi) e la progressiva libera zione dell’uomo da questa triste condizione per mezzo dell’azio ne finalizzata - il suo progressivo arricchimento mediante l’uso sempre più efficace del suo potere di appropriazione e dell’at179
tività di scambio con altri uomini. Anche l’“alienazione” delle prime fasi implica quell’opposizione dualistica tra uomo e so cietà che è caratteristica del funzionalismo borghese. Spesso Marx ha ripetuto che l’individuo è l’essere sociale, e tuttavia il suo concetto di alienazione dipende largamente dall’antitesi “tra l’uomo e il suo essere sociale” (McLellan 1971b, p. 106). L’alie nazione sembra essere il lato opposto (proletario) dell’idea del l’uomo imprenditore, per il quale la società, rispetto al suo pro getto soggettivo di soddisfazione, fa da condizione esterna. In ogni caso il comuniSmo è il risultato di questa lotta, un tra scendimento dell’alienazione che, secondo le parole di Marx (1844, ed. it. p. 120), “produce l’uomo ricco e profondamente sensibile a tutto come sua stabile realtà”; l’uomo, cioè, in gra do di percepire veramente, e in tal modo di realizzare, la sua propria assenza attraverso l’appropriazione della natura essen ziale delle cose.20 Al contrario, l’uomo nel suo stato originario è un essere limitato, un “essere sofferente”, una creatura di bi sogni e di impulsi, violentemente teso verso gli oggetti della sua esistenza: L’uomo è immediatamente un essere naturale. Come essere natu rale, come essere naturale vivente, egli è in parte fornito di forze naturali, di forze vitali, cioè è un essere naturale attivo: e queste forze esistono in lui come disposizioni e facoltà, come impulsi, in parte egli è, in quanto naturale, oggettivo, dotato di corpo e di sensi, un essere passivo condizionato e limitato, al pari degli ani mali e delle piante: vale a dire, gli oggetti dei suoi impulsi esisto no fuori di lui, come oggetti da lui indipendenti, ma questi oggetti sono oggetti del suo bisogno, oggetti essenziali, indispensabili ad at tuare e confermare le sue forze essenziali. [...] Un essere non oggettivo è un non-essere [...]. L’uomo come essere oggettivo sensibile è quindi un essere pas sivo, e poiché sente questo suo patire, è un essere appassionato. La passione è la forza essenziale dell’uomo che tende energicamen te al proprio oggetto. [Ibid., ed. it. pp. 172-74] È importante per la credibilità della mia argomentazione no tare che questa lettura del concetto di natura umana in Marx come metafora della razionalità capitalistica, non è né inusita ta né mia personale. Se il concetto non è stato ancora espres so in questi termini, l’identificazione del paradigma bisogni-mez180
zi-fini è una scoperta comune dell’analisi recente. Diversi passi dell’ottimo libro Alienazione di Ollman potranno servire come esemplificazione. Marx riassume la sua descrizione dell’uomo come un essere natu rale, come una creatura oggettiva e sensibile, riferendosi a lui come a un essere “sofferente, limitato e condizionato”; l’uomo patisce a causa di ciò a cui è sottoposto. Essere sensibile significa necessaria mente soffrire. L’uomo non può ottenere tutto ciò di cui abbisogna per realizzare i suoi poteri naturali, poiché, in un modo o in un al tro, è il mondo intero che egli esige. Ci sarà sempre una donna (o un uomo), un cibo ecc., che sarà irraggiungibile, anche se solo per un momento, e qualunque cosa gli sia negata gli causa sofferenza [...]. Poiché egli sente quello a cui è sottoposto, poiché a causa del suo essere sottoposto soffre, l’uomo è definito essere passionale. La passione è la qualità che anima lo sforzo dell’individuo per conse guire il suo oggetto. Assunta dal punto di vista del soggetto sen ziente la passione è proprio questo sforzo. Finalmente, si dice che l’uomo è limitato a causa delle restri zioni che limitano da tutti i lati i suoi desideri e le sue attività... La disponibilità degli oggetti naturali e le loro particolari qualità limitano l’uomo in tutto ciò che tenta di fare; essi regolano il mo do e il momento in cui i suoi poteri possono essere impiegati. [Ollman, 1971, ed. it. p. 117] Marx attribuisce all’uomo dei poteri che divide in naturali e ti pici della specie, e sostiene che ciascuno di questi poteri viene ri flesso nella coscienza di ciascuno da un bisogno corrispettivo; l’in dividuo sente il bisogno di tutto quello che è necessario per la realizzazione dei propri poteri. Gli oggetti di natura, compresi gli altri uomini, forniscono la materia attraverso cui si realizzano que sti poteri e, di conseguenza, sono gli oggetti che s’accordano per tipo e livello di sviluppo a questi stessi poteri. “Appropriazione” è l’espressione più generale che Marx usa per riferirsi al fatto che l’uomo incorpora dentro di sé le parti della natura con cui viene in contatto. L’attività entra in questo contesto come il mezzo prin cipale attraverso il quale l’uomo si appropria degli oggetti e di viene, perciò, il principale mediatore tra l’individuo e il mondo esterno. Marx vede quest’attività in tre speciali relazioni con i po teri dell’uomo: primo, è il principale esempio della loro opera zione combinata; secondo, stabilisce nuove possibilità per la loro realizzazione trasformando la natura e di conseguenza tutte le li mitazioni imposte dalla natura; e terzo, è il mezzo principale per sviluppare il loro potenziale. [Ibid., ed. it. p. 183; vedi Kolakow181
ski 1969, pp. 38-60, per una spiegazione molto simile dei Mano scritti di Parigi]
Marx non ha mai abbandonato questo concetto dei “bisogni”, né il concetto di produzione, quindi, come azione finalizzata al loro soddisfacimento. Al contrario, il tardo materialismo stori co dipende dalla stessa definizione naturalistica di lavoro come processo per soddisfare i bisogni - tanto più, come abbiamo vi sto, in quanto il valore d’uso va distinto dal valore di scambio per la sua diretta corrispondenza con ciò di cui l’uomo manca. Analogamente, a proposito dell’"interesse di classe”, C. Wright Mills evidenziò che “il pensiero di Marx sulla coscienza di clas se è comunque utilitaristico e razionalista quanto ogni affer mazione di Jeremy Bentham” (1962, p. 115). Ma se Marx non potè esorcizzare il quadro utilitaristico, non si senti neppure mai, per quanto ne so, obbligato a definirlo, a determinare con precisione la natura del vantaggio materiale tipico dell’azione umana nel mondo.21 La natura della razionalità economica appare nell’analisi sto rica di Marx come evidente di per sé, come qualcosa che deri vi direttamente dalla necessità naturale della produzione. Se il contenuto della produzione era una domanda senza risposta in Marx economista, qui diventa una risposta senza domanda. Tut to dipende dalla razionalità della produzione, daH’efficacia stru mentale del processo lavorativo. Infatti in questa forma devono costituirsi le condizioni materiali al di là della volontà degli uo mini, e sull’esperienza pratica di quelle essi costruiscono la lo ro esistenza sociale e intellettuale. Forse se la domanda fosse stata posta con chiarezza, invece che accettata insieme all’idea tradizionale che la produzione sia il soddisfacimento dei biso gni umani, l’intero edificio teorico eretto sull’attività materiale sarebbe stato riprogettato diversamente. C’è davvero una logica del lavoro? Si sarebbe tentati di rispondere esibendo uno o due modelli naturalistici, entrambi insoddisfacenti sia teoricamente sia storicamente (cfr. Sahlins, 1969). O è una strategia borghe se di massimizzazione, quella che Marx sembra supporre, an che se nessuno ha dimostrato meglio di lui la sua relatività so ciale; oppure è un modello ecologico di “sopravvivenza” che, dal momento che si riferisce solo a un minimo necessario di fun zionalità, lascia imprecisata l’intensità dell’uso di risorse, e tut182
to ciò che sia oltre il minimo “di adattamento”. E se dunque non c’è una logica del lavoro, può esserci una logica materiale che fondi il lavoro? Il punto è che l’efficacia materiale, la pra ticità materiale, non esistono in senso assoluto, ma solo nella misura e nella forma determinate dall’ordine culturale. Sele zionando i suoi mezzi e fini materiali tra tutti quelli possibili, e i rapporti che li collegano, è la società che pone le finalità e le intensità della produzione, nella maniera e nella misura ap propriate all’intero sistema strutturale. Rimane, come logica, so lo il sistema significante della cultura. Il materialismo storico promuove questa logica culturale a definizione della necessità materiale di ognuno. Con questa critica torniamo all’antropologia o, in particola re, a quell’antropologia che ha concepito la cultura come in tervento sulla natura. Inoltre, ora ci troviamo in una posizione più favorevole per reintegrare la nostra società nel mondo. In fatti dire che il materialismo storico è relativo alla nostra società, se da una parte sembra porre l’occidente in disparte dal resto del mondo, deve anche suggerire che il nostro sistema non è meno degli altri fondato sul significato. Il prossimo capitolo ini zia con l’analisi di alcune dimensioni semiotiche della nostra economia, con l’obiettivo di una sintesi più generale, teoretica e umana.
183
4.
La pensée bourgeoise L a società occidentale come cultura
Improvvisamente, il campo dell’economia politica, articolato sui due soli valori di scambio economico e di uso, esplode, e deve es sere interamente rianalizzato nel senso di una economia politica generalizzata, che implicherà la produzione del valore di scambio/segno [valeur d’échange/signe] allo stesso titolo, e nello stesso movimento, della produzione dei beni materiali e del valore di scambio economico. L’analisi della produzione dei segni e della cultura si impone pertanto non come qualcosa di esteriore, di ul teriore, di “sovrastrutturale” rispetto a quella della produzione ma teriale, ma come una rivoluzione dell’economia politica in quanto ta le, generalizzata attraverso l’irruzione teorica e pratica dell’eco nomia politica del segno. Baudrillard
(1972, ed. it.
p.
114)
Il materialismo storico è veramente un’autocoscienza della so cietà borghese - ma una coscienza, sembrerebbe, tutta interna ai limiti di quella società. Trattando la produzione come un pro cesso naturale-prammatico di soddisfacimento dei bisogni, ri schia di trovarsi alleato con l’economia borghese nel portare l’alienazione di persone e cose a un più alto potere conosciti vo. I due orientamenti troverebbero un punto di contatto nel nascondere dentro la prassi il sistema significante, che spiega no in termini di praticità. Quando questo occultamento è am messo, o introdotto di soppiatto come premessa, neH’antropo184
logia marxista, come nell’economia ortodossa, può succedere di tutto, come se l’analista fosse abbindolato da quello stesso feticismo della merce che incanta i partecipanti al processo. Concependo la creazione e il movimento dei beni solo dal pun to di vista della loro quantità pecuniaria (valore di scambio), si ignora il codice culturale delle proprietà concrete che gover nano 1’“utilità”, e cosi si resta incapaci di spiegare che cosa si è prodotto nei fatti. La spiegazione si accontenta di ricreare l’autoinganno della società in esame, mentre il sistema logico de gli oggetti e dei rapporti sociali procede lungo un piano in conscio, e si manifesta solo nelle decisioni di mercato basate sul prezzo; in tal modo resta l’impressione che la produzione non sia altro che il precipitato di una razionalità illuminata. La struttura dell’economia appare come la conseguenza oggettiva del comportamento pratico, e non come un’organizzazione so ciale di cose, attuata mediante gli strumenti istituzionali del mer cato, ma conforme a una trama culturale di persone e di beni. L’utilitarismo, comunque, è il modo in cui si ha esperienza dell’economia occidentale, anzi dell’intera società: il modo in cui è vissuta dal soggetto partecipante, e pensata dall’economi sta. Da tutti i punti di vista il processo sembra perseguire la massimizzazione materiale: la ben nota distribuzione di mezzi scarsi tra fini alternativi per ottenere la maggior soddisfazione possibile - o, come dice Veblen, per procurarsi qualcosa di inu tile a spese di chi può esserne interessato. Dal lato produttivo, il vantaggio materiale prende la forma di valore monetario ag giunto. Da parte del consumatore ciò è inteso più vagamente come recupero di “utilità” sull’esborso monetario; ma anche qui l’attrattiva del prodotto consiste nella sua pretesa superio rità funzionale rispetto a tutte le alternative a disposizione (cfr. Baudrillard, 1968). L’ultimo modello di automobile - o frigo rifero, o taglio degli abiti, o marca di dentifricio - è per una qualche nuova caratteristica più conveniente, più adatto alla “vi ta moderna”, più confortevole, più igienico, più sexy, più du raturo o più gustoso di qualsiasi prodotto concorrente.1 Nella concezione occidentale, l ’economia è un’arena per l’azione prammatica. E la società è il suo risultato. I principali rapporti di classe e politici, come pure i concetti che gli uomini hanno della natura e di se stessi, sono il prodotto di questa ricerca ra zionale di felicità materiale. Per cosi dire, l’ordine culturale è 185
sedimentato dal gioco reciproco tra uomini e gruppi che ope rano in diversi modi in base alla logica obiettiva delle loro si tuazioni materiali: Finché interessi discordanti producono La musica concorde di uno stato armonioso [...] Cosi Dio e Natura conchiusero la cornice universale E ordinarono all’Amore di sé e al Sociale di essere tutt’uno. [A
lexander
P
o pe
,
Essay on Man\
Questo è il modo di presentarsi della nostra società borghe se, e il sapere della sua scienza sociale comunemente diffusa. D’altra parte, è anche comune acquisizione antropologica che lo -schema “razionale” e “obiettivo” di ogni gruppo umano da to non è mai il solo possibile. Anche in condizioni materiali del tutto simili, gli ordini culturali e le finalità possono essere com pletamente diverse. Infatti le condizioni materiali, anche se sem pre indispensabili, sono potenzialmente “obiettive” e “necessa rie” in tanti modi diversi - secondo la selezione culturale me diante la quale diventano “forze” concrete. Naturalmente in un certo senso la natura è eternamente superiore a tutto. Nessuna società può vivere sui miracoli, e pensare di esistere contro di lei. Nessuna può fare a meno di provvedere alla continuità bio logica della popolazione determinandola culturalmente - tra scurare di procurarsi riparo costruendo case, o nutrimento di stinguendo il commestibile dal non commestibile. Ma gli uomini' non solo “sopravvivono”. Essi sopravvivono in una maniera de terminata. Riproducono se stessi come tipi specifici di uomini e di donne, classi sociali e gruppi, non come organismi biolo gici o aggregati di organismi (“popolazioni”). E vero che pro ducendo u n ’esistenza culturale, là società deve rimanere all’in terno dei limiti della necessità fisico-naturale. Ma ciò è stato con siderato assiomatico almeno fino a Boas, e neppure la più bio logica delle ecologie culturali può pretendere di più: i “limiti di vitalità” sono la modalità di intervento pratico della natura della cultura (cfr. Rappaport, 1967). All’interno di questi limi ti, ogni gruppo dispone di u n ’ampia serie di finalità economi che possibili, per non parlare delle scelte di strategia produtti va che si possono concepire partendo dalla diversità delle tec186
niche esistenti, dall’esempio delle società vicine, o dalla nega zione di entrambe. La ragione pratica è una spiegazione indeterminata della for ma culturale; per far di meglio occorrerebbe presupporre ciò che si pretende di spiegare - la forma culturale. Ma permette temi un legittimo “nervosismo”. Finché questo si applica al ma terialismo storico, è Marx a criticare Marx, seppure per mezzo dell’antropologia successiva. Il punto centrale di queste obie zioni è già stato anticipato dall’interpretazione marxiana della produzione che si rivolge non semplicemente alla riproduzione dei produttori, ma anche ai rapporti sociali entro cui avviene la produzione. Il principio è, inoltre, profondamente insito nel l’opera di Marx in una forma ancora più generale. Riporto un passo deli’Ideologia tedesca che informerà gli sviluppi successivi: “Questo modo di produzione non si deve giudicare solo in quan to è la riproduzione dell’esistenza degli individui; anzi, esso è già un modo determinato dell’attività di questi individui, un mo do determinato di estrinsecare la loro vita, un modo di vita de terminato” (Marx e Engels, 1845-46, ed. it. pp. 8-9). E cosi era Marx a pensare che gli uomini non producono mai in assolu to, ossia come esseri biologici in un universo di necessità fisi che. Gli uomini producono oggetti per dati soggetti sociali, nel corso della loro riproduzione mediante oggetti sociali. Neppure il capitalismo, nonostante il fatto che apparente mente si organizza mediante e per il vantaggio prammatico, può sfuggire a questa costituzione culturale di una prassi apparen temente obiettiva. Infatti, come risulta anche dalla lezione di Marx, tutta la produzione, anche quando è governata dalla for ma-merce, dal valore di scambio, resta produzione di valori d’uso. Senza consumo, l’oggetto non si realizza come prodotto: una casa disabitata non è una casa. Ma il valore d’uso non può essere inteso specificamente a livello di “bisogni” e “necessità” - proprio perché gli uomini non producono semplicemente un “edificio” o un “riparo”: essi producono abitazioni di un gene re determinato, come un casolare di contadini o un castello si gnorile. Questa determinazione dei valori d’uso, di un partico lare tipo di edificio come particolare tipo di abitazione, rap presenta un continuo processo di vita sociale in cui gli uomini definiscono gli oggetti in rapporto a se stessi e se stessi in rap porto agli oggetti. 187
La produzione, perciò, è qualcosa di più e di diverso che una logica pratica dell’efficienza materiale. E un’intenzione cultu rale. Il processo materiale dell’esistenza fisica è organizzato co me processo significativo di esistenza sociale - che per gli uo mini, dal momento che sono sempre-definiti culturalmente in forme determinate, è il solo modo della loro esistenza. Se fu Saussure a prevedere lo sviluppo di una semiologia generale ap plicata al “ruolo svolto dai segni nella vita sociale”, fu Marx a occuparsi della mise-en-scène. Situando la società nella storia, e la produzione nella società, Marx inquadrò la problematica di una scienza antropologica che non era ancora nata. Infatti la do manda che poneva conteneva in sé la risposta (in quanto la do manda è la definizione del simbolo stesso): come possiamo dar conto di u n ’esistenza di persone e cose che non può essere rav visata nella loro natura fisica? Abbiamo visto che nonostante questo Marx riservò il caratte re di simbolo all’oggetto nella sua forma-merce (feticismo). As sumendo che i valori d’uso servono evidentemente i bisogni umani, e ciò in virtù delle loro palesi proprietà, svalutò le rela zioni significanti tra uomini e oggetti, indispensabili per com prendere la produzione in qualsiasi forma storica. Lasciò irrisolta la questione: “Ma qual è la sede in cui vanno trattati questi pro blemi concernenti il sistema dei bisogni e il sistema dei lavori?” Per poter inquadrare una risposta, e dare una spiegazione cul turale della produzione, è di grande importanza notare che il si gnificato sociale di un oggetto, che lo rende utile per una certa ca tegoria di persone, non è evidenziato dalle sue caratteristiche fi siche più di quanto lo sia il valore che gli può essere attribuito nel lo scambio. Il valore d ’uso non è meno simbolico o meno arbi trario del valore della merce. Infatti 1’“utilità” non è una qualità dell’oggetto, ma una funzione significante delle qualità obiettive. La ragione per cui gli americani giudicano la carne di cane non commestibile e la carne bovina “cibo” non è più percepibile ai sensi di quanto lo sia il prezzo della carne. Analogamente, ciò che caratterizza i pantaloni come maschili e le gonne come femmini li non ha alcuna connessione necessaria con le loro caratteristiche fisiche o con le relazioni che ne derivano. E per le loro correla zioni in un sistema simbolico che i pantaloni sono prodotti per gli uomini e le gonne per le donne, e non per la natura dell’oggetto in sé o per la sua capacità di soddisfare un bisogno materiale - al188
lo stesso modo è per i valori culturali di uomini e donne, che nor malmente sono i primi e non le seconde a intraprendere questa produzione. Nessun oggetto, nessuna cosa, ha esistenza o rilievo nella società umana se non per il significato che gli uomini pos sono dare loro.2 La produzione è un momento funzionale di una struttura cul turale. Se si comprende ciò, la razionalità del mercato e della società borghese è posta in una luce diversa. La famosa logica di massimizzazione è solo la manifestazione apparente di un’al tra Ragione, per lo più inosservata e di genere completamente diverso. Anche noi abbiamo dei padri. Non è come se non aves simo cultura: come se fossimo privi di un codice simbolico di oggetti - rispetto al quale il meccanismo offerta-domanda-prez zo, apparentemente dominante, è in realtà subalterno. Consideriamo, per esempio, quello che gli americani produ cono per soddisfare i “bisogni” fondamentali di cibo e di ve stiario.*
PREFERENZE E TABU ALIMENTARI: GLI ANIMALI DOMESTICI IN AMERICA
Questi appunti sull’utilizzazione dei comuni animali dome stici in America non hanno grandi pretese: lo scopo è soltanto suggerire la presenza di una ragione culturale nelle nostre abi tudini alimentari, indicare qualche connessione significante nel le distinzioni in categorie di commestibilità tra cavalli, cani, maiali e bovini. Ma il punto non riguarda solo l’interesse ali mentare: il rapporto produttivo della società americana con l’ambiente suo proprio e mondiale è organizzato secondo de terminazioni specifiche di commestibilità e non commestibilità, qualitative in se stesse e non giustificabili in alcun modo con un vantaggio biologico, ecologico o economico. Le conseguen ze funzionali vanno dall’“adattamento” dell’agricoltura alle re lazioni di scambio internazionali e di politica mondiale. Lo sfrut tamento dell’ambiente americano, il modo di rapportarsi al pae saggio, dipendono da un modello di pasto che comprende un elemento centrale di carne col supporto periferico di carboi drati e vegetali - dove la centralità della carne, che è anche la nozione della sua “potenza”, richiama il polo maschile di un 189
codice sessuale del cibo che deve risalire all’identificazione in doeuropea tra la mandria, come ricchezza che ha la capacità di riprodursi, e la virilità.4 L’indispensabilità della carne come “po tenza”, e della bistecca come compendio delle carni virili, rimane una condizione fondamentale della dieta americana (si pensi al le diete durante gli allenamenti delle squadre di atleti, soprat tutto di football). Ne deriva anche una struttura corrisponden te della produzione agricola di cereali per l’alimentazione, e a sua volta un’articolazione specifica del mercato internazionale e tutto ciò cambierebbe dal giorno alla notte se noi mangiassi mo carne di cane. Paragonati a questo calcolo significante di pre ferenze alimentari, offerta, domanda e prezzo presentano l’in teresse dei mezzi istituzionali di un sistema che non include i costi di produzione nei propri principi di ordinamento gerar chico. I “costi di opportunità” della nostra razionalità economi ca costituiscono una formazione secondaria, l’espressione di rap porti già posti da un altro genere di pensiero, visti, a posterio ri, come interni alle costrizioni della logica dell’ordine significan te. Il tabù posto sui cavalli e sui cani rende cosi impensabile il consumo alimentare di una serie di animali il cui allevamento sarebbe agevole, e il cui valore nutritivo non è disprezzabile. Cer tamente deve essere possibile allevare alcuni cavalli e cani per alimentazione insieme a bovini e suini. Esiste anche un’enorme industria per l’allevamento di cavalli destinati a cibo per cani. Ma allora, l’America è il paese del cane sacro. Un indiano delle Pianure, o un hawaiano (per non dire di un indù), potrebbe essere sconcertato vedendo in che modo noi lasciamo prosperare i cani sotto la più stretta interdizione di consumo. Scorrazzano a piacere per le strade delle maggiori città americane, portandosi il padrone al guinzaglio e deposi tando a volontà gli escrementi sul marciapiede. Un intero si stema igienico organizzato deve essere impiegato per eliminare la sporcizia - che il modo di pensare del posto, con tutto il ri spetto per i cani, considera “inquinante” (ciò nonostante un gi ro a piedi per le vie di New York fa si che un pascolo di vac che nel midwest, con tutti i suoi rischi, somigli a una idilliaca passeggiata in campagna). Dentro le case e gli appartamenti il cane sale sulla sedia destinata all’uomo, dorme nel letto e sie de a tavola a suo modo aspettando di dividere il pasto con la famiglia. Tutto ciò nella sicurezza assoluta che non verrà mai 190
sacrificato né alla necessità né alla divinità, e che non sarà man giato neppure in caso di morte accidentale. Per quanto riguar da i cavalli, gli americani sono sfiorati dal sospetto che siano commestibili. Si mormora che i francesi li mangino. Ma la sola menzione di questo fatto basta a suscitare il sentimento totemico che i francesi stanno agli americani come le rane stanno alle persone.* Le contraddizioni di un sistema emergono nelle crisi. Du rante l’improvviso aumento dei prezzi dei generi alimentari nel la primavera del 1973, il capitalismo americano non si fece pren dere alla sprovvista - al contrario; ma le spaccature nel sistema alimentare vennero alla luce. I funzionari governativi suggeri rono che si sarebbe dovuto incoraggiare la gente a comprare tagli più economici di carne, come rognone, cuore, o altre in teriora - che in fondo sono altrettanto nutrienti di un ham burger. Per gli americani questo particolare suggerimento fece si che Maria Antonietta sembrasse un modello di compassione (vedi fig. 10). La ragione del disgusto sembra connessa alla stes sa logica che accompagnò certi tentativi poco apprezzati di so stituire la carne di cavallo al manzo, compiuti anche nello stes so periodo. L’esempio che segue è preso dall’Honolulu Advertiser del 15 aprile 1973: LA PROTESTA DEGLI AMICI DEI CAVALLI Conn. (UPI) - Ieri circa 25 persone a cavallo e a pie di hanno sfilato davanti ai Magazzini Carlson per protestare con tro il negozio che vende carne di cavallo come alternativa più economica al manzo. “Penso che macellare cavalli per consumo umano in questo pae se sia una cosa vergognosa,” ha detto Richard Gallagher, l’organiz zatore della protesta. “Non siamo ancora arrivati negli Stati Uniti al punto di essere costretti ad abbattere i cavalli per la loro carne.” “I cavalli sono fatti per essere amati e per essere cavalcati,” ha detto Gallagher. “In altre parole, i cavalli suscitano il nostro af fetto, mentre i bovini sono allevati per essere mangiati, [...] essi non hanno mai avuto chi li accarezzasse o li strigliasse o cose del
W estbrook,
* Frog (rana) è il termine usato in America e in Inghilterra come soprannome dispregiativo dei francesi, e deriva proprio dall’impiego alimentare delle rane, diffuso in Francia e largamente ritenuto incon cepibile in quei paesi. (N.d.T.) 191
genere. Comprare il cavallo di qualcuno per macellarlo, questo proprio non lo concepisco.” Il negozio ha cominciato martedì a vendere carne di cavallo come “girello equino”, “costata di cavallo” e “horseburger” - e il proprietario, Kenneth Carlson, ha dichiarato di averne venduto circa 20.000 libbre nella prima settimana. Molti macellai che vendono carne di cavallo compravano “ca valli vecchi, ormai inutili”, che in ogni modo sarebbero stati ven duti “come cibo per cani e roba del genere”, sostiene Gallagher. Ma “adesso stanno abbattendo cavalli giovani. Noi ora non pos siamo comprare questi cavalli, perché quegli assassini ci stanno mettendo fuori gioco con le loro offerte.” La ragione principale postulata nel sistema americano della carne è il rapporto tra le specie e la società umana. “I cavalli suscitano il nostro affetto, mentre i bovini sono allevati per es-
—Mrs. Virginia Knauer, thè President’s advisor on consumer affairs.
‘No matter how you slice i t ..
Figura 10
Dall Honolulu Advertiser, 2 mano 1973. 192
sere mangiati... essi non hanno mai avuto chi li accarezzasse o li strigliasse, o cose del genere.”5 Analizziamo più da vicino la serie di animali addomesticati bovini-suini-cavalli-cani. Essi sono tutti in qualche misura integrati nella società americana, ma chiaramente a livelli diversi, che corrispondono ai diversi gradi di commestibilità. La serie può essere suddivisa, in prima istan za, nelle due classi, commestibile (bovini-suini) e non comme stibile (cavalli-cani), e poi ancora, all’interno di ciascuna classe, nelle categorie di maggiore e minore gradimento (dal manzo al maiale) e di tabù più o meno rigido (dai cani ai cavalli). Tut to l’insieme appare differenziato dalla partecipazione come sog getto o come oggetto alla compagnia dell’uomo. Inoltre, la stes sa logica organizza la distinzione, negli animali commestibili, tra “carne” e “organi” interni o “interiora”. Per usare la con venzionale formula magica dello strutturalismo, “tutto accade come se” il sistema alimentare fosse tutto pervaso da un prin cipio metonimico per cui, preso nel suo insieme, esso rappre senta una metafora continuata del cannibalismo. Cani e cavalli partecipano nella società americana delle qua lità di soggetti. Hanno nomi propri; noi abbiamo l’abitudine di chiacchierarci mentre non parliamo con maiali e buoi.6 Cani e cavalli sono cosi considerati non commestibili, poiché, come di ce la Regina Rossa, “è contro le regole dell’etichetta fare a fet te qualcuno a cui si è stati presentati”. Ma come convivente in casa, il cane è più vicino agli uomini del cavallo, e mangiarlo è più impensabile: è “uno di famiglia”. Tradizionalmente i caval li hanno un rapporto più servile, di lavoro, con le persone; se i cani sono dei familiari, i cavalli sono dei domestici, e non dei parenti. Di conseguenza il consumo alimentare di cavalli è al meno immaginabile, anche se non generalmente diffuso, men tre l’idea di mangiare un cane suscita comprensibilmente una repulsione del tipo di quella che si prova verso l’incesto.7Dall’al tro lato, gli animali commestibili quali bovini e suini hanno in genere lo status di oggetto rispetto ai soggetti umani; vivono la loro vita separatamente, e non sono mai complemento diretto o strumento di lavoro di attività umane. Di solito, dunque, non hanno un nome, o se lo hanno, come qualche vacca da latte, serve principalmente come termine di riferimento nella con versazione tra gli uomini. Ma come animali da cortile e in quan to si nutrono dei rifiuti del cibo degli uomini, i maiali sono 193
contigui alla società umana più dei bovini (cfr. Leach, pp. 5051). Di conseguenza, a parità di taglio, il maiale è cibo meno nobile del manzo. Il manzo è la portata di carne della posizio ne sociale più elevata, e dell’occasione sociale più importante. Un arrosto di maiale non ha la solennità di una costata di man zo di prima scelta, e nessun punto del maiale regge il confronto con la bistecca. La commestibilità è inversamente proporzionale all’umanità. Lo stesso vale per le preferenze e le designazioni comunemen te applicate alle parti commestibili dell’animale. Gli americani fanno una distinzione categorica tra le parti “interne” e quelle “esterne”, distinzione che rappresenta per loro u n ’estensione metaforica del principio stesso di umanità. La natura organica della carne [flesh] (muscolo e grasso) viene celata, usando pre feribilmente il termine “meat” o determinazioni particolari qua li “roast”, “steak”, “chops”, o “chuck”; mentre gli organi interni sono dichiarati apertamente come tali" (o come “interiora”), e più specificamente come “cuore”, “lingua”, “rognone” e cosi via - salvo quando il processo di cottura trasforma eufemistica mente in “sweetbreads” [“animelle”] organi quali il timo e il pancreas .8 Le parti interne e le esterne, in altre parole, sono ri spettivamente assimilate e distinte rispetto alle parti del corpo umano - secondo il criterio per cui identifichiamo il nostro “io interiore” con il nostro “vero io” - e le due categorie vengono di conseguenza classificate come più o meno adatte per il con sumo umano. La distinzione tra “interno” e “esterno” in tal mo do raddoppia nell’animale la differenziazione già in atto tra spe cie commestibili e tabù, e cosi il tutto istituisce una sola logica su due piani con l’importante implicazione della proibizione del cannibalismo. E questa logica simbolica ciò che organizza la domanda. Il valore sociale della bistecca o dell’arrosto, a paragone della trip pa o della lingua, è ciò che è alla base della differenza del lo ro valore economico. Dal punto di vista nutritivo una simile no zione di tagli “superiori” o “inferiori” sarebbe difficile da soste nere. Inoltre la costata resta il punto di carne più costoso an che se la sua offerta in assoluto è molto più alta di quella del la lingua: in un capo ci sono molte più costate che lingue. Ma, ancora più importante, lo schema simbolico di commestibilità si collega con quello che organizza i rapporti di produzione per 194
poi far precipitare, attraverso distribuzione di ricchezza e do manda, un intero ordine totemico, congiungendo in una serie parallela di differenze la condizione di persona con ciò che es sa mangia. La gente più povera compra i tagli più economici, più economici perché socialmente inferiori. Ma la povertà è co dificata in primo luogo etnicamente e razzialmente. Bianchi e neri entrano nel mercato del lavoro americano: la loro parte cipazione è ordinata dalle odiose distinzioni delle relative “ci viltà”. Il nero nella società americana è come “il selvaggio in mezzo a noi”, la natura oggettiva nella cultura stessa. Ma allo ra, in virtù della conseguente distribuzione della ricchezza, 1’“in feriorità” dei neri si realizza anche come contaminazione ali mentare. Del “soul food”* si può fare virtù. Ma solo come ne gazione di una logica generale in cui la degradazione cultura le è confermata da preferenze dietetiche affini al cannibalismo, proprio in quanto questo attributo metaforico del cibo è con fermato dalla condizione di coloro che lo preferiscono. Non mi riferirei al “cosiddetto totemismo” se si trattasse sem plicemente di u n ’analogia casuale con la pensée sauvage. Vero è che Lévi-Strauss scrive come se il totemismo si fosse ridotto nel la nostra società a una pratica del tutto marginale o occasiona le (1962b; 1962a). E abbastanza giustamente - nel senso che l”’operatore totemico”, che articola le differenze nella serie cul turale con le differenze nelle specie naturali, non costituisce più un’architettura primaria del sistema culturale. Ma occorre chiedersi se non sia stato rimpiazzato da specie e varietà di ma nufatti che, al pari delle categorie totemiche, hanno il potere di trasformare la stessa delimitazione dei loro proprietari indi viduali in un processo di classificazione sociale. (Il collega Mil ton Singer suggerisce che ciò che Freud diceva delle differen ziazioni nazionali potrebbe essere esteso al capitalismo, e cioè che è un narcisismo rivolto a differenze secondarie.) E, ancora più importante, gli operatori totemici e gli operatori-prodotto non hanno forse una base comune nel codice culturale delle caratteristiche naturali, nella funzione significante attribuita ai * Si tratta del cibo - intestino di maiale, patata dolce - con cui tra dizionalmente venivano nutriti gli schiavi neri nel sud degli Stati Uni ti. (N.d.T.) 195
contrasti di forma, linea, colore e ad altre proprietà oggettuali offerte dalla natura? Lo “sviluppo” realizzato dalla pensée bourgeoise può consistere essenzialmente nella capacità di raddop piare e combinare a volontà tali variazioni, e all’interno della società stessa. In questo caso la produzione capitalistica è u n ’espansione esponenziale dello stesso genere di pensiero, con scambio e consumo quali suoi mezzi di comunicazione. Infatti, come scrive Baudrillard a questo proposito, il consu mo è anch’esso uno scambio (di significati), un discorso - a cui i valori pratici, le “utilità”, sono apposti solo post facto: Ciò è vero per la comunicazione linguistica, ma anche per quel la dei beni e dei prodotti. Il consumo è scambio. Un consuma tore, come colui che parla, non è mai solo. Ed è a questo punto che è necessario l’intervento di una rivoluzione totale nell’anali si del consumo: come non vi è il linguaggio perché vi sarebbe un bisogno individuale di parlare (cosa che porrebbe il duplice e in solubile problema di fondare individualmente questo bisogno, e di articolarlo successivamente in uno scambio possibile), ma fin dal principio vi è il linguaggio, non come sistema assoluto, auto nomo, ma come struttura di scambio, contemporanea al senso stesso, e sulla quale si articola l’intenzione individuale della pa rola - cosi non esiste un “consumo” per il fatto che vi sarebbe un bisogno obiettivo di consumare, una intenzionalità del soggetto verso l’oggetto: ciò che esiste è una produzione sociale in un si stema di scambio, di un materiale di differenze, di un codice di significati e di valori di status, mentre la funzionalità dei beni e dei bisogni individuali sopraggiunge successivamente a questi mec canismi strutturali fondamentali, per razionalizzarli e in pari tem po rimuoverli. [Baudrillard, 1972, ed. it. pp. 67-68]9 Il totemismo contemporaneo non è contraddetto dalla ra zionalità del mercato. Al contrario, è alimentato esattamente quanto il valore di scambio e il consumo dipendono da deci sioni di “utilità”. Infatti tali decisioni si basano sulla funzione si gnificante sociale delle opposizioni concrete tra prodotti. E per mezzo delle differenze significative rispetto ad altri beni che gli oggetti hanno la possibilità di essere scambiati: in tal modo es si diventano valori d’uso per determinate persone, che sono in conseguenza di ciò differenziate da altri soggetti. Allo stesso tem po, come una costruzione modulare di elementi materiali com binati secondo l’invenzione umana, soltanto i prodotti manu196
fatti si prestano a questo tipo di discorso. Producendo l’ogget to l’uomo non si limita ad alienare il suo lavoro, congelato co si in una forma oggettiva, ma, con le modificazioni fisiche che impone, egli sedimenta un pensiero. L’oggetto sta, come con cetto umano, al di fuori di sé, come un uomo che parli a un altro uomo per mezzo di cose. E la variazione sistematica delle forme oggettive è in grado di servire, anche meglio delle diffe renze tra specie naturali, come mezzo per un ampio e dinami co schema di pensiero: e questo sia perché nei manufatti pos sono essere introdotte contemporaneamente molte variazioni, mediante una manipolazione di tipo divino - e quanto maggiore è il controllo tecnico, tanto più precisa e diversificata sarà que sta manipolazione - sia perché ogni variazione in tal modo pro dotta per fini di “utilità” dall’intervento umano deve avere una funzione significante, e non soltanto quelle conformazioni che, esistendo già in natura per necessità propria, si prestano a un’os servazione culturale. Il totemismo borghese, in altre parole, è potenzialmente più elaborato di qualsiasi varietà “sauvage”, non perché sia stato liberato da una base materiale-naturale, ma pro prio perché la natura è stata domesticata. “Gli animali produ cono soltanto se stessi,” come spiegava Marx, “mentre gli uomini riproducono l’intera natura.”10 Ma se non è la mera esistenza che l’uomo riproduce, bensì un “determinato modo di vita”, ne deriva che la riproduzione dell’intera natura costituisce u n ’oggettivazione dell’intera cul tura. Mediante l’aggiustamento sistematico delle differenze si gnificative attribuite al concreto, l’ordine culturale si realizza an che come ordine di beni. I beni fanno da codice oggettuale per la significazione e la valutazione di persone e occasioni, di fun zioni e situazioni. Operando con una specifica logica di corri spondenza tra opposizioni materiali e sociali, la produzione è perciò riproduzione della cultura in un sistema di oggetti. Si è portati spontaneamente a utilizzare il duplice significato di termini quali “fashion” [“forma”, e anche “moda”] e “fabric” [“manufatto” e “tessuto”]: prendo come esempio più indicativo il sistema di abbigliamento americano.
197
N O T E SU L SIST E M A D I A B B IG L IA M E N T O A M ER IC A N O
Considerato nel suo insieme, il sistema di abbigliamento ame ricano costituisce uno schema molto complesso delle categorie culturali e delle relazioni tra loro, una mappa fedele - non è esagerato dirlo - dell’universo culturale .11 Il primo compito sarà far presente che lo schema opera mediante una specie di sin tassi generale: un insieme di regole per declinare e coniugare le classi della forma-abbigliamento in modo da formulare le ca tegorie culturali. In uno studio sulla moda come viene presen tata dalla pubblicità su diverse riviste francesi, Roland Barthes ha identificato, solo per gli abiti da donna, una sessantina di centri di significazione. Ogni elemento o dimensione com prende una serie di opposizioni significanti: alcune per semplice presenza o assenza, come per i guanti, altre per diversificazio ne, come la serie indefinita dei colori (Barthes, 1967, pp. 114 e sgg.) . 12 E evidente che con una sintassi appropriata, con del le regole combinatorie, si può sviluppare una serie enorme di proposizioni, che possono dar luogo ad altrettante formulazio ni dei rapporti tra persone e situazioni nel sistema culturale. È non meno evidente che non posso sperare di far altro che sug gerire la presenza di tale grammatica, senza la pretesa di aver la analizzata. Esistono in un abito diversi livelli di produzione semantica. Il modo in cui si è vestiti, preso nel suo insieme, costituisce una dichiarazione, che si sviluppa dal particolare accordo delle par ti del vestiario e dal contrasto con tutti gli altri modi di vestire. Inoltre c’è una logica delle parti, i cui significati vengono svi luppati a questo livello in misura differenziata per confronto, in modo saussuriano: cosi, per esempio, il valore dei calzoni da donna è determinato contemporaneamente dall’opposizione con altri indumenti di quella zona del corpo, come gonne o pantaloni da uomo, e dal contrasto con altri esemplari della stes sa classe (calzoni da donna) che differiscano per colore, mo dello o altro. Il mio interesse nel trattare questa sintassi sarà orientato più verso ciò che è noto che verso la spiegazione dell’intera serie di regole. Sarà sufficiente indicare che tale sin tassi fornisce una base sistematica per il discorso culturale “mo dellato” su di essa: 198
“La maggior parte della gente indossa dei segni, senza sapere co sa sta indicando. Scegliete il vostro segno a seconda del pubblico che avete davanti,” diceva Malloy; [...] “un bell’abito scuro, cami cia bianca e cravatta di tipo tradizionale sono i migliori amici nel guardaroba di un giovane che voglia trovare un posto da impie gato in tante imprese e categorie professionali. Essi sono simboli di autorità. E semplicissimo,” diceva. [“Fashion Column”, Chicago Daily News, 11 gennaio 1974] Ma c’è un altro problema, irn po’ più difficile. Vorrei scende re al livello delle unità costitutive che compongono il discorso: per dimostrare cosi in che modo particolari significati sociali si ri feriscono a contrapposizioni fisiche elementari nell’oggetto di ab bigliamento. Sarà anche un movimento di riawicinamento al pen siero totemico. Il principio infatti è esattamente lo stesso: una se rie di differenze concrete tra oggetti della stessa classe a cui cor rispondono distinzioni lungo determinate dimensioni dell’ordi ne sociale - come la differenza tra colletti blu e colletti bianchi è la differenza tra lavoro manuale e lavoro impiegatizio; il colore più o meno carico e più o meno luminoso differenzia l’autunno dalla primavera; o: “Un dolce disordine nella veste/accende nell’abito i sensi” (Herrick). Con questi mezzi l’insieme degli og getti manufatti è in grado di comprendere l’intero ordine cultu rale di una società a cui vorrebbe al tempo stesso dare un abito e dedicarsi - due parole ( to dress e to address) la cui derivazione da una comune radice, come diceva Tylor a proposito di “kìndred" (parentela) e “kindness” (gentilezza), esprime nel modo migliore uno dei principi più importanti della vita sociale. L’obiettivo primario in tutto ciò, voglio sottolinearlo, è dare un contributo a una spiegazione culturale della produzione. E a questo scopo che esamino il codice delle proprietà oggettua li e le loro combinazioni significanti. Evidenziare il codice im plica anche che per ora non ci occuperemo di come gli indivi dui si vestono. Questa non è semplicemente una decisione a fa vore della langue rispetto alla parole. Come la gente si veste è un problema semiotico di gran lunga più complesso di quello che può essere affrontato qui, comprendendo anche la particolare coscienza o idea di sé del soggetto in uno specifico e significa tivo “contesto di situazione”. Inoltre, sfioro appena la questio ne connessa della manipolazione del codice della moda all’in terno dell’industria dell’abbigliamento. Comunque, se tutte que199
ste limitazioni, che hanno un riferimento comune al sistema in atto, rendono la spiegazione purtroppo incompleta, esse hanno il vantaggio di mettere a fuoco il punto di vista che è necessa rio assumere in anticipo, e senza il quale ogni ulteriore analisi dell’azione rischia di cadere in un pragmatismo grossolano: la produzione è la realizzazione di uno schema simbolico. Si noti infatti che cosa viene prodotto nel sistema di abbi gliamento. Per varie caratteristiche obietdve un capo di vestiario risulta adatto per uomo o per donna, per la sera o per il gior no, “per casa” o “per uscire”, per un adulto o per un adole scente. Ciò che viene prodotto è innanzi tutto classi di tempo e di luogo che segnalano situazioni o attività; e, secondo, classi di status a cui ogni persona appartiene. Queste potrebbero essere chiamate “coordinate concettuali” dell’abbigliamento, nel senso che esse classificano i concetti base di tempo, luogo e persona in quanto costituiti nell’ordine culturale. Quindi ciò che è ri prodotto nell’abbigliamento è lo schema classificatorio. Ma non solo questo. Non solo i confini, le divisioni e le suddivisioni dei gradi di età, per esempio, o delle classi sociali; con uno speci fico simbolismo di differenze di abbigliamento, ciò che è pro dotto sono le differenze significanti tra queste categorie. Pro ducendo abiti per donna di taglio, linea o colore diversi da quel li per uomo, riproduciamo la distinzione tra femminile e ma schile cosi come è nota in questa società. Questo è quanto ac cade nel processo prammatico-materiale della produzione. Più in particolare, ciò che accade è una differenziazione del lo spazio culturale come tra città e campagna e, all’interno del la città, tra centro e periferia - e poi ancora, u n ’opposizione tra tutti questi elementi che costituiscono complessivamente la sfera pubblica, e l’ambito domestico-familiare. Quando una don na va a fare spese, normalmente indossa un abito da casa, ar ricchito da u n ’esibizione periferica di elementi come i gioielli; e questo più se va a far spese in centro che “nelle vicinanze”. Viceversa, quando un uomo torna a casa da una “dura giorna ta in ufficio”, si spoglia dello stile pubblico adottando un abbi gliamento più consono alla “familiarità” della sfera domestica.13 All’altro estremo si trovano le distinzioni più alte dello spazio nazionale: per esempio, la costa occidentale e la costa orienta le, le cui sottoclassi notevoli sono la California e gli stati nor dorientali (cfr. Rosencranz, 1972, pp. 263-264). 200
Inoltre noi concretizziamo nell’abbigliamento le valutazioni culturali di base del tempo - quotidiano, settimanale, stagiona le. Abbiamo abiti da sera e da giorno, abiti da pomeriggio e da notte (pigiama). Ciascuno di essi fa riferimento alla natura del le attività iscritte in questo periodo di tempo, per cui l’abbi gliamento della settimana sta a quello “buono” della domeni ca come il profano sta al sacro. Le variazioni stagionali marca te sono primavera e autunno, essendo i colori di queste stagio ni concepiti abitualmente come paralleli al ciclo vegetale. (Fuo ri casa i colori in sé sembrano invertiti per gli abiti estivi e invernali: verde e rosso puri segnano il solstizio d ’inverno [Na tale], mentre il bianco è tradizionalmente adatto per il Memorial Day [30 maggio] e il Labor Day [4 settembre].) Un discorso analogo potrebbe essere applicato all’abbiglia mento delle classi, dei sessi e delle età. Tutte queste categorie sociali hanno determinati indicatori, variazioni caratterizzanti a livello oggettuale. Nell’ideologia comune di produttori e con sumatori, questa consustanzialità di soggetto e oggetto è riferi ta a un’identità di essenze, cosi che la seta è “femminile” quan to la donna è “di seta”. “Fine come la seta”, “soffice come la se ta”, il tessuto si oppone da un lato alla mascolinità della lana e dall’altro alla qualità inferiore del cotone (cfr. Dichter, 1959, pp. 104 e sgg.).'4 Ma questa correlazione vebleniana tra l’alto li vello del lusso e l’alto livello della femminilità non è valida per tutte le razze: per i neri americani il maschile sembra essere il sesso marcato, mentre tra i bianchi è il femminile a essere ab bellito.15 Ma a sua volta la correlazione tra l’eleganza del ma schio nero e della donna bianca a livello di tessuto sarà artico lata in modo differenziato dall’appartenenza di classe, nella mi sura in cui razza e classe si sovrappongono, ed è un luogo co mune della sociologia fatta in casa che colori tenui e minore contrasto indicherebbero la “classe dirigente”, mentre colori vi vaci e contrasto maggiore sarebbero propri della “massa” (Birren, 1956). D’altra parte la sobria seta della donna bianca del la classe superiore è sostituita negli abiti di sua figlia dal tessu to della giovinezza: col che il cerchio si chiude riportandoci al la lana, che distingue tra giovane e maschio, da un lato, e don na adulta, dall’altro, rispetto agli attributi di attività/passività (rituale).16 Sesso e classe di età si prestano a illustrare un’altra proprietà 201
della grammatica: la presenza di alcuni meccanismi che per mettono di aprire la serie per renderla più complessa, senza tuttavia dar luogo a una revisione dei principi. Seppure allar gato, il sistema sembra corrispondere al concetto di Sapir se condo cui la moda è costume sotto l’aspetto di un allontana mento dal costume. Nuove specie e sottospecie sono permuta te, per esempio, da una sintesi combinatoria di opposizioni esi stenti. Nelle categorie del creatore di moda, la distinzione tra dizionale tra età infantile e età scolare è stata ulteriormente segmentata in: “infants”, “toddlers”, “preschoolers” e “schookhildren analogamente gli adolescenti non sono più quello che erano una volta, ma “preteens”, “subteens" e “teens” (Rosencranz, 1972, p. 203). Allo stesso modo, varie categorie di omosessualità si so no potute sviluppare da particolari combinazioni di capi di ve stiario maschili e femminili, al punto che ora, nel campo dell’ab bigliamento, abbiamo sei sessi più o meno differenziabili. Ma accanto alla linea divisoria tra adolescente e adulto si evidenzia comunemente un secondo tipo di permutazione: l’adattamen to di una distinzione che esiste da qualche altra parte del si stema, una specie di transfert metaforico, per indicare un mu tamento di contenuto in u n ’opposizione tradizionale. L’idea corrente di una “rivoluzione adolescenziale” ha senza dubbio predisposto il mutamento, ma dalla guerra del Vietnam il con flitto con l’autorità costituita (gli adulti), si è formalizzato in sen so specificamente politico, e lo stesso è avvenuto nell’abbiglia mento, dove l’opposizione adolescente/adulto si è sovrapposta a quella lavoratore/capitalista, quando i giovani hanno adotta to blue jeans e giubbotti da lavoro delle classi inferiori della so cietà. Probabilmente nulla meglio di questo prova la mancanza di utilità pratica nell’abbigliamento, poiché il lavoro è una del le cose più lontane dalla mente dei giovani. Ma l’esempio ser ve altrettanto bene a illuminare una singolare caratteristica del la società capitalistica: non che essa manchi di funzionare su un codice simbolico, ma che il codice funziona come un insie me aperto, che reagisce agli eventi, da esso organizzati e assi milati, per riprodursi in versioni allargate. Tra parentesi, questa idea della produzione come concretiz zazione di una logica culturale dovrebbe impedirci di parlare in modo ingenuo della genesi della domanda per mezzo dell’of ferta, come se il prodotto sociale fosse il risultato della cospi202
razione di pochi “decision-makers” in grado di imporre un’ideo logia della moda attraverso le seduzioni della pubblicità. Se condo l’espressione di Marx, “l’educatore deve essere educato”. Non è come se la parole del produttore diventasse la nostra langue. E non è necessario indugiare nella opposta mistificazione secondo cui la produzione capitalistica sarebbe la risposta ai bi sogni del consumatore: “Noi cerchiamo sempre di adeguarci,” dice il capo delle pubbliche relazioni della compagnia che ha fatto i maggiori guadagni con il recente incremento delle ven dite di blue jeans.17 Ma chi è allora che comanda, il produtto re o il consumatore? Sarebbe possibile tralasciare tutte queste rappresentazioni soggettive per far posto a una descrizione in termini istituzionali della produzione capitalistica come proces so culturale. Chiaramente questa produzione è organizzata in modo da sfruttare ogni possibile differenziazione sociale con una avveduta differenziazione di beni. Essa si realizza secondo una logica significante del concreto, della funzione di signifi cato delle differenze oggettive, in modo di valorizzare i segnali propri delle distinzioni sociali emergenti. Questo potrebbe de scrivere bene la specializzazione delle differenze di età nell’ab bigliamento e il transfert metaforico dei blue jeans, soprattutto se si nota che l’integrazione iconica tra distinzioni sociali e og gettuali è un processo dialettico. Il prodotto che raggiunge il mercato a cui è destinato costituisce l’oggettivazione di una ca tegoria sociale, e aiuta a costituire quest’ultima nella società; a sua volta, la differenziazione tra categorie sviluppa ulteriori de clinazioni sociali nel sistema di beni. Il capitalismo non è ra zionalità assoluta. E una forma particolare di ordine culturale; o un ordine culturale che opera in una forma particolare. Chiu sa la parentesi. Passiamo a un altro tipo di variazione nell’abito, corrispon dente alla divisione del lavoro in senso lato, per suggerire resi stenza di regole sistematiche per la classificazione sociale della forma abbigliamento. Prima, comunque, dobbiamo stabilire la classificazione sul livello sociale. Nella sua esposizione del mon de nella mode, Barthes distingue due modi alternativi in cui è concepita la funzione significante sociale (1967, pp. 248 e sgg.). Questi sono, in pratica, due modalità del discorso sociale, quel la attiva e quella passiva; fare ed essere, faìre e Stre, attività e identità. Adattando la distinzione al nostro scopo, si potrebbe 203
dire che la prima modalità ha a che fare con le funzioni: pre scrive l’abito a seconda del tipo di attività, si tratti di sport o di lavoro manuale; la seconda si riferisce invece allo status occu pazionale: la tenuta tipica dell’operaio, del contadino, della ca meriera,, del medico, del soldato. Inoltre, nello schema che se gue (fìg. 1 1 ) - una tavola generalissima e molto semplificata di funzioni -, ho concentrato un argomento importante e diversi assunti. L’assunto principale è la validità della distinzione di Veblen tra festa e lavoro nelle categorie di attività e abbigliamento in America. La chiave di lettura dell’intera tavola è questo princi pio. In ciascuna opposizione la funzione marcata o cerimonia le è posta a sinistra, e quella non-marcata o lavorativa a destra col risultato di un insieme di differenziazioni della distinzione principale tra lavoro e tempo libero (cfr. Veblen, 1899). Se que sto assunto è accettato come più o meno etnograficamente cor retto, e se le sue conseguenze sono sviluppate per classi e sot toclassi in modo attento, due notevoli elementi ricorrenti si evi denzieranno nel sistema di abbigliamento. Il primo può essere chiamato la regola della corrispondenza cerimoniale. Si riferisce al l’analoga differenziazione di abito in ciascuna delle due classi funzionali similmente ordinate rispetto all’opposizione festa/lavoro. Si consideri, per esempio, 1’“abito da cerimonia” indossa to dagli uomini in “occasioni speciali” (jéte), la cui foggia più formale, probabilmente, è lo smoking usato in occasioni molto ritualizzate (matrimoni, cerimonie di gala ecc.), seguito dal com pleto scuro, appena un po’ meno formale. Si noti che questi abiti somigliano molto all’abbigliamento “classico” degli uomi ni d’affari e dei dirigenti; sono analoghe anche le rispettive dif ferenze dall’abbigliamento sportivo nel campo del divertimen to, e dal modo di vestire impiegatizio nell’ambito del lavoro. An che gli ultimi due, per il loro relativo “non formalismo”, i co lori ammessi ecc., si somigliano; al punto che il più giovane im piegato può essere distinto dai più importanti dirigenti proprio per la sua “giacca sportiva”. Ma è esattamente la stessa differenza che caratterizza, in linea generale, l’opposizione tra la tenuta di divertimento più formale e la relativa tenuta da casa con sentita “quando non si fa niente, quando si passa una serata a casa” (sans project). O, ancora, è la stessa differenza che corre tra i blue jeans o la tuta di un operaio e la divisa più elegante 204
205
Figura 11
Schema delle funzioni significate nell’abbigliamento americano.
FUNZIONI
di una cameriera, di un fattorino o di un altro addetto ai ser vizi. Questa particolare opposizione ricompare sul versante tem po libero nelle tenute sportive di caccia o di sci, che hanno ca rattere di uniforme proprio in quanto sono differenziati dall’ab bigliamento casual dello spettatore .18 Esiste dunque una regola di analogia nelle opposizioni festa/lavoro a qualunque livello del sistema esse possano comparire. I termini di ciascuna op posizione corrispondono ai termini di ciascun'altra, cosi che gli indumenti marcati (cerimoniali) di ognuna delle due classi si richiamano a vicenda a mezzo di u n ’analoga differenziazione dagli indumenti non-marcati (di lavoro) delle loro classi ri spettive. O, in termini più formali: 1) M /.V /s My/M ?; e cioè, l’opposizione (/) tra marcato (M) e non marcato (M) in ogni classe data (x) corrispondente (=) a M/M in ogni altra classe (31). Oltre alle somiglianze nelle diversità esistono anche diversità nelle somiglianze - uno smoking è ancora più “formale” di un completo da uomo d ’affari, cosi come gli abiti da casa (soprat tutto da notte) sono più “andanti” e “pratici” degli abiti da la voro - e questo ci porta alla seconda regola: la regola dell’ampli ficazione cerimoniale. La regola dice che, da una parte, l’abbi gliamento marcato in una opposizione più cerimoniale è esso stesso più cerimoniale del suo corrispettivo in qualche opposi zione di lavoro: cosi le divise dello sport attivo sono più colo rate e tagliate con più gusto delle divise di una cameriera o di un lattaio. D’altra parte, il vestito non-marcato nell’opposizione cerimoniale è anche meno da lavoro del suo corrispettivo del lato lavorativo: cosi l’abito dello spettatore è più “casual' di quel lo dell’operaio. Lo stesso potrebbe dirsi dell’opposizione tra féte e sport all’interno della categoria “divertimento” paragonata all’opposizione dirigente/impiegato nella categoria del lavoro d’ufficio, anche se quest’ultima coppia è contemporaneamente più cerimoniale (l’abito da dirigente) e meno lavorativa (col letto bianco) della coppia addetto ai servizi/operaio. La rego la, dunque, è che l’opposizione istituita all’interno di una clas se di lavoro, è amplificata dall’opposizione corrispondente in una classe più cerimoniale. L’amplificazione funziona in en trambe le direzioni: l’abito cerimoniale è più cerimoniale al suo polo marcato, meno da lavoro al suo polo non-marcato. Formalizzando: 206
2) Mx' > My2 :: 1VP < My2 dove gli esponenti ( 1, 2, 3, ... n) rappresentano un fattore della funzione/lavoro e i segni > e < rappresentano la relativa formalizzazione. Ovvero, in diagramma (fig. 12): Risparmio al lettore l’esposizione corrispondente per la mo dalità dell’“essere” che, rispondendo alle specializzazioni sem pre più sottili dell’occupazione, è anche più proteiforme del si stema delle funzioni.19 Ma sembra legittimo fermarsi un mo mento a questo nodo per spiegare che cosa ci si aspetti da eser cizi come quelli su cui ci siamo soffermati. L’obiettivo princi pale è rispondere alla domanda posta per primo da Marx, ma rimasta, per quanto ne so, senza risposta nel suo sistema eco nomico come in tutti gli altri: che tipo di spiegazione teorica si può dare della produzione intesa come modo di vita? Io qui pro pongo un esempio possibile per l’inizio di tale spiegazione cul turale: si tratta di un esempio, perché riguarda soltanto il si stema di abbigliamento americano contemporaneo; di un ini zio, perché si occupa soprattutto della sintassi generale, delle classi sociali dell’oggetto di vestiario, e di certe regole della sua declinazione sociale. Ma occorre essere ancora più cauti. Ciò che ci si aspetta dalle regole di corrispondenza cerimoniale è solo che esse suggeriscono una tale sintassi. Per pretendere di più bisognerebbe che la trattazione toccasse le varie caratteri stiche del vestiario .a cui si applicano le regole - toni cromati ci, contrasto di colore, foggia e taglio, tipo e armonizzazione dei capi, generi di accessori, qualità di tessuti - e i modi delle
Figura 12
Regola dell’amplificazione cerimoniale. 207
loro combinazioni. La portata del progetto è enorme; questo è solo un esempio, il suggerimento di un inizio. Nello stesso spirito espongo il processo simbolico al livello più basso degli elementi costituenti e dei loro specifici significati. Quello che ho in mente è la determinazione delle opposizioni distintive minime nelle configurazioni oggettuali, quali la linea, il colore, o il tessuto, che indicano differenze di significato so ciale. Non voglio comunque rivendicare la novità del tentativo, o una sua superiorità; ho soltanto cercato di sistematizzare os servazioni che molti altri hanno già fatto: Per quello che ne so, la tuta da lavoro [l’overalls: blue jeans con pettorina e bretelle] è un capo di vestiario originario di questo paese, [...] il capo standard, classico, almeno [...] per l’agricolto re del Sud: è la sua uniforme, l’insegna e la dichiarazione del suo stato di contadino; [...] la base, ciò che essa è, può essere vista meglio quando è ancora nuova; prima che abbia perso (o acqui stato) forma, colore, e trama; e prima che le cuciture bianche ab biano perso la loro brillantezza [...]. Le bretelle incrociate e i bot toni metallici fanno pensare ai finimenti da lavoro dei cavalli. E nella disposizione funzionale delle tasche sulla pettorina, è possibile vedere dei finimenti modificati per la comodità di un animale di tanto alta intelligenza da servirsi di strumenti. [...] Anche la camicia: taglio squadrato e cuciture robuste, con gran di tasche quadrate e bottoni metallici; la stoffa è rigida, è fresca anche se si lavora sodo, quando è nuova, il colletto è largo e con le punte in fuori, finché è nuova. [James Agee, Let Us Nou Praìse Famous Men, 1941, pp. 265-67], Sono queste unità elementari di significato - tasche quadra te, stoffa rigida, bretelle incrociate - ciò a cui si riferisce la pre sente trattazione. Esiste a un livello più alto un repertorio del le unità producibili: tipi di tessuto quali seta o lana, generi di capi superiori quali camicie e bluse; prodotti come questi en trano integralmente nel corredo complessivo e normalmente diversificano l’insieme. Ma queste unità sono già costruzioni complesse la cui portata significante è affidata ai particolari che ne costituiscono la forma finale. In u n ’opera che mette in ri dicolo la pretesa che i nostri abiti siano in qualche modo “mo derni” o “civilizzati”, Rudofsky scrive:
208
Qualsiasi tessuto può essere assegnato a un sesso semplicemente dandogli una determinata figura. La forma risultante può deter minare il sesso. [...] La sovrapposizione di una camicetta, di una giacca o di un so prabito determina il sesso dell’articolo. Abbottonare un capo d’ab bigliamento sulla destra lo rende utilizzabile solo da un uomo e as solutamente inutilizzabile per una donna. Quali che siano le curio se spiegazioni del folklore, il lato destro del corpo è sempre stato maschile, e il sinistro femminile; questo orientamento sopravvive nonostante la sua irrazionalità. [Rudofsky, 1947, pp. 126-27] Si potrebbero addurre una quantità di esempi di analoghe configurazioni elementari che differenziano il genere degli abi ti. Le maniche degli uomini, per esempio, sono normalmente più sagomate di quelle delle donne e coprono il braccio inte ramente, mentre la lunghezza delle maniche femminili, tre quarti o anche meno, lascia scoperta l’estremità del braccio opposizioni che si ripetono esattamente uguali nelle differenze, agli arti inferiori, tra pantaloni e gonne.20 Il tessuto da uomo è relativamente rigido e ruvido, solitamente più pesante di quel lo da donna, soffice e leggero; a parte il bianco, che è neutro, i colori maschili sono più scuri; quelli femminili chiari o pa stello. La linea maschile è squadrata, con angoli e spigoli; gli abiti da donna sottolineano l’elemento curvo, arrotondato, mor bido e soffice. Tali caratteristiche di linea, tessuto e simili, so no i costituenti minimi, le opposizioni oggettive che convoglia no il significato sociale. Mi trattengo dal chiamarli “vestenti”, ma se necessario potreb bero essere denominati ECU, per “Elementary Constituent Units” [unità costitutive elementari]; secondo McLuhan, “la conformità a una moda mette in circolazione uno stile.” Pro pongo di prendere in considerazione solo tre classi di unità ele mentari: tessuto, linea e colore. Prima il tessuto, soprattutto per mostrare come la funzione significante si sviluppi da opposizioni binarie di significanti. Il tessuto opera semanticamente su una quantità di opposizioni oggettive - pesante/leggero, ruvido/liscio, rigido/soffice - mol te delle quali pertinenti contemporaneamente a ciascuna stof fa data. Marilyn Horn, in un testo che ha per sottotitolo “Stu dio interdisciplinare dell’abbigliamento” (1968, p. 245), compila un elenco esauriente di diadi applicabili ai tessuti, prendendo 209
ciascuna coppia come i due poli di un continuum graduale di variazioni. Da parte mia sarei portato a fare delle distinzioni tra coppia e coppia, ma bisogna riconoscere che la Horn è esper ta e informata. In ogni modo, il tessuto può essere: opaco ruvido irregolare granuloso grezzo massiccio pesante compatto pungente crespo teso duro rigido non elastico caldo scricchiolante
lucido liscio rasato levigato fine vaporoso leggero trasparente lanuginoso soffice flessibile morbido spugnoso cedevole freddo malleabile
L’assunto è che tali differenze oggettive sono al contempo evidenti e socialmente significanti (vedi nota 14 di questo cap.). Ogni stoffa è una combinazione particolare, dunque, di diver se qualità inerenti al tessuto. Nella misura in cui ogni qualità porta con sé un qualche significato, nella differenziazione dal suo opposto oggettivo, il tessuto comunica un insieme paratat tico di proposizioni che riguardano età, sesso, attività, classe, tempo, luogo e le altre dimensioni dell’ordine culturale. Le linee strutturali che compaiono nel taglio o nel modello di abito costituiscono una classe analoga di opposizioni signifi canti. La funzione significante sembra essere correlata con al meno tre caratteristiche di linea: direzione, forma e ritmo. La direzione si riferisce all’orientamento rispetto al suolo: e quindi sarà orizzontale, verticale o obliqua; quest’ultima direzione, in termedia tra le prime due, potrà essere ancora suddivisa in si nistra (verso il basso da sinistra a destra) e destra (verso l’alto da sinistra a destra) (flg. 13). Si noti che è già un piccolo esempio della costituzione cul210
direzione
obliqua
assiale
verticale
Figura 13
orizzontale
sinistra
destra
Direzione della linea.
turale del significato il fatto che una linea obliqua verso il bas so da destra a sinistra, per gli europei è inclinata verso l’alto, mentre una linea verso il basso da sinistra è vista come incli nata in basso. La distinzione “su”/ “giu” è del tutto arbitraria, anche se talvolta è implicitamente accolta sperimentalmente (per esempio, Poffenberger e Barrows, 1924). Supponendo che le linee si “leggano” da sinistra a destra, la distinzione le rende in potenza l’oggettivazione di ogni relazione sociale gerarchica che sia anch’essa concepita in termini di “su” e “giu”, “supe riore” e “inferiore”.21 La seconda dimensione della linea, la for ma, si riferisce alle sue qualificazioni di linea diritta o curva, con la forma intermedia spezzata o zig zag. Il ritmo è la perio dicità della curva o dell’angolo: una serie indefinita di movi mento o velocità che viene solitamente indicata con termini che vanno dal “lento” o “ondulato” all’“oscillante rapidamente” ma che può avere anche una significativa variazione in ampiezza. Con l’aiuto della migliore psicologia e con qualche osservazio ne estetica sul significato della linea, è possibile far emergere le valutazioni culturali da determinate opposizioni di linea. La psi cologia sperimentale può fare solo da stimolo: destinata specifi camente a scoprire il valore espressivo o emotivo della linea, la procedura dell’analisi psicologica saggia il rapporto con il sog getto individuale più che quello tra le rappresentazioni oggettive e sociali in quanto tali. Ciò nonostante le risposte emotive impli cano almeno indirettamente un’interpretazione culturale. Per un’ulteriore riflessione aggiungo quindi il vecchio esempio dell’esperimento sul “valore-sensazione della linea”, lo studio ci tato di Poffenberger e Barrows, che riporta in percentuale le rea211
’f i
15
g
4;
fi
'f i CD
j j
£
15
fi fi