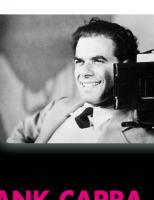U.S.A. La trilogia: Il 42° parallelo - Millenovecentodiciannove - Un mucchio di quattrini 9788852098703
Un'opera unica, una vera enciclopedia del continente americano, capace di misurarsi con il respiro epico di una naz
539 361 6MB
Italian Pages 1435 Year 2019
Polecaj historie
Table of contents :
Indice......Page 1433
Frontespizio......Page 5
Il libro......Page 3
L’autore......Page 4
Introduzione. U.S.A., ieri e oggi. Cronaca modernista del fallimento di una “democrazia da favola” di Cinzia Scarpino......Page 6
Nota alla traduzione. Cesare Pavese lettore e traduttore di U.S.A. di Sara Sullam......Page 35
Nota dell’editore......Page 54
U.S.A.......Page 57
Prologo U.S.A.......Page 58
IL 42° PARALLELO. Traduzione di Cesare Pavese......Page 61
Cine-giornale I: «Eran quelli i patrioti»......Page 62
Occhio fotografico (1): quando si cammina per la via......Page 65
MAC......Page 66
Occhio fotografico (2): filiamo rollando come in una barca......Page 72
MAC......Page 73
Cine-giornale II: «Venite a sentire»......Page 81
Occhio fotografico (3): Ô qu’il a de beaux yeux......Page 83
AMANTE DELL’UMANITÀ......Page 84
Occhio fotografico (4): si torna indietro nella pioggia......Page 87
MAC......Page 88
Cine-giornale III: «Ci vuol del fegato per vivere in questo mondo»......Page 110
Occhio fotografico (5): e giocavamo alla battaglia di Port Arthur......Page 111
Cine-giornale IV: «Ho trovato il mio amore sull’Alamo»......Page 112
Occhio fotografico (6): Dàgli Madison dàgli Madison......Page 114
Cine-giornale V: Le cimici scacciano un biologo......Page 115
MAC......Page 116
Cine-giornale VI: Parigi finalmente scandalizzata......Page 136
Occhio fotografico (7): andavamo a pattinare sullo stagno......Page 137
IL MAGO DELLE PIANTE......Page 138
Cine-giornale VII: Asserisce che questo sarà il secolo dei miliardi......Page 140
Occhio fotografico (8): uno sedeva sul letto slacciandosi le scarpe......Page 141
MAC......Page 142
Occhio fotografico (9): tutto il giorno le fabbriche di concime puzzavano......Page 148
BIG BILL......Page 149
Occhio fotografico (10): il vecchio maggiore mi portava di solito al Campidoglio......Page 152
MAC......Page 153
Cine-giornale VIII: Il prof. Ferrer, già direttore della Escuela Moderna di Barcellona......Page 162
Occhio fotografico (11): i Pennypacker andavano alla chiesa presbiteriana......Page 163
Cine-giornale IX: Stelle compromesse bevendo......Page 165
MAC......Page 166
Occhio fotografico (12): quando tutti se n’andavano in viaggio......Page 183
Cine-giornale X: Il brevetto di Moon è tutto fumo......Page 184
Occhio fotografico (13): lui era capitano di rimorchiatore......Page 186
JANEY......Page 188
Occhio fotografico (14): il signor Garfield aveva una bellissima voce......Page 201
Cine-giornale XI: il governo degli Stati Uniti deve insistere......Page 202
JANEY......Page 204
Occhio fotografico (15): Alla foce dello Schuylkill salì a bordo il signor Pierce......Page 219
Cine-giornale XII: Greci combattenti che fuggono davanti ai poliziotti......Page 220
IL RAGAZZO ORATORE DEL PLATTE......Page 222
Occhio fotografico (16): faceva caldo come in un forno......Page 225
J. WARD MOOREHOUSE......Page 226
Occhio fotografico (17): la primavera che si poteva vedere la cometa di Halley......Page 257
Cine-giornale XIII: Ero in faccia alla piazza nazionale......Page 258
ELEANOR STODDARD......Page 259
Occhio fotografico (18): era una signora molto alla moda......Page 272
ELEANOR STODDARD......Page 273
Occhio fotografico (19): la moglie del pastore metodista era una donna alta sottile......Page 285
Cine-giornale XIV: Un artigliere ferma un australiano......Page 286
IMPERATORE DEI CARAIBI......Page 288
Occhio fotografico (20): quando i tranvieri fecero sciopero......Page 291
J. WARD MOOREHOUSE......Page 292
Occhio fotografico (21): quell’agosto non venne una goccia d’acqua......Page 305
Cine-giornale XV: si spengono le luci......Page 307
PRINCIPE DELLA PACE......Page 309
Occhio fotografico (22): tutta la settimana la nebbia non si staccò dal mare......Page 310
J. WARD MOOREHOUSE......Page 311
Occhio fotografico (23): l’amica di mammà era una donnina tanto carina......Page 318
Cine-giornale XVI: il filadelfiano aveva compiuto il tredicesimo giro......Page 319
ELEANOR STODDARD......Page 320
Occhio fotografico (24): pioveva nella storica Quebec......Page 326
JANEY......Page 328
IL MAGO DELL’ELETTRICITÀ......Page 338
Occhio fotografico (25): quelle notti di primavera le ruote dei tram stridono......Page 342
Cine-giornale XVII: un attacco di uno stormo di aeronavi nemiche......Page 344
MAC......Page 345
PROTEO......Page 364
JANEY......Page 367
Occhio fotografico (26): il giardino era zeppo......Page 385
Cine-giornale XVIII: «Ciao Piccadilly, addio Leicester Square»......Page 386
ELEANOR STODDARD......Page 388
Cine-giornale XIX: Gli Stati Uniti in guerra......Page 397
Occhio fotografico (27): c’erano preti e monache sull’Espagne......Page 398
BOB IL COMBATTENTE......Page 400
CHARLEY ANDERSON......Page 403
MILLENOVECENTODICIANNOVE. Traduzione di Glauco Cambon......Page 444
Cine-giornale XX: «Oh la fanteria la fanteria»......Page 445
JOE WILLIAMS......Page 447
Occhio fotografico (28): quando arrivò il telegramma......Page 452
GIOCHERELLONE......Page 454
JOE WILLIAMS......Page 459
Cine-giornale XXI: «Addio Broadway»......Page 508
Occhio fotografico (29): le gocce di pioggia cadono a una a una......Page 510
RICHARD ELLSWORTH SAVAGE......Page 511
Cine-giornale XXII: L’anno venturo promette una rinascita......Page 537
Occhio fotografico (30): ricordando le grigie dita rattrappite......Page 539
RANDOLPH BOURNE......Page 541
Cine-giornale XXIII: «Se non ti va il buon Zio Sam»......Page 544
EVELINE HUTCHINS......Page 545
Occhio fotografico (31): un materasso coperto di roba di Vantine......Page 564
EVELINE HUTCHINS......Page 566
Cine-giornale XXIV: non si può immaginare l’entità colossale dei prestiti......Page 576
Occhio fotografico (32): à quatorze heures précisément......Page 578
IL LIETO GUERRIERO......Page 579
Occhio fotografico (33): 11.000 prostitute di mestiere......Page 585
JOE WILLIAMS......Page 588
Occhio fotografico (34): la sua voce era mille miglia lontana......Page 609
Cine-giornale XXV: le forze del generale Pershing hanno occupato oggi la fattoria......Page 611
UN DON CHISCIOTTE DELL’INDIANA......Page 613
Cine-giornale XXVI: L’Europa sul filo del rasoio......Page 619
RICHARD ELLSWORTH SAVAGE......Page 621
Cine-giornale XXVII: Intenta causa al marito e lo smaschera......Page 647
Occhio fotografico (35): c’erano sempre due gatti color latte caldo......Page 649
EVELINE HUTCHINS......Page 650
Cine-giornale XXVIII: «Oh le aquile che volano alte»......Page 662
JOE WILLIAMS......Page 664
Cine-giornale XXIX: l’arrivo della notizia provocò l’ingombro delle linee telefoniche......Page 672
Occhio fotografico (36): quando vuotavamo le gamelle sottovento......Page 674
“MISTER VILSON”......Page 675
Cine-giornale XXX: I cannoni giganti eliminati?......Page 683
Occhio fotografico (37): in ordine alfabetico e di grado......Page 685
Cine-giornale XXXI: lavatisi e vestitisi in fretta scesero a pianterreno......Page 688
FIGLIA......Page 689
Cine-giornale XXXII: La voce d’oro di Caruso aleggia sulle folle cittadine......Page 718
Occhio fotografico (38): timbrato firmato e consegnato......Page 720
Cine-giornale XXXIII: Sostiene di non ricordarsi d’aver ucciso la sorella......Page 721
EVELINE HUTCHINS......Page 723
Cine-giornale XXXIV: Il mondo intero a corto di platino......Page 763
LA DINASTIA MORGAN......Page 765
Cine-giornale XXXV: il Grand Prix de la Victoire......Page 770
Occhio fotografico (39): il giorno sgorga da una quiete rossastra......Page 772
Cine-giornale XXXVI: A gloria della Francia eterna......Page 774
RICHARD ELLSWORTH SAVAGE......Page 776
Cine-giornale XXXVII: Le guardie rosse arretrano......Page 825
Occhio fotografico (40): percorsi tutta la città a piedi......Page 828
Cine-giornale XXXVIII: «C’est la lutte finale»......Page 830
FIGLIA......Page 832
Cine-giornale XXXIX: lo spettacolo dei villaggi ridotti in macerie......Page 845
Occhio fotografico (41): non venite al picnic anarchico?......Page 847
Cine-giornale XL: Un detenuto in pigiama sega le sbarre......Page 848
JOE HILL......Page 849
BEN COMPTON......Page 851
Cine-giornale XLI: negli ambienti del Colonial Office britannico......Page 878
Occhio fotografico (42): per quattro ore noi militari di passaggio ammucchiamo rottami......Page 880
Cine-giornale XLII: per Seattle fu un giorno di gala......Page 881
PAUL BUNYAN......Page 882
RICHARD ELLSWORTH SAVAGE......Page 887
Cine-giornale XLIII: ai radicali furono strappati i cartelli......Page 892
LE SPOGLIE MORTALI DI UN AMERICANO......Page 894
UN MUCCHIO DI QUATTRINI. Traduzione di Cesare Pavese......Page 900
CHARLEY ANDERSON......Page 901
Cine-giornale XLIV: «Yankee Doodle la canzone»......Page 908
CHARLEY ANDERSON......Page 909
Cine-giornale XLV: «Senza cipria e la parrucca»......Page 915
IL PIANO AMERICANO......Page 916
Cine-giornale XLVI: questi sono gli individui......Page 921
Occhio fotografico (43): un nodo alla gola quando il piroscafo......Page 922
Cine-giornale XLVII: giovane che cerca una posizione offriamo......Page 924
Occhio fotografico (44): l’innominato viaggiatore......Page 926
CHARLEY ANDERSON......Page 928
Cine-giornale XLVIII: davvero la Steel Corporation si aderge......Page 941
MACININO......Page 942
Cine-giornale XLIX: «Fante di quadri fante di quadri»......Page 951
CHARLEY ANDERSON......Page 952
Cine-giornale L: «No la colpa non è della mia Broadway»......Page 982
L’AMARO CALICE......Page 984
Cine-giornale LI: «La mia casa è senza sole»......Page 995
MARY FRENCH......Page 996
Occhio fotografico (45): la stretta camera gialla pullula di chiacchierio......Page 1013
MARY FRENCH......Page 1015
Occhio fotografico (46): cammina e cammina per le vie......Page 1036
Cine-giornale LII: riuniti al servizio divino per i cari defunti......Page 1038
L’ARTE E ISADORA......Page 1039
Cine-giornale LIII: «Addio bel merlo»......Page 1046
MARGO DOWLING......Page 1048
Cine-giornale LIV: non ci fu nulla di significativo......Page 1070
TANGO LENTO......Page 1072
Cine-giornale LV: Folla nelle vie......Page 1077
Occhio fotografico (47): sirene scoppiarono nella nebbia sul porto......Page 1078
CHARLEY ANDERSON......Page 1080
Cine-giornale LVI: il suo primo passo fu di salire su un treno rapido......Page 1116
Occhio fotografico (48): alla volta dell’Occidente......Page 1118
MARGO DOWLING......Page 1122
Cine-giornale LVII: il medium si spogliò di ogni indumento......Page 1134
MARGO DOWLING......Page 1136
Cine-giornale LVIII: «Dolce terra che ci afferra»......Page 1155
I CAMPEGGIATORI DI KITTY HAWK......Page 1157
Cine-giornale LIX: lo straniero che viene la prima volta a Detroit......Page 1163
CHARLEY ANDERSON......Page 1165
Cine-giornale LX: Era di Céline la colpa?......Page 1200
MARGO DOWLING......Page 1202
Cine-giornale LXI: «In alto in alto»......Page 1215
CHARLEY ANDERSON......Page 1217
Cine-giornale LXII: Le stelle presagiscono disgrazie per Coolidge......Page 1250
MARGO DOWLING......Page 1252
Cine-giornale LXIII: ma qualche minuto dopo......Page 1295
ARCHITETTO......Page 1297
Cine-giornale LXIV: La cattura di un pesce misterioso......Page 1302
Occhio fotografico (49): camminando da Plymouth a North Plymouth......Page 1304
Cine-giornale LXV: Un temporale ostruisce la sotterranea......Page 1306
MARY FRENCH......Page 1308
Cine-giornale LXVI: Holmes nega la proroga......Page 1328
Occhio fotografico (50): ci hanno cacciati a bastonate dalle vie......Page 1329
Cine-giornale LXVII: quando le cose si capovolgono......Page 1331
POVERO BAMBINO MILIONARIO......Page 1333
RICHARD ELLSWORTH SAVAGE......Page 1343
Cine-giornale LXVIII: Stupore a Wall Street......Page 1382
Occhio fotografico (51): in fondo alla valle nell’ombra delle colline......Page 1385
ENERGIA SUPERENERGIA......Page 1387
MARY FRENCH......Page 1395
VAGABONDO......Page 1419
Meccano U.S.A.......Page 1422
Inserto fotografico......Page 1427
Citation preview
Il libro La trilogia U.S.A. (Il 42° parallelo, Millenovecentodiciannove e Un mucchio di quattrini) racconta i primi trent’anni del XX secolo americano e rappresenta la più importante e longeva matrice del “grande romanzo americano”. John Dos Passos coniuga l’estro formale e avanguardistico degli anni Venti con lo scavo storico, culturale e linguistico nelle radici nazionali della Grande Depressione; mette a nudo i costi inflitti al tessuto sociale e psicologico del paese da una modernizzazione senza uguali; e traccia la parabola del fallimento di una democrazia che ha tradito i propri ideali di uguaglianza, libertà, giustizia, opportunità, sacrificandoli al “mucchio di quattrini”. Alla geografia del paese da costa a costa, allo scandaglio della società in tutti i suoi strati si intreccia la ricostruzione storica che, affiancando cronache minute e quotidiane dei personaggi di fantasia a eventi ufficiali delle biografie di personaggi emblematici, tratteggia i grandi fenomeni politici e di pensiero del trentennio. Per comporre un tableau così complesso, Dos Passos sperimenta diverse modalità narrative: le vicende di dodici personaggi inventati; le brevi biografie di ventisette americani famosi; cine-giornali che interrompono le narrazioni con slogan pubblicitari, testi di canzoni popolari e titoli dei giornali; e vertiginosi squarci di riprese fotografiche o cinematografiche, passaggi joyciani in cui l’autore registra la propria vita sensoriale, vere e proprie incursioni nella soggettività. Il risultato è un’opera unica, una vera enciclopedia del continente americano, capace di misurarsi con il respiro epico di una nazione-mondo e con i suoi miti fondativi.
L’autore John Dos Passos Chicago 1896 - Baltimora 1970. Fu scrittore assai prolifico di romanzi, poesie, saggi, drammi, e anche reporter e pittore. Oltre alla “trilogia americana” (1938), ricordiamo Manhattan Transfer (1925) e la trilogia District of Columbia (1939-49). Lo sperimentalismo di U.S.A. ha ispirato sia il new journalism americano (Truman Capote, Norman Mailer, Joan Didion) sia l’epica di Underworld di Don DeLillo.
John Dos Passos
U.S.A. La trilogia IL 42° PARALLELO MILLENOVECENTODICIANNOVE UN MUCCHIO DI QUATTRINI A cura di Cinzia Scarpino e Sara Sullam Traduzioni di Cesare Pavese e Glauco Cambon
Introduzione
U.S.A., ieri e oggi. Cronaca modernista del fallimento di una “democrazia da favola” di Cinzia Scarpino Secondo una nota affermazione di Gertrude Stein contenuta nella Autobiografia di Alice Toklas (1933), l’America sarebbe «attualmente il più antico paese del mondo, giacché … fu l’America a creare il secolo Ventesimo». 1 Se così fosse, la trilogia U.S.A. (1938) di John Dos Passos, composta da tre volumi pubblicati tra il 1930 e il 1936, andrebbe considerata come l’opera narrativa più antica della modernità occidentale, nonché la matrice novecentesca più importante e longeva del “grande romanzo americano” contemporaneo. Ripercorrendo i primi tre decenni del secolo scorso, Il 42° parallelo, Millenovecentodiciannove e Un mucchio di quattrini (traduzione pavesiana del titolo The Big Money) mettono a nudo i costi inflitti da una modernizzazione senza uguali, per rapidità e scala, sul tessuto sociale del paese e la psicologia degli americani. U.S.A. traccia il fallimento inesorabile di una democrazia fondata su principi così alti da diventare impraticabili – una “democrazia da favola” («our storybook democracy», come recita il Camera Eye 46) – che ha tradito, sacrificandoli al “Big Money”, i propri ideali di uguaglianza, libertà, giustizia e opportunità. Lo spaccato restituito da Dos Passos è un enorme e brulicante campo di residui materiali e metaforici del capitale e della nascente industria culturale di massa. Dalle trincee della Prima guerra mondiale alla strada su cui si muovono, risospinti dalla necessità economica e dall’inquietudine sociale e attraversati dalle parole della modernità, i tre personaggi “anonimi” collocati all’inizio, al centro e alla fine della trilogia – «Il giovane uomo», Le spoglie mortali di un americano (The Body of an American) e Vagabondo (Vag) –, U.S.A. accumula e contiene i segni, i luoghi e le parole dell’ascesa vertiginosa della nazione a potenza mondiale. Stiamo
parlando, storicamente, del ventennio che da un lato istituzionalizza politiche sociali fortemente conservatrici (il proibizionismo, l’antisindacalismo, il blocco dei flussi immigrati) e dall’altro prepara il terreno alla più grande crisi economica del paese (avviata dal crollo del 1929). Non è un caso che U.S.A. si apra con una canzone patriottica che recita «It was that emancipated race/That was chargin’ up the hill» 2 – riecheggiando l’eccezionalismo egemonico americano (la «città sulla collina») – e si concluda, dopo oltre novecento pagine, sul «giovane uomo» diventato Vagabondo («la testa che gira, la fame gli morde nel ventre, le mani in ozio intorpidiscono») ormai rotto alla disillusione di un sogno rovesciato: «i libri dicevano occasione, gli annunzi promettevano pronta carriera, siate il padrone in casa vostra, spendete più del vostro vicino, la voce della radio sussurrava belle bambine, fantasmi di bambine biondoplatino lusingavano dallo schermo, milioni di guadagni erano scritti a gesso sulle lavagne degli uffici, la busta paga pronta per le mani volenterose» (Vagabondo, Un mucchio di quattrini). U.S.A. si innesta su una tradizione narrativa – quella del romanzo americano a grandi volute, si pensi all’epico Moby Dick (1851) di Herman Melville – che non indietreggia di fronte alle contraddizioni economiche, sociali e culturali di un passato recente e un presente in magmatico divenire e decostruisce, pezzo per pezzo, i miti fondativi della retorica nazionale. Quando, sul finire di Un mucchio di quattrini, tutte e quattro le modalità narrative della trilogia (ci torneremo) convergono sull’esecuzione di Sacco e Vanzetti nel 1927 come momento esemplare della sconfitta della democrazia americana, la grande narrative anglocentrica dei padri puritani (arrivati sul Mayflower a Plymouth Rock, Massachusetts, lo stesso luogo in cui approdano gli attivisti impegnati nella difesa dei due anarchici italiani, nuovi “santi visibili” della sinistra) è riscritta a partire da un comune “odio dell’oppressione” su cui si fonda un’etnogenesi nazionale allargata ad abbracciare tutte le ondate migratorie successive. Se la vicenda di Sacco e Vanzetti, così come la violenta repressione dello sciopero dei minatori di Harlan County (1931), chiudono la trilogia nel segno della maturata consapevolezza che
esistono, dickensianamente, due nazioni separate – i ricchi e i poveri, i potenti e gli spossessati, i topdogs e gli underdogs –, l’intellettuale e scrittore Dos Passos si schiera dalla parte degli sconfitti, «noi l’America dei vinti» (Occhio fotografico 50). Una perdita condivisa, quindi, ma anche un’esortazione a non rassegnarsi alimentata dalla speranza, residuale e sovversiva, che solo chi è stato sopraffatto dai “traditori” delle “antiche parole” della democrazia possa rinnovarle: «ricostruire le distrutte parole fatte viscose in bocca agli avvocati ai pubblici ministeri ai presidenti dei collegi ai giudici» (Occhio fotografico 49). La lingua, le parole, la voce della gente, e di un popolo. «Ma soprattutto U.S.A. è la voce del popolo» («But mostly U.S.A. is the speech of the people») recita notoriamente il Prologo di un’opera intenta a registrare una lingua, l’americano, grande e proteiforme quanto la geografia di un continente e la molteplicità sociale di una nazione che ha inventato la modernità e i suoi linguaggi (la stampa, la radio, il cinema). È la lingua di attivisti e agitatori sindacali, executives pubblicitari, marinai, aviatori, stenografe, decoratrici di interni, star e starlet del cinema, operai, vagabondi, prostituti, capitani di industria, assistenti sociali, ereditiere, meccanici, architetti, banchieri, è la lingua capace di catturare in modalità panoramica «la più grande valle» del mondo, è una lingua che fonde negli accostamenti paratattici di cataloghi aperti e virtualmente infiniti “Il canto della strada aperta” di Walt Whitman – su cui dovremo tornare – e il gergo allitterante degli annunci pubblicitari. Ed è anche, quale veicolo della modernità, la lingua dell’alienazione e dello straniamento. Ma è poi nella tenacia con cui «la lingua della nazione sconfitta non ci tace alle orecchie stanotte» (Occhio fotografico 50) che lo scrittore americano, di oggi e di ieri, può contribuire al gesto di rinascita di quella democrazia, perché «Solo le orecchie protese in ascolto non sono sole» (Prologo). «Chiamatemi Ismaele» («Call me Ishmael», Moby Dick), «Parla la tua lingua, l’americano» («He speaks in your voice, American», Underworld, Don DeLillo): gli incipit di alcuni dei più grandi romanzi americani dell’Ottocento e del Novecento, lo spiega benissimo Alessandro Portelli, 3 sono tutti attraversati dalla voce, dalla lingua,
dal parlato, e da una certa tensione etica a raccontare le storie dei marginali, dei poveri, degli sconfitti e a farlo con le loro stesse parole. Per molti versi, U.S.A. di Dos Passos funziona da cerniera tra i secoli, un monumento di narrativa modernista che, pur radicato nella tradizione passata, lascerà un’impronta indelebile nella letteratura a venire. Per incastri compositivi, varietà dei registri stilistici, intertestualità onnivora, uso consumato del collage, stratificazione delle trame, proliferazione acentrica del sistema dei personaggi, commistione metanarrativa di fatti e finzione, scavo mimetico nella, della e sulla lingua americana, U.S.A. è infatti il riferimento irrinunciabile di alcuni tra i filoni narrativi più significativi del secondo Novecento. L’eredità, spesso non dichiarata, della trilogia U.S.A. va cercata in una serie di romanzi impegnati a rappresentare un quadro espanso della società americana e di alcune soglie di attraversamento della storia del paese. Da A sangue freddo (1966) di Truman Capote a Le armate della notte (1968) di Norman Mailer, 4 al romanzo che più di tutti sembra iscritto nel solco di U.S.A. ovvero Underworld (1997) di Don DeLillo (per arrivare, forse, al recentissimo Pulitzer di Richard Powers Overstory, 2018, Il sussurro del mondo). Anche a livello più stilistico, affiliazioni letterarie future meno scontate lambiscono autori e generi assai diversi che vanno dalla sperimentazione ossessiva dei cut-up di William Burroughs (chiaro richiamo gli intarsi a collage di una congerie di materiali letterari ed extraletterari disseminati in U.S.A.) ai ritratti, lapidari, precisi e impietosi, di personaggi celebri della non-fiction di Joan Didion (un sottogenere che sembra modellato sulle straordinarie “biografie” della trilogia), fino al cluster di narratives, personaggi e di storie tenuti insieme nel romanzo-non-romanzo di Jennifer Egan A Visit from the Goon Squad (2010, Il tempo è un bastardo). Una trilogia proiettata nel futuro, quindi. Ma anche una trilogia che scompagina e, al contempo, reimpagina l’unicità del frangente storico, politico, culturale e letterario in cui nasce.
«U.S.A.», gli anni Trenta, la «taylorizzazione del romanzo» Per cogliere la portata della comparsa di U.S.A. sul panorama
letterario americano degli anni Trenta può essere utile partire da due esempi, opposti, di ricezione dei tre romanzi. Da un lato, una lettrice intellettuale e middle-class che ricorda, a circa cinquant’anni dall’uscita del 42° parallelo, come la trilogia segnò uno spartiacque per gli scrittori coevi: «Mi innamorai perdutamente di quel libro [Il 42° parallelo], andai in biblioteca alla ricerca di tutto ciò che Dos Passos aveva pubblicato prima … Come un fiore di carta giapponese lasciato cadere in un bicchiere di acqua, tutto si schiuse, dispiegandosi magicamente, da Dos Passos». 5 Dall’altro, un lettore working-class che dichiarava, in un’intervista del 1934, il senso di frustrazione di fronte alla complessità esibita di Millenovecentodiciannove: «E a proposito di Dos Passos: perché mai scrive così strano? Ho letto Millenovecentodiciannove, di cui farneticavano tutti appena uscì e, accidenti, è stato come mettere insieme un puzzle dall’inizio alla fine. Alcune cose erano interessanti e vere, non dico di no; ma perché metterci una settimana o due a scervellarmi su un libro?». 6 Mentre l’identità del secondo lettore è anonima, così come quella delle centinaia di lavoratori intervistati da Louis Adamic nel 1934 circa le letture del “proletariato” statunitense, la prima testimonianza è firmata da Mary McCarthy, scrittrice e intellettuale americana di spicco il cui esordio – The Company She Keeps (1942, Gli uomini della sua vita) – mette in scena, in maniera largamente autobiografica, i circoli letterari impegnati “on the Left” della New York degli anni Venti e Trenta. Il modernismo sperimentale e polifonico dei romanzi collettivi di John Dos Passos conquista così la giovane Mary McCarthy (che, per inciso, sposerà il critico letterario più influente dell’epoca, Edmund Wilson, dopo aver lasciato il famoso intellettuale marxista Philip Rahv) e attanaglia il lettore working-class, disorientato e spazientito di fronte alla fatica di una lettura che lo inchioda per settimane. È questo, in fondo, il dilemma che mina il genere del romanzo proletario degli anni Trenta, un genere nato sul finire del decennio precedente sulla spinta “impegnata” di scrittori sensibili tanto alle avanguardie marxiste allineate al Partito comunista americano (CPUSA) quanto, confluendo nelle maglie più larghe del romanzo sociale di protesta, alle istanze più latamente riformiste destinate ad alimentare il “fronte
culturale” del New Deal rooseveltiano. 7 Esaltato dai critici marxisti come l’unico genere in grado di cogliere l’esperienza dei lavoratori americani spezzati dalla crisi economica che stringe il paese in una morsa devastante dal 1929 al 1942, il romanzo proletario si porta dietro non poche ipoteche: la difficoltà di piegare una forma nata per rappresentare la coscienza dell’individuo borghese a una causa rivoluzionaria e collettiva e la necessità di ridefinire l’anima assai più molteplice delle masse dei lavoratori americani (operai, minatori e portuali certo, ma anche braccianti stagionali sfruttati dall’agribusiness) rispetto a quelle europee. Non deve sorprendere, quindi, che sotto la dicitura “proletarian novel” rientrino almeno tre diversi sottogeneri – il romanzo di sciopero e conversione, il romanzo del ghetto, il romanzo dei bottom-dogs (a cui molto deve il Vagabondo di U.S.A.) – e che questi tre sottogeneri vadano spesso a informare, negli anni Trenta, i cosiddetti “romanzi collettivi” (socialmente impegnati e stilisticamente innovativi) di cui la trilogia di Dos Passos è considerata l’esempio più riuscito. Quando nel 1935 Granville Hicks cura l’antologia Proletarian Literature in the U.S. il corpus dei romanzi pubblicati tra il 1929 e la metà degli anni Trenta è assai nutrito e connotato dalla varietà dei quattro sottogeneri e dalla diversa provenienza sociale di autori e autrici: da Daughter of Earth di Agnes Smedley a Bottom-Dogs di Edward Dahlberg nel 1929, a Ebrei senza denaro di Michael Gold a Strike! di Mary Heaton Vorse nel 1930, da To Make my Bread di Grace Lumpkin nel 1932 a The Disinherited di Conroy (1933) e ai primi volumi delle trilogie di Studs Lonigan di James T. Farrell (1932-35) e di Josephine Herbst (1932-39), da Chiamalo sonno di Henry Roth a Summer in Williamsburgh di Daniel Fuchs (1934), da The Shadow Before di Rollins a The Unpossessed di Tess Slesinger (1934), fino a Somebody in Boots di Nelson Algren, Waiting for Nothing di Tom Kromer e Marching! Marching! di Klara Weatherwax (1935). Se pochissimi di questi libri faranno breccia nelle letture dei lavoratori – attratti per lo più dalla letteratura di genere (soprattutto western e detective stories/noir) fruibile a prezzi popolari sui pulp magazines –, un numero ancora più esiguo di questi titoli riuscirà a sopravvivere all’oblio dei decenni successivi, salvo conoscere una parziale rinascita
a partire dagli anni Novanta del Novecento. In questo quadro, la vera cifra formale di U.S.A., ciò che colloca l’opera di Dos Passos idealmente all’inizio e alla fine della stagione del romanzo proletario, costituendone a un tempo l’espressione più promettente e il punto di non ritorno, è la sua capacità di inglobare non solo, vedremo, lo sperimentalismo formale delle avanguardie europee ma quasi tutti i filoni narrativi della produzione narrativa degli anni Venti e Trenta: il romanzo di guerra, il romanzo degli espatriati, il romanzo di protesta, il romanzo di Hollywood, il romanzo storico, il best-seller rosa, il libro fotodocumentario. I tre libri che compongono U.S.A. possono quindi essere letti come romanzi collettivi esemplari – acentrici e complessi, interessati a ritrarre i destini non di un individuo ma di più gruppi sociali – o come reincarnazione dell’epico gesto whitmaniano capace di contenere moltitudini. Ma più di tutto, U.S.A. presenta al lettore una varietà di matrici discorsive e formali radicate nei molti modernismi americani. Basta dare una scorsa al sommario dei tre volumi di U.S.A. per coglierne la struttura modulare, il disegno narrativo quadripartito, «un nastro trasportatore a quattro canali» dirà lo stesso Dos Passos, in cui sono convogliati una dozzina di personaggi ricorrenti (in apertura di ogni sessione e in maiuscolo); sessantotto titoli di Cine-giornale (Newsreel) a puntellare, a mo’ di flash news e slogan pubblicitari, gli sviluppi cronologici delle altre tre modalità; cinquantuno Occhi fotografici (Camera Eye) di cui si riportano gli incipit (il primo recita «quando si cammina per la via bisogna sempre posare i piedi con attenzione»); le brevi biografie di ventisette americani famosi a cui si allude attraverso titoletti dal significato ironico e irriverente (il primo, dedicato al sindacalista e attivista politico Eugene Debs, è Amante dell’umanità); vedi Meccano. 8 Due di queste modalità – Occhio fotografico e Cine-giornale – operano una ricodificazione di alcuni discorsi della modernità e di alcuni tratti stilistici modernisti, mentre le parti narrative relative ai dodici personaggi ricorrenti si iscrivono nel genere del romanzo collettivo degli anni Trenta, portando agli estremi l’inclusione mimetica di un certo realismo europeo ottocentesco e, ancor di più, del naturalismo americano di Theodore
Dreiser. Diverso è il caso dei profili celebri, una geniale “anomalia” che, se in parte riecheggia lo stile dello sketch graffiante alla Mark Twain e in parte si rifà ai ritratti storici di In the American Grain (1925, Nelle vene dell’America) di William Carlos Williams, 9 non ha un vero precedente nella letteratura americana (ma ha, certo, diversi epigoni, basti pensare a quello che succederà una trentina d’anni più tardi con i “profiles” dei New Journalists su riviste quali il «New Yorker»). Da un lato quindi lo scorrere orizzontale delle trame incrociate dei personaggi inventati e delle figure storiche, dall’altro gli squarci verticali che scaturiscono da una coscienza individuale, quella dell’autore (Occhio fotografico), e dai frammenti meccanici del discorso pubblico (Cine-giornale). Non è un caso che i manoscritti relativi alla composizione dei tre romanzi mostrino come Dos Passos concepisca e scriva prima le due modalità “orizzontali”, in cui si distende il respiro narrativo della trilogia, e poi, a innesto, le altre due modalità. 10 Altrettanto indicativa del disegno dell’opera è la stesura separata di ciascuna delle quattro matrici che, solo una volta completate singolarmente, vengono poi assemblate nella struttura finale: un correlativo della “catena di montaggio” ispirato, scrive Michael Denning, a una «taylorizzazione del romanzo». 11 Una struttura compositiva ripresa nel celebre Citizen Kane (1941, Quarto potere) di Orson Welles, puzzle filmico di flashback, cinegiornali e frammenti di coscienza a evocare la vita di un grande magnate della stampa (Randolph Hearst). Spuria e stratificata la matrice di U.S.A. sembra inoltre anticipare alcuni sviluppi artistici visceralmente americani quali la tecnica del transfer-drawing di Robert Rauschenberg e le “bandiere” di Jasper Johns. 12 Ed è forse proprio Map di Jasper Johns, che ritrae una cartina degli Stati Uniti intesa per essere «vista ma non guardata, non esaminata», a fornire il corrispettivo visuale del montaggio cubista, a un tempo concreto e astratto, di U.S.A. Le diverse parti formano il tutto, ma è il tutto, lo sguardo che contiene, il gesto che include e ricompone, a stagliarsi sull’orizzonte del lettore. 13
Le parti narrative Se lette in continuità le parti narrative della trilogia raggiungono,
come hanno scritto i maggiori critici della letteratura degli anni Trenta, l’effetto di un romanzo collettivo della Grande Depressione (viene in mente la saga dei Trexler di Josephine Herbst). 14 Tuttavia, a colpire maggiormente il lettore di oggi è il modo in cui queste contengono, quasi a offrirne una magistrale campionatura, molti generi e sottogeneri americani dello stesso decennio (il romanzo proletario, il romanzo di guerra, il romanzo del ghetto, il romanzo dei bottom-dogs, il romanzo di Hollywood). Grazie alla tecnica che Donald Pizer definisce «interlacing» e che intreccia la ricomparsa di alcuni personaggi accanto ad altri (è il caso di Margo Dowling e Charley Anderson in Un mucchio di quattrini) e di più personaggi in uno stesso luogo (per esempio un ristorante di Parigi alla fine di Millenovecentodiciannove), nelle parti narrative trovano spazio le vicende di dodici personaggi centrali narrate in un indiretto libero mimetico e tipizzante, «regolare e implacabile come una catena di montaggio». 15 Niente viene concesso al lettore in termini di anticipazioni o sinossi, nemmeno quando un personaggio scompare dalla narrazione per centinaia di pagine, o, nel caso di Charley Anderson, per un intero volume. Se i personaggi principali sono dodici – Mac, Janey, Moorehouse, Eleanor Stoddard, Charley Anderson, Joe Williams, Richard Ellsworth (Dick) Savage, Eveline Hutchins, Figlia, Ben Compton, Mary French, Margo Dowling – attorno a tre di questi – Moorehouse, Anderson e, in misura minore, Dowling (vedi Meccano) – si addensano, per contiguità lavorativa e sociale e mai per genealogie familiari, le vicende di altri. Il sistema dei personaggi di U.S.A. è infatti assimilabile a una lista di personaggi accostati l’uno all’altro dal caso, l’esatto contrario, come osserva Michael Denning, delle genealogie agglutinate di Yoknapatawpha in Faulkner. 16 Il cluster più importante è quello che si sviluppa intorno a J. Ward Moorehouse nel 42° parallelo, datore di lavoro nonché protettore di Janey, Eleanor Stoddard, Dick Savage. Quella di Moorehouse è una storia alla Horatio Alger, firma della Gilded Age (anni Settanta dell’Ottocento) diventata celebre grazie a una serie di romanzi per ragazzi di impianto edificante che esalta la laboriosità e l’audacia di chi riesce a farsi da solo passando dagli “stracci” alla
“ricchezza”. Moorehouse si sposa due volte con le figlie del suo capo, assicurandosi una fulminante ascesa sociale al prezzo di matrimoni infelici e relazioni che si reggono solo sull’esercizio del proprio potere. La formidabile parabola di Moorehouse (vedi Meccano) – modellato sul pubblicista Ivy Lee (l’inventore delle pubbliche relazioni e rappresentante di Rockefeller) – lo vede transitare dal mercato immobiliare alle relazioni pubbliche per le multinazionali dell’acciaio e del petrolio e approdare infine al regno pubblicitario di Madison Avenue. Altrimenti assimilabili a rivisitazioni moderne e amare della “success story” americana sono le traiettorie degli altri due personaggi “aggreganti”. Charley Anderson compare per la prima volta sul finire del 42° parallelo, è un giovane meccanico del North Dakota che parte per l’Europa, scompare quasi del tutto nel corso di Millenovecentodiciannove (impegnato a diventare un asso dell’aviazione nella Prima guerra mondiale) e torna poi, veterano pluridecorato, in Un mucchio di quattrini, dove, diventato imprenditore di se stesso e della propria invenzione (un nuovo motore aereo), domina larghe parti della narrazione. L’eroe di guerra che si trasforma in uomo d’affari deve però sacrificare i propri valori migliori per scendere a patti con finanzieri scaltri – sposa anche lui la figlia di un banchiere – ed esponenti accaniti delle lobbies di Washington. Per vendere il proprio prodotto dovrà imparare a vendere se stesso al prezzo di una tragica bancarotta emotiva: l’alcolismo, un matrimonio infelice, un giro tanto nutrito quanto casuale di amanti. Tra queste ultime figura Margo Dowling che aggiunge alla parabola “from rags to riches” un’ulteriore ramificazione in chiave hollywoodiana. L’unico bene su cui Margo Dowling, nata povera ma bella, può far leva nella propria corsa al riscatto sociale è il sesso. Violentata dal patrigno quando è ancora una ragazzina, tenta di fuggire allo squallore familiare con un gay cubano poverissimo che la sposa e la reclude a l’Avana, dove mette al mondo un bambino nato cieco e morto poco dopo, torna a New York e si reinventa, bionda e callida, quale escort dalle velleità cinematografiche. Sullo sfondo, l’apprendistato fallimentare come “chorus girl” delle Ziegfield Follies, i necessari compromessi relazionali e sessuali per mantenersi – tra cui l’affair con Charley
Anderson, dal quale riceve assegni e azioni mentre sta scoppiando la nota bolla immobiliare della Florida (“Florida Land Bubble”) – e, colpo di coda finale, la rinascita con il lancio hollywoodiano, che la fa passare dai film muti ai “talkies”, grazie a un regista famoso. Margo cambia pelle, amanti, conti bancari, città e coste (New York, Cuba, la Florida, Hollywood) con una velocità tutta americana resa possibile materialmente da aerei, treni, auto (straordinario l’attraversamento transcontinentale – Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Arizona, San Bernardino, Los Angeles – che la porta a Hollywood; vedi Meccano) e telefoni. Emotivamente, quella stessa dinamicità si regge, per Margo e per quasi tutti i personaggi della trilogia, sulla rimozione continua degli effetti indesiderati di rapporti lavorativi e interpersonali frenetici, falsi, vacui: gravidanze non volute, malattie veneree, aborti, alcolismo. A scartabellare le oltre novecento pagine dei tre volumi si è colpiti dall’assenza di matrimoni e relazioni felici: la sfera degli affetti – là dove non è repressa tout court, come nel caso di Dick Savage e Eleanor Stoddard – è ridotta a continue transazioni sessuali ed economiche. Anche la linea narrativa dell’attivismo sindacale che vede protagonisti prima Mac e poi Ben Compton, Don Stevens e Mary French è disseminata di amori infelici perché governati dagli ideali (nel caso della prima generazione, quella di Mac) o, peggio, dai dogmi (nel caso della seconda generazione di Stevens e Compton) politici. Per Mac, che in questo non si discosta molto dalla protagonista di Daughter of Earth di Agnes Smedley, l’unica via alla felicità, dopo una vita da agitatore Wobbly su e giù per il paese, è l’esodo. Abbandonati la moglie e il figlio americani, Mac raggiunge il Messico, si fa conquistare dalla causa anarchica e mette su famiglia con una nativa. Anche Mary French – il personaggio forse più ispirato di Un mucchio di quattrini e per molti versi la coscienza “centrale” dell’ultima parte della trilogia (è attraverso i suoi occhi che assistiamo agli ultimi momenti della vicenda di Sacco e Vanzetti) – non conosce felicità. Sensibile, acuta, figlia di una madre borghese e di un medico dei lavoratori che anticipa alcuni best-seller americani degli anni Trenta (si pensi agli inglesi La cittadella, 1937, di A.J. Cronin e Com’era verde la mia vallata, 1939, di Richard Llewellyn), Mary studia
a Vassar College ma capisce che la sua vera formazione si darà altrove: nelle città minerarie e industriali (Pittsburgh) e come volontaria nella prima casa di assistenza sociale americana, Hull House, fondata nel 1920 da Jane Addams nel ghetto immigrato del West Side di Chicago. L’impegno militante di Mary French – modellata sulla già citata scrittrice e giornalista Mary Heaton Vorse (autrice di Strike!, 1930) – non è ideologico, nasce invece da un odio istintivo per l’oppressione e l’ingiustizia. Ma la sua effettiva capacità di aiutare la causa dei lavoratori è fatalmente compromessa dalle storie d’amore disastrose con diversi leader della sinistra radicale. Prima Gus, un attivista di Pittsburgh, poi George Barrow, uomo politico che sta a Washington e a cui Mary farà da segretaria, poi Ben Compton, accolto e accudito a New York, di cui resterà incinta salvo poi dover abortire ed essere abbandonata; in ultimo il settario Don Stevens. Mary è emotivamente nomade, irrequieta, senza casa. Se il passaggio tra una prima generazione di attivisti politici e una seconda riflette la maggiore consapevolezza politica dei secondi, comune è il loro fallimento ideologico e umano. Al di là delle singole vicende, tuttavia, presi nel loro insieme i dodici fili narrativi assumono ulteriore significato grazie alla “rete” in cui emergono, a quello che Antonio Bibbò chiama «l’aggregato sociale» del romanzo collettivo. 17 Sono infatti le relazioni e le dinamiche tra tipologie sociali a compendiare non solo il quadro di una democrazia fallita ma la possibilità stessa di articolare e quindi affrontare quella perdita di valori come individui. La rappresentazione delle relazioni che intercorrono tra questa dozzina di personaggi e almeno un altro centinaio di comparse non è altro che la resa narrativa della polverizzazione della coscienza individuale – “privata” e “politica” – schiacciata dalle logiche economiche e culturali del capitale americano tra la fine dell’Ottocento e i primi tre decenni del Novecento. In questo senso vanno forse letti alcuni limiti della parte narrativa della trilogia nel restituire uno spaccato molteplice anche nella resa della diversità (sociale, etnica, sessuale). Tra questi dodici personaggi mancano intere categorie sociali – non ci sono agricoltori e allevatori, non ci sono operai, non ci sono medici e
avvocati – e la presa geografica e culturale, per quanto incredibilmente espansa, interessa soprattutto il Midwest e l’Est, con incursioni suggestive ma sempre piuttosto aeree della Florida e una focalizzazione quasi “politica” dell’Ovest (vedi Meccano). Sono infatti i sindacalisti e gli attivisti a muoversi a e verso ovest, in una sovrapposizione geografico-politica insita nel “Go Left, Young Man” con cui Mike Gold, nel 1929, esorta i giovani radicals a un gesto di conquista del continente in cui risuona il celebre “Go West, Young Man, and grow with the Country” (“Vai a Ovest, giovane uomo, e cresci col paese”) di metà Ottocento attribuito a Horace Greeley. Non solo. Questi dodici personaggi riprodurrebbero, secondo alcuni critici, un’omogeneità identitaria poco rispettosa di una rappresentatività realmente inclusiva: l’“altro” etnico è sempre proiettato in una sfera negativa (si pensi alla parabola di Mac in Messico o a quella di Margo a Cuba); l’omosessualità è sempre connotata negativamente (si pensi alla vicenda di Dick Savage, personaggio di successo e infelice che reprime il proprio orientamento sessuale fino alla fine); 18 la donna, “altro” per eccellenza perché vittima simbolica e materiale di strutture patriarcali e misogine dure a morire tanto nelle nuove professioni della modernità quanto nelle gabbie marxiste del radicalismo americano, 19 è sempre venduta, comprata, barattata o violentata. Ma è forse proprio questo il significato dell’affresco di Dos Passos: di fronte all’appiattimento brutalizzante del capitale americano che ottunde la cognizione con i linguaggi drogati dei media, la possibilità stessa di riconoscere la diversità e l’alterità nella coscienza individuale non è data, perché la coscienza individuale stessa non esiste più, persa e perduta negli scambi vacui di quello che Michael Denning ha individuato come il vero cronotopo della trilogia, il cocktail party. 20
Le biografie celebri Le biografie celebri costituiscono per molti versi le parti più amate di U.S.A., certamente, insieme al Prologo e a un paio di Occhi fotografici, le più antologizzate. I fattori che contribuiscono alla leggibilità icastica di questi segmenti sono la riconoscibilità di profili famosi della storia americana e lo stile impressionistico in cui sono scritte. Ciascuna delle ventisette biografie è infatti evocata nel volgere
di un paio di pagine per mezzo di un tratto rapido tutto giocato sulla ripetizione con variazione di alcune frasi a effetto che portano a un climax o un anticlimax finale. Nel disegno complessivo della trilogia le biografie seguono a specchio – con un puntuale gioco di rimandi interni – le vicende delle parti narrative (vedi Meccano). Molte delle tipologie delle figure celebri riecheggiano infatti quelle dei dodici personaggi: ci sono magnati delle relazioni pubbliche e della stampa, ingegneri e meccanici geniali, artisti, attori e attrici, politici e attivisti sindacali. E ci sono – assimilabili ad altrettanti Moorehouse – i “falsificatori” delle parole della democrazia americana: gli statisti (Woodrow Wilson), i padroni della stampa (Randolph Hearst), i populisti (William Jennings Bryan), i magnati paternalisti (Andrew Carnegie), i banchieri e finanzieri (la dinastia dei Morgan). Lo sprezzo di Dos Passos per questi ultimi è palpabile quanto la simpatia per gli attivisti politici di inizio Novecento: Eugene Debs e Big Bill Haywood, fondatori entrambi, nel 1904, del sindacato degli Industrial Workers of the World, a cui aderisce anche Joe Hill, altro profilo positivo della trilogia (non a caso gli unici ritratti genuinamente favorevoli di U.S.A. sono contenuti nel primo volume, traduzione romanzesca di una visione politica meno disincantata dell’autore circa le sorti rivoluzionarie dei lavoratori americani). Esistono poi delle figure per così dire di mezzo, come Thomas Edison (Il mago dell’elettricità), positivo nella sua inventività laboriosa ma a cui manca una visione. È però in una triade di figure tragiche nella loro grandezza non ascoltata di Un mucchio di quattrini che Dos Passos sembra proiettare, a un tempo, la propria disillusione politica e le proprie speranze di far rivivere gli ideali democratici americani: Thorstein Veblen (L’amaro calice), Isadora Duncan, l’unica donna delle ventisette miniature (L’arte e Isadora), e Frank Lloyd Wright (Architetto). Veblen è un economista e sociologo del Minnesota di origini norvegesi di cui si ricorda oggi soprattutto La teoria della classe agiata (1899), opera in cui analizza il sistema capitalista americano come opposizione tra una classe agiata (oziosa e parassitaria) e una classe produttiva di ingegneri e tecnici che detiene la cultura tecnologica e nelle cui mani risiede, per l’autore, il futuro dell’economia e della nazione. Quella di Veblen è, per Dos
Passos, la vita tragica di un uomo che non si è mai sottratto all’analisi lucida e rigorosa dei cortocircuiti socioculturali statunitensi – ancora attuale, alla luce di alcune derive del “politicamente corretto”, la disamina spietata dell’ambiente accademico – e ha pagato la propria coerenza (la sua incapacità di pronunciare gli “essential yes”) con l’isolamento dallo stesso establishment intellettuale. Anche la figura di Frank Lloyd Wright, come quella di Veblen e di Duncan, sarà più apprezzata all’estero che in America. Wright è l’architetto che per primo, scrive Dos Passos, progetta «costruzioni secondo il futuro d’America, non secondo il passato d’Europa», e che sulle volumetrie orizzontali creerà il modello urbanistico e edilizio “organico” – “Usonian city” – suburbano e residenziale, lasciando un’impronta, come quella whitmaniana, americana e duratura. Il disegno di Wright sarebbe quindi l’incarnazione di ciò che Virginia Woolf, in un articolo del 1938 (l’anno della pubblicazione di U.S.A.) intitolato programmaticamente “L’America è la cosa più interessante del mondo, oggi”, individua come lo spirito di un luogo dominato dal presente e dal futuro («Ecco quello che li [gli americani] rende il popolo più interessante del mondo: guardano al futuro, non al passato»). 21 Isadora Duncan – «un’americana come Walt Whitman» – la danzatrice che rivoluzionerà il balletto nel Novecento, è anch’essa una figura tragica, nella vita personale e nella fortuna pubblica, enorme in Europa e nel mondo, ma non in patria. Se la biografia di Isadora Duncan incornicia, insieme a quella di Rodolfo Valentino (Tango lento), il debutto, nella trilogia, di Margo Dowling, il gioco di incastri tra le parti narrative e i profili celebri è capillare: Mac trova eco in Eugene Debs e Big Bill Haywood; Moorehouse in Andrew Carnegie, J.P. Morgan e Samuel Insull; Charley Anderson in Frederick Taylor e Henry Ford e Thomas Edison; Margo Dowling in Rodolfo Valentino e Isadora Duncan. Rifrazioni prismatiche amplificate da una strategia narrativa che crea una sorta di “impuntura incrociata” tra le due modalità, come quando Mac assiste a un comizio di Big Bill Haywood. 22 Ma è soprattutto grazie alla presenza organizzatrice di macro segmenti storici dominanti che la compenetrazione tra il piano orizzontale delle parti narrative e delle biografie e quello verticale del
Cine-giornale e dell’Occhio fotografico si fa più visibile e significativo.
Cine-giornale Il Cine-giornale di U.S.A. si presenta come un montaggio cubista di titoli di notizie di giornale, versi di canzoni, frammenti di discorsi ascoltati alla radio. Il titolo scelto da Dos Passos per questa modalità richiama esplicitamente le Newsreels, i brevi spezzoni documentari distribuiti, a scopo informativo e via via propagandistico, nei cinema americani tra il 1911 e gli anni Trenta, quando raggiungono la loro massima diffusione, nonché la loro fine, con il celebre The March of Time prodotto da Henry Luce. In una decina di minuti, una martellante voce fuoricampo srotola notizie su un sottofondo musicale rumoroso e uno sfondo visivo in cui si avvicendano rapidi fotogrammi. Se, nella messa a punto stilistica di questa modalità della trilogia, è decisiva la lezione del regista americano David W. Griffith e quella dell’avanguardia del cinema sovietico coronata dall’incontro del 1928 con Sergej Ejzensˇtejn, non va tuttavia dimenticata la conoscenza diretta di Dos Passos del balletto russo. Nella Parigi degli anni Venti, infatti, non solo Dos Passos incontrerà Fernand Léger ma contribuirà all’ideazione degli allestimenti scenici di Gerard Murphy, pittore e scenografo americano a cui viene commissionato l’American Ballet – con musiche di Cole Porter e danze di Djagilev – e per il quale Murphy creerà uno sfondo che ritrae una grande parodia di una prima pagina di quotidiano, con tanto di titoli privi di senso. 23 Già utilizzata da Dos Passos in Manhattan Transfer (1925), questa tecnica compositiva si fa sistematica nella trilogia. Commento disincantato e contrappunto inesorabile alla parabola di declino della democrazia americana, le Newsreels si aprono con la translatio imperii che vede gli Stati Uniti sostituire l’Inghilterra nel ruolo di potenza egemone agli inizi del “nuovo secolo” – «Il ventesimo secolo sarà americano», nelle parole del Senatore Albert J. Beveridge (Cine-giornale I, Il 42° parallelo), secolo iniziato nel sangue della guerra nelle Filippine – e si chiudono, a meno di trent’anni di distanza, sulla crisi di Wall Street, la più grande depressione economica del paese, la retorica miope di un presidente (Herbert Hoover) che «prevede vicina la prosperità» (Cinegiornale LXVIII, Un mucchio di quattrini) e il sangue dei minatori e dei
sindacalisti per mano delle forze dell’ordine. 24 Da un punto di vista strutturale, la funzione delle Newsreels è di anticipare e puntellare in modo obliquo e ironico gli eventi che dominano le altre tre modalità nella sezione della trilogia in cui compaiono. In Un mucchio di quattrini, per esempio, il Cine-giornale LV, che è posizionato tra il profilo di un Rodolfo Valentino evocato soprattutto attraverso il “funerale-evento” e la parte narrativa su un Charley Anderson sempre più perso nelle speculazioni immobiliari e finanziarie che lo condurranno al tracollo, riportano riferimenti a “Valentino funeral”, “Funds Accumulate in New York” e “Pittsburgh Bank”. A livello stilistico, invece, presi complessivamente, ovvero dal 42° parallelo a Un mucchio di quattrini, i frammenti di cronaca dei Cine-giornale sembrano spostarsi da una sorta di raccolta aneddotica di eccentricità da small town (che da un lato precorrono lo spirito delle Guide agli Stati finanziate, tra il 1937 e il 1941, dall’agenzia rooseveltiana del Federal Writers’ Project, e dall’altro richiamano gli scritti sferzanti con cui Henry Louis Mencken fustiga la mentalità di provincia americana) a un catalogo di slogan politici vuoti e accattivanti. Una tendenza che risponde, ancora una volta, al progressivo svuotamento semantico di un discorso pubblico ormai scollato dall’esperienza materiale di un’America che Dos Passos vede, nostalgicamente, come più autentica, e sempre più consegnato alla finzione di «contratti, profitti, viaggi in vacanza, il gran continente fra l’Atlantico e il Pacifico, energia, ronzio di dollari sui fili, città zeppe, colline deserte … treni, aeroplani; la storia la velocità miliardaria» (Vagabondo, Un mucchio di quattrini).
Occhio fotografico Il Camera Eye è un romanzo nel romanzo, una sorta di Künstlerroman in cui si delinea la maturazione intellettuale e artistica dello scrittore che arriva, non senza disillusioni, ad accettare il proprio ruolo attivo nel conflitto di classe e a forgiare, di conseguenza, la propria identità letteraria. Mentre nel 42° parallelo è possibile ripercorrere l’infanzia dell’autore fino alla partenza per l’Europa nel 1917, Millenovecentodiciannove copre il suo periodo europeo durante la Prima guerra mondiale e Un mucchio di quattrini è segnato dalle tappe
dell’attivismo politico in difesa, prima, di Sacco e Vanzetti – a cui Dos Passos ha già dedicato il pamphlet Facing the Chair (1927, Davanti alla sedia elettrica) – e, poi, dei minatori di Harlan County, alla cui causa ha lavorato insieme a Theodore Dreiser e Sherwood Anderson pubblicando il volume a più mani Harlan Miners Speak (1932). La morte dei due anarchici italiani e la repressione nel sangue delle rivendicazioni dei minatori di Harlan sono, si è già scritto, i due momenti in cui la percezione del fallimento delle istituzioni democratiche americane si fa più dolorosa e incontrovertibile. All’intellettuale e scrittore non restano che le parole («noi abbiamo soltanto parole» recita il finale dell’ultimo Occhio fotografico della trilogia). Formalmente Dos Passos si rifà qui al monologo interiore delle sperimentazioni moderniste di James Joyce e William Faulkner, riportando, come in presa diretta, le proprie reazioni interiori a un evento esterno. Il nome richiama d’altronde il Kino Eye (1924) del regista russo Dziga Vertov, in cui la telecamera diventa uno strumento di registrazione della vita mentre accade. Quello stesso Vertov che individua nelle sequenze di brevi immagini a ritrarre gli spazi americani del Walt Whitman di The Open Road l’anticipazione del montaggio cinematografico dell’avanguardia russa. 25 Presenza imprescindibile per Dos Passos, Whitman compare già nel 1916, in uno scritto intitolato Against American Literature in cui, giovanissimo, ne loda l’americanità, la ricerca di una poesia autoctona e non aristocratica in cui confluiscono le molte voci, plebee e multietniche, del paese (“la lingua di madri polacche”, come dirà in quegli stessi anni William Carlos Williams circa le origini della propria lingua poetica). Ma è poi con Un mucchio di quattrini che l’ammirazione per Whitman si trasforma in identificazione: «mentre ritorno a casa dopo un bicchierino e un boccone caldo e leggo (con qualche difficoltà nello stile della biblioteca Loeb) gli epigrammi di Marziale e medito il corso della storia e quali leve occorrono per sbalzare i proprietari dal potere e restaurare (anch’io Walt Whitman) la nostra democrazia da favola» (Occhio fotografico 46). 26 Il filo che lega Dos Passos a Whitman in U.S.A. è dunque un’adesione ideale a “visioni democratiche” inclusive della molteplicità dell’esperienza americana, e una tensione compositiva
volta a incorporare quella stessa esperienza rinnovandone i valori originari. Pur sapendo che quei valori non sono altro che il frutto della mitizzazione di un’innocenza mai esistita, in questo Occhio fotografico che reitera una geremiade laica, Dos Passos vede nel passato nazionale un possibile approdo sicuro alla propria inquietudine politica.
John Dos Passos: l’intellettuale come nomade irrequieto «È sempre lì che va o torna da qualche parte, e non rimane mai a lungo. Entra ed esce dalla politica o dal teatro così come entra ed esce dalla vita delle persone e dai diversi paesi.» Così Hemingway ricorda, senza citarlo per nome ma evocandolo impietosamente con l’epiteto «pilot fish» (letteralmente “opportunista”, “scroccone”, ma anche “pesce piccolo”), John Dos Passos in uno degli sketch parigini aggiunti postumi a una recente versione di Festa mobile. 27 Se il risentimento illividito di Hemingway nei confronti di ex amici scrittori (Anderson, Fitzgerald, Stein) è ormai un dato acquisito dalla critica e se la rottura tra i due va inserita in un quadro politico specifico (la guerra civile spagnola), il ritratto di un Dos Passos affetto da una forma di ipercinesi fisica, emotiva e politica ne coglie tuttavia il costante senso di sradicamento e dislocazione geografica e culturale. Nato a Chicago nel 1896, figlio illegittimo di John Randolph Dos Passos, un ricco avvocato di Wall Street di origini portoghesi, e Lucy Madison, proveniente da una vecchia famiglia della Virginia, entrambi intrappolati in matrimoni infelici da cui non riusciranno a liberarsi fino al 1910, John Roderigo Dos Passos vivrà i primi quindici anni della propria vita con la madre, soprattutto in Europa. “Un’infanzia da hotel”, come dirà lui stesso, e una condizione di outsider in perenne movimento. La ricchezza del padre gli consente tutti gli agi di un’adolescenza e di una giovinezza privilegiata (precettori, scuole eccellenti, viaggi e soggiorni all’estero). Dopo aver frequentato l’esclusiva Choate School in Connecticut, nel 1912 si iscrive a Harvard – dove conosce, tra gli altri l’amico E.E. Cummings. Dopo la laurea, nel 1916, torna in Spagna, l’anno successivo è a Greenwich Village (già cuore pulsante della vita bohémien americana)
in attesa di partire per il fronte europeo come conducente di ambulanze. Sarà attivo, prima con i Norton-Harjes Ambulance Corps e poi con la Croce Rossa americana, a Verdun e nell’Italia settentrionale tra il 1917 e il 1918. Dall’esperienza di guerra nascerà il suo primo romanzo di successo, Three Soldiers (1921, Tre soldati), in cui Dos Passos ritrae, senza infingimenti, la distanza fra gli ideali astratti della retorica bellica e la carneficina meccanizzata dei combattimenti sul campo. Proprio in Italia, nel 1918, Dos Passos incontra brevemente Hemingway poco prima del celebre ferimento di quest’ultimo a Fossalta del Piave. L’amicizia tra i due fiorirà, consolidandosi, nella Parigi degli espatriati (con gli Hemingway, i Fitzgerald e i Murphy) dei primi anni Venti. Pur in costante movimento tra Europa e America, Dos Passos riesce a mantenere ritmi di scrittura assai produttivi che lo porteranno a pubblicare, nel 1925, quella che viene considerata la sua opera più importante accanto a U.S.A., Manhattan Transfer, romanzo sperimentale panoramico e collettivo in cui, nelle parole entusiaste di Sinclair Lewis, il lettore vedrebbe finalmente la città per la prima volta. 28 Il 1925 è anche l’anno in cui Dos Passos, sempre più allineato al Partito comunista americano, contribuisce a fondare la rivista marxista «New Masses», intensificando una militanza a sinistra condivisa da molti intellettuali americani tra la seconda metà degli anni Venti e la prima metà del decennio successivo. L’impegno politico lo vedrà quindi intervistare Bartolomeo Vanzetti e protestare, nel 1927, contro la condanna a morte dei due anarchici. Il 1931 segna, oltre alla partecipazione alle manifestazioni di protesta a difesa degli Scottsboro Boys, la sua discesa in campo, si è già scritto, accanto a Theodore Dreiser e Sherwood Anderson che istituiranno una commissione di inchiesta sugli scontri sanguinosi tra i lavoratori in sciopero e le forze dell’ordine a Harlan County. L’affiliazione di Dos Passos con la sinistra radicale comunista si allenta tuttavia nei tre anni anni successivi, fino alla rottura del 1935, quando all’American Writers’ Congress legge un documento in cui accusa il CPUSA di essersi appiattito sui diktat stalinisti perdendo di vista l’unicità storica dell’esperienza americana. In Spagna, nel frattempo, si apre la guerra
civile (1936-39) che vede contrapposti il governo repubblicano legittimamente eletto di ispirazione marxista e una rivolta armata reazionaria tra le cui fila milita Francisco Franco. Schierato sulle prime a favore del fronte popolare repubblicano ma sempre più critico delle ingerenze sovietiche all’interno dello stesso, Dos Passos se ne allontana definitivamente nel 1937 a seguito della notizia della morte, in circostanze mai del tutto chiarite, dell’amico – nonché autore di una delle traduzioni più riuscite di Manhattan Transfer – José Robles tornato in Spagna per combattere contro Franco e ucciso dai repubblicani perché sospettato di spionaggio. La scomparsa di Robles segna anche l’ultimo atto della rottura con Hemingway che liquida l’assassinio come “necessario in tempo di guerra”. La parabola politica di Dos Passos, da qui in avanti, si muoverà sempre più a destra, rinnegando apertamente gli afflati rivoluzionari degli anni Venti. Sarà un sostenitore del maccartismo e un detrattore del potere dei sindacati, voterà – con un ardore «da fan adolescente che urla davanti ai Beatles» (queste le parole di Edmund Wilson) 29 – il repubblicano Barry Goldwater nel 1964 e nel 1970 loderà l’incursione militare della Cambogia dell’amministrazione Nixon. L’inversione politica andrà di pari passo a un graduale inaridimento della vena creativa e della popolarità di Dos Passos che pur restando scrittore assai prolifico darà alle stampe opere di carattere per lo più memorialistico e storico (tra cui spicca The Head and Heart of Thomas Jefferson, 1954, Thomas Jefferson). Se la traiettoria intellettuale dell’autore di U.S.A. richiama quella di altri scrittori degli anni Trenta – su tutte la vicenda politica altrimenti altalenante di John Steinbeck –, l’incapacità di ritrovare un’immaginazione letteraria paragonabile all’epico gesto romanzesco che sottende la trilogia è un tratto comune a molti autori americani (si pensi, per fare solo alcuni nomi, a Melville, Steinbeck e DeLillo). Il sigaro che un Dos Passos all’apice della propria fama tiene tra le dita nella famosa copertina del numero di «Time Magazine» del 10 agosto 1936 si spegnerà per molti versi, da lì a due anni, con la pubblicazione della trilogia U.S.A.
Storia editoriale di «U.S.A.» e sua fortuna/sfortuna nel canone americano
Dos Passos inizia a lavorare al 42° parallelo nel 1927 ma è solo al ritorno dalla Russia, nel 1929, che comincia a concepirlo come primo volume di una trilogia in grado di dare respiro a una materia impossibile da imbrigliare nella struttura di un unico romanzo. Provvisoriamente intitolato “The New Century” – “U.S.A.” arriverà solo nel 1937 – il progetto della trilogia si apre quindi con la pubblicazione, nel 1930, di The 42nd Parallel per Harper & Brothers, e una copertina su cui campeggia una mappa degli Stati Uniti iscritta tra meridiani e paralleli. Intanto Dos Passos è già a buon punto di Millenovecentodiciannove, lo finisce nel 1931, ma Harper blocca le stampe per una controversia sulla biografia satirica dedicata all’impero dei Morgan che, qualche anno prima, hanno aiutato economicamente la casa editrice. Inamovibile circa la possibilità di eliminare La dinastia Morgan, Dos Passos trova un altro editore, Harcourt Brace, che pubblica 1919 (unica edizione in cui compare il titolo in cifre) nel 1932 optando nuovamente per una copertina giocata sul motivo geografico e riproducendo la cartina dell’Europa. Seguono quattro anni di salute malferma, un periodo debilitante che gli impedisce di lavorare con continuità al terzo romanzo della trilogia, Un mucchio di quattrini. Si tratta tuttavia di uno iato in cui Dos Passos non solo affina l’accuratezza del proprio metodo compositivo, perfezionando gli incastri narrativi delle quattro modalità, ma conosce, si è già detto, un profondo ripensamento dei propri orientamenti politici, passando dalla cauta fiducia in una sinistra rivoluzionaria che ispira Il 42° parallelo all’amaro disincanto – L’amaro calice di Veblen – di Un mucchio di quattrini, uscito sempre per Harcourt, nel 1936. È nel 1937, rimettendo mano ai tre volumi in preparazione della loro pubblicazione come trilogia, che Dos Passos pensa al titolo U.S.A. e comincia a scrivere un Prologo concependolo, anche stilisticamente, come speculare a Vag, epilogo di Un mucchio di quattrini e dell’intera opera. Il 27 gennaio 1938, Harcourt pubblica quindi U.S.A. e l’anno successivo la trilogia compare nella Modern Library Series. Nel 1946, Harcourt mette in commercio un’edizione limitata di U.S.A. con le illustrazioni di Reginald Marsh che, considerate allora “atroci” da Hemingway, costituiscono oggi uno
degli esempi più studiati di corredo iconografico a un testo letterario. 30 La fortuna letteraria di Dos Passos è inscindibile da quella di U.S.A. Riconosciuto come uno degli scrittori americani più importanti dell’epoca intorno alla metà degli anni Trenta, in coincidenza con la pubblicazione della trilogia, la sua fama sarà tuttavia tutt’altro che stabile e duratura. 31 Se Jean-Paul Sartre, in un saggio su Millenovecentodiciannove del 1938, lo saluta come «il più grande scrittore del nostro tempo», gli attestati di stima dei connazionali, a partire dagli anni Quaranta, saranno assai meno entusiastici. L’unico riconoscimento americano alla carriera arriverà infatti nel 1956, quando sarà insignito della Golden Medal for Eminence in Fiction da parte dell’Institute of Arts and Letters e per mano di William Faulkner – già Nobel nel 1949 – che gliela consegnerà aggiungendo: «Nessuno se l’è meritata di più o l’ha dovuta aspettare più a lungo». 32 E a riprova di una discrepanza tra il gradimento europeo e quello americano della sua opera, nel 1967 Dos Passos riceverà il Premio Antonio Feltrinelli per la narrativa dall’Accademia nazionale dei Lincei. Fin dagli anni Trenta, la ricezione americana di U.S.A. resta irrisolta, come sospesa a una contraddizione di fondo: la sua opera è troppo sperimentale per essere considerata “letteratura proletaria” e troppo politica per entrare nel rango dei modernisti. Contraddizione che si acutizzerà nel secondo dopoguerra con l’avvento della scuola, programmaticamente estetizzante e antimarxista, dei New Critics e con una riconfigurazione del canone letterario americano che porterà alla rimozione degli autori socialmente impegnati dei decenni “rossi”. Diventato l’intelaiatura metodologica dell’insegnamento universitario grazie alla pratica del “close reading”, il New Criticism contribuirà non poco alla scomparsa di Dos Passos dall’accademia americana tra gli anni Cinquanta e gli anni Novanta, consegnando U.S.A. a una sorta di limbo di illeggibilità in cui la pur oggettiva complessità dell’opera non è che un motivo fuorviante. Bisognerà aspettare gli anni Novanta perché U.S.A. torni a essere letto e studiato insieme ad altre opere latamente radical della Grande Depressione grazie all’interesse di studiosi quali Michael Denning, Barbara Foley, Paula Rabinowitz e
Donald Pizer. Quanto alla riscoperta di U.S.A. in Italia oggi, si può forse partire da qui. 1. Gertrude Stein, L’autobiografia di Alice Toklas. «Gertrude Stein parla sempre dell’America come di quello che è attualmente il più antico paese del mondo, giacché, attraverso i metodi della guerra di secessione e le concezioni economiche che le tennero dietro, fu l’America a creare il secolo Ventesimo», Einaudi, Torino 1972 (1938, trad. Cesare Pavese), p. 79. 2. La traduzione italiana rende bene la rima musicale della canzone patriottica ma sacrifica «the hill»: «Eran quelli i patrioti/caricavano impetuosi sotto il fuoco micidiale/di quei porci rivoltosi» (Cine-giornale I, Il 42° parallelo). 3. Alessandro Portelli, «We Do Not Tie It in Twine.» Rifiuti, la storia e il peccato in «Underworld» di Don DeLillo, in «Ácoma», 7 (19), 2000, pp. 4-15; Il testo e la voce. Oralità, letteratura e democrazie in America, Il manifesto Libri, Roma 1992. 4. Si legga in questo senso il saggio con cui Barbara Foley vede nell’uso della storia di Dos Passos in U.S.A. un’anticipazione della non-fiction documentaria di Norman Mailer e della metanarrativa storica postmodernista di E.L. Doctorow: Barbara Foley, Notes on the Forms of Historical Consciousness in Modern Fiction, in «American Literature», 50, March 1978, pp. 85-105. 5. Mary McCarthy, The Lasting Power of the Political Novel, in «The New York Times Book Review», January 1, 1984. 6. Testimonianza anonima contenuta in Louis Adamic, What the Proletariat reads: Conclusions based on a year’s study among hundreds of workers throughout the U.S., in «The Saturday Review of Literature», XI.20 (1 Dec. 1934). 7. Michael Denning, The Cultural Front. The Laboring of American Culture in the Twentieth Century, Verso, London 1987. 8. John Dos Passos cit. in Denning, The Cultural Front, op. cit., p. 170. 9. È proprio Williams, amico di Pound, con cui trascorre un anno a Parigi nel 1924, che si farà sostenitore della necessità di scrivere l’America in un idioma americano. Nel 1925, Williams pubblica Nelle
vene dell’America, l’opera si compone di diversi capitoli ognuno intitolato o a un evento cruciale per la storia americana o a grandi personaggi, da Eric il Rosso a Abramo Lincoln. Per ognuno di questi capitoli, Williams sceglie uno stile diverso. 10. Donald Pizer, Dos Passos U.S.A. A Critical Study, University Press of Virginia, Charlottesville 1988, pp. 86-87. 11. Michael Denning, The Cultural Front, op. cit., p. 177 («The tayloring of the novel»). 12. Si veda Phoebe Kosman, 1928, Summer: John Dos Passos, in eds. Greil Marcus and Werner Sollors, A New Literary History of America, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2009, pp. 622-27. 13. Si veda il sito MoMA, https://www.moma.org/collection/works/79372. 14. Si veda Barbara Foley, Radical Representations. Politics and Forms in U.S. Proletarian Fiction, 1929-1941, Duke University Press, Durham 1993; M. Denning, The Cultural Front, op. cit.; Paula Rabinowitz, Labor and Desire. Women’s Revolutionary Fiction in Depression America, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 1991. 15. Donald Pizer, Dos Passos U.S.A., op. cit., p. 74. La definizione «Its storytelling is as regular and relentless as an assembly line» è di Michael Denning, The Cultural Front, op. cit., p. 177. 16. Michael Denning, The Cultural Front, op. cit., p. 182. 17. Antonio Bibbò, Characters as Social Document in Modernist Collective Novels: the Case of «Manhattan Transfer», in eds. C. Van den Bergh et al., Literature as Document. Generic Boundaries in 1930’s Western Literature, Brill-Rodopi, Leiden-Boston 2019, p. 59. 18. Si legga Andrew Yerkes, Twentieth-Century Americanism. Identity and Ideology in Depression-Era Leftist Fiction, Routledge, London 2005, il capitolo dedicato a U.S.A. (Totality and John Dos Passos’s «U.S.A.»). 19. Si leggano in questo senso Labor and Desire di Paula Rabinowitz, op. cit.; Janet Galligani, Historicing the Female in «U.S.A.»: Re-Visions of Dos Passos’s Trilogy, in «Twentieth-Century Literature», Vol. 41, No. 3 (Autumn 1995), pp. 249-64. 20. Michael Denning, The Cultural Front, op. cit., pp. 182 sgg.
21. Virginia Woolf, America, Which I Have Never Seen, in «Hearst’s International combined with Cosmopolitan», aprile 1938. 22. Donald Pizer parla di «cross-stitching», in Dos Passos U.S.A., op. cit., pp. 56 sgg. 23. Townsend Ludington, John Dos Passos 1896-1970: Modernist Recorder of the American Scene, in «The Virginia Quarterly Review», Vol. 74, No. 4 (Autumn 1996), pp. 565-80. 24. Più avanti, in Millenovecentodiciannove, troviamo il personaggio di Woodrow Wilson, «il primo presidente che avesse mai lasciato il territorio degli Stati Uniti durante il periodo di carica» (“Mister Vilson”, Millenovecentodiciannove). E, quando Dick Savage racconta a Anne Trent della visita di Wilson ai fori imperiali, riporta le parole che ha sentito pronunciare: «Siamo i Romani del ventesimo secolo!», salvo poi commentare con amara ironia, «e io invece volevo essere soltanto un greco» (Ibid.). 25. Mario Corona, La gallina furtiva e il gatto dalla coda troppo lunga. Sulle tracce di Walt Whitman, Introduzione a Walt Whitman, Foglie d’erba, traduzione e cura di M. Corona, I Meridiani, Mondadori, Milano 2017, pp. XI-CVIII, p. XLVI. 26. In “la nostra democrazia da favola” mi discosto dalla traduzione di Pavese «la nostra scolastica democrazia» perché «storybook» ha proprio il significato di “libro di favole”, “libro di storie per bambini”, a cui non corrisponde l’italiano «scolastico». 27. A Movable Feast, The Restored Edition, Scribner, New York 2009 («The Pilot Fish and the Rich»). 28. Sinclair Lewis, Manhattan, at Last!, in «Saturday Review of Literature», Dec. 5, 1925. 29. Wilson cit. in George H. Douglas, Edmund Wilson’s America, University Press of Kentucky, Lexington 1983, p. 167. 30. Per la parte relativa alla genesi editoriale di U.S.A. rimandiamo a Donald Pizer, Dos Passos U.S.A., op. cit., pp. 31-36. 31. Ricordiamo gli scritti di Lionel Trilling, The America of John Dos Passos (1938), in ed. Allen Belkind, Dos Passos, the Critics, and the Writer’s Intention, Southern Illinois Press, Carbondale 1971, pp. 35-43; Malcolm Cowley, John Dos Passos: the Poet and the World (1932), in
Belkind, Dos Passos, op. cit., pp. 22-34; Alfred Kazin, On Native Grounds. An Interpretation of Modern American Prose Literature, Doubleday, New York 1942, Chap. 11. 32. Townsend Ludington, John Dos Passos. A Twentieth-Century Odissey, E.P. Dutton, New York 1980, p. 471.
Bibliografia critica essenziale Adamic, Louis, What the Proletariat reads: Conclusions based on a year’s study among hundreds of workers throughout the U.S., in «The Saturday Review of Literature», XI.20 (1 Dec. 1934). Beal, Wesley, Network Narration in John Dos Passos’s U.S.A. Trilogy, in «Digital Humanities Quarterly», Vol. 5, No. 2, 2011, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/2/000094/000094.html. Bibbò, Antonio, Characters as Social Document in Modernist Collective Novels: the Case of «Manhattan Transfer», in eds. C. Van den Bergh et al., Literature as Document. Generic Boundaries in 1930’s Western Literature, Brill-Rodopi, Leiden-Boston 2019, p. 59. Corkin, Stanley, John Dos Passos and the American Left: Recovering the Dialectic of History, in «Criticism», Vol. 34, No. 4 (Fall, 1992), pp. 591611. Denning, Michael, The Cultural Front. The Laboring of American Culture in the Twentieth Century, Verso, London 1987. Foley, Barbara, Notes on the Forms of Historical Consciousness in Modern Fiction, in «American Literature», 50, March 1978, pp. 85-105. — Radical Representations. Politics and Forms in U.S. Proletarian Fiction, 1929-1941, Duke University Press, Durham 1993. Galligani, Janet, Historicing the Female in «U.S.A.»: Re-Visions of Dos Passos’s Trilogy, in «Twentieth-Century Literature», Vol. 41, No. 3 (Autumn 1995), pp. 249-64. Gelfant, Blanche, The Search for Identity in the Novels of John Dos Passos, in «PMLA», 76 (March 1961), pp. 133-49. Giles, Paul, The Novel After the War, in eds. P. Wald, M.A. Elliott, The Oxford History of the Novel in English, Vol. 6, The American Novel, Oxford University Press, Oxford-New York 2014, pp. 436-52. Hegeman, Susan, The Novel and the Rise of Social Science, in eds. P. Wald, M.A. Elliott, The Oxford History of the Novel in English, Vol. 6, The American Novel, Oxford University Press, Oxford-New York 2014, pp. 405-22. Kosman, Phoebe, 1928, Summer: John Dos Passos, in eds. Greil Marcus and Werner Sollors, A New Literary History of America,
Harvard University Press, Cambridge (MA) 2009, pp. 622-27. Ludington, Townsend, John Dos Passos 1896-1970: Modernist Recorder of the American Scene, in «The Virginia Quarterly Review», Vol. 74, No. 4 (Autumn 1996), pp. 565-80. — John Dos Passos. A Twentieth-Century Odissey, E.P. Dutton, New York 1980, p. 471. — Ed., The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos, Gambit, Boston 1973. Marz, Charles, U.S.A.: Chronicle and Performance, in «Modern Fiction Studies», 26 (Autumn 1986), pp. 398-416. McCarthy, Mary, The Lasting Power of the Political Novel, in «The New York Times Book Review», January 1, 1984. Moglen, Seth, Mourning Modernity. Literary Modernism and the Injuries of American Capitalism, Stanford University Press, Redwood City (CA) 2007. Pizer, Donald, Dos Passos U.S.A. A Critical Study, University Press of Virginia, Charlottesville 1988. Price, Kenneth M., To Walt Whitman, America, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2004. Rabinowitz, Paula, Labor and Desire. Women’s Revolutionary Fiction in Depression America, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 1991. Stratton, Matthew, Start Spreading the News: Irony, Public Opinion, and the Aesthetic Politics of «U.S.A.», Twentieth-Century Literature, Vol. 54, No. 4 (Winter 2008), pp. 419-47. Yerkes, Andrew, Twentieth-Century Americanism. Identity and Ideology in Depression-Era Leftist Fiction, Routledge, London 2005.
Nota alla traduzione
Cesare Pavese lettore e traduttore di U.S.A. di Sara Sullam Nelle brevi pagine del Prologo di U.S.A. il «giovane uomo» cammina da solo, mescolandosi alla folla nelle strade d’America, da costa a costa, registrando ciò che vede, reagendovi con tutto il proprio corpo – camminare è scrivere, muoversi è raccontare l’America, sembra dire Dos Passos. Nel coro delle voci che sente, il giovane uomo ritrova quelle che l’hanno accompagnato fin da bambino, le uniche che gli hanno permesso di sentirsi meno solo, affratellato al destino altrui. Perché U.S.A. – oltre che un lungo elenco di nomi e luoghi – è «soprattutto … la voce del popolo.» Nella trilogia ogni cosa – e ognuno – parla a suo modo, ma tutto confluisce all’interno del «nastro trasportatore a quattro canali», come lo definiva Dos Passos. All’interno di una sola opera egli combina, come si è visto, la sperimentazione di James Joyce, lo storytelling di Sherwood Anderson, il naturalismo di Theodore Dreiser, il documentarismo di Upton Sinclair e un giornalismo capace di narrare la realtà in presa diretta meglio di qualsiasi trattato, come quello di John Reed, «americano dell’Ovest» per cui «le parole avevano un significato preciso» (Giocherellone, Millenovecentodiciannove). Quale sfida migliore per un traduttore? Per non dire di un traduttore-scrittore? Insomma, per Cesare Pavese? È sua la traduzione del 42° parallelo (1934) e di Un mucchio di quattrini (1938), mentre Millenovecentodiciannove viene tradotto nel 1951 da Glauco Cambon. Traduzioni “d’epoca”, i due volumi a firma di Pavese si possono accostare ad altre sue importanti traduzioni anch’esse tuttora in circolazione – quelle da Herman Melville (Moby Dick, 1932), Sherwood Anderson (Riso nero, 1932), James Joyce (Dedalus, 1933), Daniel Defoe (Moll Flanders, 1938), Charles Dickens (David Copperfield, 1939), Gertrude Stein (Tre esistenze, 1940 e L’autobiografia di Alice Toklas, 1938). Data l’ampiezza e la complessità
dell’opera, la traduzione dei due volumi di Dos Passos registra un felice incontro tra il continente americano, le sue voci e lo scrittore italiano. Forse più di altri, questo incontro permette a Pavese di esprimere in italiano l’enorme potenziale che, a partire dalla sua tesi su Whitman 1 (autore cui U.S.A. è fortemente indebitato), lo scrittore ha individuato nella letteratura americana contemporanea. Come ricorda Italo Calvino nella prefazione alla Letteratura americana e altri saggi, «nella polemica letteraria, gli autori nordamericani rappresentano l’antitesi ideale al clima della prosa d’arte e dell’ermetismo: un movimentato spettacolo d’energie poetiche che cercano di farsi letteratura nazionale; e insieme una ricerca di linguaggio parallela a quella europea, ma innestata su un tronco fantastico più giovane e vigoroso» 2 (LAS, p. XIV). Tradurre Dos Passos permette a Pavese di lavorare sulla lingua e insieme su una materia romanzesca dinamica e ancora in trasformazione. Per Pavese Il 42° parallelo è la quinta traduzione, e inaugura la collaborazione con Mondadori. Prima ci sono state, in rapida successione, Il nostro signor Wrenn di Sinclair Lewis (Bemporad, Firenze 1931), Moby Dick di Herman Melville (Frassinelli, Torino 1932), Riso nero di Sherwood Anderson (Frassinelli, Torino 1932) e poi, fuori dai confini americani, il Dedalus di James Joyce (Frassinelli, Torino 1933). Com’è noto, l’attività traduttiva di Pavese è sempre accompagnata da una riflessione critica che l’autore consegna a saggi pubblicati in rivista. Per capire il fascino che la complessità stilistica e linguistica di 42° parallelo e Millenovecentodiciannove esercitavano su Pavese, particolarmente interessanti sono lo scritto su Sherwood Anderson 3 e, naturalmente, quello su Dos Passos. 4 In essi Pavese mette a fuoco questioni centrali sia per la lettura di U.S.A. e per la letteratura americana dell’epoca, sia per la propria ricerca sul romanzo: la cosiddetta “questione della lingua”, 5 e la funzione e l’interazione di diversi generi all’interno della narrazione. In Anderson, storyteller per eccellenza, 6 Pavese evidenzia la capacità di dare voce a quella «evasione nel sangue straniero», quello di «svedesi, tedeschi, israeliti, italiani» che fa rinascere (dopo la l’età gloriosa di Whitman e Melville) «una letteratura che scopre
l’America» in seguito al «ciclone» che la attraversa: Nell’80 un ciclone attraversa l’America. L’industrialismo in grande si sposa alle risorse del paese, assorbe tutte le formule nazionali di conquista e ottimismo, apre un pratico campo a ciò che fino allora era stato solo mistica aspirazione, spazza e trasforma tutti i modi antichi … Le fabbriche inghiottono tutto. Gli artigiani, innamorati un tempo dei cantucci, della materia, diventano operai che ogni giorno cambiano mestiere, indifferenti all’opera. I campi sono lavorati a macchina, grandi fabbriche anch’essi … I nuovi numi grotteschi sono penosi. Nascono i re del petrolio, dell’acciaio, della carne scatolata, del grano. Ha origine, insomma, l’America attuale. (LAS, p. 36) “Attuale” è qui sinonimo di “contemporaneo”, aggettivo con il quale gli scrittori dei primi decenni del Novecento – siano essi oggi raggruppati sotto l’etichetta di “modernisti” o meno – hanno un rapporto non semplice: ciò che è contemporaneo va oltre il moderno, e la modernità li getta nell’esperienza di una contemporaneità frammentata, dolorosa e fonte d’ispirazione insieme, come è il primo dopoguerra. Pavese sottolinea come Anderson da un simile processo abbia «tratto le più dolorose e pensose e risolutive rappresentazioni di vita moderna, insieme elementari e complicatissime, cerebrali e illetterate» (LAS, p. 36). Ciò permetterebbe di illuminare le contraddizioni della contemporaneità per come si manifestano sul suolo americano, e allo stesso tempo di cogliere il grande potenziale di una simile realtà, ancora tutta da “nominare”. 7 In tal senso è significativo notare come le riflessioni di Pavese consuonino con quelle di Virginia Woolf, scrittrice tanto londinese quanto era piemontese Pavese, e ugualmente affascinata, anche lei con un trasporto che oggi ci appare quasi ingenuo, da quell’America che, sempre come Pavese, non aveva mia visto. 8 È proprio in un saggio intitolato American Fiction (La narrativa americana, 1925), pubblicato su una rivista newyorchese, 9 che Woolf dedica lunghe pagine ad Anderson. Come nel caso di Pavese, parlare dell’autore americano le serve per illuminare un nuovo territorio dell’immaginario narrativo, un territorio sul quale, a detta sua, il romanzo del Novecento si realizzerà pienamente. La riflessione di Woolf, come quella di Pavese,
nasce dalla constatazione che gli scrittori americani stiano fondando una «nuova tradizione» 10 che, seppure a partire dalla specificità (da quell’attualità implacabile) del loro territorio, è in realtà in grado di dare nuova linfa alla letteratura europea. Woolf osserva: «l’America ci sembra un posto stranissimo … Un continente vasto … I lenti carri inglesi diventano automobili Ford; i pendii coperti di primule mucchi di vecchie lattine; i granai capanni di ferro ondulato. Tutto in economia, nuovo, brutto, un insieme di cose messe insieme di fretta e alla rinfusa». 11 O ancora, l’America è un «mosaico di pezzi sconnessi in attesa di essere ordinati dalle mani di un artista», e «la popolazione è ugualmente frammentata in diverse nazionalità. Per descrivere, unificare, mettere ordine tra le diverse parti sono necessari una nuova arte e il controllo di una nuova tradizione», e gli americani starebbero «adattando la lingua ai propri bisogni». 12 Nel 1931, Pavese aprirà il suo saggio su Anderson con una chiara presa di posizione: «Non abbiamo mai avuto quell’uomo o quell’opera che, oltre ad essere carissimi a noi, raggiungessero davvero quell’universalità e quella freschezza che si fanno comprendere a tutti gli uomini e non soltanto ai conterranei. Questo è il nostro bisogno non ancora soddisfatto. Mentre, al rispettivo bisogno, nella loro terra e nella loro provincia, sono appunto bastati i romanzieri americani di cui parlo. Da questi noi, dunque, dobbiamo imparare» (LAS, p. 34). Per alcuni scrittori americani, il processo di liberazione della lingua partirà dalla lettura di Joyce, l’irlandese che si scrolla di dosso, come loro stanno facendo, le ipoteche linguistiche e culturali del romanzo inglese. Basti pensare, prima di Dos Passos, a William Carlos Williams: quest’ultimo, dopo un passaggio in Europa, a Parigi, e la lettura di Joyce, scrive un’opera dal titolo emblematico, Il grande romanzo americano (1924), nel quale rende tributo a Joyce “liberatore della lingua”: «Non è necessario che noi impariamo da nessuno se non da noi stessi – sarebbe almeno un sollievo scoprire un critico che guardasse la produzione americana da un punto di vista americano». 13 Pavese, che su Joyce torna a più riprese e con il quale ha un rapporto decisamente contraddittorio, 14 non manca di registrare anche l’esplicito tributo di Anderson allo scrittore irlandese:
Proprio in Dark Laughter Anderson cita Joyce e ci dice che l’Ulysses gli è piaciuto enormemente … Ora, è spiegabilissimo come ad Anderson – che, in America, è un novatore contro il modo convenzionale, puritanesco e vittoriano di scrivere, che là infuria, o infuriava – interessi James Joyce. (LAS, p. 41) Si tratterebbe tuttavia, per Pavese, di una «leggenda da sfatare» (LAS, p. 41), perché ad Anderson «interessano, e forse anche di più … i romanzieri russi ed i francesi naturalisti … E in Hello Towns, tra parentesi, ci dice che Joyce non sa raccontare» (LAS, p. 41). Si capisce quindi quale sia il fascino di sfida che Dos Passos riveste per Pavese, nel quale, come si è detto, convivono e collaborano diversi accenti narrativi; e nel quale il fascino per Joyce, evidente più che mai negli Occhi fotografici, si unisce a uno spiccato talento affabulatorio (molte delle parti narrative si concludono su un atto del personaggio volto a creare curiosità, quando non suspense, come nella migliore tradizione romanzesca) e a una capacità di riprodurre quelle che potremmo definire “le parole del nuovo, dell’attuale” nei Cine-giornale o nelle biografie, però sottoposte a una critica profonda. L’articolo su Dos Passos può essere considerato un vero e proprio saggio sulla traduzione, che la prepara. Se il primo incontro con Dos Passos, dice Pavese, è avvenuto con Manhattan Transfer, e con l’immersione nelle voci e nei movimenti della grande metropoli, è con Il 42° parallelo e Millenovecentodiciannove che, dopo un significativo (anche se fallimentare) passaggio dalla scrittura teatrale, Dos Passos torna alla sperimentazione romanzesca. Lo fa mettendo in prospettiva, nel tempo (cioè sull’arco temporale che va dal 1898 al 1929, gli anni coperti dal romanzo) e nello spazio (con gli ampi movimenti dei protagonisti delle parti narrative attraverso il continente americano), le diverse vite che compongono il romanzo: dalla vita collettiva riportata nei Cine-giornale, alle biografie esemplari, alle vite dei personaggi fittizi a quella della voce degli Occhi fotografici. E diciamo “vite” perché è Pavese stesso a metterle “in dominante” nella sua lettura dei due romanzi: 15 Dos Passos ha scelto di raccontare non più per episodi ma per tratti di biografia, e ciò non è poco, poiché sebben anche questi tratti di
biografia siano tutti intessuti con episodi dello spirito e dello stile che formavan quelli di Manhattan Transfer, pure la loro semplice esposizione … origina una certa prospettiva, organizza un’esperienza umana. (LAS, p. 117) La “prospettiva” – che fa riferimento a un dato strutturale, di organizzazione dei contenuti – è anche quella che richiede la combinazione delle quattro modalità espressive, alle quali è dedicato il resto del saggio. Nelle parti narrative, Pavese ravvisa un dono “impressionistico” di Dos Passos, capace di «guardare e accumulare le mille parvenze per giudicare» e generatore di «uno stile, nella sua umile oggettività, ricchissimo di sfumature» (LAS, p. 118). È interessante notare come gli esempi portati da Pavese per illustrare questo punto siano tratti per lo più da Millenovecentodiciannove, volume che non tradusse, sebbene lo apprezzasse molto. 16 Mettere in dominante i personaggi (sono i loro nomi a dare il titolo ai diversi capitoli) e il loro sviluppo serve a muoversi tra interiorità ed esteriorità, evitando così lo psicologismo associato, all’epoca, al romanzo che oggi chiamiamo modernista. L’esempio più calzante viene dalla pagina finale del secondo capitolo dedicato a Joe Williams in Millenovecentodiciannove, che narra, facendone presagire il fallimento, il matrimonio tra Joe e Della: And Joe and Del left in a taxicab a feller he knew drove and everybody threw rice at them and Joe found he had a sign reading Newlywed pinned on the tail of his coat and Del cried and cried and when they got to their apartment Del locked herself in the bathroom and wouldn’t answer when he called and he was afraid she’d fainted. Joe took off his new blue serge coat and his collar and necktie and walked up and down not knowing what to do. It was six o’clock in the evening. He had to be aboard ship at midnight because they were sailing for France as soon as it was day. He didn’t know what to do. He thought maybe she’d want something to eat so he cooked up some bacon and eggs on the stove. By the time everything was cold and Joe was walking up and down cussing under his breath, Del came out of the bathroom looking all fresh and pink like nothing had happened. She said she couldn’t eat anything but let’s go to a movie… (1919)
Pavese offre una prova di traduzione del passo all’interno del proprio saggio, che sarà qui interessante paragonare alla traduzione effettivamente pubblicata, a firma di Cambon. E Joe e Del se ne andarono in un tassì guidato da un uomo che lui conosceva e tutti gettavano riso e Joe scoprì che aveva un cartello Oggi Sposi appuntato alla coda dell’abito e Del continuava a piangere e, quando arrivarono all’alloggio, Del si chiuse nella stanza da bagno e non rispondeva quando la chiamava e Joe aveva paura che fosse svenuta. Joe si tolse l’abito nuovo di panno blu, il colletto e la cravatta, e camminava avanti e indietro, non sapendo cosa fare. Erano le sei pomeridiane. Doveva trovarsi a bordo a mezzanotte, perché sarebbe partito per la Francia appena giorno. Non sapeva cosa fare. Pensò che forse Del aveva bisogno di mangiar qualcosa e le fece cuocere uova e prosciutto sulla stufa. Quando tutto fu freddo e Joe camminava avanti e indietro bestemmiando tra i denti, Del uscì dalla stanza da bagno, fresca e rosea come niente fosse stato. Disse che non poteva mangiare nulla, ma andiamo a un cinema… (LAS, p. 119) Pavese è abile nel mantenere il carattere rapido, oggettivo del testo, a rendere l’agitazione di Joe attraverso la traduzione dei verbi di movimento all’imperfetto (tempo che individua la “percezione in diretta” del protagonista) ma senza marcare oltre la sua rappresentazione del discorso, come invece farà Cambon, il quale traduce, per esempio, «He didn’t know what to do» con «Non sapeva proprio che fare», con un chiaro indice della riproduzione dei pensieri di Joe. Pavese riesce a cogliere come Dos Passos lavori per “ammasso” di impressioni (cfr. LAS, p. 121), impressioni che formano, come nel caso del brano su Joe, «carne e vita dei personaggi» (LAS, p. 121) nelle parti narrative, ma che invece vengono combinate in maniera diversa negli Occhi fotografici, dove l’autore dà in una pagina una specie di veduta parolibera delle proprie impressioni al tempo dei vari avvenimenti che passano nel racconto; ma anche qui, tranne qualche momento esageratamente cerebrale … regge il confronto con le migliori pagine narrative. (LAS, p. 121)
Sono modalità discorsive diverse per raccontare la stessa cosa, ma sempre a partire dalle impressioni di una persona ben precisa, sia esso il narratore degli Occhi fotografici, in prima persona (con significativi scivolamenti alla seconda in alcuni casi), o quello delle parti narrative, in un gradiente che va dall’assenza quasi totale di interiorità in Joe Williams a una psicologia su cui abbiamo più scorci, come quella di Richard Ellsworth Savage. Ciò raggiunge il culmine in Millenovecentodiciannove. È sempre da quest’ultimo che Pavese sceglie l’esempio per illustrare il funzionamento degli Occhi fotografici: at the Gare de l’Est they’re singing the International entire the gendarmerie nationale is making its way slowly down Magenta into stones whistles bits of iron the International Mort Aux Vaches Barricades we must build barricades young kids are trying to break down the shutters of an arms shop revolver shots an old woman in a window was hit (Whose blood is that on the cobbles?) we’re all running down a side street dodging into courtyards concièrges (sic) trying to close the outside doors on cavalry charging twelve abreast firecracker faces scared and mean behind their big moustaches under their Christmastree helmets at a corner I run into a friend running too Look out They’re shooting to kill and it’s begun to rain hard so we dive in together just before a shutter slams down on the door of the little cafe (sic) dark and quiet inside a few working men past middle age are grumblingly drinking at the bar Ah les salops There are no papers Somebody said the revolution had triumphed in Marseilles (sic) and Lille Ca va taper dure (sic) We drink grog americain our feet are wet at the next table two elderly men are playing chess over a bottle of white wine later we peep out from under the sliding shutter that’s down over the door into the hard rain on the empty streets only a smashed umbrella and an old checked cap side by side in the clean stone gutter and a torn handbill L’UNION DES TRAVAILLEURS FERA (The Camera Eye 40, 1919) Così Pavese: alla Gare de l’Est cantano l’Internazionale intera la gendarmerie nationale si apre lentamente una strada giù per Magenta tra pietre
fischi pezzi di ferro l’Internazionale Mort aux Vaches Barricate dobbiamo costruire barricate giovanotti cercano di abbattere le saracinesche del negozio di un armaiolo una rivoltella spara una vecchia a una finestra è stata colpita (Di chi è quel sangue sui ciottoli?) corriamo tutti per una strada laterale scansando in cortili concierges che cercano di chiudere le porte cavalleria che carica per dodici petardo facce spaventate e vili dietro i loro grossi baffi sotto gli elmi da albero di Natale A un angolo scontrai un amico che correva anche lui Sta’ attento Sparano per uccidere ed è cominciato a piovere dirotto così ci precipitiamo insieme l’istante prima che una saracinesca si sbatta sull’entrata di un piccolo café scuro e tranquillo dentro alcuni lavoratori vecchi bevono scontrosamente al banco Ah les salops Non ci sono giornali Qualcuno diceva che la rivoluzione aveva trionfato a Marseille e a Lille ça va taper dur Beviamo grog americano abbiamo i piedi bagnati al tavolo vicino due uomini anziani giocano a scacchi su una bottiglia di vino bianco Più tardi guardiamo fuori di sotto alla saracinesca calata sulla porta nella pioggia dirotta sulle vie vuote soltanto un ombrello fracassato e un vecchio berretto a quadri accanto alle pietre pulite e un manifestino strappato L’Unione Des Travailleurs Fera. (LAS, p. 122) Nella traduzione proposta all’interno del saggio, Pavese dimostra un’eccezionale abilità di riprodurre il ritmo del brano, espresso tipograficamente, in assenza o quasi di punteggiatura, dagli spazi bianchi che lo scandiscono. È come se si trattasse di versi liberi, tuttavia, nota Pavese a proposito delle biografie (ma lo stesso si può dire degli Occhi): «Quest’energia di tratti, tutta realistica, che salva il verso libero degli americani dal fiacco impressionismo del verso libero europeo, è l’eredità di Walt Whitman» (LAS, p. 28). Pavese sceglie inoltre di mantenere tutti i francesismi («gendarmerie nationale», «concierges» invece del «portinai» per cui opterà Cambon). In generale, si dimostra più ricettivo della riproduzione del parlato straniero – che talvolta nell’originale rasenta l’esercizio di stile – rispetto a Cambon. 17 Pavese esibisce una profonda comprensione di quella che Pizer
chiamerà tecnica del «cross-stitching», il punto croce, in base alla quale gli stessi eventi, o motivi, storici dominano segmenti di testo che si estendono su diverse “modalità”. 18 Alla traduzione dell’Occhio fotografico appena citato segue quella di un Cine-giornale in cui viene riportata, in francese, proprio una strofa dell’Internazionale che il narratore ha sentito cantare per le strade di Parigi poco prima. Tuttavia, spiega Pavese, i Cine-giornale hanno tutt’altra funzione: Essi sono centoni messi insieme da stralci di giornali, brani di canzonette, motti, tratti di discorsi e via dicendo, apparsi circa il tempo in cui cadono tra le biografie i vari Film-Giornale. Sono brevi sciocchezzai dell’ipocrisia e retorica capitalistiche, del colpevole disorientamento del mondo borghese durante e dopo la guerra. (LAS, p. 123) Nelle biografie degli americani illustri, infine, Pavese ravvisa esplicitamente l’impronta di Whitman e del poeta Carl Sandburg, del quale cita “Il portatore di ghiaccio”, componimento appartenente ai Chicago Poems (LAS, p. 127). Per Pavese U.S.A. è l’enciclopedia di un continente e Dos Passos l’autore che «potrebbe suggerire un più serio orientamento degli studi sull’arte e sul pensiero nordamericani», più attento a intercettarne lo «speech of the people» – discorso, discorsi, parlata, voce – perché «specialmente nella poesia, nulla di notevole nasce se non ispirandosi a una cultura autoctona o, se tale non può essere il caso, a una cultura almeno seriamente e definitivamente assimilata dalla razza e dalla nazione» (LAS, p. 129). Al netto del senso di sconfitta che pervade la trilogia (e massimamente Un mucchio di quattrini), «noi abbiamo soltanto parole» (Occhio fotografico 51, Un mucchio di quattrini), ma è da quelle che, proprio nell’Occhio fotografico che riprende la tragica esperienza di Bartolomeo Vanzetti, si dice si debba ripartire: ricostruire le distrutte parole fatte viscose in bocca agli avvocati ai pubblici ministeri ai presidenti dei collegi ai giudici senza le antiche parole che gli immigrati nell’odio dell’oppressione portarono a Plymouth come puoi capire quali sono i tuoi traditori America o che questo pescivendolo che tieni nel carcere di Charlestown è uno dei tuoi fondatori o Massachusetts? (Occhio fotografico 49, Un
mucchio di quattrini) Dos Passos è un autore su cui Pavese manterrà un giudizio immutato nel tempo, 19 anche se rimarrà deluso dalla lettura di Un mucchio di quattrini, come leggiamo nel parere di lettura commissionatogli da Mondadori: Egr. Dott. Rusca, In risposta alla Sua del 16 c.m., ecco il mio parere sul Big Money. L’ossatura del libro sono due biografie: Ch. Anderson, uomo d’affari, e Margo Dowling, futura stella del cinema. In esse s’insiste sull’arrivismo dei due, sulla loro povertà interiore, sulla volgarità e monotonia degli ambienti. Poi c’è una Mary French, organizzatrice comunista che vive tra scioperi e lavoro sociale, e finisce in prigione. Le biografie romanzate come quella di Edison, nel 42° Parall., sono numerose: c’è R. Valentino, H. Ford, i frat. Wright, Isadora Duncan, ecc. Il libro nel suo insieme mi pare valga molto meno del 42° Parall., anzitutto perché la canzone è sempre quella e nessun lettore troverebbe più qui quell’interesse di novità d’una volta, e poi perché veramente la mano di Dos Passos sembra stanca. Non c’è più quella gioia di inventare ambienti e paesaggi e scorrazzare per tutta l’Unione, come nel I vol. Politicamente e moralmente, non mi pare che ci sia più che nel 42° Parall., se si astrae da certe battute che possono tagliarsi senza danno. Per tutto il libro i personaggi vanno a letto, si ubriacano, bestemmiano, conoscono pederasti, niente di nuovo. Quanto alla politica è la solita lotta di classe. Credo insomma che il libro deluderebbe un poco i lettori, anche perché parecchi suoi personaggi (R. Savage, J.W. Moorehouse, J. Williams, Eveline Hutchins, Ben Compton, ecc.) continuano 1919. Ammesso che si voglia tradurre Dos Passos, mi sembra perciò logico tradurre prima 1919, anche perché questo è immensamente superiore non solo a Big Money, ma (credo) anche al 42° Parall. 1919 presenta gli ambienti della guerra, mostra retroscena, satireggia, maledice ed è piena attualità. Politicamente non è peggio del 42° Parall., tranne il viaggio di R. Savage in Italia e questo si potrebbe tagliarlo.
Questo è tutto. Non nascondo che tanto 1919 che Big Money sono di un lessico indiavolato: 1919 per via dei neologismi di guerra, e Big Money perché ogni anno che passa, complica quel volgare. I filmgiornale e gli Occhi fotografici dei due sono poi sovente incomprensibili, tanto che ho pensato se non si farebbe bene a dare un taglio generale e pubblicare soltanto le migliori biografie. Veda Lei. Sono stato della massima imparzialità e in attesa di un suo biglietto sono suo Cesare Pavese 20 Mondadori, tuttavia, non seguirà le indicazioni di Pavese. Millenovecentodiciannove era un romanzo, paradossalmente, più “politico” ancora di Un mucchio di quattrini, data la sua visione spassionata sulla guerra, la rappresentazione delle sue conseguenze – le conseguenze narrative di una pace imposta a suon di repressione. Ma questa resta un’ipotesi. Fatto sta che 1919 venne pubblicato in traduzione italiana solo nel 1951, con la firma di Glauco Cambon. Appartenente a una generazione successiva a quella di Pavese (era nato nel 1921), Cambon, 21 laureatosi a Pavia dopo essere stato prigioniero di guerra degli inglesi, era all’epoca della traduzione un giovane americanista, e, proprio nel 1951, trascorse un periodo a New York come Fulbright scholar. A scorrere l’elenco delle traduzioni di Cambon, si nota un addensamento particolare sulla letteratura del primo Novecento americano: Erskine Caldwell (Gretta, 1957), William Faulkner (Assalonne, Assalonne!, 1954), Sinclair Lewis (Il cercatore di Dio, 1952), riprendendo quindi alcuni nomi già praticati anche da Pavese. 22 Cambon del resto non era nuovo alla scrittura di Dos Passos: prima di Millenovecentodiciannove aveva tradotto Servizio speciale (1950) e in seguito avrebbe tradotto La riscoperta dell’America (1954). Cambon, inoltre, corrispose con lo stesso Dos Passos per dirimere alcune questioni terminologiche, specialmente quelle legate ai «neologismi di guerra» che Pavese aveva segnalato a Mondadori come elementi di particolare difficoltà. 23 Si tratta questa volta della traduzione non di uno scrittore che coglie, “in presa diretta”, il potenziale di un esperimento letterario, come Pavese, ma di uno studioso e traduttore
di professione, più felice nella traduzione di alcuni termini tecnici e dati culturali americani, che invece fanno talvolta sorridere in Pavese, per il quale «Thanksgiving Day» è bizzarramente «giorno di Grazie» e ancora «el train» (o L train) tradotto come «treno aereo»: traduzione sicuramente poetica, ma che non individua quel particolare mezzo di trasporto. Nei primi anni Cinquanta, il giovane Cambon sarà, grazie alle sue competenze e alla sua presenza fisica negli Stati Uniti, un collaboratore prezioso di Mondadori, lavorando spesso in “staffetta” con traduttori e scrittori della generazione già attiva nell’entre deux guerres. 24 Da Pavese prenderà il testimone nella traduzione di Dos Passos, quando si tratterà di pubblicare Millenovecentodiciannove e di offrire così ai lettori italiani l’intera trilogia. Nell’edizione del 1951 compare per la prima volta il “Prologo” che Dos Passos aveva anteposto alla pubblicazione in unico volume uscita nel 1938. Nell’edizione italiana, in tre volumi, il Prologo venne collocato in apertura al 42° parallelo, e la traduzione quindi attribuita automaticamente a Cesare Pavese (traduttore del volume). Non tutte le edizioni successive a quella del 1951 lo riportano e i documenti d’archivio 25 non serbano traccia dell’autore della traduzione, e non è da escludere che essa sia stata fatta da Cambon, a testimonianza proprio di un lavoro di staffetta. Nel dubbio, si è deciso di riportarlo qui di seguito, come appendice alla presente nota. «But mostly U.S.A is the speech of the people» (Prologo), conclude Dos Passos. Nel suo saggio, Pavese sottolineava come la forza dei due primi volumi della trilogia risiedesse nel fatto che, proprio grazie alla strategia compositiva dell’opera e all’interazione delle quattro modalità narrative, malgrado il tema politico non vi fosse alcuna «tesi espressa», perché «Dos Passos nel racconto non enuncia critiche o programmi: si accontenta di ascoltare i suoi eroi» (LAS, p. 124). È proprio questo ascolto che ritroviamo nel Prologo, che lo scandisce. Il giovane uomo ascolta le parole di sua madre quando tanto tempo fa, i racconti di suo padre quando ero ragazzo, le barzellette degli zii, le bugie degli scolari, gli aneddoti degli inservienti, o le storie dei fantaccini ubriachi;
era voce che aderiva alle orecchie, il legame che fremeva nel sangue; U.S.A. Allo stesso modo, Pavese dimostra di aver saputo ascoltare le cadenze di Dos Passos, al cui ritmo possiamo di nuovo avventurarci per un lungo viaggio negli Stati Uniti. Il giovanotto cammina da solo a passo rapido nella folla che si va diradando per le vie notturne; occhi avidi della calda curva d’altri volti, del balenio d’altri occhi che rispondono, della positura di una testa, della mossa di una spalla, del modo che hanno le mani di stendersi e stringersi; il sangue ronza di desideri; la mente è un alveare di speranze sonore e pungenti; i muscoli anelano dolorosamente alla conoscenza dei mestieri, al lavoro di picco e pala dei rappezzatori di strade, alla perizia che il pescatore dispiega quando issa la viscida rete dal parapetto della paranza dondolante, al gesto vibrato del braccio dell’arsenalotto quando ribadisce il bullone incandescente, alla lenta morsa saggia dell’ingegnere sulla leva della valvola, all’impiego totale che del suo corpo fa il bifolco quando, con un «Arri!» ai muli, sposta l’aratro dal solco. Il giovanotto cammina da solo ficcando sulla folla avidi occhi indagatori, la folla dagli occhi avidi, avide orecchie tese in ascolto, solo con se stesso. Le strade sono deserte. La gente si è accalcata nella metropolitana, ha preso d’assalto tranvai e autobus; nelle stazioni ha fatto chissà che sgambate per pigliare i treni suburbani; si è infiltrata nelle pensioni, negli alloggi di coabitazione, è salita con gli ascensori ai rispettivi appartamenti. In una vetrina due pallidi vetrinisti in maniche di camicia stanno portando alla ribalta un manichino femminile in abito da sera rosso, all’angolo saldatori in maschera protettiva si curvano su fogli di fiamma azzurra per riparare una rotaia, passano con andatura strascicata alcuni scioperati ubriachi, e un passante immalinconito gira inquieto sotto un lampione. Dal fiume giunge il profondo fischio cavernoso di un piroscafo che salpa. Un rimorchiatore ulula in distanza. Il giovanotto cammina da solo, a passo rapido ma non abbastanza, lontano ma non abbastanza (i volti spariscono scivolando dal quadro visivo, i discorsi si strascicano in brandelli, i passi acciottolano più
deboli nei viali); egli deve prendere l’ultima metropolitana, tranvai, autobus, salir di corsa le passerelle d’imbarco di tutti i piroscafi, fornire le proprie generalità a tutti gli alberghi, lavorare nelle città, rispondere alle inserzioni, imparare i mestieri, iniziare gli impieghi, vivere in tutte le pensioni, dormire in tutti i letti. Un letto non basta, un lavoro non basta, una vita non basta. Di notte, la testa sommersa da onde di velleità, cammina solo con se stesso. Niente lavoro, niente donna, niente casa, niente città. Solo le orecchie intente a cogliere a volo la parlata non sono sole; le orecchie sono strettamente prese e congiunte dalle volute delle parole infilate in frasi, dalla caratteristica di uno scherzo, dallo smorire cantilenato di un racconto, dalla brusca chiusa di una frase; congiungenti volute di linguaggio si allacciano per i caseggiati della città, si espandono per i selciati, prolificano lungo spaziosi viali alberati, si affrettano con gli autocarri che iniziano le loro lunghe corse notturne su rombanti arterie interurbane, bisbigliano per sabbiose straducole che passano da fattorie decrepite, collegando città e posti di rifornimento, rimesse di locomotive, piroscafi, aeroplani che tentano le vie del cielo; parole esplodono alte sui pascoli montani, seguono lente la deriva dei fiumi che si allarga nel mare e nelle spiagge attonite. Non era certo nelle lunghe camminate notturne attraverso folle turbinose che lui era meno solo, o nel campo di addestramento di Allentown, o nella giornata passata sulla banchina di Seattle, o nel vuoto afrore di Washington città, notti estive della fanciullezza ardente, o nel ristorante popolare di Market Street, o nella nuotata presso gli scogli rossi di San Diego, o nel letto pieno di pulci di New Orleans, o nel freddo vento tagliente del lago, o nei volti terrei tremanti nell’arrotio degli ingranaggi nella via sottostante a Michigan Avenue, o negli scompartimenti fumatori degli espressi a prenotazione, o nelle passeggiate per la campagna, o nelle ascensioni degli aridi canyons, fatte a dorso di mulo, o nella notte passata in Yellowstone Park senza sacco a pelo tra piste di orso gelate, o nelle gite domenicali in canoa sul Quinnipiac; ma nelle parole di sua madre che parlavano di tanto tempo fa, nei
racconti di suo padre: «quand’ero ragazzo io...», nelle storielle umoristiche degli zii, nelle bugie che i ragazzi dicevano a scuola, i racconti del salariato, le spacconate dei fanti dopo che avevano alzato il gomito; era il linguaggio che faceva presa sulle orecchie, il vincolo che ronzava nel sangue; U.S.A. U.S.A. è una fetta di continente. U.S.A. è un gruppo di società madri, alcune aggregazioni di sindacati, un corpo di leggi rilegato in pelle di vitello, una rete radiofonica, una catena di cinematografi, una colonna di quotazioni borsistiche cancellata e riscritta da un ragazzo della Western Union sopra una lavagna, una biblioteca pubblica piena di vecchie riviste e sgualciti libri di storia con proteste scarabocchiate a matita sui margini. U.S.A. è la più grande vallata del mondo frangiata di monti e colline. U.S.A. è una sequela di funzionari dalla bocca grossa e con troppi conti in banca. U.S.A. è una quantità di uomini sepolti in divisa al cimitero di Arlington. U.S.A. sono le iniziali che si appongono in calce all’indirizzo quando si scrive dall’estero. Ma più che altro U.S.A. è la parlata del mondo. 1. Pavese discute la tesi di laurea Interpretazione della poesia di Walt Whitman il 20 giugno 1930, all’Università di Torino, sotto la direzione del francesista Ferdinando Neri. Sull’argomento si rimanda a Gabriella Remigi, Cesare Pavese e la letteratura americana. Una «splendida monotonia», Olschki, Firenze 2012 (pp. 15 sgg.). Al volume di Remigi si rimanda anche per una trattazione approfondita ed esaustiva sul Pavese traduttore corredata da un’aggiornata bibliografia critica, che negli ultimi anni ha raggiunto una mole considerevole e che sarebbe impossibile – oltre che non pertinente – riportare all’interno di questa breve nota. Si veda anche Lawrence G. Smith, Cesare Pavese and America: Life, Love, and Literature, University of Massachusetts Press, Amherst 2008. 2. Italo Calvino, Prefazione a Cesare Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, Torino 1962 (d’ora in avanti abbreviato nel testo come LAS seguito dal numero di pagina da cui si cita). 3. Sherwood Anderson, in «La Cultura», 5, aprile 1931, pp. 400-07, ora in La letteratura americana e altri saggi, op. cit., pp. 33-47.
4. John Dos Passos e il romanzo americano, in «La Cultura», 1, gennaio-marzo 1933, pp. 162-73, ora con il titolo Esperimento e tradizione in La letteratura americana e altri saggi, op. cit., pp. 115. 5. Il carteggio tra Pavese e il musicista italo-americano Anthony Chiuminatto, suo vero e proprio mentore sulla lingua e sulla letteratura americana contemporanea, è rivelatore della centralità della questione. Cfr. Cesare Pavese and Antonio Chiuminatto: Their Correspondence, a cura di Mark Pietralunga, University of Toronto Press, Toronto 2007. Cfr. anche Gian Luigi Beccaria, Il lessico, ovvero la ‘questione della lingua’ in Cesare Pavese, in «Sigma», I, 3-4, 1964, pp. 8794 (il numero di «Sigma» contiene anche un bel saggio di Claudio Gorlier, Tre riscontri sul mestiere di tradurre, pp. 72-86). 6. Pavese cita a proposito il racconto A Storyteller Story «dove si rievoca il tipo bizzarro del padre, fannullone dionisiaco, che non sa che inventare storie – sotto tutti gli aspetti sono storie – e le racconta ai contadini dell’Ohio, dell’Ovest, alle famiglie di provincia, come un aedo, come un trovero» (LAS, p. 42). 7. L’enfasi sul “nominare” è una nota che risuona dagli elenchi whitmaniani al “rinominare le cose viste” che riassume il programma del poeta e romanziere modernista americano William Carlos Williams (1883-1963) nel suo Nelle vene dell’America (1925, trad. di Aldo Rosselli e Rodolfo Wilcock, Adelphi, Milano 1969), vera e propria “storia modernista” dell’America e dei suoi miti fondativi. Williams era noto a Pavese, come si evince da una lettera a Chiuminatto in cui gli chiedeva di inviargli, insieme a quelle di altri autori, opere di Williams (lettera del 12 gennaio 1930 in Cesare Pavese, Lettere 1926-1950, a cura di Italo Calvino e Lorenzo Mondo, Einaudi, Torino 1968, p. 102). 8. Il riferimento è al saggio America, Which I Have Never Seen, pubblicato negli Stati Uniti su «Hearst’s International combined with Cosmopolitan», aprile 1938, ora in The Essays of Virginia Woolf: Volume VI, 1933-1941, a cura di Stuart N. Clarke, The Hogarth Press, London 2011, pp. 128-33. 9. Virginia Woolf, American Fiction, in «Saturday Review of Literature», 1 agosto 1925, ora in The Essays of Virginia Woolf: Volume
IV, 1925-1928, a cura di Andrew McNeillie, The Hogarth Press, London 1994, pp. 269-80. Le traduzioni da questo saggio sono di chi scrive. 10. Virginia Woolf, American Fiction, op. cit., p. 278. 11. Ibid., p. 270. 12. Ibid., p. 278. 13. William Carlos Williams, Il grande romanzo americano, trad. it. di Rosella Mamoli Zorzi, Marsilio, Venezia 1996, p. 155. 14. Subito dopo la traduzione del 42° parallelo, Mondadori propone a Pavese di tradurre l’Ulisse, ma Pavese declina l’offerta, ritenendo che ci siano persone più titolate di lui ma adducendo anche ragioni di carattere economico (cfr. lettera del 12 luglio 1933 a Luigi Rusca in Lettere, op. cit., p. 226. In una lettera a Enrico Cederna nel gennaio 1948, Pavese arrivava persino a dire: «In confidenza tutto Joyce mi fa rabbia», Lettere, op. cit., p. 575). 15. Nel parere di lettura su The Big Money richiestogli da Mondadori, Pavese si spingeva addirittura a dire che si sarebbero potute pubblicare solo le biografie, dove sembra che il termine faccia riferimento sia alle biografie vere e proprie sia alle parti narrative. Il parere è raccolto in Non c’è tutto nei romanzi, a cura di Pietro Albonetti, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 1994, pp. 393-96. 16. Cfr. il parere di lettura raccolto in Non c’è tutto nei romanzi, op. cit. 17. Ciò avviene anche nella traduzione di Un mucchio di quattrini, dove nel primo capitolo rende «tootsuite» [tout de suite] con «tuzuit», mentre Cambon opta quasi sempre per una parafrasi o per una locuzione. Per esempio, in Millenovecentodiciannove, nel penultimo capitolo dedicato a Richard Savage «you can parleyvoo [parlez-vous] better’n I can» è “normalizzato” da Cambon con «tu sai parlar francese meglio di me». O ancora, l’«havanuzzerone» che scandisce a intervalli regolari l’Occhio fotografico (33) di Millenovecentodiciannove – ossia la riproduzione di “Have another one” pronunciato da un francese – viene reso con la locuzione «su, prendetene un altro», affidando la spiegazione della scelta traduttiva a una nota. 18. Donald Pizer, Towards a Modernist Style: John Dos Passos,
Bloomsbury, New York-London-New Delhi-Sydney 2011, p. 46. 19. A tal proposito Maria Stella (Cesare Pavese traduttore, Bulzoni, Roma 1977, p. 106; cfr. per Dos Passos in generale le pp. 105-21) cita anche un brano tratto dal diario di Pavese: «Bisogna imparare non solo a essere molte persone diverse (Dos Passos ci riesce), ma anche a fare queste persone scegliendole e scegliendone i tratti (i tratti di Dos Passos si possono spostare da un personaggio all’altro)» (Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950), il Saggiatore, Milano 1965, p. 186). 20. Parere di lettura contenuto in Non c’è tutto nei romanzi, op. cit. 21. Cfr. James H. Potter, In Memoriam: Glauco Cambon (1921-1988), in «Italica», Vol. 65, No. 3, 1988, pp. VII-X. 22. Un altro nome, inoltre, lega i due traduttori: Joyce. Cambon sarà tra i “curatori scientifici” della traduzione di Ulisse, iniziata alla fine degli anni Quaranta e pubblicata solo nel 1960. 23. Ringraziamo Steffen, Claudio e Marlis Cambon per avere portato la nostra attenzione su questo fatto, testimoniato dalla lettera di risposta di Dos Passos del 25 dicembre 1949 (Glauco Cambon Papers. Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Libraries). 24. Per esempio farà parte della squadra, inizialmente condotta da Eugenio Montale, che presiede all’impresa della traduzione dell’Ulisse di Joyce. A Montale Cambon rimarrà molto legato. Sarà il primo a studiarlo e a scriverne in ambito statunitense, come autore di diversi saggi e di uno studio monografico sul poeta ligure, nonché curatore di diverse antologie e traduttore verso l’inglese di alcune liriche. 25. La corrispondenza di Pavese con Mondadori è conservata in parte presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, e in parte presso il Centro Studi Gozzano-Pavese, Torino. L’archivio delle carte di Glauco Cambon è conservato presso la biblioteca della University of Connecticut. Si ringraziano per le preziose indicazioni fornite Anna Lisa Cavazzuti e Marco Magagnin (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori); Maria Pia Masoero (Centro Studi GozzanoPavese); Mark Pietralunga (Florida State University); Patricia Parlette (University of Connecticut) nonché Marlis Cambon, Steffen Cambon e Andrea Celli (University of Connecticut).
Nota dell’editore È la prima volta che in Italia i tre romanzi della trilogia U.S.A. – The 42nd Parallel (1930), 1919 (1932), The Big Money (1936) – vengono raccolti in un unico volume a costituire quella grande enciclopedia del continente americano negli anni tra il 1899 e il 1929 a cui lo stesso John Dos Passos diede forma nel 1938: tre romanzi in un unico volume con un prologo che esplicita la chiave musicale («la voce del popolo») dell’intero progetto. Il presente volume raccoglie le traduzioni storiche di questi romanzi, tutte uscite presso Mondadori nella gloriosa collana della “Medusa”. Due di esse – quelle del primo e dell’ultimo romanzo della trilogia, Il 42° parallelo (1934) e Un mucchio di quattrini (1938) – si devono a Cesare Pavese, il quale ebbe modo di lavorare anche sul secondo romanzo, Millenovecentodiciannove, la cui traduzione fu poi affidata a Glauco Cambon e vide la luce per ultima, nel 1951. I tre volumi della “Medusa”, con i numeri progressivi 27, 269 e 93, a partire dal 1951 portarono in frontespizio anche l’indicazione “U.S.A. I”, “U.S.A. II”, “U.S.A. III”. L’incontro con U.S.A., cioè con le voci del continente americano, fu particolarmente felice per Cesare Pavese nella duplice veste di scrittore e di intellettuale: non solo ne tradusse più di due terzi, ma svolse anche un approfondito lavoro critico alla ricerca della “prospettiva” letteraria e politica del testo. È parso perciò non solo opportuno ma necessario riproporre – nonostante la grande distanza temporale – la sua ineguagliabile voce traduttoria: virtuosistica nelle parti più liriche dei Camera Eye, efficacissima nelle biografie di americani illustri, attenta a creare una “lingua del nuovo, dell’attuale” nei Cine-giornale, talvolta un po’ datata nelle sezioni narrative, dove si raccontano le vicende di personaggi di fantasia. Lo straordinario interesse del lavoro di Pavese su Dos Passos, la presenza di brani di Millenovecentodiciannove da lui tradotti e quindi confrontabili con la versione di Glauco Cambon hanno anche offerto l’occasione di approfondire il metodo di lavoro dei due traduttori, di ragionare sui risultati da loro raggiunti, oltre che di mettere a fuoco la visione
dell’America di due intellettuali appartenenti a generazioni diverse. U.S.A., si diceva, è una grande enciclopedia del continente americano, esplorato nello spazio e nel tempo. Il lettore di oggi dispone di ben altre conoscenze in proposito, spesso di prima mano, rispetto al pubblico di Pavese e Cambon. Per renderli riconoscibili e attuali, ed eventualmente ricercabili online, si è deciso di ricondurre sistematicamente all’originale (di solito inglese, ma talvolta anche francese) o all’uso invalso in italiano tutti i cosiddetti realia, che invece soprattutto da Pavese erano stati tradotti, e spesso tradotti in modo non uniforme. Si tratta di toponimi, di titoli (di volumi, riviste, drammi, film e canzoni), di nomi propri (di associazioni, marchi industriali, società, enti, partiti politici, monumenti), di soprannomi. Le altre scelte traduttorie sono state tutte rispettate, compreso l’uso del voi in luogo del lei. Il viaggio di U.S.A. alla scoperta del continente americano nel tempo e nello spazio è approfondito negli apparati di questa edizione. Oltre all’introduzione critica e alla nota sul lavoro traduttorio e critico di Pavese, il lettore troverà nel volume delle pagine intitolate “meccano”. Se la trilogia nel suo complesso funziona come una vera e propria “piattaforma” in cui spazio, tempi, personaggi e diverse tecniche e generi narrativi collaborano a fornire un grande affresco dell’America del Novecento, lo scopo di queste pagine è “smontare” e “rimontare” il complesso organismo di U.S.A., mettere in evidenza la struttura narrativa che lo sostanzia, rendere visibili con mappe schemi diagrammi le trame e le corrispondenze che lo attraversano, mostrare sull’atlante gli spostamenti dei protagonisti e coglierne la valenza ideale e ideologica. La modernità di U.S.A. va però ben oltre l’aspetto visivo, l’unico che sia stato possibile rappresentare su carta: un romanzo fatto di voci necessita di un corredo di audio e di video, esempi udibili e visibili di ciò che la scrittura funambolica di Dos Passos riesce a farci sentire e vedere nelle sezioni Camera Eye e Newsreel: il lettore li troverà disponibili sul sito web degli Oscar Mondadori. Un cenno, da ultimo, sulle attribuzioni del lavoro. Due, lo si è visto, sono i traduttori. Due sono anche le curatrici di questa edizione,
Cinzia Scarpino e Sara Sullam. Fatte salve le loro competenze specifiche, l’impianto complessivo dell’edizione, la costruzione dei diversi apparati e la scelta dei contenuti è frutto del loro affiatatissimo lavoro in comune.
U.S.A.
Prologo U.S.A. Il giovane uomo cammina veloce, da solo, in mezzo alla folla che si dirada nelle strade la sera; piedi stanchi per le ore di cammino; occhi in cerca di volti cordiali, di una risposta al lampo di uno sguardo, a un cenno del capo, a un’alzata di spalle, a una stretta di mano; sangue che ribolle di desideri; in testa nugoli di speranze che ronzano e pungono; muscoli che fremono per conoscere mestieri: il piccone e la pala dello stradino, la mossa del pescatore con l’arpione per issare la rete scivolosa dalla battagliola del peschereccio dondolante, il colpo assestato dall’operaio per ribattere un bullone incandescente sul ponte, la presa esperta dell’ingegnere che regola lievemente una valvola, il movimento del corpo di un contadino che strattona l’aratro incitando i muli. Il giovane uomo cammina veloce, da solo, percorrendo la folla con occhi smaniosi, con orecchie smaniose, protese in ascolto, da solo, solo. Le strade sono vuote. La gente si è stipata in metropolitana, è salita sui tram e sugli autobus; ha corso dietro un treno regionale; si è infilata nelle pensioni, nei caseggiati, è salita in ascensore fino al proprio appartamento. In una vetrina, due commessi dalla pelle giallastra in maniche in camicia sistemano un manichino con un vestito rosso, all’angolo della strada due saldatori si chinano su lamine di fiamma blu per riparare una rotaia, alcuni ubriaconi si trascinano lì accanto, un triste passante si agita sotto un lampione. Dal fiume giunge il rombo profondo della sirena di una nave che sta mollando gli ormeggi. Un rimorchiatore fischia in lontananza. Il giovane uomo cammina da solo, veloce ma non abbastanza, lontano ma non abbastanza (i volti scivolano via, i discorsi si disperdono in frammenti, lo scalpiccio dei passi nei viali si fa sempre più lieve); deve prendere l’ultima metropolitana, il tram, l’autobus, deve correre sulle passerelle di tutti i piroscafi, registrarsi in tutti gli alberghi, lavorare nelle città, rispondere agli annunci, imparare mestieri, accettare lavori, vivere in tutte le pensioni, dormire in tutti i letti. Un letto non basta, un lavoro non basta, una vita non basta. La
sera, con la testa piena di desideri, cammina in silenzio, da solo, solo. Senza un lavoro, senza una donna, senza una casa, senza una città. Solo le orecchie protese in ascolto non sono sole; sono legate da viticci di parole combinate in frasi, dalla battuta finale di una barzelletta, da una storia che muore in cantilena, dalla chiusura brusca di una frase; viticci di voci si ricollegano negli isolati della città, si sviluppano sui marciapiedi, proliferano lungo gli ampi viali alberati, corrono veloci con i camion in partenza per lunghi tragitti notturni nel frastuono delle autostrade, mormorano su vie sterrate che costeggiano fattorie in rovina, collegano città, stazioni di rifornimento, rimesse, piroscafi, aerei che brancolano nelle vie del cielo; le parole risuonano nei pascoli in quota, scivolano lentamente lungo i fiumi che si allargano avvicinandosi al mare e alle spiagge silenziose. Non erano le lunghe camminate tra la folla sgomitante a farlo sentire meno solo, o il campo di addestramento di Allentown, una giornata trascorsa sui moli di Seattle, l’afrore vuoto delle calde notti estive da adolescente a Washington, un pranzo su Market Street, una nuotata vicino agli scogli rossi di San Diego, un letto pieno di pulci a New Orleans, o il vento tagliente in riva al lago, i grigi volti tremanti nella morsa degli ingranaggi sulla strada sotto Michigan Avenue, la carrozza fumatori dei treni espressi, le passeggiate in campagna, le cavalcate nei canyon riarsi, o la notte senza sacco a pelo, nello Yellowstone, sulle piste degli orsi ghiacciate, o le gite in canoa, la domenica, sul Quinnipiac; ma le parole di sua madre quando tanto tempo fa, i racconti di suo padre quando ero ragazzo, le barzellette degli zii, le bugie degli scolari, gli aneddoti degli inservienti, o le storie dei fantaccini ubriachi; era voce che aderiva alle orecchie, il legame che fremeva nel sangue; U.S.A. U.S.A. è una fetta di continente. U.S.A. è un gruppo di finanziarie, un’unione di sindacati, un corpo di leggi rilegate in pelle, una rete radiofonica, una catena di cinema itineranti, una colonna di quotazioni azionarie cancellata e riscritta su una lavagna da un ragazzo della Western Union, una biblioteca pubblica piena di vecchi
quotidiani e libri di storia con l’orecchia per tenere il segno e frasi di protesta scribacchiate sui margini a matita. U.S.A. è la più grande valle costeggiata da montagne e colline, U.S.A. è un gruppo di agenti chiacchieroni con troppi conti in banca. U.S.A. è molti uomini sepolti in divisa al cimitero di Arlington. U.S.A. sono le lettere alla fine di un indirizzo quando si è lontani da casa. Ma soprattutto U.S.A. è la voce del popolo. (traduzione di Sara Sullam)
Il 42° parallelo Traduzione di Cesare Pavese
Cine-giornale I Eran quelli i patrioti caricavano impetuosi sotto il fuoco micidiale di quei porci rivoltosi. È FINITO IL SECOLO DELLA CAPITALE Il generale Miles, con la brillante uniforme e il generoso destriero, era il centro di tutti gli sguardi specialmente a causa dell’irrequietezza della cavalcatura. Proprio quando la banda passò davanti al generale in capo, il cavallo si drizzò sulle zampe posteriori e rimase quasi eretto. Il generale Miles istantaneamente strinse le redini dell’animale atterrito e piantò gli speroni nel tentativo di dominare il cavallo, che tra l’orrore degli spettatori ricadde all’indietro completamente addosso al generale in capo. Con molto sollievo della folla, il generale Miles non riportò ferita alcuna, ma il cavallo ebbe abrasa dal fianco una quantità considerevole di pelle. Il cappotto del generale Miles era quasi interamente ricoperto di polvere della strada e fra le spalle si era prodotto uno squarcio di un pollice circa di diametro. Senza aspettare che qualcuno gli spazzolasse la polvere dagli abiti, il generale Miles rimontò a cavallo e passò in rivista la parata come se si trattasse di un avvenimento d’ogni giorno. L’incidente attirò naturalmente l’attenzione della folla e questo fece notare il fatto che il generale in capo non lascia mai che una bandiera gli passi davanti, senza scoprirsi e restare in questa posizione finché i colori non siano passati. Capitano dell’Ottava combatteva in prima fila da soldato di coraggio le pallottole sfidava. I FUNZIONARI IGNORANO I VIZI I commissari di sanità derivano l’acqua del fiume Chicago in un canale di drenaggio IL LAGO MICHIGAN STRINGE LA MANO AL PADRE DELLE ACQUE la gara di canto dei canarini della Züchterverein tedesca si apre la battaglia per il bimetallismo alla
proporzione di 16 a 1 non è stata perduta dice Bryan GLI INGLESI BATTUTI A MAFEKING Perché molti soldati son stati ammazzati a Luzon CHIEDE LE ISOLE PER SEMPRE Lo Hamilton Club Ascolta il Discorso dell’ex deputato Posey dell’Indiana UN BACCANO SALUTA IL NUOVO SECOLO IL LAVORO SALUTA IL NUOVO SECOLO LE CHIESE SALUTANO IL NUOVO SECOLO Il sig. McKinley è assorto al lavoro nel suo ufficio mentre comincia il nuovo anno LA NAZIONE SALUTA L’ALBA DEL SECOLO Rispondendo a un brindisi Viva la Columbia! al banchetto del Columbia Club di Indianapolis Ind. l’ex presidente Benjamin Harrison disse fra l’altro: Non ho obiezioni da fare qui o altrove contro l’espansione territoriale; ma non considero, come certuni, l’espansione territoriale la via più sicura e allettante dello sviluppo nazionale. Attraverso i vantaggi del carbone e del ferro in abbondanza e a buon mercato, di un’enorme sovraproduzione di articoli commestibili, delle invenzioni e dell’economia nella produzione, noi meniamo ora per il naso le più grandi tra le nazioni colonizzatrici originarie. Sgradita Sorpresa tra Signorine di Società: Un Ballo Insieme Ai Poliziotti Perché molti soldati sono stati ammazzati a Luzon e Mindanao RAGAZZE ALLEGRE ASSALITE DALLA FOLLA NEL NEW JERSEY Una delle litografie della prima donna la rappresentava in un costume anche più succinto che quelli da bagno di Atlantic City, seduta su una stufa rovente, in una mano un bicchiere di vino traboccante, nell’altra dei nastri aggiogati a un paio di aragoste rampanti. Perché molti soldati sono stati ammazzati a Luzon Mindanao e Samar
Rispondendo al brindisi «Il ventesimo secolo», il senatore Albert J. Beveridge disse fra l’altro: Il ventesimo secolo sarà americano. Il pensiero americano lo dominerà. Il progresso americano gli darà la tinta e la direzione. Le gesta americane lo renderanno illustre. La civiltà non lascerà mai la presa che ha su Shanghai. La civiltà non si staccherà mai da Hong Kong. Le porte di Pechino non saranno mai più chiuse ai metodi dell’uomo moderno. La rigenerazione del mondo, tanto fisica quanto morale, è cominciata e le rivoluzioni non tornano mai indietro. Perché molti bravi soldati ammazzati alle Filippine dormono sepolti in tombe solitarie.
Occhio fotografico (1) quando si cammina per la via bisogna sempre posare i piedi con attenzione sui ciottoli in modo da non pestare i fili d’erba lucenti tutti ansiosi è più facile se si stringe la mano della mamma e ci si fa reggere, così si possono alzare i piedi ma camminando in fretta bisogna pestare troppi fili d’erba le povere lingue verdi ferite si raggrinzano sotto i piedi forse è per ciò che quella gente è tanto infuriata e ci segue agitando i pugni gettano sassi, gente adulta che getta sassi La mamma cammina in fretta e noi corriamo la punta acuta delle sue scarpe sporge netta tra i poveri fili calpestati sotto le pieghe agitate della sottana marrone Inglese un sasso tintinna sui ciottoli Presto tesoro presto nel negozio di cartoline è tranquillo la gente infuriata sta fuori e non può entrare Non nein nicht inglese, amerikanisch américain Hoch Amerika Vive l’Amérique Mamma ride Caro mi avevano proprio spaventata la guerra nel Veldt Kruger Bloemfontein Lady-smith e regina Vittoria una vecchia signora con la cuffia a punta mandò cioccolato ai soldati per Natale sotto il banco è scuro e la signora la brava signora olandese che ama gli americani e ha parenti a Trenton mostra cartoline che risplendono nell’oscurità begli alberghi e palazzi Ô que c’est beau schön carino carino e la luna luccica luccica sotto un ponte e i piccoli réverbères sono accesi nell’oscurità sotto il banco e le finestrine degli alberghi intorno al porto Ô que c’est beau la lune e la luna piena
Mac Quando il vento spirava dalle fabbriche di argenterie attraverso il fiume, l’aria della grigia baracca per quattro famiglie, dove Fainy McCreary era nato, soffocava per tutto il giorno con l’odore di sapone di balena. Altre volte sapeva di cavoli, di bambini e delle caldaie da bucato della signora McCreary. Fainy non poteva mai giocare in casa perché papà, un individuo zoppo dal petto incavato e i baffetti biondo-grigi, era guardiano notturno alle manifatture Chadwick e dormiva tutto il giorno. Soltanto intorno alle cinque un ondulato sbuffo di fumo di tabacco filtrava, per la porta della stanza d’ingresso, in cucina. Era questo un segno che papà s’era alzato, tutto arzillo, e presto avrebbe cercato il pranzo. Allora mandavano Fainy di corsa a uno dei due angoli della breve via fangosa di baracche in legno, tutte identiche, dove stavano. Sulla destra c’era un mezzo isolato per arrivare da Finley, dove al banco, tra una foresta di calzoni inzaccherati di fango, Fainy avrebbe dovuto aspettare che tutte le bocche violente e sbraitanti dei grandi venissero turate con birre e whisky. Poi se ne tornava a casa, posando ogni passo con molta cura, e il manico della secchia di birra schiumante gli tagliava la mano. A sinistra c’era un mezzo isolato per arrivare ai commestibili vari di Maginnis, prodotti esteri e nazionali. A Fainy piaceva il negro del cartello “Crema di grano” nella vetrina, la bacheca con dentro varie qualità di salumi, i barili di patate e di cavoli, l’odore dello zucchero bruno, segatura, zenzero, aringa salata, prosciutto, aceto, pane, pepe, lardo. «Una pagnotta di pane, per piacere, mezza libbra di burro e una scatola di tortelli allo zenzero.» Qualche sera, quando mamma non si sentiva bene, Fainy doveva andar più lontano; girato l’angolo oltre Maginnis, giù per Riverside Avenue, dove correva il tram, traverso il ponte rosso sul fiumiciattolo che d’inverno scorreva nero scalzando banchi di neve agghiacciati, giallo schiumoso nei disgeli primaverili, scuro e oleoso nell’estate. Di là dal fiume per tutta la strada fino all’angolo del lungofiume e della
via principale, dov’era la farmacia, vivevano boemi e polacchi. I loro monelli erano sempre in guerra coi monelli dei Murphy, degli O’Hara e degli O’Flanagan, che vivevano in Orchard Street. Fainy camminava con le ginocchia tremanti, la bottiglietta della medicina, nella sua carta bianca, serrata nella mano coperta dal mezzoguanto. All’angolo di Quince c’era un gruppo di ragazzi a cui bisognava passar davanti. Passare non era tanto brutto: era dopo venti passi che la prima palla di neve gli fischiava alle orecchie. Non era possibile andare indietro. Se si metteva a correre, gli davano la caccia. Se lasciava cadere la bottiglia della medicina, le prendeva poi, giunto a casa. Gliene piombava una molle sulla testa da dietro e la neve si metteva a sgocciolargli giù per la schiena. Quando era a un mezzo isolato dal ponte, affrontava il rischio e correva. «Gatto che scappa… Straccione irlandese… Gambestorte Murphy… Corre a casa per dirlo alla guardia…» schiamazzavano i monelli polacchi e boemi tra una palla e l’altra. Le indurivano versandoci sopra dell’acqua e lasciandole gelare nottetempo; se una di queste lo coglieva, faceva uscire il sangue. Il cortile era il solo luogo dove si poteva veramente sentirsi al sicuro giocando. C’erano palizzate in rovina, immondezzai ammaccati, vecchie pentole e padelle troppo simili a setacci per potersi ancora riparare, una stia vuota che sotto aveva ancora piume e fatte, erba porcina d’estate, melma d’inverno; ma la meraviglia del cortile McCreary, era la conigliera dove Tony Harriman allevava lepri del Belgio. Tony Harriman era tisico e viveva con la madre al pianterreno di sinistra. Aveva pure intenzione di allevare ogni specie di altre bestiole, tassi, lontre e persino volpi argentate, e in quel modo sarebbe diventato ricco. Il giorno ch’egli morì, nessuno riuscì a trovare la chiave del catenaccio che chiudeva la porta della conigliera. Fainy nutrì per diversi giorni le lepri cacciando foglie di cavolo e di lattuga attraverso il duplice spessore della griglia. Poi venne una settimana di nevischio e pioggia che lui non uscì più nel cortile. La prima giornata bella, quando andò a vedere, una delle lepri era morta. Fainy si sbiancò in faccia; cercò di dirsi che la lepre dormiva, ma quella stava distesa con goffa rigidità, non addormentata. Le altre erano
raggruppate in un angolo dando in giro occhiate, coi musi agitati e tremanti, e le grosse orecchie penzoloni abbandonate sulle schiene. Povere lepri, Fainy aveva voglia di piangere. Corse per le scale della cucina, dove stava la mamma, si chinò sotto l’asse da stiro e prese il martello dal cassetto del tavolo da cucina. Al primo tentativo che fece si schiacciò un dito, ma la seconda volta riuscì a far saltare il catenaccio. Dentro la gabbia c’era un bizzarro odor acido. Fainy raccolse per le orecchie la lepre morta. Il morbido ventre bianco cominciava a gonfiarsi, uno degli occhi morti era aperto paurosamente. Qualcosa, di botto, afferrò Fainy e gli fece gettare la lepre nel più vicino immondezzaio e correre su per la scala. Ancora freddo e tremante, uscì in punta di piedi nel portico dietro la casa e guardò giù. Tenendo il fiato osservò le altre lepri. A cauti balzelloni si avvicinavano alla porta della conigliera nel cortile. Una era uscita. Sedeva sulle gambe posteriori, le orecchie flosce improvvisamente drizzate. Mamma chiamò Fainy che le portasse un ferro da stiro che era sulla stufa. Quando ritornò al portico, le lepri erano sparite tutte. Quell’inverno ci fu uno sciopero alle manifatture Chadwick e papà perse il posto. Stava tutto il giorno a sedere nell’entrata, fumando e sacramentando: «Uomo in gamba, Cristo, le do a chiunque di questi dannati polacchi, con la gruccia legata dietro la schiena… dico così al signor Barry; non voglio entrare in nessuno sciopero, signor Barry, sono un uomo tranquillo che capisce le cose, un pezzo d’invalido, con donna e marmocchi a cui pensare… otto anni sono stato guardiano e adesso mi date una pedata per assumere una squadra di malviventi, poliziotti d’agenzia. Quel lurido nasopiatto figlio d’una vacca.» «Se quei maledetti pidocchiosi di forestieri non avessero lasciato il lavoro» s’intrometteva qualcuno per calmarlo. Lo sciopero non era popolare in Orchard Street. Significava che mamma doveva lavorare sempre di più, facendo caldaie di bucato sempre più grosse, e che Fainy e la sorella più alta, Milly, dovevano aiutarla, quando tornavano da scuola. Poi un giorno mamma ammalò e dovette rimettersi a letto invece di cominciar a stirare e stava stesa con il viso bianco, tondo e logoro, più bianco del guanciale, e le mani,
logore dall’acqua, strette a nodo sotto il mento. Vennero il dottore e l’infermiera del quartiere, e tutte le tre stanze dell’alloggio sapevano di dottori, infermiere e medicine e il solo posto dove Fainy e Milly trovavano da sedersi era sulle scale. Sedevano là e piangevano cheti insieme. Poi il viso di mamma sul guanciale si raggrinzò in una piccola cosa bianca logora come un fazzoletto spiegazzato in una mano e dissero che era morta e la portarono via. Il funerale partiva dai locali dell’agenzia, in Riverside Avenue, l’isolato seguente. Fainy si sentiva molto fiero e importante perché tutti lo baciavano e gli battevano sulla testa e dicevano che si comportava da ometto. Aveva anche un abito nero nuovo, come un abito da grande, con tasche e tutto, tranne che i calzoni erano corti. C’era ogni specie di gente nei locali dell’agenzia, gente che non aveva ancor mai visto da vicino: il signor Russell, il macellaio, e padre O’Donnell e lo zio Tim O’Hara, che era venuto da Chicago, e si sentiva odor di whisky e di birra come da Finley. Zio Tim era un uomo magro con una faccia rossa protuberante e occhi celesti annebbiati. Portava una cravatta di seta nera aperta, che era l’afflizione di Fainy, continuamente si curvava d’improvviso, piegandosi sulla cintola quasi stesse per chiudersi come un coltello a serramanico e bisbigliava con una voce spessa nell’orecchio di Fainy. «Non fargli attenzione, amico, sono una squadra di lazzaroni e ipocriti, pieni quasi tutti fino al gozzo… Guarda padre O’Donnell, grasso come un maiale, che fa già il conto della tariffa di sepoltura… ma non fargli attenzione, ricordati che sei un O’Hara, da parte di madre. Io non li guardo neanche, amico, ed era mia sorella per nascita e per sangue.» Quando tornarono a casa, Fainy aveva un sonno terribile e i piedi freddi e umidi. Nessuno si prese di lui la minima cura. Sedette piagnucolando sulla sponda del letto, nel buio. Nell’entrata si sentivano voci e un rumore di coltelli e di forchette, ma lui con osava andarci. Si raggomitolò contro la parete e si addormentò. Lo risvegliò una luce negli occhi. Zio Tim e papà gli stavano ritti innanzi e parlavano a voce alta. Avevano un’aria stramba e non sembravano molto in gambe. Zio Tim reggeva la lampada.
«Be’, Fainy, amico mio» diceva zio Tim, dando alla lampada un pericoloso rollio sopra la testa di Fainy. «Fenian O’Hara McCreary, sedetevi e state a sentire e diteci che cosa pensate della nostra intenzione di traslocare nella grande e ognora crescente città di Chicago. Middletown è un orribile buco, se volete saperlo… Senza offesa, John… Ma Chicago… Dio del Cielo, amico, quando tu arrivi là ti sembra di essere stato morto e inchiodato nella cassa, tutti questi anni.» Fainy aveva paura. Si trasse le ginocchia al mento e fissò con un tremito le due grosse figure vacillanti di uomini nella luce vacillante della lampada. Tentò di parlare, ma le parole gli si seccarono sulle labbra. «Dorme il ragazzo, Tim, con tutta la tua ’loquenzia… Spogliati, Fainy, e va’ a letto e fa’ una bella dormita. Domani mattina partiamo.» E tardi, in un mattino piovoso, senza aver fatto colazione, con un gran baule vecchio tondo in cima, legato a funi, traballante pericolosamente sul tetto della carrozza che Fainy era stato mandato a ordinare alla rimessa Hodgeson, partirono. Milly piangeva. Papà non diceva nulla, ma masticava una pipa spenta. Zio Tim faceva tutto lui, dicendo continuamente freddure che non facevano rider nessuno, tirando fuori di tasca in tutte le circostanze un rotolo di biglietti o dando gran sorsate gorgoglianti alla fiaschetta che teneva in tasca. Milly continuava a piangere. Fen guardava con grossi occhi asciutti le vie familiari, tutte a un tratto stranite e squilibrate, che scomparivano dietro la carrozza; il ponte rosso; le case con i tetti di legno ammuffiti dove vivevano i polacchi; la farmacia d’angolo Smith e Smith… ecco Billy Hogan che usciva allora con un pacchetto di chewing gum tra le mani. Di nuovo marinava la scuola. Fainy ebbe voglia di dargli una voce, ma qualcosa gliela gelò… La via principale con gli olmi e i tram; gli isolati dei negozi, girato l’angolo della chiesa, e poi il reparto dei pompieri. Fainy guardò per l’ultima volta la buia caverna dove luccicavano fascinosamente le curve in ottone e rame della macchina, poi passò davanti alle facciate coperte di affissi della prima chiesa congregazionalista, della chiesa battista del Carmelo, della chiesa episcopale di Sant’Andrea, costruita in mattoni e sita di sbieco sul suo
appezzamento, invece che per dritto, con una facciata austera alla via come le altre chiese; poi i tre cervi in ferro battuto sul praticello davanti alla casa commerciale, e le ville, ciascuna col suo praticello, ciascuna con la sua veranda e graticciata, ciascuna col suo cespuglio d’idrangea. Poi le case impicciolirono e scomparvero i praticelli; la carrozza continuò a rotolare oltre i magazzini grano e foraggio Simpson, lungo una filza di botteghe di barbieri, liquorerie e trattorie, e scesero finalmente alla stazione. Al banco della trattoria nella stazione, zio Tim li fece mangiare tutti. Asciugò le lacrime di Milly, soffiò a Fainy il naso in un grosso fazzoletto nuovo che aveva ancora il cartellino su una cocca e li impegnò intorno al lardo, alle uova e al caffè. Fainy non aveva mai preso il caffè prima d’allora e così l’idea di esser seduto come un uomo a prendere il caffè gli dava una certa soddisfazione. A Milly il proprio non piaceva, diceva che era amaro. Li lasciarono soli nella trattoria per qualche tempo insieme ai piatti vuoti e alle tazze vuote, sotto gli occhi piccini di una donna dal collo lungo e dalla faccia a punta come una gallina, che da dietro il banco fissava tutt’e due con aria di disapprovazione. Poi, con un enorme strepitoso rimbombo, ciacpuff, ciac… puff, il treno entrò nella stazione. Furono spazzati su e trascinati per la banchina e attraverso un carrozzone fumoso di pipa e, prima che se ne accorgessero, il treno s’era mosso e il rossastro paesaggio invernale del Connecticut sbatacchiava al finestrino.
Occhio fotografico (2) filiamo rollando come in una barca nella muffita vettura a quattro ruote che sa di stalla Continuava a dire Che cosa fareste Lucy se ne invitassi uno alla mia tavola? Sono gente molto amabile Lucy le persone di colore e aveva chiodi di garofano in una scatoletta d’argento e odore di whisky di segala nell’alito e correva a prendere il treno per New York e lei diceva Oh poverino spero che non faremo tardi e Scott attendeva coi biglietti e dovemmo correre sulla banchina della stazione della Settima Strada e tutti quei cannoncini continuavano a cadere dall’Olympia e tutti si chinavano a raccoglierli e il capotreno Tuttincarrozza signora presto signora erano cannoncini d’ottone lucenti al sole sulla banchina della stazione della Settima Strada e Scott ci spinse su tutti e il treno si moveva e la campana della locomotiva squillava e lui tese una manciata di cannoncini d’ottone minuti grossi quanto basta per contenere il più piccolo petardo rosso alla battaglia della Manila Bay e Scott disse Ecco l’artiglieria Jack e lui continuava nella vettura salone ma sì Lucy se fosse necessario per la causa dell’umanità uscirei anch’io e mi farei uccidere quando capitasse e tu Jack anche tu? e voi facchino? che portava apollinaris e lui aveva una fiaschetta nella valigia dove i fazzoletti di seta con le iniziali sapevano sempre di lozione aromatica e quando arrivammo a Havre de Grace lui disse Ricordati Lucy si doveva pigliare la chiatta attraverso il Susquehanna prima che costruissero il ponte e anche attraverso il Gundpowder Creek
Mac Colline rossastre, pezzi di boschi, cascine, mucche, un puledro rosso che stava a far niente in un prato, steccati, strisce di stagni. «Ebbene, Tim, mi sento come un cane bastonato… Finora nella mia vita, Tim, ho cercato di agir sempre come si deve» continuava a ripetere papà con una voce raganellante. «E adesso che cosa diranno di me?» «Dio del Cielo, omo, non c’era altro modo, no? Cosa diavolo puoi fare se denaro non ne hai e lavoro nemmeno e un mucchio di dottori e di becchini e di padroni di casa ti arrivano addosso con le note e tu hai due bambini da mantenere?» «Ma io ero un uomo pacifico e onorato, fermo e disgraziato fin da quando mi sposai e misi su casa. E adesso che cosa penseranno di me, scappato via come un cane bastonato?» «John, sta’ sicuro che sarei io l’ultimo a mancar di rispetto alla morta, che fu mia sorella di nascita e di sangue… Ma non è colpa tua e neanche mia… è colpa della miseria e la miseria è colpa del sistema… Fenian, ascolta Tim O’Hara un momento e anche tu, Milly, ascolta, perché una ragazza deve saperle queste cose come un uomo e per una volta tanto Tim O’Hara dice la verità… È colpa del sistema che non dà a ciascuno il frutto della sua fatica… Il solo che guadagna qualcosa dal capitalismo è chi truffa e arriva a farsi milionario in poco tempo. Ma un lavoratore onesto come John o come me, possiamo anche lavorare cent’anni e non lasciare abbastanza da pagarci una sepoltura decente.» Il fumo turbinava bianco davanti al finestrino squassando di tra le sue spire alberi, pali telegrafici, casette quadrate dal tetto d’assicelle, cittadine, tram e lunghe file di carrozzelle con cavalli fumanti allineati. «E chi si mangia il frutto della nostra fatica? i dannati uomini d’affari, gli agenti, gli intermediari che non hanno mai fatto tanto così di lavoro produttivo in tutta la vita.» Gli occhi di Fainy seguono i fili del telegrafo che si abbassano e s’innalzano. «Neanche a Chicago è il paradiso, puoi star sicuro, John, ma al giorno d’oggi è un mercato meglio dell’Est per il braccio e il cervello
del lavoratore… Perché, hai chiesto perché? La domanda e l’offerta: han bisogno di mano d’opera a Chicago.» «Tim, ti dico che mi sento come un cane bastonato.» «È il sistema, John, è questo lurido dannato sistema.» Un gran trambusto nel vagone svegliò Fainy. Era buio. Milly piangeva di nuovo. Fainy non sapeva dove fossero. «Signori» diceva zio Tim «stiamo per arrivare nell’antica cittadina di New York.» Nella stazione c’era chiaro; ciò sorprese Fainy che credeva fosse già notte. Lui e Milly vennero lasciati per un bel pezzo a sedere su una valigia nella sala d’aspetto. La sala d’aspetto era immensa e piena di gente mai vista, che faceva paura come la gente nei libri illustrati. Milly continuava a piangere. «Ehi Milly, te ne lascio andar uno se non la smetti di piangere.» «Perché?» gemette Milly, piangendo ancor di più. Fainy si teneva il più possibile lontano da lei perché la gente non credesse che fossero insieme. Quando stette per piangere anche lui, papà e zio Tim arrivarono e portarono loro e la valigia nel ristorante. Avevano un forte odore di whisky recente nel fiato e parevano molto lucidi agli occhi. Sedettero tutti a un tavolino dalla tovaglia candida e un cortese negro in abito bianco porse loro un grande cartoncino tutto stampato. «Mangiamoci un bel pranzo,» disse zio Tim «fosse anche l’ultima cosa che facciamo in questo mondo.» «Maledetta la spesa,» disse papà «è il sistema che ha la colpa.» «Al diavolo il papa» disse zio Tim. «Faremo ancora di te un socialdemocratico.» Diedero a Fainy ostriche fritte, pollo, gelato e dolce; e quando dovettero correre tutti al treno, Fainy aveva una fitta terribile al fianco. Si cacciarono in una carrozza che sapeva di gas da bruciare e di ascelle. «Quando andremo a letto?» cominciò a piagnucolare Milly. «Non andiamo a letto» disse zio Tim vispo. «Dormiremo qui come tanti topolini… come topolini nel formaggio.» «Non li voglio io i topi» strillò Milly con un nuovo profluvio di lacrime, mentre il treno s’incamminava.
Gli occhi di Fainy bruciavano; nelle orecchie aveva il rombo continuato, lo sbatacchio sugli incroci, il ruggito improvviso sotto i ponti. Era una galleria: tutta la strada fino a Chicago era una galleria. Di fronte a lui, le facce di papà e di zio Tim erano rosse e cagnesche, non gli piaceva l’aria che avevano, e la luce era fumosa e agitata e fuori era tutta una galleria e gli occhi gli facevano male, ruote e rotaie gli rombavano dentro le orecchie e s’addormentò. Quando si svegliò c’era una città e il treno correva dritto per la via principale. Era un mattino di sole. Si vedevano persone girare per i loro affari, negozi, carrozze e carrettini fermi ai marciapiedi, strilloni che vendevano giornali, indiani in legno fuori delle tabaccherie. Dapprima Fainy credé di sognare, ma poi ricordò e decise che doveva essere Chicago. Papà e zio Tim dormivano sul sedile di fronte. Tenevano la bocca aperta, con grosse chiazze sulla faccia e non gli piaceva l’aria che avevano. Milly era raggomitolata con tutt’intorno uno scialle di lana. Il treno rallentava, era una stazione. Se era Chicago, dovevano scendere. In quel momento passò il controllore, un vecchio che somigliava un poco a padre O’Donnell. «Per piacere, signore, è questa Chicago?» «Chicago è ancora ben lontana, figliuolo» disse il controllore senza sorridere. «Questa è Syracuse.» E si svegliarono tutti, e per ore e ore i pali del telegrafo passarono: cittadine, case in legno, fabbriche in mattoni con file su file di finestre luccicanti, mucchi di rifiuti, rimesse di treni, terra arata, pascoli e mucche e a Milly venne il mal del treno e a Fainy pareva che gli si dovessero staccare le gambe, tanto era stato seduto; in un luogo nevicava, in un altro faceva sole, e Milly continuava a star male e puzzava tremendamente di vomito, e venne buio e tutti dormirono; e di nuovo chiaro e allora le cittadine, le case in legno e le fabbriche cominciarono a raccogliersi, ammucchiandosi in magazzini e grue, e le rimesse dei treni si distesero quanto l’occhio spaziava ed era Chicago. Ma faceva tanto freddo e il vento gli cacciava tanto forte la polvere in faccia e gli occhi li aveva talmente incollati dalla polvere e dalla stanchezza che non poté guardar niente. Dopo che ebbero atteso un bel po’, Milly e Fainy, raggomitolati insieme nel freddo, salirono su un
tram e viaggiarono. Avevano tanto sonno che non seppero mai bene dov’era finito il treno e dov’era cominciato il tram. La voce di zio Tim non finiva più di parlare con fierezza e animazione di Chicago, Chicago, Chicago. Papà sedeva col mento sulla gruccia. «Tim, mi sento come un cane bastonato.» Fainy visse dieci anni a Chicago. In principio andò a scuola e giocò al baseball negli spiazzi dietro le case il sabato pomeriggio, ma poi venne l’ultima premiazione e tutti i ragazzi cantarono My Country, ’Tis of Thee e la scuola era finita e Fainy dovette mettersi a lavorare. Lo zio Tim aveva a quel tempo una tipografia in una viuzza polverosa all’altezza del North Clark al pianterreno di un antico e sconnesso edificio in mattoni. La bottega occupava una piccola parte dell’edificio che era adibito essenzialmente a magazzino e andava famoso per i topi. Aveva una semplice finestra con una grossa lastra di vetro, resa risplendente da caratteri gotici in oro: TIMOTHY O’HARA, TIPOGRAFO. «E ora, Fainy, amico,» disse zio Tim «avrai occasione di imparare il mestiere cominciando dalla gavetta.» E così Fainy fece commissioni, recapitò pacchi di circolari, manifestini e cartelloni; era sempre a schivare tram, a scivolar da sotto il morso schiumoso dei grossi cavalli da tiro, a scroccar corse sui carretti dei negozianti. Quando non c’erano commissioni da fare, scopava sotto le macchine, nettava i caratteri, vuotava il cestino dei rifiuti dell’ufficio, oppure, nei giorni di gran lavoro, correva all’angolo a prender caffè e panini imbottiti per il compositore o una fiaschetta di bourbon per zio Tim. Papà girò arrancando sulla gruccia per diversi anni, sempre in cerca di un posto. La sera fumava la pipa e malediceva la fortuna, sul pianerottolo posteriore della casa di zio Tim, e ogni tanto minacciava di ritornare a Middletown. Poi un giorno prese la polmonite e morì pacificamente all’ospedale del Sacro Cuore. Ciò avvenne quasi negli stessi giorni che zio Tim comprò una linotype. Zio Tim era così agitato che non bevette un sorso in tre giorni. Le tavole del pavimento erano talmente fradice che bisognò costruire per la linotype un basamento in mattoni fin dalla cantina. «Be’, quando ne prenderemo un’altra, cementeremo dappertutto qui» disse a tutti zio
Tim. Per un giorno intero nessuno fece nulla. Tutti stavano d’attorno a guardare l’alta e intricata macchina nera che si drizzava là come un organo in chiesa. Quando la macchina funzionò e la tipografia si empì dell’odore caldo del metallo fuso, gli occhi di tutti seguirono il sensitivo braccio indagatore che scattava e si fletteva sulla tastiera. Quando si fecero girare di mano in mano i tiepidi piombi lucidi dei caratteri, il vecchio compositore tedesco, per qualche ragione detto in bottega Mike, si spinse gli occhiali sulla fronte ed esclamò: «Cinquantacinque anni a stampare e adesso che son vecchio dovrò portare le tinozze per vivere». La prima cosa che zio Tim compose sulla nuova macchina fu la frase: Lavoratori di tutto il mondo, unitevi: non avete altro da perdere che le catene. Quando Fainy ebbe diciassette anni e cominciava a preoccuparsi di gonnelle, di caviglie e di biancheria intima delle ragazze, la sera quando tornava a casa dal lavoro e vedeva le luci della città luminose contro il cielo occidentale luminoso e inebriante, ci fu uno sciopero tra i tipografi di Chicago. Tim O’Hara aveva sempre avuto la bottega unionista 1 e faceva lui a prezzo di costo tutti gli stampati della società. Preparò persino un programmetto firmato “Un cittadino”, titolo “Una viva protesta” che Fainy ebbe il permesso di comporre sulla linotype una sera, dopo che il linotipista era andato a casa. Una frase si piantò in mente a Fainy e la ripeteva a se stesso quella notte, dopo che fu a letto: È tempo che tutti gli uomini onesti si radunino per resistere ai guasti del privilegio ingordo. Il giorno dopo era domenica e Fainy andò per Michigan Avenue con un fascio di quei manifestini da distribuire. Era una giornata di prematura primavera. Sopra il ghiaccio giallo e putrido del lago giungevano brezzoline che sapevano all’improvviso di fiori. Le ragazze eran tutte terribilmente carine e le gonnelle svolazzavano al vento e Fainy sentiva il sangue primaverile pulsargli dentro ardente, aveva voglia di dar baci e rotolarsi per terra e scorrazzare sui banchi di ghiaccio e far discorsi dall’alto dei pali telegrafici e volteggiare al disopra dei tram; e invece distribuiva manifestini e si preoccupava dei calzoni ragnati e avrebbe voluto possedere un abito bello e una bella
ragazza da portare a passeggio. «Ehi, giovanotto, dov’è il permesso di dar via quei manifesti?» Era la voce di una guardia, ringhiosa al suo orecchio. Fainy diede alla guardia un’occhiata al disopra della spalla, lasciò cadere i manifestini e corse via. Si cacciò tra il nero lucido delle vetture e delle carrozze, corse giù per una viuzza e andò andò, senza guardarsi mai indietro, finché non si fu messo oltre un ponte, giusto un attimo prima che questo s’aprisse. Ad ogni modo la guardia non lo inseguiva. Rimase un bel pezzo sullo scalino del marciapiede, e il fischio di un venditore di pistacchi gli echeggiava beffardo all’orecchio. Quella notte a cena lo zio gli chiese notizie dei manifestini. «Li ho dati via tutti in riva al lago… Una guardia ha cercato di fermarmi, ma gli ho detto dove andarsi a sbattere.» Fainy divenne rosso di fuoco, quando tutta la tavola gli fece un’urlata. Si riempì la bocca di purea di patate e non rispose più. La zia e lo zio e le loro tre figlie ridevano tutti, pazzamente. «Be’, meno male che sei corso più in fretta della guardia» disse zio Tim «altrimenti avrei dovuto farti uscire e ci sarebbero voluti soldi.» Il mattino dopo, di buon’ora, Fainy stava scopando l’ufficio quando un tale, con una faccia che pareva un pezzo di carne cruda, salì gli scalini; e fumava un sigaro nero e sottile di una specie che Fainy non aveva mai veduto prima. Bussò alla porta di vetro smerigliato. «Debbo parlare col signor O’Hara, Timothy O’Hara.» «Non c’è ancora, ma arriverà da un momento all’altro. Se volete aspettarlo…» «Sicuro che lo aspetto.» L’uomo sedette sull’orlo di una sedia e sputò, cavandosi prima di bocca l’estremità masticata del sigaro e osservandola a lungo con un’aria meditabonda. Quando Tim O’Hara giunse, l’uscio dell’ufficio si chiuse con un rimbombo. Fainy s’aggirò intorno trepidante, un po’ impaurito che quell’uomo fosse un poliziotto sulle tracce dell’affare dei manifestini. Le voci scoppiavano e s’abbassavano, quella dello sconosciuto in brevi invettive strepitanti, quella di O’Hara in lunghe tirate di rimostranza; di tanto in tanto Fainy afferrava la parola “protesto”, finché a un tratto l’uscio si
spalancò e lo sconosciuto piombò fuori, con la faccia più rossa che mai. Sulla soglia di ferro si volse e cavando di tasca un nuovo sigaro lo accese dall’altro. Borbottando le parole tra il sigaro e lo sbuffo azzurro di fumo, disse: «Signor O’Hara, avete ventiquattro ore da pensarci su… Una vostra parola e le pratiche cessano immediatamente». Poi uscì nella via lasciandosi dietro una lunga traccia di fumo puzzolente. Un minuto dopo, zio Tim uscì dall’ufficio, con la faccia bianca come un foglio di carta. «Fenian, amico,» disse «vatti a cercare lavoro. Mi ritiro dagli affari… Apri l’occhio. Io vado a bere una volta.» E durò ubriaco sei giorni. Alla fine dei quali, una serie di individui dalla faccia bonaria comparvero con tante citazioni, e zio Tim dovette smaltire la sbornia così da potersi recare in tribunale e inoltrare domanda di fallimento. La signora O’Hara borbottava e smaniava. «Non te lo dicevo, Tim O’Hara, che non sarebbe venuto che male da quelle tue relazioni con quei miscredenti di lavoratori, di socialdemocratici e di cavalieri del lavoro, tutti ubriaconi e fannulloni come te, Tim O’Hara? Eh già che i tipografi grossi si son messi insieme e han comperato le cambiali che avevi in giro e ti hanno schiacciato! e ti starebbe bene anche, Tim O’Hara, a te, barbetto d’un socialista, e alla tua vita di sbornie; solo che avessero pensato alla povera moglie e a queste sventurate figliuole; e adesso faremo tutti la fame, noi e i dipendenti e tutti gli scrocconi che ci hai messi in casa.» «Ah, no!» gridò Milly, la sorella di Fainy «come se io non avessi sgobbato e consumato le dita fino all’osso per ogni pezzo di pane che ho mangiato in questa casa!» e si alzò da tavola dove facevan colazione e se ne uscì dalla stanza dimenandosi. Fainy stette seduto, mentre la tempesta continuava a infierirgli sul capo; poi si alzò, cacciandosi, mentre andava, un panino in tasca. Nell’anticamera trovò la sezione delle offerte d’impiego del «Chicago Tribune», prese il berretto e uscì nell’aspra mattina domenicale piena di scampanii che gli tempestavano discordi nelle orecchie. Salì su un tram e andò al Lincoln Park. Là stette seduto per un bel po’ su una panca masticando il panino e scorrendo le colonne degli avvisi. “Cercasi giovane…” Ma nessuno aveva un’aria molto allettante. Da una cosa era legato: non
avrebbe accettato un altro impiego in una tipografia prima che finisse lo sciopero. Poi l’occhio incontrò Cercasi giovane sveglio ambiz. gusto letter. conoscenza di tipogr. ed editor. Vendite e distrib. facili proposta 15 dollari settim. scrivere P.O. Cassetta 1256b. Di botto a Fainy parve che la testa gli volasse. Giovane sveglio, son io, ambizioso e gusto letterario… Dio, debbo finire Guardando indietro… perdio, mi piace molto leggere e saprei comandare una linotype o comporre se mi lasciassero. Quindici dollari la settimana… una cosa da nulla, dieci dollari d’aumento. E cominciò a scrivere nella sua testa una lettera per chiedere il posto. Egregio signore (Gentilissimo signore) oppure Signori, facendo richiesta del posto che offrite oggi domenica nel «Tribune» io sarei disposto, (mi sia concesso dire) che ho diciassette anni, no, diciannove, con un’esperienza di parecchi anni nella tipografia e nell’editoria, ambizioso e con un’eccellente conoscenza e gusto nel campo della tipografia e dell’editoria, no, non posso dirlo due volte… E sono molto ansioso di ottenere questo posto… Mentre procedeva, la lettera gli si confondeva in testa sempre più. Scoprì che stava fermo vicino a un carretto di pistacchi. Faceva un freddo cane: un vento che pelava strideva attraverso il ghiaccio infranto e le pozze nere d’acqua nel lago. Strappò via l’avviso e abbandonò al vento il resto del giornale. Poi si comperò un pacchetto caldo di pistacchi. 1. Associata alla trade union o sindacato: corpo organizzato per la protezione degli interessi comuni di un mestiere. (NdT)
Cine-giornale II Venite a sentire venite a sentire venite a sentire Nel suo indirizzo alla Legislatura dello Stato di Michigan, il governatore in ritiro, Hazen S. Pingree, disse tra l’altro: Vi predico che se coloro che sono in carica e nelle cui mani riposa il potere legislativo non mutano l’attuale sistema di ineguaglianza, ci sarà una sanguinosa rivoluzione tra meno di un quarto di secolo in questo nostro grande paese. CARNEGIE PARLA DEL SUO EPITAFFIO il ragtime d’Alessandro è il migliore è il migliore la colazione che venne servita nel laboratorio di fisica era traboccante di sorprese. Un altoforno in miniatura, di quattro piedi, stava sul tavolo del banchetto e un binario a scartamento ridotto lungo quaranta piedi correva sull’orlo del tavolo. Invece di metallo fuso l’altoforno versava punch bollente in piccoli vagoni sul binario. Il gelato venne servito in forma di traversine e il pane aveva la forma di locomotive. Il signor Carnegie, esaltando i vantaggi di una superiore educazione in ogni ramo del sapere, venne infine a questa conclusione: Il lavoro manuale si è rivelato il miglior fondamento per i più grandi lavori intellettuali. VICEPRESIDENTE CHE VUOTA UNA BANCA Venite a sentire il ragtime d’Alessandro è il migliore è il migliore il fratello di Jesse James dichiara che la commedia in cui lo si dipinge come bandito svaligiatore di treni e fuorilegge è immorale, una vera battaglia fra distretti termina con la poligamia, che, stando a un’inchiesta di pastori del Lago Salato, è ancor praticata dai mormoni
le donne di un club stupefatte è il miglior ragtime del paese dicono che gli animali di circo mangiano soltanto carne equina di Chicago. La vendita a tasso dei lotti dell’Indiana segna la chiusa dei rialzi della Fiera mondiale adopera una bandiera per borsa da cenci ucciso su un’isola di cannibali guardiano che cade nell’acqua e i leoni marini lo assalgono. La scialuppa venne ad accostarsi al pallone semisgonfio dell’aerostato che minacciava di momento in momento di soffocare Santos Dumont. Questi mezzo venne tirato e mezzo s’inerpicò sopra il parapetto della barca. Il principe di Monaco lo sollecitò a lasciarsi portare a bordo dello yacht per asciugarsi e mutarsi d’abito. Santos Dumont non volle saperne di lasciare la scialuppa finché tutto ciò che si poteva salvare fosse stato portato a terra, poi, bagnato ma sorridente e calmissimo, approdò tra le frenetiche acclamazioni della folla.
Occhio fotografico (3) Ô qu’il a de beaux yeux disse la signora dal sedile opposto ma Lei disse che non si parlava così ai bambini e il ragazzino si sentiva impacciato e sudaticcio ma era il crepuscolo e la lampada in forma di un mezzo popone diventava rosso cupo e il treno rintronava e improvvisamente fui addormentato e fu un buio nero e i pendagli a fiocco turchino lungo il paralume scuro in forma di popone e dappertutto ci sono ricurve ombre a punta (la prima volta che Lui venne portò un popone e il sole entrava per le lunghe tendine di pizzi e quando lo tagliammo l’odor di popone riempì tutta la stanza) No caro non mangiare i semi danno l’appendicite ma si spia fuori del finestrino nella nera oscurità rintronante dove a un tratto si vedono allineati forni appiattati sul terreno e ci si spaventa del fumo nero e degli sbuffi di fiamma che si accendono e svaniscono dai forni appiattati Stoviglie tesoro lavorano tutta la notte Chi lavora tutta la notte? operai e gente così lavoratori, travailleurs, messicani 1 ci si spaventava ma ora il buio era di nuovo tutto nero la lampada nel treno il cielo e ogni cosa aveva addosso un’ombra azzurronera e Lei raccontava una storia di Tantotempofa Primadellafieramondiale Primachetufossinato e loro erano andati nel Messico su una vettura riservata della nuova linea internazionale e gli uomini sparavano all’antilope dal fondo del treno e li chiamavano grossi conigli maschioni e una notte Tantotempofa Primadellafieramondiale Primachetufossinato una notte Mamma si era così spaventata di tutte quelle detonazioni ma non era successo nulla si seppe che non era nulla soltanto un po’ di sparatoria avevano solo sparato a un messicano ecco tutto questo nei tempi antichi 1. Nel testo: greaser, che ha tono ingiurioso. (NdT)
Amante dell’umanità Debs era un ferroviere, nato in una baracca coperta d’assi a Terre Haute. Era uno tra dieci fratelli. Suo padre era venuto in America su un veliero nel ’49, un alsaziano di Colmar; non troppo affarista, appassionato della musica e della lettura, diede modo ai figlioli di finire la scuola pubblica e ciò fu pressoché tutto quel che poté fare. A quindici anni Gene Debs lavorava già da meccanico sulla ferrovia Indianapolis-Terre Haute. Lavorò da fuochista ferroviario, fu commesso in un negozio si associò alla sede locale della confraternita dei Fuochisti ferrovieri, venne eletto segretario, viaggiò per tutto il paese come organizzatore. Era un uomo alto, dal passo strascicato, aveva un genere di oratoria burrascosa che infiammava i lavoratori ferroviari nei saloni di tavole di pino dava loro il desiderio del mondo che anche lui desiderava, un mondo in mano di fratelli dove tutti avrebbero fatto le parti uguali: Io non sono un capopartito di lavoratori. Io non voglio che voi seguiate me o chiunque altro. Se voi sperate in un Mosè che vi conduca fuori del deserto capitalista, resterete lì dove siete. Neanche se potessi, io vi guiderei in questa terra promessa, perché, se io vi potessi condurre dentro, qualcun altro ve ne condurrebbe fuori. Così parlava a facchini e guardiani di linea, a fuochisti, manovratori e macchinisti, dicendo loro che non bastava organizzare i ferrovieri, che tutti i lavoratori dovevano organizzarsi nella repubblica cooperativa dei lavoratori. Fuochista ferroviario in tanti lunghi servizi notturni, sotto il fumo un fuoco lo ardeva, ardeva nelle parole burrascose che scoppiavano nei saloni di tavole di pino; lui voleva che i suoi
fratelli fossero uomini liberi. Questo fu ciò che vide nella folla che lo venne a incontrare alla stazione di Old Wells Street quando uscì di prigione dopo lo sciopero Pullman, furon quelli gli uomini che gli misero insieme nel millenovecentododici 900.000 voti e impaurirono gli abiti da cerimonia, i cappelli a cilindro e le ingioiellate padrone di casa di Saratoga Springs, Bar Harbor, Lake Geneva col babàu di un presidente socialista. Dove erano i fratelli di Gene Debs quando nel millenovecentodiciotto Woodrow Wilson lo fece rinchiudere ad Atlanta perché parlava contro la guerra, dove erano gli omaccioni ghiotti di whisky e ghiotti l’uno dell’altro, cari girovaghi raccontatori di storie su un banco di osteria nelle cittadine del Middle West, quei tipi pacifici che volevano una casa col portico per farci flanella e una moglie grassa a far la cucina, qualcosa da bere e sigari, un giardino da vangarci, qualche vecchio amico da far quattro ciance e volevano lavorare per aver tutto questo e che anche gli altri lavorassero per averlo; dov’erano i fuochisti e i macchinisti ferrovieri quando lo impacchettarono a spintoni per il penitenziario di Atlanta? E lo riportarono a morire a Terre Haute a sedere nel portico su una sedia a dondolo con un sigaro in bocca, accanto a lui rose American Beauty che la moglie gli aggiustava in un vaso; e la gente di Terre Haute e la gente dell’Indiana e la gente del Middle West gli volevano bene e ne avevano paura e lo immaginavano come un bravo vecchio zio che li amava, e desideravano stargli insieme e ricevere da lui canditi, ma ne avevano paura come se avesse contratto una malattia sociale, la sifilide o la lebbra, e ciò facesse loro troppo dispiacere; ma per via della bandiera e della prosperità e rendere il mondo sicuro per la democrazia,
temevano di stargli insieme, o di pensare troppo a lui per timore di giungere a dargli ragione; perché lui diceva: Finché c’è una classe inferiore io vi appartengo, finché c’è una classe criminale io vi appartengo, finché c’è un’anima in prigione io non sono libero.
Occhio fotografico (4) si torna indietro nella pioggia sulla carrozza strepitante fissando le loro due facce alla luce traballante della vettura a quattro ruote e le grosse valigie di Lei rimbombano sul soffitto e Lui recita Otello con la sua voce d’avvocato M’amava il padre, spesso m’invitava, mi chiedeva la storia di mia vita di anno in anno, le guerre, le avventure del passato. Io raccontavo tutto, dall’infanzia fino all’istante che mi comandava; e parlavo dei casi più terribili, di sventure pietose in mare e in terra, di miracoli e scampi dalla morte imminente. ecco quello è lo Schuylkill gli zoccoli del cavallo risuonano secchi sul liscio asfalto bagnato dopo i ciottoli attraverso le strisce grigie di pioggia il fiume appare rossastro dal fango invernale quando avevo la tua età Jack mi tuffai da questo ponte traverso la ringhiera del ponte possiamo guardare giù nell’acqua fredda increspata di pioggia Avevi vestiti indosso? Soltanto la camicia
Mac Fainy era in piedi vicino alla porta dell’aerea zeppa di gente; contro la schiena del grassone che davanti a lui si teneva al tirante, continuava a rileggere le parole su un fragile foglio di carta da lettere, bagnato d’acqua. La Compagnia letteraria Ricerca e diffusione Verità, Inc. Uffici generali 1104 S. Hamlin Avenue Chicago, Ill., 14 aprile 1904 Fenian O’H. McCreary 456 North Wood Street Chicago, Ill. Egregio signore, abbiamo ricevuto la vostra graditissima del 10 c.m. Riguardo la faccenda in questione, crediamo che molto ci sarebbe di guadagnato in un’intervista personale. Se vorrete esser così gentile da fare un passo all’indirizzo suddetto lunedì 16 alle nove, crediamo che potremo vagliare a fondo le vostre attitudini per la posizione che v’interessa. Vostro, nella ricerca della Verità, Emmanuel R. Bingham, dott. in Teologia Fainy era impaurito. Il treno giunse troppo presto alla sua stazione. Aveva quindici minuti per percorrere due isolati. Bighellonò per la via, guardando nelle vetrine dei negozi. C’era impagliato in quella di un imbalsamatore un fagiano dorato, e, sopra, era appeso un gran pesce piatto e verdiccio munito di un becco coi denti a sega, dal quale penzolava un cartellino: PESCE SEGA (pristis perotteti) Abita il golfo e le acque della Florida. Abbonda nelle insenature basse e nei bracci di mare. Magari non sarebbe andato affatto. In fondo alla vetrina c’era una lince e dall’altra parte un gatto dalla coda corta, ciascuno sul suo frammento d’albero. D’un tratto gli si tagliò il respiro. Avrebbe fatto tardi. Si precipitò a furia giù per l’isolato.
Era senza fiato e il cuore gli rimbombava peggio dei tram, quando fu in cima ai quattro piani di scale. Esaminò gli usci, in vetro smerigliato, del pianerottolo: COMPAGNIA UNIVERSALE CONTATTI F.W. Perkins Assicurazioni COMPAGNIA MAGICA NOVITÀ CITTÀ DEL VENTO dott. Noble Articoli per ospedali e camere malati L’ultimo era un uscio sporco, in fondo, vicino al gabinetto. Era caduta l’indoratura dalle lettere, ma Fainy riuscì a decifrare dai contorni SOCIETÀ GENERALE EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI Poi vide un biglietto sulla parete accanto all’uscio, con disegnata una mano che reggeva una torcia e sotto le parole: “Ricerca Verità Inc.”. Tamburellò cautamente sul vetro. Nessuna risposta. Tamburellò ancora. «Avanti… Non bussate» esclamò una voce profonda. Fainy si accorse di balbettare mentre apriva l’uscio ed entrava in una stanza angusta e scura, interamente riempita da due grosse scrivanie a saracinesca. «Scusate, vengo a cercare il signor Bingham, signore.» Alla scrivania estrema, in faccia all’unica finestra, sedeva un omone con una gran mascella pendente che gli dava un po’ l’espressione di un cane da ferma. Aveva i capelli neri lunghi e un tantino ricci sulle orecchie, e in capo, buttato indietro, teneva un largo cappello nero, di feltro. Si appoggiò allo schienale della sedia e guardò Fainy, da capo a piedi. «Buon giorno, giovanotto. Che genere di libri avete idea di acquistare stamattina? Che cosa posso fare per voi stamattina?» esclamò. «Siete il signor Bingham, signore, scusate?» «È il dottor Bingham che vi sta innanzi.» «Scusate, signore, io… sono venuto per quel posto.» L’espressione del dottor Bingham mutò. Storse la bocca come se
avesse allora assaggiato qualcosa d’acido. Fece un giro sulla sedia e sputò in una sputacchiera d’ottone nell’angolo della stanza. Poi tornò a volgersi a Fainy e tese verso di lui un dito grassoccio. «Giovanotto, come la scrivete la parola esiliare?» «E… s… i… g… l… i…» «Basta così… Non avete istruzione… Lo pensavo… Non avete cultura, nessuno di quei sentimenti più elevati che distinguono l’uomo civilizzato dal selvaggio aborigeno delle foreste… Non avete entusiasmo per la verità, per la missione di portar la luce nei luoghi di tenebra… Lo capite, giovanotto, che non è un impiego quello che io vi offro, ma una grande occasione… una splendida occasione di rendervi utile e migliorarvi. Io vi offro gratis un’educazione.» Fainy mosse i piedi. Aveva un impedimento in gola. «Se è nel ramo tipografico, credo di saperlo bene.» «Bene, giovanotto, durante il breve interrogatorio che ora vi farò, ricordatevi che siete sulla soglia della fortuna.» Il dottor Bingham frugò a lungo nelle caselle della sua scrivania, si trovò un sigaro, ne morse via la punta, l’accese e poi tornò a volgersi a Fainy che stava dritto, un po’ su un piede e un po’ sull’altro. «Dunque, se volete dirmi come vi chiamate…» «Fenian O’Hara McCreary…» «Uhm… scozzese e irlandese… è una buona razza… anch’io vengo di là. Religione?» Fen disse a disagio: «Papà era cattolico ma…». Divenne rosso. Il dottor Bingham rise e si fregò le mani. «O Religione quanti delitti si commettono in tuo nome! Io, come io, sono agnostico… non m’importa la classe o la confessione quando sono con amici; benché qualche volta, ragazzo mio, occorra piegarsi col vento… Nossignore, il mio Dio è la verità, che levandosi sempre più alto nelle mani degli onesti dissiperà le nebbie dell’ignoranza e dell’ingordigia e largirà la libertà e la saggezza agli uomini… Siete d’accordo con me?» «Ho lavorato per mio zio. È un socialdemocratico.» «Ah, un giovane entusiasta… Sapete guidare un biroccino?» «Sì, signore, credo bene.»
«Be’, non vedo perché non dovrei prendervi.» «L’avviso nel “Tribune” parlava di quindici dollari la settimana.» La voce del dottor Bingham assunse un particolare tono vellutato. «Ma, Fenian, ragazzo mio, quindici dollari alla settimana sarà il minimo che voi guadagnerete… Non avete mai sentito del sistema cooperativo? È così che voglio impiegarvi… Come proprietario e rappresentante unico della Associazione per la ricerca della verità io ho qui una magnifica partita di libretti e di opuscoli abbraccianti ogni ramo della scienza e delle ricerche umane… Mi accingo proprio ora a una campagna di vendita, che dovrà estendersi in tutto il paese. Voi sarete uno dei miei distributori. I libri vengono da dieci a cinquanta cents. Su ogni libro di dieci cents voi guadagnate un cent, su quelli da cinquanta ne guadagnate cinque.» «E alla settimana non avrò nulla?» balbettò Fainy. «Vorrete rischiare il molto per il poco? Buttar via l’occasione più splendida di tutta una vita per la certezza di un vile sostentamento? No, io lo vedo dal vostro occhio fiammeggiante, dal vostro nome ribelle, illustre nella storia dell’antica Irlanda, che voi siete un giovane di spirito e di volontà… Intesi? Datemi la mano allora e perbacco, Fenian, non avrete da pentirvene mai.» Il dottor Bingham balzò in piedi, afferrò la mano di Fainy e gliela strinse. «Adesso, Fenian, venite con me, abbiamo da compiere una operazione preliminare molto importante.» Il dottor Bingham si calcò il cappello avanti sulla testa e scesero per le scale al portone d’entrata: era un omone e il grasso gli pendeva abbondantemente addosso, mentre camminava. Be’, è sempre un posto, si disse Fainy. Andarono prima in una sartoria dove un tale giallo, dal naso lungo, che il dottor Bingham chiamava Lee, venne loro incontro strascicando i piedi. La sartoria sapeva di vapori di panno e di lozione smacchiatrice. Lee parlava come se non avesse in bocca il palato. «Son ben malato» disse. «Ho speso più di mille dollari in dottori e non sto bene.» «Be’, noi non vi abbandoniamo, lo sapete, Lee.» «Certo, Mannie, certo, soltanto che mi dovete troppi denari.»
Il dottor Emmanuel Bingham diede un’occhiata in tralice a Fainy. «Posso assicurarvi che l’intera situazione finanziaria entro sessanta giorni si sarà schiarita… Ma quello che mi occorre ora da voi sono due di quei vostri grossi cartoni, in prestito, quegli scatoloni di cartone che adoperate per mandare a domicilio gli abiti.» «Che cosa volete farne?» «Questo giovanotto mio amico ed io abbiamo un certo progetto.» «Soltanto, non fate nessuna birbanteria con quelle scatole, c’è sopra il mio nome.» Il dottor Bingham rise di cuore mentre uscivano dalla porta, tenendo sotto ciascun braccio uno di quegli scatoloni piatti sui quali era scritto in caratteri pomposi “Levy e Goldstein, sartoria di fiducia”. «È un gran burlone, Fenian» disse. «Ma prendete esempio dalla triste condizione di quell’uomo… Il disgraziato soffre per le conseguenze di un’orribile malattia sociale contratta in seguito a qualche follia giovanile.» Passavano di nuovo davanti al negozio dell’imbalsamatore. Ecco i gatti selvatici e il fagiano dorato e il grosso pesce sega… Abbonda nelle insenature basse e nei bracci di mare. Fainy fu tentato di lasciar cadere gli scatoloni del sarto e scappare. Ma comunque, era un impiego. «Fenian» disse il dottor Bingham, in tono confidenziale. «Conoscete la Mohawk House?» «Sissignore, facevamo noi gli stampati per loro.» «E non vi conoscono mica là?» «No, assolutamente… Vi ho soltanto recapitato una volta della carta da scrivere.» «Superbo!… Fate bene attenzione, la mia camera è il 303. Aspettate un cinque minuti e poi entrate. Siete il commesso del sarto, capite? che viene a prendere degli abiti per smacchiarli. Allora salite nella mia camera e prendete gli abiti e li portate al mio ufficio. Se qualcuno vi chiede dove li portate, voi dite che vanno da Levy e Goldstein, capito?» Fainy trasse un lungo respiro. «Capito benissimo.» Quand’egli arrivò nella stanzetta in cima alla Mohawk House, il
dottor Bingham camminava in su e in giù. «Levy e Goldstein, signore» disse Fainy, conservando la faccia impassibile. «Ragazzo mio» disse il dottor Bingham «sarete un buon aiuto, son contento di avervi trovato. Vi darò un dollaro in anticipo, sul vostro stipendio.» Mentre parlava, andava togliendo abiti, carte e vecchi libri da un grosso baule in mezzo al pavimento. Collocò tutto accuratamente in uno degli scatoloni. Nell’altro mise un soprabito foderato di pelliccia. «Questo indumento costò duecento dollari, Fenian, un relitto di antiche grandezze… Ah le foglie dell’autunno a Vallombrosa… Et tu in Arcadia vixisti… È latino, lingua degli studiosi.» «Mio zio Tim, che dirigeva la tipografia dove io lavoravo, sapeva il latino niente male.» «Credete di poterle portare, queste, Fenian… Non sono troppo pesanti?» «Posso sì.» Fainy avrebbe voluto chiedere di quel dollaro. «Bene, e adesso gambe… Aspettatemi all’ufficio.» Nell’ufficio Fainy trovò un tale seduto alla seconda scrivania. «Be’, cosa volete qui?» strillò quello, con una voce raschiante. Era un giovanotto dal naso tagliente e dalla pelle cerea, coi capelli neri che stavan su dritti. Fainy era sfiatato dalla corsa su per le scale. Aveva le braccia irrigidite dal peso degli scatoloni. «Sarà, m’immagino, un’altra delle stupidaggini di Mannie. Ditegli che deve sgombrare di qui, ho affittato l’altro scrittoio.» «Ma il dottor Bingham mi ha assunto poco fa per la compagnia letteraria Ricerca e diffusione verità.» «Vi hanno assunto un corno.» «Sarà qui a momenti.» «Be’, sedete e state zitto, non vedete che ho da fare?» Fainy sedé tetro sulla sedia a perno, vicino alla finestra, l’unica sedia dell’ufficio che non fosse ingombrata da alte pile di libretti avvolti in fogli di carta. Fuori della finestra si vedeva qualche tetto polveroso e uscite di sicurezza. Attraverso sudice finestre si vedevano altri uffici, altre scrivanie a saracinesca. Sulla scrivania che aveva di
fronte, c’erano pacchi di libri. Tra questi, mucchi di libercoli sciolti. Con l’occhio afferrò un titolo: LA REGINA DELLE SCHIAVE BIANCHE Scandalose rivelazioni di Milly Meecham rapita ai genitori all’età di sedici anni, e trascinata dal suo vile seduttore in una vita d’infamia e di vergogna. Cominciò a leggere quel libro. Gli si disseccò la lingua e si sentiva tutto sudaticcio. «Nessuno vi ha detto niente, eh?» ruppe sulla sua lettura la voce rintronante del dottor Bingham. Prima che Fainy potesse rispondere, la voce dell’uomo dalla scrivania ringhiò: «Badate, Mannie, dovete sgombrare di qui… ho affittato la scrivania». «Non scuotermi dinanzi le tue chiome sanguinose, Samuel Epstein. Questo giovanotto mio amico ed io stiamo ora preparando una spedizione tra gli aborigeni del tenebroso Michigan. Partiamo per Saginaw stanotte. Tra due mesi sarò di ritorno e rileverò tutto l’ufficio. Questo giovane viene con me per imparare la professione.» «Professione un corno» grugnì l’altro; e ricacciò la faccia fra le sue carte. «Procrastinare, Fenian, è farsi rubare il tempo» disse il dottor Bingham, ficcandosi napoleonicamente nel panciotto a doppio petto una mano grassa. «C’è una marea nelle cose umane, che nel suo flutto porta…» E per due ore Fainy sudò, sotto le sue istruzioni, a chiudere libercoli in pacchi di carta marrone, legandoli e indirizzandoli alla Ricerca della verità, Inc., Saginaw, Mich. Chiese un’ora per andare a casa a vedere i suoi. Milly lo baciò sulla fronte con le sottili labbra serrate. Poi scoppiò a piangere. «Sei fortunato, tu; oh, vorrei essere un ragazzo» le uscì tra le lacrime; e scappò per le scale. La signora O’Hara gli disse di essere un bravo ragazzo e di alloggiare sempre all’YMCA che toglieva i ragazzi dalle tentazioni e che lo zio Tim con il suo vizio di bere gli servisse di lezione. Aveva la gola ben serrata quando andò a cercare lo zio Tim. Lo trovò nel retro di O’Grady. Parlando a Fainy, aveva gli occhi turchino lucido e il labbro inferiore gli tremava. «Bevi una volta con me,
figliolo, ora che ti mantieni.» Fainy cacciò giù una birra senza gustarla. «Fainy, tu sei un ragazzo sveglio… Vorrei averti potuto aiutar di più, tu sei un O’Hara fino alle midolla. Leggi Marx… studia quanto puoi, ricordati che sei un ribelle di nascita e di sangue… Non dar mai la colpa alle persone per quel che ti può succedere… Guarda quella terribile furia dalla lingua a forca, che ho sposato: do forse la colpa a lei, io? No, la do al sistema. E non venderti mai ai porci fottuti, figliuolo, son sempre le donne che ti costringeranno a venderti. Tu mi capisci. E adesso va’… meglio che scappi altrimenti perdi il treno.» «Ti scriverò da Saginaw, zio Tim, ti prometto che ti scriverò.» La faccia rossa e scarna di zio Tim nella stanza deserta piena di fumo, il banco con lo scintillio d’ottone e il barista dalle braccia arrossate piegatovi sopra, le bottiglie, gli specchi e il ritratto di Lincoln gli fecero in testa un mezzo giro nebuloso e Fainy si trovò fuori nella via lucida di pioggia sotto le nuvole lucide, a correre verso la stazione dell’aerea con la valigia in mano. Alla Illinois Central Station trovò il dottor Bingham che lo attendeva, in mezzo a un circolo di pacchi in carta marrone. Fen si sentì scuotere dentro quando lo vide: le grasse guance smorte, il panciotto a doppio petto, il rigonfio abito nero da pastore, il cappello nero impolverato, di feltro, che faceva sporgere i capelli in bruschi ciuffetti di pelurie sopra le orecchie bovine. Comunque, era sempre un posto. «Debbo ammettere, Fenian,» cominciò il dottor Bingham, appena Fainy l’ebbe raggiunto «che, confidente come sono nella mia conoscenza degli uomini, nutrivo qualche apprensione che non sareste tornato. Dov’è che il poeta dice: difficile è il primo stentato volo dell’uccellino dal nido? Mettete questi pacchi in treno mentre io vado a prendere i biglietti, e assicuratevi che sia uno scompartimento fumatori.» Dopo che il treno fu partito e il controllore ebbe forato i biglietti, il dottor Bingham si curvò innanzi e batté a Fainy sul ginocchio con un indice paffuto. «Son lieto di constatare che sapete vestirvi, ragazzo mio; non dovete mai dimenticare l’importanza di mostrare al mondo una fronte dignitosa. Anche se il cuore è in cenere e polvere, l’aspetto
esteriore dev’essere allegro e cordiale. Andiamo a sederci un po’ nello scompartimento fumatori, in su, per sfuggire a tutto questo contadinume.» Pioveva forte e i finestrini del treno eran rigati di strisce trasversali perlate contro il buio. Fainy si sentì imbarazzato a seguire traballando il dottor Bingham attraverso la vettura salone in felpa verde, fino al piccolo scompartimento fumatori, tappezzato in cuoio, al fondo. Qui giunto il dottor Bingham trasse di tasca un grosso sigaro e cominciò ad emettere una magnifica serie di anelli di fumo. Fainy gli sedeva accanto coi piedi sotto il sedile, cercando di occupare meno spazio che poteva. A poco a poco lo scompartimento si empì di uomini silenziosi e di increspate spirali di fumo. All’esterno la pioggia batteva contro i finestrini con un rumore di ghiaia. Per molto tempo nessuno disse nulla. Ogni tanto qualcuno si spurgava e dava nella sputacchiera con una gran boccata di catarro o uno schizzo di sugo di tabacco. «Sissignore» cominciò una voce che non veniva da nessun luogo in particolare, rivolta a nessun luogo in particolare «fu una gran bella inaugurazione, anche se si gelava da crepare.» «Siete stato a Washington?» «Sì, sono stato a Washington.» «La maggior parte dei treni non ha potuto arrivare fino al giorno dopo.» «Lo so, sono stato fortunato: ce ne furono bloccati dalla neve per quarantotto ore.» «Qualche tormenta sicuro.» Cacciossi innanzi a turbini la neve Borea rabbioso, finché fu il mattino: il sole nella chiara nebbia lieve accese basso il volto porporino recitò il dottor Bingham timidamente, con gli occhi abbassati. «Dovete avere una buona memoria per saper recitare versi così l’uno dopo l’altro.» «Sì, ho una memoria che credo possa, senza eccessivamente offender la modestia, chiamarsi compendiaria. Se essa fosse un dono
naturale, sarei costretto ad arrossire e tacere, ma giacché è il risultato di quarant’anni di studi su quanto di meglio vi è nelle letterature epica, lirica e drammatica di tutto il mondo, penso che richiamarvi sopra l’attenzione possa talora incoraggiare qualcun altro i cui passi si volgano anch’essi per i sentieri della conoscenza e dell’autoeducazione.» Si volse d’un tratto a Fainy. «Giovanotto, vi piacerebbe sentire il discorso di Otello al Senato veneziano?» «Certamente» disse Fainy arrossendo. «Be’, finalmente Roosevelt ha un’occasione di mantenere la parola che ha dato di combattere i trust.» «Vi dico che il voto degli agrari ribelli del grande North-West…» «È una cosa tremenda, l’incaglio di quei treni speciali per l’inaugurazione.» Ma il dottor Bingham era lanciato: Potenti e colendissimi signori, amati e nobili padroni miei, è vero che ho involato la figliuola di questo vecchio: è vero, l’ho sposata… «Non se la caveranno con quelle leggi contro i trust, credetemi, non se la caveranno. Non si può restringere la libertà della libertà individuale in questo modo.» «È la libertà dell’uomo d’affari individuale che l’ala progressista del partito repubblicano cerca di proteggere.» Ma il dottor Bingham era in piedi, una mano ficcata nel panciotto a doppio petto, e con l’altra faceva larghi gesti circolari: Rozza la mia parola e poco assuefatta alle melliflue frasi di pace, ché da quando il braccio ebbe il vigore dei sette anni fino a nove lune fa, sempre per me usò l’azioni sue più belle in campo «Il voto degli agrari» cominciò l’altro con voce stridente: ma nessuno ascoltava. Il dottor Bingham aveva il campo: Poco di questo mondo io so il linguaggio quando non sia di zuffa e di battaglia però gioverò poco a mia ragione
perorando per me Il treno cominciava a rallentare. La voce del dottor Bingham risonava bizzarramente fragorosa nel rumore diminuito. Fainy si sentì la schiena sospinta contro lo schienale del sedile, e poi di botto fu calma, e il rintocco di una campana di locomotiva in distanza e la voce del dottor Bingham in un bisbiglio fastidioso. «Signori, ho qui in formato opuscolo un’edizione completa e non castigata di uno dei classici universali, il famoso Decamerone del Boccaccio, che per quattro secoli è stato un sinonimo di spirito piccante e umorismo licenzioso…» Trasse un mazzo di libriccini da una delle sue tasche cascanti e cominciò a ciondolarli tra mano. «Soltanto a titolo di amicizia sarei disposto a cederne qualcuno, se tra voi signori c’è chi se ne interessi… Su, Fenian, prendeteli e sentite se qualcuno ne desidera, sono due dollari cadauno. Questo giovanotto mio amico si occuperà della distribuzione… Buona notte, signori.» E se ne andò e il treno era ripartito e Fainy si trovò in piedi coi libretti in mano nel centro della vettura rollante, mentre gli occhi sospettosi di tutti i fumatori lo frugavano come tanti succhielli. «Vediamone uno» disse un uomo piccolotto dalle orecchie sporgenti, che sedeva nell’angolo. Aprì il libro e cominciò a leggere avidamente. Fainy restava in piedi nel centro della vettura, sulle spine. Notò un bagliore bianco nella coda dell’occhio, quando quell’altro guardò giù per la fila dei sigari attraverso il fumo increspato. Un pizzico di rosso si diffuse per le orecchie sporgenti di colui. «Roba extra» disse «ma due dollari sono troppi.» Fainy si trovò a balbettare: «Nonnoon sono miiiei, signore, non so». «Ah ben, diavolo!…» l’uomo piccolotto gettò due biglietti da un dollaro in mano a Fainy e ritornò alla sua lettura. Fainy aveva sei dollari in tasca e due libri di residuo, quando ritornò all’antico scompartimento. A metà vettura incontrò il controllore. Il suo cuore quasi cessò di battere. Il controllore lo guardò fissamente, ma non disse nulla. Il dottor Bingham stava seduto al suo posto con la testa nella mano
e gli occhi chiusi come se sonnecchiasse. Fainy gli scivolò nel posto accanto. «Quanti ne hanno presi?» domandò il dottor Bingham parlando nell’angolo della bocca, senza aprire gli occhi. «Ho sei dollari… Maledetto il controllore, mi ha fatto paura, dal modo che mi ha guardato.» «Lasciate fare a me quanto al controllore e ricordate che non è mai un delitto in faccia all’umanità e al progresso diffondere le opere dei grandi umanisti in mezzo ai mercanti e ai cambiavalute di questo paese abbandonato da Dio… Adesso sarà bene che mi consegniate i quattrini.» Fainy avrebbe voluto chiedere di quel dollaro che gli era stato promesso, ma il dottor Bingham si era di nuovo buttato su Otello. Se dopo ogni tempesta questa pace ci giunge il navigante faticoso scalerà ancora le onde fatte a monti alti come l’Olimpo Dormirono fino a tardi alla casa commerciale di Saginaw e mangiarono un’abbondante colazione, durante la quale il dottor Bingham parlò sulla teoria e pratica della vendita dei libri. «Temo forte che in tutto il retroterra dove stiamo per penetrare» disse, mentre tagliuzzava tre uova al tegame e s’inzeppava la bocca di biscotto alla polvere di lievito «troveremo i villani ancora assetati di Maria Monk.» Fainy non sapeva chi fosse Maria Monk, ma non ebbe voglia di chiederlo. Andò col dottor Bingham alla rimessa pubblica Hummer a noleggiare un cavallo e un carretto. Seguì un lungo alterco tra la ditta Ricerca della verità Inc. e la direzione della rimessa pubblica Hummer intorno all’affitto di un carretto sospeso e di un venerabile cavallo pomellato con groppe buone da sospendervi un cappello, cosicché fu avanzato pomeriggio prima che se ne uscissero da Saginaw coi pacchi dei libri ammucchiati alle spalle, diretti sulla strada. Era un freddo giorno di primavera. Nuvole rigonfie si muovevano in un incerto grigiore sopra un cielo azzurriccio, d’argento. Il pomellato continuava a rallentare finché andava al passo; Fainy gli batteva continuamente le briglie sul groppone incavato e con la lingua
schioccava, finché non ebbe la bocca secca. Alla prima botta il pomellato si cacciava a un galoppo che degenerava subito in un trotterello a sbalzi e poi in un passo. Fainy sacramentava e schioccava, ma non riusciva a mantenere il cavallo nel galoppo o nel trotterello. Intanto il dottor Bingham gli sedeva accanto col largo cappello gettato all’indietro sulla testa, fumando un sigaro e discorrendo: «Bisogna dire ora, Fenian, che l’atteggiamento di un uomo dalle idee illuminate è: “Che venga un accidente a tutta”… Anch’io sono panteista… ma anche un panteista… deve mangiare: andatevene, Maria Monk». Certe gocce di una pioggia diaccia e pungente come grandine avevano cominciato a piombar loro in faccia. «Mi prenderò la polmonite, di questo passo, e sarà colpa vostra, anche: mi pareva che aveste detto che sapete guidarlo un cavallo… Su, entrate in quella cascina a sinistra. Può darsi che ci lascino mettere cavallo e carretto nel granaio.» Mentre si dirigevano per il sentiero verso la casa e la baracca del granaio, grigiastri sotto una macchia di pini, un po’ fuori della strada, il pomellato rallentò fino a procedere al passo e cominciò ad allungare il collo per giungere ai ciuffi verdi-lucidi d’erba sulla sponda del fossato. Fainy lo picchiò con le estremità delle briglie e sporse persino un piede dal cruscotto e gli diede calci, ma quello non ne voleva sapere. «Dannazione, datemi le briglie.» Il dottor Bingham diede alla testa del cavallo un terribile strattone, ma il cavallo non fece altro che volgere il capo e guardarli, con una schiuma verde d’erba in parte masticata tra i dentacci gialli. A Fainy parve che quello ridesse. La pioggia veniva forte. Tirarono su il colletto. Ben presto Fainy ebbe un rigagnolo ghiacciato giù per la nuca. «Scendete e andate a piedi, che il diavolo se lo porti, conducetelo se non sapete guidarlo» barbugliò spruzzando il dottor Bingham. Fainy saltò giù e condusse il cavallo alla porta retrostante della cascina; la pioggia gli scorreva per la manica della mano con cui teneva il cavallo. «Buon giorno, signora.» Il dottor Bingham era sceso e si inchinava
a una vecchietta che era uscita alla porta. Le si fermò accanto sul ripiano, fuori della pioggia. «Vi dispiace se metto per qualche momento cavallo e carretto nel vostro granaio? Ho del prezioso materiale danneggiabile nel carretto e nessun riparo impermeabile…» La vecchietta annuì con una testa candida, come di fibre. «Questo è molto gentile da parte vostra, bisogna dire… Allora, Fenian, mettete il cavallo nel granaio e ritornate con quel pacchetto ch’è sotto il sedile… Stavo dicendo appunto a questo giovanotto che ero certo che una qualche buona samaritana doveva abitare in questa casa, per ricoverare, come ha fatto, due stanchi viandanti.» «Venite dentro, signore… magari avrete desiderio di mettervi vicino alla stufa e farvi asciugare. Venite, signor…» «Mi chiamo dottor Bingham… il reverendo dottor Bingham» Fainy sentì che diceva, entrando in casa. Era inzuppato e corso da brividi, quando entrò in casa anche lui, portando un pacco di libri sotto il braccio. Il dottor Bingham era sdraiato, comodo come un pascià, su una sedia a dondolo davanti alla stufa di cucina. Vicino, sul ben strofinato tavolo d’abete, c’era un pezzo di torta e una tazza di caffè. La cucina aveva un buon profumo tiepido di mele, di lardo grasso e di lucerna. La vecchia si piegava attraverso il tavolo, ascoltando quel che il dottor Bingham le diceva. Un’altra donna, grande e ossuta questa, con gli scarsi capelli rossicci fatti su in una treccia sopra la testa, stava in disparte con sui fianchi le mani dalle nocche arrossate. Un gatto bianco e nero, schiena arcuata e coda all’aria, si fregava contro le gambe del dottor Bingham. «Ah, Fenian, proprio a tempo» cominciò costui con una voce che ronzava come il gatto. «Stavo appunto dicendo… esponendo alle nostre ospiti cortesi la materia della nostra interessantissima biblioteca educativa, il fior fiore della letteratura devota e ispiratrice di tutto il mondo. Sono state così gentili con noi nella nostra piccola disavventura per causa del tempo, che ho creduto non fosse che giusto far loro vedere qualcuno dei nostri titoli.» La donna grande si tormentava il grembiule. «Mi piace ogni tanto leggere un po’» disse timidamente. «Ma non ho molto tempo, fino a quest’inverno.»
Sorridendo benigno, il dottor Bingham slegò lo spago e si aprì il pacco sulle ginocchia. Un libercolo cadde sul pavimento. Fainy vide che era The Queen of the White Slaves. Un’ombra di dispetto passò in faccia al dottor Bingham. Mise il piede sul libro caduto. «Questi sono i “Discorsi sui Vangeli”, ragazzo mio» disse. «Io volevo i “Sermoni brevi per ogni occasione”, del dottor Spikenard.» Porse il pacco semiaperto a Fainy che lo prese di strappo. Poi si curvò, raccolse il libro da sotto al piede spazzandolo con un lento gesto della mano, e se lo fece scivolare in tasca. «Vedo che dovrò andarli a cercare io stesso» continuò con la sua voce più ronzante. Quando l’uscio della cucina si chiuse alle loro spalle, ringhiò in un orecchio a Fainy: «Sotto il sedile, canaglia… Se me ne fai ancora una simile, ti spacco tutte le ossa che hai indosso». E gli cacciò il ginocchio così seccamente nel fondo dei pantaloni, che a Fainy sgretolarono i denti e schizzò fuori nella pioggia, alla volta del granaio. «Davvero, non l’ho fatto apposta» badava a gemere Fainy. Ma il dottor Bingham era già di ritorno in casa e la sua voce giungeva con la striscia della lucerna, gorgogliando vellutata, fin fuori nel buio stillante. Stavolta Fainy ebbe cura di aprire il pacco prima di portarlo. Il dottor Bingham gli tolse i libri di mano, senza guardarlo in faccia, e Fainy andò dietro al tubo della stufa. Rimase là nel vapore grondante dell’abito, ascoltando gli imbonimenti del dottor Bingham. Aveva fame, ma pareva che nessuno pensasse di offrirgli un pezzo di torta. «Ah, mie anime buone, come posso dirvi con quanta riconoscenza per il Gran Donatore un solitario ministro dell’evangelo della luce, peregrinante fra le gramigne e le afflizioni di questa terra, incontra persone pronte ad ascoltarlo? Son certo che questi libriccini saranno di consolazione e d’ispirazione per tutti coloro che si sottoporranno al piccolo sforzo di leggerli attentamente. Son tanto convinto di questo che ne porto sempre con me alcune copie in più per cederle a un modico compenso. Mi spezza il cuore che io non possa distribuirli gratuitamente.» «Quanto vengono?» domandò la vecchia, mentre una subitanea asprezza le appariva in volto. Quell’altra ossuta si lasciò cadere le
braccia ai fianchi e scosse il capo. «Ricordate, Fenian?» domandò il dottor Bingham, ripiegandosi genialmente indietro sulla sedia. «Qual era il prezzo di costo di questi libercoli?» Fainy era offeso. Non rispose. «Su, Fenian» disse il dottor Bingham in tono mellifluo. «Voglio rammentarvi le parole del vate immortale: Umile stato è scala all’ambizione cui il giovine volge in alto il guardo ma quando è giunto all’ultimo gradino volge allora la schiena a queste scale…» «Dovete aver fame. Mangiate la mia torta.» «Credo che troveremo un pezzo di torta per il ragazzo» disse la vecchia. «Non è dieci cents che costano?» disse Fainy avanzandosi. «Ah se costano solo dieci cents, uno mi piacerebbe» disse la vecchia in fretta. Quella ossuta stava per dir qualcosa, ma era già troppo tardi. Erano appena scomparse la torta nella gola di Fainy e la moneta luccicante, presa dalla vecchia tabacchiera nella credenza, nella tasca del panciotto del dottor Bingham, quando si udì un frastuono di finimenti tintinnanti e il barlume di una lanterna da barroccio passò nel buio stillante fuori della finestra. La vecchia si alzò in piedi e guardò nervosamente la porta che si aprì subito. Un uomo grigio, tarchiato, con una barbettina sporgente da una tonda faccia rossa entrò, scrollandosi la pioggia dalle falde della giacca. Dietro gli veniva un giovanotto magro dell’età di Fainy. «Buona sera signore, buona sera figliuolo» esclamò il dottor Bingham, mentre finiva la torta e il caffè. «Hanno chiesto di ricoverare il cavallo nel granaio finché cessasse di piovere. Ho fatto bene, vero, James?» domandò la vecchia nervosamente. «Va bene» disse l’uomo abbandonandosi sulla sedia vuota. La vecchia aveva nascosto l’opuscolo nel cassetto del tavolo. «Viaggiate in libri, da quanto vedo.» Fissò duramente il pacco aperto degli opuscoli. «Be’, non abbiamo bisogno di quella roba, noi, ma potete fermarvi la notte nel granaio. In una notte simile non si può
cacciar fuori nessuno.» E così staccarono il cavallo e si aggiustarono i giacigli nel fieno sopra la stalla. Prima che uscissero di casa, il vecchio si fece consegnare i fiammiferi. «Dove son fiammiferi c’è pericolo d’incendio» disse. La faccia del dottor Bingham era nera come il temporale quando si avvolse in una coperta da cavallo, borbottando di «oltraggio all’abito». Fainy era eccitato e tutto felice. Stava disteso sul dorso ascoltando il battito della pioggia sopra il tetto e il gorgoglio nelle grondaie e le scosse e zampate delle bovine e del cavallo, sotto. Aveva il naso pieno dell’odor del fieno e della calda fragranza di prato delle mucche. Non sentiva sonno. Avrebbe voluto averci qualcuno della sua età per chiacchierare. Be’, era sempre un lavoro e dopo tutto era in viaggio. Si era appena addormentato che una luce lo destò. Il ragazzo che aveva visto nella cucina gli stava sopra con una lanterna. L’ombra arrivava enorme fin contro le travi. «Dite, vorrei comprare un libro.» «Che libro?» Fainy sbadigliò e sedette. «Ma… uno di quelli che parlano di ballerine, di schiave bianche e di tutte queste cose.» «Quanto volete spendere, giovanotto?» fece la voce del dottor Bingham da sotto la coperta. «Abbiamo un buon numero di interessantissime pubblicazioni che espongono le cose con franchezza e spregiudicatezza e descrivono la deplorevole dissolutezza della vita nelle grandi città, prezzi da uno a cinque dollari. La “Sessologia completa” del professor Burnside viene sei e cinquanta.» «Non posso passare un dollaro… Non andate mica a dirlo al vecchio» disse volgendosi dall’uno all’altro. «Seth Hardwick, che sta giù per lo stradale, è andato una volta a Saginaw e ha preso un libro da uno all’albergo. Era fantastico.» Ridacchiò malsicuro. «Fenian, scendete a prendergli “La regina delle schiave bianche” per un dollaro» disse il dottor Bingham; e si rimise a dormire. Fainy e il giovanotto scesero per la scala sgangherata. «Dite, è eccitante?… Se il Pa’ lo trova, sì che mi stanga… ’Cidenti, scommetto che voi li avete letti tutti quei libri.»
«Io?» disse Fainy fieramente. «Non ho bisogno di leggere i libri. Io la vedo la vita, se voglio. Eccolo… tratta delle donne perdute.» «Ma è ben piccolo per un dollaro. Credevo di pigliarne uno grosso per un dollaro.» «Questo è tutto eccitante.» «Be’, allora lo prendo, prima che il Pa’ mi peschi a girare… Buona notte.» Fainy ritornò al giaciglio nel fieno e s’addormentò presto. Sognava di salire in un granaio per una scala sgangherata con sua sorella Milly, che continuamente si faceva più grande, più bianca e più grassa e aveva un cappello enorme con piume di struzzo tutt’attorno, e il vestito le incominciava a fendersi dal collo, giù, sempre più giù, e la voce del dottor Bingham diceva: È Maria Monk la regina delle schiave bianche, e proprio sul punto che stava per afferrarla la luce del giorno gli spalancò gli occhi. Il dottor Bingham gli era piantato innanzi, le gambe larghe, si pettinava con un pettinino e declamava: Partiamo dunque, il sole universale non confina a una terra i rai beati né l’uomo è come l’albero… «Su, Fenian,» esclamò, quando vide Fainy svegliato «scuotiamo via la polvere di quest’inospite cascina, allacciandoci le scarpe con una maledizione come i filosofi di un tempo… Attacca il cavallo, faremo colazione per la strada.» Ciò durò per diverse settimane, finché una sera si trovarono in direzione di una linda casa giallina in mezzo a un boschetto di ciuffosi larici cupi. Fainy attese nel carretto, mentre il dottor Bingham visitava la gente della casa. Dopo un po’ il dottor Bingham comparve sulla porta, le guance increspate di un largo sorriso. «Saremo ricevuti molto bene, Fenian, come si conviene a uno che veste l’abito e tutto… Voi fate ben attenzione come parlate, intesi? Conducete il cavallo al granaio e staccatelo.» «Dite, signor Bingham, e quei soldi che mi spettano? sono tre settimane ora.» Fainy saltò giù e andò alla testa del cavallo. Un’espressione desolata passò in faccia al dottor Bingham. «Oh lucro, lucro… Guardate dunque
la mano candida, la palma quasi netta, ma qua e là un’impronta sozza appare ed è denaro… Avevo grandi progetti per un’impresa cooperativa e voi li rovinate con la vostra fretta e avidità giovanili… Ma se proprio ne avete bisogno, vi consegnerò stanotte tutto ciò che vi spetta e anche di più. Adesso staccate il cavallo e portatemi quel pacchetto di “Maria Monk” e “La congiura dei papisti”.» Era una tiepida giornata. C’eran pettirossi a cantare intorno al granaio. Tutto sapeva di erbadolce e di fiori. Il granaio era rosso e il cortile pieno di galline bianche. Dopo ch’ebbe staccato il carretto e messo il cavallo in uno scomparto della stalla, Fainy sedette su un traverso dello steccato che guardava, dietro la casa, il campo verdargento di avena, e fumò una sigaretta. Avrebbe voluto averci una ragazza da tenere abbracciata o un compagno col quale chiacchierare. Una mano gli cadde sulle spalle. Il dottor Bingham gli era in piedi accanto. «Fenian, amico, abbiamo trovato la vigna» disse. «È sola in casa e il marito è andato in città per due giorni col servitore. Non ci sarà nessuno tranne i suoi due ragazzini, dolci creature. Forse io farò il Romeo. Non mi avete mai veduto in amore. È la mia parte più sublime. Ah, qualche giorno vi racconterò della mia indomita giovinezza. Venite a conoscere la dolce incantatrice.» Quando passarono la porta della cucina, una donna grassoccia col viso a pozzette, in una cuffia casalinga color lavanda, li salutò con modestia. «Questo è il giovanotto mio aiutante, signora» disse il dottor Bingham con un nobile gesto. «Fenian, ecco la signora Kovach.» «Avrete fame. La cena è subito pronta.» Il sole morente accese una rastrelliera della cucina, tutta piena di tegami e casseruole. Un vapore fragrante usciva a piccoli sbuffi da rotondi coperchi ben lustri. Parlando, la signora Kovach si piegò in modo che il suo gran sedere turchino, coi nastri del grembiale inamidati e annodati in fiocco, si drizzò nell’aria; aprì lo sportello del
forno e ne trasse una gran padella di tortellini di granoturco che vuotò in un piatto sulla tavola già apparecchiata vicino alla finestra. Quel caldo fumo di fritto riempì tutta la cucina. Fainy si sentì l’acquolina in bocca. Il dottor Bingham si fregava le mani e girava intorno gli occhi. Sedettero e i due marmocchi, faccia bisunta e occhi azzurri, vennero fatti sedere e si misero a trangugiare in silenzio, e la signora Kovach riempì il piatto a tutti con pomodori in salsa, purea di patate, stufato di manzo e fagiolini al lardo. Versò loro il caffè e poi disse con gli occhi umidi, sedendosi anch’essa: «Amo veder gli uomini mangiare.» Assunse in viso un’aria di viola del pensiero derelitta, che a Fainy faceva guardare altrove, quando gli capitava di fissarla. Dopo cena stette ascoltando, con una compiaciuta espressione di spavento, il dottor Bingham che parlava parlava, fermandosi ogni tanto a piegarsi all’indietro e mandare un anello di fumo verso la lucerna. «Benché io personalmente non sia luterano come direste voi, signora, ho però sempre ammirato, che dico?, venerato la grande figura di Martin Lutero come di uno dei luminari dell’umanità. Se non fosse per lui, noi saremmo ancora a brancolare sotto la spaventosa dominazione del papa di Roma.» «Non ci riusciranno mai in questo paese, per amor di Dio, mi vengono i brividi a pensarci.» «No certamente, finché c’è una goccia rossa di sangue nelle vene dei liberi protestanti… ma il modo di combattere le tenebre, signora, è con la luce. La luce viene dall’educazione, dalle letture e dagli studi…» «Per amor di Dio, mi viene mal di capo a leggere molto e non ho troppo tempo, a dir la verità. Mio marito legge libri che prende alla sezione d’Agricoltura. Una volta cercò di farmene leggere uno, sulla pollicoltura, ma non son riuscita a capirci molto. La sua famiglia viene dall’Europa… credo che la gente sia differente laggiù.» «Dev’essere difficile vivere sposata con uno straniero simile.» «Talvolta non capisco nemmeno io come faccio a sopportarlo, però era un uomo bellissimo quando l’ho sposato… Non ho mai saputo resistere a un bell’uomo.»
Il dottor Bingham si piegò attraverso il tavolo. Gli giravano gli occhi come se stessero per scoppiar fuori. «E io non sono mai stato capace di resistere a una bella donna.» La signora Kovach trasse un sospiro profondo. Fainy si alzò e uscì. Aveva cercato d’intromettere una parola a proposito dei suoi quattrini, ma a che cosa serviva? Fuori faceva freddo, le stelle rilucevano sopra i tetti dei granai e delle tettoie. Dalla stia veniva ogni tanto un chioccio sonnacchioso o uno starnazzo di penne, quando una gallina perdeva l’equilibrio sul posatoio. Passeggiò su e giù per il cortile, maledicendo il dottor Bingham e tirando ogni tanto un calcio a una zolla di letame. Dopo qualche tempo guardò nella cucina illuminata. Il dottor Bingham aveva il braccio intorno alla vita della signora Kovach e declamava versi, facendo gran gesti con la mano libera: … a sentir tai cose Desdemona da vero si piegava ma sempre le faccende la prendevano che appena avea spacciato in grande fretta tornava a dar l’orecchio ansioso… Fainy tese il pugno alla finestra. «Maledetta pellaccia, voglio i miei soldi» disse a voce alta. Poi andò a passeggiare giù per lo stradale. Quando fu di ritorno, aveva sonno e freddo. La cucina era vuota e la lucerna abbassata. Non sapeva dove andar a dormire, e così, per scaldarsi, si acconciò in una sedia vicino al fuoco. Il capo cominciò a ciondolargli e s’addormentò. Un tremendo tonfo sul pavimento sul suo capo e gli urli di una donna lo risvegliarono. Il primo pensiero fu che il dottor Bingham derubasse e assassinasse la donna. Ma udì immediatamente un’altra voce che bestemmiava e vociava in un cattivo inglese. Si era alzato a mezzo dalla sedia, quando gli guizzò accanto il dottor Bingham. Indosso non aveva che il suo completo di flanella. In una mano teneva le scarpe, nell’altra gli abiti. I pantaloni gli svolazzavano dietro, all’estremità delle bretelle, come la coda di un aquilone. «Ehi, cosa facciamo?» Fainy gli gridò dietro, ma non ebbe risposta.
Invece si trovò a faccia a faccia con un uomo alto e fosco, dalla ruvida barba nera, che stava freddamente ficcando cartucce in un fucile a doppia canna. «Pallini. Gli sparo dietro, a quel fetente.» «Ehi, non farete questo» cominciò Fainy. Si prese la canna del fucile nello stomaco e ricadde di sfascio sulla sedia. L’uomo scomparve dalla porta con lunghi passi elastici e seguirono due scariche che rintronarono per tutto il caseggiato. Allora ricominciarono gli urli della donna, intermittenti tra uno strascicato piantoriso isterico. Fainy rimase seduto sulla sedia vicino alla stufa, come incollato. Osservò una moneta da mezzo dollaro sul pavimento, che doveva esser caduta dai pantaloni del dottor Bingham in corsa. L’afferrò e se l’era appena cacciata in tasca quando l’uomo alto dal fucile rientrò. «Scarico» disse pesantemente. Poi sedette sopra il tavolo tra i piatti sporchi della cena e cominciò a piangere come un bambino; le lacrime gli sgocciolavano tra le dita nocchiute delle grosse mani fosche. Fainy uscì furtivamente per la porta e andò nel granaio. «Dottor Bingham» chiamò a bassa voce. I finimenti giacevano in mucchio tra le stanghe del carretto, ma non c’era traccia del dottor Bingham né del cavallo pomellato. Il chioccio di spavento delle galline disturbate nella stia si mescolava agli urli della donna che ancora echeggiavano dal piano superiore della cascina. “Cosa diavolo faccio, ora?” stava chiedendosi Fainy quando s’accorse di una figura alta che spiccava nella porta luminosa della cucina e gli puntava il fucile. E proprio quando il fucile fiammeggiò, Fainy saltò nel granaio e via per la porta posteriore. Alcuni pallini gli miagolarono sul capo. «Sacrodio, ha trovato cartucce.» Fainy partì con tutta la velocità delle gambe attraverso il campo d’avena. Alla fine, senza più fiato in corpo, s’arrampicò su uno steccato coperto di rovi che gli laceravano faccia e mani e giacque steso in un fossato vuoto, a riaversi. Nessuno lo inseguiva.
Cine-giornale III «CI VUOL DEL FEGATO PER VIVERE IN QUESTO MONDO» ESTREME PAROLE DI GEORGE SMITH IMPICCATO DALLA FOLLA INSIEME COL FRATELLO NEL KANSAS IL MARCHESE DI QUEENSBERRY È MORTO FIAMME CHE ROVINANO UNA MANIFATTURA DI SPEZIERIE IL TRIBUNALE RILASCIA LIBERO ZOLA alcuni anni fa gli anarchici del New Jersey, con il bottone McKinley e il distintivo rosso dell’anarchia sulle giacche e forniti di birra dai repubblicani, tramarono la morte di una delle teste coronate dell’Europa ed è probabile che il piano di assassinare il presidente sia nato allora o poco dopo Fa un bel chiaro di luna stanotte sul Wabash si diffonde dai prati l’odore del fieno tagliato la candela risplende fra i tronchi dei bei sicomori sulle rive del Wabash beato ALLA PAZZA GIOIA Seimila Lavoratori a Smolensk Sfilano con Cartelli che Dicono Morte Allo Zar Assassino. sommosse e serrate di vie segnano l’inizio dello sciopero dei carrettieri LA MAGGIOR BATTAGLIA NAVALE DEL MONDO È VICINA la polizia di Madrid si scontra con 5000 lavoratori dalla bandiera nera gira la testa agli spettatori mentre la danzatrice mangia un arancio battendo il primato che aveva fatto impazzire uno
Occhio fotografico (5) e giocavamo alla battaglia di Port Arthur nella vasca da bagno e l’acqua stillò giù per il soffitto del salotto e fu davvero una rovina ma a Kew Gardens il vecchio signor Garnet che era sempre arzillo benché tanto vecchio veniva a prendere il tè lo vedevamo prima dalla finestra faccia rossa e basette alla John Bull e la zietta diceva che aveva un passo ondeggiante da marinaio portava una scatola sotto il braccio e Vikie e Pompom abbaiavano e c’era il signor Garnet a prendere il tè e toglieva da una scatola nera un grammofono e metteva un cilindro sul grammofono e allontanavano il servizio da tè dall’angolo del tavolo Attenzione a non lasciarlo cadere ora si graffiano molto facilmente Sì un comune ago da cucire andrebbe bene signora ma io ho aghi speciali e ci mettevamo a parlare dell’ammiraglio Togo e dei Baniani e come i russi bevevano tanta vodka e uccidevano tutti quei poveri pescatori nel mare del Nord e lo caricava con molta cura per non rompere la molla e l’ago faceva grr grr sì fui anch’io marinaio ragazzo mio da quando ero un piccolo marmocchio non più grosso di te salii fino a secondo sulla prima corazzata inglese Warrior e so ancora ballare una hornpipe sì signora aveva una bussola da marinaio rossa e azzurra sul dorso della mano e le unghie nere e spesse mentre brancicava con l’ago e l’ago faceva grr grr e lontano una banda suonava e da un rumore raschiante nel cornetto nero usciva God Save the King e i cagnolini latravano
Cine-giornale IV Ho trovato il mio amore sull’Alamo quando la luna stava per spuntare sol con lo sguardo mi diceva ti amo e gli occhi non finivan di brillare durante il mattino pattuglie delle Unioni rimandarono un carro carico di 50 sedie da campo che si dirigeva alla caserma dei pompieri in Michigan Avenue e Washington Street. Pare che le sedie fossero destinate all’uso degli agenti di polizia distaccati in servizio di sciopero PROBABILE UNA BATTAGLIA NAVALE OGGI A OVEST DI LUZON tre grossi lupi vennero uccisi prima di pranzo. Si pensa di fare una grande sfilata in cui il presidente Roosevelt starà a cavallo in modo da esser visibile ai cittadini. In testa ci sarà un orso in gabbia recentemente catturato, dopo ch’ebbe ucciso dodici cani e ferito vari uomini. All’orso sarà data un’ora di vantaggio nelle colline, poi le mute partiranno in traccia e il presidente Roosevelt e i bracchieri verranno dietro, all’inseguimento tre studenti della Columbia cominciarono un viaggio per Chicago in automobile, dietro scommessa LO SCIOPERO GENERALE MINACCIA Fa un bel chiaro di luna stanotte sul Wabash IL PIÙ BEL GIORNO DEL RE DEL PETROLIO un cherubino ogni cinque minuti il mercato continua sostenuto per ogni classe di immobili insistente domanda di appezzamenti per fabbriche di proprietà di residenza e d’affari le decisioni dei tribunali contro i lavoratori DOMENICA DI SANGUE A MOSCA angeli ridotti in frantumi le truppe sorvegliano i campi di petrolio l’America tende a diventare un impero come ai tempi dei Cesari poesia da 5 dollari che guadagna un marito ricco mangiate meno dice Edison un ricco giocatore di poker cade morto avendo preso sequenza reale accusa la corruzione a Cicero
LO SCIOPERO IN RUSSIA PUÒ SIGNIFICARE LA RIVOLTA avventura lacustre di due yacht un assassinio pone fine a un odio operaio il Michigan inonda Albion bandiere rosse a Pietroburgo LO ZAR CEDE AL POPOLO tiene un bambino morto quaranta ore famiglie espropriate da una tubatura d’acqua rotta LO ZAR CONCEDE LA COSTITUZIONE Si diffonde dai prati l’odore del fieno tagliato la candela risplende fra i tronchi dei bei sicomori.
Occhio fotografico (6) Dàgli Madison dàgli Madison diceva il signor Linwood il direttore quando uno correva per il campo pigliando a calci il pallone rotondo footer lo chiamavano a Hampstead e poi era tempo di tornare a casa e uno si sentiva contento perché il signor Linwood aveva detto Dàgli Madison Taylor diceva Ecco un altro americano che arriva aveva i denti come quelli di Teddy nei giornali e il naso all’insù e un vestito da Rough Rider 1 e diceva Tu per chi voti? e uno diceva Non so e lui sporgeva il petto e diceva I tuoi per chi Roosevelt o Parker? e uno diceva Il giudice Parker i capelli dell’altro americano erano nerissimi e tendeva i pugni e il naso all’insù e diceva Io sono per Roosevelt vuoi batterti? Tutto trepidante uno diceva Io sono per il giudice Parker ma Taylor diceva Chi ha due soldi per la birra dolce? e nessuno si batteva allora 1. Corpo di cavalieri fondato da Roosevelt (“Teddy”). Significa qualcosa come “cavalieri alla brava”. (NdT)
Cine-giornale V LE CIMICI SCACCIANO UN BIOLOGO fuggitivi che legano e imbavagliano; è liberato da un cane L’IMPERATORE NICOLA II DI FRONTE ALLA RIVOLTA DELL’IMPERO CONCEDE AI SUDDITI LA LIBERTÀ la paralisi ferma il coltello di un chirurgo con un tratto di penna l’ultima monarchia assoluta d’Europa passa nella storia il minatore della valle della Morte e l’eccentrico reclamista della strada di Santa Fe possono morire va in casa di correzione per il furto di un angelo di scagliola Sulle rive del Wabash beato.
Mac Il mattino dopo, subito dopo l’alba, Fainy zoppicando entrò, sfuggendo a un pesante acquazzone, nella stazione di Gaylord. C’era una gran stufa con un pancione protuberante, accesa nella sala d’aspetto. Lo sportello del bigliettaio era chiuso. Nessuno in vista. Fainy si tolse prima una scarpa tutta inzuppata e poi l’altra e si abbrustolì i piedi finché le calze furono asciutte. Su ciascun tallone si era formata e rotta una vescica e le calze stavano appiccicate ai piedi per una crosta sporca. Si rimise le scarpe e si distese sulla panca. Di botto, fu addormentato. Un tizio alto, vestito di turchino, gli parlava. Cercò di sollevare la testa ma aveva troppo sonno. «Ehi, amico, faresti bene a non farti trovare dal sorvegliante» disse la voce che aveva sentito prima attraverso il sonno. Fainy aprì gli occhi e sedette. «Acci… credevo foste una guardia.» Un giovanotto spallequadre, in camicia di cotone turchino e tuta, gli stava in piedi accanto. «Ho pensato che era meglio svegliarti, è un tipo il sorvegliante in questo buco.» «Grazie.» Fainy stese le gambe. Aveva i piedi così enfiati che non poteva quasi star dritto. «Perdio, sono ingranchito.» «Di’, se avessimo un quarto di dollaro a testa, conosco un buco dove si potrebbe fare una colazione magnifica.» «Ci ho un dollaro e mezzo io» disse adagio Fainy. Era in piedi con le mani in tasca, la schiena alla stufa calda, e fissava attento le mascelle quadre e maschie e gli occhi azzurri dell’altro giovanotto. «Di dove vieni?» «Vengo da Duluth… sono sulla strada, più o meno. Tu di dove vieni?» «Perdio. Vorrei saperlo. Fino a stanotte avevo un posto.» «Ti sei licenziato?» «Senti, se andassimo a mangiare in quel posto?» «Fantastico! Ieri non ho mangiato… Mi chiamo George Hall… I soci mi chiamano Ike. Non proprio che io sia sulla strada, vedi. È che voglio girare il mondo.»
«Credo che dovrò girarlo il mondo, ora» disse Fainy. «Mi chiamo McCreary. Vengo da Chi. 1 Ma son nato giù nell’Est a Middletown, Connecticut.» Quando aprirono l’uscio della pensione Ferrovieri giù sullo stradale, li accolse un odor di salame, caffè e polvere insetticida. Una bionda dai denti cavallini e dalla voce rugginosa mise loro i piatti. «Dove lavorate, ragazzi? Non mi pare di avervi mai visti.» «Lavoravo alla segheria» disse Ike. «La segheria ha chiuso due settimane fa, perché il sovraintendente si è tirato un colpo.» «Grazie. Lo sapevo.» «Ragazzi, è meglio pagare anticipato.» «Li ho i soldi» disse Fainy, sventolandole in faccia un biglietto da un dollaro. «Be’, se avete i soldi allora pagherete» disse la cameriera scoprendo in un sorriso i lunghi denti gialli. «Sta’ sicura, pomin d’amore, pagheremo come milionari» disse Ike. Si rimpinzarono di caffè, farinata, salame, uova e biscottoni pesanti bianchi, alla polvere di lievito, e alla fine del pasto ridevan talmente delle storie di Fainy sulla vita e gli amori del dottor Bingham, che la cameriera s’informò se avevano bevuto. Ike scherzeggiando riuscì a farsi portare un’altra tazza di caffè a testa, senza aumento. Poi pescò due sigarette peste da una tasca della tuta. «Ne vuoi una, 2 Mac?» «Non si può fumare qui» disse la cameriera. «La signora non lascia fumare.» «Brava, tesoro, filiamo subito.» «Andate lontano?» «Quanto a me vado a Duluth. È là che ci sono i miei…» «Ah, venite da Duluth voi?» «E be’, cosa c’è da ridere su Duluth?» «Non ce da ridere, c’è da piangere.» «Non credete mica di pigliarmi in giro?» «Non val la pena, amore.» La cameriera ridacchiò mentre sparecchiava. Aveva manone rosse e unghie spesse, bianche di rigovernatura. «Ohi, ci sono dei giornali? Voglio qualcosa da leggere mentre aspetto il treno.» «Ve ne porto uno. La padrona prende l’“American” di Chicago.»
«Accidenti, non vedo un giornale da tre settimane.» «Anche a me piace leggere il giornale» disse Mac. «Mi piace sapere quel che succede nel mondo.» «Un mucchio di storie… la maggior parte… in mano degli interessi.» «Hearst è per il popolo.» «Non do fiducia a lui più che agli altri.» «Hai mai letto l’“Appello alla ragione”?» «Di’, sei socialista?» «Sicuro, ho lavorato nella tipografia di mio zio finché i grandi interessi l’han fatto chiudere perché prendeva la parte degli scioperanti.» «Ostia, fantastico… qua la mano… anch’io… Di’, Mac, è un gran giorno per me… non mi capita sempre di incontrare uno che la pensa come me.» Uscirono con un fascio di giornali e sedettero sotto un gran pino un po’ fuori della cittadina. Il sole era uscito bel caldo; grosse nuvole bianche marmoree viaggiavano per il cielo. Eran distesi sul dorso, col capo su un fittone di radice rossiccio, dalla corteccia come un alligatore. A onta della pioggia della notte scorsa, gli aghi del pino eran tiepidi e secchi sotto di loro. Di fronte l’unico binario correva in mezzo ai boschetti e alle radure di una regione disboscata da un incendio, dove la gramigna cominciava a rimettere qua e là pallidi stocchi di foglie verdi. Leggevano fogli del giornale di una settimana prima, voltandoli e rivoltandoli, e discorrevano. «Forse comincerà in Russia, è il paese più retrogrado, dove il popolo è più oppresso… C’era un collega russo che lavorava alla segheria, uno istruito, scappato di Siberia… io gli parlavo molto insieme. La pensava così: diceva che la rivoluzione sociale sarebbe cominciata in Russia e di là avrebbe invaso il mondo. Era un tipo in gamba. Scommetto che era qualche pezzo grosso.» «Zio Tim pensava che sarebbe cominciata in Germania.» «Dovrebbe cominciare proprio qui in America… Abbiamo già libere istituzioni qui… Non ci sarebbe che da liberarci degli interessi.» «Zio Tim dice che stiamo troppo bene in America… non sappiamo che
cosa sia l’oppressione né la miseria. Lui e i miei altri zii erano feniani in Irlanda, prima che venissero qui. È per questo che mi han messo nome Fenian… A papà non piaceva, credo…. non aveva molto fegato, mio papà.» «Hai mai letto Marx?» «No… accidenti però, mi piacerebbe.» «Neanch’io, ho letto però Guardando indietro di Bellamy; è ciò che mi ha fatto diventare socialista.» «Contamelo, avevo proprio cominciato a leggerlo quando son venuto via da casa.» «Dice di un tale che si addormenta e si sveglia nell’anno duemila e la rivoluzione sociale è bell’e fatta e tutto è socialistico e non ci sono più prigioni né miseria e nessuno lavora per sé e non c’è mezzo per nessuno di diventare un ricco azionista o capitalista e tutta la vita è magnifica per i lavoratori.» «È quello che ho sempre pensato anch’io… Sono i lavoratori che creano la ricchezza e son loro che debbono averla, non un mucchio di fannulloni.» «Se potessimo disfarci del sistema capitalistico, dei grandi trust e di Wall Street, le cose andrebbero così.» «Accidenti.» «Quel che ci vorrebbe è uno sciopero generale e che i lavoratori rifiutassero di lavorare ancora per un padrone… Perdio, se la gente soltanto capisse, come sarebbe facile! Gli interessi comandano a tutta la stampa e impediscono ai lavoratori di sapere e di istruirsi.» «Io so stampare niente male, e comporre alla linotype… Sacrodio, un giorno o l’altro potrò far qualcosa forse.» Mac si alzò in piedi. Era tutto vibrante. Una nuvola aveva coperto il sole, ma giù per le rotaie i boschi pelati eran tutto un riflesso verde oro di foglie novelle di betulla al sole. Il suo sangue era come il fuoco. Stava là, coi piedi piantati larghi, guardando giù per le rotaie. Alla curva, nella lontana distanza, comparve un carrello, con sopra una squadra, un grappolo di bruno e di turchino scuro. L’osservò avvicinarsi. La macchia di una bandierina rossa s’agitava sul davanti del carrello, ingrossava, cacciandosi in chiazze di ombra, più grande e
più distinta ogni volta che usciva in una chiazza di sole. «Di’, Mac, faremmo meglio a tenerci nascosti, se vogliamo saltare su quel treno. Ci sono certi luridi… guardiani su questa linea.» «Giusto.» Si allontanarono per un centinaio di metri, nella giovane vegetazione di pini nani e di betulle. Vicino a un grosso ceppo verdemuscoso, Mac si fermò a far acqua. L’orina volava giallosplendida nel sole, scomparendo subito nell’impasto poroso di foglie e legno fradici. Mac era pieno di felicità. Diede un calcio al ceppo. Fradicio. Il piede lo attraversò e una polvere minuta, come fumo, s’innalzò, mentre il ceppo rovinava nei cespugli di sambuco ch’eran dietro. Ike si era seduto su un tronco e si stuzzicava i denti con uno stecchino di betulla. «Di’, sei mai stato sulla costa, Mac?» «No.» «Ti piacerebbe?» «Sicuro.» «E be’, filiamocene insieme fino a Duluth… voglio passare a salutare la vecchia, non la vedo da tre mesi. Poi ci mettiamo nel raccolto dei grani e arriviamo a Frisco o a Seattle quest’autunno. Mi han detto che a Seattle ci sono ottime scuole serali gratis. Voglio studiare un po’, io. Non so ancora un… di niente.» «Fantastico.» «Mai saltato su un merci o viaggiato sulle ruote, Mac?» «Non proprio.» «Allora vienimi dietro e fa’ quel che faccio io. Andrà magnificamente.» Giù dal binario sentirono l’ululo di una sirena di locomotiva. «È il numero tre che fa la curva adesso… Ci saltiamo sopra appena esce dalla stazione. Ci porterà a Mackinaw City entro quest’oggi.» Al cader della sera, quel giorno, entrarono ingranchiti e gelati sotto una piccola tettoia, alla calata dei vaporetti, in Mackinaw City, per ripararsi un po’. Il mondo era nascosto da un’errante nebbia al largo del lago, stillante di pioggia. Avevano comperato un pacchetto da
dieci cents di semi dolci e così non avevano più che novanta cents tra tutti e due. Discutevano su quanto dovevan spendere per cena, quando l’impiegato dei vaporetti, un ometto col paraocchi verde e l’impermeabile, uscì dallo sgabuzzino. «Ragazzi, cercate lavoro?» domandò. «Perché c’è uno della Lakeview House che cerca un paio di lavapiatti. L’agenzia non ne ha mandati abbastanza, pare. Cominciano domani.» «Quanto pagano?» domandò Ike. «Non credo sia molto, ma c’è una buona tavola.» «Ci stai, Mac? Mettiamo da parte la paga e poi andiamo a Duluth in battello come due milionari.» Così quella notte andarono in vaporetto all’isola Mackinac. Era una gran noia all’isola Mackinac. C’era una quantità di vedute spicciole con sopra cartelli “La pentola del diavolo”… “Il pan di zucchero”… “Il balzo degli amanti” e le mogli e i bambini di mediocri uomini d’affari, che venivano da Detroit, Saginaw e Chicago. La donna, grigia in volto, che faceva andare l’albergo, nota come La Direzione, li teneva al lavoro dalle sei del mattino fino a parecchio dopo il tramonto. Non si trattava soltanto di lavare i piatti, ma di segar legna, far commissioni, pulir gabinetti, strofinare pavimenti, rotolare bagaglio e una quantità di faccende fuorivia. Le cameriere eran tutte vecchie zitelle oppure mogli avvilite di contadini che si ubriacavano. L’unico altro maschio del luogo era il cuoco, un ipocondriaco meticcio franco-canadese che pretendeva di venir chiamato Monsieur le Chef. Alla sera stava seduto nella sua capannetta di tronchi dietro l’albergo bevendo calmanti e borbottando qualcosa su Dio. Quando ricevettero il salario del primo mese, fecero su le loro poche cose in un giornale e salirono alla chetichella sul Juniata alla volta di Duluth. Il biglietto ingoiò tutto il capitale, ma furon felici, in piedi a poppa, di osservare la collina di Mackinac coperta d’abeti e di balsamifere sparire nel lago. Duluth: l’intravata sullo scalo, le colline coperte di baracche, gli alti camini sottili, la confusione dei silos gobbi e il fumo delle fabbriche campeggiavano foschi sopra un vasto tramonto rossosalmone. Ike
aveva il diavolo a lasciare il battello, per via di una bella ragazza dai capelli scuri, che per tutto il tempo aveva voluto abbordare. «’Dinci, non ti guarderebbe neanche, Ike, è troppo ben messa, per te» badava a ripetergli Mac. «Ad ogni modo la vecchia sarà contenta di vederci» disse Ike, mentre correvano giù per la passerella. «Mi aspettavo quasi di vederla allo scalo, benché non le avessi scritto che arrivavamo. Ragazzo, che bel pranzo ci darà.» «Dove abita?» «Non lontano. Ti conduco. Di’, non chieder niente del vecchio, eh, è un poco di buono. Dev’essere dentro, ora. La vecchia ha dovuto veder le sue per tirar su noi marmocchi… Ho due fratelli a Buffalo… Non andiamo d’accordo… Lei fa dei ricami fantasia e delle confetture, cuoce dolci al forno, roba così. Lavorava in una panetteria, ma adesso ha la lombaggine troppo forte. Sarebbe stata davvero una donna intelligente, se non fossimo sempre stati così maledettamente poveri.» Presero per una via melmosa su una collina. In cima alla collina c’era una casetta per bene, che pareva una scuola. «Ecco casa nostra… Non capisco perché non ci sia luce.» Entrarono per un cancello nel recinto di piuoli. C’era del garofanetto in fiore nell’aiuola davanti alla casa. Ne sentivano il profumo, benché non potessero quasi vederlo, tant’era buio. Ike bussò. «Perbacco, non capisco cosa sia successo.» Bussò un’altra volta. Poi, accese un fiammifero. Sulla porta era inchiodato un cartello DA VENDERE e il nome di un sensale. «Cristo, quest’è bella, deve aver traslocato. Adesso che ci penso, non ho ricevuto una lettera da lei, in due mesi. Basta che non stia male… Vado a chiedere a Bud Walker qui, all’altra porta.» Mac sedette sullo scalino di legno e attese. In alto, traverso uno squarcio tra le nubi che ancora avevano un’ombra di rosso nel crepuscolo, il suo occhio cadde in un vuoto nero, fitto di stelle. Il profumo dei garofani selvatici gli solleticava il naso. Sentì fame. Un sommesso sibilo di Ike lo scosse. «Vieni» disse quello, brusco, e si mise a camminare in fretta giù per la collina con la testa affondata
tra le spalle. «Dunque, cos’è capitato?» «Niente. La vecchia è andata a stare coi miei fratelli a Buffalo. Quei porci lazzaroni le han fatto vendere tutto, per poterli spendere loro, si vede.» «Cristo, siam ben presi, Ike.» Ike non rispose. Camminarono finché giunsero all’angolo di una via, dov’erano negozi illuminati e tram. Un’arietta di pianola usciva saltellante da un’osteria. Ike si volse e batté Mac sulla schiena. «Andiamo a bere una volta, ragazzo… Diavolo!» C’era soltanto un altro individuo al lungo banco. Era uno alto alto e d’età, ubriaco fradicio, con gli stivaloni da legnaiuolo e con in testa un sudovest, e continuava a urlare con una voce inarticolata: «Datele da sotto, ragazzi!» e a menar botte all’aria con la lunga mano sporca. Mac e Ike buttarono giù due whisky ciascuno, tanto forti e crudi che quasi rimasero senza fiato. Ike si mise in tasca il resto di un dollaro e disse: «Diavolo, usciamo di qui.» Nell’aria fresca della via cominciarono a sentirsi brilli. «Cristo, Mac, andiamocene stanotte… È terribile ritornare alla città dove si è stati da bambini… Incontrerei tutti i mattacchioni che conoscevo e le ragazze che mi han dato delle cotte… Pare che a me venga sempre in mano la punta sporca del bastone.» In una trattoria vicino alla stazione merci trovarono polpette, patate, pane, burro e caffè per quindici cents a testa. Dopo che ebbero comprato delle sigarette, rimasero loro ancora otto e settantacinque tra tutti e due. «Sacrodio, siamo ricchi» disse Mac. «E allora, dove andiamo?» «Aspetta un momento. Vado in ricognizione alla stazione. Una volta ci lavorava uno che conoscevo.» Mac gironzolò sotto un lampione all’angolo della via e fumò una sigaretta, in attesa. Faceva più caldo, da quando era caduto il vento. Da uno stagno in qualche parte nei recinti della stazione veniva il piip piip piip dei rospi. Su per la collina suonava una fisarmonica. Dalla stazione giunse l’ansito pesante di una locomotiva merci e il cozzo di vagoni smistati e lo strepito ritmico delle ruote.
Dopo un po’ sentì il sibilo di Ike dal lato oscuro della via. Corse là. «Mac, bisogna far presto. Ho trovato quel tale. Ci lascerà aperto un vagone sul merci che va all’Ovest. Ha detto che quel treno ci porterà fino alla costa, se non scendiamo.» «Ma come faremo a mangiare se siamo chiusi in un merci?» «Mangeremo benissimo. Lascia fare a me.» «Ma Ike…» «Chiudi il becco, chiudi… Vuoi proprio che tutta la città sappia quel che vogliamo fare?» Camminarono in punta di piedi al buio tra due binari di vetture. Poi Ike trovò uno sportello semiaperto e si cacciò dentro. Mac venne dietro e si chiuse alle spalle con cautela il pannello scorrevole. «Adesso, tutto quel che abbiamo da fare è dormire» bisbigliò Ike, con le labbra che toccavano l’orecchio di Mac. «Il socio mi ha detto che stanotte non ci sono guardiani in servizio.» In fondo alla vettura trovarono del fieno uscito da una balla sfasciata. Tutto il vagone sapeva di fieno. «Neh, che delizia!» bisbigliò Ike. «Da leccarsi il…, Ike.» Ben presto il treno partì e loro si coricarono a fianco a fianco per dormire nel fieno sparso. Il vento freddo della notte soffiava per le fessure del pavimento. Dormirono a sbalzi. Il treno partiva e si fermava, partiva e deviava avanti e indietro sugli scambi e le ruote strepitavano e rintronavano nelle orecchie e rimbombavano sugli incroci. Verso il mattino, caddero in un sonno tiepido e lo strato sottile di fieno sulle tavole diventò improvvisamente morbido e caldo. Nessuno dei due aveva un orologio e il tempo era così coperto che quando si svegliarono non capirono che ora fosse. Ike schiuse un filo di porta perché si potesse veder fuori; il treno stava correndo attraverso un’immensa vallata colma, come per una piena, dell’increspatura verde del frumento in rigoglio. Di tanto in tanto, in distanza, un ciuffo di bosco sporgeva come un’isola. A ogni stazione c’era la cieca massa gobbosa di un silo. «Ostia, questo dev’essere il Red River, ma non capisco dove andiamo» disse Ike. «Sacrodio, la berrei una tazza di caffè» disse Mac.
«Ne avremo del buono a Seattle, corpo se ne avremo, Mac.» Tornarono ad addormentarsi e, quando si svegliarono, avevano sete ed erano ingranchiti. Il treno si era fermato. Non si sentiva alcun rumore. Giacquero sul dorso, stirandosi e ascoltando. «Ostia, chissà dove diavolo siamo.» Dopo un bel po’ udirono i carboni spenti cricchiare lungo il binario e qualcuno che tentava i serrami agli sportelli delle vetture lungo il treno. Stettero così immobili che potevano sentirsi il cuore battere. I passi sui carboni cricchiarono sempre più vicino. La porta scorrevole si spalancò e d’un tratto la vettura fu piena di sole. Stettero immobili. Mac si sentì la spunzonata di un bastone nel petto e sedette, battendo le palpebre. Una voce scozzese gli ronzò nell’orecchio: «Mi pareva che avrei trovato dei milionari in viaggio… Su, in piedi e filate, altrimenti vi spedisco al posto di polizia.» «Porco giuda» disse Ike, strisciando innanzi. «Sacramenti e bestemmie non servono… Se ci avete un paio di fogli, vi lascio andare fino a Winnipeg a far fortuna… Altrimenti, ne spaccherete delle pietre prima di poter cantare alleluia.» Il guardiafreno era un ometto dai capelli neri con un tranquillo fare villano. «Dove siamo, macchinista?» domandò Ike cercando di parlare con l’accento inglese. «Gretna… Siete nel dominio del Canada. Vi si può far citare per aver attraversato illegalmente la frontiera di Sua Maestà, oltre che per vagabondaggio.» «Credo che faremo meglio a svignarcela… Vedete, siamo due figli di nobili che giriamo, sacrodio, per divertirci un po’, macchinista.» «Non serve bestemmiare né equivocare. Quanto avete?» «Due dollari in tutto.» «Fa’ vedere.» Ike tirò fuori di tasca prima un dollaro, poi un altro; ripiegato nel secondo dollaro, c’era un biglietto da cinque. Lo scozzese spazzò i tre biglietti con un solo gesto e poi sbatté lo sportello. Lo sentirono abbassare il saliscendi all’esterno. A lungo rimasero seduti, cheti, nel buio. Alla fine Ike disse: «Mac, dammi un
pugno sul muso. È stata una maledetta sciocchezza… Non avrei mai dovuto tenerli nei calzoni… dentro la cinghia andavano… Così non ci restano che settantacinque cents. Siamo ben presi, adesso… Probabilmente telegraferà alla prossima grossa città per farci prendere». «C’è la polizia a cavallo anche in ferrovia?» domandò Mac con un sordo bisbiglio. «Mah, non ne so più di te.» Il treno si rimise in moto e Ike si rovesciò bocconi e s’addormentò cupo. Mac si distese sul dorso dietro a lui, fissando la striscia di sole che penetrava per la fessura dello sportello, e si chiedeva come fosse l’interno di una prigione canadese. Quella notte, dopo che il treno rimase fermo per qualche tempo in mezzo ai sibili e agli strepiti di un grande scalo merci, si sentì il saliscendi dello sportello aprirsi. Dopo un po’, Ike si arrischiò a far scorrere la porta e si lasciarono cadere ingranchiti e tremendamente affamati, sulla cenere dei carboni. C’era un altro merci sul binario accanto, cosicché tutto quanto si vedeva era un sentiero lucente di stelle, in alto. Uscirono senza fatica dai recinti e si trovarono a camminare per le vie deserte di una città enorme. «Che posto morto come la… che è Winnipeg» disse Ike. «Dev’essere passata mezzanotte.» Girarono, girarono senza posa, finché trovarono una piccola trattoria tenuta da un cinese che stava allora chiudendo. Spesero quaranta cents in un po’ di stufato, patate e caffè. Chiesero al cinese se li lasciava dormire per terra dietro il banco, ma quello li cacciò fuori e si trovarono di nuovo stracchi morti a girare per le larghe vie deserte di Winnipeg. Faceva troppo freddo per sedersi in qualche luogo, e non riuscivano a trovare un posto che avesse l’aria di poter loro offrire una cuccia per trentacinque cents, e così camminarono camminarono sempre, e ad ogni modo il cielo cominciava a impallidire in una lenta alba d’estate nordica. Quando fu giorno pieno, ritornarono dal cinese e spesero i trentacinque cents in farina d’avena e caffè. Poi andarono all’ufficio Impieghi della Canadian Pacific e firmarono l’ingaggio per un campo di costruzioni a Banff. Le ore che dovettero attendere fino
alla partenza del treno le passarono alla biblioteca pubblica. Mac lesse parte di Guardando indietro di Bellamy, e Ike, non riuscendo a trovare un volume di Carlo Marx, lesse una puntata di Quando il dormiente si sveglierà nello «Strand Magazine». Così, quando salirono sul treno, erano pieni della prossima rivoluzione socialista e cominciarono a propinarla a due scarni boscaioli, rossi in faccia, che sedevano di fronte a loro. Di quelli, uno masticò in silenzio tabacco per tutto il tempo, ma l’altro sputò la cicca dal finestrino e disse: «Zucconi che siete, lasciate perdere questi discorsi, se vi preme di continuare a star bene». «Perdio, questo è un paese libero, no? Uno è libero di parlare, no?» disse Ike. «Uno zuccone può parlare finché uno che la sa più lunga non gli dice di chiudere il becco.» «Perdio, non ho voglia d’attaccar briga, io» disse Ike. «E fai bene» disse l’altro: e non parlò più. Lavorarono per la CPR 3 tutta l’estate e al 1° d’ottobre erano a Vancouver. Avevano valigie e abiti nuovi. Ike possedeva quarantanove dollari e cinquanta cents e Mac ottantatré e quindici, dentro un portafogli nuovissimo in pelle di porco. Mac ne aveva di più perché non giocava a poker. Presero insieme una stanza da un dollaro e mezzo e restarono a letto come due principi, la loro prima mattinata libera. Erano abbronzati e induriti e avevano le mani callose. Dopo il puzzo di pipe rancide, di piedi sporchi e di cimici, nei baracconi della compagnia, la stanzetta d’albergo dai letti lindi e dall’assito nitido pareva un palazzo. Quando fu del tutto sveglio, Mac sedette sul letto e tese la mano al suo Ingersoll. 4 Le undici. La luce del sole al davanzale era rossastra per via del fumo delle foreste incendiate, lungo la costa. Scese dal letto e si lavò nell’acqua fredda della catinella. Passeggiò avanti e indietro nella stanza strofinandosi l’asciugamano sul viso e sulle braccia. Gli dava un senso di benessere seguire la forma del collo e il vuoto tra le scapole e il muscolo delle braccia, mentre si asciugava con l’asciugamano fresco e ruvido. «Di’, Ike, cosa dobbiamo fare? Io direi di scendere in battello fino a
Seattle, Wash., come due passeggeri fini. Io vorrei fermarmi a lavorare da tipografo, rende molto. Ho intenzione di studiare come un disperato quest’inverno. Cosa ne dici, Ike? Voglio andarmene da questo buco alla limonata e tornare nel paese di Dio. 5 Cosa ne dici, Ike?» Ike gemette e si rivoltò nel letto. «Svegliati, Ike, porco giuda. Dobbiamo dare un’occhiata a questo paesello e poi via.» Ike sedette sul letto. «Sacrodio, è di una donna che ho bisogno.» «Mi han detto che ci sono delle belle pischerle a Seattle, Ike.» Ike saltò dal letto e cominciò a inondarsi di acqua fredda dalla testa ai piedi. Poi si cacciò nei vestiti e, pettinandosi via l’acqua dai capelli, stava a guardare dalla finestra. «Quando parte ’sto battello…? Perdio, ho fatto due volte la carta geografica stanotte, e tu?» Mac arrossì. Accennò col capo. «Perdio, bisogna che troviamo delle donne. ’Sti sogni indeboliscono l’uomo.» «Non vorrei pigliarmi qualcosa.» «Sacrodio, uno non è uomo finché non ha fatto i suoi tre scoli.» «Va’ là, andiamo a veder la città.» «Se è mezz’ora che ti aspetto!» Corsero giù per le scale, e fuori nella via. Passeggiarono per Vancouver, aspirando l’odor vinoso delle legnamerie lungo la gettata, bighellonando sotto i grandi alberi nel parco. Poi presero i biglietti all’ufficio Battelli, entrarono da un merciaio e si comprarono cravatte a strisce, calze di colore e camicie di seta da quattro dollari. Gli pareva di esser milionari quando salirono sulla passerella del battello di Victoria e Seattle, con gli abiti e le valigie nuove e le camicie di seta. Gironzolarono sul ponte fumando sigarette e guardando le ragazze. «Ostia, là ce n’è un paio che ci starebbero… Scommetto che vanno loro a caccia» bisbigliò Ike nell’orecchio di Mac, e gli diede un fittone nelle costole col gomito, mentre passavano davanti a due ragazze dalle larghe cappelline, che venivano per il ponte in direzione opposta alla loro. «… Cerchiamo di abbordarle.»
Presero due birre al bar e poi tornarono sul ponte. Le ragazze non c’erano più. Mac e Ike passeggiarono un po’ tutti sconsolati per il ponte e poi scoprirono le ragazze appoggiate sulla ringhiera di poppa. Era una notte nuvolosa, di luna. Il mare leggero e le isole cupe, ricoperte di sempreverdi germoglianti, rilucevano in un marezzato bagliore argentino. Tutte e due le ragazze avevano capelli arricciati e cerchi cupi sotto le occhiaie. Mac pensò che avevano un’aria troppo vecchia, ma ormai Ike s’era spinto troppo ed era tardi per fare osservazioni. La ragazza con cui parlò lui si chiamava Gladys. Gli piaceva di più l’altra, che si chiamava Olive, ma Ike le arrivò vicino prima. Rimasero sul ponte a scherzare e ridacchiare, finché le ragazze dissero che avevano freddo; allora scesero nel salone e sedettero su un sofà e Ike andò a comprare una scatola di canditi. «Oggi a pranzo abbiamo mangiato cipolle» disse Olive. «Non ve ne importa mica? Gladys, te l’avevo detto ch’era meglio non mangiarle le cipolle, oggi che dovevamo salire sul battello.» «Diamoci un bacio e ti dirò se me ne importa o no» disse Ike. «Ohi bambolo, non ci parlerete così sfacciato, e sul battello, poi» ribatté Olive: e ai lati della bocca le apparvero due brutte rughe. «Bisogna che stiamo ben attente a tutto quel che facciamo qui sul battello» spiegò Gladys. «La gente è terribilmente sospettosa al giorno d’oggi, di due ragazze che viaggiano sole. Non è una vergogna?» «Sicuro che è una vergogna.» Ike si accostò un altro po’ sul sofà. «Basta… “Fatevi a cerchio e rotolate via.” 6 Dico sul serio.» Olive andò a sedersi dall’altra parte. Ike la seguì. «Una volta si era liberi di fare i propri comodi su questi battelli, ma ora non più» disse Gladys, parlando a Mac con un sommesso tono d’intimità. «E voialtri, lavoravate alle manifatture?» «No, siamo stati alla CPR tutta l’estate.» «Avrete guadagnato dei bei soldi.» Mac notò che, mentre gli parlava, quella continuava a seguire l’amica con la coda dell’occhio. «Uhhh… non troppi… Io ho messo da parte quasi un centone.» «E adesso andate a Seattle?» «Voglio trovar lavoro da linotipista.» «Anche noi stiamo a Seattle. Olive e io abbiamo un alloggetto…
Andiamo sul ponte, fa troppo caldo qui.» Mentre passavano davanti a Olive e Ike, Gladys si piegò e bisbigliò qualcosa nell’orecchio dell’amica. Poi si volse a Mac con un sorriso struggente. Il ponte era deserto. Gli lasciò circondare la vita col braccio. Le dita di Mac sentirono le stecche come di un busto. Le diede una stretta. «Oh, più garbo, bambolo» piagnucolò la ragazza con una vocetta buffa. Mac rise. Levando la mano, le sentì la forma del seno. Camminando, fregò una gamba contro la gamba di lei. Era la prima volta che stava tanto vicino a una ragazza. Dopo un poco, Gladys disse che doveva andare a letto. «Non potrei scendere anch’io?» Quella scosse il capo. «Non qui sul battello. Vi vedrò domani, magari verrete col vostro amico a trovarci a casa nostra. Vi faremo vedere la città.» «Certo» disse Mac. Si mise a passeggiare per il ponte, col cuore che gli batteva forte. Sentiva il pulsare delle macchine e il cavallone, a forma di freccia, dell’acqua tagliata a prua e sussultava allo stesso modo. Incontrò Ike. «La mia ragazza ha detto che doveva andare a dormire.» «Anche la mia.» «Hai concluso qualcosa, Mac?» «Le andremo a trovare domani. Hanno un alloggio a Seattle.» «La mia mi ha dato un bacio. È calda come tutto. Ostia, a momenti credevo che mi palpasse.» «Domani combineremo ogni cosa.» Il giorno dopo c’era un bel sole; davanti alla banchina di Seattle, quando scesero dal battello, c’era tutto uno scintillio, odor di legnami, strepito di carri e urla di conducenti. Andarono a prendere una camera all’YMCA. L’avevan finita di fare i braccianti e i vagabondi, avrebbero trovato lavori più da cristiani, condotto una vita decente e sarebbero andati alla scuola serale. Passeggiarono per la città tutto il giorno e, alla sera, trovarono Olive e Gladys davanti al palo del totem in Pioneer Square. Le cose andarono in fretta. Finirono in un ristorante e bevettero vino rimpinzandosi bene, poi in una birreria all’aperto, dove c’era l’orchestra, e bevettero del whisky. Quando andarono in casa delle
ragazze, presero con sé un quarto di whisky e Mac lo lasciò quasi cadere sugli scalini e le ragazze dissero: «Santo Dio non fate tanto rumore o ci farete arrivare addosso le guardie», e la camera sapeva di profumo e di cipria e c’era biancheria femminile disseminata per tutte le sedie e le ragazze prima cosa si fecero dare quindici dollari a testa. Mac era nella stanza da bagno con la sua, che gli impiastricciò di rossetto il naso, e risero risero finché Mac diventò villano e la ragazza gli diede uno schiaffo. Poi sedettero tutti intorno al tavolo e bevettero un altro po’ e Ike ballò a piedi nudi una danza delle isole Salomone. Mac rise, c’era da crepare, ma era seduto sul pavimento e quando cercò di alzarsi cadde bocconi e tutto in un momento fu nel bagno che vomitava e Gladys che lo mandava all’inferno dalle maledizioni. Riuscì a vestirlo, soltanto che Mac non trovava la cravatta e tutti dicevano ch’era troppo sbronzo e lo spinsero fuori e Mac camminava giù per la strada cantando Make a Noise Like a Hoop and Roll Away e domandò a una guardia dov’era l’YMCA e la guardia lo cacciò in una cella in sezione e ve lo rinchiuse. Mac si svegliò con la testa che gli pareva una macina da mulino in tanti pezzi. Aveva vomito sulla camicia e uno strappo ai pantaloni. Si frugò in tutte le tasche e non riuscì a trovare il portafogli. Una guardia aprì l’uscio della cella e gli disse: «Galleggia» e lui se ne uscì nel sole abbarbagliante che lo ferì negli occhi come un coltello. L’uomo allo scrittoio dell’Y lo guardò in un modo curioso, quando lui entrò, ma lui salì nella sua camera e cadde sul letto senza che nessuno gli dicesse nulla. Ike non era ancora tornato. Mac sonnecchiò continuando nel dormiveglia a sentirsi il mal di capo. Quando si svegliò, trovò Ike seduto sul letto, Ike aveva gli occhi lucidi e le guance rosse. Era ancora un po’ ubriaco. «Di’, Mac, ti han ripulito? Non riesco a trovare il mio portafogli e ho cercato di tornare, ma non son riuscito a trovare la camera. Dio mio, le avrei prese a pugni quelle troie… Sono ancora ubriaco come una scimmia. Di’, quel cranio al banco mi ha detto che dobbiamo sgombrare. Non possiamo tenere ubriaconi all’YMCA.» «Ma, cribbio, abbiamo pagato per una settimana noi.» «Ce ne darà indietro una parte… Su, che diavolo, Mac… Siamo in bolletta, ma mi sento tanto bene… Di’, l’ho vista brutta con la tua Jane, sai, dopo che ti
han buttato fuori.» «Aff! Sto peggio di un cane.» «Non voglio dormire, perché dopo starei male. Vieni fuori, ti farà bene.» Erano le tre del pomeriggio. Andarono in un ristorantino cinese davanti al mare e bevettero caffè. Avevano due dollari ricavati dall’impegnare le valigie. Lo strozzino non volle prendere le camicie di seta, perché erano sudice. Fuori pioveva a catinelle. «Sacrodio, perché siamo stati così stupidi da bere? Siamo proprio due testoni, Ike.» «Ci siamo divertiti… ostia, com’eri ridicolo con quel rossetto su tutta la faccia.» «Io ho un diavolo per capello… voglio studiare e lavorare sul serio; tu sai come voglio dire, non per diventare un lurido sfruttatore, ma per il socialismo e la rivoluzione e tutto, non lavorare e far baldoria, lavorare e far baldoria, come quei maledetti tangheri della ferrovia.» «Diavolo, un’altra volta saremo più furbi e lasceremo il morto in qualche posto al sicuro… Corpo… comincio anch’io ad andare a fondo.» «Se ’sta casa fottuta pigliasse fuoco, non avrei più la forza di uscire.» Stettero seduti nel locale cinese finché poterono e poi uscirono sotto la pioggia alla ricerca di un asilo da trenta cents, dove passarono la notte e le cimici li mangiarono vivi. Al mattino girarono cercando lavoro, Mac nelle tipografie e Ike nelle agenzie di trasporti. Si trovarono alla sera che non avevano avuto fortuna e, siccome era una bella notte, dormirono nel parco. Alla fine fecero tutti e due la firma per un campo di legnami su dallo Snake River. Vennero spediti dall’agenzia in un carro ferroviario zeppo di svedesi e finlandesi. Mac e Ike erano i soli che parlavano inglese. Quando arrivarono, trovarono un sorvegliante così duro e la sbobba così schifosa e la baracca così sporca che dopo un paio di giorni se la batterono, tornando a vagabondare. Faceva già freddo tra le Montagne Azzurre e sarebbero morti di fame se non fossero riusciti a mendicar cibo nelle cucine dei campi di legname, per la strada. Raggiunsero la ferrovia a Baker City e
si arrabattarono a rifar la strada sino a Portland sui treni merci. A Portland non poterono trovar lavoro, tanto avevano gli abiti sporchi, e così marciarono a piedi verso il Sud, traverso una gran vallata dell’Oregon che non finiva mai, piena di frutteti, e dormivano nei granai, guadagnandosi un pasto ogni tanto a tagliar legna o far lavori minuti nei ranci. A Salem, Ike scoprì che aveva lo scolo e Mac non riusciva a dormire la notte, agitato dalla paura di avercelo anche lui. Tentarono di andare da un dottore a Salem. Era un omone con la faccia rotonda e un ridere gioviale. Quando dissero che non avevano denaro, quello trovò che non c’era niente di male e che avrebbero fatto qualche lavoro per pagargli la visita, ma, a sentire che si trattava di una malattia venerea, li cacciò via con un infiammato sermone sui guiderdoni del peccato. Si trascinarono per la strada, affamati e spedati; Ike aveva la febbre e non poteva camminare. Nessuno dei due diceva nulla. Alla fine arrivarono in una stazioncina per le spedizioni di frutta, dove c’erano serbatoi d’acqua, sulla linea principale della Southern Pacific. Qui Ike disse che non ne poteva più e dovevano aspettare un merci. «Dio santo, si starebbe meglio in prigione.» «Quand’uno è disgraziato, in questo paese qui, è disgraziato completo» disse Mac: e chi sa per che motivo tutti e due risero. Tra i cespugli dietro la stazione trovarono un vecchio vagabondo, che bolliva caffè in una scatola di latta. Questi diede loro caffè, pane, un po’ di lardo e Mac e Ike gli raccontarono le loro disgrazie. Disse che andava al Sud per passarvi l’inverno e che il rimedio di quel male era infusione di noccioli e picciuoli di ciliegie. «Ma dove diavolo vado a trovare i noccioli e i picciuoli delle ciliegie?» Va bene, disse di non pigliarsela: non era niente di più che un brutto raffreddore. Era un allegro vecchiotto con una faccia così imbrattata di sudiciume che sembrava una maschera di cuoio marrone. Avrebbe tentato di salire su un merci che si fermava là per acqua, un po’ dopo il tramonto. Mac si appisolò, mentre Ike e il vecchio parlavano. Quando si svegliò, Ike gli gettava urli e tutti correvano verso il merci che s’era già mosso. Nel buio Mac mise un piede in fallo e stramazzò sui traversini. Si slogò un
ginocchio, pestando il naso nella cenere e, quando si fu rimesso in piedi, tutto quel che si vedeva ancora erano i due lumi alla coda del treno, che sparivano nella bruma di novembre. E questa fu l’ultima volta che vide Ike Hall. Si portò indietro sulla strada e venne zoppicando finché giunse presso un rancio. Un cane gli abbaiò contro, tormentandogli le caviglie, ma era troppo abbattuto, Mac, e non gli importava di nulla. Finalmente venne alla porta una donna corpulenta, che gli diede del biscotto e della salsa di mele e gli disse che lo lasciava dormir nel granaio, purché le consegnasse tutti i fiammiferi che aveva. Mac andò zoppicando al granaio, si raggomitolò in un mucchio di erbadolce secca e si mise a dormire. Al mattino, il ranchero, un uomo alto e rubicondo di nome Thomas, dalla voce risonante, venne al granaio e gli offrì di lavorare per qualche giorno al compenso di vitto e alloggio. Furono buoni con lui, e avevano una figlia carina di nome Mona, della quale più o meno Mac s’innamorò. Era una ragazza grassoccia, rosea in faccia, robusta come un maschio, e non aveva paura di niente. Gli dava spintoni e faceva la lotta con lui; e Mac, specialmente dopo che si fu ingrassato e riposato un po’, non poteva quasi dormire, la notte, a pensare di lei. Stava disteso sul letto d’erbadolce, riandando il contatto del braccio nudo che si sfregava al suo, quando Mona gli rendeva la rosa dell’annaffiatoio degli alberi da frutta e lo aiutava ad accatastare i ramicelli potati per bruciarli; e la rotondità dei seni e le fiatate che gli giungevano dolci sul collo come quelle di una mucca, quando ruzzavano e si facevano scherzi, la sera, dopo cena. Ma i Thomas avevano altre intenzioni sulla figlia e dissero a Mac che non avevano più bisogno di lui. Lo mandarono via gentilmente con un sacco di buoni consigli, qualche abito smesso, una colazione fredda avvolta in un giornale, ma niente denari. Mona gli corse dietro, quando lui s’incamminò giù per la carraia polverosa e solcata, e lo baciò dritto sotto gli occhi dei genitori. «Io ti voglio» disse. «Metti insieme tanti soldi e ritorna a sposarmi.» «Perdinci, sta’ sicura» disse Mac; e si allontanò con le lacrime agli occhi e sentendosi tanto bene. Era particolarmente lieto di non essersi
preso la malattia da quella ragazza di Seattle. 1. Chicago. (NdT) 2. Impossibile rendere in italiano la coloritissima espressione gergale americana per “sigaretta”: coffin nail, ossia “chiodo di bara”. (NdT) 3. Canadian Pacific Railway: ferrovia Canada-Pacifico. (NdT) 4. Marca d’orologi. (NdT) 5. God’s country: nomignolo affettuoso col quale gli americani designano la patria. (NdT) 6. Parole di una canzonetta del tempo. (NdT)
Cine-giornale VI Parigi finalmente scandalizzata HARRIMAN COMPARE COME IL RE DELLE FERROVIE noto truffatore travolto TEDDY 1 BRANDISCE IL MANGANELLO il pubblico chiede un miglior servizio tranviario. E noi si navigava sotto il chiaro di luna una voce sussurrava sulla dolce laguna tu mi hai rubato il cuore bimba mia non andare più via mentre noi si cantava una dolce canzone d’amore nel chiaro di luna UNA FOLLA FA UN LINCIAGGIO DOPO UNA PREGHIERA quando il metallo traboccò dal forno io vidi uomini correre in cerca di riparo. Alla destra del forno vidi un gruppo di dieci uomini in corsa pazza con gli abiti tutti in fiamme. Pareva che qualcuno tra loro fosse stato colpito dall’esplosione e diversi incespicarono e caddero. Il metallo rovente coprì i poveretti in un attimo. LODATE LA MONOPOLIZZAZIONE COME UN VANTAGGIO PER TUTTI i nemici dell’industria lavorano alla pace in casa della signora Potter Palmer una dolce canzone d’amore e noi si navigava nel chiaro di luna 1. Il presidente Roosevelt. (NdT)
Occhio fotografico (7) andavamo a pattinare sullo stagno vicino alla fabbrica della compagnia dell’argento veniva un buffo odore irritante dal mucchio di rifiuti accanto allo stagno; era sapone di balena, diceva qualcuno, usato per pulire i coltelli i cucchiai e le forchette d’argento, e lustrarli per la vendita era lustro il ghiaccio, ghiaccio nero recente che risonava come la lama di una sega, tutto graffiato di bianco dai primi pattinatori io non riuscivo a imparare e cadevo sempre attenzione ai forestieri, dicevano tutti, i ragazzi boemi e polacchi mettono pietre nelle palle di neve scrivono parolacce sui muri fanno sporcizie nei vicoli i loro genitori lavorano alla fabbrica noi eravamo giovani decenti Ragazzi Americani Erranti pronti nel maneggiar utensili Uccisori di Cervi giocavamo all’hockey Giovani Esploratori e scrivevamo degli otto sul ghiaccio. Io non riuscivo a imparare e cadevo sempre
Il mago delle piante Luther Burbank nacque in una casa di campagna a Lancaster Mass, andò a passeggio per i boschi un inverno schiacciando la neve dalla crosta lucente capitò in una valletta dove c’era una sorgente calda e trovò l’erba verde e la gramigna germogliante e il cavolo che sporgeva un grumolo potente, andò a casa e seduto accanto alla stufa lesse Darwin La lotta per l’esistenza – L’origine della specie La selezione naturale ciò non era quel che insegnavano in chiesa, così Luther Burbank cessò di credere traslocò a Lunenburg, trovò una pallottola di semi in una pianta di patata seminò quei semi e fece soldi della Selezione naturale del signor Darwin di Spencer e Huxley con la patata Burbank. Giovanotto va’ all’Ovest; Luther Burbank andò a Santa Rosa pieno del suo sogno di erba verde nell’inverno sempre – fioriti fiori sempre – mature bacche; Luther Burbank sapeva far soldi con la Selezione naturale Luther Burbank portò il suo sogno apocalittico di erba verde nell’inverno e di bacche senza semi e di susine senza nocciolo e di rose senza spine di rovi di cactus – Erano squallidi gli inverni in quella squallida casa di campagna nello squallido Massachusetts – laggiù nell’assolata Santa Rosa e fu un vecchio assolato e le rose fiorivano tutto l’anno sempre fiorite sempre mature ibride. L’America era ibrida l’America doveva far soldi con la Selezione naturale.
Lui era un infedele lui credeva in Darwin e nella Selezione naturale e nell’influsso dei grandi morti e nella frutta di un buon spedizioniere adatta a scatolarsi. Fu uno dei grandi uomini di una volta finché le chiese e le congregazioni non annusarono che era un infedele e credeva in Darwin. Luther Burbank non ebbe mai un pensiero di male, sceglieva ibridi riusciti per l’America in quegli anni di sole a Santa Rosa. Ma quella volta urtò un nido di vespe non voleva lasciar andare Darwin e la Selezione naturale e quelle lo morsero e lui morì confuso. Lo seppellirono sotto un albero di cedro. La sua fotografia favorita era quella di un omarino in piedi accanto a un’aiuola di ibridi sempre fiorite margherite Shasta doppie e mai un pensiero di male e il monte Shasta nello sfondo, era una volta un vulcano ma vulcani non ce ne sono più.
Cine-giornale VII ASSERISCE CHE QUESTO SARÀ IL SECOLO DEI MILIARDI E DEI CERVELLI un neonato di Minneapolis giunge qui in un incubatore Cheyenne Cheyenne salta sul cavallino dice che Jim Hill batte il trust del petrolio su 939 punti GROSSO TRENO SALTA IN PEZZI una donna e i bambini annientati ammette di aver visto frustate e persino mutilazioni ma nessun atto spaventevole LA VERITÀ SULLO STATO LIBERO DEL CONGO La Scoperta di Un Grave Difetto in Una Dreadnought Santos Dumont parla del rivale dei rapaci le mogli sono il primo fine dei nativi del Congo una lettera straordinaria che richiama i marinai degli S.U. I BIANCHI NEL CONGO PERDONO IL SENSO MORALE una donna tenuta prigioniera da avvocati in cerca di cause Thaw di Fronte al Giudice nella Lotta Mortale LA MINACCIA DELLA CLASSE OPERAIA NEL CAMPO POLITICO l’ultima rappresentazione di Salomè a New York l’inutile eroismo di una madre C’è posto per due tesoro ma dopo le nozze e il festino due come uno solo torniamo a cavallo del mio cavallino via dalla vecchia Cheyenne
Occhio fotografico (8) uno sedeva sul letto slacciandosi le scarpe Ohi Frenchie strillava Tyler all’uscio devi batterti col Piccolo non ho voglia di battermi devi combatterlo deve combatterlo ragazzi? Frenchie cacciava la faccia per la fessura dell’uscio e faceva una smorfia Devi combatterlo proprio e tutti i ragazzi dell’ultimo piano c’erano se no che uomo sei e io avevo il pigiama e cacciarono dentro il Piccolo e il Piccolo colpì Frenchie e Frenchie colpì il Piccolo e ci si sentiva in bocca sapore di sangue e tutti strillavano Dàgli Piccolo eccetto Gummer e lui strillava Spaccagli il muso Jack e Frenchie mise sotto il Piccolo sul letto e tutti lo strapparono via e tennero Frenchie contro l’uscio e Frenchie menava a destra e a sinistra e non poteva vedere chi lo colpiva e tutti cominciarono a strillare il Piccolo gliele ha date e Tyler e Freddy gli tenevano le braccia e dicevano al Piccolo di venire a colpirlo ma il Piccolo no e si era messo a piangere il sapore sanguigno dolce nauseante e poi sonava la campana del silenzio e tutti correvano alle loro camere e tu entravi nel letto con la testa palpitante e piangevi quando Gummer entrava in punta di piedi e diceva peccato stavolta gliele davi sul serio Jack era una vergogna marcia era stato Freddy a darti quella botta quella volta ma Hoppy gironzolava in punta di piedi per il corridoio e sorprese Gummer che cercava di rientrare nella sua camera e gli diede le sue
Mac Per il giorno del Ringraziamento, Mac se n’era venuto a Sacramento, dove trovò lavoro a spaccare cassettine in un magazzino di frutta secca. Per il primo dell’anno aveva risparmiato tanto da comprarsi un vestito nuovo intero e prendere il battello per San Francisco. Erano circa le otto di sera, quando arrivò. Con la valigia in mano, camminò su per Market Street dallo scalo. Le vie erano piene di luci. Giovanotti e belle ragazze a colori vivaci passavano svelti in mezzo a un gran vento sferzante che scompigliava sottane e sciarpe, rincoloriva a schiaffi le guance, soffiava in aria polvere e fogli di carta. C’eran cinesi, guappi, portoghesi, giapponesi per le vie. Gente si precipitava a spettacoli e ristoranti. Dalle porte dei bar usciva musica; dai ristoranti, sentori culinari di fritto e unto, sentori di birra e di barili di vino. Mac avrebbe voluto fare un po’ di festino, ma non aveva che quattro dollari, e così andò a fissare una camera all’Y e mangiò col caffè un dolce molliccio nella cafeteria deserta, al pianterreno. Quando salì nella camera nuda, qualcosa come un ospedale, aprì la finestra, ma soltanto su un pozzo d’aria. La camera sapeva di una qualche specie di lozione sgrassatrice e, quando Mac si distese sul letto, la coperta sapeva di formaldeide. Stava troppo bene, Mac. Sentiva il sangue fremente ribollirgli per tutto il corpo. Gli occorreva parlar con qualcuno, andare a un ballo, bere una volta con qualche conoscente o scherzare con qualche ragazza. Gli ritornò l’odor di rossetto e di cipria profumata della stanza di quelle ragazze a Seattle. Si alzò a sedere sulla sponda del letto, dondolando le gambe. Poi decise di uscire, ma prima di farlo mise i soldi nella valigia e la chiuse a chiave. Solo come un fantasma, camminò su e giù per le vie, finché non fu stracco morto; camminava in fretta senza guardare a destra o a sinistra, sfiorando agli angoli ragazze dipinte, individui che cercavano di mettergli in mano indirizzi, ubriachi che cercavano di attaccar briga, mendicanti che imploravano un aiuto piagnucolando. Poi, amareggiato, infreddolito e stanco, ritornò alla camera e cadde nel letto.
Il giorno dopo uscì e trovò lavoro in una piccola tipografia diretta e posseduta da un italiano calvo, con grandi basette e fluente cravatta nera, di nome Bonello. Bonello gli disse che era stato camicia rossa con Garibaldi e adesso era anarchico. Ferrer era il suo grande eroe; prese Mac, perché sperava di convertirlo. Per tutto l’inverno Mac lavorò da Bonello, mangiò spaghetti, bevette vino rosso e parlò di rivoluzione alla sera con lui e gli amici; andò a merende socialiste o a riunioni libertarie, alla domenica. Le notti del sabato andava in giro nei casini con un tale di nome Miller, che aveva conosciuto all’Y. Miller studiava da dentista. Mac riuscì a far amicizia con una ragazza di nome Maisie Spencer, che lavorava nel reparto Modisteria dell’Emporium. Alla domenica, essa cercava di farlo andare in chiesa. Era una ragazza calma, dagli occhioni azzurri, che gli sollevava in viso con un sorriso incredulo, quando Mac le parlava di rivoluzione. Aveva dentini perlacei tutti uguali e si vestiva con grazia. Dopo qualche tempo, finì che non lo seccava più con la chiesa. Le piaceva farsi condur da lui a sentir la banda al Presidio o a guardare le statue al Sutro Park. Il mattino del terremoto, il primo pensiero di Mac, quando gli fu passato il proprio grandissimo spavento, fu per Maisie. La casa, dove la famiglia di lei viveva, in Mariposa Street, era ancora in piedi quando vi arrivò, ma tutti se n’erano andati. Non fu che al terzo giorno, tre giorni di fumo, di travi crollanti e di dinamite, nei quali lavorò in una squadra di soccorso, che la trovò a far coda agli approvvigionamenti all’entrata del Golden Gate Park. Gli Spencer stavano in una tenda vicino alle serre fracassate. Maisie non lo riconobbe, perché lui aveva capelli e ciglia abbruciacchiati, i vestiti a brandelli e dalla testa ai piedi era tutto fuliggine. Prima Mac non l’aveva mai baciata, ma stavolta la prese tra le braccia davanti a tutti e la baciò. Quando la lasciò andare, la faccia di lei s’era tutta sporcata di fuliggine sulla sua. Qualcuno della fila rise e batté le mani, ma la vecchia dietro a loro, che aveva i capelli alla Pompadour per storto, in modo che si vedeva il posticcio, e portava due vesti da camera di seta rosa imbottita, l’una sull’altra, disse dispettosamente: «Adesso dovete andarvi a lavare la faccia». Dopo ciò, i due si considerarono fidanzati, ma non potevano
sposarsi, perché la tipografia di Bonello era andata sfondata col resto dell’isolato e Mac era senza lavoro. Maisie si lasciava baciare e stringere nei portoni bui, quando tornavano a casa di notte, ma più in là Mac cessò anche di tentare. Nell’autunno trovò un posto al «Bulletin». Era un lavoro notturno e non vedeva quasi mai Maisie eccetto la domenica, ma cominciarono a parlare di sposarsi dopo Natale. Quando era lontano da lei, Mac si sentiva il più del tempo come irritato contro Maisie, ma quando le era insieme si struggeva davvero. Cercò di farle leggere opuscoli sul socialismo, ma quella rideva e gli voltava i teneri occhioni azzurri e diceva che eran cose troppo profonde per lei. Le piaceva andare a teatro e mangiare nei ristoranti, dove la biancheria era inamidata e c’eran camerieri in marsina. Verso quel tempo Mac andò una notte a sentire Upton Sinclair parlare sui recinti bestiame di Chicago. Vicino gli stava un giovanotto vestito di fustagno. Aveva un naso da falcone, occhi grigi, pieghe profonde sotto gli zigomi e parlava con una pronuncia lenta, strascicata. Si chiamava Fred Hoff. Dopo la conferenza, andarono a prendere una birra insieme e discorrere. Fred Hoff apparteneva alla nuova organizzazione rivoluzionaria detta dei Lavoratori industriali del mondo. Lesse a Mac il programma, sopra un secondo bicchiere di birra. Fred Hoff era arrivato allora come aiuto macchinista su un vapore mercantile. Era stufo della sbobba impossibile e della vita dura del mare. Aveva ancora la paga in tasca ed era deciso a non farla partire in una baldoria. Aveva sentito che c’era uno sciopero di minatori a Goldfield e pensava di andar lassù a vedere che cosa si potesse fare. Fece capire a Mac che conduceva un’esistenza ben stupida, contribuendo a stampare bugie sulla classe lavoratrice. «Perdio, voi siete appunto quel che ci occorre laggiù. Pubblicheremo un giornale a Goldfield, Nevada.» Quella notte Mac andò alla sezione locale, riempì una scheda e tornò alla pensione con la testa vacillante. Stavo proprio per vendermi ai porci fottuti, si disse. La domenica successiva lui e Maisie avevano combinato di salire sulla ferrovia panoramica in vetta al monte Tamalpais. Mac aveva un
sonno tremendo, quando la sveglia lo cavò dal letto. Dovevano partir di buon’ora, perché Mac doveva ritornare al lavoro la notte. Mentre andava allo scalo del chiattone, dove aveva appuntamento con Maisie per le nove, gli stava ancora nella testa il battito delle macchine e l’odor acido d’inchiostro e di carta schiacciata sotto i torchi, e oltre a ciò l’odore del corridoio della casa dov’era stato con due altri, l’odore delle camere muffite e delle secchie d’acqua sporca e l’odor di ascelle e il tavolino da toeletta della ragazza riccia che era stata sua sul letto appiccicoso e il sapore della birra rancida bevuta insieme e la macchinale voce vezzeggiante: «Nanotte, tesoro, torna presto». “Dio mio, sono un bel maiale” Mac disse a se stesso. Una volta tanto, era una mattinata limpida: tutti i colori della via luccicavano come pezzetti di vetro. Dio mio, era stufo di girare a puttane. Se soltanto Maisie fosse stata più di compagnia; se soltanto fosse stata una ribelle con cui parlare come si parla a un amico. E come diavolo fare a dirle che dava un calcio all’impiego? Maisie lo aspettava al chiattone e aveva un’aria da ballerina con l’elegante abito azzurro marinaio e il cappellino a larghe falde. Non ebbero il tempo di dirsi nulla, perché dovettero correre al chiattone. Una volta che ci furono Maisie alzò il viso perché la baciasse. Aveva labbra fresche e la mano guantata poggiava così lieve su quella di lui. A Sausalito salirono sul tranvai e cambiarono e Maisie continuò a sorridergli quando corsero a prender buoni posti nella vettura belvedere e si sentirono così soli nella muggente immensità della montagna fulva, cielo e mare azzurri. Non erano mai stati così felici insieme. Maisie gli corse innanzi per tutta la strada fino alla vetta. All’osservatorio erano tutti e due senza fiato. Si fermarono contro un muro fuori dagli sguardi degli altri e lei si lasciò baciare su tutto il viso, su tutto il viso e il collo. Brandelli di nebbia passavan rapidi nascondendo alla loro vista zone della baia, delle valli e delle montagne oscurate. Quando andarono, girando, dalla parte del mare, un vento gelato strideva dappertutto. Uno schiumoso nebbione sgorgava dal mare come un’ondata di marea. Maisie gli strinse il braccio. «Oh, mi fa paura, Fainy.» Allora, d’un tratto, Mac le disse che aveva lasciato il lavoro.
Lei alzò gli occhi a guardarlo spaventata, battendo i denti nel vento freddo, piccina e sola; e cominciarono a scenderle lacrime dalle due parti del naso. «Ma io credevo che tu mi amassi, Fenian… Credi che sia stato facile per me aspettarti tanto tempo, mentre ti volevo e ti amavo? Oh, credevo che mi amassi.» Mac la circondò col braccio. Non seppe dir nulla. Si incamminarono verso il vagoncino. «Non voglio che tutta quella gente veda che ho pianto. Eravamo così felici prima. Scendiamo a piedi fino ai Muir Woods.» «È lontano, Maisie.» «Non me ne importa niente, voglio andare.» «Ostia, sei in gamba, Maisie.» Si cacciarono giù per il sentiero e la nebbia cancellò tutto. Dopo un paio d’ore si fermarono a prender riposo. Lasciarono il sentiero e trovarono un fondo d’erba in mezzo a un grosso boschetto di cisti. Tutt’intorno c’era la nebbia, ma in alto era luminoso e, attraverso, si sentiva il tepore del sole. «Ahi, mi son venute le bolle» disse Maisie, e mostrò una faccia buffa che fece rider Mac. «Non può più esser tanto lontano» disse. «Sul serio, Maisie.» Avrebbe voluto spiegarle dello sciopero e degli internazionali e perché lui andava a Goldfield, ma non riuscì. Tutto quel che poté, fu di baciarla. La bocca di lei stava attaccata alle sue labbra e le braccia gli erano strette intorno al collo. «Davvero, non sarà diverso per sposarci; davvero, non sarà diverso… Maisie, sono pazzo di te… Maisie, lasciami… Devi lasciarmi… Sul serio, non sai com’è terribile per me, io amarti così e tu non mi lasci.» Mac si alzò e le ricompose il vestito. Maisie stava distesa con gli occhi chiusi e il viso bianco; egli ebbe paura che fosse svenuta. Si inginocchiò e la baciò sulla guancia. Lei sorrise un momento e gli tirò giù il capo e gli arruffò i capelli. «Piccolo marito» disse. Dopo un po’ si rialzarono e attraversarono senza vederlo il boschetto dei legni rossi, fino alla stazione del tranvai. Tornando a casa sul chiattone, decisero che si sarebbero sposati entro la settimana. Mac promise di non andare in Nevada. Il mattino dopo si alzò abbacchiato. E così, si vendeva. Radendosi
nel bagno, si fissò nello specchio e disse quasi a voce alta: «Bastardo, ti vendi ai porci fottuti». Ritornò nella sua camera e scrisse a Maisie una lettera. Cara Maisie, proprio davvero non devi credere neanche per un minuto solo che non ti ami tanto, ma ho promesso di andare a Goldfield per aiutare il gruppo a stampare quel giornale e bisogna che ci vada. Ti manderò l’indirizzo appena arrivato e, se tu avrai proprio bisogno di me, per qualunque cosa, ritornerò subito indietro, davvero ritornerò. Tanto amore e tanti baci da Fainy Andò all’ufficio del «Bulletin» e riscosse lo stipendio, fece su la valigia e andò alla stazione a vedere quando c’era un treno per Goldfield, Nevada.
Occhio fotografico (9) tutto il giorno le fabbriche di concime puzzavano qualcosa di tremendo e di notte la capanna era piena di zanzare capaci di portar uno via ma era Crisfield sulla Costa Orientale e se avessimo avuto una lancia a motore per trasportarli qui dall’altra parte della baia avremmo potuto spedire i pomodori il granoturco e le pesche primaticce spedirle senz’altro a New York invece di farci truffare dai commissionari di Baltimora dirigere una cascina spedire primizie di vegetali irrigare fertilizzare arricchire la terra del Northern Neck esausta dal tabacco se avessimo avuto una lancia a motore avremmo potuto trasportarvi ostriche d’inverno allevare tartarughe per il mercato ma sulla banchina dei treni merci attaccai discorso con un giovanotto non poteva essere molto più vecchio di me dormiva in uno dei vagoni piatti dormiva là nel sole e nell’odore dei fusti di granoturco e nella puzza di pesce fradicio che veniva dalle fabbriche di concimi aveva capelli ricciuti misti di fili di fieno e traverso la camicia aperta si poteva vedere che aveva il corpo abbronzato fino alla cintura credo fosse piuttosto a terra ma era venuto vagabondando per tutta la strada dal Minnesota andava a sud e quando gli dissi della Chesapeake Bay non rimase sorpreso ma disse Credo sia troppo lontano per farla a nuoto troverò un posto in una barca da pesca
Big Bill Big Bill Haywood nacque nel ‘69 in una pensione di Salt Lake City. Venne allevato nello Utah, fece i suoi studi a Ophir, un campo di minatori, nelle risse con sparatoria, nei faraoni delle notti del sabato, nel whisky versato sui tavolini da poker ammucchiati di dollari nuovi d’argento. Quand’ebbe undici anni, sua madre lo mise sotto un campagnolo, lui scappò perché il campagnolo lo sferzava con una frusta. Questo fu il suo primo sciopero. Perdette un occhio tagliuzzando una fionda da un querciolo. Lavorò per bottegai, tenne un banco di frutta, fece la maschera al teatro di Salt Lake, il fattorino, il cameriere al Continental Hotel. Quand’ebbe quindici anni se ne andò alle miniere del distretto Humboldt, Nevada il suo equipaggiamento era una tuta, un perforatore, un camiciotto turchino, scarponi da miniera, due paia di coperte, una serie di pezzi da scacchi, guantoni da boxe e una gran colazione di torta, che sua madre gli aveva preparato. Quando si sposò, andò a vivere al Fort McDermitt costruito nei tempi antichi contro gli indiani, abbandonato ora che non c’era più frontiera; là sua moglie partorì il loro primo bambino senza dottore né levatrice. Bill tagliò il cordone ombelicale, Bill seppellì la placenta; il bambino visse. Bill guadagnava denaro come poteva, facendo misurazioni, curando il fieno a Paradise Valley, domando puledri, cavalcando per un’immensa regione accidentata. Una notte a Thompson’s Mill capitò una cosa strana, egli fu uno dei cinque che s’incontrarono per caso e si fermarono la notte nella fattoria abbandonata. Ciascuno di loro aveva perduto un occhio, erano i soli guerci della regione. Persero la dimora, gli affari andarono a rotoli, la moglie si ammalò, aveva figli da mantenere. Andò a lavorare da minatore a Silver City. A Silver City, Idaho, entrò nella WFM, 1 tenne là il suo primo ufficio d’Unione; fu il delegato dei minatori di Silver City al congresso
della Western Federation of Miners tenuto a Salt Lake City nel ’98. Da allora fu organizzatore, oratore, propagandista, i bisogni di tutti i minatori erano i suoi; combatté a Cœur D’Alene, a Telluride, a Cripple Creek, entrò nel partito socialista, scrisse e parlò attraverso l’Idaho, lo Utah, il Nevada, il Montana, il Colorado a minatori scioperanti per le otto ore, per una vita migliore, per una parte della ricchezza che scavavano dalle colline. A Chicago nel gennaio 1905 si riunì una conferenza che ebbe luogo in quello stesso salone in Lake Street dove gli anarchici di Chicago avevano tenuto riunioni venti anni prima. William D. Haywood fu presidente permanente. Fu questa conferenza a scrivere il manifesto che creò l’IWW. 2 Quando ritornò a Denver, venne rapito nell’Idaho e processato insieme a Moyer e Pettibone per l’assassinio dell’allevatore Steunenberg, ex governatore dell’Idaho, fatto saltare da una bomba in casa. Quando li rilasciarono a Boise (Darrow era il loro avvocato) Big Bill Haywood era noto come capopartito operaio da una costa all’altra. Ora i bisogni di tutti i lavoratori erano i suoi, era il portavoce dell’Ovest, dei cow-boys, dei legnaiuoli, dei braccianti e dei minatori. (La perforatrice a vapore aveva gettato sul lastrico migliaia di minatori; la perforatrice a vapore aveva gettato il panico in tutti i minatori dell’Ovest.) La WFM diventava conservatrice. Haywood lavorò con la IWW a costruire una nuova società nel guscio dell’antica, fece la campagna per Debs presidente nel 1908 sul Red Special. Si trovò in tutti i grandi scioperi dell’Est, dove lo spirito rivoluzionario cresceva, a Lawrence, a Paterson, allo sciopero dei siderurgici del Minnesota. Ma attraversarono l’oceano con l’AEF 3 per salvare i prestiti Morgan, per salvare la democrazia wilsoniana, visitarono la tomba di Napoleone e sognarono l’Impero, presero cocktail di champagne al Ritz e dormirono con contesse russe a Montmartre e sognarono l’Impero; in tutto il paese, alle sedi dell’American Legion e ai pranzi
degli uomini d’affari, far strillare l’aquila rendeva; linciavano i pacifisti e i germanofili e gli internazionali e i rossi e i bolscevichi. Bill Haywood fu processato coi cento e uno a Chicago dove il giudice Landis, il re del baseball, con la sommaria procedura di un tribunale di traffico, distribuiva le sue sentenze di vent’anni e le multe di trentamila dollari. Dopo due anni a Leavenworth, lasciarono uscire Big Bill su garanzia (aveva cinquant’anni, un uomo accasciato, distrutto), la guerra era finita, ma avevano imparato l’Impero nella sala degli Specchi a Versailles; i tribunali rifiutarono un nuovo processo. Dipendeva da Haywood lasciare la cauzione o ritornare in prigione per vent’anni. Era malato di diabete, aveva condotto una vita dura, la prigione gli aveva rovinato la salute. La Russia era una repubblica di lavoratori; andò in Russia e stette a Mosca un paio d’anni e morì: arsero la grossa carcassa distrutta del suo corpo e ne seppellirono le ceneri sotto le mura del Cremlino. 1. Western Federation of Miners: Federazione minatori dell’Ovest. (NdT) 2. Industrial Workers of the World: Lavoratori industriali del mondo. Il sostantivo wobbly, che significa associato a questa organizzazione, è reso in tutta questa traduzione con “internazionale”. (NdT) 3. American Expeditionary Forces: le truppe americane inviate nel 1917 in Europa. (NdT)
Occhio fotografico (10) il vecchio maggiore mi portava di solito al Campidoglio quando il Senato e la Camera dei rappresentanti erano in sessione era stato nel commissariato dell’esercito della Confederazione e aveva modi molto distinti gli inservienti s’inchinavano al vecchio maggiore eccetto i paggi che erano ragazzini non più vecchi di vostro fratello stato paggio una volta nel Senato e ogni tanto un rappresentante o un senatore lo guardava con gli occhi socchiusi magari è qualcuno e s’inchinavano o stringevano cordiali una mano o la levavano il vecchio maggiore vestiva molto elegante nell’abito da mattina e portava favoriti a costoletta di montone e usavamo passeggiare adagio nella piatta luce del sole dentro i Giardini botanici e guardare i cartellini sugli alberi e sui cespugli e vedere i pettirossi grassi e gli stornelli saltellanti per l’erba e salire per i gradini e attraverso l’aria piatta della rotonda con le morte statue di grandezze diverse e la Camera del Senato rosso piatto e la stanza dei comitati e l’Assemblea verde piatto e le stanze dei comitati e la Corte Suprema ho dimenticato il colore della Corte Suprema e delle stanze dei comitati e i bisbigli dietro l’uscio delle tribune dei visitatori e l’aria morta e una voce sgradevole sotto gli abbaini di vetro e le scrivanie sbatacchiate e i lunghi corridoi pieni dell’aria morta e le nostre gambe erano stanchissime e io pensavo agli stornelli sull’erba e alle lunghe vie piene di aria morta e le mie gambe erano stanche e sentivo un dolore tra gli occhi e i vecchi si inchinavano coi vivi occhi socchiusi magari era qualcuno e grosse bocche ostili socchiuse e il feltro nero polveroso e l’odore dei guardaroba e l’aria morta e mi domando a che cosa pensava il vecchio maggiore e a che cosa pensavo io magari a quel grande quadro nella galleria d’arte Corcoran pieno di colonne e di gradini e di cospiratori e Cesare vestito di purpureo steso piatto al suolo chiamato Cesare morto
Mac Mac era appena disceso dal treno a Goldfield, quando un uomo sparuto in camicia e calzoncini color marrone, calzato con uose d’ordinanza, in tela, gli venne incontro. «Dite un po’, che cosa venite a fare, fratello, in questa città?» «Viaggio in libri.» «Che genere di libri?» «Libri scolastici e simili per la Ricerca della verità, Inc. di Chicago.» Mac sparò il tutto molto rapidamente e quell’altro parve impressionato. «Niente da dire» fece. «Andate all’Eagle?» Mac annuì. «Vi accompagnerà Plug, quello col tiro da due… Dovete sapere che stiamo in guardia per quei dannati agitatori, la banda dei non-vogliolavorare.» Fuori del Golden Eagle Hotel c’eran due soldati di guardia, due uomini dall’aria dura, piccolotti, con i cappelli sugli occhi. Quando Mac entrò, tutti quelli che erano al bar si volsero a guardarlo. Lui disse: «Buona sera a tutti» quanto più bruscamente poté e salì dal padrone a chiedere una camera. In tutto questo frattempo si andava chiedendo a chi mai avrebbe avuto il coraggio di domandare dov’era l’ufficio del «Nevada Workman». «Sì, ho un letto per voi. Viaggiatore?» «Sì» disse Mac. «In libri.» Giù abbasso, un omaccio con basette da tricheco era al bar e parlava in fretta con una voce lamentosa, da ubriaco. «Se mi lasciassero soltanto fare di mia testa, caccerei di città quei lavativi in quattro e quattr’otto. Ci sono troppi maledetti avvocati mescolati in questa storia. Cacciarli via, quei lazzaroni. E se resistono, fucilate, è così che parlo al governatore, ma ci son tutti ’sti lazzaroni d’avvocati che intorbidano l’acqua con i mandati e l’habeas corpus e le loro tiritere che non finiscono più. L’habeas corpus un corno.» «Bene, Joe, andateglielo a dire» fece il padrone per calmarlo. Mac comprò un sigaro e bighellonò fuori. Mentre la porta gli si richiudeva dietro, l’omaccio urlava di nuovo. «Vi dico l’habeas corpus un corno.» Era quasi buio. Un vento gelido soffiava lungo le vie dai decrepiti tetti di legno. Con i piedi impacciati nel fango di profonde rotaie, Mac girò intorno a vari isolati, dando occhiate alle finestre buie, in alto. Percorse tutta la città, ma nessun indizio dell’ufficio di un giornale.
Quando si trovò a passare per la terza volta dinanzi alla stessa trattoria cinese, rallentò i passi e si fermò irresoluto allo scalino del marciapiede. In fondo alla via, il gran tronco scabro di una collina sovrastava la città. Dall’altra parte della via, un giovanotto, con testa e orecchie abbassate nel colletto di una giacchetta impermeabile, bighellonava davanti alla vetrina scura di un negozio di articoli di ferro. Mac decise che quello era un lavoratore come si deve e gli andò incontro a parlargli. «Dite, dov’è l’ufficio del “Nevada Workman”?» «Per che diavolo volete saperlo?» Mac e l’altro si guardarono a vicenda. «Voglio vedere Fred Hoff… Sono venuto da San Fran per aiutare in tipografia.» «Hai il biglietto rosso?» Mac tirò fuori il suo biglietto di membro dell’IWW. «Ho anche il biglietto dell’Unione, se volete.» «No, diavolo… Mi sembri in regola, ma come diceva quel tale, pensa se io fossi stato un questurino travestito, adesso saresti in gabbia, caro mio.» «Ho detto che ero un viaggiatore di libri, per entrare in questa lurida città. Ho speso il mio ultimo quarto in un sigaro per sostenermi l’aria borghese.» L’altro rise. «Va be’, compagno. Ti conduco io.» «Cos’è, c’è la legge marziale, qui?» domandò Mac, mentre seguiva quell’altro giù per un vicolo tra due casupole coperte di verde. «Tutti i più luridi gambali gialli dello Stato di Nevada sono nella città… Sarà già molto se non ti capiterà di venir messo fuori con una baionettata nei coglioni, come diceva quel tale.» In fondo al vicolo c’era una casetta grossa come una scatola da scarpe, con finestre vividamente illuminate. Giovanotti in abito da minatore o in tuta empivano il fondo del vicolo e stavan seduti in tre file sugli scalini sgangherati. «Cos’è, un biliardo?» domandò Mac. «È il “Nevada Workman”… Ah, io mi chiamo Ben Evans, adesso ti presento alla squadra… Ohi voialtri, questo è il compagno McCreary… è venuto da Frisco a comporre per il giornale.» «Qua la mano, Mac» disse un gigante dall’aria come di un legnaiolo svedese, e diede alla mano di Mac uno strappo che gli fece scricchiolare le ossa. Fred Hoff aveva una visiera verde, seduto dietro uno scrittoio
ammonticchiato di vantaggi. Si alzò e gli strinse la mano. «Ragazzo, arrivi proprio in tempo. Siamo ben presi qui. Hanno messo dentro il tipografo e noi questo foglio dobbiamo farlo uscire.» Mac si tolse la giacca e andò a esaminare la macchina. Stava piegandosi sul tavolo del compositore, quando Fred Hoff ritornò e lo chiamò con un cenno in un angolo. «Sentite, Mac, vi dico come stanno le cose quaggiù… È una situazione che non manca di comico… La WFM si è messa con i gialli… È una guerra d’inferno. Il Santo è stato qui l’altro giorno e quel fetente Mullany gli ha sparato trapassandogli le braccia, e si trova adesso all’ospedale… Sono furibondi come cani perché noi inculchiamo idee di solidarietà rivoluzionaria, capite? Abbiamo fatto abbandonare il lavoro ai camerieri e a qualcuno dei lavoratori di miniera. Ora l’AFL 1 si fa furba e han trovato una testa di legno di organizzatore di crumiri, bazzicando con i padroni delle miniere al Montezuma Club.» «Ohi, Fred, lasciatemi ambientare un poco alla volta» disse Mac. «Poi, c’è stato un po’ di sparatoria l’altro giorno in faccia a un ristorante basso e il padrone del locale s’è buscato una pallottola e per via di questo adesso abbiamo due dei nostri in prigione.» «Ostia!» «E Big Bill Haywood verrà a parlare la settimana ventura… Ecco, su per giù la situazione è questa, Mac. Io bisogna che butti giù un articolo… Voi siete il capo tipografo e avrete diciassette e cinquanta, come prendiamo tutti. Mai scritto niente?» «No.» «È la volta, questa, che uno rimpiange di non aver lavorato di più a scuola. Accidenti, vorrei saper scrivere decentemente.» «Mi proverò magari a un articolo, se sarà il caso.» «Big Bill ci scriverà qualcosa. Lui scrive bene.» Misero una cuccia per Mac dietro la macchina. Passò una settimana, prima che trovasse il tempo di andare fino all’Eagle a prender la valigia. Sopra l’ufficio e le macchine c’era un lungo solaio con una stufa dove la maggior parte degli altri dormivano. Quelli che avevano coperte, ci si facevan su dentro; quelli che non ne avevano, si mettevano le giacche sulla testa; quelli che non avevan giacca,
dormivano come meglio potevano. In fondo alla stanza c’era un lungo foglio di carta, dove qualcuno aveva stampato il programma a foschi caratteri cubitali. Sulla parete a intonaco dell’ufficio qualcuno aveva disegnato una caricatura di un lavoratore, intitolato “IWW”, che dava a un uomo grasso in cappello a cilindro, intitolato “Padrone di miniera”, un calcio nel fondo dei calzoni. E sopra, avevano cominciato le lettere di “Solidarietà”, ma si erano fermati a SOLIDA. Una notte di novembre, Big Bill Haywood parlò all’Unione dei minatori. Mac e Fred Hoff andarono a trascrivere il discorso per il giornale. La cittadina aveva l’aria solitaria di un vecchio immondezzaio nella gran vallata piena di vento stridente e di neve turbinosa. Il salone era caldo e nebbioso per l’umidità dei grossi corpi, per il fumo del tabacco, per gli spessi indumenti di montagna che esalavano l’odor da capanna delle lucerne a olio, della legna carbonizzata, delle padelle unte e del whisky crudo. Al principio della riunione, qualcuno si muoveva irrequieto, treppicando coi piedi e schiarendosi la gola dal catarro. Anche Mac non si sentiva a posto. Aveva in tasca una lettera di Maisie. La sapeva a memoria. Carissimo Fainy, tutto è andato come avevo paura. Tu sai che cosa voglio dire, amatissimo piccolo marito mio. Sono già due mesi e io sono tanto spaventata e non ho nessuno da dirglielo. Amore devi ritornare subito. Morirò se tu non ritorni. Davvero morirò e mi sento tanta voglia di vederti però ho tanta paura che qualcuno se ne accorga. Così come stanno le cose, bisognerà che andiamo via in qualche posto, quando ci sposeremo, e che non ritorniamo finché sarà passato molto tempo. Se sapessi di poter trovare lavoro costì dove sei, verrei con te a Goldfield. Credo che sarebbe bello se andassimo a San Diego. Ho degli amici là e dicono che è tanto un bel posto e là possiamo dire a tutti che è da un pezzo che siamo sposati. Davvero, vieni tesoro, piccolo marito. Ho tanta voglia di vederti, e sopportare tutto questo da sola è così brutto. Le croci sono tanti baci. La tua affezionatissima moglie, Maisie +++++++++++++++
Big Bill parlava della solidarietà e che tutti dovevano stringersi insieme di fronte alla classe dominante e Mac continuava a domandarsi che cosa avrebbe fatto. Big Bill diceva che era venuto il giorno di cominciare a costruire una nuova società nel guscio di quella antica e che i lavoratori dovevano prepararsi ad assumere il controllo delle industrie da loro create col sudore e col sangue. Quando disse: «Noi siamo per l’unica grande unione», ci fu uno scoppio di evviva e di applausi da tutti i lavoratori del salone. Fred Hoff diede del gomito a Mac, applaudendo. «Buttiamo giù la volta, Mac.» Le classi sfruttatrici sarebbero state inermi contro la solidarietà di tutta la classe lavoratrice. Anche le milizie e i gambali gialli erano in fondo lavoratori. Una volta che avessero compreso la missione storica della solidarietà, la classe dominante non avrebbe mai più potuto adoperarli a mitragliare i loro fratelli. I lavoratori dovevano comprendere che ogni piccola lotta per gli aumenti delle paghe, per la libertà di parola, per condizioni di vita più decenti, significava qualcosa soltanto come parte della grande lotta per la rivoluzione e la repubblica cooperativa. Mac dimenticò Maisie. Quando Big Bill ebbe finito, Mac con la mente era corso innanzi sul discorso tanto che aveva dimenticato ciò che Big Bill diceva, ma era tutto acceso e strillava evviva, come un demonio. Lui e Fred Hoff strillavano e il massiccio minatore boemo che puzzava tanto, lì vicino, applaudiva, e il polacco guercio, dall’altra parte, applaudiva, e il giapponesino, cameriere al Montezuma Club, applaudiva, e il mucchio di italianacci applaudivano e il ranchero alto sei piedi, che era venuto con la speranza di veder botte, applaudiva. «Che razza d’oratore che è, quel figlio d’una vacca» continuava a ripetere. «Vi dico io che lo Utah è lo Stato degli uomini in gamba. Sono di Ogden anch’io.» Dopo la riunione, Big Bill si trattenne all’ufficio e scherzò con tutti e sedette a scriver lì su due piedi un articolo per il giornale. Tirò fuori una fiaschetta e tutti ne presero un sorso, eccetto Fred Hoff che non vedeva di buon occhio che Big Bill, o chiunque altro del resto, bevesse, e tutti se ne andarono a letto col nuovo numero in macchina, stanchi, rossi in faccia e contenti.
Il mattino dopo Mac, quando si svegliò, pensò a un tratto a Maisie, rilesse la lettera e gli vennero le lacrime agli occhi, così seduto sulla sponda del lettuccio prima che qualunque altro fosse in piedi. Cacciò il capo in una secchia di acqua gelida della pompa, ed era così agghiacciata che dovette versarci una pentola di acqua calda della stufa per scioglierla, ma non riuscì a cavarsi dalla fronte quel penoso senso di perplessità. Quando si recò con Fred Hoff alla trattoria per far colazione, cercò di dirgli che ritornava a San Francisco per sposarsi. «Mac, non potete far questo, siete necessario qui.» «Ma tornerò, state certo che tornerò, Fred.» «Il primo dovere è verso la classe lavoratrice» disse Fred Hoff. «Appena il bambino sarà nato e lei potrà tornare a lavorare, io sarò di ritorno. Ma sapete bene com’è, Fred. Non posso pagare le spese d’ospedale con diciassette e cinquanta alla settimana.» «Bisognava star più attenti.» «Ma, sacrodio, sono fatto di carne e di sangue come tutti. Porco giuda, cosa volete che diventiamo, santi di latta?» «Un internazionale non dovrebbe avere né moglie né figli, almeno fin dopo la rivoluzione.» «Ma io non lascio la lotta, Fred… Non mi vendo, giuro in faccia a Dio che non mi vendo.» Fred Hoff era diventato pallidissimo. Succhiandosi le labbra tra i denti, si alzò dal tavolino e uscì dal ristorante. Mac stette seduto un bel po’, tetro come l’inferno. Poi ritornò all’ufficio del «Workman». Fred Hoff era al tavolino e dava dentro a scrivere. «Sentite, Fred,» disse Mac «starò ancora un mese. Scrivo subito a Maisie.» «Lo sapevo che vi sareste fermato. Mac, non siete voi quello che abbandona.» «Ma, sacrodio, voi chiedete troppo a un uomo.» «Troppo è ancor troppo poco» disse Fred Hoff. Mac si mise a sorvegliare il giornale tra le macchine. Per le successive due o tre settimane, quando le lettere di Maisie arrivavano, se le metteva in tasca senza leggerle. Le scrisse, in tono quanto più poté rassicurante, che sarebbe corso da lei non appena i compagni avessero trovato uno da mettere al suo posto. Poi, la notte di Natale, lesse tutte le lettere di Maisie. Erano tutte la
stessa, lo fecero piangere. Non aveva nessuna voglia di sposarsi, ma era un inferno vivere là nel Nevada tutto l’inverno senza una ragazza, e di andare in giro a puttane era stufo. Non piacendogli che i compagni lo vedessero con quell’aria nera, scese a bere un bicchiere nella liquoreria dove andavano i lavoratori camerieri. Un gran coro muggente di canzoni avvinazzate usciva dal locale. Entrando incontrò Ben Evans. «Ciao, Ben, dove vai?» «Vado a berne uno, come diceva quel tale.» «Io, lo stesso.» «Come mai?» «Sono giù di morale.» Ben Evans rise. «Ostia, e io no?… e non è Natale?» Bevettero tre bicchieri a testa, ma il bar era affollato e non si sentivano in vena di festeggiamenti; così portarono una fiaschetta da un litro, tutto quanto poterono permettersi, nella camera di Ben Evans. Costui era un giovane scuro, ben piantato, dagli occhi e dai capelli nerissimi. Veniva da Louisville, Kentucky. Aveva fatto studi notevoli ed era meccanico automobilista. La camera era d’un freddo di ghiaccio. Sedettero sul letto, ciascuno avvolgendosi in una coperta. «E be’, non è un modo anche questo, di far Natale?» disse Mac. «Santo Dio, è andata bene che Fred Hoff non ci ha pescati» sogghignò Mac. «Fred è un maledetto bravo ragazzo, bravo come il sole e tutto, ma non lascia vivere la gente.» «Chi sa, se tutti noi altri assomigliassimo di più a Fred, riusciremmo un po’ più presto a far qualcosa.» «Riusciremmo… ma… Di’, Mac, io ho un diavolo per capello a proposito di quest’affare, le rivoltellate e quei tali del WFM che vanno al Montezuma Club e se la vedono con quel lurido crumiro di Washington.» «Ma nessuno dei nostri rivoluzionari ha fatto niente di questo.» «No, ma noi non siamo molti…» «Ci vuol da bere per te, Ben.» «È proprio come ’sto maledetto litro, come diceva quel tale: se ne avessimo molti saremmo sbronzi, ma non li abbiamo. Se avessimo molti compagni come Fred Hoff, faremmo la rivoluzione, ma non li abbiamo.» Bevettero tutti e due una volta alla bottiglia e poi Mac fece: «Di’, Ben, hai mai ingravidato una ragazza? una di cui tu fossi cotto?». «Sì, a centinaia.» «E non ti è mai rincresciuto?» «Cristo, Mac, se una ragazza non fosse una troia sfondata, non si
lascerebbe, no?» «Ostia, io non ragiono così, Ben… Ma, porco cane, non so come fare… È una brava ragazza, lei, sacr…» «Non c’è da fidarsi di nessuna… Conosco un tale che una volta ha sposato una ragazza così, faceva la vita: si è messa a piangere e gli ha detto che l’aveva riempita. Lui la sposò in regola e poi trovò che la ragazza era una troia che gli diede la sifilide… Te lo dico io, ragazzo… Lisciarle e lasciarle, è l’unico modo per gente come noi.» Finirono il litro. Mac ritornò all’ufficio del «Workman» e andò a dormire col whisky che gli bruciava nello stomaco. Sognò che passeggiava per un campo con una ragazza in una giornata di sole. Il whisky gli era dolceardente in bocca, gli ronzava come api alle orecchie. Non era sicuro se la ragazza fosse Maisie o soltanto una troia sfondata, ma si sentiva tiepido e tenero e lei diceva con una voce dolceardente “facciamo all’amore, piccolo” e Mac le vedeva il corpo attraverso il vestito di garza sottile mentre si piegava su di lei che continuava in cantilena a mormorargli “facciamo all’amore, piccolo” con un ronzio dolceardente. «Ohi, Mac, non avete più intenzione di svegliarvi?» Fred Hoff, strofinandosi il viso e il collo con un asciugamano, gli stava sopra. «Ho bisogno che qui sia tutto pulito prima che arrivino.» Mac sedette sul lettuccio. «Be’, cosa c’è?» Non aveva il mal di capo, ma si sentiva giù, se ne accorse subito. «Dunque eravate pieno, stanotte?» «Pieno un corno, Fred… Ho bevuto una volta, ma sacro…» «Vi ho sentito brancolare qui, andando a letto, come un bue.» «Sentite, Fred, nessuno vi ha preso per balia. So guardarmi da me.» «Ne avete bisogno di balie voi, tutti insieme… Non riuscite neanche ad aspettare che abbiamo vinto lo sciopero prima di girare a bettole e casini.» Mac era seduto sulla sponda del letto e si allacciava le scarpe. «Per che diavolo fottuto credete che stiamo tutti qui… per la nostra salute?» «Non lo so per che cosa i più di voi stiano qui» disse Fred Hoff, e uscì sbattendo la porta. Un paio di giorni dopo, capitò che c’era un altro a disposizione che
sapeva maneggiare una linotype e Mac lasciò la città. Vendette la valigia e i suoi abiti buoni per cinque dollari e saltò su un treno di vagoni bassi carichi di minerale greggio, che lo portò a Ludlow. A Ludlow si sciacquò di bocca la polvere alcalina, mangiò una volta e si ripulì un po’. Aveva una fretta tremenda di arrivare a Frisco, e per tutto il tempo continuò a pensare che Maisie poteva uccidersi. Era pazzo dal desiderio di vederla, di sederle accanto, di ricevere da lei colpettini sulla mano e star seduti a fianco a fianco e sentirla parlare come una volta. Dopo i mesi squallidi e polverosi di Goldfield, ne aveva bisogno, di una donna. Il biglietto per Frisco costava 11,50 e Mac non aveva che quattro dollari e qualche soldo. Cercò di arrischiare un dollaro ai dadi nel retro di una liquoreria, ma lo perdette senz’altro, si prese paura e uscì. 1. American Federation of Labor: Federazione americana del lavoro. (NdT)
Cine-giornale VIII Il prof. Ferrer, già direttore della Escuela Moderna di Barcellona, che fu quivi processato sotto l’accusa di esser stato il principale istigatore del recente movimento rivoluzionario, è stato condannato a morte e sarà fucilato mercoledì se la sentenza non verrà revocata Cook serba fiducia negli eschimesi dice che l’interno dell’isola di Luzon è il più bel sito della terra LE FREDDURE RISCALDANO I DISCORSI SUL POLO Non voglio esser sepolto nella deserta prateria dove il coyote addosso mi urlerà dove il serpente fischia e passa il vento in libertà Le squadre di Gypsy dan l’assalto alla fortezza del peccato I Grandi della Nazione Attendono la Gita sul Fiume Le Donne del Club di Englewood Lavorano per Elevare il Dramma L’Esercito dell’Evangelista Forte di Migliaia Tocca il Cuore a un’Affollata Banchina Ammutolita Possiede dollari 3018 e viene arrestato DÀ UN MILIONE PER LA LOTTA CONTRO I VERMI La Spettrale Parata di Gypsy Smith nel Quartiere Meridionale della Mala Vita con un coraggio che strappò le lacrime al plotone dei dodici uomini distaccati a fucilarlo, Francisco Ferrer andò stamane al fossato preparato per ricevere il suo corpo dopo la scarica fatale Tuffo in Auto; Morte nel Fiume
Occhio fotografico (11) i Pennypacker andavano alla chiesa presbiteriana e le ragazze dei Pennypacker cantavano nel coro con voci fredde e squillanti e tutti salutavano quando andavano in chiesa e all’esterno le foglie dell’estate sugli alberi andavano e venivano verdazzurrogialle attraverso le finestre e noi entrammo tutti in fila nel banco e io domandai al signor Pennypacker diacono della chiesa Chi erano i Molly Maguire? uno scoiattolo gridava sulla quercia bianca ma le Pennypacker e tutte le signorine con i loro migliori cappellini cantando l’inno Chi erano i Molly Maguire? pensieri fori di pallottole in un vecchio granaio pozzi di miniera abbandonati scheletro nero rovesci immondizie piene d’erbacce Chi erano i Molly Maguire? ma era troppo tardi non si poteva parlare in chiesa e tutti i migliori cappellini delle signorine e i graziosi abiti rosa-verde-azzurro-giallo e lo scoiattolo che gridava Chi erano i Molly Maguire? e prima che me ne accorgessi fu la comunione e io volevo dire che non ero stato battezzato ma tutti gli occhi sembravano chiusi quando mi misi a bisbigliare a Con la comunione era succo d’uva in bicchierini e quadratelli di pane raffermo e bisognava inghiottire il pane e mettersi il fazzoletto sulla bocca e sembrar santi e i bicchierini facevano un rumore buffo di risucchio e tutta la chiesa tranquilla in mezzo all’assolata domenica lucidazzurra in mezzo alle querce bianche che andavano e venivano e l’odore di fritture dalla casetta bianca e il fumo azzurro tranquillo domenicale dei comignoli su dalle stufe dove il pollo arrosto soffriggeva e le frittelle e il sugo scuro rimesso al caldo in mezzo agli scoiattoli e ai mucchi delle miniere in mezzo all’azzurra domenica estiva in Pennsylvania i bicchierini il risucchio per bere fino all’ultima goccia della comunione e io mi sentivo prudere la schiena sarei stato colpito dalla folgore a mangiare il pane bere la comunione io non credente né battezzato né presbiteriano e chi erano i Molly Maguire? uomini mascherati cavalcanti di notte, sparanti pallottole nei granai di notte che cosa
cercavano nelle notti di un tempo? il servizio era finito e ciascuno usciva fuori in fila e veniva salutato all’uscita e ciascuno aveva un buon appetito dopo la comunione, ma io non potevo mangiare molto mi prudeva la schiena pauroso di uomini mascherati cavalcanti di notte i Molly Maguire
Cine-giornale IX STELLE COMPROMESSE BEVENDO “Non voglio esser sepolto nella deserta prateria” Non rispettarono l’ultima preghiera Venne sepolto nella deserta prateria UN CAPOCOLLEGIO VIETA I BACI allora ci ritornò il coraggio poiché ci accorgemmo che la salvezza era vicina, tornammo a urlare e strillare ma non sapevamo se ci avevano uditi. Venne poi la liberazione e io perdetti i sensi. Tutti quei giorni e quelle notti scomparvero a un tratto e io caddi addormentato A MEZZANOTTE IL VOTO CHE SEGNERÀ IL DESTINO DI ALTMAN Questo è il quarto giorno che siamo quaggiù. Così credo ma i nostri orologi si sono fermati. Ho atteso nel buio perché abbiamo mangiato la cera delle lampade di sicurezza. Io ho anche mangiato un pezzo di tabacco, della corteccia e un po’ di scarpa. Non sono riuscito che a masticarla. Spero che leggerai questo. Non ho paura di morire. Santissima Vergine abbi pietà di me. Credo che la mia ora sia giunta. Tu sai che cosa posseggo. Lo abbiamo guadagnato insieme ed è tutto tuo. Questo è il mio testamento e tu devi osservarlo. Sei stata una buona moglie. Che la Santissima Vergine ti protegga. Spero che questo ti giungerà un volta o l’altra e lo leggerai. C’è da un po’ molto silenzio quaggiù e mi domando che cos’è stato dei nostri compagni. Addio finché il Cielo non ci riunisca. Disturbatore di Ragazze Sferzato in Pubblico SI STRUGGE PER LE OSTRICHE Dentro una bara stretta sei per tre le ossa marciscono ora nella deserta prateria
Mac Mac andò al serbatoio dell’acqua oltre i binari, aspettando l’occasione di saltare su un merci. Il cappello del vecchio e le sue scarpe rotte erano un grigio cenere di polvere; stava seduto tutto aggobbito con la testa tra le ginocchia e non fece un movimento, finché Mac non gli fu vicino. Mac gli sedette accanto. Un aspro lezzo di sudore febbrile usciva dal vecchio. «Che diavolo avete?» «Sono agli ultimi, tutto qui… Ho patito di polmoni tutta la vita e stavolta ci sono.» La bocca gli si torse in uno spasimo di dolore. Lasciò cadere la testa in mezzo alle ginocchia. Dopo un momento, tornò a rialzarla, dando certi aneliti impotenti con la bocca, come un pesce morente. Quando riebbe il respiro, disse: «Ogni volta mi pare che un rasoio mi tagli i polmoni. Non lasciarmi, ragazzo». «State tranquillo» disse Mac. «Senti, ragazzo, ho bisogno dell’Ovest dove ci sono gli alberi e tutto… Tu devi aiutarmi a salire in uno dei vagoni… Son troppo debole per le strade… Non lasciarmi coricare… Io perdo sangue se mi corico, capisci.» Tornò a soffocare. «Ho qualche dollaro. Magari mi metto d’accordo col guardiafreno.» «Tu non parli da vagabondo.» «Sono un tipografo. Bisogna che arrivi a San Francisco al più presto.» «Un lavoratore. Maledetto me. Senti, ragazzo… Io non lavoro da diciassette anni.» Il treno giunse e la locomotiva si fermò, sbuffante, al serbatoio. Mac aiutò il vecchio a rialzarsi e lo mise appoggiato nell’angolo di un carro basso, carico di pezzi di macchine coperti di un telo cerato. Vide il fuochista e il macchinista guardarli dalla garitta del freno, ma quelli non dissero nulla. Quando il treno partì, il vento era freddo. Mac si tolse la giacca e la mise dietro il capo del vecchio per impedirgli di dibattersi ai sussulti della vettura. Il vecchio sedeva con gli occhi chiusi e la testa abbandonata. Mac non sapeva se era o no morto. Venne notte. Mac
aveva un freddo terribile e si raggomitolò, rabbrividendo, in una piega del telo, dall’altra parte del carro. Nel grigio dell’alba, Mac si risvegliò da un sopore coi denti che battevano. Il treno s’era fermato su un tronco laterale. Si sentiva le gambe così intirizzite che ci volle del tempo prima di potersi drizzare. Andò a vedere il vecchio, ma non capì se era vivo o morto. Si fece un po’ più chiaro e l’Oriente cominciò a infuocarsi come il bordo di un pezzo di ferro in una fucina. Mac balzò a terra e andò lungo il treno verso la garitta. Il guardiafreno sonnecchiava vicino alla lanterna. Mac gli disse che un vecchio vagabondo stava morendo in uno dei carri scoperti. Il guardiafreno aveva una fiaschetta di whisky nella giubba buona attaccata a un chiodo nella garitta. Risalirono insieme lungo il treno. Quando arrivarono al carro scoperto, era quasi giorno. Il vecchio era cascato sul fianco. Aveva il viso bianco e serio come il viso della statua di un generale della guerra civile. Mac gli aprì la giacca e la biancheria lacera e sporca e gli pose la mano sul petto. Era esanime e freddo come un tronco. Quando levò la mano, c’era sopra del sangue appiccicaticcio. «Emorragia» disse il guardiafreno dando, tanto per far qualcosa, uno schiocco con la bocca. Il guardiafreno disse che dovevano calare il corpo dal treno. Lo deposero tosto nel fosso accanto alla ghiaia, col cappello sulla faccia. Mac chiese al guardiafreno se aveva una vanga per sotterrarlo, in modo che i bozzagri non lo trovassero, ma quello disse di no, che i guardiani della linea lo avrebbero visto e seppellito. Ricondusse Mac alla garitta, gli diede da bere e gli domandò tutti i particolari della morte del vecchio. Mac fece la strada fino a San Francisco. Maisie dapprima fu fredda e amara, ma dopo che ebbero parlato un po’ disse che aveva l’aria assottigliata e cenciosa di un vagabondo e scoppiò in lacrime e lo baciò. Andarono a ritirare i risparmi di lei dalla banca e Mac si comprò un abito, poi andarono al Palazzo di Città e si sposarono senza dir nulla ai parenti di Maisie. Erano tutti e due felici, scendendo sul treno verso San Diego e là presero una camera ammobiliata con
uso di cucina e dissero alla padrona che erano marito e moglie da un anno. Telegrafarono ai parenti di Maisie: erano laggiù in luna di miele e presto sarebbero stati di ritorno. Mac trovò lavoro in una tipografia e cominciarono a pagare a rate una casetta sulla spiaggia del Pacifico. L’impiego non era cattivo e Mac era ben felice di quella vita tranquilla con Maisie. Dopo tutto, per un po’ ne aveva abbastanza di fare il vagabondo. Quando Maisie andò all’ospedale per partorire, Mac dovette chiedere due mesi di paga anticipata al padrone, Ed Balderston. E tuttavia dovettero mettere una seconda ipoteca sulla casetta per pagare la nota del dottore. Il bambino era una femmina, aveva gli occhi azzurri e le misero nome Rose. La vita a San Diego era assolata e tranquilla. Mac andava al lavoro il mattino sul trenino a vapore e ritornava la sera sul trenino a vapore e la domenica bighellonava per casa o qualche volta sedeva su una spiaggetta con Maisie e la bambina. Era inteso ormai tra loro che lui doveva fare tutto quel che Maisie voleva, poiché l’aveva tanto fatta soffrire prima che si sposassero. L’anno seguente ebbero un altro figlio e Maisie stette male e fu all’ospedale per molto tempo, in modo che ora tutto ciò che Mac poteva fare col suo stipendio settimanale era di coprire gli interessi dei nuovi debiti e aveva sempre da contar baie al droghiere e al lattivendolo e al panettiere per mantenere aperti di settimana in settimana i conti correnti. Maisie leggeva un sacco di riviste e aveva sempre bisogno di novità per la casa, una pianola, una nuova ghiacciaia, un fornello elettrico. I suoi fratelli facevano denari nei beni immobili a Los Angeles e la sua famiglia saliva nel mondo. Ogni volta che riceveva una loro lettera, Maisie tormentava Mac che chiedesse un aumento al padrone o si cercasse un impiego migliore. Quando qualcuno della cricca rivoluzionaria si trovava in città in bolletta o quando cercavano soldi per fondi di sciopero o cose simili, Mac contribuiva con un paio di dollari, ma non poteva mai far molto per paura che Maisie se ne accorgesse. Tutte le volte che lei trovava l’«Appeal to Reason» o qualunque altro foglio radicale per casa, lo metteva nel fuoco e allora litigavano e stavano col muso e si rendevan la vita infelice per qualche giorno, finché Mac decideva cosa importa
poi e non gliene parlava più. Ma la cosa li teneva separati quasi come se lei credesse che Mac andasse in giro con qualche altra donna. Un sabato pomeriggio Mac e Maisie avevano potuto lasciare a un vicino i bambini e stavano recandosi a un teatro d’operetta, quando videro una folla sull’angolo, di fronte alla farmacia Marshall. Mac si aprì la strada a gomitate. Un giovanotto magro, vestito di cotone turchino, stava accanto al lampione d’angolo dov’era la cassetta incendi e leggeva la Dichiarazione d’indipendenza: Quando nel corso degli avvenimenti umani… Arrivò una guardia e gli disse di circolare. … diritto inalienabile… la vita di libertà e la ricerca della felicità. Adesso ce n’erano due di guardie. Una teneva il giovanotto per le spalle e cercava di strapparlo dal lampione. «Vieni, Fainy, faremo tardi per lo spettacolo» badava a ripetere Maisie. «Ah, va’ a prendere una lima, ’sto lavativo si è chiuso a chiave al lampione» sentì che una guardia diceva all’altra. A questo punto Maisie era riuscita a tirarlo allo sportello del teatro. Dopo tutto, aveva promesso di portarla al teatro e da tutto l’inverno lei non usciva. L’ultima cosa che vide fu che la guardia aveva strappato via, e colpito con un pugno alla mascella quel giovane. Mac stette seduto, nel teatro oscuro e soffocante, tutto il pomeriggio. Non vide i vari atti né i quadri tra un atto e l’altro. Non parlò con Maisie. Stette seduto là con un peso alla bocca dello stomaco. Probabilmente i compagni preparavano in città una battaglia per la libertà di parola. Di tanto in tanto dava uno sguardo al viso di Maisie nel riflesso cupo del palcoscenico. Si era ingrassata un po’, in curve soddisfatte, come fa un gatto accovacciato vicino a una stufa calda, però Maisie era sempre una bella ragazza. Aveva dimenticato già ogni cosa ed era interamente felice a guardar lo spettacolo, le labbra chiuse, gli occhi accesi, come una bambina a una festa. “Mi son proprio venduto ai porci fottuti, proprio, proprio” si ripeteva Mac. L’ultimo numero del programma era Eva Tanguay. La voce nasale che cantava I’m Eva Tanguay, I Don’t Care trasse Mac dalla sua tetra fissità. Ogni cosa di colpo gli fu splendida e chiara, il proscenio con le sue pesanti scanalature dorate, i volti della gente nei palchi, le teste
che aveva di fronte, il vistoso polverulento miscuglio di luci ambrate e azzurre sul palco, la donna magra che si dibatteva dentro il cerchio iridato del riflettore. Il giornale mi dà per demente non… m’… importa. Mac si alzò. «Maisie, ti raggiungerò a casa. Guarda il resto dello spettacolo. Non mi sento a posto.» Prima che lei potesse rispondere, Mac era scivolato al di là della fila degli spettatori, giù per il corridoio, e usciva. Nella via non c’era altro che la solita folla del pomeriggio del sabato. Mac camminò in lungo e in largo per il quartiere del centro. Non sapeva nemmeno dov’era la sede dell’IWW. Aveva bisogno di parlare con qualcuno. Mentre passava davanti all’albergo Brewster, gli giunse una zaffata di birra. Quel che gli occorreva era un sorso. A quel modo veniva matto. All’angolo successivo entrò in una liquoreria e bevette senz’altro quattro whisky di segala. Il banco era affollato di uomini che bevevano, parlavano a voce alta di baseball, incontri di pugilato, Eva Tanguay e la sua danza di Salomè. Accanto a Mac c’era un omone rosso in faccia, col cappello di feltro a larga tesa cacciato indietro sulla testa. Mentre Mac allungava la mano al quinto bicchierino, quello gli pose la sua sul braccio e disse: «Scusate, collega, questo ve lo offro io… Faccio festa oggi…». «Grazie, a voi!» disse Mac. «Collega, scusate se ve lo dico, voi bevete come se aveste intenzione di asciugare tutta la botte in una volta e non lasciarne più niente per noi… accettate un gotto.» «Ma sì, amico» disse Mac. «Un gotto di birra.» «Mi chiamo McCreary» disse l’omone. «Ho venduto ora il mio raccolto di frutta. Sono delle parti di San Jacinto.» «Anch’io mi chiamo McCreary» disse Mac. Si strinsero la mano cordialissimi. «Corpo di un elefante, questa sì che è una coincidenza! Dobbiamo esser parenti o quasi… Di dove venite, collega?» «Io da Chicago, ma i miei erano irlandesi.» «I miei dell’Est, Delaware… ma è la buona vecchia razza scozzeseirlandese.» Su questo fatto vuotarono altri bicchieri. Poi andarono in un’altra
liquoreria, dove sedettero in un angolo a un tavolino e chiacchierarono. L’omone parlava del suo rancho e del raccolto delle albicocche e che sua moglie era inchiodata a letto dal tempo del suo ultimo bambino. «Voglio tanto bene alla pupa, ma cosa deve fare uno? Non si può castrarsi per restar fedeli alla moglie.» «Io amo mia moglie» disse Mac «e ho dei bambini. Rose ha quattro anni e comincia già a leggere e Ed sta imparando a camminare… Ma, accidenti, prima di sposarmi credevo sempre che avrei contato qualcosa al mondo… Non che pretendessi di diventar nulla di speciale… Sapete com’è.» «Proprio, collega, anch’io la pensavo così quand’ero giovanotto.» «Maisie è anche una bella ragazza e mi piace sempre di più» disse Mac, sentendosi sopraffare da una calda lacerante ondata di affetto, come qualche volta al sabato sera, dopo che l’aveva aiutata a fare il bagno ai bambini e a metterli a letto e la stanza era ancor piena di vapore e i suoi occhi incontravano a un tratto quelli di Maisie, e non avevano nessun posto dove andare e si trovavano tutti e due là insieme. L’uomo delle parti di San Jacinto si mise a cantare: Mia moglie è ritornata al paesello urrà, urrà, urrà, amo mia moglie ma, ragazzo mio, mia moglie mi ha lasciato in libertà. «Ma, sacramento,» disse Mac «un uomo bisogna che lavori per qualcosa di più che non se stesso e i suoi figli, per sentirsi soddisfatto.» «Sono con voi as…solutamente, collega, ciascuno per sé e che il diavolo si porti chi sta indietro.» «Cribbio,» disse Mac «vorrei esser ancora sulla strada oppure a Goldfield con la combriccola.» Bevettero, bevettero e mangiarono qualcosa e tornarono a bere, sempre whisky e gotti di birra e l’uomo delle parti di San Jacinto aveva un indirizzo telefonico e telefonò a certe ragazze e comperarono una bottiglia di whisky e andarono in casa loro e il ranchero delle parti di San Jacinto stava seduto con una ragazza per ginocchio cantando My Wife’s Gone to the Country. Mac stava seduto a ruttare in un angolo, con la testa che gli penzolava sul petto; poi d’improvviso si
sentì una rabbia amara e saltò in piedi rovesciando un tavolo con un vaso di vetro sopra. «McCreary,» disse «non è questo il posto per un ribelle che ha coscienza di classe… Sono un internazionale io, capite… Me ne vado a prender parte alla lotta per la libertà di parola.» L’altro McCreary continuò a cantare e non gli prestò attenzione. Mac uscì sbattendo la porta. Una delle ragazze gli andò dietro balbettando del vaso rotto, ma lui le diede uno spintone in faccia e uscì nella via tranquilla. C’era la luna. Aveva perduto l’ultimo trenino e sarebbe dovuto andare a casa a piedi. Quando arrivò a casa, trovò Maisie in chimono, seduta nel portico. Piangeva. «E io che ti avevo preparato una cena così buona» continuava a ripetere; e lo guardava con occhi gelidi e amari come quella volta che lui era ritornato da Goldfield prima del matrimonio. Il giorno dopo Mac aveva un mal di capo martellante e lo stomaco tutto scombussolato. Calcolò di aver speso quindici dollari, che non avrebbe dovuto sprecare. Maisie non gli rivolgeva la parola. Rimase in letto, rivoltolandosi, facendo pietà a se stesso, desiderando d’addormentarsi e di dormire per sempre. Quella domenica, la sera, un fratello di Maisie, Bill, venne a casa. Appena questi entrò in casa, Maisie cominciò a parlare a Mac come se nulla fosse accaduto. Lo addolorò accorgersi che ciò era soltanto per nascondere a Bill che avevano litigato. Bill, poderoso, capelli stopposi, aveva il collo rosso e cominciava a ingrassare. Sedette alla tavola, mangiando l’arrosto e il pane di meliga preparati da Maisie, dicendo grandi cose sui rialzi dei terreni a Los Angeles. Aveva fatto il macchinista ferroviere, era stato ferito in uno scontro e aveva fatto il suo primo colpo con un paio di opzioni su appezzamenti, pagate col denaro del suo risarcimento. Cercò di convincere Mac a lasciar perdere il posto a San Diego e a mettersi con lui. «Ti darò la prima spinta, per amor di Maisie» disse e ridisse molte volte. «E in dieci anni sarai un uomo ricco, come io lo sarò in meno tempo… È il momento questo, Maisie, di tentare, finché siete giovani, altrimenti sarà troppo tardi e Mac non sarà mai altro che un operaio per tutta la vita.»
A Maisie brillavano gli occhi. Andò a prendere una torta coperta di cioccolato e una bottiglia di vino dolce. Le rosseggiavano le guance e rideva continuamente scoprendo tutti i suoi dentini perlati. Non era più stata così bella, da quando aveva avuto il primo bambino. Le parole di Bill sulla ricchezza la ubriacavano. «E se uno non volesse far soldi… sapete quel che diceva Gene Debs: “Io voglio innalzarmi con le masse, non sopra le masse”» disse Mac. Maisie e Bill risero. «Quando un individuo parla così è pronto per il manicomio, poco ma sicuro» disse Bill. Mac arrossì e tacque. Bill respinse la sedia e si schiarì la gola in tono serio: «Senti, Mac… io mi fermo in questa città per qualche giorno a studiare la situazione, ma mi pare che qui sia tutto morto. La mia proposta è questa… Tu sai che cosa penso di Maisie… la credo la più cara ragazzina del mondo. Vorrei che mia moglie avesse la metà di ciò che ha Maisie… Insomma, ecco la mia proposta: in Ocean View Avenue posseggo diverse casette in stile missionario ancora libere, tutte venticinque piedi di facciata, e danno su un’elegante via di proprietari. Me ne han già proposto cinque bigliettoni in contanti. Tra un anno o due nessuno di noi potrà più ficcare il naso là dentro. Sarà la via dei milionari… Ebbene, se sei disposto a prendere la casa sotto il nome di Maisie, ti dico come devi fare… Scambierò la proprietà con te, pagando tutte le spese della trasferta del nome titolare e compenserò le ipoteche, che terrò io per non uscir dalla famiglia, in modo che tu non avrai, tutto sommato, da far pagamenti più grandi di quelli che fai qui e sarai lanciato sulla strada del successo». «Oh Bill caro!» esclamò Maisie. Gli corse addosso, lo baciò sulla testa e sedette su di lui, dondolando le gambe sul bracciolo della seggiola. «Corpo, bisognerà che ci pensi sopra stanotte» disse Mac. «È un bel favore che ci fai, quest’offerta.» «Fainy, mi pare che dovresti essere più riconoscente con Bill» disse Maisie secca. «Certo che accetteremo.» «No, hai tutte le ragioni» disse Bill. «Uno deve pensarci sopra, a una proposta simile. Ma non dimenticare i vantaggi che ci sono, scuole migliori per i ragazzi, un ambiente più distinto, una città in
ascesa, che tutti i giorni si fa più ricca, invece di un buco morto come questo, e la possibilità di farti avanti nel mondo, invece di restare un dannato salariato.» E così, un mese dopo, i McCreary traslocarono a Los Angeles. Le spese del trasloco e dell’assetto del mobilio misero Mac in debito di cinquecento dollari. Per di più la piccola Rose fece la rosolia e il conto del dottore cominciò a salire. Mac non riuscì a trovar lavoro in nessuno dei giornali. All’Unione locale, a cui si trasferì, ne avevano dieci di disoccupati come lui. Spese del gran tempo a camminare per la città tormentandosi. Non gli piaceva più stare in casa. Lui e Maisie non andavano più d’accordo ormai. Maisie aveva sempre la testa a ciò che succedeva in casa di Bill, che tipo di vestiti portava Mary Virginia, sua moglie, come quelli tiravan su i bambini, il bel grammofono nuovo che quelli avevano comperato. Mac sedeva sulle panche dei giardini in città, leggendo l’«Appeal to Reason» e l’«Industrial Worker» e i giornali locali. Un giorno notò l’«Industrial Worker» sporgente dalla tasca dell’individuo che gli sedeva accanto. Erano tutti e due su quella panca da molto tempo, quando qualcosa gli fece volger gli occhi a guardar l’altro. «Di’, non sei Ben Evans tu?» «Porco giuda, Mac, ma come… cosa ti è successo, sei dimagrito.» «Ah, niente, cerco un padrone, tutto qui.» Parlarono a lungo. Poi andarono a prendere una tazza di caffè, in un ristorante messicano, dove alcuni dei compagni si trovavano. Un giovanotto biondo dagli occhi azzurri si mise là con loro e parlava inglese con un accento straniero. Tutti parlavano del Messico. Madero aveva cominciato la sua rivoluzione. Di giorno in giorno si attendeva la caduta di Díaz. Per tutto il paese i peoni battevano le colline, scacciando dai ranchos i ricchi científicos. La propaganda anarchica si diffondeva tra i lavoratori delle città. Il ristorante aveva un tiepido profumo di chile e di caffè troppo tostato. A ogni tavolino c’erano fiori di carta color rosa morato o vermiglio, un lampo di tanto in tanto di denti candidi nel bronzo e volti scuri che parlottavano. Qualcuno di quei messicani apparteneva all’IWW, ma la maggior parte erano anarchici. I discorsi di rivoluzione e di paesi stranieri rendevano di
nuovo Mac felice e avventuroso, quasi avesse uno scopo nella vita, come quando era stato per le strade con Ike Hall. «Senti, Mac, andiamo al Messico a veder che cosa c’è di vero in tutta questa revoluccione» badava a ripetere Ben. «Se non fosse per i bambini… Cristo, aveva ragione Fred Hoff quando me l’ha contata dicendo che un rivoluzionario non deve sposarsi!» Finalmente Mac trovò un posto da linotipista al «Times» e le cose in casa andarono un po’ meglio, ma non aveva mai un soldo d’avanzo, perché tutto andava in soldi di debiti e interessi di ipoteche. Era anche stavolta lavoro notturno e Mac non vide quasi più Maisie e i bambini. La domenica, Maisie portava il piccolo Ed dal fratello Bill e lui e Rose andavano a passeggio oppure facevano gite in tram. Era questa la parte migliore della settimana. La notte del sabato andava talvolta a una conferenza o a far quattro chiacchiere coi compagni alla sede dell’IWW, ma temeva di farsi troppo veder in compagnia di radicali, per paura di perdere il posto. I compagni lo giudicavano alquanto fifoso, ma lo sopportavano, perché era pur sempre uno degli antichi. Ricevette qualche lettera da Milly, che gli diceva della salute di zio Tim. Milly aveva sposato un tal Cohen, ragioniere iscritto, che lavorava in uno degli uffici dei recinti bestiame. Zio Tim viveva con loro. A Mac sarebbe piaciuto farlo venire a star con lui a Los Angeles, ma sapeva che ne sarebbero soltanto nati battibecchi con Maisie. Le lettere di Milly erano scoraggianti. Era curioso, diceva, esser sposata a un ebreo. Zio Tim stava sempre così così. Il dottore diceva ch’era il bere, ma tutte le volte che gli davano qualche soldo, lui se lo beveva senz’altro. Milly desiderava avere dei bambini. Era ben fortunato Fainy, diceva, di avere dei bimbi così belli. Temeva che il povero zio Tim non sarebbe durato molto in questo mondo. Lo stesso giorno che i giornali riportarono l’assassinio di Madero a Messico, Mac ricevette un telegramma da Milly che zio Tim era morto e per piacere mandasse subito denaro per il funerale. Mac andò alla cassa di risparmio e prese 53,75 dollari che teneva depositati per gli studi dei bambini, li portò alla Western Union e ne spedì
telegraficamente cinquanta alla sorella. Maisie non scoprì la cosa finché non giunse il compleanno del ragazzo, quando andò a depositare un regalo di cinque dollari da parte di Bill. Quella notte, quando Mac entrò aprendo a chiave, fu sorpreso di trovare la luce accesa nel vestibolo. Maisie sedeva mezzo addormentata sul sofà dell’entrata, con una coperta addosso, attendendolo. Mac ebbe piacere di vederla e le andò incontro a baciarla. «Cosa c’è, bimba?» disse. Lei lo respinse e balzò in piedi. «Sei qui, ladro,» disse «non potevo dormire se non ti dicevo prima quel che penso di te. M’immagino che li avrai spesi in bevute o con qualche altra donna. Non voglio vederti mai più.» «Maisie, ragazza mia… Che c’è? Parliamo con calma.» «Chiederò il divorzio, questo farò. Rubare il denaro ai tuoi figli per battere i marciapiedi… ai tuoi piccoli bam…» Mac si raccolse e strinse i pugni. Parlò molto calmo, benché le labbra gli tremassero. «Maisie, avevo il diritto assoluto di ritirare quel denaro. Ne depositerò altro entro una settimana o due e il naso ficcalo da un’altra parte.» «Bella speranza di risparmiare cinquanta dollari, tu che non sei uomo capace di procurare una vita decente a tua moglie e ai tuoi figli e devi sottrarli dal conto di quei poveri innocenti.» Maisie ruppe in un secco singhiozzo. «Maisie, piantala con questa storia… ne ho quasi abbastanza.» «Son io che ne ho abbastanza di te e dei tuoi miscredenti discorsi socialisti che non han mai servito a niente, e tutti quei lazzaroni malandati che vai a cercare… Oh se non ti avessi sposato! E non ti avrei mai sposato, sta’ sicuro, se non mi fossi lasciata cogliere a quel modo.» «Maisie, non parlare così.» Maisie gli camminò dritto incontro, con gli occhi sbarrati e febbrili. «La casa è a nome mio, non dimenticartene.» «E va be’, ne ho abbastanza stavolta.» Prima di avervi pensato, si era sbattuto dietro la porta e camminava lungo l’isolato. Cominciava a piovere. Ogni goccia faceva
una chiazza grossa come un dollaro d’argento nella polvere della via. Pareva pioggia da teatro, intorno ai lampioni. Mac non riusciva a trovare un posto dove andare. Inzuppato, continuava a camminare. Su un angolo c’era un ciuffo di palme in un cortile, che offrivano un certo riparo. Rimase là a lungo, tremante. Quasi piangeva pensando alla tiepida delicatezza di Maisie, quando lui tirava un po’ indietro la coperta e s’infilava nel letto accanto a lei addormentata, giunto a casa dal lavoro nella stamperia rintronante e puzzolente; alle sue poppe, al contatto dei capezzoli attraverso la camicia da notte sottile; ai bambini nei loro lettucci fuori nella veranda, e lui che si piegava a baciare tutte e due le piccole fronti tiepide. «Be’, è finita» disse forte, come se parlasse con qualcuno. Soltanto allora gli venne il pensiero: “Sono libero di veder paesi ora, di lavorare per il movimento, di tornare sulla strada”. Alla fine andò alla pensione di Ben Evans. Ce ne volle del tempo per ottenere che qualcuno venisse ad aprire. Quando finalmente fu entrato, Ben sedette nel letto e lo guardò, istupidito dal sonno. «Che diavolo?» «Ben, ho mandato all’aria la casa… vado al Messico.» «Hai le guardie dietro? Porco giuda, non era questo il posto da venire.» «No, è soltanto per mia moglie.» Ben si mise a ridere. «Oh, santa Maria!» «Di’, Ben, vuoi venire al Messico a vedere la rivoluzione?» «Cosa diavolo si farebbe al Messico… Ad ogni modo i colleghi mi han fatto segretario del 257… Bisogna che stia qui a guadagnare i miei 17,50. Ma tu sei tutto a mollo, vestiti e prendi la mia uniforme di fatica che è appesa là sulla porta… Farai meglio a dormire un po’. Adesso me ne vado.» Mac restò in città due settimane, finché trovarono uno per sostituirlo alla linotype. Scrisse a Maisie che lui se ne andava e che le avrebbe mandato denaro per aiutarla a mantenere i bambini, appena sarebbe stato in condizione di farlo. Poi una mattina salì sul treno con venticinque dollari in tasca e un biglietto per Yuma, Arizona. A Yuma scoprì che faceva più caldo che all’Inferno. Un tale alla pensione Ferrovieri gli disse che sarebbe morto certamente di sete se cercava di entrare per di là nel Messico, e nessuno sapeva niente della rivoluzione. Così Mac se ne andò lungo la Southern Pacific a El Paso.
Attraverso la frontiera s’era scatenato l’inferno, dicevano tutti. I banditi potevano prendere Juárez da un momento all’altro. Sparavano sugli americani, solo a vederli. I bar di El Paso erano pieni di rancheri e di minatori che rimpiangevano i bei giorni di una volta, quando Porfirio Díaz aveva il potere ed era possibile a un bianco far denari, al Messico. E fu così, col cuore che gli batteva, che Mac attraverso il ponte internazionale entrò nelle vie in mattoni, polverose e affaccendate, di Juárez. Mac andò in giro osservando i piccoli tranvai, le mule, i muri imbrattati di azzurro oltremarino, le donne peone accovacciate dietro mucchi di frutta al mercato, le facciate a voluta delle chiese decrepite e i bar profondi, aperti sulla via. Tutto era nuovo e l’aria gli riusciva pepata alle narici. Mac si domandava che cosa avrebbe fatto in seguito. Era un avanzato pomeriggio di un giorno di aprile. Mac sudava nella sua camicia turchina di flanella. Si sentiva il corpo insabbiato e pruriginoso e avrebbe desiderato un bagno. “Invecchio per ’sta vita” si disse. Finalmente trovò la casa di un tal Ricardo Perez, che uno degli anarchici messicani di Los Angeles gli aveva detto di andar a cercare. Ebbe da fare a trovarlo, nella grande casa col cortile sporco, al margine della cittadina. Nessuna delle donne che stendevano panni pareva capirlo. Finalmente una voce dall’alto si fece sentire, e in un inglese accuratamente modulato. «Venite su, se cercate Ricardo Perez… favorite… io sono Ricardo Perez.» Mac guardò in su e vide un uomo alto, bronzeo, dai capelli grigi, vestito di un vecchio spolverino marrone, che si sporgeva dall’ultimo balcone del cortile. Salì gli scalini di ferro. L’uomo alto gli strinse la mano. «Compagno lavoratore McCreary… I miei camerati mi hanno scritto che dovevate arrivare.» «Sono io in persona… Sono lieto che parliate inglese.» «Ho vissuto a Santa Fe molti anni e a Brockton, Massachusetts. Sedetevi… favorite, sono felicissimo di dare il benvenuto a un lavoratore rivoluzionario americano… Benché le nostre idee probabilmente non s’accordino in tutto, abbiamo molto in comune. Siamo camerati nella grande lotta.» Batté Mac sulla spalla e lo spinse su una sedia. «Favorite.» C’erano diversi ragazzini gialli in camicie cenciose, che scorrazzavano intorno scalzi. Ricardo Perez
sedette e si prese il più piccolo sulle ginocchia, una bambina dalle treccioline attorcigliate e dalla faccia sporca. Quel luogo sapeva di chile, di olio d’oliva bruciato, di bambini e di bucato. «Che cosa farete nel Messico, compagno lavoratore?» Mac diventò rosso. «Oh, vorrei entrare, non so, negli avvenimenti, nella rivoluzione.» «La situazione quaggiù è molto imbarazzante… I nostri lavoratori di città si stanno organizzando e hanno una coscienza di classe, ma i peoni, i campagnoli, vengono facilmente deviati da capi senza scrupoli.» «Vorrei vedere del movimento, Perez… Vivevo a Los Angeles e stavo per diventare un maledetto arrivista come tutti. Credo di sapermi guadagnare la vita come tipografo.» «Bisogna che vi presenti ai camerati… Favorite… Andremo subito.» Il crepuscolo azzurrino piombava sulle vie, mentre uscivano. S’accendevan lumi, gialli. Pianoforti automatici tintinnavano e rimbalzavano nei bar. Sulla soglia di un portone, un’orchestrina stonata suonava. Il mercato era tutto illuminato da torce vacillanti, ogni genere di lucide merci dai colori vivaci era in vendita nelle baracche. In un angolo, un vecchio indiano e una vecchia dalla faccia larga, ciechi e fittamente butterati tutti e due, cantavano una stridula canzone interminabile in mezzo a un numeroso gruppo di campagnoli bassi e tarchiati, le donne con scialli neri sul capo, gli uomini in abiti di cotone che parevano pigiami. «Cantano dell’assassinio di Madero… Serve molto all’educazione del popolo… Capite, non sanno leggere i giornali e così ascoltano le notizie nelle canzoni. È stato il vostro ambasciatore ad assassinare Madero. Era un idealista borghese, ma un grand’uomo… Favorite… Ecco il salone… Vedete, quel cartello dice “Evviva la rivoluzione rivendicatrice preludio alla rivoluzione sociale”. Questo è il salone dell’Unione anarchica dell’industria e dell’agricoltura. Huerta ha qualche federale qui, ma sono tanto deboli che non osano attaccarci. La Ciudad Juárez è corpo e anima con la rivoluzione… Favorite rivolgere due parole di saluto ai compagni.»
Il salone fumoso e il palco erano pieni di uomini foschi in abiti da fatica di cotone turchino; in fondo c’era qualche peone in bianco. Molte mani strinsero quella di Mac, occhi neri lo guardarono fisso negli occhi, parecchi lo abbracciarono. Gli venne data una sedia, di quelle pieghevoli, nella prima fila del palco. Evidentemente Ricardo Perez era il presidente. Seguirono applausi a ogni pausa del suo discorso. Un senso di grandi avvenimenti aleggiava nel salone. Quando Mac si alzò in piedi, qualcuno urlò in inglese «Solidarietà per sempre». Mac balbettò qualche parola sul fatto che lui non era un rappresentante dell’IWW, ma che tutti i lavoratori americani con coscienza di classe seguivano la rivoluzione messicana con grandi speranze, e concluse col motto dell’IWW: costruire la nuova società dentro il guscio dell’antica. Il discorso divenne imponente quando Perez lo tradusse, e Mac si sentì a posto. Poi la riunione continuò un bel pezzo, altri discorsi, e ogni tanto canzoni. Mac si trovò a sonnecchiare, varie volte. Il suono di quella lingua straniera gli metteva sonno. Riusciva a malapena a tenersi sveglio, finché una bandetta attraverso la porta spalancata del salone non proruppe in un motivo e tutti si misero a cantare e la riunione si sciolse. «È Cuatro milpas… significa quattro meligai, è una canzone di peoni, che tutti cantano ora» disse Perez. «Ho una certa fame… vorrei trovare qualcosetta da mangiare, in qualche luogo» disse Mac. «Non ho mangiato da stamattina, che ho preso una tazza di caffè e un tortello a El Paso.» «Mangeremo in casa del nostro compagno» disse Perez. «Favorite… di qua.» Entrarono dalla via, ora nera e vuota, attraverso un’altra porta dalla tenda a perline, in una stanza imbiancata, rischiarata violentemente da una fiamma di acetilene che sapeva forte di carburo. Sedettero all’estremità di un lungo tavolo coperto di un panno macchiato. Il tavolo si riempì a poco a poco di gente della riunione, la maggior parte giovanotti in abiti turchini da fatica, con sottili facce sveglie. All’altra estremità sedeva un vecchio scuro, dal grosso naso e dai larghi zigomi piatti da indiano. Perez versò a Mac due bicchieri di un liquido bianco dal sapore curioso, che gli fecero girare la testa. Il
cibo era piuttosto infuocato di pepe e chile e Mac un pochino ci soffocò. I messicani coccolavano Mac, come un bambino al compleanno. Dovette bere molti bicchieri di birra e di cognac. Perez andò a casa presto e lo lasciò in consegna a un giovane di nome Pablo. Pablo aveva una Colt automatica a tracolla, attaccata a una bretella, e ne andava molto orgoglioso. Parlava un po’ di inglese misto e sedeva con una mano al collo di Mac, l’altra sulla fibbia della custodia. «Gringo 1 male… Uccidere subito… Compagno lavoratore bene… internacional… Urrà» continuava a dire. Cantarono diverse volte L’internazionale, e poi La marsigliese e La carmagnola. Mac si sentiva trasportare in un vapore pepato. Cantava, beveva, mangiava, finché tutto cominciò a perdere i contorni. «Compagno lavoratore sposare graziosa ragazza» disse Pablo. Erano a un bar, in qualche parte. Fece il gesto di dormire con le due mani contro la faccia. «Venite.» Andarono a una sala da ballo. All’ingresso tutti dovevano lasciare le armi da fuoco su una tavola, sotto la sorveglianza di un soldato dal berretto a visiera. Mac notò che uomini e ragazze si tenevano un po’ scostati da lui. Pablo si mise a ridere. «Credere voi gringo… Dico io revolucionario internacional. Là, bella ragazza… Niente brutta puttana… non pagare bella ragazza lavoratrice… compagno.» Mac si trovò che lo presentavano a una ragazza bruna dal viso largo, di nome Encarnación. Era ben messa e aveva i capelli nerosplendidi. Gli diede il lampo luminoso di un sorriso. Mac la carezzò sulla guancia. Bevettero birra al bar e se ne andarono. Pablo aveva anche lui una ragazza insieme. Gli altri si fermarono ancora alla sala da ballo. Pablo e la sua vennero con loro a passeggio fino alla casa di Encarnación. Era una camera in un cortiletto. Al di là c’era una gran distesa di deserto color chiaro, che spaziava fin dove giungeva l’occhio, sotto una luna evanescente. In lontananza, c’eran certe macchioline di fiamma. Pablo le indicò con tutta la mano e sussurrò: «Revolución». Poi gli altri dissero buona notte, alla porta della cameretta di Encarnación, che conteneva un letto, un quadro della Vergine e una recente fotografia di Madero appuntata con uno spillo. Encarnación
chiuse la porta, la inchiavistellò e sedette sul letto fissando Mac con un sorriso. 1. Ingiuria messicana contro gli angloamericani. (NdT)
Occhio fotografico (12) quando tutti se n’andavano in viaggio Jeanne ci portava ogni giorno a giocare in Farragut Square e raccontava come sul Giura d’inverno scendono i lupi e ululano per le strade dei villaggi e qualche volta vedevamo il presidente Roosevelt passare tutto solo a cavallo di un baio e un giorno fummo molto fieri perché quando ci levammo il cappello fummo molto fieri perché lui sorrise mostrandoci i denti come nel giornale e si toccò il cappello e noi fummo molto fieri e lui aveva un aiutante di campo ma avevamo un’anitra di panno con la quale giocavamo sugli scalini finché cominciava a imbrunire e i lupi ululavano correvano col sangue dei bambini grondante dal muso per le strade dei villaggi soltanto che era d’estate e tra il cane e il lupo ci metteva a letto e Jeanne era una ragazza francese del Giura dove i lupi ululavano correvano per le strade e quando tutti erano andati a letto lei ci prendeva in letto con sé ed era una lunghissima storia di spavento e il più cattivo dei lupi che ululavano per le strade nel crepuscolo per gelare il sangue dei bambini era il Loup Garou ululante nel Giura e noi eravamo atterriti e lei aveva mammelle sotto la camicia da notte e il Loup Garou era spaventoso e pelo nero e sfrega contro di lei e fuori i lupi ululavano nelle strade e in quel posto era bagnato e lei diceva che non era nulla che si era lavata ma il Loup Garou era davvero un uomo stringimi forte chéri un uomo che ululava per le strade col muso insanguinato che squarciava il ventre delle bambine e dei ragazzi il Loup Garou era molto utile perché in seguito si sapeva come erano fatte le ragazze e lei era molto sciocca e si faceva promettere di non dirlo ma voi comunque non l’avreste detto
Cine-giornale X IL BREVETTO DI MOON È TUTTO FUMO gli insorti vincono alle elezioni del Kansas sposini di Oak Park che dividono una folla di 8000 persone per fare una corsa in auto dice che la ragazza mendicò per suo marito I SENTIMENTI DELLA PLATEA FAVORISCONO UN RIVOLGIMENTO O mia bella bambolina grossa bella bambolina il mondo non può capire tutto ciò che vi è in questo, ella disse. Appare come un comune avvenimento mondano con gli orpelli della bassezza e della volgarità, ma non c’è nulla di tutto questo. Egli è onesto e sincero. Io lo conosco. Ho combattuto a fianco a fianco con lui. Il mio cuore è ora con lui lascia che ti stringa al cuore lascia che ti guardi amore Quasi Immobili Nel Languore Dell’Estate Sull’Oceano Degli Affari Un Milione Di Persone Vedono Ubriachi Sballottati paragonano l’amore al Vesuvio le vie decorate attendono il passaggio dei paladini in marcia nella spettacolosa parata lascia che ti guardi amore o mia bella bambolina grossa bella bambolina SCAMBIA UN CAVALLO BIANCO CON UNO ROSSO le truppe di Madero sconfiggono i ribelli in Battaglia a Parral Roosevelt trionfa nell’Illinois per 115.000 L’Eloquenza chiude gli occhi Chicago chiede più acqua NOTI ANARCHICI BACIANO IN GINOCCHIO LA BANDIERA DEGLI S.U. Il Movimento Sunbeam si Estende LA BOMBA N. 4 FRANTUMA UN LOCALE DEL QUARTIERE OVEST una notizia stampata mercoledì secondo la quale un paziente ricoverato in una sezione privata dell’ospedale San Luca, sottoposto all’operazione
estirpatoria di una vegetazione cancerosa alla base della lingua, sarebbe il generale Grant, è stata smentita tanto dalle autorità dell’ospedale quanto dal luog. Howze che definì la storia una tendenziosa invenzione
Occhio fotografico (13) lui era capitano di rimorchiatore e conosceva il fiume come il palmo della sua mano da Indian Head ai Virginia Capes e la baia e la Costa Orientale sino a Baltimora certo e abitava ad Alexandria in una casa di mattoni rossi la cabina del pilota puzzava di cento pipe spente quello è il Mayflower il panfilo del presidente e quell’altro è il Dolphin e quello è il vecchio monitore Tippecanoe e quello lì è il cutter guardiacoste e adesso stiamo giusto doppiando la lancia della polizia quando capitan Keen alza il braccio per tirare la corda della sirena sul soffitto della cabina di pilotaggio gli si può veder tatuato sul polso sotto i peli neri il braccialetto rosso e verde sull’anima mia il vecchio capitan Gifford 1 era amico mio quante volte siamo andati per ostriche insieme sulla Costa Orientale e i pirati ostricai a quei tempi intrappolavano i giovanotti e li facevano lavorare come negri tutto inverno non si poteva scappare altro che raggiungendo la riva a nuoto e l’acqua era troppo maledettamente fredda e il vecchio ci portava via i vestiti a tutti quanti per impedirci di guadagnare la riva quando s’era ancorati in una cala o vicino a una casa o roba del genere ragazzo mio quelli eran schiene da galera i pirati ostricai sull’anima mia ogni volta che c’era un giovanotto lo facevan lavorare sino all’esaurimento e allora lo buttavano in mare a raccoglier ostriche, o ad alare la draia proprio roba da pirati ostrici d’inverno si faceva il lavoraccio più bestiale con la spruzzaglia che ghiacciava sul cordame e ti tagliuzzava le mani e la draia che s’inceppava ogni minuto e noi la si doveva issare a bordo e aggiustare con le nostre mani una volta issammo un pezzo duro Che cos’è un pezzo duro? Sull’anima mia un pezzo duro è un morto ragazzo mio ed era un giovane per giunta senza un filo addosso e il cadavere dava segno di esser stato percosso con una caviglia qualcosa di tremendo oppure con un remo chissà forse non voleva lavorare o era malato o roba del genere e il vecchio non avrà fatto altro che picchiarlo sino a farlo morire certo non poteva esser stato che un pirata ostricaio 1. Da questo punto sino alla fine del brano il testo americano usa una forma dialettale sia sintatticamente sia foneticamente: ci è
impossibile renderla in italiano, e d’altra parte il passo perde parte della sua vivezza. (NdT)
Janey Quando Janey era piccola, viveva in una vecchia casa in mattoni, a facciata piatta, due o tre porte su per la collina, partendo da M Street in Georgetown. La parte anteriore della casa era sempre scura, perché mamma teneva chiuse le pesanti tendine di pizzo e abbassate le cortine gialle di lino, dai frammezzi di pizzo. I pomeriggi della domenica Janey, Joe, Ellen e Francie dovevano star seduti nella camera anteriore a guardar vignette o leggere libri. Janey e Joe leggevano insieme la pagina umoristica, perché erano i più vecchi e gli altri due non erano che marmocchi ancor troppo giovani per capire quel che fosse umoristico. Non potevano ridere forte perché papalino sedeva col resto del «Sunday Star» davanti, e di solito, dopo pranzo, si addormentava con la prima pagina sgualcita in una manona dalle vene azzurre. Piccole increspature di sole dardeggianti tra le aperture del pizzo nella cortina della finestra gli si posavano sulla testa pelata, su una grossa pinna rossa del naso, sulla piega di un baffo, sul picchiettato panciotto festivo e sulle maniche bianche e inamidate della camicia dai polsini lucenti, sostenute sopra il gomito da un elastico. Janey e Joe stavano seduti sulla stessa seggiola e si sentivano vicendevolmente le costole sobbalzare quando ridevano di Bibì e Bibò che mettevano un grosso petardo sotto lo sgabello del capitano. I più piccoli li vedevano ridere e ridevano anch’essi, ma «Non siete capaci di star zitti?» sibilava Joe da un angolo della bocca. «Non sapete di che cosa ridiamo.» Una volta ogni tanto, se non si sentivano rumori da parte di mamma, che faceva la sua siesta domenicale disopra, distesa nella stanza da letto posteriore, in una vestaglia con le frange lilla scolorita, prima ascoltavano a lungo lo stiracchiato grugnito, che finiva in un sibilo, di papalino che russava, poi Joe si lasciava scivolare dalla seggiola e Janey gli veniva dietro, tenendo il respiro, fin nell’entrata, e fuori. Una volta chiusa la porta con molta cura perché il martello non battesse, Joe le dava una pacca, gridava: «Sei sotto» e correva giù dalla collina verso M Street, e lei doveva rincorrerlo, col cuore che le batteva, con le mani fredde dalla paura che Joe scappasse e l’abbandonasse.
D’inverno i marciapiedi di mattoni eran gelati e donne di colore spargevano cenere fuori delle porte, quando i bambini al mattino andavano a scuola. Joe non voleva mai camminare con loro, perché erano ragazze; si fermava indietro o correva innanzi. Janey avrebbe desiderato di camminargli al fianco, ma non poteva lasciare le sorelline che si tenevano strette alle sue mani. Un inverno presero l’abitudine di salire la collina con una ragazzina mulatta, che stava proprio dirimpetto a casa loro e si chiamava Pearl. Al pomeriggio, Janey e Pearl tornavano a casa insieme. Pearl aveva di solito due o tre soldi per comperare confetti o banane candite in un piccolo negozio su per Wisconsin Avenue e faceva sempre a metà con Janey, che le voleva molto bene. Un pomeriggio, Janey disse a Pearl di entrare e giocarono alla bambola insieme sotto il grande cespuglio di rose Sharon, nel giardino. Quando Pearl andò via, la voce di mamma chiamò dalla cucina. Mamma aveva le maniche rimboccate sulle pallide braccia scolorite e un grembiule a quadretti e stava impastando una sfoglia per la cena, in modo che aveva le mani coperte di farina. «Janey, vieni qui» disse. Janey s’accorse dal freddo timbro di quella voce che c’era qualcosa che non andava. «Sì, mamma.» Janey stava davanti alla madre, scuotendo il capo in modo che le due rigide trecce rossicce sferzavano da una parte all’altra. «Sta’ ferma, per amor di Dio… Janey, vorrei parlarti di una cosa. Quella bambina di colore che hai condotto in casa oggi…» A Janey cadde il cuore. Provò come un malessere e s’accorse di arrossire, non seppe nemmeno lei perché. «Non capir male, apprezzo e rispetto la gente di colore, qualcuno tra loro è una persona come si deve e rispettosa di sé nella sua condizione… Ma tu non devi più condurre in casa quella bambina negra. Trattare le persone di colore gentilmente e con rispetto è uno degli indizi di una buona educazione… Non devi dimenticare che la famiglia di tua madre era gente distinta, tutti di nascita… Georgetown era molto diversa in quei tempi. Abitavamo in una grande casa con magnifici prati… ma non devi mai andare insieme a gente di colore, da pari a pari. Vivendo in questi paraggi è ancor più importante far molta attenzione a queste cose… Né i bianchi
né i neri rispettano quelli che… Insomma Janey, hai capito, e adesso corri a giocare, presto sarà ora di cena.» Janey cercò di dir qualcosa ma non riuscì. Rimase irrigidita in mezzo al cortile, sopra la griglia che copriva la fogna, fissando lo steccato posteriore. «Ami i negri» le gridò Joe in un orecchio. «Ami i negri, pun – pap – pa… Ami i negri, ami i negri, pun – pap – pà.» Janey si mise a piangere. Joe era un ragazzo taciturno dai capelli rossi, che già da piccolo sapeva dare un tiro imprendibile alla palla. Imparò a nuotare e tuffarsi nel Rock Creek e diceva di solito che voleva fare il manovratore sui tram, quando sarebbe stato grande. Per diversi anni il suo miglior amico fu Alec McPherson, che aveva il padre macchinista sulla B. e O. 1 Allora Joe volle fare il macchinista. Janey soleva andar sempre dietro ai due ragazzi, quando questi glielo permettevano, nelle rimesse in fondo alla Pennsylvania Avenue, dove fecero amicizia coi bigliettai e i manovratori che li lasciavano qualche volta salire con loro sulla piattaforma, per un paio d’isolati, se non c’erano controllori in giro; giù lungo il canale o su per il Rock Creek, dove acchiappavano girini e cadevano nell’acqua e si spruzzavano di fango. Le sere d’estate, che il crepuscolo dopo cena durava a lungo, giocavano ai leoni e alle tigri con altri ragazzi del vicinato tra l’erba alta di qualche appezzamento sgombro, vicino al cimitero di Oak Hill. C’erano lunghi periodi di tempo in cui la rosolia o la scarlattina giravano e mamma non li lasciava uscire. Allora veniva Alec da loro e giocavano nel cortile. Queste erano le volte che Janey preferiva. Allora i ragazzi la trattavano come una di loro. Il buio dell’estate cadeva loro addosso, soffocante e pieno di lucciole. Se papalino era di buon umore, la mandava su per la collina al negozio di North Street a comprare il gelato, e là c’erano giovanotti in maniche di camicia e paglietta, gironzolanti con ragazze che portavano un pezzo di agarico nei capelli per tener lontane le zanzare; un sentore aspro e l’odor di profumo ordinario che veniva dalle famiglie di colore, riunite sulle soglie di casa, a ridere e parlare sommesso con un lampo dei denti, con un giro del bianco dell’occhio, ogni tanto. La densa notte sudaticcia era paurosa, ronzava e rombava di tuoni lontani, di insetti e lo strepito del traffico lungo M Street e l’aria della via, densa e
irrespirabile sotto gli alberi fitti, ma quand’era con Alec e Joe, Janey non aveva paura, neanche degli ubriachi o dei grossi negri che passavano strascicando i piedi. Quando erano di ritorno, il papalino fumava un sigaro e sedevano tutti nel cortile e le zanzare li mangiavano vivi e mamma e zia Francine e i piccoli mangiavano il gelato e papalino fumava il sigaro e raccontava storie di quando era stato capitano di rimorchiatore laggiù nel Chesapeake ai suoi tempi e aveva salvato il brigantino Nancy Q pericolante sui Kettlebottoms in una bufera di scirocco. Poi veniva l’ora di andare a letto e mandavano a casa Alec e Janey andava a dormire nella soffocante stanzetta posteriore, all’ultimo piano, con due sorelline nei lettucci contro la parete opposta. Magari si levava un temporale e Janey giaceva sveglia sbarrando gli occhi al soffitto, fredda dalla paura, e ascoltava le sorelline piagnucolare nel sonno, finché non le giungeva il rumore tranquillante di mamma che girava per casa chiudendo le finestre, e il tonfo di una porta, il gemito del vento e lo strepito della pioggia, e il tuono che le piombava tremendamente fragoroso e vicino sul capo, come un migliaio di carri da birra che rimbombassero sul ponte. In tali momenti pensava di scendere nella camera di Joe e cacciarsi nel suo letto, ma per chissà quale motivo aveva paura di farlo, benché una volta o due fosse arrivata fino al pianerottolo. Joe le avrebbe riso dietro e l’avrebbe chiamata pastamolle. Circa una volta alla settimana, Joe se le prendeva. Papalino arrivava a casa dall’ufficio Brevetti dove lavorava, irritato e fuori di sé, e le ragazze ne avevano paura e giravano per casa chete come topolini; ma Joe pareva ci pigliasse gusto a provocarlo, correva fischiando per il vestibolo posteriore o strepitava su e giù per le scale piantando un fracasso d’inferno con le sue scarpe chiodate in punta e placcate di ferro. Allora papalino cominciava a sgridarlo e Joe gli si fermava davanti senza dire una parola, fissando il pavimento con scontrosi occhi azzurri. Le viscere di Janey si contorcevano e rabbrividivano, quando papalino saliva le scale alla volta della stanza da bagno, spingendosi innanzi Joe. Sapeva quel che sarebbe accaduto. Papà tirava giù la cinghia del rasoio di dietro l’uscio, si metteva la testa e le spalle del figlio sotto il braccio e batteva. Joe serrava i denti,
s’infiammava e non diceva una parola e, quando papalino era stanco di batterlo, si guardavano in faccia, Joe riceveva l’ordine di salire nella sua camera, papalino scendeva le scale tremando tutto e facendo finta che niente fosse successo, e Janey sgusciava fuori nel cortile coi pugni serrati bisbigliando a se stessa: «Lo odio… lo odio… lo odio». Una volta, una notte piovigginosa di sabato, Janey stava davanti alla palizzata, nel buio, a guardare la finestra illuminata. Sentiva la voce di papalino e di Joe, che contendevano. Pensò che probabilmente sarebbe caduta morta al primo schianto della cinghia. Non si poteva sentire che cosa dicevano. Poi, d’un tratto, venne il suono di cuoio dei colpi, e Joe che soffocava un ansito. Janey aveva undici anni. Qualcosa si schiantò. Si precipitò in cucina con tutti i capelli bagnati di pioggia. «Mamma, ammazza Joe. Tienilo.» Sua madre alzò un viso appassito, impotente, sfinito, da una padella che stava strofinando. «Oh, non c’è niente da fare.» Janey corse su per le scale e si mise a battere sull’uscio del bagno. «Basta, basta» gridava la sua voce. Aveva paura, ma un qualcosa più forte di lei l’aveva presa. L’uscio si aprì; c’era Joe con un’aria balorda e papalino con tutta la faccia in fiamme e la cinghia del rasoio in mano. «Batti me… son io cattiva… Non voglio che tu batta Joe così.» Aveva paura. Non sapeva che cosa fare, le bruciavano le lacrime negli occhi. La voce di papalino fu inaspettatamente buona: «Tu va’ subito a letto senza cena e ricordati che hai abbastanza da fare a combattere le tue battaglie, Janey». Janey corse nella sua camera e si gettò sul letto, tremando. Quando si fu addormentata, la voce di Joe la svegliò di sussulto. Era in piedi in camicia da notte all’uscio. «Di’, Janey» mormorò. «Non far più questo, sai. So guardarmi da me. Una ragazza non deve mettersi così tra gli uomini. Quando lavorerò e guadagnerò abbastanza soldi, mi comprerò un fucile e, se papalino cerca di darmele, lo ammazzo.» Janey cominciò a tirar su dal naso, quasi piangeva. «Cosa c’è da piangere per questo, non è mica il diluvio.» Janey lo sentì ridiscendere le scale in punta di piedi, scalzo. Rimase nel letto, vestita, sentendosi sola e orribilmente vergognosa e come se
volesse abbracciare Joe e anche papalino e insieme li odiasse. Quando entrò alla scuola media, prese il corso commerciale e imparò stenografia e dattilografia. Era una ragazza semplice dal viso esile tra i capelli rossi, tranquilla e popolare tra gli insegnanti. Aveva le dita svelte e imparò con facilità a scrivere a macchina e a stenografare. Le piaceva leggere e di solito prendeva alla biblioteca libri come The Inside of the Cup, The Battle of the Strong, La rivincita di Barbara Worth. Sua madre badava a ripeterle che si sarebbe rovinata gli occhi, se leggeva tanto. Leggendo soleva immaginar di essere l’eroina e che il debole fratello, che finiva male ma era gentiluomo nell’anima, capace di qualsiasi sacrificio, come Sydney Carton in Le due città, era Joe, e l’eroe, Alec. Stimava Alec il più bel ragazzo di Georgetown e il più forte. Alec aveva capelli neri tagliati corti, una pelle molto bianca con qualche lentiggine e un modo energico, quadrato, di camminare. Dopo di lui, Joe era il più bello e il più forte e di tutti il miglior giocatore di baseball. Tutti dicevano che avrebbe dovuto continuare la scuola media visto che era un così buon giocatore di baseball, ma finito il primo anno papalino disse che aveva tre ragazze da mantenere e che Joe doveva mettersi a lavorare; così questi s’impiegò da fattorino nella Western Union. Janey era ben fiera di lui in uniforme, finché le compagne di scuola non la presero in giro. Ad Alec i genitori avevano promesso di mandarlo all’università, purché se la cavasse bene alla scuola media, e così Alec studiava d’impegno. Non era villano e sboccato, come la maggior parte dei ragazzi che Joe conosceva. Era sempre gentile con Janey, benché non mostrasse mai il desiderio di trovarsi da solo a sola con lei. Janey ammetteva a se stessa di avere una terribile cotta per Alec. Il giorno più bello della sua vita fu quella soffocante domenica estiva che andarono tutti e tre insieme in canoa alle Grandi Cascate. Janey aveva preparato il pranzo la sera prima. Al mattino aggiunse una braciola che trovò nel frigorifero. C’era un vapore azzurro in fondo a tutte le vie – case in mattoni e scuri alberi verdestate – quando, prima che chiunque altro fosse sveglio, lei e Joe sgattaiolarono di casa verso le sette, quel mattino.
Trovarono Alec all’angolo di fronte alla stazione. Stava ad aspettarli coi piedi piantati larghi e un pentolino in mano. Si misero a correre e presero il tram, che partiva allora per Cabin John’s Bridge. Ebbero la vettura tutta per loro, come fosse un tram privato. Il tram ronzava sopra le rotaie passando oltre capanne imbiancate e casupole di negri lungo il canale, costeggiando colline dove la meliga ondeggiante alta sei piedi marciava in file come tanti soldati. La luce del sole balenava in un bagliore biancoazzurro sopra le agitate foglie penzolanti della meliga ciuffosa; un bagliore e un frinio, un tintinnio di cavallette e libellule, saliva in caldo fumo nel cielo pallido, intorno al tram elettrico sbatacchiante, sussultante. Mangiarono mele dolci, che Joe aveva comperate da una donna di colore alla stazione, e si rincorsero per il tram e si lasciarono cadere l’uno sull’altro negli angoli dei sedili e risero e ridacchiarono finché furono stracchi. Poi il tram passò attraverso i boschi; si vedeva l’intravatura della giostra delle automobili di Glen Echo in mezzo agli alberi e saltarono giù dal tram al Cabin John’s, che si erano divertiti più che una banda di scimmie. Corsero al ponte a guardare a monte e a valle il fiume bruno e scuro nella bianca mattinata abbagliante tra le sponde molli di foglie; poi trovarono la canoa, che era di un amico di Alec, in una casa presso il canale, comperarono limonata, bibite dolci, qualche pacchetto di mentini e partirono. Alec e Joe pagaiavano e Janey sedeva al fondo col maglione avvolto intorno a un banco, da cuscino. Alec pagaiava a prua. Faceva un caldo soffocante. Il sudore gli teneva la camicia appiccicata all’infossatura della schiena tozza, che si piegava a ogni colpo di pagaia. Dopo un po’ i ragazzi si misero in costume da bagno, che indossavano già sotto gli abiti. Diede un brivido in gola, a Janey, guardare la schiena e i muscoli sporgenti del braccio di Alec che pagaiava; la riempì di felicità e di paura. Stava là, seduta, nell’abito bianco di tela, abbandonando la mano nell’acqua erbosa verdebruna. Si fermarono a raccogliere ninfee e altri candidi fiori d’acqua, che risplendevano come di ghiaccio, e dappertutto c’era l’odore umido, fradicio delle limacciose radici di ninfea. La limonata si scaldò e la bevettero così com’era e si canzonarono a vicenda e Alec sprofondò
per sbaglio la pagaia e coprì l’abito di Janey con spruzzi verdemelmosi e a Janey non importava nulla e chiamarono Joe capitano e Joe si lasciò andare e confessò che sarebbe entrato in marina e Alec disse che avrebbe fatto l’ingegnere civile e costruito un battello a motore e portato tutti in crociera e Janey era felice perché includevano anche lei, quando parlavano, come se fosse anche lei un ragazzo. In un punto sotto le cascate, dove c’erano cateratte nel canale, ebbero da fare un lungo trasporto a spalle su per il fiume. Janey portava le provviste, le pagaie e la padella, e i ragazzi sudavano e sacramentavano sotto la canoa. Poi attraversarono pagaiando fino alla sponda della Virginia e fecero un fuoco in una cavità tra grigi pietroni rugginosi. Joe cosse la braciola e Janey aprì il pacco dei panini imbottiti e dei pasticcini e curò certe patate messe ad abbrustolire tra la cenere. Arrostirono pure pannocchie di meliga grattate in un campo vicino al canale. Tutto andò benissimo, eccetto che non avevano portato abbastanza burro. In seguito, sedettero a mangiar pasticcini e a bere le bibite, parlando tranquilli intorno alle braci. Alec e Joe tirarono fuori le pipe e Janey si sentì a meraviglia seduta là alle Grandi Cascate del Potomac con due uomini che fumavano la pipa. «Ostia, Janey, Joe ha cotto per bene quella braciola.» «Quando eravamo marmocchi, sempre acchiappavamo rane e le arrostivamo a Rock Creek… Ti ricordi, Alec?» «Accidenti, se mi ricordo, e Janey che è venuta una volta, che fracasso hai piantato allora, Janey.» «Non mi piace vedere quando le scorticate.» «Ci pareva di essere veri cacciatori dell’Ovest selvaggio allora. Quanto ci siamo divertiti!» «Preferisco adesso, Alec» disse Janey esitando. «E io no?…» disse Alec. «Porco d’un fulmine, vorrei averci un melone.» «Forse ne troveremo sulla riva andando a casa.» «Giuda porco, che cosa non farei per un melone, Joe.» «Mamma ne aveva uno in ghiaccio» disse Janey. «Forse ce ne sarà ancora, quando arriveremo a casa.» «Io non voglio più andare a casa» disse Joe facendosi amaramente
serio tutt’a un tratto. «Joe, non devi parlare così.» Janey si sentì bambina e spaventata. «Parlo come diavolo mi sembra… Porco dio, non posso più soffrirlo quel buco da topi.» «Joe, non devi parlare così.» Janey s’accorse di star per piangere. «Che Dio mi fulmini» disse Alec. «È tempo di tagliarcela… Cosa dici tu, socio… Ancora un tuffo e poi macchina indietro.» Quando i ragazzi ebbero finito di nuotare, salirono tutti a guardare le cascate e poi partirono. Filavano veloci nella rapida corrente sotto l’erta sponda coperta di alberi. Il pomeriggio era molto afoso, passavano attraverso strati di cocente aria piena di vapori. Grossi ammassi di nuvole si ammucchiavano a nord. Non era più un divertimento per Janey. Temeva che si mettesse a piovere. Dentro si sentiva male e disseccata. Temeva che si avvicinasse il suo periodo. Non aveva ancora avuto la maledizione più di qualche volta e il solo pensiero l’atterriva e le toglieva ogni forza, le metteva voglia di strisciar via e nascondersi come un gattaccio rognoso. Non voleva che Joe e Alec si accorgessero del suo stato. Pensava che cosa poteva accadere se lei capovolgeva la canoa. I ragazzi sarebbero stati buoni a nuotare a riva e lei sarebbe annegata e avrebbero sondato il fiume per trovarne il corpo e tutti avrebbero pianto e ne sarebbero stati tanto tristi. Tenebre plumbeo-violacee sorsero risolutamente e affogarono le cime candide delle nuvole. Tutto si fece biancolivido e violaceo. I ragazzi pagaiavano quanto più forte potevano. Si poteva sentire il brontolio del tuono che avanzava. Il ponte era bene in vista quando li prese il vento, un caldo vento temporalesco, pieno di polvere, di foglie morte, di pezzetti di pula e di paglia, che faceva schiumare il fiume. Giunsero alla riva appena in tempo. «Giuda porco, questo sarà un temporale» disse Alec. «Janey, sotto la barca.» Rovesciarono la canoa sulla riva sassosa al riparo di un gran masso e ci si raggomitolarono sotto. Janey sedeva al centro con le ninfee raccolte la mattina, tutte appassite e appiccicaticce dal calore della mano. I ragazzi le stavano ai due lati nei loro costumi bagnati. I capelli neri scomposti di Alec le erano contro la guancia. Dall’altra parte, Joe stava disteso con la testa
in fondo alla canoa e i piedi e le gambe, magri e bruni, fatti su nei calzoni arrotolati, riparati sotto la sua sottana. L’odor di sudore e d’acqua di fiume e il caldo odore maschio dei capelli e delle spalle di Alec le davano le vertigini. Quando la pioggia cadde tamburellando sul fondo della canoa, avvolgendoli con bianche sferzate di spruzzi, Janey insinuò il braccio intorno al collo di Alec e gli tenne timidamente una mano sulla spalla nuda. Alec non si mosse. La pioggia cessò poco dopo. «Ostia, non è stato brutto come credevo» disse Alec. Erano tutti bagnati e infreddoliti, ma si sentivan bene nell’aria fresca, lavata dalla pioggia. Rimisero la canoa in acqua e discesero fino al ponte. Poi la portarono alla casa dove l’avevan presa e andarono alla piccola tettoia, in attesa del tram elettrico. Erano stanchi, cotti dal sole e appiccicaticci. Il tram era zeppo di una folla domenicale tutta bagnata, gitanti sorpresi dal temporale alle Grandi Cascate e a Glen Echo. Janey credette di non resistere più fino a casa. Aveva il ventre tutto contorto da un crampo. Quando furono a Georgetown, i ragazzi avevano ancora cinquanta cents fra tutti e due e volevano andare al cinema, ma Janey corse via e li lasciò. Il suo solo pensiero era di arrivare a letto, dove avrebbe potuto cacciare il viso nel cuscino e piangere. Dopo questa volta, Janey non pianse più troppo; la vita la sconvolse, ma invece lei si corazzò di un freddo senso di durezza. La scuola media passò presto, e le calde e temporalesche estati washingtoniane, tra un trimestre e l’altro, punteggiate di una gita ogni tanto a Marshall Hall o una festicciola in qualche casa del vicinato. Joe trovò lavoro nella Adams Express. Non lo vedeva più sovente, perché lui non mangiava più a casa. Alec aveva comperato una motocicletta e, benché fosse ancora in scuola media, Janey sentiva ben poco sue notizie. Qualche volta stava sveglia per scambiare una parola con Joe, quando lui tornava a casa di notte. Joe sapeva di tabacco e di liquore, ma non pareva mai ubriaco. Andava al lavoro alle sette e, quando usciva alla sera, andava in giro con la congrega per i biliardi in 4½ Street o a giocare ai dadi o alle bocce. La domenica giocava al baseball nel Maryland. Janey stava seduta ad aspettarlo, ma quando arrivava Joe, Janey gli chiedeva come andavano le cose dove lavorava, e Joe
diceva «Bene» e poi le chiedeva come andavano le cose a scuola, e Janey diceva «Bene» e poi tutti e due andavano a letto. Una volta ogni tanto Janey gli chiedeva se aveva veduto Alec e Joe diceva «Sì» con un lampo di sorriso e lei domandava come stava Alec e Joe diceva «Bene». Janey aveva un’amica, Alice Dick, una bruna ragazza tozza, con gli occhiali, che seguiva tutti i suoi stessi corsi a scuola. Il sabato pomeriggio indossavano il vestito migliore e andavano a guardare le vetrine giù per F Street. Comperavano qualche cosuccia, si fermavano a prendere un selz e ritornavano in tram, convinte di aver passato un pomeriggio laboriosissimo. Una volta, proprio di tanto in tanto, andavano a una mattinata al Poli e Janey si conduceva Alice Dick a cena in casa. Alice Dick trovava simpatici i Williams e loro trovavan simpatica lei. Diceva che le faceva parere d’esser più libera, passare qualche ora con gente d’idee larghe. I suoi erano metodisti del Sud e molto gretti. Suo padre era impiegato all’ufficio stampa governativo e viveva in una paura quotidiana che il suo posto venisse a cadere sotto i regolamenti del servizio civile. Era un uomo corpulento e asmatico, dedito a giocar scherzi villani alla moglie e alla figlia, e soffriva di dispepsia cronica. Alice Dick e Janey progettarono che, appena finita la scuola media, avrebbero cercato lavoro e abbandonato la casa. Scelsero persino la pensione dove sarebbero entrate, una casa in pietra verde vicino al Thomas Circle, tenuta da una tal signora Jenks, vedova di un ufficiale di marina, donna distinta che faceva cucina meridionale e non prendeva molto per il vitto. Una domenica sera, la primavera del suo ultimo trimestre da studentessa, Janey era nella camera, che si spogliava. Francie e Ellen giocavano ancora nel cortile. Giungevano le loro voci attraverso la finestra aperta, insieme a fragranti ondate dai lilla delle siepi nel cortile vicino. Janey si era appena disciolti i capelli e stava a guardarsi nello specchio immaginando di essere una bellezza e di avere i capelli castano dorato, quando sentì bussare alla porta e, all’esterno, la voce di Joe. C’era qualcosa di curioso in quella voce. «Vieni,» disse lei «mi sto appuntando i capelli.»
Gli vide dapprima la faccia nello specchio. Era bianchissima e aveva la pelle stirata agli zigomi e intorno alla bocca. «Ma cosa c’è, Joe?» balzò in piedi e si volse. «Questo c’è, Janey» disse Joe emettendo le parole a fatica. «Alec è morto. Si è sfracellato sulla motocicletta. Vengo adesso dall’ospedale. È bell’e morto.» Parve a Janey di scriversi quelle parole su un foglio bianco dentro la testa. Non poté dir nulla. «Si è sfracellato ritornando da Chevy Chase… Era venuto alla partita per vedermi giocare. Dovresti vederlo, tutto sfracellato.» Janey tentava di dir qualcosa. «Era il tuo miglior…» «Era il miglior ragazzo fra quanti ne ho conosciuti e ne conoscerò in tutta la vita» continuò Joe sommessamente. «Ecco tutto, Janey… Ma volevo dirti che non voglio più fermarmi in questo lurido buco ora che Alec se n’è andato. Vado ad arruolarmi in marina. Dillo tu a loro… Io non ne ho voglia. È così: vado in marina a vedere il mondo.» «Ma Joe…» «Ti scriverò, Janey, sta’ sicura… Ti scriverò tante volte. Tu e io… Be’, addio, Janey.» La prese per le spalle e la baciò goffamente sul naso e sulle guance. Tutto ciò che gli seppe dire fu, a bassa voce: «Sta’ attento Joe» e rimase là davanti all’armadio nella ventata dei lilla, tra le grida delle bambine, che giungevano dalle finestre spalancate. Udì i passi di Joe posarsi rapidi giù per le scale e la porta d’entrata chiudersi. Spense la luce, si spogliò al buio e andò a letto. Rimase là senza piangere. Vennero la licenza e la premiazione e lei e Alice andarono a festicciole e persino, una volta, con un grosso gruppo, a uno dei viaggi notturni giù per il fiume a Indian Head, sul vaporetto Charles McAlister. Il gruppo era più volgare di quel che garbasse a Janey e Alice. Qualcuno dei giovani beveva esagerato e c’erano coppie che si baciavano e stringevano in tutti gli angoli bui, tuttavia la luna sul fiume dava meravigliosi scintillii e Alice e Janey accostarono due sedie e parlarono insieme. C’era un’orchestra e si ballava, ma loro non
ballarono per via dei tipi volgari che circondavano le coppie e facevano osservazioni. Chiacchierarono insieme e sulla via del ritorno su per il fiume, Janey, parlando a bassa voce e appoggiandosi alla ringhiera ben vicino ad Alice, le disse di Alec. Alice aveva letto di lui nel giornale, ma non si era sognata che Janey lo avesse conosciuto tanto davvicino o avesse provato per lui quei sentimenti. Si mise a piangere e Janey si sentiva tanto forte consolandola, e tutte e due sentivano che dopo tutto ciò sarebbero state amiche molto intime. Janey mormorò che non le sarebbe mai più riuscito di amare nessun altro e Alice disse che non credeva di poter mai amare un uomo: bevevano tutti e fumavano e parlavan sudicio tra loro e non avevano che un pensiero. In luglio, Alice e Janey trovarono un impiego nell’ufficio della signora Robinson, pubblica stenografa al Riggs Building, per sostituire ragazze in ferie. La signora Robinson era una donnetta dai capelli grigi, seno da piccione, con un accento stridulo del Kentucky, che faceva pensare Janey a un pappagallo. Era molto minuziosa e nel suo ufficio si rispettavano tutte le convenienze. «Signorina Williams,» cinguettava, appoggiandosi alla sedia della scrivania «quel manoscritto del giudice Roberts dev’essere assolutamente finito oggi… Mia cara, abbiamo impegnato la nostra parola e lo consegneremo, dovessimo stare fino a mezzanotte. Noblesse oblige, mia cara» e le macchine trillavano e strepitavano e le dita di tutte quelle ragazze filavano pazzamente, battendo lettere, manoscritti di discorsi politici mai pronunciati, occasionali sfoghi di un giornalista o di uno scienziato, prospetti per uffici di immobiliari o promotori di brevetti, lettere di sollecitazione di dentisti e di medici. 1. Baltimora e Ohio. (NdT)
Occhio fotografico (14) il signor Garfield aveva una bellissima voce da lettura La domenica notte c’erano polpette di pesce e fave al forno e il signor Garfield ci faceva lettura con una bellissima voce e tutti erano così silenziosi che si sarebbe sentito cadere uno spillo perché il signor Garfield leggeva L’uomo senza patria ed era una storia terribile e Aaron Burr era stato un uomo pericolosissimo e questo povero giovane aveva detto Maledetti gli Stati Uniti spero di non sentire mai più il loro nome ed era una cosa terribile a dirsi e il giudice dai capelli grigi era tanto gentile e buono e il giudice mi condannò e fui portato lontano in paesi stranieri su di una fregata e gli ufficiali erano gentili e buoni e parlavano con voci da lettura gentili gravi molto tristi come il signor Garfield e tutto era tanto gentile e grave e triste e le fregate e il Mediterraneo azzurro e le isole e quando fui morto cominciai a piangere e avevo paura che gli altri ragazzi s’accorgessero che avevo le lacrime agli occhi un americano non deve piangere deve mostrarsi gentile e grave e triste quando mi avvolsero nelle stelle e strisce e mi portarono in patria su di una fregata a seppellirmi ero così triste che non ricordai più se mi portarono in patria o mi seppellirono in mare ma comunque ero avvolto nell’Old Glory
Cine-giornale XI il governo degli Stati Uniti deve insistere e pretendere che i cittadini americani che siano stati presi prigionieri dall’una o dall’altra delle due parti come partecipanti agli attuali disordini insurrezionali vengano trattati secondo i larghi princìpi della legge internazionale I SOLDATI PROTEGGONO LA CONVENZIONE il Titanic lasciò Southampton il 10 aprile per il suo primo viaggio dev’essere compiuta contro il parere della New York Life secondo “Kimmel” Sì sanno che sono Kimmel a Niles sono George per tutti anche per la mamma e la sorella quando c’incontriamo nelle vie Vo da Maxim allor assiduo avventor sto con le donne là in grande intimità si stura lo champagne si cancaneggia un po’ e poi carezze e baci e quel che seguir può Lolo, Dodo, Joujou Cloclo, Margot, Froufrou IL TITANIC LA PIÙ GRANDE NAVE DEL MONDO AFFONDA personalmente non sono così certo che le dodici ore siano un male per i lavoratori specialmente quando essi stessi insistono a voler lavorare tutto questo tempo per guadagnare di più E sempre canterò Mio Dio vicino a te vicino a te era circa l’una del mattino, una bella notte stellata senza luna. Il mare era calmo come uno stagno, niente più di un leggero sussulto quando la scialuppa beccheggiava sull’onda, una notte ideale se non fosse per il freddo tagliente. Nella distanza il Titanic appariva di una lunghezza enorme, il suo grande scafo in risalto nero sul cielo stellato, ogni finestrino e salone smagliante di luce l’abito della sposa è di satin charmeuse con una cintura di pizzo velato di
chiffon. Il velo è di crêpe lisse orlato a punto di Venezia una novità rispetto al convenzionale velo nuziale e il bouquet sarà di mughetti e di gardenie Lolo, Dodo, Joujou Cloclo, Margot, Froufrou la cara patria mia dimenticar mi fan il Titanic si innalzò lentamente da una parte con la poppa quasi verticale e intanto le luci nelle cabine e nei saloni, che non avevano vacillato un istante da quando eravamo venuti via, morirono, si ripresero per un attimo, e finalmente si spensero del tutto. Intanto le macchine strepitavano nel bastimento con un frastuono e un rantolo che si poteva sentire per miglia. Poi con un calmo tuffo obliquo
Janey «Ma è tanto interessante, mamma» diceva Janey, quando sua madre si lagnava che lei dovesse lavorare. «Ai miei tempi non era da signora, era considerata una cosa degradante.» «Ma ora non più» diceva Janey, perdendo la calma. Allora le dava un gran sollievo uscir dalla casa soffocante e dalle soffocanti vie alberate di Georgetown, e fermarsi a prendere Alice Dick e scendere nei cinematografi, a vedere i cine-giornali e le pellicole di paesi esotici, e la gente in F Street, e poi fermarsi in uno spaccio a prendere un selz, prima di salire sul tram per Georgetown, e sedere al banco parlando del film che avevano veduto, di Olive Thomas, di Charly Chaplin e John Bunny. Cominciò a leggere ogni giorno il giornale e a interessarsi di politica. Cominciò a sentire che c’era un grande mondo sussultante, a luce elettrica, in qualche luogo, fuori di là, e che vivere soltanto a Georgetown dove tutto era così barbogio e all’antica, e mamma e papalino così barbogi e all’antica, le impediva di irrompere nel mondo. Le cartoline che Joe mandava le davano lo stesso senso. Joe era marinaio sulla nave da guerra Connecticut. Erano una veduta della banchina all’Avana o del porto di Marsiglia o di Villefranche oppure la fotografia di una ragazza vestita da contadina, dentro un ferro da cavallo di stagnola, e sotto, poche righe con l’augurio che lei stesse bene e le piacesse il lavoro, mai una parola di sé. Janey gli scriveva lunghe lettere piene di domande sul conto suo e dei paesi esotici, ma Joe a queste non rispondeva mai. Pure le dava come un senso d’avventura, ricevere le cartoline. Ogni volta che vedeva un marinaio per via o un fante di mare in licenza da Quantico, pensava a Joe e si chiedeva come stesse. La vista di un semplice marinaio che andasse rollando vestito di turchino, col berretto sulle ventitré, le dava un curioso colpo al cuore. Alla domenica, Alice quasi sempre veniva a Georgetown. La casa adesso era differente; partito Joe, madre e padre più vecchi e tranquilli, Francie ed Ellen sboccianti in due belle scolare piene di sogghignetti, popolarissime tra i ragazzi del vicinato, sempre a festicciole, sempre a lagnarsi che non avevan denari da spendere.
Sedendo a tavola con loro, aiutando mamma agli intingoli, portando le patate o i cavoli brusselli per il pranzo domenicale, Janey si sentiva adulta, quasi zitellona. Teneva ora le parti del padre e della madre contro le sorelle. Papalino cominciava a prendere un’aria invecchiata e rattrappita. Parlava spesso di ritirarsi e pensava alla pensione. Era già da otto mesi con la signora Robinson, quando ebbe un’offerta da Dreyfus e Carroll, legali dell’ufficio Brevetti all’ultimo piano del Riggs Building, di lavorare con loro a diciassette dollari settimanali, cinque dollari più di quel che prendeva dalla signora Robinson. Ciò la lusingò molto. Comprese di valere ormai nel suo lavoro e di esser capace di mantenersi, qualunque cosa capitasse. Facendosi forte di questo, andò da Woodward e Lothrop con Alice Dick a comperarsi un abito. Voleva un abito da grande in seta, con sopraricami. Aveva ventun anni, avrebbe guadagnato diciassette dollari alla settimana e pensava di avere il diritto di indossare un abito bello. Alice disse che ci voleva un colore oro bronzato per accompagnare i capelli. Girarono tutti i negozi di F Street, ma non trovarono nulla che andasse e non costasse troppo, e così ciò che poteron fare fu di comprar la stoffa e qualche rivista di mode e portarle a casa a mamma che facesse lei. Rincresceva a Janey dipendere ancora da sua madre a quel modo, ma non c’era rimedio; e così la signora Williams dovette fare il nuovo abito di Janey, come aveva fatto gli abiti di tutti i suoi figli, da quand’erano al mondo. Janey non aveva mai avuto la pazienza di imparare a cucire, come sapeva mamma. Comprarono tanta stoffa che ne uscisse uno anche per Alice e la signora Williams ne ebbe due da fare. Il lavoro da Dreyfus e Carroll era tutto diverso dal lavoro presso la signora Robinson. C’erano essenzialmente uomini nell’ufficio. Il signor Dreyfus era un ometto dalla faccia esile con baffetti neri, due occhietti neri e ammiccanti e un’ombra di accento che gli dava una distinta aria di diplomatico straniero. Portava guanti di camoscio gialli, una canna gialla, e aveva gran varietà di soprabiti elaboratissimi. Era il Cervello della ditta, come diceva Jerry Burnham. Il signor Carroll era un tipo tarchiato, rosso in faccia, che fumava gran sigari, si schiariva la gola continuamente e aveva un antiquato
Chediomibenedica modo di parlare meridionale. Jerry Burnham diceva che era la Pancetta della ditta. Jerry Burnham era un giovanotto rugoso, dagli occhi consumati, consigliere della ditta in argomenti di tecnica e di ingegneria. Rideva molto, arrivava sempre in ritardo all’ufficio, e per chi sa che motivo prese in simpatia Janey e sempre le diceva freddure su tutto, mentre dettava. A Janey piaceva, benché quell’aria consunta sotto gli occhi la tenesse un po’ lontana, intimidita. Le sarebbe piaciuto parlargli come una sorella, e distoglierlo dal buttarsi via a quel modo. Poi c’era un contabile anziano, il signor Sills, un uomo raggrinzito che viveva ad Anacostia e non diceva mai una parola a nessuno. A mezzogiorno non usciva a mangiare, ma stava seduto alla scrivania, nutrendosi di un pane imbottito e di una mela avvolti in carta oleata, che in seguito ripiegava accuratamente, rimettendosela in tasca. Poi c’erano due fattorini sfacciati e una dattilografetta dal viso ordinario, chiamata signorina Simonds, che guadagnava soltanto dodici dollari alla settimana. Ogni razza di gente, in ogni specie di vestiti, logoro-decenti o tipo vorrei-ma-nonposso, entravano durante il giorno nell’ufficio esterno a sentire il ricco vocione del signor Carroll da dietro l’uscio di vetro smerigliato. Il signor Dreyfus scivolava dentro e fuori senza una parola, sorridendo leggermente alle conoscenze, sempre con una gran fretta misteriosa. A pranzo in una piccola cafeteria o a un bar, Janey raccontava di tutto ad Alice e Alice sollevava gli occhi a guardarla, ammirata. Alice l’aspettava sempre nel vestibolo all’una. Avevano combinato di uscire allora, perché c’era meno gente. Nessuna delle due spendeva mai più di venti cents, e così lo spuntino non occupava molto tempo, e avevano agio di fare un giro in Lafayette Square o talvolta intorno alla Casa Bianca, prima di tornare all’ufficio. Avvenne un sabato notte che Janey ebbe da lavorare fino a tardi, per finir di copiare la descrizione di un motore fuoribordo, che doveva arrivare all’ufficio Brevetti avanti al resto, il lunedì mattina. Tutti avevano lasciato l’ufficio. Janey decifrava le complicate parole tecniche come meglio poteva, ma aveva la testa a una cartolina con la figura del Cristo delle Ande, ricevuta quel giorno da parte di Joe. Tutto ciò che diceva, era:
“Al diavolo le navi di latta dello Zio Sam. Tornerò presto.” Non era firmata, ma Janey conosceva la mano. Ne era tormentata. Jerry Burnham sedeva al centralino telefonico ripassando i fogli di mano in mano che lei li finiva. Di tanto in tanto andava nel gabinetto di toeletta e, quando tornava, ogni volta una calda fiatata di whisky attraversava l’ufficio. Janey era nervosa. Batté a macchina finché le letterine nere presero a contorcersi sotto i suoi occhi. Si tormentava al pensiero di Joe. Come poteva tornare a casa prima che fosse finita la sua ferma? Ci doveva esser qualcosa. E Jerry Burnham, che si agitava irrequieto sul sedile della telefonista, la metteva a disagio. Janey e Alice avevano parlato del pericolo di restar sole in ufficio con un uomo simile. Così tardi e così bevuto, un uomo ha soltanto un pensiero. Quando Janey gli passò il penultimo foglio, l’occhio di lui, lucido e umido, colse il suo. «Scommetto che siete stanca, signorina Williams» disse. «Corpo, è una vergogna trattenervi così, e una notte di sabato, poi.» «Va benissimo, signor Burnham» disse lei gelidamente: e le sue dita si animarono. «È colpa del vecchio Pancettone. Ha cianciato tanto di politica tutto il giorno, che nessuno poteva più far niente.» «Non m’importa più» disse Janey. «Più nulla importa… Sono quasi le otto. Così, ho dato un cane alla mia più cara ragazza… o quasi. Scommetto che anche voi avete dato un cane, signorina Williams.» «Dovevo trovarmi con un’altra ragazza, ecco tutto.» «Senti un po’…» Rideva con tanta naturalezza che anche lei si trovò a ridere. Quando l’ultima pagina fu finita e messa nella busta, Janey si alzò per prendere il cappello. «Adesso, signorina Williams, imbucheremo questo e poi sarà meglio che veniate a mangiare un boccone con me.» Scendendo nell’ascensore Janey aveva intenzione di scusarsi e andare a casa, ma, chi sa come, non lo fece e si trovò, tutta agitata nell’intimo, seduta con calma davanti a Jerry Burnham, nel ristorante francese di H Street.
«Bene, e che cosa ne pensate della Nuova Libertà, signorina Williams?» domandò Jerry Burnham con una risata, dopo che si fu seduto. Le porse la lista. «Ecco il totalizzatore… Sia la coscienza la vostra guida.» «Non me ne intendo troppo, signor Burnham.» «A me invece va, francamente. Credo Wilson un grand’uomo… Non c’è niente come cambiare, poi, la cosa più bella del mondo, non vi pare? Bryan è un enorme idiota vociferante, ma anche lui rappresenta qualcosa e persino Josephus Daniels che riempie la flotta di sciroppo. Credo che abbiamo una probabilità di tornare a essere una democrazia… Forse non ci sarà bisogno di una rivoluzione, che vi pare?» Non aspettava mai una risposta, semplicemente parlava e se la rideva tutto da sé. Quando più tardi Janey tentò di raccontare ad Alice le cose che Jerry Burnham diceva, queste non eran più così buffe né il cibo così buono e più niente così vivace. Alice fu molto aspra al proposito. «Oh, Janey, come hai potuto uscire di notte tardi con un ubriaco, in un locale così, e io qui che stavo sulle spine… Sai che un uomo così ha solo un pensiero… Davvero che sei stata senza cuore e leggera. Non ti avrei creduta capace di una cosa simile.» «Ma, Alice, non è mica andata così…» badava a ripetere Janey, ma Alice pianse e andò in giro con la faccia offesa per una settimana intera; cosicché Janey non parlò più di Jerry Burnham. Era il primo dissenso che nasceva tra loro e la fece star molto male. Pure riuscì a stringer amicizia con Jerry Burnham. Pareva gli piacesse condurla in giro e averla attenta alle sue parole. Anche dopo che ebbe dato un calcio al suo posto da Dreyfus e Carroll, venne qualche volta al sabato pomeriggio per portarla da Keith. Janey combinò un incontro in Rock Creek Park, che non si poté dire troppo riuscito. Jerry condusse le ragazze a prendere il tè alle antiche pietrerie. Lavorava in un giornale d’ingegneria e scriveva una lettera settimanale per il «New York Sun». Sconvolse Alice chiamando Washington un pozzo nero, un lavandino di noia, e dicendo che lui marciva là dentro e che la maggior parte degli abitanti erano tutti più
o meno morti, dal collo in su. Quando le rimise sull’automobile di ritorno a Georgetown, Alice disse con molta enfasi che quel Burnham non era il genere di giovanotto che una ragazza come si deve può conoscere. Janey sedeva beatamente appoggiata allo schienale della macchina scoperta, guardando gli alberi, le ragazze vestite da estate, gli uomini coi cappelli di paglia, le cassette postali, le facciate dei negozi che scivolavano via, e disse: «Ma, Alice, è vivo come una frustata… Io amo la gente che pensa, tu no?». Alice la guardò, scosse il capo attristata e non disse nulla. Lo stesso pomeriggio andarono all’ospedale di Georgetown a vedere papalino. Era una cosa orribile. Mamma e Janey e il dottore e l’infermiera sapevano che aveva un cancro alla vescica e non poteva più durare molto, ma non lo ammettevano nemmeno con se stessi. Lo avevano allora messo in una camera privata dove sarebbe stato più comodo. Costava molto denaro e dovettero mettere sulla casa una seconda ipoteca. Avevano già speso tutti i risparmi che Janey teneva in un conto di banca suo personale come riserva per qualche brutto momento. Quel pomeriggio ebbero da attendere un bel po’. Quando l’infermiera uscì con un orinale di vetro sotto un asciugamano, Janey entrò sola. «Ciao, papalino» disse con un sorriso forzato. L’odore del disinfettante la nauseava. Per la finestra aperta veniva l’aria tiepida degli alberi avvizziti dal sole, i rumori sonnacchiosi del pomeriggio domenicale, il gracchio di una cornacchia, un’eco lontana del traffico. La faccia di papalino era stirata e contratta da una parte. I baffoni avevano una patetica aria di seta bianca. Janey s’accorse di amarlo più di chiunque altro al mondo… Aveva la voce affiochita ma abbastanza ferma. «Janey, sono al fondo, ragazza mia, e credo che mai più… tu lo sai meglio di me, quei furfanti non me lo vogliono dire… Dimmi di Joe, tu hai sue notizie, no? vorrei che non fosse entrato in marina, non c’è avvenire là per un ragazzo senza la spinta, ma sono contento che si sia messo in mare, rinnova me… Io ho fatto tre volte il Capo Horn ai miei tempi, prima di avere vent’anni. È stato prima che mi fissassi nei rimorchiatori, vedi… Ma qui in letto ho pensato che Joe ha fatto lo stesso che ho fatto io, una scheggia dell’antico ceppo, e ne sono contento. Non mi preoccupo per lui, ma vorrei che voi ragazze foste
sposate, via dalle mie spalle. Mi sentirei più tranquillo. Non do fiducia alle ragazze del giorno d’oggi con quelle sottane alle caviglie e tutto il resto.» Gli occhi di papalino la percorsero tutta con un fiacco e freddo bagliore, che le diede un nodo alla gola quando cercò di parlare. «Credo di saper pensare a me stessa» disse. «Adesso devi pensare a me. Io ho fatto con voi quel che ho potuto. Non sapete cosa sia la vita, nessuno di voi lo sa, sempre al coperto, e adesso mi spedite a morire all’ospedale.» «Ma, papalino, hai detto tu stesso che era preferibile andare dove ti avrebbero curato meglio.» «Non mi piace quell’infermiera del turno di notte, Janey, mi maneggia troppo sgarbata… Reclama, sotto, all’ufficio.» Fu un sollievo quando venne il momento di andarsene. Lei e Alice camminavano per la via senza dir nulla. Finalmente Janey disse: «Per amor di Dio, Alice, non farmi il muso. Se soltanto sapessi come dispiaceva tanto anche a me… oh Dio, vorrei…». «Che cosa vorresti, Janey?» «Oh, non lo so.» Luglio era caldo quell’estate, all’ufficio si lavorava in un continuo ronzio di ventilatori, i colletti degli uomini avvizzivano e le ragazze si tenevano esageratamente intonacate di cipria; soltanto il signor Dreyfus conservava sempre l’aria fresca e vispamente elegante, come se uscisse allora da una scatola di cartone. L’ultimo giorno del mese, Janey rimase seduta un momento al tavolino a raccogliere energia per tornare a casa lungo le vie sobbollenti, quando entrò Jerry Burnham. Aveva le maniche della camicia rimboccate al gomito, pantaloni bianchi di tela e teneva sul braccio la giacca. Le chiese come stava suo padre, e disse che lui era tutto eccitato dalle notizie d’Europa e aveva bisogno di portarla fuori a cena per parlare con qualcuno che lo calmasse. «Ho un’automobile di proprietà di Bugs Dolan e non ho la patente, ma credo che possiamo infilare l’autostrada e rinfrescarci lo stesso.» Janey cercò di dir di no, perché doveva andare a casa a cena e Alice faceva tanto il muso quando lei usciva con Jerry, ma Jerry s’accorse che in realtà Janey aveva voglia di venire e insistette. Sedettero tutti e due davanti nella Ford e gettarono le giacche sul sedile posteriore. Fecero una volta un giro dell’autostrada, ma l’asfalto pareva un forno. Gli alberi e il fiume scuro stagnante cuocevano
nell’ombra del tardo pomeriggio, come carne e verdura in una pentola. Il calore del motore li soffocava. Jerry, rosso in faccia, parlava senza posa della guerra fermentante in Europa e che sarebbe stata la fine della civiltà e il segnale di una rivoluzione proletaria generale e che a lui non importava nulla e qualunque cosa lo cavasse da Washington, dove beveva da incretinirsi, col cervello intontito dal caldo e dai memoriali del Congresso, sarebbe tanta manna e quanto era stufo delle donne che cercavano soltanto di spillargli denari o festini o il matrimonio o chi sa che altra maledizione, e quanto gli riusciva dolce parlare con Janey che non era di quel tipo. Faceva troppo caldo e così rimandarono la passeggiata a più tardi e andarono al Willard a mangiare qualcosa. Jerry volle assolutamente andare al Willard perché, diceva, aveva le tasche piene di denari e comunque voleva spenderli e Janey era tutta intimidita perché non s’era mai trovata prima in un grande albergo e sentì di non aver l’abito adatto e disse che temeva di fargli far brutta figura e Jerry rise e disse che non era possibile. Si sedettero nel lungo salone da pranzo dorato e Jerry disse che pareva una morgue da milionari e il cameriere era cortesissimo e Janey non riuscì a trovare sulla lista un cibo che le andasse e prese un’insalata. Jerry le fece prendere un gin spumante perché disse che rinfrescava; in seguito, lei si sentì leggera di testa, alta, sguaiata. Tenne dietro senza fiato ai discorsi di Jerry, a quel modo che andava dietro a Joe e Alec nelle rimesse tranviarie quand’era una ragazzina. Dopo cena girarono un altro po’ in automobile e Jerry si calmò e lei si sentì a disagio e non sapeva cosa dire. Uscirono un po’ per Rhode Island Avenue e tornarono facendo un giro per la Casa dei Veterani. Non c’era aria in nessun luogo e i lampioni identici, fissi, passavano ai due lati, rischiarando segmenti di monotoni alberi immobili. Persino fuori sulle colline non c’era un alito. Fuori per le strade buie, al di là dei lampioni, si stava meglio. Janey perse ogni senso della direzione e giaceva appoggiata, traendo il fiato negli occasionali tratti di fresco che venivano da un meligaio o da qualche boschetto ceduo. In un punto dove una leggera umidità di pantano esalava un vapore fresco per la strada, Jerry arrestò
d’improvviso l’auto, si piegò e le diede un bacio. A Janey il cuore prese a battere rapido. Voleva dirgli di non farlo, ma non riuscì. «Non volevo, ma non mi son tenuto» sussurrò Jerry. «È la vita di Washington che mina la volontà… O magari sarà che sono innamorato di voi, Janey. Non so… Sediamo dietro, che fa più fresco.» La prese alla bocca dello stomaco una debolezza che le saliva alla testa. Mentre lei scendeva, Jerry l’afferrò tra le braccia. Janey gli lasciò cadere il capo sulla spalla, le labbra sul collo. Intorno alle sue spalle, le braccia di Jerry erano calde ardenti; Janey gli sentiva attraverso la camicia le costole che premevano. La testa cominciò a girarle in un vapore di tabacco, liquore e sudore d’uomo. Le gambe di lui cominciarono a premere contro le sue. Janey si strappò via e salì sul sedile posteriore. Tremava. Lui le fu dietro. «No, no» disse Janey. Jerry le si sedette accanto cingendola col braccio alla vita. «Fumiamo una sigaretta» disse con una voce malferma. Il fumare le diede qualcosa da fare, la uguagliò a lui. Le due estremità rosse granulose delle sigarette sfavillavano a fianco a fianco. «Dite che vi piaccio, Jerry?» «Sono pazzo di te, piccola.» «Volete dire che…?» «Vi voglio sposare… E perché no? Io non… E se fossimo fidanzati?» «Volete dire che volete che vi sposi?» «Se vi va… Ma non capite come uno si sente… una notte come questa… l’odore della palude… Dio, darei qualunque cosa per aver voi.» Finirono di fumare le loro sigarette. Stettero seduti a lungo senza fare una parola. Janey sentiva il pelo del braccio di Jerry contro il proprio braccio nudo. «Sono preoccupata per mio fratello Joe… È in marina, Jerry, e temo che voglia disertare o qualcosa… Credo che vi piacerebbe. È un giocatore di baseball meraviglioso.» «Che cosa vi ha fatto pensare a lui? Provate per me gli stessi sentimenti? L’amore è una bella cosa, dannazione, non capite che non è come il sentimento per un fratello?»
Le mise una mano sul ginocchio. Janey lo sentiva fissarla nel buio. Si piegò a baciarla, leggero. Gli piacquero le labbra leggere contro le sue, così. Le baciava anche lei. Cadeva in mezzo a secoli di oscurità paludosa. Il petto ardente di Jerry pesava contro i suoi seni, rovesciandola. Si stava stringendo a lui, che la rovesciava giù in mezzo a secoli di oscurità paludosa. Poi, tutto a un tratto, in un gelido spasimo, Janey si sentì male, e annaspò per respirare, come se annegasse. Si mise a lottare con lui. Riuscì a sollevare una gamba e lo respinse forte, nell’inguine, col ginocchio. Jerry la lasciò stare e scese dall’auto. Lo sentiva passeggiare in su e in giù per la strada dietro di lei, nel buio. Lei era tutta tremante e atterrita e sofferente. Dopo un po’ Jerry risalì, accese la luce e guidò via senza guardarla. Fumava una sigaretta e ne sfuggivano piccole faville, mentre guidava. Quando fu all’angolo di M Street, sotto la casa dei Williams in Georgetown, si fermò, scese e le aprì lo sportello. Janey scese, non sapendo cosa dire, temendo di guardarlo. «M’immagino pensiate che io vi debba chieder scusa per esser stato un maiale» disse Jerry. «Jerry, sono…» disse. «Potrei crepare piuttosto. Credevo fossimo amici. Avrei dovuto saperlo che in questo buco di letame non c’era una sola donna con dentro una scintilla di vita… Immagino siate convinta che dovete conservarvi per i fiori d’arancio. Fate. È affar vostro. Io posso avere quel che mi occorre da una qualunque prostituta negra di questa strada… Buona notte.» Janey non disse nulla. Lui partì. Janey salì a casa e si mise a letto. Per tutto quell’agosto suo padre fu moribondo, saturo di morfina, all’ospedale di Georgetown. I giornali uscivano ogni giorno con grossi titoli sulla guerra in Europa, Liegi, Lovanio, Mons. L’ufficio di Dreyfus e Carroll era in febbre. Pendevano grandi cause su brevetti per munizioni. Si cominciò a sussurrare in giro che l’immacolato signor Dreyfus era un agente del governo tedesco. Jerry venne a trovar Janey un giorno, per scusarsi di esser stato così villano quella sera e per dirle che aveva un posto da corrispondente di guerra e
partiva tra una settimana per il fronte. Fecero insieme un bel pranzo. Jerry parlò di spie, di intrighi inglesi, di panslavismo, dell’assassinio di Juarès, della rivoluzione socialista, e rise continuamente e disse che tutto andava benissimo nella generale corsa al diavolo. A Janey parve straordinario e voleva dir qualcosa sul fatto che erano fidanzati e si sentiva piena di tenerezza verso di lui, e di paura che restasse ucciso, ma a un tratto fu ora di tornare all’ufficio e nessuno dei due aveva toccato l’argomento. Jerry ritornò al Riggs Building con lei e le disse addio e le diede un gran bacio là davanti a tutti e scappò promettendo che avrebbe scritto da New York. In quel momento arrivò Alice che se ne andava dalla signora Robinson e Janey si trovò a raccontarle di esser fidanzata con Jerry Burnham che andava in Europa alla guerra a fare il corrispondente. Quando suo padre morì al principio di settembre, fu un grande sollievo per tutti gli interessati. Soltanto, nel ritorno dal cimitero di Oak Hill, tutto ciò che aveva desiderato da ragazza le tornò in mente, e il ricordo di Alec e ogni cosa le parve tanto triste da non poter più reggere. La mamma era molto calma, aveva gli occhi rossi e continuava a dire che era tanto contenta che ci sarebbe stato spazio là vicino per venir sepolta anche lei in Oak Hill. Le sarebbe rincresciuto troppo se lui fosse stato sepolto altrove che nel cimitero di Oak Hill. Era un così bel posto e tutta la gente più distinta di Georgetown ci veniva sepolta. Col denaro dell’assicurazione, la signora Williams fece imbiancare la casa e aggiustò i due ultimi piani per affittarli come alloggi. Era questa l’occasione che Janey aveva tanto atteso per stare da sé, e lei e Alice presero una camera in Massachusetts Avenue vicino alla biblioteca Carnegie, con diritto di cucina. Così, un sabato pomeriggio Janey telefonò dalla farmacia per un tassì e partì con la valigia, il baule e un mucchio di quadri incorniciati, che venivano dalla sua camera, sul sedile accanto. I quadri erano due stampe a colori di indiani fatte da Remington, una ballerina, una fotografia della nave Connecticut nel porto di Villefranche mandatale da Joe e una, ingrandita, di suo padre in uniforme al timone di una nave immaginaria, sullo sfondo di un cielo burrascoso, provveduto da un fotografo di Norfolk, Va. Poi
c’erano due stampe a colori di Maxfield Parrish, senza cornice, comperate di recente, e un’istantanea incorniciata di Joe vestito da baseball. La foto piccola di Alec l’aveva avvolta tra le sue cose nella valigia. Il tassì puzzava di chiuso e sbatacchiava per le vie. Era un vivido giorno d’autunno, i fossati eran pieni di foglie secche. Janey si sentiva intimorita ed eccitata, come se partisse tutta sola per un viaggio. Quell’autunno lesse molti giornali e riviste e The Beloved Vagabond di W.J. Locke. Cominciò a odiare i tedeschi che distruggevano l’arte e la cultura, la civiltà, Lovanio. Attendeva una lettera di Jerry, ma nessuna lettera giunse. Un pomeriggio che usciva dall’ufficio un po’ tardi, ecco che nel vestibolo vicino all’ascensore c’era Joe. «Ciao, Janey» disse. «Dio, neanche un milione di dollari!» Fu così contenta di vederlo che non poteva parlare, soltanto stringergli forte il braccio. «Mi han pagato e spedito ora… Penso, è meglio che venga qui a vedere la famiglia prima di spender tutto… Vieni con me, ti pago un bel pranzone, e il cinema se vuoi…» Era arso dal sole e aveva spalle più larghe di quand’era partito. Le mani grosse e i polsi nodosi uscivano da un vestito turchino – nuovo pareva – che lo stringeva troppo alla vita. Anche le maniche eran troppo corte. «Sei andato a Georgetown?» gli chiese. «Già.» «Sei andato al cimitero?» «Mamma voleva, ma a cosa serve?» «Povera mamma, ci soffre tanto!…» Camminavano. Joe non diceva nulla. Faceva caldo. La polvere volava per le vie. Janey disse: «Joe, mi devi raccontare tutte le tue avventure… devi essere stato in posti magnifici. Fa effetto, avere un fratello in marina». «Janey, pigliala più bassa con la marina, neh!… Non voglio sentirlo dire. Ho disertato in Buenos Aires, sai, e viaggiato di là su un inglese, su un piroscafo inglese… È anche qui una vita da cani, ma qualunque cosa è meglio della marina americana». «Ma, Joe!»
«Non c’è niente da pigliarsela.» «Ma, Joe, cos’è successo?» «Non dire niente a nessuno, mi raccomando, Janey. Capisci, abbiamo litigato con un graduato che cercava troppo di maltrattarmi, quel dannato. Glien’ho dato uno in faccia e l’ho quasi pestato, capisci, e le cose andavano male, così mi sono buttato ai boschi… Ecco tutto.» «Oh Joe, e io che speravo che saresti diventato ufficiale.» «Un marinaraccio diventare ufficiale…? Bella speranza.» Janey lo condusse al Mabillion, dove l’aveva condotta Jerry. Alla porta Joe sbirciò dentro con aria critica. «È questo il posto più elegante che sai, Janey? Guarda che ho cento caviglie in tasca.» «Oh, questo costa già l’osso del collo… È un ristorante francese. E non bisogna che tu spenda tutti i tuoi soldi per me.» «E per chi diavolo vuoi che li spenda?» Joe si sedette al tavolino e Janey andò a telefonare ad Alice che non sarebbe ritornata fino a tardi. Quando tornò al tavolino, Joe stava cavandosi dalle tasche certi pacchettini fatti su in carta velina rossa verderigata. «Oh, cosa sono?» «Aprili, Janey… Sono per te.» Janey aprì i pacchetti. Erano vari colletti di pizzo e una tovaglia ricamata. «Il pizzo è irlandese e l’altra viene da Madeira… Avevo anche un vaso cinese per te ma qualche porco fot… maledetto me l’ha grattato.» «Sei stato caro a pensare a me… Sono molto contenta.» Joe giocherellò con coltello e forchetta. «Bisogna muovere le gambe qui, Janey, altrimenti sarà tardi per il cine… Ho dei biglietti per Il giardino di Allah.» Quando uscirono dal Belasco in Lafayette Square, che era fresca e quieta con uno stormìo di vento negli alberi, Joe disse: «Vale una cicca, ho veduto una vera tempesta di sabbia io, una volta» e Janey si sentì a disagio col fratello così rozzo e maleducato. Lo spettacolo la faceva sentire come quando era piccola, piena di desideri ansiosi verso paesi lontani, l’odor dell’incenso, gli occhi foschi, i duchi con l’abito a code, che gettavano via il denaro sui tavoli da gioco di Monte Carlo, i
monaci e l’Oriente misterioso. Se Joe fosse soltanto stato un po’ meglio educato, sarebbe stato davvero capace di apprezzare tutti i porti interessanti che visitava. La lasciò sullo scalino di casa in Massachusetts Avenue. «Dove andrai a stare, Joe?» gli chiese. «Credo che finirò a New York e troverò una cuccetta… Fare il marinaio è una vigna con questa guerra.» «Stanotte?» Joe annuì. «Vorrei averci un letto per te, ma non posso per via di Alice.» «Macché, non voglio restare in questo buco… Sono soltanto venuto a salutarti.» «Allora, buona notte, Joe, e scrivi sicuro.» «Buona notte, Janey, certamente.» Lo guardò allontanarsi per la via, finché non scomparve nell’ombra degli alberi. La rattristò vederlo andarsene tutto solo per la via inombrata. Non aveva affatto il passo rollante del marinaio, ma aveva tutta l’aria d’un operaio. Janey sospirò ed entrò in casa. Alice l’attendeva in piedi. Mostrò ad Alice il pizzo e si provarono i colletti e conclusero che erano molto carini e di valore. Janey e Alice se la passarono bene quell’inverno. Si misero a fumare sigarette e offrire il tè agli amici, i pomeriggi della domenica. Leggevano romanzi di Arnold Bennett e s’immaginavano di far vita da donne scapole. Impararono a giocare al bridge e si accorciarono le sottane. A Natale, Janey ricevette da Dreyfus e Carroll una regalia di cento dollari e un aumento a venti la settimana. Incominciò a trattare Alice da vecchia bugianèn, perché restava con la signora Robinson. Per sé cominciò a nutrire ambizioni di un avvenire negli affari. Non aveva più paura degli uomini e scherzava a botta e risposta dentro l’ascensore con giovanotti impiegati, su argomenti che l’anno prima l’avrebbero fatta arrossire. Quando Johnny Edwards o Morris Byer la portavano al cinema la sera, non ci faceva caso se le mettevano il braccio intorno o se le davano un bacio o due mentre lei cercava, frugando nella borsetta, la chiave del portone. Sapeva bene come afferrare per il polso la mano di un giovanotto e respingerla senza far scene, quando questi cercasse di prendersi troppa confidenza. Quando
Alice tornava ogni tanto a metterla in guardia dagli uomini che non hanno che un pensiero, Janey rideva dicendo: «Non sono mica così svegli». Scoprì che un tantino di acqua ossigenata nel catino, quando si lavava i capelli, glieli faceva più biondi e cancellava quell’aria da topo. Talvolta, quando si preparava a uscire la sera, si metteva una punta di rossetto sul mignolo e se lo sfregava con molta attenzione sulle labbra.
Occhio fotografico (15) alla foce dello Schuylkill salì a bordo il signor Pierce, di novantasei anni e sano come un pesce. Lui era aiutante nell’ufficio del signor Pierce circa al tempo che si era arruolato e non si era potuto trovare alla battaglia di Antietam per via della dissenteria tanto violenta e la figliuola del signor Pierce, la signora Black, lo chiamava Jack e fumava sigarettine fosche. Suonavano Fra Diavolo sul grammofono e tutti erano allegrissimi. Il signor Pierce si tirava i favoriti e prese un toddy e la signora Black accendeva le sigarette una dopo l’altra e parlavano dei tempi d’una volta e di come suo padre avrebbe voluto farne un sacerdote e la sua povera madre aveva penato per mettere insieme tanto da sfamare quei ragazzi mai sazi e suo padre era un uomo taciturno e parlava quasi sempre portoghese e quando non gli piaceva com’era cucinato un piatto che arrivava in tavola, lo prendeva e lo buttava dalla finestra e Lui voleva mettersi in mare e studiò legge all’università e nell’ufficio del signor Pierce e cantava Chi può dire la sua gioia quando in mare la sua nave si mette a navigare… e Lui fece un toddy e il signor Pierce si tirava i favoriti e tutti erano allegrissimi e parlarono della goletta Mary Wentworth e come stavano seri il colonnello Hodgeson e padre Murphy sull’allegro bicchiere… e Lui fece un toddy e il signor Pierce si tirò i favoriti e la signora Black fumava le sigarettine fosche una dopo l’altra e tutti erano allegrissimi con Fra Diavolo che suonava sul grammofono e l’odore del porto e le chiatte e il Delaware tutto argentincrespato. Era tutto una palude dove andavamo a caccia delle anatre e Lui cantava Vittoria col grammofono… e a padre Murphy prese un tremendo attacco di gotta e dovettero portarlo via disteso su un’imposta e il signor Pierce di novantasei anni e sano come un pesce prese un sorso di toddy e si tirò i favoriti argenteo-increspati e l’odor di fiume veniva sul vento fresco e il fumo dei cantieri navali a Camden e l’odore limonato-spiritosozuccheroso dei bicchieri di toddy e tutti erano allegrissimi.
Cine-giornale XII Greci combattenti che fuggono davanti ai poliziotti. Viaggiatori in Vagone Letto Svegliati con una Pistola Sotto il Naso Corri fiume verso il mare rendi a me bel fiume rendi quell’amore COMBATTIMENTO A TORREON Cuba Nei Sussulti Della Rivolta Negra alla fine dell’ultima campagna, scrive Champ Clark, il brillante deputato del Missouri, ero quasi esaurito dal lavoro eccessivo, dalla tensione nervosa, dalla perdita del sonno e dell’appetito e dai continui discorsi, ma tre bottiglie di Electric Bitters mi rimisero in perfetta forma Roosevelt Capo di Un Nuovo Partito donna malaticcia esaurita dal lavoro che ritrova una splendida salute negli Electric Bitters CLARK FINISCE BRYAN CON L’AIUTO DI PARKER Io sincero ti sarò ma è un sentiero molto lungo molto lungo dalle rive della Senna il delitto per cui Richeson venne condannato alla sedia elettrica fu l’assassinio confessato della sua antica innamorata di 19 anni Avis Linnell di Hyannis allieva del conservatorio New England di Boston. La fanciulla impediva il matrimonio del pastore con una signorina di società ed ereditiera, di Brookline, tanto per la promessa che ancora sussisteva tra i due quanto per lo stato in cui si trovava la signorina Linnell. La fanciulla prese per inganno un veleno, fornitole da Richeson, che avrebbe dovuto rimediare a quel suo stato, e morì nella sua camera dell’Associazione cristiana delle giovani. ROOSEVELT DICE PER LA PRIMA VOLTA
COME PRENDEMMO PANAMA 100.000 persone che non possono entrare nel grande salone fanno eco agli applausi all’ora del pranzo il governatore disse che non aveva sentito notizie dirette da parte del signor Bryan per tutto il giorno. «Con l’attuale andamento di ripresa,» disse il signor Wilson «letti i risultati del quindicesimo scrutinio, calcolo che ci vorranno ancora 175 scrutini per portarmi a buon punto.» Il Giovanotto dai Capelli Rossi Dice che Sono State le Storie delle Facili Ricchezze a Portarlo al Delitto l’interesse per il fatto divenne intenso il 20 dicembre quando si seppe che l’ex ecclesiastico si era mutilato da sé nella sua cella al carcere di Charles Street CINQUE UOMINI MUOIONO DOPO ESSER GIUNTI AL POLO SUD DÍAZ PUNTA L’ARTIGLIERIA PESANTE SUL QUARTIERE DEGLI AFFARI Dalle rive della Senna c’è di mezzo ancora il mare una donna non può stare non può stare senza rive della Senna
Il ragazzo oratore del Platte Fu nell’Assemblea di Chicago nel ’96 che il ragazzo oratore vincitore del premio, il figlio del pastore, le labbra del quale non avevan mai toccato un liquore, emise la sua voce d’argento tanto da riempire il gigantesco salone, e le orecchie della semplice gente: Signor presidente e signori dell’assemblea: Sarei veramente presuntuoso a presentarmi contro i distinti signori che avete ascoltato, se questa fosse una semplice gara di abilità; ma questa non è una gara d’individui. Il più umile cittadino di tutto il paese, quando sia rivestito dell’armatura di una giusta causa, è più forte di tutte le schiere dell’errore. Io vengo a parlarvi in difesa di una causa altrettanto sacra che la causa della Libertà… un uomo piuttosto giovane, dalla grande bocca, dalla cravatta bianca un guitto, un predicatore, un evangelista, la sua voce incantava gli ipotecati contadini delle grandi pianure, echeggiava per edifici scolastici dal tetto di legno nella vallata del Missouri, era dolce agli orecchi di piccoli bottegai avidi di un facile credito, struggeva le viscere di tutti, come il canto di un tordo o di un motteggiatore nella pace grigia prima dell’alba o come un balzo improvviso dei grani d’inverno o una tromba che dia gli squilli e la bandiera sventoli; Lingua d’argento della semplice gente: … colui che è impiegato a stipendio è tanto uomo d’affari quanto il suo principale; l’avvocato di una cittadina di campagna è altrettanto uomo d’affari che il consulente di una società in una grande metropoli; il negoziante del negozio sul crocicchio è altrettanto uomo d’affari che il negoziante di New York; il contadino che esce al mattino e fatica tutto il giorno, che comincia in
primavera e fatica tutta l’estate e che applicando il cervello e il braccio alle risorse naturali del paese crea la ricchezza, è altrettanto uomo d’affari quanto l’uomo che va alla Camera di Commercio e specula sul prezzo dei grani; i minatori che discendon mille piedi dentro la terra o s’inerpicano per duemila piedi sulle rupi e strappano dai loro nascondigli i metalli preziosi da versare nei canali del commercio sono altrettanto uomini d’affari quanto i pochi magnati della finanza che in una camera segreta ammucchiano il denaro del mondo. Il bracciante e l’avvocato di campagna si alzarono e ascoltarono, queste erano le parole che occorrevano al contadino che aveva ipotecato il raccolto per pagare il concime, le parole che occorrevano al chincagliere di provincia, al droghiere, al mercante di foraggi e cereali, all’appaltatore, all’ortolano… E siccome abbiamo dietro di noi le masse produttrici di questa nazione e del mondo appoggiate dagli interessi commerciali, dagli interessi operai e dagli uomini di fatica, ovunque, noi rispondiamo a coloro che chiedono un tallone aureo dicendo loro: Voi non pianterete sulla fronte del lavoro questa corona di spine, voi non crocifiggerete l’umanità sopra una croce d’oro. Urlarono da spaccarsi i polmoni (corona di spine e croce d’oro) lo portarono per il salone sulle spalle, lo abbracciarono, lo amarono, diedero il suo nome ai loro figli, lo proposero a presidente, ragazzo oratore del Platte, lingua d’argento della semplice gente.
Ma McArthur e Forrest, due scozzesi del Rand, avevano inventato il processo al cianuro di estrarre l’oro dal minerale, il Sudafrica inondò il mercato aurifero; non c’era bisogno di un profeta dell’argento. La lingua d’argento continuò a inneggiare dalla grande bocca, inneggiando al Pacifismo, al Proibizionismo, al Fondamentalismo; mordicchiando ravanelli sul palco delle conferenze, bevendo sciroppo d’uva e acqua, ingurgitando grossi pasti di granturco; Bryan divenne grigio nell’atmosfera soffocante delle tende Chautauqua, 1 tra gli applausi, tra le strette di mano, tra le pacche sulla schiena, tra il fumo di sigaro dei comitati delle assemblee democratiche, una lingua d’argento in una grande bocca. A Dayton sognò di giocar di nuovo il suo tiro, di rimettere indietro gli orologi per la semplice gente, di marchiare, scorticare, far tutta una gran burla del darwinismo, delle idee miscredenti degli scienziati di città, degli stranieri dalla barba e dalla morale scimmiesca. Nella Florida aveva parlato tutti i giorni a mezzodì su una zattera sotto un tendone vendendo appezzamenti per Coral Gables… lui ne aveva bisogno di parlare, di sentire le voci morenti far silenzio, di sentire le orecchie tese nell’approvazione, la bufera dei battimani. Perché non far di nuovo la campagna in lungo e in largo a inalberar di nuovo la parola vacillante, per la semplice gente che voleva la semplice parola di Dio? (corona di spine e croce d’oro) la semplice prospera comoda parola di Dio per semplici prosperi comodi americani del centro? Era una gran forchetta. Faceva caldo. Un colpo lo ammazzò. Tre giorni dopo giù in Florida la compagnia consegnò il cavalletto elettrico che lui aveva ordinato per far ginnastica quando aveva veduto il cavalletto elettrico su cui il presidente faceva ginnastica alla Casa Bianca. 1. Compagnia americana di scuole per corrispondenza, che fa anche giri di conferenze.
Occhio fotografico (16) faceva caldo come in un forno a scendere per il canale da Delaware City e le tartarughe che pigliavano il sole capitombolavano nella spessa onda color ocra che producevano passando Lui era allegro e Lei una volta tanto si sentiva bene e Lui fece un punch di tè menta e un po’ di rum Saint Croix ma faceva caldo come le porte di Delaware 1 e vedemmo fringuelli scarlatti e merli dall’ala rossa e martin pescatori che chiocciolavano irosamente mentre l’onda gialla dalla candida prora frusciava tra i giunchi e le tife e il calamo Lui parlava di riforme legislative e che gente erano i politicanti e dove erano gli Uomini Degni in questo paese e diceva: Proprio con le idee che ho non ho potuto essere eletto pubblico notaio in nessun distretto dello Stato neanche per tutto il denaro del mondo e nemmeno accalappiacani 1. Freddura basata sull’espressione inglese: “caldo come le porte dell’Inferno”. (NdT)
J. Ward Moorehouse Nacque a Wilmington, Delaware, il 4 luglio. Dall’ospedale la povera signora Moorehouse sentì i mortaretti all’esterno scoppiare e crepitare per tutto il tempo che ebbe le doglie. E quando rinvenne e le portarono il bambino, domandò all’infermiera, con un bisbiglio rauco e tremulo, se pensava che tutto quel rumore avrebbe avuto un cattivo effetto sul bambino, influsso prenatale, come sapete. L’infermiera disse che il ragazzino doveva diventare molto patriottico e probabilmente presidente, essendo nato il Glorious Fourth, e si mise a raccontare una lunga storia di una donna che era stata spaventata da una mano cacciatale d’improvviso sotto il naso da un mendicante immediatamente avanti il parto e il bambino era nato con sei dita, ma la signora Moorehouse era troppo debole per ascoltare e s’addormentò. Più tardi, passò il signor Moorehouse, di ritorno dalla stazione dove lavorava come impiegato, e decisero di chiamare il piccolo John Ward, rinnovando il padre della signora Moorehouse, agricoltore nello Iowa e persona molto a mezzi. Poi il signor Moorehouse andò fino da Healy a sbronzarsi, dato che lui era padre e quel giorno era il Glorious Fourth, e la signora Moorehouse tornò a dormire. Johnny crebbe a Wilmington. Aveva due fratelli, Ben e Ed, e tre sorelle, Myrtle, Edith e Hazel; ma tutti dicevano che, come lui era il più vecchio, così era l’aquila della famiglia. Ben e Ed erano più forti e più atticciati, ma lui era il campione di birilli della scuola, e si fece una fama considerevole un trimestre con un’incetta di birilli screziati che condusse a compimento con l’aiuto di un ragazzotto ebreo, Ike Goldberg, per cui i due riuscirono a dare in affitto agli altri ragazzi birilli screziati a dieci un cent la settimana. Quando ci fu la Guerra spagnola, tutti a Wilmington traboccavano di entusiasmo marziale, tutti i ragazzi seccavano i parenti perché gli comprassero la divisa da Rough Rider e giocavano ai filibustieri, alle guerre indiane e al colonnello Roosevelt e Ricordati il Maine e alla White Fleet e all’Oregon che navigava nello stretto di Magellano. Johnny era una sera d’estate sul molo, quando la squadra dell’ammiraglio Cervera, che passava in
formazione di combattimento per i Delaware Capes, venne avvistata da un distaccamento della milizia statale, che senz’altro aprì il fuoco su un vecchio negro che pescava gamberetti nel fiume. Johnny corse a casa come Paul Revere 1 e la signora Moorehouse raccolse i suoi sei bambini; spingendone due dentro la carrozzella e tirandosi dietro gli altri quattro, si diresse alla stazione in cerca del marito. Quando ebbero deciso di saltare sul primo treno per Filadelfia, girò la notizia che la squadra spagnola non erano altro che certe barche in pesca di menhaden e che i militi venivano consegnati in baracca per ubriachezza. Ritirata fin l’ultima lenza da gamberi, il vecchio negro ritornò, remando, a terra e mostrò agli amici vari spacchi prodotti dalle pallottole nei fianchi dell’imbarcazione. Quando Johnny prese la licenza, come capo del gruppo controversie, oratore della classe e vincitore nella gara di componimento con un saggio intitolato “Roosevelt l’uomo del momento”, tutti sentirono che bisognava mandarlo all’università. Ma la situazione finanziaria della famiglia non era troppo florida, disse suo padre scuotendo il capo. La povera signora Moorehouse, che era sempre stata malaticcia dalla nascita dell’ultimo bambino, era andata all’ospedale per un’operazione e ci sarebbe stata qualche tempo. I bambini più piccoli avevano avuto la rosolia, la tosse asinina, la scarlattina e gli orecchioni, tutto l’anno. C’era da pagare l’ammortizzamento della casa e il signor Moorehouse non aveva avuto l’aumento atteso, quel Capodanno. Così, invece di lavorare da aiutante spedizioniere o raccogliere pesche nei paraggi di Dover come aveva fatto le altre estati, Johnny girò nel Delaware, nel Maryland e nella Pennsylvania, come agente di una ditta distributrice di libri. A settembre ne ricevette un biglietto di congratulazioni. Questo biglietto diceva che lui era il primo agente che avessero mai avuto capace di vendere un centinaio consecutivo di raccolte della storia degli Stati Uniti del Bryant. Forte di questo, Johnny Moorehouse andò a West Philadelphia e fece domanda di un posto gratuito all’università di Pennsylvania. Ebbe il posto, passò agli esami e si iscrisse come matricola, scegliendo la facoltà di Scienze. Nel primo trimestre lasciò Wilmington per risparmiare la spesa di una camera. Il sabato e la
domenica faceva qualche soldo raccogliendo sottoscrizioni per le conferenze di Stoddard. Tutto sarebbe andato bene, se suo padre non fosse scivolato sugli scalini della stazione rompendosi un’anca, una mattina di gennaio, quando Johnny era già fagiolo. Venne portato all’ospedale e seguì una complicazione dopo l’altra. Un avvocato ebreo, di fatto il padre di Ike Goldberg, venne a vedere Moorehouse disteso con la gamba per aria, tutta ingessata, e lo indusse a querelare la compagnia chiedendo centomila dollari in base alla legge sulla responsabilità dei datori di lavoro. Gli avvocati della compagnia portarono testimoni in prova che Moorehouse beveva forte e il dottore, che lo aveva visitato, testimoniò che mostrava tracce di aver preso liquori il mattino della disgrazia, cosicché alla metà di giugno Moorehouse uscì arrancando sulle grucce dall’ospedale, senza lavoro e senza indennità. Fu questa la fine degli studi universitari di Johnny e gli lasciò dentro un duraturo astio contro il bere e contro suo padre. La signora Moorehouse per salvare la casa dovette scrivere, chiedendo aiuti, a suo padre, ma la risposta ci mise tanto che, prima che arrivasse, la banca mandò in protesto, e comunque non sarebbe servito a molto, perché erano soltanto cento dollari in biglietti da dieci, chiusi in una busta raccomandata, e servirono appena a pagare le spese del trasloco al pianterreno di una baracca di legno, a quattro alloggi, vicino alla stazione merci della Pennsylvania. Ben lasciò la scuola e prese un posto da aiuto spedizioniere e Johnny riluttando abbandonò la speranza di una laurea all’università di Pennsylvania ed entrò nell’ufficio di Hillyard e Miller, immobiliari. Myrtle e la mamma cuocevano torte alla sera e facevano pasta angelica da mandare al magazzino per donne e il signor Moorehouse sedeva in una poltrona da infermo nel salotto d’entrata, maledicendo gli avvocati ebrei, i tribunali e la Pennsylvania Railroad. Fu una brutta annata per Johnny Moorehouse. Aveva venti anni, né beveva né fumava e si manteneva casto per la ragazza che avrebbe sposato, una ragazzina in mussolina rosa coi riccioli d’oro e l’ombrellino. Stava seduto nel muffito ufficio di Hillyard e Miller elencando proprietà da affittare, camere ammobiliate, alloggetti, lotti in vendita, e pensava alla guerra boera, al Vigor di vita 2 e alle ricerche
aurifere. Dalla sua scrivania vedeva un tratto di una via di case in legno e un paio di olmi, attraverso un vetro sudicio. Davanti alla finestra c’era d’estate un acchiappamosche conico a fil di ferro aggrovigliato, dove le mosche prigioniere ronzavano e sibilavano, e d’inverno una stufetta a gas aperta, che emetteva un flebile fischio tutto suo particolare. Alle sue spalle, dietro una tramezza di vetro smerigliato, che saliva fin quasi al soffitto, il signor Hillyard e il signor Miller sedevano l’un di fronte all’altro a una gran scrivania doppia, fumando sigari e pasticciando carte. Il signor Hillyard era un uomo smorto in faccia, con capelli neri un po’ troppo lunghi, che era stato sulla strada di farsi una rinomanza come avvocato penalista, quando, per via di un qualche scandalo che nessuno mai nominava, essendo universalmente convenuto in Wilmington che la sua vita l’aveva riscattato, il collegio degli avvocati l’aveva espulso. Il signor Miller era un ometto faccia tonda, che viveva con la madre attempata. Era stato costretto a mettersi nell’attività immobiliare, perché suo padre era morto lasciandogli lotti da costruzione, sparpagliati per Wilmington e alla periferia di Filadelfia, e nient’altro da viverci su. Il lavoro di Johnny consisteva nello star seduto nel primo ufficio e mostrarsi gentile coi probabili compratori, elencare proprietà, curare la pubblicità, dattilografare le lettere della ditta, vuotare i cestini e gli acchiappamosche, condurre i clienti a visitare gli alloggi, le case e i lotti di terreno, e, in genere, rendersi utile e piacevole. Fu durante questo lavoro che si accorse di avere un paio di vividi occhi azzurri e di saper assumere una cattivante aria fanciullesca che alla gente piaceva. Vecchie signore in cerca di casa solevano chiedere in particolare la guida di quel distinto giovanotto e gli uomini d’affari che capitavano a far quattro chiacchiere col signor Hillyard o col signor Miller accennavano del capo con aria convinta e dicevano: «Ragazzo in gamba, quello». Guadagnava otto dollari alla settimana. Oltre al Vigor di vita e alla cara ragazza che doveva innamorarsi di lui, c’era una sola cosa che occupava la mente di Johnny Moorehouse, mentre sedeva alla scrivania elencando soddisfacenti case d’alloggio di cinque o sette vani: salotto, sala da pranzo, cucina e dispensa, tre camere da letto padronali col bagno, una stanza per la donna, acqua,
elettricità, gas, posizione salubre su terreno ghiaioso in una limitata area residenziale. Johnny avrebbe voluto fare il compositore di canzonette. Aveva una piacente voce tenorile e ce la faceva a Lardboard Watch oppure I Dreamt I Dwelt in Marble Halls oppure ‘Mid Pleasures and Palaces Though We Roam, molto soddisfacentemente. I pomeriggi della domenica prendeva lezioni di musica dalla signorina O’Higgins, una raggrinzita irlandese, piccola, nubile, sui trentacinque, che gli insegnava gli elementi del piano e ascoltava rapita le sue composizioni originali, che lei scriveva su fogli da musica, già pronti con tutti i righi quando Johnny arrivava. Una canzone che cominciava Qual è lo Stato del pesco fiorito, delle fanciulle belle?… Il Delaware le parve buona abbastanza da mandarla a un editore musicale di Filadelfia, ma le tornò indietro, come fece la composizione successiva, sulla quale la signorina O’Higgins – Johnny la chiamava già Marie e lei diceva che non avrebbe preso denaro da lui per le lezioni, almeno fino a quando lui non fosse ricco e famoso –, sulla quale Marie pianse e disse che valeva McDowell, e cominciava Laggiù nel Delaware la baia argentea scende nel mare in mezzo ai peschi in fiore quando il mio cuore piange dall’angoscia la sua memoria mi ritorna in cuore. La signorina O’Higgins aveva un salottino con sedie dorate, dove dava le sue lezioni di musica. Vi pendevano pesanti cortine di pizzo e portiere damascate, color salmone, comperate a un’asta pubblica. Al centro c’era un tavolo di noce nero, coperto da pile di logori album in cuoio nero. La domenica pomeriggio, quand’era finita la lezione, la signorina portava il tè, i dolci e i crostini alla cannella. Johnny stava sdraiato nella poltrona di crine, che bisognava tener coperta estate e inverno con un panno fiorito perché era tanto strusciata, e i suoi occhi erano così azzurri e parlava di cose che avrebbe voluto fare e metteva in burla il signor Hillyard e il signor Miller, e lei gli raccontava storie di grandi compositori e le s’infiammavano le guance e sentiva d’esser quasi bella e che tra loro, dopo tutto, il divario d’età non era così terribile. Manteneva con le sue lezioni di musica una madre inferma e
un padre che era stato un noto baritono e patriota a Dublino ai tempi della giovinezza, ma che adesso si era messo a bere; ed era pazzamente innamorata di Johnny Moorehouse. Johnny Moorehouse continuava a lavorare da Hillyard e Miller, seduto nell’ufficio che sapeva di chiuso, irritandosi quando non aveva niente da fare, finché pensava di ammattire, correr la strage e uccidere qualcuno; mandando agli editori canzoni che sempre gli ritornavano; leggendo il «Success Magazine» pieno di stanchi aneliti verso il futuro: esser lontano da Wilmington e dal borbottio e dal fumo di pipa di suo padre, dal fracasso che facevano fratellini e sorelline, dall’odore di carne in scatola e cavoli, dall’affranto viso grinzoso e dalle mani logore della madre. Ma un giorno venne mandato a Ocean City, Maryland, a riferire su certi appezzamenti che la ditta aveva in elenco laggiù. Sarebbe andato il signor Hillyard personalmente, soltanto che aveva un foruncolo sul collo. Diede a Johnny il biglietto di andata e ritorno e dieci dollari per il viaggio. Era un soffocante pomeriggio di luglio. Johnny corse a casa a prendere una valigetta e a mutarsi d’abito e arrivò alla stazione giusto in tempo per salire sul treno. Il viaggio era soffocante e faceva sudare, giù per orti di peschi e deserti di pini, sotto un fiammeggiante cielo d’ardesia che riverberava da terreni sabbiosi tra scabri granturcheti e baracche imbiancate e strisce di pantani. Johnny si era tolta la giacca del vestito di flanella grigia e, ripiegandola sul sedile accanto per non spiegazzarla, vi aveva messo sopra il colletto e la cravatta per averli in ordine all’arrivo, quando notò una ragazza dagli occhi scuri, in un abito rosa pieghettato e ampio cappello bianco di paglia, seduta dall’altra parte del corridoio. Era parecchio più anziana di lui e aveva l’aria di quel tipo di donna vestita alla moda, che sarebbe stato più a posto in una vettura salotto che non nel carrozzone comune. Ma Johnny ricordò che non c’erano vetture salotto su quel treno. E quando non la guardava, sentiva che era lei a guardarlo. Si affrettò a rimettersi la cravatta e la giacchetta e si lambiccò il cervello per trovare qualche modo di attaccar discorso. Sentiva di doverle parlare. Il pomeriggio si copriva e cominciò a piovere, grosse gocce si
rompevano sui finestrini. La ragazza in pieghettature rosa si arrabattava per chiudere il finestrino. Johnny saltò in piedi e glielo abbassò. «Permettete» disse. «Grazie.» La ragazza alzò gli occhi e gli sorrise. «È così sporco in questo orribile treno.» Gli mostrò i guanti bianchi tutti insudiciati dai fermagli del finestrino. Johnny tornò a sedersi dalla parte interna del sedile. L’altra gli volse interamente la faccia. Era una faccia scura, irregolare, con brutte righe dal naso agli angoli della bocca, ma quegli occhi gli rimescolarono il sangue. «Non vi parrà troppo spregiudicato da parte mia, se parliamo un poco, vero?» disse quella. «Mi secco a morte su quest’orribile treno e non ci sono vetture salotto, benché l’impiegato a New York giurasse che ce n’era.» «Scommetto che siete in viaggio da tutto il giorno» disse Johnny con un’aria timida e fanciullesca. «Peggio. Son discesa da Newport sul battello la notte scorsa.» Il tono casuale con cui disse Newport lo fece trasalire. «Io vado a Ocean City» disse. «Anch’io. Non è un posto orribile? Non ci vorrei stare nemmeno un secondo se non fosse per il babbo. Lui sostiene che gli piace!» «Dicono che Ocean City abbia un grande avvenire… Dal punto di vista dei terreni da costruzione, cioè» disse Johnny. Ci fu una pausa. «Sono salito a Wilmington» disse Johnny con un sorriso. «Un luogo orribile, Wilmington… Non posso sopportarlo.» «Ci sono nato e cresciuto… Credo sia per questo che mi piace» disse Johnny. «Oh, non intendevo dire che a Wilmington non ci sia gente distinta… care famiglie antiche… Conoscete i Rawlins?» «Oh, non importa… Non voglio già passare a Wilmington tutta la vita… Ma guardate che pioggia.» Pioveva così forte che un canale coperto si era allagato e il treno giunse a Ocean City con quattro ore di ritardo. Quando arrivarono, erano ormai buoni amici, aveva tuonato e folgorato e la donna era stata tanto nervosa e lui si era mostrato tanto forte e protettore e il vagone si era empito di zanzare e tutti e due, mangiati vivi, si erano
sentiti insieme crescere l’appetito. La stazione era nera come la pece e non si vedevano facchini e Johnny dovette fare due viaggi per portarle fuori le valigie e, anche allora, quasi dimenticavano la borsetta in pelle di coccodrillo e lui dovette ritornare alla vettura una terza volta a prenderla e insieme a prender la propria valigia. A quel punto era già comparso un vecchio moro con un biroccino, che disse di venire dall’Ocean House. «Spero che anche voi ci andiate» disse la donna. Johnny disse di sì e salirono, benché non ci fosse spazio per posare i piedi, tante erano le valigie di lei. Non c’erano lampioni in Ocean City per via della burrasca. Le ruote del biroccino scricchiolavano in profonde buche di sabbia, di tanto in tanto questo rumore e gli schiocchi di lingua del cocchiere al cavallo venivano affogati nel muggito della risacca sulla spiaggia. L’unica luce veniva dalla luna nascosta continuamente da nuvole fuggenti. La pioggia era cessata, ma l’aria tesa dava l’impressione di un altro rovescio imminente. «Sarei certamente perita nella tempesta, se non fosse stato per voi» disse lei; poi d’improvviso gli porse la mano come un uomo. «Mi chiamo Strang… Annabelle Marie Strang… Non è un nome buffo?» Johnny le prese la mano. «Io, John Moorehouse… Fortunatissimo, signorina Strang.» La palma della mano di lei era calda e asciutta. Parve comprimersi nella sua. Quando la lasciò s’accorse che lei avrebbe voluto la tenesse di più. Rideva la donna, d’un riso duro e sommesso. «Adesso abbiamo fatto le presentazioni, signor Moorehouse, e tutto è in regola… State certo che dirò quel che gli viene, al babbo. Si è mai sentito, non venire alla stazione incontro all’unica figlia?» Nello scuro vestibolo dell’albergo, rischiarato da un paio di affumicate lanterne, la vide con la coda dell’occhio gettare le braccia al collo di un uomo alto dai capelli bianchi, ma quando ebbe scarabocchiato sul registro John W. Moorehouse, nella sua più impetuosa calligrafia, e ricevuta la chiave dall’impiegato, quelli se ne erano già andati. Su, nella stanzetta in legno di pino, faceva troppo caldo. Quando aprì la finestra, il muggito della risacca entrò per la persiana rugginosa, fondendosi allo strepito della pioggia sul tetto. Si cambiò il colletto e si lavò con acqua tiepida, versata dalla brocca
screpolata che c’era, e scese in sala da pranzo per tentar di trovare qualcosa da mangiare. Una cameriera dentuta come un caprone stava appunto portandogli la minestra, quando la signorina Strang giunse, seguita dall’uomo alto. Siccome l’unica lucerna si trovava sul tavolo dov’era lui, quelli si avvicinarono e Johnny si alzò sorridente. «Eccolo, babbo» disse lei. «E gli siete debitore del cocchiere che ci ha portati dalla stazione… Signor Morris, vi presento mio padre, il dottor Strang… Morris vi chiamate, vero?» Johnny arrossì. «Moorehouse, ma fa lo stesso… Sono lieto di conoscervi, signore.» Cenarono insieme. La signorina Strang si lagnava continuamente del cibo e domandava alla cameriera se non poteva trovar loro qualcosa un po’ meglio di quella farinata fredda in quegli orribili semicupi da uccellini e il dottor Strang rideva e le disse che diventava troppo alta società. Johnny pensò che avrebbe fatto bene a stare zitto, finché non fosse maggiormente entrato nello spirito di quella gente. La ragazza continuava a guardarlo con quegli scuri occhi audaci, che lo riempivano di agitazione; già Johnny cercava di immaginarsi come avrebbe potuto restare un giorno o due di più. La mattina dopo si alzò presto e andò all’ufficio dell’Improvement and Realty Company di Ocean City, la quale si trovava in una villetta recente, dagli embrici macchiati di verde, sulla nuova via lungo la spiaggia. Non c’era nessuno, e così andò a girare la cittadina. Era una grigia giornata d’afa e le casette e i negozi in legno e le baracche non ancora dipinte, lungo il binario della ferrovia, avevano un’aria ben desolata. Di tanto in tanto, Johnny si schiacciava una zanzara sul collo. Aveva il suo ultimo colletto pulito e lo preoccupava il timore che gli si strusciasse. Ogni volta che usciva dai marciapiedi di tavole, gli entrava sabbia nelle scarpe e acute lappole di spiaggia gli aderivano alle caviglie. Finalmente trovò un individuo corpulento, vestito di tela bianca, seduto sugli scalini dell’ufficio Beni immobili. «Buon giorno, signore,» disse «siete voi il colonnello Wedgewood?» Quello corpulento era troppo trafelato per rispondere e non fece che accennare del capo. Aveva un fazzolettone di seta ficcato nel colletto alla nuca e con un altro si tergeva la faccia. Johnny gli diede la lettera della ditta e rimase in attesa che dicesse qualcosa. Il grassone lesse la
lettera, con le ciglia aggrottate, e lo precedette nell’ufficio. «È quest’asma» ansimò in mezzo a gran fiatate sibilanti. «Mi taglia il respiro se cerco di andare in fretta. Sono lieto di conoscervi, figlio mio.» Johnny definì il contratto dei terreni che venivano venduti a percentuale spartita, attraverso Hillyard e Miller e l’Improvement and Realty Company di Ocean City unitamente; e passò il resto della mattinata intorno al vecchio colonnello Wedgewood, con gli occhi azzurri e l’aria fanciullesca, prestando cortesemente orecchio alle storie della guerra civile e del generale Lee e del suo cavallo bianco Traveller e dei banchetti di prima della guerra sulla Costa Orientale; corse in negozio a prendere un pane di ghiaccio per il frigorifero, fece un discorsetto intorno all’avvenire di Ocean City come villeggiatura estiva – «Ma che cosa c’è a Atlantic City o a Cape May, che non l’abbiamo anche noi qui?» vociò il colonnello –, andò con lui a pranzo nella sua villetta perdendo così il treno che avrebbe dovuto prendere per il ritorno a Wilmington, rifiutò uno sciroppo di menta – non beveva né fumava mai – però assistette con ammirazione al colonnello che ne preparò e bevve due robusti, contro l’asma; esercitò il sorriso, gli occhi azzurri e i passettini infantili sulla cuoca negra del colonnello, Mamie, e alle quattro stava facendo risate sul governatore della Carolina del Nord e sul governatore della Carolina del Sud e aveva accettato un impiego nell’Improvement and Realty Company di Ocean City a quindici dollari la settimana, con casetta ammobiliata sul patto. Ritornò all’albergo e scrisse al signor Hillyard, accludendo i documenti per i terreni e il suo conto delle spese, si scusò se lasciava la ditta dietro un così breve preavviso, ma spiegò che questo, di avvantaggiarsi quanto più poteva, doveva farlo per i suoi, che erano in ristrettezze; poi scrisse a sua madre, che si fermava a Ocean City e che facesse il favore di spedirgli alla grande velocità i suoi abiti; si chiese se doveva scrivere alla signorina O’Higgins, ma decise di no. Dopo tutto, il passato era passato. Quand’ebbe mangiato la cena, andò al banco e chiese il conto, tutto nervoso per la paura di non aver denaro abbastanza per pagare, e stava appunto uscendo con un mezzo dollaro in tasca e la valigia in
mano, quando incontrò la signorina Strang. Era in compagnia di un ometto scuro, vestito di flanella, che gli presentò come Monsieur de la Rochevillaine. Era un francese, ma parlava bene l’inglese. «Spero che non ci lasciate» disse lei. «No, signorina, vado a stare lungo la spiaggia, in una delle casette del colonnello Wedgewood.» Il francese metteva Johnny a disagio, così sorridente e soave come un barbiere accanto a lei. «Oh, conoscete quel grasso simpaticone, allora? È un grande amico del babbo. Lo trovo un po’ troppo seccante col suo cavallo bianco Traveller.» La signorina Strang e il francese sorrisero insieme, come avessero qualche segreto in comune. Il francese le stava al fianco dondolandosi sui tacchi, come se fosse accanto a un qualche mobile di sua proprietà e lo stesse vantando a un amico. A Johnny venne voglia di appioppargliene uno, dritto dove la maglia candida si gonfiava in pancetta. «Bisogna che vada» disse. «Non volete tornare più tardi? si ballerà un poco. Ameremmo ci foste anche voi.» «Ma sì, tornate ad ogni modo» disse il francese. «Verrò se mi sarà possibile» disse Johnny; e se ne andò con la valigia tra mano, sentendosi sudaticcio sotto il colletto e indiavolato. «Maledetto quel francese» disse a voce alta. Eppure c’era qualcosa nel modo che la signorina Strang aveva di guardar lui. Concluse che stava innamorandosi. Trovò il dottor Strang dal colonnello e venne in chiaro che l’Improvement and Realty Company di Ocean City consisteva nel colonnello, nel dottor Strang e in Obadiah Ames, il bottegaio, un uomo scuro con barba di due giorni e mani molto pelose, un povero bianco, 3 decise Johnny. Stavano discutendo un opuscoletto e una campagna pubblicitaria generale e lo trattarono da esperto in quegli argomenti. Ciò lo rimise a posto e così, quando ritornò all’albergo in cerca della signorina Strang, se la sentiva di tener testa a quel francese, pur non sapendo ballare. Fu un agosto caldissimo; le mattine quiete, i pomeriggi accumulanti nell’afa i temporali. Tranne quando c’eran clienti da portar in giro per gli scottanti appezzamenti di sabbia e i deserti di
pini segnati di vie, Johnny sedeva all’ufficio, solo, sotto un ventilatore a due ali, vestito di flanella bianca e in camicia rosa da tennis rimboccata ai gomiti, abbozzando la descrizione lirica di Ocean City (Maryland) che avrebbe servito di prefazione all’opuscolo: “Le onde vivificatrici del grande Atlantico battono sulle spiagge cristalline di Ocean City (Maryland)… le toniche esalazioni dei pini portan sollievo agli asmatici e ai tisici… non lontano, quel paradiso dei cacciatori che è l’Indian River distende il suo vasto estuario formicolante di…”. Nel pomeriggio entrava il colonnello sudato e ansimante e Johnny gli leggeva ciò che aveva scritto e quello diceva: «D’incanto, figliolo, d’incanto» e suggeriva di rifarlo tutto. E Johnny cercava una nuova infornata di parole in un orecchiuto vocabolario, e ricominciava. Sarebbe stata una bella vita, se non fosse stato innamorato. La sera non poteva star lontano dall’Ocean House. Ogni volta che saliva gli scalini scricchiolanti del portico e, passando davanti alle vecchie signore che si dondolavano e rinfrescavano con ventagli di foglia di palma, entrava per la porta a battenti nel vestibolo, era certo che questa volta avrebbe trovato Annabelle Marie sola, ma sempre c’era con lei quel francese, più sorridente, più calmo, più pancetta che mai. Tutti e due si davano un gran da fare intorno a Johnny e lo coccolavano come un cagnolino o un bambino prodigio; Annabelle Marie gli insegnò a ballare il boston, e il francese, che si chiarì un duca o barone o cosa fosse, badava a offrirgli bibite e sigari e sigarette profumate. Johnny rimase inorridito quando vide che lei fumava, ma chissà, era una cosa legata ai duchi, a Newport, ai viaggi all’estero e a tutto il resto. La donna usava una certa qualità di profumo muschiato, e la fragranza di questo, insieme col lieve fortore di sigaretta che le restava nei capelli, quando ballava con lei gli dava la vertigine e la febbre. Qualche notte cercò di spossare il francese al gioco del biliardo, ma allora lei scompariva per andar a dormire e a Johnny non restava che tornare a casa bestemmiando tra i denti. Spogliandosi, si sentiva ancora un lieve solletico di muschio alle narici. Tentava di mettere insieme una canzone: Sul mare d’argento per te è il mio tormento
Annabelle Marie… Poi tutt’a un tratto s’accorgeva che era troppo troppo stupida e passeggiava su e giù per la sua veranda in pigiama, con le zanzare sibilanti intorno al capo e il battito del mare e il ghigno delle libellule e delle cavallette nelle orecchie, maledicendo la sua giovinezza e povertà e ineducazione, e prospettando come si sarebbe fatto un gruzzolo tanto grosso da togliersi dai piedi qualunque rompiscatole francese; e allora sarebbe stato lui l’amore e il paragone di Annabelle Marie e non gli sarebbe più importato, se lei lo voleva, che si tenesse un rompiscatole francese come portafortuna. Stringeva i pugni e passeggiava per la veranda, mormorando: «Perdio, son capace». Poi una sera trovò Annabelle Marie sola. Il francese era partito col treno di mezzodì. Parve lieta di vederlo, ma era chiaro che qualcosa le pesava in mente. Aveva troppa cipria in faccia e gli occhi rossi; forse aveva pianto. C’era la luna. Gli mise una mano sul braccio: «Moorehouse, passeggiate sulla spiaggia con me» disse. «Non posso soffrire tutte queste galline spennate, in poltrona.» Sul passeggio che attraverso uno scabro prato portava alla spiaggia, incontrarono il dottor Strang. «Che cosa succede a Rochevillaine, Annie?» disse. Era un uomo alto con una fronte spaziosa. Aveva le labbra serrate e un’aria impensierita. «Ha ricevuto una lettera di sua madre… Non gli permette.» «Diavolo, ma è d’età, no?» «Papà, tu non capisci la nobiltà francese… il consiglio di famiglia non gli permette… Potrebbero tagliargli le rendite.» «Accidenti, ne avrai abbastanza tu per due… Gliel’ho anche detto.» «Oh, sta’ zitto, adesso, non puoi?…» Si mise d’improvviso a singhiozzare come una bimba. Passò davanti a Johnny di corsa e tornò all’albergo, lasciando Johnny e il dottor Strang a faccia a faccia sulle strette tavole. Il dottor Strang s’accorse allora di Johnny. «Uhm… scusateci» disse sfiorandolo; e risalì a lunghi passi il marciapiede, lasciando che Johnny scendesse alla spiaggia e guardasse la luna tutto solo.
Ma nelle notti successive Annabelle Marie uscì sulla spiaggia con lui e cominciò a sentire di non aver forse amato tanto il francese, dopo tutto. Andavano insieme oltre le ultime casette sparse, facevano un fuocherello e sedevano a fianco a fianco guardando nella fiamma. Le loro mani talvolta si sfioravano durante la passeggiata; quando lei voleva levarsi in piedi, Johnny le prendeva le due mani e se la tirava contro e sempre stabiliva che l’avrebbe tirata a sé e baciata, ma non ne aveva il coraggio. Una notte faceva molto caldo e Annabelle Marie a un tratto propose di fare il bagno. «Ma non abbiamo i costumi.» «Non siete mai andato in acqua senza? È molto meglio… Oh ragazzino, vi vedo arrossire perfino al chiaro di luna.» «Volete sfidarmi?» «Doppiamente vi sfido.» Johnny si allontanò un poco di corsa, si tirò via gli abiti e entrò in fretta nell’acqua. Non osava guardare e colse soltanto un lampo con la coda dell’occhio, di gambe e seni candidi e d’un’onda schiumante candida ai piedi di lei. Rivestendosi, Johnny si domandava se davvero era disposto a sposare una ragazza che insomma faceva il bagno con un uomo, così nuda. Si chiedeva se l’avesse fatto anche con quel maledetto francese. «Sembravate un fauno di marmo» disse Annabelle, quando Johnny ritornò accanto al fuoco, dove si stava annodando intorno al capo i capelli neri. Aveva spille tra le labbra e parlava attraverso. «Un fauno di marmo, nervoso anzichenò… Mi son bagnata i capelli.» Non aveva avuto l’intenzione, Johnny, ma d’un tratto la trasse a sé e la baciò. Non parve affatto sconcertata, lei, ma si impiccinì tra le sue braccia e alzò il viso per farsi baciare ancora. «Lo sposereste uno come me, senza un soldo?» «Non ci avevo mai pensato, caro, ma perché no?» «Voi siete molto ricca, credo, e io non ho il becco di un quattrino e debbo mandare a casa denaro ai miei… Ma ho delle cose in vista.» «Che cose in vista?» Gli abbassò il volto, gli scompigliò i capelli e lo baciò. «Farò fortuna in questi immobili. Giuro che la farò.» «Farà fortuna, lui?… poverino.»
«Non siete molto più vecchia di me… Quanti anni avete, Annabelle?» «Là, ne ammetto ventiquattro, ma non dovete dirlo a nessuno, e né di stanotte né d’altro.» «A chi lo direi, Annabelle Marie?» Ritornarono a casa in silenzio. Qualcosa pareva le pesasse sul cuore perché non fece nessuna attenzione a tutto ciò ch’egli poté dire. Durante le settimane che seguirono, Johnny il più del tempo non sapeva che cosa pensare di Annabelle Marie. Certi giorni lo trattava come fossero segretamente fidanzati, altre volte non pareva quasi riconoscerlo. Talvolta gli mandava a dire, per mezzo del padre, che stava poco bene e non poteva lasciare la camera, e ben presto Johnny la vedeva passare al galoppo vicino all’ufficio vestita da amazzone, e il cavallo di scuderia, che lei montava, era tutto schiumante ai fianchi, dove lo percuoteva col frustino. Poteva accorgersi che qualcosa la tormentava e aveva il sospetto che in fondo a tutto ci fosse quel maledetto francese. Una sera che eran seduti sotto il portico della sua casetta, fumando – Johnny fumava ora ogni tanto una sigaretta per tenerle compagnia –, le chiese che cosa la tormentasse. Lei gli posò le mani sulle spalle e lo scosse. «Oh, Moorehouse, siete così sciocco… Ma mi piace così.» «Ma ci dev’essere qualcosa che vi tormenta, Annabelle… Non avevate l’aria sofferente quel giorno che siam venuti insieme in treno.» «Se ve lo dicessi… Dio, mi par di vederla che faccia.» Annabelle rise di quel suo riso duro e rauco, che sempre lo metteva a disagio. «Vorrei avere il diritto di farmelo dire… Dovreste dimenticarlo quel maledetto francese.» «Oh, voi siete così innocente» disse. Poi si alzò in piedi e passeggiò su e giù per il portico. «Non sedete, Annabelle, non mi volete neanche un po’ di bene?» Gli stropicciò la mano tra i capelli e giù per il volto. «Ma certo, poverino, occhi azzurri lui… Ma non vedete che tutto mi mette il diavolo… Quelle vecchie gatte dell’albergo parlano di me come fossi una sgualdrina, perché qualche volta fumo una sigaretta
nella mia camera… Ma se in Inghilterra donne della più alta aristocrazia fumano in pieno pubblico e nessuno dice crepa… E poi sono in pensiero per papà. Butta troppi denari negli immobili. Credo che stia perdendo la testa.» «Ma ci sono tutti i sintomi che si avvicina qui una gran richiesta. A suo tempo sarà un’altra Atlantic City.» «Sentite, siate sincero, quanti terreni ha venduto la CMIOC questo mese?» «Via, non tanti… Ma ci sono delle vendite importanti in sospeso… C’è quella società che deve costruire il nuovo albergo.» «Avrà fortuna il babbo se riprenderà la metà dei suoi dollari… e lui continua a dirmi che sono scervellata. È un medico lui, e non un mago della finanza, e dovrebbe metterselo in testa. Va tutto bene che uno come voi, che non ha niente da perdere e una strada da farsi nel mondo, s’impicci d’immobili… Quanto a quel colonnello grasso, vorrei sapere se è uno stupido o un ladro.» «Dottore in che cosa, vostro padre?» «Come, non avete mai sentito parlare del dottor Strang? È il più noto specialista di naso e gola di tutta Filadelfia… Oh, è così bravo lui…» Lo baciò sulla guancia… «… e ignorante…» lo baciò di nuovo «… e innocente.» «Io non sono tanto innocente» disse in fretta Johnny; e la guardò fisso negli occhi. I loro volti cominciarono ad arrossire guardandosi. Gli lasciò lentamente cadere il capo sulla spalla. A Johnny batteva il cuore. Lo stordiva il sentore dei capelli, del profumo muschiato. La trasse in piedi, col braccio intorno alle spalle. Barcollando un po’ gamba contro gamba, l’asprezza del busto di lei contro le costole, i capelli contro il volto, la spinse attraverso la saletta nella stanza da letto e dietro si chiuse a chiave la porta. Poi la baciò quanto poté più forte e più a lungo, sulle labbra. Annabelle sedette sul letto e cominciò a togliersi l’abito, un po’ flemmaticamente, pensò Johnny, ma era andato troppo avanti per ritirarsi. Quando si tolse il busto, lo gettò in un angolo della camera. «Via,» disse «odio questi orrori.» Si alzò e gli venne incontro in camicia e gli cercò il volto nel buio. «Che cos’hai, tesoro?» bisbigliò selvaggiamente. «Ti faccio paura?»
Tutto fu molto più semplice di quel che Johnny si aspettava. Fecero insieme piccole risate, mentre si rivestivano. Ritornando lungo la spiaggia all’Ocean House, Johnny si ripeteva: “Adesso bisognerà che lei mi sposi”. A settembre un paio di freddi colpi di nord-est, subito dopo la festa del Lavoro, vuotarono l’Ocean House e le ville. Il colonnello parlava sempre più grandioso sulla prossima fortuna e sulla sua campagna pubblicitaria e beveva sempre di più. Johnny ora consumava i suoi pasti con lui invece che nella pensione della signora Ames. L’opuscolo era stato terminato e approvato e Johnny aveva fatto due o tre scappate a Filadelfia col testo e le fotografie per i preventivi dei tipografi. Passare per Wilmington in treno senza scendere gli dava un piacevole senso di indipendenza. Il dottor Strang aveva l’aria sempre più preoccupata e parlava di proteggere i suoi capitali investiti. Non avevano parlato del fidanzamento di Johnny con la figlia, ma pareva una cosa intesa. Gli umori di Annabelle erano inspiegabili. Ripeteva sempre che lei moriva di noia. Punzecchiava e tormentava Johnny continuamente. Una notte questi si svegliò d’improvviso e se la trovò dritta accanto al letto. «Ti ho fatto paura?» gli disse. «Non potevo dormire… Ascolta la risacca.» Il vento sibilava intorno alla casa e una risacca tremenda muggiva sulla spiaggia. Fu quasi chiaro prima che Johnny riuscisse a metterla fuori e farla ritornare all’albergo. «Che mi vedano… non me ne importa» diceva. Un’altra volta, che passeggiavano per la spiaggia, le prese la nausea e Johnny dovette attendere, mentre lei vomitava dietro una duna di sabbia, poi la sorresse, bianca e tremante, fino all’Ocean House. Johnny era seccato e irrequieto. In una delle sue corse a Filadelfia andò a vedere al «Public Ledger» se lo volevano come cronista. Un sabato pomeriggio era seduto che leggeva il giornale nel vestibolo dell’Ocean House. Non c’era nessun altro, quasi tutti i clienti se n’erano andati. L’albergo avrebbe chiuso il quindici. D’un tratto si trovò che ascoltava una conversazione. I due ragazzi camerieri erano entrati e stavano parlando a voce bassa al banco contro la parete. «Be’, mi sono divertito, ’st’estate, porco giuda, Joe.» «Mi sarei divertito anch’io, se non fossi stato male.»
«Non te l’avevo detto di non fare lo stupido con quella Lizzie? Scommetto che tutti i pezzenti della città han dormito con quella vacca, compresi i negri.» «Di’… E quella dagli occhi neri? Hai detto che provavi.» Johnny gelò. Tenne il giornale rigido innanzi a sé. Il cameriere emise un sibilo sommesso: «Roba extra» disse. «È fantastico cosa combinano queste dame di società.» «Davvero, hai provato?» «Non proprio… Avevo paura di prendermi qualcosa. Ma quel francese sì… Corpo… era sempre nella sua stanza.» «Lo so. L’ho sorpreso una volta.» I due risero. «Si erano dimenticati di chiudere la porta.» «Era nuda lei?» «Credo… sotto il chimono… E lui, calmo come tutto, ha ordinato acqua e ghiaccio.» «Perché non hai mandato su il signor Greeley?» «Perché diavolo? Il francese non era mica un tipo malvagio. Mi ha dato cinque biglietti.» «Credo che quella fa tutto ciò che vuole. Suo padre è quasi padrone qui della casa, dicono, lui e il vecchio colonnello Wedgewood.» «Credo che quel giovanotto dell’ufficio ci sia lui adesso… sembra che la voglia sposare.» «Ostia, la sposerei anch’io una ragazza che avesse tutti quei soldi.» Johnny aveva i sudori freddi. Voleva andarsene dal vestibolo senza che lo vedessero. Un campanello sonò e uno dei ragazzi corse via. Sentì l’altro mettersi sul banco. Forse leggeva una rivista o qualcosa. Johnny piegò il suo giornale con calma e uscì per il portico. Camminò per la via senza veder nulla. Per un momento pensò di andare alla stazione, prendere il primo treno in partenza e buttare al diavolo tutta la baracca, ma c’era l’opuscolo da stampare, e una probabilità che, se veniva l’ondata, lui avrebbe potuto farsi una base, e c’era questa relazione coi capitali e cogli Strang: l’opportunità bussa una volta sola alla porta di un giovane. Ritornò a casa sua e si chiuse a chiave nella stanza da letto. Rimase un momento a guardarsi nel vetro
del cassettone. I capelli chiari elegantemente scriminati, il naso e il mento ben disegnati: l’immagine si confuse. S’accorse di piangere. Si gettò bocconi sul letto e singhiozzò. Quando andò a Filadelfia un’altra volta a leggere le bozze dell’opuscolo OCEAN CITY (MARYLAND) TERRA DELLE VACANZE DIVINA si portò dietro anche un abbozzo degli inviti nuziali da stampare: Il dottor Alonso B. Strang annuncia il matrimonio di sua figlia col signor J. Ward Moorehouse che avrà luogo alla chiesa protestante episcopale di St. Stephens, Germantown, Pennsylvania, il quindici di novembre millenovenove, alle dodici, mezzogiorno Poi c’era un biglietto d’invito da mandare a un elenco particolare di persone. Doveva riuscire un grande matrimonio, perché il dottor Strang aveva tanti obblighi sociali. Annabelle decise per J. Ward Moorehouse, come più distinto di John W., e cominciò a chiamarlo Ward. Quando gli chiesero se invitava la famiglia, lui disse che madre e padre erano tutti e due invalidi e i suoi fratelli e sorelle troppo piccoli per prender parte. Scrisse a sua madre che era certo che lei avrebbe capito, ma da come stavano le cose e da come stava papà… era certo che lei avrebbe capito. Poi una sera Annabelle gli disse che era incinta. «Mi pareva infatti.» Gli occhi di Annabelle furono a un tratto, paurosamente freddi e neri, nei suoi. Johnny l’odiò in quell’istante, poi sorrise, occhi azzurri e fanciulleschi. «Voglio dire, con te così nervosa e tutto.» Rise e le prese la mano. «Bene, farò di te una donna onesta, neh?» Adesso aveva il sopravvento. La baciò. Lei scoppiò a piangere. «Oh, Ward, vorrei che non dicessi “neh”.» «Scherzavo, cara… Ma non c’è nessun modo?» «Ho provato tutto… Il babbo saprebbe, ma non oso dirglielo. Sa
che sono molto indipendente… ma…» «Dovremo star lontani un anno dopo sposati… È brutto per me. Mi hanno appunto offerto un posto al “Public Ledger”.» «Andremo in Europa… Il babbo ci metterà a posto, per la luna di miele… È contento di levarsi la responsabilità di me e io ho denaro che mi spetta da parte della mamma.» «Forse è tutto un errore.» «Come può essere?» «Da quanto tempo… ti sei accorta?» Di nuovo gli occhi di Annabelle gli furono a un tratto neri e inquisitori nei suoi. «Da molto tempo» disse: e gli tirò l’orecchio come a un ragazzo e salì a sbalzi le scale per vestirsi. Il colonnello fu contento come una pasqua, del fidanzamento, e li aveva invitati tutti a pranzo per celebrarlo. Lo sposalizio riuscì con molta eleganza e J. Ward Moorehouse si trovò a essere il centro di tutti gli sguardi, in un abito da cerimonia che gli stava a perfezione, e tuba. Diede l’impressione di essere un bell’uomo. Sua madre laggiù a Wilmington lasciò raffreddare un ferro dopo l’altro, mentre leggeva attentamente i ragguagli nei giornali; alla fine si tolse gli occhiali, ripiegò con cura i giornali e li posò sull’asse da stiro. Era felice. La giovane coppia partì da New York il giorno successivo sul Teutonic. La traversata fu così cattiva che soltanto negli ultimi due giorni fu possibile salire in coperta. Ward stette male e si ebbe le cure di un simpatizzante maggiordomo londinese, che parlava di Annabelle come di “Madam” e credeva fosse sua madre. Annabelle era una buona navigatrice, ma il bambino la faceva star male e ogni volta che si guardava nello specchietto era tanto sparuta che non usciva più di cuccetta. La cameriera le suggerì gin con dentro uno schizzo di amaro e ciò l’aiutò a trascorrere gli ultimi giorni della traversata. La notte della cena del capitano, ella finalmente comparve nella sala in un abito da sera di valencienne nero e tutti la giudicarono la più bella donna della nave. Ward aveva la febbre, per la paura che bevesse troppo champagne, perché l’aveva già veduta mandar giù, mentre si vestiva, quattro bicchierini di gin con amaro e un cocktail
Martini. Aveva fatto amicizia con un banchiere d’età, il signor Jarvis Oppenheimer, e signora, e temeva che Annabelle apparisse loro un po’ troppo libera. La cena del capitano trascorse tuttavia senza un intoppo e Annabelle e Ward scoprirono che formavano una bella coppia. Il capitano, che aveva conosciuto il dottor Strang, venne poi a sedersi con loro nel fumaiolo e prese con loro e con gli Oppenheimer un bicchiere di champagne e sentirono gente domandarsi chi poteva essere quella giovane coppia così incantevole scintillante brillante, certo gente di molto interesse, e quando andarono a letto dopo aver avvistato i fari del mar d’Irlanda sentirono che tutti i giorni di disagio erano, dal primo all’ultimo, valsi la pena. Ad Annabelle non piaceva Londra, dove le vie scure erano intristite da una continua pioggerella di nevischio, e così si fermarono soltanto una settimana al Cecil, prima di passare a Parigi. Ward patì di nuovo il mare sul battello da Folkestone a Boulogne e non riuscì a tener dietro ad Annabelle, che scovò poi nella sala da pranzo intenta a bere brandy al selz con un ufficiale inglese, quando il battello raggiunse le acque tranquille tra le lunghe gettate del porto di Boulogne. Non fu così brutto come si era aspettato, il trovarsi in un paese di cui non sapeva la lingua, e Annabelle parlava il francese più che a sufficienza. Presero uno scompartimento di prima classe e un cesto col pollo freddo, panini imbottiti e vino dolce, che Ward bevette allora per la prima volta – paese che vai, usanza che trovi – ed erano proprio la coppia in luna di miele che va in treno a Parigi. Andarono in carrozza dalla stazione all’Hôtel Wagram, soltanto col bagaglio a mano perché il facchino dell’albergo si occupò del resto, attraverso vie brillanti di verdi riverberi di gas sui lastricati bagnati. Gli zoccoli dei cavalli battevano secchi sull’asfalto, le ruote cerchiate a gomma della carrozza turbinavano leggere e le vie erano affollate, sebbene fosse una piovigginosa notte d’inverno. C’era gente seduta fuori, a tavolini di marmo, intorno a piccole stufe di fronte ai caffè, e nell’aria passavano odori di caffè, di vino, di burro squagliato e di pane arrostito. Gli occhi di Annabelle afferravano tutte le luci; lei era incantevole, lo toccava continuamente per mostrargli ogni cosa e gli batteva sulla coscia con una mano. Annabelle aveva scritto all’albergo
dove aveva alloggiato prima col padre, e trovarono una camera da letto e un salotto, bianchi, ad attenderli, un direttore faccia tonda, elegantissimo e affabilissimo, ad accoglierli con inchini, e un fuoco nella griglia. Presero una bottiglia di champagne e un po’ di pâté di foie gras, prima di andare a letto, e Ward si sentiva come un re. Annabelle si spogliò dei suoi abiti da viaggio e indossò una vestaglia, Ward indossò una giacchetta da fumatore, regalatagli da lei e mai portata sino allora, e tutto il suo risentimento dell’ultimo mese dileguò. Sedettero a lungo guardando nel fuoco e fumando Muratti dalla scatoletta di latta. Annabelle continuava a carezzargli i capelli e passargli la mano sulle spalle e sul collo. «Perché non sei più affettuoso, Ward?» diceva con un tono sommesso e aspro. «Io sono di quelle donne che amano esser dominate… Sta’ attento… Potresti perdermi… Qui gli uomini sanno far la corte a una donna.» «Lasciami fare!… Prima cosa, mi cerco un impiego in qualche ditta americana. Credo che il signor Oppenheimer in questo mi aiuterà. Comincerò subito a prender lezioni di francese. Sarà per me una grande opportunità.» «Sei buffo.» «Non crederai che ti voglia correr dietro come un cagnolino, senza guadagnare da parte mia… Puoi star certa che no.» Si alzò e la trasse in piedi. «Andiamo a letto.» Ward andò regolarmente alla Berlitz per le lezioni di francese e girò a visitare Notre-Dame, la tomba di Napoleone e il Louvre col vecchio signor Oppenheimer e sua moglie. Annabelle diceva che i musei le davano il mal di capo e passava le sue giornate a girare nei negozi e misurar vestiti dai sarti. Non c’erano troppe ditte americane a Parigi: il solo impiego che Ward trovò, anche con l’aiuto del signor Oppenheimer che conosceva tutti, fu nel giornale di Gordon Bennett, l’edizione parigina del «New York Herald». Il lavoro consisteva nel seguire le tracce di uomini d’affari americani in arrivo, nell’intervistarli sulle bellezze di Parigi e sui rapporti internazionali. Quest’era il suo pane e lo mise in grado di stringere molte conoscenze preziose. Annabelle decise che tutto ciò era troppo seccante e rifiutò di
sentirne parlare. Gli faceva indossare il frac tutte le sere e si faceva accompagnare all’Opera e a teatro. A questo lui era dispostissimo, perché giovava al suo francese. Annabelle andò da un famosissimo specialista di malattie di donne, che fu con lei d’accordo che a nessun patto avrebbe dovuto questa volta avere un bambino. S’imponeva un’operazione immediata e sarebbe stata un po’ pericolosa perché il bambino era così avanzato. Non ne parlò a Ward e lo avvertì soltanto dall’ospedale, quando tutto fu finito. Era Natale. Lui andò subito a vederla. Ascoltò i particolari gelato dall’orrore. Si era abituato all’idea di avere un bambino e pensava che avrebbe servito a dare un po’ di fermezza a Annabelle. Era distesa, pallidissima, nel letto di una clinica privata e Ward le stava accanto coi pugni serrati, senza far parola. Finalmente l’infermiera gli disse che stancava Madame e lui andò via. Quando Annabelle ritornò dall’ospedale dopo quattro o cinque giorni, annunciando allegramente di esser vispa come una anguilla e che andava nel Sud della Francia, lui non disse nulla. Annabelle si dispose a pigliar per concesso che anche lui veniva, ma il giorno che partì sul treno di Nizza si sentì dire che lui sarebbe rimasto a Parigi. Lo guardò fissamente e poi disse con una risata: «Mi metti in libertà, no?». «Io ho i miei affari e tu i tuoi piaceri» disse Ward. «Va bene, ragazzo, è cosa fatta.» La condusse alla stazione e la mise in treno; diede al controllore cinque franchi, ché ne avesse cura, e ritornò a piedi dalla stazione. Ne aveva abbastanza dell’odore di muschio e di profumi, per un po’. Parigi era meglio di Wilmington, ma a Ward non piaceva. Tanta calma, e lo spettacolo di tanta gente seduta a mangiare e bere, gli davano ai nervi. Si sentì pieno di nostalgia il giorno che gli arrivò l’opuscolo di Ocean City e, acclusa, una lettera entusiastica del colonnello Wedgewood. Le cose si muovevano, finalmente, diceva il colonnello; quanto a sé, lui investiva fin l’ultimo cent, che avrebbe potuto racimolare, elemosinare o chiedere a prestito, in opzioni. Suggeriva persino che Ward gli mandasse qualche soldo da investire a suo nome, adesso che lui si trovava in posizione di poter rischiare una posta sulla certezza di un vasto rivolgimento; ma rischiare non era la
parola perché l’intera situazione era ormai già sicura: niente da fare se non scrollare l’albero e pigliarne in bocca i frutti. Ward scese i gradini dell’ufficio di Morgan Harjes, dove riceveva la posta, e uscì in boulevard Haussmann. La carta dalla copertura pesante gli era deliziosa alle dita. Si mise la lettera in tasca e scese giù per il boulevard con il clamore delle trombe, lo strepito degli zoccoli dei cavalli e lo scalpiccio dei piedi nelle orecchie, leggendo una frase di tanto in tanto. Mah, quasi quasi gli metteva la voglia di ritornare lui a Ocean City (Maryland). Una scarsa luce rossastra riscaldava l’inverno grigio delle vie. Un odore di caffè tostato veniva da qualche parte; Ward pensò al sole bianco crepitante delle giornate ventose in patria, giornate che frustavano piene di energia e di speranza; il Vigor di vita. Aveva un appuntamento per il pranzo col signor Oppenheimer in uno scelto ristorantino, in qualche parte nei quartieri popolari, chiamato la Tour d’Argent. Entrando in una vettura a tassametro, dalle ruote rosse, gli diede nuovamente un senso di conforto sentire che l’autista comprendeva le sue indicazioni. Dopo tutto era un’educazione e suppliva a quegli anni di università che lui aveva perduti. Aveva letto l’opuscolo per la terza volta, quando giunse al ristorante. Scese al ristorante e stava pagando il tassì, quando vide il signor Oppenheimer e un altro, che giungevano sul quai, a piedi. Il signor Oppenheimer indossava un soprabito grigio e una bombetta grigia, dello stesso color perla dei suoi baffi; l’altro era un individuo grigiacciaio, dal naso e dal mento sottili. Quando li vide, Ward decise che in avvenire sarebbe stato più attento a come si vestiva. Pranzarono a lungo e con molte portate, benché l’uomo grigiacciaio, che si chiamava McGill – era direttore di una delle acciaierie di Jones e Laughlin a Pittsburgh –, dicesse che il suo stomaco non avrebbe sopportato altro che una costoletta e una patata al forno, e bevesse whisky al selz invece che vino. Il signor Oppenheimer si godeva i suoi cibi enormemente e intavolava al proposito lunghe consultazioni col capocameriere. «Signori, dovete scusarmi un pochino… questa è per me un’orgia» diceva. «Non essendo sotto l’occhio vigilante di mia moglie, posso prendermi certe libertà col mio stomaco… Mia moglie è entrata nei sacri recinti di un
salottino dalla sua corsetière e non bisogna disturbarla… Voi, Ward, non siete abbastanza vecchio per comprendere tutte le possibilità della tavola.» Ward aveva un’aria imbarazzata e fanciullesca e disse che gustava molto quell’anitra. «La tavola» continuò il signor Oppenheimer «è l’ultimo piacere dei vecchi.» Quando furono seduti tra grossi bicchieri (in forma di scodelle) di brandy Napoleon e sigari, Ward si fece coraggio a tirar fuori l’opuscolo su Ocean City, Maryland, che per tutto il pranzo quasi gli aveva fatto un buco nella tasca, tanto scottava. Lo pose con modestia sul tavolino. «Ho pensato che forse vi sarebbe piaciuto dargli un’occhiata, signor Oppenheimer, come… come a qualcosa di un po’ diverso dal solito, nel ramo pubblicitario.» Il signor Oppenheimer si tolse gli occhiali e se li aggiustò sul naso, prese un sorso di brandy e scorse il libro con un blando sorriso. Lo richiuse, soffiò una lieve spira azzurra ondulante per le narici e disse: «Ma allora Ocean City è davvero un paradiso terrestre… Non avete… eh… esagerato un pochetto?». «Ma vedete, signor Oppenheimer, bisogna far in modo che l’uomo della strada muoia dalla voglia di andarci… Ci dev’essere una parola che vi afferra l’occhio appena guardate.» Il signor McGill, che sin allora non aveva guardato Ward, gli piantò addosso in un’occhiata fissa due occhi grigio falco. Tese una manona rossa a prender l’opuscolo. Lo lesse attentamente, mentre il signor Oppenheimer continuava a parlare del bouquet del brandy e di come si deve intiepidire un po’ il bicchiere tra la mano e sorbirlo a sorsellini, aspirando piuttosto che berlo. D’un tratto il signor McGill batté un pugno sul tavolo e rise una risata secca e rapida che non gli smosse un solo muscolo del volto. «Perdiana, questo va» disse. «Mi pare sia Mark Twain che ha detto che nasce un imbecille ogni minuto…» Si volse a Ward e disse: «Mi spiace di non aver sentito bene il vostro nome, giovanotto, volete ripetermelo?». «Con piacere… Moorehouse, J. Ward Moorehouse.» «Dove lavorate?» «Sono all’“Herald” di Parigi, per il momento» disse Ward arrossendo.
«Dove vivete, quando siete negli Stati?» «Ho la casa a Wilmington, Delaware, ma non credo che ci andrò quando tornerò in patria. Mi hanno offerto lavoro di redazione sul “Public Ledger” di Philly.» Il signor McGill tirò fuori un biglietto di visita e vi scrisse sopra un indirizzo. «Ebbene, se mai pensate di venire a Pittsburgh, venitemi a trovare.» «Sarò lietissimo di vedervi.» «Sua moglie» intromise il signor Oppenheimer «è la figlia del dottor Strang, lo specialista di naso e gola, di Filadelfia… A proposito, Ward, come sta la cara ragazza? Spero che Nizza l’avrà rimessa dalla sua tonsillite.» «Sì, signore,» disse Ward «scrive che sta molto meglio.» «È una bella creatura… incantevole…» disse il signor Oppenheimer scolando l’ultimo sorso del bicchiere con gli occhi velati. Il giorno dopo Ward ricevette un telegramma da Annabelle, che arrivava a Parigi. Le andò incontro al treno. Annabelle gli presentò come «Monsieur Forelle, compagno di viaggio» un francese alto di statura, barba alla Van Dyck nera, che la stava aiutando alle valigie, quando lui giunse. Non ebbero un momento libero per parlare, finché non salirono insieme in carrozza. La carrozza puzzava di chiuso e dovevano tenere i finestrini abbassati per via della pioggia. «Be’, mio caro,» disse Annabelle «non hai più i nervi che avevi quando sono partita? Spero di no, perché ho cattive notizie per te.» «Cos’è successo?» «Papà si è messo negli imbrogli… Lo sapevo che sarebbe accaduto. Non ha idea degli affari più di un gatto… E quel tuo bel rialzo di Ocean City è andato all’aria prima di cominciare e papà si è spaventato e ha cercato di scaricarsi dei lotti di sabbia, ma naturalmente nessuno li ha voluti comperare… Poi l’Improvement and Realty Company ha fatto bancarotta e quel tuo caro colonnello è scomparso e papà è restato, chi sa come, responsabile di persona per gran parte dei debiti dell’impresa… Ecco tutto. Gli ho telegrafato che tornavamo col primo piroscafo. Vedrò quel che potrò fare… È più
inetto di un bambino, negli affari.» «Questo non mi farà certo dispiacere. Non sarei venuto quaggiù, se non fosse stato per te.» «Tutto abnegazione tu, eh?» «Non litighiamo, Annabelle.» Gli ultimi giorni, Parigi a Ward cominciò a piacere. Sentirono la Bohème all’Opéra e tutti e due ci si commossero molto. Poi andarono in un caffè e presero un po’ di pernice fredda e vino e Ward raccontò ad Annabelle come aveva voluto fare il compositore di canzonette, e di Marie O’Higgins e come aveva cominciato a comporre una canzone su di lei, e si sentirono molto teneri l’uno per l’altra. La baciò diverse volte nella carrozza che li portava a casa, e l’ascensore, che saliva alla loro camera, parve terribilmente lento. Avevano ancora un migliaio di dollari sulla lettera di credito che il dottor Strang aveva dato loro come regalo di nozze, in modo che Annabelle comprò ogni sorta di abiti, cappelli e profumi e Ward andò da un sarto inglese presso la chiesa della Madeleine e si fece fare quattro vestiti. L’ultimo giorno Ward le comperò una spilla in forma di galletto fatta di smalto Limoges e montata a granati, spendendo del suo stipendio dell’«Herald». Pranzando, dopo che il bagaglio fu a bordo del piroscafo, si sentirono molto commossi per Parigi e l’un l’altro e la spilla. Partirono da Le Havre sul Touraine ed ebbero una traversata interamente tranquilla, un mare morto, grigio vitreo, per tutto il tempo, benché fosse febbraio. Ward non soffrì il mal di mare. Passeggiava in giro per la prima classe ogni mattina, prima che Annabelle si alzasse, indossando un berretto e un soprabito scozzesi di tweed a riscontro di un binocolo gettato sulla spalla, e cercava di escogitare qualche piano per il futuro. Ad ogni modo Wilmington era ben lontana alle sue spalle, come uno scafo di nave sotto la linea dell’orizzonte. Il piroscafo, coi rimorchiatori sbuffanti ai fianchi, si aprì una strada prueggiando tra i barconi, i rimorchiatori, le chiatte ferroviarie e i rossi chiattoni sibilanti, nel porto di New York, contro un ululante vento di nord-ovest color ghiaccio. Annabelle fu scontrosa e disse che la scena era orrida, ma Ward si
sentì entusiasmato quando un signore ebreo dal berretto a quadretti additò i bastioni, la dogana, l’Aquarium, la chiesa della Trinità. In carrozza vennero dritto dallo scalo al chiattone e mangiarono nella sala a tappeti rossi della stazione di Pennsylvania a Jersey City. Ward prese ostriche fritte. L’amichevole cameriere negro in abito bianco era la patria. «Di ritorno nella terra di Dio» disse e decise che doveva andare fino a Wilmington per salutare i suoi. Annabelle rise di lui e stettero rigidamente seduti senza parlarsi nella vettura salotto del treno di Filadelfia. Gli affari del dottor Strang andavano molto male e, siccome lui era tutto il giorno occupato con la clientela, Annabelle prese tutto su di sé. La sua abilità nel trattar finanze sorprese tanto Ward quanto il padre. Abitavano nella gran casa antica del dottor Strang in Spruce Street. Ward, attraverso un amico del dottor Strang, ottenne un posto al «Public Ledger» e raramente era in casa. Quando aveva qualche momento di libertà, andava a sentir conferenze di economia e di affari all’istituto Drexel. La sera, Annabelle si mise a uscire con un giovane architetto chiamato Joachim Beale, che era ricchissimo e possedeva un’automobile. Beale era un giovanotto esile con un capriccio per la maiolica e il whisky bourbon e chiamava Annabelle «la mia Cleopatra». Ward entrò in casa una notte e li trovò tutti e due ubriachi, seduti con poche vesti indosso, nel ritiro di Annabelle all’ultimo piano della casa. Il dottor Strang era andato a un congresso di medicina a Kansas City. Ward si fermò sull’uscio con le braccia conserte e annunciò che ne aveva abbastanza e che avrebbe chiesto il divorzio; lasciò la casa sbattendosi dietro la porta e andò all’YMCA per quella notte. Il pomeriggio seguente, giunto all’ufficio, trovò una raccomandata di Annabelle, che lo supplicava di pensare a quel che faceva, poiché qualsiasi pubblicità sarebbe stata rovinosa per la professione del padre, e si offriva di fare qualunque cosa lui suggerisse. Immediatamente Ward rispose: Cara Annabelle, comprendo finalmente che è sempre soltanto stata tua intenzione sinora di adoperarmi come uno schermo per la tua condotta
ignominiosa e indegna di una donna. Capisco ora perché tu preferisca la compagnia di libertini stranieri e gente simile, a quella di giovani americani che hanno un’ambizione. Non desidero affatto di causare a te e a tuo padre la minima sofferenza o pubblicità, ma in primo luogo tu devi cessar di degradare il nome dei Moorehouse, finché lo porterai legalmente, e anche vedrò che, quando il divorzio sarà stato soddisfacentemente definito, io sia qualificato a un certo compenso per la perdita di tempo ecc. e il danno, che alla mia carriera è toccato per colpa tua. Parto domani per Pittsburgh, dove ho una posizione che mi attende e del lavoro che spero mi farà dimenticare te e il grande dolore che la tua infedeltà mi ha causato. Si domandò per un istante come finire la lettera e alla fine scrisse sinceramente JWM e l’impostò. Stette sveglio tutta la notte nella cuccetta della vettura per Pittsburgh. Era dunque là, a ventitré anni, senza una laurea, e non sapeva un mestiere e aveva abbandonato la speranza di fare il compositore. Maledetto dio, non avrebbe più fatto il servitore a nessuna dama di società. La vettura era mal ventilata, il guanciale continuava a torcerglisi a nodo sotto l’orecchio, riudiva brani dei discorsi per vendere le storie di Bancroft o di Bryant… Al mare in mezzo ai peschi in fiore…, la voce del signor Hillyard, che parlava dalle profondità dell’ufficio di Wilmington: «La ricchezza immobile, signore, è l’unico investimento salvo sicuro fermo conservatore, inattingibile dai danni delle piene o degli incendi; il proprietario di immobiliari si lega con lacci indissolubili allo sviluppo della città o della nazione… faccia o no migliorie a suo agio e convenienza, siede a casa sua tranquillo e sicuro lasciando che le ricchezze gli piovano in grembo, prodotte dall’inevitabile inalienabile sviluppo della ricchezza in una potente nazione…». «A un giovane con buone referenze e, se mi è lecito, con così affabili modi e una soda cultura classica,» aveva detto il signor Oppenheimer «la banca dovrebbe offrire un importante campo per la coltivazione delle virtù, dell’energia, della diplomazia e forse dell’industria…»
Una mano gli tirava le coperte. «Pittsburgh, signore, tra quarantacinque minuti» fece la voce del facchino negro. Ward s’infilò i pantaloni, notò con sgomento che perdevano la piega, saltò giù dalla cuccetta, cacciò i piedi nelle scarpe, che erano appiccicaticce per essere state lucidate in fretta con lucido di seconda qualità, e andò incespicando per la corsia, lungo gente scarmigliata che sorgeva dai lettucci, al lavatoio per uomini. Aveva gli occhi incollati e gli occorreva un bagno. La vettura era insopportabilmente mal ventilata e il lavatoio sapeva di mutande e di sapone da barba altrui. Attraverso il finestrino, Ward poteva vedere colline nere incipriate di neve, ogni tanto una montagna di carbone, file di baracche grigie tutte uguali, il letto di un fiume scarpato da rifiuti di miniera e mucchi di scorie, frastagli violacei di alberi lungo il taglio della collina spiccanti netti sopra un sole rosso; poi sopra la collina, splendida e rossa come il sole, la chiazza di fiamma di una fonderia. Ward si rasò, si pulì i denti, si lavò la faccia e il collo quanto meglio poté, si scriminò i capelli. Mascelle e zigomi gli stavan prendendo un’aria quadrata che lui ammirava. “Giovane dirigente risoluto” si disse fermandosi il colletto e annodando la cravatta. Era stata Annabelle a insegnargli lo stratagemma di portare una cravatta dello stesso colore degli occhi. Mentre pensò a quel nome, lo turbò un lieve ricordo tattile di quelle labbra, del profumo muschiato che lei usava. Spazzò via quel pensiero, si mise a fischiettare, tralasciò temendo che agli altri, che si vestivano, paresse una stranezza, e andò a fermarsi sulla piattaforma. Il sole era tutto sorto ora, le colline eran rosa e nero e c’erano vuoti azzurri, dove si ammassava il fumo dei fuochi delle colazioni. Tutto era baracche a file, fornaci, montagne di carbone. Di quando in quando una collina lanciava una fila di baracche o un gruppo di forni contro il cielo. Bande di uomini scuri in volto, vestiti di scuro, stavano nella mota agli incroci. Muri sudici di carbone precludevano il cielo. Il treno passava traverso gallerie, sotto ponti a zigzag, traverso scavi profondi. «Union Station, Pittsburgh!» gridò il facchino. Ward mise un quarto di dollaro in mano al negro, tirò fuori la valigia da un mucchio di valigie altrui e scese con un passo vivace e fermo sulla banchina, respirava profondamente l’aria
fresca e fumosa di carbone della tettoia. 1. Eroe dell’indipendenza americana: diede l’avviso dello sbarco inglese a Boston. (NdT) 2. The Strenuous Life: libro di Theodore Roosevelt, tradotto in italiano col titolo suddetto. (NdT) 3. Termine di sprezzo usato negli stati del Sud-est contro un bianco che non abbia saputo far molto di più di un negro. (NdT)
Occhio fotografico (17) la primavera che si poteva vedere la cometa di Halley sugli olmi dalle finestre posteriori all’ultimo piano della Camera Alta il signor Greenleaf disse che dovevo entrare in classe di cresima per esser cresimato poi dal vescovo e la volta successiva che andammo in barca io dissi a Skinny che non volevo esser cresimato perché era mia fede il campeggio e la canoa e la cometa di Halley e l’Universo e il rumore che la pioggia faceva sulla tenda la notte che leggemmo tutti e due Il mastino dei Baskerville 1 e appendemmo la carne fuori su un albero e un cane doveva averla annusata perché continuò a girarci intorno e latrare qualcosa di spaventoso e noi eravamo tanto atterriti (ma questo non lo dissi non so quel che dissi) e non in chiesa e Skinny disse che se non ero mai stato battezzato non potevo ricevere la cresima e andai a dirlo al signor Greenleaf e lui mi guardò molto freddo e disse che avrei fatto bene a non andare più in classe di cresima e dopo dovevo andare in chiesa alla domenica ma potevo andare in qualunque delle due volevo così qualche volta andavo nella congregazionalista e qualche volta nell’episcopaliana e la domenica che venne il vescovo non si vedeva più la cometa di Halley e vidi cresimare gli altri e durò per ore perché c’era una quantità di bambine e cresimavano anche loro e non si sentiva che borbotta borbotta Questo tuo figliolo borbotta borbotta questo tuo figliolo e mi domandavo se sarei stato vivo la prossima volta che sarebbe venuta la cometa di Halley 1. Celebre romanzo poliziesco di Conan Doyle. (NdT)
Cine-giornale XIII Ero in faccia alla piazza nazionale quando cominciò il fuoco. Corsi attraverso la Plaza con altre migliaia di uomini donne e bambini fuggenti che cadevano a dozzine nel loro tentativo di cercare un riparo LA SCOPERTA DI NUOVE ALTE MONTAGNE Oh Jim O’Shea venne buttato sopra un’isola selvaggia ai nativi della spiaggia piacque il suo corpo arruffato il sorriso d’irlandese IL MANICOMIO NELL’ARTE BANDITI CHE SONO A CASA LORO NEI DESERTI Washington considera disgraziata illogica e innaturale la scelta del generale Huerta a presidente del Messico come successore del caduto presidente Francisco Madero 3 FUGGONO LA CITTÀ TEMENDO UNA TRAPPOLA aveva messo sabbia nello zucchero dell’albergo uno scrittore dice che venne esule in America e vi trovò soltanto spilorceria LUNG YU GIÀ IMPERATRICE DELLA CINA MUORE NELLA CITTÀ PRECLUSA La cucaracha la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene porque no tiene marijuana que fumar. trascurare le classi inferiori nell’organizzazione della repubblica può causare un’altra sollevazione 600 AMERICANI FUGGONO LA CAPITALE Sulle dita avrai coralli campanelli alle caviglie elefanti per cavalli con tante altre meraviglie bella rosa dell’Irlanda vieni dunque al tuo nababbo
Eleanor Stoddard Quand’era piccola, odiava tutto. Odiava suo padre, un uomo corpulento, dai capelli rossi, che puzzava di baffoni e di tabacco da pipa rancido. Il padre lavorava in un ufficio all’ammazzatoio e ritornava a casa con il puzzo d’ammazzatoio negli abiti e raccontava sanguinarie barzellette sul macello delle pecore, dei manzi, dei maiali e degli uomini. Eleanor odiava gli odori e la vista del sangue. Nottetempo sognava che viveva sola con sua madre, in una grande casa linda e candida in Oak Park, d’inverno quando a terra c’è la neve, e che aveva disteso una bianca tovaglia di lino con argenteria lucente e disposto fiori bianchi e carne bianca di pollo davanti a sua madre che era una signora della società in un abito di seta bianca, ma d’improvviso ecco sulla tavola una macchiolina rossa e cresceva cresceva e sua madre faceva disperati movimenti scomposti con le mani e lei cercava di cancellarla, ma cresceva in una macchia di sangue che sgorgava in una chiazza sanguinosa che s’allargava sulla tovaglia e lei si svegliava dall’incubo nell’odore dell’ammazzatoio e gridava. Quando aveva sedici anni, alla scuola media, lei e una ragazza chiamata Isabelle giurarono insieme che, se mai un ragazzo le avesse toccate, si sarebbero uccise. Ma quell’anno la ragazza fece la polmonite dopo la scarlattina, e morì. Eleanor fu sola come nei suoi sogni. L’unica altra persona, che a Eleanor piaceva, era la signorina Oliphant, la sua insegnante d’inglese. La signorina Oliphant era nata in Inghilterra. I suoi genitori erano venuti a Chicago quando lei era una ragazza non ancor ventenne. Era una grande entusiasta dell’inglese, cercava di far usare ai suoi allievi l’a larga e sentiva di aver diritto a una certa autorità nelle cose che riguardano la letteratura inglese, per via della sua lontana parentela con una certa signora Oliphant, ch’era stata una letterata della metà del secolo diciannovesimo e aveva scritto cose tanto belle su Firenze. Così, di tanto in tanto, la signorina invitava le sue allieve più promettenti, quelle che parevano figlie di genitori più distinti, a prendere il tè nel
suo appartamentino, dove lei viveva tutta sola con un sonnacchioso gatto persiano color turchino e un fringuello, e discorreva loro di Goldsmith e degli energici detti del dottor Johnson e di Keats e del cor cordium e come era terribile che fosse morto giovane e di Tennyson e come aveva trattato male le donne e come avveniva il cambio della guardia a Whitehall e la vite piantata da Enrico VIII a Hampton Court e l’infelice Mary regina degli scozzesi. I genitori della signorina Oliphant erano stati cattolici e avevano considerato gli Stuart legittimi eredi al trono inglese e usavano far passare i bicchieri di vino sul boccale dell’acqua, quando brindavano al re. Tutto ciò eccitava moltissimo i ragazzi e le ragazze e in particolare Eleanor e Isabelle, e la signorina Oliphant soleva dar loro punti elevati per i componimenti e incoraggiarle alla lettura. Eleanor l’amava molto e in classe stava molto attenta. Il solo udire la signorina Oliphant pronunciare una frase come «I grandi monumenti della prosa inglese» oppure «I principini nella torre» o «St. George e la gaia Inghilterra», le dava piccoli brividi su e giù per la spina. Quando Isabelle morì, la signorina Oliphant seppe trattare Eleanor così affettuosamente, presero il tè da sole e le lesse Lycidas con una vivace e limpida voce e le disse di leggere Adonais quando fosse a casa, ma che lei non poteva leggerglielo perché sapeva che, se lo leggeva, si sarebbe dovuta fermare sopraffatta. Poi parlò della sua miglior amica di quando lei era ragazza, la quale era stata una ragazza irlandese dai capelli rossi e una chiara pelle tiepida e bianca come il Crown Derby, mia cara, e che era andata in India e morta di febbre e la signorina Oliphant aveva creduto di non sopravvivere al dolore e come era stato inventato il Crown Derby e l’inventore aveva speso il suo ultimo centesimo a lavorare sulla formula di questa porcellana meravigliosa e gli necessitava dell’oro come ultimo ingrediente, e stavano già morendo di fame e non restava più nulla tranne l’anello nuziale della moglie e tenevano acceso il fuoco nel fornello bruciando sedie e tavoli e finalmente aveva fatto questa porcellana meravigliosa usata esclusivamente dalla famiglia reale. Fu la signorina Oliphant che indusse Eleanor a prender lezioni all’istituto d’Arte. Aveva sulle sue pareti riproduzioni di quadri di
Rossetti e Burne-Jones e parlava a Eleanor della confraternita preraffaellita: le faceva sentire che l’Arte era qualcosa di candido come l’avorio, molto puro e nobile e lontano e triste, proprio come lei la desiderava. Quando sua madre morì di anemia perniciosa, Eleanor era una ragazza esilina di diciott’anni, che lavorava di giorno in un negozio di pizzi nel centro e di sera studiava arte commerciale all’istituto d’Arte. Dopo il funerale, andò a casa, fece su le sue cose e traslocò a Moody House. Quasi mai venne a trovare il padre. Lui qualche volta la chiamava al telefono, ma, quando poteva, Eleanor schivava di rispondergli. Voleva dimenticare tutto di lui. Nel negozio di pizzi era benvista per la sua distinzione e perché dava all’ambiente ciò che la vecchia signora Lang, proprietaria del negozio, chiamava «un’indefinibile aria di chic», ma la pagavano solamente dieci dollari la settimana, di cui cinque andavano in fitto e pensione. Non mangiava molto, ma il vitto era tanto cattivo in sala da pranzo e le era odioso sedersi con le altre ragazze, cosicché qualche volta doveva prendere una bottiglia di latte in più da bere nella sua stanza e certe settimane si trovava senza un soldo per comprar matite e carta da disegno e doveva andare a trovare suo padre e chiedergli due o tre dollari. Lui glieli dava abbastanza volentieri, ma in un certo senso ciò glielo faceva odiare ancora di più. Di sera, soleva star seduta in quel piccolo, sordido canile della sua stanza con quella brutta coperta e quel brutto letto in ferro, mentre dalla sala comune saliva un continuo inneggiare, e leggeva Ruskin e Pater presi alla biblioteca pubblica. Talvolta si lasciava cadere il volume sulle ginocchia e sedeva tutta la sera fissando la fosca lampadina elettrica rossiccia, tutto ciò che la direzione permetteva. Ogni volta che chiedeva un aumento, la signora Lang diceva: «Ma voi vi sposerete presto e mi abbandonerete, cara, una ragazza col vostro modo di fare, indefinibilmente chic, non può star sola molto tempo, e allora non ne avrete bisogno». La domenica solitamente andava in treno a Pullman dove la sorella di sua madre aveva una casetta. Zia Betty era una donnetta tranquilla e massaia, che ascriveva tutte le stranezze di Eleanor a fantasie
giovanili e stava ben sveglia se comparisse un giovane adatto, per accalappiarglielo da innamorato. Suo marito, zio Joe, era caporeparto in un laminatoio. I molti anni trascorsi nel laminatoio l’avevan reso interamente sordo, ma lui pretendeva che, in verità, persino in fabbrica sentiva quel che si diceva. Se era d’estate, passava la domenica zappando la sua aiuola, dove si specializzava in lattughe e asteri. D’inverno o quando faceva brutto, stava seduto nella stanza d’entrata leggendo «The Railroad Man’s Magazine». Zia Betty cucinava un pranzo elaboratissimo con le ricette del «Ladies’ Home Journal» e pregavano Eleanor di disporre per loro i fiori sulla tavola. Dopo pranzo, zia Betty lavava i piatti e Eleanor li asciugava e, mentre i vecchi facevano il sonnellino, lei, seduta nella stanza d’entrata, leggeva la rubrica di società del «Chicago Tribune». Dopo cena, se faceva bello, i vecchi facevano una passeggiata con lei fino alla stazione e la mettevano sul treno e zia Betty diceva ch’era una vergogna marcia che una ragazza carina come lei vivesse tutta sola nella gran città. Eleanor sorrideva un vivido e amaro sorriso e diceva che non aveva paura. I tram al ritorno erano zeppi, la notte della domenica, di giovanotti e di ragazze sudaticci, scarmigliati e cotti dal sole per via di una gita in campagna o sulle dune. Eleanor li odiava e odiava le famiglie d’italiani, coi loro marmocchi strillanti, che riempivano l’aria di un puzzo di vino e d’aglio; odiava i tedeschi rossi in faccia per la birra bevuta nel pomeriggio e gli operai finlandesi e svedesi ubriachi, che la fissavano, occhi larghi, con un azzurro bagliore di alcool sulle facce legnose. Talvolta qualche uomo cominciava a tentar approcci e lei doveva cambiare di tram. Una volta che il tram era molto affollato, un individuo dai capelli ricciuti si sfregava contro di lei, invitante. La folla era così fitta che Eleanor non poteva tirarsi via. Poté appena trattenersi dal gridare aiuto; fu soltanto che le pareva troppo volgare fare uno scalpore. Vertigini invincibili le scesero addosso, quando alla fine si aprì una via alla stazione, e dovette fermarsi in una farmacia sulla strada di casa a prendere un po’ di sali forti d’ammoniaca. Attraversò a precipizio l’entrata della Moody House e salì nella sua camera, ancora
in un tremito. Era nauseata e una delle ragazze la trovò che vomitava nel bagno e la guardò in un modo così curioso. Era molto infelice in circostanze come queste e pensava al suicidio. Soffriva crampi dolorosi durante i suoi periodi mensuali e doveva starsene a letto almeno un giorno al mese. Qualche volta stava male per tutta la settimana. Un giorno nell’autunno aveva telefonato alla signora Lang che non si sentiva bene e doveva stare in letto. Risalì nella stanza e si distese sul letto a legger Romola. Stava leggendo per intero le opere complete di George Eliot ch’erano nella biblioteca della Moody House. Quando la vecchia donna di fatica aprì l’uscio per venir a fare il letto, Eleanor le disse: «Sto male… pulirò io, madama Koontz». Nel pomeriggio le venne fame e le lenzuola le si eran tutte raggrinzite sotto la schiena e, benché provasse una certa vergogna di se stessa a esser in grado di uscire quando aveva detto alla signora Lang di star troppo male per muoversi, sentì di soffocare se restava ancora un minuto nella stanza. Si vestì con cura e scese le scale, sentendosi un po’ colpevole. «Così, non state troppo male allora» disse la matronale signora Biggs, quando le passò accanto nell’entrata. «Ho provato il bisogno di una boccata d’aria.» «Brutto affare» sentì dir tra i denti alla signora Biggs, mentre usciva dalla porta. La signora Biggs era molto sospettosa di lei, perché Eleanor studiava arte. Sentendosi deboluccia, si fermò in una farmacia e si fece dare un po’ di sali forti d’ammoniaca con acqua. Poi prese un tram per il Grant Park. Un tremendo vento di nord-ovest involava polvere e pezzi di carta a turbini, lungo il lago. Andò all’istituto d’Arte e salì nella sala Stickney a vedere i Whistler. Le piaceva l’istituto d’Arte più di ogni altra cosa in Chicago, più di ogni altra cosa al mondo: la quiete, l’assenza di uomini disturbatori, l’odor dolce di vernice dei quadri. Eccetto la domenica quando veniva la folla, e diventava un orrore. Quel giorno non c’era altri nella sala Stickney che una ragazza ben vestita, con un colletto di volpe grigia e un cappellino grigio con una piuma. Quell’altra ragazza guardava fissamente il ritratto di Manet. Eleanor fu incuriosita e
faceva finta di guardare i Whistler piuttosto che non li guardasse. Ogni volta che poteva, guardava l’altra ragazza. Si trovò di fianco all’altra, anche lei a guardare il ritratto di Manet. D’improvviso i loro occhi s’incontrarono. L’altra aveva occhi bruno-pallidi tagliati a mandorla e piuttosto staccati. «Secondo me, è il più gran pittore del mondo» disse combattiva, come se volesse che qualcuno lo negasse. «Mi pare un bel pittore» disse Eleanor cercando di impedire alla voce di tremare. «Amo quel quadro.» «Sapete che non è di Manet in persona, ma di Fantin-Latour» disse l’altra. «Oh sì, certo» disse Eleanor. Ci fu una pausa. Eleanor ebbe paura che questo sarebbe stato tutto, ma l’altra disse: «Quali altri quadri vi piacciono?». Eleanor guardò con cura il Whistler; poi disse lenta: «Mi piacciono Whistler e Corot». «Anche a me, ma preferisco Millet. È così pieno e caldo… Siete mai stata a Barbizon?» «No, ma mi piacerebbe.» Ci fu una pausa. «Ma a me pare che Millet sia un po’ grossolano, no?» arrischiò Eleanor. «Volete dire quella litografia dell’Angelus? Sì, detesto e disprezzo i sentimenti religiosi in un quadro, voi no?» Eleanor non seppe bene che cosa rispondere, e allora scosse la testa e disse: «Mi piacciono tanto i Whistler; quando li ho guardati, posso guardare dalla finestra e tutto ha l’aria, sapete, di un pastello uguale». «Mi viene un’idea» disse l’altra che aveva dato una occhiata a un orologetto che portava nella borsetta. «Non devo essere a casa che per le sei. Perché non venite a prendere il tè con me? So un posticino dove si trova del tè ottimo, una pasticceria tedesca. Non devo essere a casa fino alle sei e possiamo fare una bella chiacchierata. Non vi parrà spregiudicato da parte mia, questo, vero? Amo le cose poco convenzionali, voi no? Non l’odiate, Chicago?» Sì, Eleanor odiava Chicago e le persone convenzionali e tutto. Andarono alla pasticceria e presero il tè e la ragazza in bigio che si chiamava Eveline Hutchins prese il suo col limone. Eleanor parlò molto e fece ridere l’altra. Suo padre, Eleanor si trovò che spiegava, era un pittore che stava a Firenze e che lei non aveva veduto da
piccina. C’era stato un divorzio e sua madre s’era risposata, un uomo d’affari in rapporti con Armour e Co., e ora che sua madre era morta e lei non aveva più che qualche parente a Lake Forest, studiava all’istituto d’Arte, ma pensava di lasciar stare perché gli insegnanti non le piacevano. Pensava che vivere in Chicago era davvero troppo orribile e avrebbe voluto andare nell’Est. «Perché non andate a Firenze a stare con vostro padre?» domandò Eveline Hutchins. «Potrei, un giorno o l’altro, quando mi capiterà l’occasione» disse Eleanor. «Io, io non sarò mai ricca» disse Eveline. «Mio padre è un pastore… Andiamo insieme a Firenze, Eleanor, a trovare vostro padre. Se arrivassimo là, non potrebbe mica cacciarci via.» «Mi piacerebbe fare un viaggio un giorno o l’altro.» «Dovrei già essere a casa. A proposito, dove abitate? Troviamoci domani pomeriggio e guarderemo insieme tutti i quadri.» «Temo che sarò occupata domani.» «Allora potrete forse venire a cena una sera. Chiederò alla mamma quando potrò avervi. È tanto raro trovare una ragazza con cui parlare. Noi stiamo in Drexel Boulevard. Ecco il mio biglietto. Vi manderò una cartolina e voi promettete di venire, vero?» «Mi piacerebbe molto, purché non sia per prima delle sette… Vedete, ho un’occupazione che mi tiene impegnata tutti i pomeriggi, eccetto la domenica, e la domenica di solito vado a trovare i miei parenti a…» «A Lake Forest?» «Ecco… Quando sono in città, abito in una specie di YWCA, Moody House, un luogo ordinario ma conveniente… Vi scriverò l’indirizzo su questo biglietto.» Il biglietto era della signora Lang, “Pizzi di importazione e ricami a mano”. Vi scrisse il suo indirizzo, scarabocchiando l’altra facciata, e lo porse ad Eveline. «Così va bene» disse quella; «vi lascerò un biglietto stasera stessa e promettete di venire, vero?» Eleanor l’accompagnò fino al tram e poi si mise a camminare lentamente per la via. Aveva dimenticato interamente che era malata, ma ora che l’altra se n’era andata sentì di essere disperata e meschinamente vestita e di percorrere una strada solitaria attraverso
il ventoso trambusto serotino delle vie. Eleanor fece parecchie amicizie attraverso Eveline Hutchins. La prima volta che andò dagli Hutchins era troppo intimidita per far molta attenzione, ma più tardi si sentì più libera con loro, specialmente poiché scoprì che tutti la giudicavano una ragazza interessante e molto fine. La famiglia era composta del dottore, della signora Hutchins, di due figlie, e di un figlio all’università. Il dottor Hutchins era pastore unitario e aveva idee molto larghe e la signora Hutchins faceva acquerelli di fiori che si diceva mostrassero molto ingegno. La figlia maggiore, Grace, aveva compiuto gli studi nell’Est, a Vassar, e pareva avesse rivelato una certa disposizione letteraria, il figlio studiava greco fuoricorso a Harvard ed Eveline seguiva i corsi più interessanti alla Northwestern. Il dottor Hutchins aveva la voce vellutata, una gran faccia liscia e rosea e grandi mani bianche e lisce, come cadaveriche. Gli Hutchins progettavano di fare un viaggio l’anno successivo, che sarebbe stato per il dottore il sabbatico. Eleanor non aveva mai sentito prima parlar a quel modo e ne fu scossa. Poi una sera Eveline la condusse dalla signora Shuster. «Non devi dir nulla della signora Shuster in casa, capisci?…» disse Eveline mentre scendevano dall’aerea. «Il signor Shuster è un mercante d’arte e al babbo sembrano un po’ troppo spregiudicati… È solo perché Annie Shuster venne da noi una sera e fumò tutto il tempo della cena… Ho detto che andavamo al concerto, all’Auditorium.» Eleanor si era fatta per l’occasione un abito nuovo, un semplicissimo abito bianco con sopra un po’ di verde, non proprio un abito da sera, ma indossabile in qualunque circostanza, e Annie Shuster, una donnina tozza dai capelli rossi, che aveva un modo di camminare e di parlare a scatti, aiutandole a deporre i soprabiti in anticamera, trovò che era grazioso. «Ma sì, è carino» disse Eveline. «Davvero, sei graziosa come un fiore stanotte, Eleanor.» «Giocherei che quest’abito non è stato fatto in città… Ha un’aria parigina» disse la signora Shuster. Eleanor sorrise come a dire “per carità” e arrossì un poco, apparendo più bella che mai. C’era una gran folla di persone ammucchiate in due stanzette, e fumo e tazze di caffè e un odore come di punch. Il signor Shuster era
un uomo canuto e grigio in volto, con una testa troppo grande per il corpo, e modi stracchi. Parlava come un inglese. Aveva intorno diversi giovanotti; uno di questi Eleanor l’aveva conosciuto casualmente, quando studiava all’istituto d’Arte. Si chiamava Eric Egstrom e le era sempre piaciuto; aveva capelli stopposi, occhi azzurri e baffettini biondi. Eleanor vedeva bene che il signor Shuster lo stimava molto. Eveline la portò attorno e la presentò a tutti e a tutti faceva domande che a volte parevano imbarazzanti. Uomini e donne fumavano e parlavano di libri e quadri e di gente che Eleanor non aveva mai sentito nominare. Si guardava intorno e non parlò molto: osservò i profili greci sui paralumi arancione, i quadri che avevano davvero un aspetto curioso sulle pareti, le due file di libri francesi dal dorso giallo sugli scaffali, e s’accorse che là dentro avrebbe potuto imparar molto. Se ne andarono presto, perché Eveline doveva passare all’Auditorium per veder quale fosse il programma del concerto temendo che gliene chiedessero, ed Eric e un altro giovanotto le accompagnarono a casa. Lasciata Eveline sotto casa sua, domandarono ad Eleanor dove abitava e a lei ripugnava dire Moody House perché si trovava in una via tanto orribile; così li fece venire fino a una stazione dell’aerea e corse in fretta per gli scalini e non volle con sé i due, quantunque le facesse paura andare a casa sola, tardi com’era. Molti clienti della signora Lang credevano Eleanor francese, per via dei capelli scuri, della sottile faccia ovale e della pelle diafana. Di fatto, un giorno che una signora McCormick (che la signora Lang sospettava fosse “una” dei McCormick) s’informò di quella graziosa ragazza francese che l’aveva servita altre volte, alla signora Lang venne un’idea. Eleanor sarebbe stata da allora in poi francese; e le pagò venti biglietti per la Berlitz e le disse che avrebbe avuto l’ora libera al mattino, dalle nove alle dieci, per andare a prendere lezioni di francese. Così per tutto dicembre e gennaio Eleanor studiò il francese tre volte alla settimana con un vecchio dalla giacchetta d’alpaca puzzolente e cominciò di tanto in tanto parlando coi clienti a lasciar scorrere una frase nel discorso, con quanta maggior disinvoltura poteva, e quando c’era qualcuno in negozio la signora
Lang la chiamava sempre «Mademoiselle». Lavorò molto e prese di quei libri gialli dalla biblioteca degli Shuster, da leggere la sera con un vocabolario, e ormai sapeva più francese di Eveline che aveva avuto da bambina la governante francese. Un giorno alla Berlitz trovò un nuovo insegnante. Il vecchio aveva la polmonite e al suo posto c’era un francese giovane. Era un giovanotto sottile con un acuto mento azzurrino sbarbato e occhioni bruni dalle lunghe ciglia. Ad Eleanor piacque subito, con quelle sottili mani aristocratiche e quell’aria superiore. Dopo mezz’ora, avevano del tutto dimenticato la lezione e parlavano in inglese. Il giovanotto parlava l’inglese con un accento buffo, ma correntemente. A Eleanor piaceva specialmente il modo gutturale che aveva di pronunciare la r. La volta dopo trepidava tutta, salendo le scale, ansiosa se sarebbe stato lo stesso giovanotto. Le era sì. Le disse che il vecchio era morto. Eleanor sentì che doveva rincrescerle, ma non le rincresceva. Il giovanotto notò il suo stato e contorse la faccia in una buffa espressione mezzo di riso mezzo di pianto, dicendo «Vae victis». Poi le disse della sua casa in Francia e come odiava quella convenzionale vita borghese e come era venuto in America, che era la terra della giovinezza e del futuro e dei grattacieli e del Twentieth Century Limited 1 e quanto gli pareva bella Chicago. Eleanor non aveva mai sentito nessuno parlare a quel modo e gli disse che avrebbe dovuto andare in Irlanda a baciare la pietra di Blarney. 2 Lui allora parve offeso e disse «Mademoiselle, c’est la pure vérité!» e lei disse che gli credeva assolutamente e quant’era interessante conoscerlo e che doveva presentarlo alla sua amica Eveline Hutchins. Poi, lui seguitò a raccontarle come aveva vissuto a New Orleans e come era venuto facendo il maggiordomo su un piroscafo francese e come aveva lavorato da lavapiatti e tranviere e suonato il piano nei cabaret e peggio e quanto amava i negri e che era pittore e desiderava tanto aprire uno studio e dipingere ma non aveva ancora il denaro. Eleanor fu un po’ raffreddata dai particolari della rigovernatura, dei cabaret e della gente di colore, ma quando quello disse che s’interessava d’arte pensò che davvero lo dovesse presentare a Eveline e si sentì audacissima e spregiudicata quando gli propose di trovarsi con loro
all’istituto d’Arte domenica pomeriggio. Dopo tutto, se decidevano di no, non avrebbe avuto che da non andare. Eveline ne fu eccitatissima, ma fecero anche venire Eric Egstrom, per via della pessima riputazione dei francesi. Il francese ritardò molto e cominciavano a temere che non venisse e di averlo perduto nella calca, ma Eleanor lo vide finalmente che saliva il grande scalone. Si chiamava Maurice Millet (no, niente parente del pittore) e li spaventò tutti assai, rifiutando di guardare i quadri dell’istituto d’Arte e dicendo che bisognava dargli fuoco, e usò una quantità di parole come cubismo e futurismo che Eleanor non aveva mai sentite prima. Ma Eleanor poté veder subito che aveva fatto un gran colpo su Eveline e Eric: tutti e due gli pendevano dalle labbra e durante il tè nessuno dei due fece più attenzione a Eleanor. Eveline invitò Maurice in casa e andarono tutti insieme a cena in Drexel Boulevard, dove Maurice fu molto gentile col signore e la signora Hutchins; e in seguito, dagli Shuster. Uscirono insieme dagli Shuster e Maurice disse che gli Shuster erano gente impossibile e tenevano sulle pareti quadri orribili. «Tout ça c’est affreusement pompier» disse. Eleanor si sentì in imbarazzo, ma Eveline e Eric dissero che comprendevano perfettamente: voleva dire che quelli s’intendevano tanto d’arte quanto può capirne un gruppo di pompieri, e risero molto. La volta dopo che vide Eveline, Eveline le confessò di essere pazzamente innamorata di Maurice, e piansero tutte e due in abbondanza e decisero che dopo tutto la loro bella amicizia poteva soffrire anche questo. Fu su, in camera di Eveline, in Drexel Boulevard. Sul caminetto c’era un ritratto di lui che Eveline a memoria aveva fatto con i pastelli. Sedettero a fianco a fianco sul letto, molto strette con le braccia reciprocamente al collo e parlarono di se stesse a vicenda, con solennità, e Eleanor disse come la pensava degli uomini. Eveline non la pensava proprio a quel modo, ma nulla avrebbe mai potuto spezzare la loro bella amicizia e si sarebbero sempre rivelate ogni cosa, a vicenda. Verso quel tempo Eric Egstrom trovò lavoro nel reparto di decorazione d’interni da Marshall Field, che gli fruttava cinquanta dollari settimanali. Prese un bello studio, con luce a mezzanotte, in un
vicolo di North Clark Street e Maurice andò a starci con lui. Le ragazze ci venivano spesso e ricevevano molti amici e prendevano il tè in bicchieri alla russa, e talvolta un po’ di vino Virginia Dare, cosicché non avevano più bisogno di andare dagli Shuster. Eleanor cercava sempre di dire una parola da sola a sola con Eveline; e il fatto che a Maurice non piacesse Eveline, come a Eveline piaceva lui, rendeva Eveline molto triste, ma Maurice e Eric parevano assolutamente beati. Dormivano nello stesso letto ed erano sempre insieme. Qualche volta Eleanor se ne inquietava, ma era tanto bello conoscere ragazzi che con le donne non erano brutali. Andavano tutti insieme all’Opera, a concerti, a esposizioni d’arte – erano Eveline o Eric che generalmente prendevano i biglietti e pagavano quando mangiavano nei ristoranti – e Eleanor se la passò meglio in quei pochi mesi che non in tutta la sua vita precedente. Non ritornò più a Pullman e lei e Eveline parlavano di prendere insieme uno studio, quando gli Hutchins fossero ritornati dal loro viaggio all’estero. Il pensiero che ogni giorno avvicinava maggiormente giugno e allora lei avrebbe perduto Eveline e dovuto fronteggiare da sola l’orribile estate di Chicago, granulosa, polverosa, soffocante, rendeva un po’ infelice Eleanor, ma Eric stava cercando di trovarle un posto da Marshall Field, lei ed Eveline seguivano un corso serale di decorazione d’interni all’università e ciò le dava qualcosa da sperare per il futuro. Maurice dipingeva quadri squisiti, in bruno pallido e violetto, di ragazzi lunghi in viso con grandi occhi luminosi e lunghe ciglia, e ragazze lunghe in viso, che parevano ragazzi, e cagnacci di Russia, con grandi occhi luminosi, e sempre nello sfondo c’era qualche grossa trave o un grattacielo bianco e un gran sbuffo di nuvole bianche ed Eveline e Eleanor pensavano ch’era una tal vergogna ch’egli dovesse continuare l’insegnamento alla Berlitz. Il giorno prima che Eveline s’imbarcasse per l’Europa, fecero una festicciola da Egstrom. I quadri di Maurice erano intorno sulle pareti e tutti eran contenti e rattristati ed eccitati e ridevano assai. Poi giunse Egstrom con la nuova che aveva parlato di Eleanor al padrone: che sapeva il francese e aveva studiato arte, era tanto carina e via di seguito, e il signor Spotmann aveva detto di condurgliela l’indomani a
mezzogiorno e il posto, se avesse potuto averlo, le avrebbe reso almeno venticinque dollari la settimana. C’era stata una vecchia signora a vedere i quadri di Maurice e pensava di comperarne uno; tutti si sentivano lieti e bevettero vino in quantità, di modo che alla fine, quando venne il momento degli addii, fu Eveline che si sentì solitaria a staccarsi da loro, invece di Eleanor a restare indietro, come si era aspettata. Quando ritornò dalla stazione, dove aveva accompagnato gli Hutchins in partenza per New York, la sera dopo, e tutte le valigie avevano l’etichetta del piroscafo Baltic e tutti gli occhi erano lucidi per l’eccitazione di andare all’Est e poi all’estero, e l’odore del fumo di carbone e il rintocco delle campane ferroviarie e lo scalpiccio dei piedi, Eleanor camminò coi pugni serrati e le unghie appuntite piantate nelle palme delle mani, ripetendosi molte e molte volte: “Anch’io andrò, è soltanto questione di tempo. Anch’io andrò”. 1. Noto treno direttissimo. (NdT) 2. Famosa lapide vicino a Cork, Irlanda, baciando la quale si diventa ingannatori. (NdT)
Occhio fotografico (18) era una signora molto alla moda e adorava i bullterriers e aveva un signore suo amico ch’era famoso per la somiglianza con re Edoardo era una signora molto alla moda e c’erano gigli bianchi nell’anticamera No mio caro non posso sopportarne il profumo nella stanza e i bullterriers mordevano i fornitori e il piccolo giornalaio No mio caro non han mai morso la gente come si deve e sono meravigliosi con Billy e i suoi amici andavano tutti in carrozza a tiro a quattro e l’uomo dietro suonava un lungo corno ed era là che stava Dick Whittington col gatto e le campane C’eran panieri pieni di provviste e la signora Pinelli aveva gli occhi grigi e si mostrava molto buona con il ragazzino del suo amico benché detestasse semplicemente la maggior parte dei bambini e il signore suo amico che era famoso per la somiglianza con re Edoardo non poteva sopportare i bambini o i bullterriers e lei continuava a domandare Perché lo chiamate così? e si pensava a Dick Whittington e alle grosse campane di Bow tre volte sindaco di Londra e si guardava in quegli occhi grigi e si diceva Forse perché l’ho chiamato così dalla prima volta che l’ho visto e non mi piaceva il tiro a quattro ma volevo che Dick Whittington tre volte sindaco di Londra facesse rimbombare le grosse campane di Bow e volevo Dick Whittington volevo essere a casa ma non avevo casa e l’uomo dietro suonava un lungo corno
Eleanor Stoddard Il lavoro da Marshall Field era molto diverso dal lavoro che si faceva dalla signora Lang. Dalla signora Lang non c’era che una padrona, ma nel grande negozio pareva che tutti quelli del reparto la sovrastassero. Pure, Eleanor era così fine e calma e aveva un suo modo così abile e definito di parlare che, quantunque non piacesse troppo, se la cavava bene. Persino la signora Potter e il signor Spotmann, capireparto, ne erano un poco intimiditi. Si sparse la voce che Eleanor era una signorina di società e che in fondo non aveva affatto bisogno di guadagnarsi da vivere. Era molto cordiale coi clienti sui loro problemi di arredamento e aveva un certo umile condiscendente modo di fare con la signora Potter e ne ammirava gli abiti, tanto che trascorso un mese la signora Potter disse al signor Spotmann: «Mi pare che abbiamo fatto una vera e propria scoperta con quella ragazza», e il signor Spotmann, senza aprire la sua bianca trappola di bocca da vecchia, disse: «È stata anche la mia idea fin da principio». Quando Eleanor uscì sul Randolph un bel pomeriggio di sole con tra le dita la busta delle prime settimane, si sentì felice. Aveva sulle labbra sottili un sorrisetto così tagliente, che due o tre persone si volsero a guardarla, mentre camminava abbassando la testa nel vento turbinoso per impedire al cappello di volar via. Prese per Michigan Avenue verso l’Auditorium, guardando le vetrine lucenti e il pallidissimo cielo azzurro e i cumuli di fioccose nubi grigiopiccione sopra il lago e le candide chiazze di fumo delle locomotive. Entrò nel profondo vestibolo, a luci ambrate, dell’Auditorium Annex, sedette tutta sola a un tavolino di vimini nell’angolo della sala di riposo e rimase là un bel pezzo sola, bevendo una tazza di tè e mangiando crostini imburrati, gettando gli ordini al cameriere con una secca vocetta fine e danarosa. Poi andò a Moody House, fece i bagagli e traslocò all’Eleanor Club, dove prese una camera con pensione per sette e cinquanta. Ma la camera non era molto meglio e tutto conservava quell’odor grigio d’istituto di carità; così, la settimana successiva tornò a traslocare in
un alberghetto pensione sul North Side, dove ebbe camera e pensione per quindici settimanali. Siccome così le restava solo un margine di tre e cinquanta – il posto, come s’era poi veduto, non le dava che venti dollari, che voleva dire in realtà diciotto e cinquanta, detrattane l’assicurazione – Eleanor dovette tornare a far visite al padre. Gli fece un tal colpo con la sua ascesa nel mondo e con le speranze di aumenti, che le promise cinque dollari alla settimana, benché lui stesso ne guadagnasse solo venti e stesse pensando di risposarsi con una signora O’Toole, vedova con cinque bambini, padrona di una pensione dalle parti di Elsdon. Eleanor rifiutò di andar a trovare la futura matrigna e fece promettere al padre che le avrebbe mandato il denaro per vaglia ogni settimana, dato che non poteva pretendere che venisse lei fino a Elsdon a prenderlo. Andandosene, lo baciò sulla fronte e lo rese felice. E, per tutto il tempo, badava a ripetersi che quella era proprio l’ultima volta. Poi ritornò all’albergo Ivanhoe e salì nella sua stanza e si gettò supina sul comodo letto d’ottone, guardando intorno la stanzetta dai legni bianchi e dalla tappezzeria giallo pallido, con strisce seriche più cupe, e le tendine di pizzo e le pesanti cortine. C’era una screpolatura nell’intonaco della volta e il tappeto era logoro, ma l’albergo era molto distinto, lo si vedeva, pieno di vecchie coppie che vivevano di piccole rendite; il personale era anziano e manieroso; Eleanor si sentì in casa propria per la prima volta nella sua vita. Quando Eveline Hutchins ritornò dall’Europa la primavera successiva, con un cappello largo e sopra una piuma, piena di discorsi sul Salon des Tuileries e la rue de la Paix e i musei e le esposizioni d’arte e l’Opera, trovò che Eleanor era mutata. Appariva più vecchia che in realtà, vestiva pacato e alla moda, e aveva un nuovo tono, amaro e tagliente, nel parlare. Era definitivamente stabilita nel reparto Decorazione interni da Marshall Field e da un giorno all’altro attendeva un aumento, quantunque non ne parlasse. Aveva cessato di seguire corsi o frequentare l’istituto d’Arte e passava moltissimo tempo con una vecchia zitella che anche lei stava all’Ivanhoe e si diceva fosse molto ricca e molto tirchia, una certa signorina Eliza
Perkins. La prima domenica che fu tornata Eveline, Eleanor la invitò al tè nell’albergo e sedettero nella sala di riposo, che sapeva di chiuso, a chiacchierare in sommessi bisbigli con la vecchia signorina. Eveline chiese di Eric e di Maurice. Eleanor supponeva che stessero bene, ma non li aveva più veduti molto, da quando Eric aveva perduto il posto presso Marshall Field. Eric non riusciva così bene come lei aveva sperato, disse. Lui e Maurice si erano messi a bere e andare in giro con compagnie discutibili e raramente Eleanor aveva modo d’incontrarli. Pranzava ogni sera con la signorina Perkins e la signorina Perkins aveva di lei una grande stima e le comprava vestiti e la portava a scarrozzare nel parco e qualche volta al teatro, quando c’era qualcosa che valeva veramente la pena: Minnie Maddern Fiske e Guy Bates Post in qualche lavoro interessante. La signorina Perkins era la figlia di un ricco padrone di liquoreria e in gioventù era stata ingannata da un giovane avvocato, cui aveva dato incarico d’investire per lei certi denari e intanto se n’era innamorata. Quello era scappato con un’altra ragazza e una quantità di biglietti di banca. Quanto le fosse restato precisamente, Eleanor non aveva potuto chiarire, ma siccome al teatro prendeva sempre i posti migliori e le piaceva andare a cena in alberghi e ristoranti carissimi e noleggiava una carrozza per mezza giornata ogni volta che ne aveva voglia, inferì che doveva ancora star bene. Lasciata la signorina Perkins per recarsi a cena insieme dagli Hutchins, Eveline disse: «Francamente non capisco che cosa tu ci veda in quella… quella zitelletta… E io che scoppiavo dalla voglia di raccontarti un milione di cose e farti un milione di domande… È stato maligno da parte tua». «Le sono molto devota, Eveline. Credevo t’interessasse conoscere qualsiasi mia cara amica.» «Ma certo che sì, ma, Dio mio, non riesco a capirti.» «Bene, non sarai più obbligata a rivederla, quantunque ti possa dire che, dal modo come s’è comportata, tu le eri simpatica.» La passeggiata dall’aerea a casa Hutchins fu più secondo i tempi di una volta. Eleanor parlò della tensione che aumentava tra il signor
Spotmann e la signora Potter e come ciascuno dei due la voleva dalla sua e fece ridere Eveline, e Eveline confessò che sul Kroonland nel viaggio di ritorno s’era innamorata forte di uno di Salt Lake City, un tal sollievo dopo tutti quegli stranieri, e Eleanor la punzecchiò lì sopra e disse che probabilmente quello era un mormone e Eveline rise e disse no, era un giudice e ammise ch’era già sposato. «Ecco» disse Eleanor «vedi che è un mormone.» Ma Eveline disse che era certa di no e che, se lui avesse divorziato dalla moglie, l’avrebbe sposato, senz’altro. Allora Eleanor disse che non approvava il divorzio e, se non fossero giunte alla porta, cominciavano a litigare. Quell’inverno non vide molto Eveline. Eveline aveva molti adoratori e andava molto a feste; Eleanor leggeva di lei la domenica mattina sulla pagina mondana. Era molto occupata e sovente troppo stanca alla sera, anche soltanto per andare a teatro con la signorina Perkins. La lite tra la signora Potter e il signor Spotmann era venuta a conclusione: la direzione aveva trasferito la signora Potter in un altro reparto e lei s’era lasciata plum! cadere in una vecchia poltrona di Spagna e lì s’era abbandonata e giù a piangere davanti ai clienti e Eleanor l’aveva dovuta condurre al gabinetto di toeletta e cercar per lei sali canforati e aiutarla a rifarsi i capelli ossigenati nella grande pompadour e consolarla, dicendo che probabilmente si sarebbe trovata meglio nell’altro locale. In seguito, il signor Spotmann fu affabilissimo per diversi mesi. Una volta ogni anno, portava Eleanor a pranzo con sé e ridevano insieme di una certa facezia sulla pompadour della signora Potter, traballante quando quella aveva pianto di fronte ai clienti. Mandava Eleanor a far molte commissioncine in case ricche e i clienti ne eran contenti, tanto lei era fine e cordiale, e gli altri impiegati del reparto la detestavano e la soprannominarono “il cocco del signor maestro”. Il signor Spotmann disse persino che avrebbe cercato di ottenerle un percento sulle commissioni e parlava spesso di quell’aumento a venticinque la settimana. Poi un giorno Eleanor giunse a casa tardi per la cena e il vecchio impiegato dell’albergo le disse che alla signorina Perkins era mancato il cuore, mentre mangiava carne e pasticcio di rognone, che era morta
là nella sala da pranzo dell’albergo e il corpo era stato trasportato alla cappella funeraria Irving, e le domandò se non conosceva suoi parenti da avvertire. Eleanor non sapeva nulla, eccetto che i suoi affari finanziari li trattava la Corn Exchange Bank e credeva che avesse nipoti a Mound City, ma non ne sapeva i nomi. L’impiegato era molto preoccupato: chi mai avrebbe pagato il trasporto della salma, il dottore e il conto, ancora aperto, di una settimana e disse che tutti gli oggetti della signorina sarebbero restati sotto sigillo, finché una qualche persona qualificata non fosse comparsa a reclamarli. Pareva convinto che la signorina Perkins fosse morta principalmente per fare un dispetto alla direzione dell’albergo. Eleanor salì nella sua camera, chiuse a chiave l’uscio e si buttò sul letto, dove pianse un po’, perché era stata affezionata alla signorina Perkins. Poi le s’insinuò un pensiero in testa che le fece accelerare i battiti del cuore. Magari la signorina Perkins le aveva lasciato un patrimonio nel testamento. Cose simili accadevano. Giovanotti che aprivano banchi di chiesa, un cocchiere che raccoglieva una borsetta; le signore vecchie lasciavan sempre il loro patrimonio a gente così. Lo vedeva a grosse lettere: IMPIEGATA DI MARSHALL FIELD CHE EREDITA UN MILIONE. Non riuscì a dormire quella notte e al mattino trovò il direttore dell’albergo e si offrì di fare tutto quel che poteva. Telefonò al signor Spotmann e lo indusse a lasciarla in libertà per quel giorno, spiegandogli che era pressoché prostrata dalla morte della signorina Perkins. Poi telefonò alla Corn Exchange Bank e parlò con un signor Smith, incaricato della sostanza dei Perkins. Questi l’assicurò che la banca avrebbe fatto il possibile per proteggere gli eredi e i legatari universali e disse che il testamento era nella cassetta di sicurezza della signorina Perkins e che era certo che tutto fosse nella debita forma legale. Eleanor non aveva nulla da fare tutto il giorno, e così s’impadronì di Eveline per il pranzo, poi andarono insieme al Keith. Sentiva che non era del tutto corretto andare a teatro, con la vecchia amica ancor giacente alle pompe funebri, ma era così nervosa e isterica che doveva
far qualcosa per distogliere la mente da quel tremendo colpo. Eveline fu molto comprensiva e si sentirono più vicine che non fossero mai state da quando gli Hutchins erano andati in viaggio. Eleanor non disse nulla delle sue speranze. Al funerale ci furono soltanto Eleanor e la cameriera irlandese dell’albergo, una vecchia che tirò su dal naso e si segnò in quantità, con il signor Smith e un signor Sullivan in rappresentanza dei parenti di Mound City. Eleanor era in nero e l’impresario le si avvicinò e disse: «Scusatemi, signorina, ma non posso fare a meno di dirvi quanto state bene: un giglio delle Bermude». La cosa non fu così triste come Eleanor si aspettava e in seguito lei, il signor Smith e il signor Sullivan, il rappresentante dello studio legale incaricato degli interessi dei parenti, erano allegrissimi insieme, uscendo dal crematorio. Era una radiosa giornata di ottobre e tutti convennero che ottobre era il miglior mese dell’anno e che il pastore aveva letto l’ufficio funebre superbamente. Il signor Smith domandò a Eleanor se non veniva a pranzo con loro, dato che anche lei compariva nel testamento, e il cuore di Eleanor cessò quasi di battere e abbassò gli occhi e disse che per lei era un piacere. Entrarono tutti in un tassì. Il signor Sullivan disse ch’era un sollievo fuggirsene dal cimitero e da simili tetri pensieri. Andarono a pranzo da De Yonghe e Eleanor li fece ridere raccontando come si erano comportati all’albergo e in che trambusto s’eran trovati tutti, ma quando le porsero la lista disse che non si sentiva di mangiare un boccone. Pure, quando vide il pesce bianco fritto, disse che ne avrebbe preso un po’, da spilluzzicare. Si capì poi che l’aria d’ottobre e la lunga corsa in tassì avevano messo fame a tutti. Eleanor gustò molto il suo pranzo e, dopo il pesce, mangiò un po’ d’insalata Waldorf e poi un gelato alla pesca. Gli uomini le domandarono se permetteva loro di fumare il sigaro e il signor Smith assunse un’aria libertina e chiese se voleva una sigaretta e Eleanor arrossendo rispose di no, che non fumava, e il signor Sullivan disse che lui non rispettava una donna che fumasse, e il signor Smith che certe ragazze delle migliori famiglie di Chicago fumavano e, quanto a sé, non vedeva che male ci fosse, sempreché
non si trasformassero in tanti fumaioli. Dopo pranzo, attraversarono la via e salirono nell’ascensore all’ufficio del signor Sullivan e là sedettero in grandi poltrone di cuoio e il signor Sullivan e il signor Smith assunsero visi solenni e il signor Smith si schiarì la gola e cominciò a leggere il testamento. Eleanor dapprima non ci capì niente e il signor Smith dové spiegarle che il grosso del patrimonio dei tre milioni di dollari andava all’asilo Florence Crittenton per le ragazze discole, ma che la somma di mille dollari a testa era per le tre nipoti di Mound City e un bello spillone di diamanti, a forma di locomotiva, veniva a Eleanor Stoddard e «Se passate alla Corn Exchange Bank un momento in giornata di domani, signorina Stoddard,» disse il signor Smith «sarò lieto di consegnarvelo». Eleanor scoppiò a piangere. I due furono molto riguardosi e commossi del fatto che la signorina Stoddard fosse così commossa al ricordo della sua cara amica. Quando uscì dall’ufficio, promettendo di passar domani per lo spillone di diamanti a forma di locomotiva, il signor Sullivan stava dicendo con la sua voce più cordiale: «Signor Smith, capite bene che dovrò tentare di far annullare questo testamento nell’interesse dei Perkins di Mound City» e il signor Smith rispondeva con la sua voce più cordiale: «Lo credo bene, signor Sullivan, ma non vedo che possiate ottener molto. È un documento corazzato e ribadito a rame, se così debbo dire, che non dovrei, perché l’ho compilato io stesso». Così, il giorno dopo, alle otto, Eleanor ritornava da Marshall Field e ci rimase per parecchi anni. Ebbe l’aumento e le percentuali sulle commissioni e col signor Spotmann diventarono molto amici, ma lui non cercò di farle l’innamorato e i loro rapporti eran sempre formali; e questo era un sollievo per Eleanor che sentiva continuamente storie di sorveglianti e capireparto che imponevano le loro attenzioni alle impiegate giovani e il signor Elwood del reparto Mobili era stato licenziato proprio per questo, quando si scoprì che Lizzie Dukes era incinta, ma forse non era stata tutta colpa del signor Elwood, perché Lizzie Dukes non aveva un’aria meglio di quel che fosse in realtà. Comunque, pareva ormai a Eleanor di dover passare quel che le restava di vita a mobiliare i salotti e le sale da pranzo nuove del
prossimo, ad assortire tendine e modelli di tappezzeria e carta da parati, a mitigare clienti indignate, che avevano ricevuto un cane di porcellana orientale invece di un tavolino da tè intarsiato oppure che, anche dopo averlo scelto esse stesse, non erano soddisfatte del disegno di quel tal cretonne. Trovò ad aspettarla Eveline Hutchins, una sera mentre il negozio chiudeva. Eveline non piangeva, ma era d’un pallore mortale. Disse che non aveva mangiato nulla da due giorni e che Eleanor venisse a prendere il tè con lei alla Sherman House o dove voleva. Andarono all’Auditorium Annex e sedettero nella sala di riposo, ordinarono tè e crostini alla cannella e allora Eveline disse che aveva rotto il fidanzamento con Dirk McArthur e deciso, non di uccidersi, ma di mettersi a lavorare. «Non mi innamorerò mai più di nessuno, ecco, ma bisogna che faccia qualcosa e tu ti sprechi proprio in quel magazzino tabaccoso; Eleanor, sai che non hai mai modo di mostrare quel che tu valga, non fai altro che sprecare le tue capacità.» Eleanor disse che detestava quel lavoro come il tossico; ma che cosa doveva fare? «Perché non facciamo quel che abbiamo detto tutti questi anni… Oh, c’è da ammattire a vedere come la gente non avrà mai coraggio, non farà mai qualcosa di divertente o d’interessante… Scommetto che, se aprissimo una casa di decorazione, avremmo un mucchio di ordini. Sally Emerson ci darà la sua casa nuova da decorare e allora tutti dovranno venire da noi per essere eleganti… È impossibile che le persone vogliano veramente abitare in quegli orribili buchi che hanno, è soltanto che non ne conoscono di migliori.» Eleanor sollevò la tazza e bevve qualche sorsellino. Si guardò la manina candida, attentamente curata, con le unghie appuntite, che reggeva la tazza. Poi disse: «Ma dove troviamo il capitale? Bisogna averlo un capitale per cominciare». «Il babbo ci darà qualcosa, penso, e magari Sally Emerson anche lei, è una brava persona, e allora la nostra prima ordinazione ci avrà lanciate… Stacci, su… Eleanor, sarà così divertente.» «Hutchins e Stoddard, Decorazione interni» disse Eleanor, deponendo la tazza «oppure Signora Hutchins e signora Stoddard, ebbene, mi sembra un’idea grande.» «Non credi che Eleanor Stoddard
e Eveline Hutchins, semplicemente, sarebbe meglio?» «Oh be’, potremmo decidere il nome quando prenderemo lo studio e lo faremo mettere sulla guida dei telefoni. Perché non facciamo così, cara Eveline… se riesci a farci affidare dalla tua amica Emerson la decorazione della sua casa nuova, ci mettiamo senz’altro, se no, aspettiamo finché non ci sia un’ordinazione genuina da contarci su.» «Bene allora, son sicura che ce l’affiderà. Corro subito a cercarla.» Eveline era adesso ben colorita. Si alzò in piedi e, piegandosi su Eleanor, la baciò. «Oh, Eleanor, sei un tesoro.» «Aspetta un momento, non abbiamo pagato il tè» disse Eleanor. Nel mese seguente l’impiego fu insopportabile, e le lagnanze dei clienti e dover uscire in fretta dall’Ivanhoe tutte le mattine e mostrarsi gentile col signor Spotmann e trovar freddure da farlo ridere. La camera all’Ivanhoe le pareva angusta e sordida, e l’odor di cucina che saliva dalla finestra e l’odor di unto del vecchio ascensore. Molti giorni telefonava di star poco bene e poi s’accorgeva di non poter resistere nella camera e vagabondava per la città, nei negozi e nei cinematografi, poi d’un tratto si sentiva stanca morta e il bisogno di tornare in tassì, spesa che non poteva permettersi. Tornò persino qualche volta all’istituto d’Arte, ma conosceva a memoria tutti i quadri e non aveva più la pazienza di starli a guardare. Finalmente Eveline convinse la signora Philip Paine Emerson che la sua nuova casa non poteva stare senza una nota di modernità nella sala da pranzo e le presentarono un preventivo molto più basso di quello di qualunque altro decoratore stabilito e Eleanor ebbe il piacere di vedere la faccia stupefatta del signor Spotmann, quando gli rifiutò di rimanere oltre, anche per un aumento a quaranta settimanali e disse che aveva l’incarico, insieme a un’amica, di decorare la nuova casa Paine Emerson in Lake Forest. «Be’, cara mia,» disse il signor Spotmann schioccando la sua bianca bocca quadra «se volete sacrificare la carriera, non sarò io quello che vi ferma. Potete andarvene all’istante, se volete. Naturalmente perdete il premio di Natale.» A Eleanor il cuore batté forte. Guardò la luce grigia che entrava per l’ufficio, la casella gialla del catalogo a schede,
le lettere sul raccoglitore e i piccoli campioni che ne penzolavano. Nell’ufficio all’esterno, Ella Bowen, la stenografa, aveva cessato di scrivere a macchina, probabilmente stava in ascolto. Eleanor annusò l’aria morta che sapeva di chintz, di vernice di mobilio, di vapore e di fiato del prossimo e poi disse: «Bene, signor Spotmann, vado!». Ci volle tutta la giornata per venir nel suo e mettere insieme l’ammontare dell’assicurazione dovutale, e sostenne un gran litigio con un cassiere circa la somma, cosicché fu pomeriggio tardi quando poté uscire nella neve che cadeva fuori, entrando in una farmacia a telefonare a Eveline. Eveline aveva già preso in affitto due piani di una antica casa vittoriana in fondo a Chicago Avenue e per tutto l’inverno furono affaccendate a decorare l’ufficio e le mostre al pianterreno e l’alloggio disopra, dove avrebbero abitato, e a preparare la sala da pranzo di Sally Emerson. Presero una ragazza di colore di nome Amelia, cuoca molto abile benché bevesse un poco; finito il pomeriggio, si facevano le loro fumatine e cocktail e cenette con vino; scoprirono un sarto francese in bolletta che fece loro abiti da sera, per indossarli quando uscivano con Sally Emerson e le persone della sua cerchia; giravano in tassì e fecero la conoscenza di molte interessantissime persone. In primavera, quando finalmente ricevettero da Philip Paine Emerson un assegno di cinquecento dollari, erano allo scoperto di mille, ma vivevano come piaceva a loro. La sala da pranzo fu giudicata un po’ spinta, ma a qualcuno piacque e venne qualche altra ordinazione. Fecero molte amicizie e si rimisero a uscire con artisti e con redattori speciali del «Daily News» e dell’«American» che le portavano a cena in ristoranti esotici, dove c’era molto fumo e dove si parlava abbondantemente della moderna pittura francese, del Middle West e di andare a New York. Andarono alla mostra Armory e tenevano una fotografia dell’Uccello d’oro di Brancusi sulla scrivania dell’ufficio e copie della «Little Review» e di «Poetry» tra i gruppi di lettere dei clienti e i conti non pagati dei fornitori. Eleanor uscì molto con Tom Custis, un individuo anziano, rosso in faccia, appassionato di musica, di ballerine e di liquori, socio di tutti i circoli e stato per anni un grande ammiratore di Mary Garden. Aveva
un palco all’Opera, una Stevens-Duryea e niente da fare, eccetto andar dai sarti, visitare specialisti e di tanto in tanto escludere un ebreo o un novellino, che cercava di entrare in qualche circolo al quale lui apparteneva. Gli Armour avevano rilevato tutta l’azienda paterna di carne in scatola, quando lui era ancora atleta all’università, e da allora non aveva mosso un dito per lavorare. Pretendeva di esser del tutto disgustato della vita di società e se la godeva a interessarsi del lavoro di decorazione delle due ragazze. Si teneva in stretto contatto con Wall Street e di tanto in tanto girava un paio delle azioni, in cui stava negoziando, a Eleanor. Se salivano, il guadagno era per lei, se cadevano la perdita era sua. Aveva una moglie in una clinica privata, e con Eleanor decisero che loro due sarebbero stati semplicemente buoni amici. Talvolta diventava un momentino troppo affettuoso, di ritorno a casa in tassì alla sera, ma Eleanor lo sgridava e il giorno dopo lui era tutto contrito e le mandava grandi scatole di fiori candidi. Eveline aveva diversi ammiratori, scrittori, disegnatori e gente del genere, ma quelli non avevan mai un soldo e, quando venivano a cena, mangiavano e bevevano tutto ciò che c’era in casa. Uno di questi, Freddy Seargeant, era attore e inscenatore, arenato per il momento a Chicago. Aveva amici all’ufficio Shubert e la sua grande ambizione era di allestire una pantomima come il Sumurun di Reinhardt, fondata la sua sulle storie degli indiani maya. Aveva in quantità fotografie di rovine maya e Eleanor e Eveline si misero a disegnargli costumi e scene. Speravano di far finanziare da Tom Custis o dai Paine Emerson questa produzione in Chicago. Il guaio più grosso era la musica. Un giovane pianista, che Tom Custis aveva mandato a Parigi a studiare, cominciò a comporla e venne una notte a suonarla. Gli prepararono un vero ricevimento. Vennero Sally Emerson e molta gente distinta, ma Tom Custis bevve troppi cocktail, per poter ancora sentire anche solo una nota, e la cuoca Amelia s’ubriacò e rovinò la cena e Eveline disse al giovane pianista che la sua musica pareva musica da cinema e quello se ne andò infuriato. Quando tutti furono via, Freddy Seargeant e Eveline e Eleanor errarono per l’alloggio devastato, ciascuno di pessimo umore. Freddy Seargeant si tormentava con le lunghe mani i neri capelli già
leggermente chiazzati di grigio e diceva che voleva ammazzarsi e Eleanor e Eveline bisticciarono con violenza. «Ma pareva musica da cine, sì o no? e dopo tutto perché non dovrebbe esserlo?» badava a ripetere Eveline. Allora Freddy Seargeant afferrò il cappello e uscì dicendo: «Voi donne mi fate della vita un inferno» e Eveline scoppiò a piangere e le venne la crisi isterica e Eleanor dovette chiamare il dottore. Il giorno dopo raggranellarono cinquanta dollari per rimandare Freddy a New York e Eveline ritornò a vivere a casa in Drexel Boulevard, lasciando che Eleanor tirasse avanti le decorazioni da sola. La primavera seguente Eleanor e Eveline vendettero per cinquecento dollari certi candelabri, buscati in un negozio di anticaglie nel quartiere occidentale per venticinque, e stavano appunto scrivendo assegni per i loro debiti più pressanti quando giunse un telegramma. FIRMATO CONTRATTO CON SHUBERT PRODUZIONE TESS DEI D’URBERVILLE FARETE SCENOGRAFIA COSTUMI DUECENTOCINQUANTA SETTIMANALI CIASCUNA VENITE NEW YORK IMMEDIATAMENTE DOVETE TELEGRAFARE SUBITO HOTEL DES ARTISTES CENTRAL PARK SOUTH FREDDY «Eleanor, dobbiamo andare» diceva Eveline togliendo una sigaretta dalla borsetta e passeggiando per la camera con buffate furibonde. «Sarà un perdifiato, ma prendiamo oggi il Twentieth Century… È quasi mezzogiorno» disse Eleanor con la voce malferma. Senza rispondere, Eveline andò al telefono e chiese l’ufficio Pullman. Quella sera, sedute nel loro scompartimento, guardavano fuori del finestrino le acciaierie di Indiana Harbor, le grandi fabbriche di cemento che eruttavano fumo livido, le fiammeggianti fornaci di Gary nascoste nel barlume invernale, turbinoso di fumo. Nessuna di loro riusciva a parlare.
Occhio fotografico (19) la moglie del pastore metodista era una donna alta sottile che cantava canzoncine al piano con una ronzante voce perduta aveva saputo che vi piacevano i libri e coltivavate fiori e vegetali e s’interessava tanto perché un tempo era stata episcopaliana e amava le cose belle e avevano pubblicato racconti suoi in una rivista Era più giovane del marito che era un silenzioso uomo dai capelli neri con una bocca che pareva una trappola da topi e sugo di tabacco sul mento e vestiva abiti bianchi leggeri e usava profumo e parlava con una voce che pareva una campanella delle cose che erano belle come un giglio e la luna era lucente come una bolla piena da scoppiare dietro il grande pino quando tornavamo indietro lungo la spiaggia e uno sentiva che bisognava circondarla col braccio e baciarla soltanto non si voleva e comunque uno non ne avrebbe avuto il coraggio camminando adagio attraverso la sabbia e gli aghi dei pini sotto la grossa luna gonfia a scoppiare come un’enorme goccia di mercurio e lei parlava tutta triste delle cose che aveva sperato e uno si sentiva davvero spiacente vi piacevano i libri e la Decadenza e caduta dell’impero romano del Gibbon e i romanzi del capitano Marryat e avevate voglia di andar via e in mare e in città straniere Carcassonne Marrakech Ispahan e vi piaceva che le cose fossero belle e avreste voluto avere il coraggio di stringere e baciare Martha la ragazza di colore che dicevano fosse mezzo indiana la figlia della vecchia Emma e la piccola Mary dalla testa rossa le insegnai a nuotare se soltanto avessi avuto il coraggio le notti senza brezza quando la luna era piena ma oh Dio non gigli
Cine-giornale XIV UN ARTIGLIERE FERMA UN AUSTRALIANO il colonnello dice che i democratici hanno ridotto in angustie la nazione Darò le dimissioni quando morirò rugge Huerta in una sfida feroce e mezzo il Messico morirà con me non si videro fiamme ma l’enorme pennacchio di fumo annerito ondeggiò all’altezza di un miglio dal cratere e cenere vulcanica cadde sulla piana di Macomber a tredici miglia di distanza Uova Rumorose? Senza Gettoni da Poker Giù per la bella riva della vecchia Alabamy dove c’è babbo e mamma con Ephram e Sammy FANNO UN BALLO LE FATE DELLA LUNA SULLE AIUOLE DI RAVINIA WILSON SI CONSULTERÀ CON GLI UOMINI D’AFFARI ammette di aver gettata la bomba donna poliziotto paga da bere dopo l’una perde nei grani viene ucciso come scassinatore Nelle notti di luna vanno tutti nel prato e là tutti attendono e i banjo già sincopano che cos’è che dicono che cos’è che cantano riconoscendo la scrittura di James il presidente afferrò il razzo e tirò il fuso. Un torrente di pastiglie di gomma dorate cadde sulla scrivania; poi dando un’occhiata al foglio il dirigente lesse: «Non mangiatene troppe perché Mamma dice che vi farebbero male». A CAVALLO DI UN LUPO MARINO NELLE ACQUE MESSICANE Tutti insieme si dondolano canterellano e oscillano è quel bastimento il Robert E. Lee che è venuto a pigliare il cotone anche qui
LA NUOVA FELICITÀ DI ISADORA DUNCAN disturbatori dell’IWW assalirono una celebrazione del genetliaco di Garibaldi a Rosebank Staten Island quest’oggi nel pomeriggio, insultarono la bandiera italiana, picchiarono e bastonarono membri della Società italiana del tiro a segno e avrebbero gettato nella polvere la bandiera americana se SEI RAGAZZE AL BAGNO SENZA COSTUME PESTANO GLI OCCHI DI UN SATIRO tuffatori indiani ricercano il corpo del ragazzo annegato qualcuno dei testimoni dice che ha visto una donna nella folla. Venne colpita con un mattone. L’uomo in grigio si rifugiò dietro le sottane di lei per sparare. I ponti superiori e i luoghi appartati del battello sono il paradiso degli spasimanti dove sovente ci si prende delle libertà con giovani signorine ubriache le madri delle quali non avrebbero dovuto permetter loro di andare sole su un pubblico battello IL MIDWEST PUÒ FARE O DISTRUGGERE WILSON DICONO LE CAUSE DELL’IRREQUIETEZZA MONDIALE DEI LAVORATORI «Sono un ammiraglio svizzero che va in America» e il poliziotto chiamò un tassì. Vedili scivolare ascoltali cantare oh è magnifico qui sopra il fiume, dal mare, aspettano il Robert E. Lee.
Imperatore dei Caraibi Quando Minor C. Keith morì, tutti i giornali riportarono la sua fotografia, un uomo dagli occhi vivaci, col naso da falco, una rispettabile pancetta e un’aria inquieta sotto gli occhi. Minor C. Keith era figlio di un uomo ricco, nato in una famiglia che amava l’odor del denaro, sapevano annusare il denaro da una parte all’altra del globo in quella famiglia. Suo zio era Henry Meiggs, il don Enrique della Costa Occidentale. Suo padre aveva una grossa impresa in legnami e trattava immobili a Brooklyn; il giovane Keith era una scheggia del vecchio ceppo (In antico, nel ’49, don Enrique era stato attirato a San Francisco dalla corsa all’oro. Lui non era andato alla cerca nelle colline, lui non era morto di sete setacciando polvere alcalina nella valle della Morte. Lui vendeva equipaggiamenti a quegli altri. Rimase a San Francisco e fece della politica e dell’alta finanza finché ci si trovò dentro fino al collo e dovette imbarcarsi in tutta fretta. Il bastimento lo portò nel Cile. Lui annusò denaro nel Cile. Era il capitalista yanqui. Costruiva la ferrovia da Santiago a Valparaíso. C’eran depositi di guano nelle isole Chincha. Meiggs annusò denaro nel guano. Si scavò una fortuna nel guano, divenne una potenza sulla Costa Occidentale, prestidigitò cifre, ferrovie, esercito, la politica dei caciques e dei políticos locali; erano tutti gettoni di una gran partita di carte. Dietro una grossa mano, lui ammucchiava i dollari. Finanziò le incredibili ferrovie delle Ande.) Quando Tomás Guardia divenne dittatore della Costa Rica, scrisse a don Enrique di costruirgli una ferrovia; Meiggs aveva da fare nelle Ande, un contratto di 75.000 dollari non valeva la pena per lui e così mandò a chiamare il nipote Minor Keith. Non si lasciavano crescer l’erba sotto i piedi in quella famiglia. A sedici anni Minor Keith viveva del suo, vendendo colletti e cravatte in un negozio di vestiario.
In seguito fece il sorvegliante di legnameria e diresse una azienda di legnami. Quando suo padre comperò l’isola del Padre al largo di Corpus Christi Texas, vi mandò Minor a farne denaro. Minor Keith cominciò ad allevar bestiame sull’isola del Padre e a pescar pesce in grande, ma pesce e bestiame non rendevano denaro abbastanza presto e così comprò maiali e macellò i manzi e bollì la carne e la diede ai maiali e macellò il pesce e lo diede ai maiali; ma i maiali non rendevano denaro abbastanza presto, così lui fu contento di andarsene a Limón. Limón era uno dei peggiori pestilenziari dei Caraibi, persino gli indiani vi morivano di malaria, febbre gialla, dissenteria. Keith ritornò a New Orleans sul vapore John G. Meiggs ad assoldare braccia per costruire la ferrovia. Offriva un dollaro al giorno e la pagnotta, e assoldò settecento uomini. Qualcuno di questi era già stato laggiù ai tempi filibustiereschi di William Walker. Di quella squadra ne tornarono vivi sì e no venticinque. Gli altri lasciarono le carcasse arse dal whisky a marcire nelle paludi. In un altro carico ne imbarcò millecinquecento; morirono tutti a dimostrare che soltanto i negri della Giamaica potevano vivere a Limón. Minor Keith non morì. Nel 1882 erano costruite venti miglia di ferrovia e Keith aveva un milione di dollari allo scoperto; le ferrovie non avevan niente da trasportare. Keith fece piantare banane perché la ferrovia avesse qualcosa da trasportare, per vendere le banane dovette mettersi nelle spedizioni; e questo fu l’inizio del commercio di frutta dei Caraibi. Intanto i braccianti morivano di whisky, di malaria, febbre gialla e dissenteria. I tre fratelli di Minor Keith morirono. Minor Keith non morì. Costruì ferrovie, aprì negozi al minuto per tutta la costa, a
Bluefields, Belize, Limón, comprò e vendé gomma, vaniglia, osso di tartaruga, salsapariglia, tutto ciò che poteva pagar poco lo comprava, tutto ciò che poteva vender caro lo vendeva. Nel 1898 in cooperazione con la Boston Fruit Company formò la United Fruit Company che è da allora diventata una delle più potenti unità industriali del mondo. Nel 1912 creò le International Railroads of Central America; tutto questo, fatto con le banane; in Europa e negli Stati Uniti la gente aveva cominciato a mangiar banane, e così abbatterono le giungle nell’America Centrale per piantarvi banane, e costruirono ferrovie per trasportare le banane, e ogni anno altri vapori della Great White Fleet viaggiarono a nord carichi di banane, e questa è la storia dell’impero americano nei Caraibi, e del canale di Panama e del futuro canale del Nicaragua e della fanteria di marina e delle navi da guerra e delle baionette. Perché quell’aria inquieta sotto gli occhi, nella fotografia di Minor C. Keith, il pioniere del commercio della frutta, il costruttore di ferrovie, in tutte le sue fotografie che i giornali riportarono quando morì?
Occhio fotografico (20) quando i tranvieri fecero sciopero a Lawrence aderendo ai vattelapesca erano un mucchio di guappi comunque, boemi ungheresi che non si lavavano il collo mangiavan aglio con marmocchi strillanti mogli grasse unte gli italiani fottuti venne fuori un avviso che cercava volontari bravi puliti giovani per servire sui tram e far vedere agli agitatori stranieri che si era ancora in una terra civile be’ costui viveva a Matthews e aveva sempre desiderato di fare il manovratore di tram dicevano che il signor Grover era stato manovratore ad Albany e beveva e si lasciava vedere per strada con troiette be’ costui viveva a Matthews e andò a Lawrence con un socio di stanza e si presentarono a Lawrence e la gente gli gridava Crumiri Fetenti ma quelli che non erano guappi eran tangheri elementi infimi andava molto d’accordo costui col socio di stanza e salì sulla piattaforma e girò la manovella lucente d’ottone e rintoccò la campana erano in rimessa il socio di stanza pasticciava qualcosa tra i respingenti e costui girò la manovella lucida d’ottone e il tram partì e investì il socio di stanza e gli schiacciò la testa così tra i respingenti lo uccise sul colpo proprio così là nella rimessa e adesso costui ha da tener testa ai parenti del socio di stanza
J. Ward Moorehouse A Pittsburgh, Ward Moorehouse trovò un posto di cronista nel «Times Dispatch» e passò sei mesi a riferire su nozze italiane, congressi locali del circolo degli Alci, 1 morti tenebrose, assassini e suicidi tra lituani, albanesi, croati e polacchi, difficoltà per i documenti di naturalizzazione dei padroni greci di ristoranti, banchetti dei figli d’Italia. Abitava in una gran casa rossa, di legno, in fondo a Highland Avenue, tenuta da una signora Cook, una rattrappita vecchia di Belfast, costretta a subaffittare da quando suo marito, ch’era stato caporeparto in una delle fabbriche Homestead, era stato schiacciato da una gru che gli aveva lasciato cadere addosso un carico di masselli di ferro. Costei preparava a Ward la colazione e alla domenica il pranzo e, assistendo, mentre lui da solo mangiava nella vecchia sala da pranzo piena di mobili, gli raccontava della sua giovinezza nel Nord dell’Irlanda, della perfidia dei papisti e delle virtù del defunto signor Cook. Furon brutti giorni per Ward. Non aveva amici a Pittsburgh e soffrì di raffreddori e mali di gola durante tutto quell’inverno freddo, lurido e nevoso. Detestava l’ufficio del giornale e le salite delle vie e gli orizzonti coperti e le scale di legno a rompicollo su cui stava sempre andando su e giù, e l’odor di miseria, di cavoli, di bambini, di bucato negli alloggi a trappola, dove sempre lui aveva da scovare la signora Piretti, il cui marito era stato ucciso in rissa alla bettola in Locust Street, o Sam Burkovich, eletto presidente della società canterini dell’Ucraina, o una qualche donna dalle mani insaponate la cui creatura era stata sgozzata da un degenerato. Non tornava mai a casa prima delle tre o quattro del mattino e dal momento che faceva colazione, verso mezzogiorno, non gli pareva mai di aver avuto tempo di far nulla, che doveva già di nuovo telefonare all’ufficio per gli incarichi. Appena era giunto a Pittsburgh, era andato a trovare il signor McGill, conosciuto con Jarvis Oppenheimer a Parigi. Il signor McGill si ricordava di lui, se ne annotò l’indirizzo e gli disse di mantenersi in contatto perché sperava di farlo entrare nel nuovo ufficio d’informazioni che la Camera di Commercio stava organizzando, ma le settimane passavano e non riceveva una parola
da parte del signor McGill. Ricevette un asciutto biglietto una volta, da parte di Annabelle Marie, intorno a tecnicismi legali; avrebbe divorziato da lui allegando mancanza di sostentamento, abbandono e maltrattamenti. Tutto ciò che aveva da far lui era rifiutare di recarsi a Filadelfia, quando gli fosse mandata la citazione. Il profumo del cartoncino azzurro gli sollevò un debole spasimo di desiderio di donne, nell’animo. Ma doveva mantenersi casto e pensare alla carriera. Il peggio era il giorno settimanale di libertà. Spesso restava tutta la giornata disteso sul letto, troppo abbattuto per uscire nella mota nera delle vie. Scrisse a scuole per corrispondenza per darsi a corsi di giornalismo e di pubblicità e persino a un corso di frutticoltura, seguendo l’impulso di dare un calcio a tutto e andar nell’Ovest a cercar lavoro in un rancho o simili, ma si sentiva troppo svogliato per seguirli, e i libercoli s’accumulavano settimana per settimana sul tavolo della sua stanza. Nulla pareva condurre in qualche luogo. Ripercorse più e più volte tutta la sua vita, da quando aveva lasciato Wilmington quel giorno sul treno per scendere a Ocean City. Doveva aver fatto uno sbaglio in qualche luogo, ma non capiva dove. Si mise a giocare al solitario, ma non riusciva a fermarci la mente. Dimenticava le carte e, seduto al tavolo dal panno vellutato, color pepe, guardava, oltre il vaso di polverose felci artificiali, adorne di un involucro in carta crespo e di un polveroso fiocco rosa di scatola da dolci, giù nella via ampia, dove passavano i tram di continuo, raschiando sulla curva, e dove i fanali accesi nella foschia del tardo pomeriggio baluginavano un po’ sul ghiaccio fosco dei rigagnoli. Pensava molto ai tempi d’una volta in Wilmington, a Marie O’Higgins, alle sue lezioni di piano e alle pescate su di un vecchio guscio lungo il Delaware quand’era ragazzo; gli prendeva un tal nervoso che era costretto a uscire e andare a bere una cioccolata calda nel caffè all’angolo vicino e poi scendere al centro a un cinemino o a un’operetta. Si mise a fumare tre sigari al giorno, uno dopo ciascun pasto. Ciò gli dava un piacere da ripromettersi e desiderare. Andò due o tre volte a cercare il signor McGill nel suo ufficio al Frick Building. Ogni volta lo trovò assente per un viaggio. Scambiava
qualche chiacchiera con la ragazza al tavolino, mentre aspettava, e poi se ne andava controvoglia, dicendo: «Oh già, lo diceva che doveva partire» oppure: «Deve aver dimenticato l’appuntamento» per nascondere il suo imbarazzo di doversene andare. Quanto gli dispiaceva lasciare la ben illuminata anticamera d’ufficio, dalle lucide poltrone di mogano con zampe di leone per piedi, e il cinguettio delle macchine da scrivere dietro le pareti e i telefoni squillanti e gli impiegati e i dirigenti ben vestiti che s’affaccendavano dentro e fuori. Invece, all’ufficio del suo giornale c’era frastuono di macchine rintronanti e sentore acido d’inchiostro da composizione e rotoli di carta umida e fattorini sudati che scorrazzavano coi paraocchi verdi. E non conoscere nessuna persona veramente distinta, mai ricevere un incarico che non facesse capo a lavoratori, a stranieri, a delinquenti; come detestava tutto ciò. Un giorno nella primavera, andò allo Schenley a intervistare un conferenziere ospite. Si sentiva ben disposto perché sperava di cavarne qualche rigo di più dal redattore capo. Si apriva la strada nel vestibolo affollato dall’arrivo di un congresso statale di Kiwanians, 2 quando s’imbatté nel signor McGill. «Ohi, salute, Moorehouse» disse il signor McGill, con un tono casuale come lo vedesse da tutto quel tempo. «Sono lieto d’avervi incontrato. Quelle bestie dell’ufficio avevano smarrito il vostro indirizzo. Siete libero un momento?» «Sì, certamente, signor McGill» disse Ward. «Ho un appuntamento con un tale, ma può attendere.» «Non bisogna mai far attendere, quando si ha un appuntamento» disse il signor McGill. «Ma non è un appuntamento d’affari» disse Ward, levando in faccia al signor McGill il suo fanciullesco sorriso occhi-azzurrino. «Non gli importerà, un minuto.» Andarono in sala di scrittura e sedettero su un divano damascato. Il signor McGill spiegò che era stato allora eletto temporaneo direttore generale per riorganizzare la Bessemer Metallic Furnishings and Products Company, che maneggiava un vasto ramo di sottoprodotti delle fabbriche Homestead. Era in cerca di un uomo energico e ambizioso che s’incaricasse della pubblicità e dello sviluppo. «Ricordo
quell’opuscolo che mi avete mostrato a Parigi, Moorehouse, e credo che siate voi l’uomo.» Ward fissava il pavimento. «Naturalmente questo significherebbe abbandonare il mio presente lavoro.» «Cos’è?» «Il giornalismo.» «Oh, lasciate perdere, non ha avvenire… Dovremo fare qualcun altro direttore pubblicitario nominale per ragioni che non staremo ora a esaminare… ma voi sarete il dirigente effettivo. Che stipendio chiedete?» Ward guardò il signor McGill negli occhi e il sangue gli si arrestò nelle orecchie, mentre ascoltava la propria voce dire con noncuranza: «Che cosa ne direste di cento settimanali?» Il signor McGill si lisciò i baffi e sorrise. «Be’, dibatteremo la cosa più tardi» disse, alzandosi. «Credo di potervi consigliare senz’altro a lasciare il vostro impiego presente… Ne telefonerò al signor Bateman… in modo che comprenda perché vi portiamo via da lui… Nessun risentimento, capite, per le vostre improvvise dimissioni… mai lasciar risentimenti… Venite a vedermi domani alle dieci. In ufficio, al Frick Building.» «Credo di avere qualche buona idea per la pubblicità, signor McGill, è il lavoro che più m’interessa» disse Ward. Il signor McGill non gli badava più. Accennò del capo e se ne andò. Ward salì a intervistare il suo conferenziere, temendo per ora di lasciarsi andare al troppo giubilo. Il giorno dopo fu per lui l’ultimo in un ufficio di giornale. Accettò uno stipendio di settantacinque dollari con promessa di aumento appena le entrate lo permettessero; prese una camera con bagno allo Schenley; ebbe un suo ufficio al Frick Building, dove sedeva a una scrivania con un giovanotto chiamato Oliver Taylor, nipote di uno dei direttori, che stavano facendo salire a forza nell’azienda. Oliver Taylor era un giocatore di tennis di prim’ordine, apparteneva a tutti i circoli e non era che troppo lieto di lasciar lavorare Moorehouse. Quando seppe che Moorehouse era stato all’estero e s’era fatto fare abiti in Inghilterra, lo fece entrare al Sewickley Country Club e lo portava con
sé a bere, dopo le ore d’ufficio. A poco a poco Moorehouse fece conoscenze e cominciava a venir invitato come scapolo possibile. Si mise a giocare al golf con un istruttore su un piccolo campo ad Allegheny dove sperava non venisse nessuna sua conoscenza. Quando seppe cavarsela bene, andò al Sewickley a provare. Una domenica pomeriggio, Oliver Taylor venne con lui e gli indicò sul campo tutti i grandi dirigenti delle acciaierie, dei terreni minerari e dell’industria del petrolio, emettendo osservazioni ribalde sul conto d’ognuno, che fecero sogghignare un po’ Ward, ma gli parvero di pessimo gusto. Era un pomeriggio di maggio, pieno di sole, e si odoravano i fiori dei carrubi sulla brezza che giungeva dalle grasse terre dell’Ohio e si sentiva il secco colpo delle palle da golf e il fruscio degli abiti vivaci sul prato, intorno al ridotto, e frulli di risate e, portati sulla brezza assolata, che ancora riteneva un po’ dell’arsura fumosa dei forni, brani baritonali del sodo parlare degli uomini d’affari. Faticava a non lasciar scorgere dagli uomini, cui veniva presentato, quanto si sentiva contento. Il resto del tempo non faceva altro che lavorare. Dalla stenografa (la signorina Rodgers, una zitella dal viso ordinario, che conosceva da capo a fondo l’industria dei prodotti metallurgici per aver lavorato quindici anni negli uffici di Pittsburgh) si fece cercare libri su quest’argomento e li leggeva all’albergo la sera, in modo che alle riunioni di dirigenti stupiva tutti con la sua conoscenza dei processi e dei prodotti dell’industria. Aveva la testa piena di trivelle, curvalegno, mazze, piombi d’intelaiatura, scuri, asce, chiavi inglesi; ogni tanto, all’ora del pranzo, entrava in una bottega di ferramenti col pretesto di comprare certi chiodini o puntali e attaccava discorso col negoziante. Leggeva Crowds Jr e vari libri di psicologia, cercava di immaginar se stesso come un negoziante di articoli in ferro o il direttore di Hammacher Schlemmer o di qualche altra grande casa di ferrerie e andava almanaccando che razza di letteratura industriale gli sarebbe in questo caso andata a genio. Radendosi, mentre l’acqua del bagno scorreva al mattino, vedeva lunghe processioni di alari, graticole, suppellettili da forno, pompe, tritacarne, trapani, calibri, viti, girelle, maniglie di cassetti passargli tra la faccia e lo specchio e si chiedeva
come rendere queste cose desiderabili al mercato minuto. Si radeva con un Gillette, e perché si radeva con un Gillette, invece che con un qualche altro tipo di rasoio? Bessemer era un bel nome, che sapeva di denaro, di lamiere poderose, di grandi dirigenti che scendevano da macchine di lusso. Il punto era interessare l’acquirente di questi prodotti, far sì che si sentisse parte di una organizzazione forte e poderosa, pensava, scegliendo una cravatta. “Bessemer” si ripeteva, mangiando la colazione. Perché le nostre copiglie dovrebbero piacere più di qualunque altra copiglia, si domandava, montando sul tram. Mentre sobbalzava tra la calca attaccata alle cinghie e il tram lo portava al centro, mentre fissava senza vederli i titoli nel giornale, anelli di catene, ancore, manicotti, gomiti snodati, attacchi, cappelletti e testiere gli tumultuavano in capo. “Bessemer.” Quando chiese un aumento, l’ebbe, a 125 dollari. A un ballo in un circolo campestre conobbe una bionda, che ballava molto bene. Si chiamava Gertrude Staple, era figlia unica del vecchio Horace Staple, direttore di diverse società e supposto possessore di una gran parte delle azioni della Standard Oil. Gertrude era fidanzata con Oliver Taylor, benché, quand’erano insieme, non facessero altro che bisticciarsi, e così la ragazza fece le sue confidenze a Ward, mentre sedevano in disparte durante un ballo. Ward portava la marsina come dipinta e aveva l’aria molto più giovane di quasi tutti gli uomini presenti. Gertrude disse che gli uomini di Pittsburgh non avevano fascino. Ward parlò di Parigi e lei disse ch’era morta di noia e avrebbe preferito vivere a Nome, in Alaska, piuttosto che a Pittsburgh. Fu contentissima che lui conoscesse Parigi e la Tour d’Argent e l’Hôtel Wagram e il Ritz Bar, e a Ward dispiacque di non avere l’automobile, perché notò che la ragazza gli stava facilitando la richiesta di permetterle di accompagnarla a casa. Ma il giorno dopo le mandò qualche fiore con un biglietto in francese che, pensava, l’avrebbe fatta ridere. Il sabato pomeriggio successivo andò in una scuola di guida per imparare a condurre una macchina e passò all’agenzia Stutz per vedere a quali condizioni poteva comprare una vetturetta. Un giorno Oliver Taylor entrò nell’ufficio con un sorriso buffo in faccia e disse: «Ward, Gertrude ha preso una cotta per voi. Non parla
più d’altro… Fate pure, che non me ne importa un cavolo. A me dà troppi fastidi a trattarla. In mezz’ora sono fuori combattimento». «Probabilmente è perché non mi conosce» disse Ward arrossendo un poco. «Il brutto è che il vecchio non le lascerà sposare altro che un milionario. Un po’ d’amore però, potete farcelo.» «Non ho tempo da perdere in queste cose» disse Ward. «A me non avanza il tempo per nient’altro» disse Taylor. «Be’, salute… Tenete voi la fortezza, io ho un puntello per un pranzetto con una bella ragazza… è un tipo caldo, balla al Red Mill, prima fila, terza da sinistra.» Strizzò l’occhio, diede una manata sulla schiena a Ward e uscì. La volta successiva, quando Ward andò in visita nella gran casa degli Staple addentrata fra gli alberi, ci andò in una rossa Stutz da viaggio, che aveva preso in prova. Se la cavò abbastanza bene, benché voltasse troppo presto e facesse strage di certi tulipani in un’aiuola. Gertrude lo vide dalla finestra della biblioteca e lo canzonò per questo. Ward disse ch’era un pessimo guidatore, che sempre era stato e sempre lo sarebbe stato. Lei gli diede il tè e un cocktail a un tavolinetto sotto un melo, dietro la casa, e Ward, per tutto il tempo che le parlò, continuò a chiedersi se doveva accennarle al proprio divorzio. Le disse della sua vita infelice con Annabelle Strang. Gertrude fu molto comprensiva. Sapeva del dottor Strang. «E io che speravo foste soltanto un avventuriero… da contadinello a presidente, sapete, cose del genere.» «Ma lo sono» disse lui; e tutti e due risero e Ward poté vedere che realmente Gertrude era pazza di lui. Quella notte si trovarono a un ballo e passeggiarono fino in fondo alla serra, dove tra le orchidee faceva un caldo umido, e Ward la baciò e le disse che somigliava a un’orchidea giallo pallido. Dopo quella volta, sempre se la battevano furtivi non appena potevano. Aveva un modo, Gertrude, di afflosciarglisi improvvisa tra le braccia sotto i baci, che lo assicurava del suo amore per lui. Ma di ritorno a casa, dopo quelle serate, era nervosissimo e troppo eccitato per riuscir a dormire, e camminava per la stanza anelando una donna che gli dormisse insieme e maledicendosi. Sovente prendeva un bagno freddo e si
diceva di badare al lavoro e di non occuparsi di quelle cose o lasciarsi entrar nel sangue a quel modo una ragazza. Le vie nei quartieri più bassi della città eran piene di prostitute, ma Ward temeva di pigliarsi qualche malattia o venir ricattato. Poi una notte, dopo una festa, Taylor lo portò in una casa interamente da fidarsi – diceva – dove trovò una ragazza polacca, scura e carina, non più che diciottenne, ma non vi tornò troppo sovente perché gli costava cinquanta dollari e lo faceva sempre star nervoso per paura di un’irruzione della polizia e di dover subire un ricatto. Una domenica pomeriggio, Gertrude gli disse che sua madre l’aveva rimproverata perché si faceva tanto vedere in giro con lui, che aveva avuto una moglie a Filadelfia. La notizia della sentenza era apparsa il mattino precedente. Ward era tutto esultante e glielo disse e le chiese di sposarla. Erano al pubblico concerto d’organo nell’istituto Carnegie, un buon posto per trovarsi, perché nessuno, che fosse qualcuno, ci andava mai. «Venite allo Schenley e vi mostrerò la sentenza.» La musica era cominciata. Gertrude scosse il capo, ma gli batté la mano che lui le poggiava sul sedile di felpa accanto al ginocchio. Uscirono a metà del numero. La musica dava loro sui nervi. Rimasero a parlare a lungo, nel vestibolo. Gertrude aveva un’aria sofferente e dimagrita. Disse che stava molto male di salute, che papà e mamma non le avrebbero mai consentito di sposare un uomo che avesse una rendita inferiore alla sua, che desiderava di essere una povera stenografa o telefonista, da poter fare di sua testa, e che lo amava tanto e l’avrebbe sempre amato e certamente si sarebbe data ai liquori e agli stupefacenti o qualche altra cosa, perché la vita era troppo orribile. Ward fu freddo assai e serrò le mascelle e disse che non era possibile le importasse di lui; quanto a lui quella era la fine e, se ancora si fossero incontrati, sarebbero stati buoni amici. La condusse per Highland Avenue nella Stutz che aveva ancora da pagare, e le mostrò la casa dov’era vissuto appena giunto a Pittsburgh e parlò di andare nell’Ovest e aprire una ditta sua di pubblicità e finalmente la lasciò in casa di un’amica in Highland Park, dove lei aveva detto al suo autista di venirla a prendere alle sei.
Ritornò allo Schenley e si fece portare in camera una tazza di caffè nero e si sentì cattivo e si mise a lavorare a un articolo che stava facendo, ripetendo «al diavolo quella vacca», per tutto il tempo, tra i denti. Non si preoccupò molto di Gertrude nei mesi che seguirono, perché avvenne uno sciopero a Homestead e ci furono scioperanti uccisi dalle guardie delle miniere e certi scrittori di New York e Chicago, gente sentimentale, cominciarono a occupare lunghi spazi nei giornali con articoli che marchiavano l’industria dell’acciaio e le condizioni feudali di vita in Pittsburgh, come le chiamavan loro, e i progressisti al Congresso facevan clamore e si diceva che gente coll’intenzione di farne della politica domandava un’inchiesta del Congresso. Il signor McGill e Ward pranzarono insieme, loro soli, allo Schenley per parlare della situazione e Ward disse che quel che ci voleva era un sistema interamente nuovo nella pubblicità dell’industria. Era interesse dell’industria educare il pubblico con un piano di pubblicità accuratamente tracciato per un giro di anni. Il signor McGill ne fu molto colpito e disse che avrebbe parlato, nelle riunioni dei direttori, della utilità di fondare per tutta l’industria un ufficio comune d’informazioni. Ward disse che gli pareva di dover essere posto lui a capo della cosa, poiché alla Bessemer Products non faceva che perdere tempo; tutto si era abbassato a un lavoro abitudinario, di cui chiunque altro poteva occuparsi. Parlò di andarsene a Chicago e là aprire un’agenzia sua di pubblicità. Il signor McGill sorrise, si lisciò i baffi grigio acciaio e disse: «Non tanto presto, giovanotto, state ancora un po’ qui e vi do la mia parola che non avrete da rimpiangerlo», e Ward disse che c’era disposto, ma insomma, era stato a Pittsburgh cinque anni e che cosa concludeva? L’ufficio d’informazioni si fondò e Ward venne incaricato dei lavori a 10.000 dollari l’anno. Cominciò a giocare un tantino in Borsa col denaro superfluo, ma c’erano vari individui sopra di lui, che prendevano stipendi maggiori e non facevan niente, soltanto gli impedivano la strada, e si sentiva pieno d’irrequietezza. Sentiva di doversi sposare e farsi una casa. Aveva molti rapporti nei differenti rami delle industrie della ghisa, dell’acciaio e del petrolio, e sentiva di
dover dare ricevimenti. Ricevere al Fort Pitt o allo Schenley costava molto e dopo tutto non pareva una cosa seria. Poi, un mattino, aprì il giornale e ci trovò che Horace Staple era morto di angina pectoris il giorno prima, mentre saliva in ascensore nel Carnegie Building, e che Gertrude e sua madre erano affrante, nella loro magnifica residenza di Sewickley. Subito sedette allo scrittoio, benché così facesse tardi per l’ufficio, e scrisse a Gertrude un biglietto: Carissima Gertrude, in questo terribile istante di dolore, permettetemi di rammentarvi che penso a voi continuamente. Fatemi sapere subito se posso esservi di qualche utilità, in qualunque modo. In questa valle di ombre della morte, dobbiamo ben sapere che il Grande Datore, a cui sono dovuti tutti i nostri amori e le ricchezze e gli affetti del giocondo focolare, è anche il Pallido Mietitore… Dopo aver considerato le parole un istante, mordendo il cannello della penna, decise che il “Pallido Mietitore” era un po’ forte e ricopiò il biglietto tralasciando l’ultima frase, lo firmò “il vostro devoto Ward” e lo mandò a Sewickley da un fattorino particolare. A mezzogiorno stava per andarsene a pranzo, quando il ragazzo gli disse che c’era una signora al telefono. Era Gertrude. Aveva la voce tremante, ma non pareva poi così tremendamente sconvolta. Gli chiese di portarla a cena fuori quella sera in qualche luogo, dove nessuno li vedesse, perché la casa e ogni cosa le davano i brividi e sarebbe impazzita a sentire ancora altre condoglianze. Ward le disse di venirlo a incontrare nel vestibolo del Fort Pitt e l’avrebbe portata fuori in macchina in qualche posticino, dove star tranquilli e discorrere. Quella sera c’era un gelido vento turbinoso. Il cielo era stato plumbeo tutto il giorno: nuvole color inchiostro che sbucavano dal Nord-ovest. Gertrude era così imbacuccata di pellicce che Ward non la riconobbe quando entrò nel vestibolo. Gli porse la mano e disse: «Usciamo di qui» appena gli fu vicina. Ward disse che conosceva una piccola locanda sulla strada di McKeesport, ma forse le raffiche eran troppo fredde per lei nella macchina scoperta. Lei disse: «Andiamo,
su… Mi piace la tormenta». Quando salì nell’auto, disse con la voce tremante: «Contento di vedere la vostra antica fiamma, Ward?» e lui disse: «Dio mio, sì, Gertrude, ma voi, siete contenta di vedermi?». E allora lei disse: «Non ho l’aria contenta?». Allora lui cominciò a barbugliare qualcosa sul padre, ma lei: «Fate il favore, non parliamo di questo». Il vento ululò dietro a loro per tutta la strada, lungo la valle del Monongahela, con sferzanti folate di neve ogni tanto. Montagne di carbone e forni Bessemer e alte file di comignoli risaltavano nero inchiostro contro un basso cielo villoso che prendeva tutto il riflesso del metallo fiammeggiante, della scoria rossa, e il bianco delle lampade e dei fari dei treni. A un incrocio stavano per sbattere in un treno di carbone. La mano di Gertrude gli si strinse sul braccio, quando l’auto slittò sui freni serrati. «L’abbiamo scampata bella» disse Ward tra i denti. «Non m’importa. Non m’importa di niente stanotte» disse lei. Ward dovette scendere per avviare la macchina, poiché aveva arrestato il motore. «Andrà bene se non moriremo assiderati» disse. Quando risalì nella macchina, Gertrude gli si piegò e lo baciò sulla guancia. «Volete ancora sposarmi? Vi voglio bene, Ward.» Il motore filava, mentr’egli si voltò e la baciò stretto sulla bocca, nel modo che aveva baciato Annabelle quel giorno nella villetta a Ocean City. «Certo, sì, cara» disse. La locanda era tenuta da una coppia di francesi e Ward parlò in francese con loro e ordinò una cena con pollo e vino rosso e toddies bollenti di whisky per scaldarsi, finché aspettavano. Non c’era altri nella locanda e Ward fece mettere un tavolino proprio in faccia ai ceppi finti, al fondo di una stanza da pranzo in rosa e giallo, scarsamente illuminata, una lunga serie spettrale di tavolini vuoti e di lunghe finestre accecate dalla neve. Durante la cena parlò a Gertrude dei suoi progetti di costituire una sua agenzia e disse che aspettava soltanto di trovare un socio adatto ed era sicuro che ne avrebbe fatto la più grande agenzia del paese, specialmente sotto questo nuovo punto di vista, mai sfruttato, dei rapporti tra capitale e lavoro. «Ma allora io potrò aiutarvi molto con capitali e consigli e tante cose,
quando saremo sposati» disse Gertrude, fissandolo con le guance accese e gli occhi scintillanti. «Certo che potrete, Gertrude.» Gertrude bevette molto durante la cena e volle altri whisky in seguito e Ward le diede molti baci e le mise le mani su per le cosce. Lei pareva non badasse a quel che faceva e lo baciava sotto gli occhi del padrone della locanda. Quando uscirono per risalire in auto e tornare a casa, il vento soffiava a sessanta miglia all’ora e la neve aveva cancellato la strada. Ward disse che sarebbe stato un suicidio, partire per Pittsburgh in una notte simile. Il padrone della locanda disse che aveva una camera bell’e pronta per loro e Monsieur e Madame sarebbero stati pazzi a partire, specialmente visto che avrebbero avuto il vento in faccia per tutta la strada. Allora Gertrude ebbe un istante di panico e disse che si sarebbe uccisa piuttosto che fermarsi. Poi, d’un tratto, si raggomitolò tra le braccia di Ward, singhiozzando istericamente: «Voglio fermarmi, voglio fermarmi, ti amo tanto». Telefonarono a casa Staple e parlarono con l’infermiera, la quale disse che la signora Staple riposava più con calma, aveva preso un narcotico e dormiva tranquilla come un bimbo, e Gertrude le disse che, quando la mamma si svegliasse, le dicesse che lei passava la notte con la sua amica Jane English e che sarebbe stata di ritorno non appena la tormenta avesse loro permesso di mettere un’auto per strada. Poi telefonò a Jane English e le disse che era sconvolta dal dolore e aveva preso una camera al Fort Pitt per star sola. E se la mamma telefonava, di dirle che lei dormiva. Poi telefonarono al Fort Pitt e fissarono una stanza a suo nome. Poi salirono a letto. Ward era felice e decise che l’amava moltissimo, e pareva che lei avesse già fatto altre volte una cosa del genere, perché, prima cosa, disse: «Non abbiamo bisogno di farne un matrimonio alla pistola, vero, caro?». Sei mesi dopo erano sposati e Ward abbandonò il suo posto all’ufficio d’informazioni. Aveva avuto una certa fortuna in Wall Street e decise di prendersi un anno di vacanze in luna di miele in Europa. Si trovò che il patrimonio degli Staple era tutto in mano della signora Staple e a Gertrude sarebbe solo toccata una annualità di quindicimila dollari, fino alla morte della madre, ma i due contavano d’incontrarsi con la vecchia signora a Carlsbad e speravano di cavarle
con le buone un po’ di capitale per la nuova agenzia di pubblicità. Partirono nell’appartamento nuziale sul Deutschland per Plymouth, ebbero una bella traversata e Ward soffrì il mare soltanto un giorno. 1. Una delle logge americane. (NdT) 2. Un’altra delle logge americane. (NdT)
Occhio fotografico (21) quell’agosto non venne una goccia d’acqua e non aveva quasi piovuto neanche in luglio l’orto era in uno stato orribile e per tutto il Northern Neck della Virginia non serviva a nulla raccogliere il foraggio perché le foglie basse erano tutte raggrinzite e arricciate agli orli soltanto i pomodori diedero un raccolto quando non adoperavano Rattler nei lavori dei campi si poteva montarlo era un sauro castrato di tre anni e andava inciampando per l’alto bosco dei pini bianchi e per le strade di sabbia accese piene di rampicanti rosse e per pantani secchi e screpolati a spinapesce come la corazza degli alligatori passava davanti alla casa dei Morris dove tutti i piccoli Morris avevano un’aria secca polverosa scura e girava per la riva del fiume oltre Harmony Hall dove ci sarebbe Sydnor un omaccio di sei piedi e cinque pollici con un muso lungo un naso lungo e una grossa verruca sul naso a strascicarsi in giro scalzo senza sapere che cosa fare per via della siccità e la moglie malata e sul punto di avere un altro bambino e i bambini con la tosse asinina e lui col suo mal di stomaco e ritornava oltre Sandy Pint oltre i grandi pini e la signorina Emily sarebbe a guardare di là dalla palizzata dritta vicino alla mortella (la signorina Emily portava berretti a punta e aveva sempre qualche fiore e un paio di pollastri da vendere e il miglior sangue del Sud le scorreva nelle vene Tancheford lo scriviamo lo pronunciamo Tofford se soltanto quei ragazzi non fossero così disperati sempre a bere e a spassarsela giù per il fiume e a introdurre whisky dal Maryland invece di pescare e a girare ubriachi morti e tagliare o perdere le reti delle trappole la signorina Emily beveva un gocciolo anche lei ogni tanto ma faceva sempre buon viso guardando oltre la palizzata dritta vicino al cespuglio di mortella occupandosi un tantino del prossimo con la gente che passava per la strada) poi a Lynch’s Pint c’era il vecchio Bowie Franklin (neanche lui era molto più d’un disperato pareva un galletto da combattimento Bowie Franklin con il lungo collo scarno e il passo dinoccolato non poteva
fare molto lavoro e non aveva denaro per pagarsi da bere e così allevava i suoi polli grigi disperati che avevano l’aria di Bowie e gironzolava per la calata e qualche volta quando era lì il battello o c’erano dei pescatori nel torrente per via del vento che spadroneggiava nella baia qualcuno gli faceva scorrere un sorso un whisky e Bowie stava un giorno intero a smaltirlo dormendo) Rattler sudava qualcosa di spaventoso sostentato a meliga in una temperatura così soffocante e la vecchia sella puzzava e i mosconi gli ronzavano sui fianchi e veniva ora di cena e si tornava a casa adagio odiando la maledetta regione esausta e la siccità che non lasciava venir su il giardino e le locuste e le libellule canzonanti tra le gomme degli arbusti e i persimmoni resi spettrali dalla polvere lungo la strada e la spiaggia falcata dove le ortiche di mare bruciavano quando si cercava di allontanarsi a nuoto e le larvette e i piccoli ritagli di chiacchiere su quel che accadeva all’Aia o a Varsavia o a Pekatone e il telefono alla villa che sempre suonava ogni volta che la moglie di un contadino della linea staccava il ricevitore per parlare con la moglie di un altro contadino e per tutta la linea si sentivano i ricevitori scattare perché tutti correvano al ricevitore per ascoltare quel che si diceva e la terra tra i fiumi era tutta esausta dal tabacco dei tempi antichi di Walter Raleigh del capitano John Smith di Pocahontas ma che cos’era rispetto alla guerra che esauriva tutto, uomini e donne? e cavalcavo Rattler di tre anni un sauro castrato che incespicava tante volte e odiavo i sabbioni cucinati dal sole e il sottosuolo d’argilla e i pini sfruscianti e le gomme inutili e i cespugli di persimmono e i rovi c’era soltanto la baia che mi piaceva scintillante all’orizzonte e il vento del Sud-est che rinfrescava ogni pomeriggio e le vele bianche dei battelli
Cine-giornale XV si spengono le luci mentre suonano agli avventori Home Sweet Home i salari bassi causano i disordini, dice una donna C’è una ragazza in fondo al Maryland che mi ha donato il cuore O UNA GRANDE GUERRA O NIENTE la mannequin che è così gran parte dello spettacolo nelle corse a Parigi supera se stessa nel lancio delle novità. Sa indossare il costume più sbalorditivo e portarlo con perfetto sangue freddo. L’incoerenza è la sua parola d’ordine Tre ufficiali di stato maggiore tedeschi che passavano vennero quasi lasciati per morti dalla folla entusiasta che volle loro stringer la mano Una Ragazza Pesta Un Cerino; L’Abito In Fiamme; Muore. E il Maryland beato fu un paese incantato quando mi disse che il cuor m’avea donato LE DETONAZIONI DEL DANUBIO SONO IL SEGNALE DELLA LOTTA sono contro la pena capitale come tutte le donne equilibrate. Mi fa orrore pensare che una donna assista a un’impiccagione. È una cosa tremenda da parte dello Stato commettere un assassinio LO ZAR PERDE LA PAZIENZA CON L’AUSTRIA il panico nell’esodo da Carlsbad la scomparsa del maggiore rivela una lunga serie di assassini décolleté alla luce del sole biancheria intima che non può aver avuto nessun contatto con la tinozza. Che cosa si porterà in seguito? Parigi piange ragazzi cantori che vanno al campo professore nei boschi La Caduta di Belgrado LA GUERRA GENERALE È VICINA UN ASSASSINO UCCIDE IL DEPUTATO JAURÈS VIVE PER DUE ORE DOPO CHE È MORTO persi un amico e un compagno quando Garros sacrificò la vita ma credo che perderò altri amici della mia professione prima che questa guerra finisca
BAULI PERDUTI CHE SI RITROVANO A LONDRA le convenzioni di qualunque genere vengono inevitabilmente trascurate o calpestate durante i languidi o riposati giorni dell’estate, e a causa del rilassamento vi sono ora diversi membri del gruppo più giovane, al cui esordio mancano due o tre stagioni, che si godono splendidamente ANCHE IL PAPA NERO È MORTO C’è una ragazza in fondo al Maryland che mi ha donato il cuore
Principe della pace Andrew Carnegie nacque a Dumferline in Scozia venne negli Stati su una nave di emigranti lavorò alle spole in una fabbrica tessile accese caldaie fece l’impiegato in una fabbrica di spole a 2,50 dollari la settimana corse per Filadelfia a portar telegrammi fattorino della Western Union imparò il codice Morse fu operatore telegrafico sulle linee della Pennsylvania fu operatore telegrafico militare nella guerra civile risparmiò sempre il suo stipendio; ogni volta che aveva un dollaro lo investiva. Andrew Carnegie cominciò comprando azioni della Adam Express e della Pullman durante un ribasso improvviso; aveva fiducia nelle ferrovie, aveva fiducia nelle comunicazioni, aveva fiducia nei trasporti, credeva nel ferro. Andrew Carnegie credeva nei ponti di ferro negli stabilimenti Bessemer negli alti forni nelle laminerie Andrew Carnegie credeva nel petrolio Andrew Carnegie credeva nell’acciaio risparmiò sempre il suo denaro ogni volta che aveva un milione di dollari lo investiva Andrew Carnegie divenne l’uomo più ricco del mondo e morì Bessemer Duquesne Rankin Pittsburgh Bethlehem Gary Andrew Carnegie diede milioni per la pace e per biblioteche e istituti scientifici e dotazioni e risparmi ogni volta che guadagnava un miliardo di dollari dotava un’istituzione per promuovere la pace universale sempre eccetto in tempo di guerra.
Occhio fotografico (22) tutta la settimana la nebbia non si staccò dal mare e dagli scogli a mezzogiorno c’era attraverso la nebbia quanto calor solare bastava per mantenere in essiccazione sui graticci il merluzzo salato graticci grigi mare verde case grigie nebbia bianca a mezzogiorno c’era quanto sole bastava per maturare le mele e le pere per intiepidire sulle brughiere le bacche d’alloro e la felce e all’ora dei pasti nella pensione tutti aspettavano gli operatori della radio gli operatori della radio non potevano quasi mangiare sì era la guerra Entreremo noi? Entrerà l’Inghilterra? Le obbligazioni secondo il trattato di… consegnato all’ambasciatore i suoi passaporti tutte le mattine mettevano fuori i merluzzi sui graticci, allargandoli anche in quel fiacco ardore di sole attraverso la nebbia un piroscafo che fischiava in distanza sbattere delle onde contro i pali e lungo le rupi algose strida di gabbiani, acciottolio di piatti nella pensione La guerra dichiarata… Grande Battaglia nel Mar del Nord La Flotta Tedesca Distrutta… LA FLOTTA INGLESE HA DISTRUTTO UNA SQUADRA AL LARGO DEL CAPO RACE Terranovesi fedeli alla bandiera Porto chiuso a St. Johns Port aux Basques e tutte le sere riportavano il merluzzo dai graticci e l’acciottolio dei piatti della pensione e tutti attendevano gli operatori della radio lo sbattere delle onde contro i pali della banchina strida di gabbiani roteanti e piombanti bianchi nella nebbia bianca un piroscafo che fischiava in distanza e tutte le mattine allargavano il merluzzo sui graticci
J. Ward Moorehouse Quando Ward ritornò dalla sua seconda luna di miele all’estero, aveva trentadue anni, ma ne mostrava di più. Possedeva capitali e conoscenze e sentiva che il gran momento era venuto. I discorsi di guerra in luglio lo avevano deciso a troncare il viaggio. In Londra aveva raccolto un giovane di nome Edgar Robbins che era in Europa per l’International News. Edgar Robbins beveva troppo e faceva lo scemo con le donne, ma Ward e Gertrude lo portarono con loro dappertutto e ciascuno confidò all’altro il desiderio di rimettere il giovane sulla buona via. Poi un giorno Robbins prese Ward in disparte e gli disse che aveva la sifilide e che per forza doveva seguire la diritta e angusta via. Ward pensò un poco alla cosa e gli offrì un posto nell’ufficio di New York, che avrebbe aperto appena tornato. Raccontarono a Gertrude ch’erano disturbi di fegato e Gertrude lo sgridava come un bambino, quando quello beveva una volta. Sul piroscafo di ritorno, sentirono che era completamente affezionato a tutti e due. Ward in seguito non ebbe più da scrivere e poteva dedicare tutto il suo tempo a organizzare l’impresa. La vecchia signora Staple era stata indotta a investire cinquantamila dollari nella ditta. Ward prese in affitto un ufficio al n. 100 della Quinta Avenue, lo addobbò con vasi di porcellane cinesi, portacenere orientali in smalto, comperati da Vantine, e nel suo ufficio privato mise un tappeto di pelle di tigre. Serviva il tè, all’inglese, ogni pomeriggio, e si elencò nella guida dei telefoni come “J. Ward Moorehouse, Consulenza di pubblici rapporti”. Mentre Robbins abbozzava gli opuscoli da inviare in giro, Ward si recò a Pittsburgh, Chicago, Bethlehem e Filadelfia a ristabilire i contatti. A Filadelfia stava entrando nel vestibolo di Bellevue Stratford, quando eccoti Annabelle Marie. Lei lo salutò affabilmente e disse che aveva sentito di lui e della sua impresa pubblicitaria; pranzarono insieme, parlando dei tempi andati. «Tu sei certo migliorato» badava a ripetere Annabelle Marie. Ward poté capire che lei rimpiangeva un poco il divorzio, ma quanto a sé era convinto di non poter dire lo stesso. Mostrava le linee sul viso
approfondite, Annabelle Marie, non terminava le frasi, e aveva nella voce una pappagallesca raucedine come di tisi. Era terribilmente truccata e Ward si domandò se non prendesse stupefacenti. Era in faccende per divorziare da Beale che, disse a Ward, si era rivelato omosessuale con lei. Ward disse asciutto che si era sposato un’altra volta e viveva felice. «E chi non lo sarebbe con la fortuna degli Staple sul patto?» disse lei. Quell’arietta da padrona irritava Ward, che appena finito il pranzo fece le sue scuse: doveva andare al lavoro. Annabelle lo guardò attraverso gli occhi semiaperti, con la testa su una spalla, dicendo: «Buona fortuna» e salì nell’ascensore con una risatina stridula. Il giorno dopo Ward prese il Pennsylvania per Chicago, viaggiando in vettura salotto. Vennero con lui la signorina Rosenthal, sua segretaria, e Morton, il domestico inglese. Mangiò il pranzo nel salotto con la signorina Rosenthal, una ragazza smorta in faccia, ma semplice e perspicace, ch’egli sentiva devota ai suoi interessi. Era stata con lui a Pittsburgh, nella Bessemer Products. Quando il caffè venne sparecchiato e Morton ebbe versato a tutti e due un sorso di brandy, sul quale la signorina Rosenthal fece molti sogghigni dichiarando che le avrebbe dato alla testa, Ward cominciò a dettare. Il treno rimbombava e rollava e di tanto in tanto a Ward giungeva l’odor del carbone e dell’ardente corpo, grasso di vapore, della locomotiva in testa al treno, ardente lucido acciaio scagliato in mezzo ai foschi Appalachi. Bisognava parlar forte per farsi udire. Il rimbombo del treno gli faceva vibrare le corde vocali. Dimenticò tutto nelle sue parole… L’industria americana come una macchina a vapore, come la locomotiva ad alto potenziale di un grande treno espresso, scagliata attraverso la notte degli antichi metodi individualistici… Che cosa occorre a una macchina a vapore? La cooperazione, la coordinazione del cervello dell’inventore col cervello del capitalista, che ha reso possibile lo sviluppo di questi prodotti ad alto potenziale… La coordinazione del capitale, l’accumulata energia della razza nella forma del credito sapientemente indirizzato… col lavoro, il prospero e soddisfatto lavoratore americano, al quale le inaudite possibilità del capitale raccolto in grandi società hanno riempito la pentola e dato gli
autotrasporti a buon prezzo, l’assicurazione, l’orario ridotto… una misura di comodità e prosperità ineguagliata sinora nella tragica successione della storia in qualunque regione conosciuta del globo abitabile. Ma dovette cessar di dettare, perché s’accorse che aveva perduto la voce. Mandò la signorina Rosenthal a letto e anche lui si coricò, ma non poté dormire: parole, idee, progetti, quotazioni di Borsa gli si snodavano in testa in un interminabile ticchettio. Il pomeriggio seguente al LaSalle ebbe una visita del giudice Bowie C. Planet. Ward, seduto, attendeva che salisse, guardando fuori il pallidissimo cielo azzurro del lago Michigan. In mano aveva una schedina, dove era scritto: Planet, Bowie C. … Giudice del Tennessee, sposato Elsie Wilson Denver; piccoli interessi rame e piombo… Anaconda? disgraziato speculatore in petrolio… membro meschino studio legale Planet e Wilson, Springfield, Illinois. «Va bene, signorina Rosenthal» disse, quando bussarono all’uscio. La donna uscì nell’altra stanza con la scheda. Morton aprì l’uscio, introducendo un uomo tondo in faccia, con un cappello nero di feltro e un sigaro. «Buon giorno, giudice» disse Ward, alzandosi in piedi e porgendo la mano. «Come va? Accomodatevi.» Il giudice Planet s’avanzò lentamente nella stanza. Aveva un curioso passo rollante, come se soffrisse ai piedi. Si strinsero la mano e il giudice Planet si trovò seduto di fronte alla luce, d’uno splendore d’acciaio, che entrava dalle grandi finestre dietro la scrivania di Moorehouse. «Il signore prende una tazza di tè?» domandò Morton, avanzandosi lentamente con un vassoio, rilucente d’un servizio d’argento. Il giudice fu così sorpreso che si lasciò cadere sul panciotto gonfio la lunga cenere, conservata dal sigaro per dimostrare a se stesso la propria temperanza. Il viso del giudice restò tondo e blando. Era il viso di un villano, dal quale ogni ruga di villania era stata con cura cancellata a forza di massaggi. Il giudice si trovò a sorseggiare una tazza di tè tiepido con latte. «Schiarisce il cervello, giudice, schiarisce il cervello» disse Ward; e
dinanzi la tazza gli si raffreddava intatta. Il giudice Planet tirò silenzioso al suo sigaro. «Bene, signore,» disse «sono contento di vedervi.» In quel momento Morton annunciò il signor Barrow, un individuo ossuto dagli occhi sporgenti e gran pomo d’Adamo sopra una cravatta stiracchiata. Aveva un modo nervoso di parlare e fumava troppe sigarette. Aveva l’aria di esser tutto macchiato di nicotina, giallo in faccia, nelle dita, nei denti. Sul tavolo di Ward c’era un’altra schedina, che diceva: Barrow G.H. rapporti col lavoro, tipo riformista. Stato segret. confratern. Ferrovieri macchinisti; non dà affidamento. Alzandosi in piedi voltò la scheda. Strinse la mano al signor Barrow, se lo collocò di fronte alla luce e lo imbarazzò con una tazza di tè. Poi cominciò a parlare. «Capitale e lavoro,» cominciò con una voce lenta e cauta, come dettasse «come avrete notato nel corso delle vostre inutili e svariate carriere, capitale e lavoro, queste due grandi forze della nostra vita nazionale, nessuna delle quali può esistere senza l’altra, si vanno scostando sempre più; una qualsiasi occhiata superficiale ai giornali ve lo dirà. Orbene, ho pensato che uno dei motivi di questo disgraziato stato di cose fosse l’assenza di una agenzia privata la quale potesse equamente presentare la situazione al pubblico. L’assenza di una ben distribuita informazione è la causa di massima parte dei malintesi in questo mondo. I grandi capi del capitale americano, come probabilmente voi sapete, signor Barrow, credono fermamente nel buon gioco e nella democrazia e non sono che troppo disposti di dare al lavoratore la sua parte nei profitti dell’industria, purché vedano un modo di farlo serbando giustizia al pubblico e all’investitore. Dopo tutto il pubblico è l’azionista che noi tutti siamo qui per servire.» «Talvolta,» disse il signor Barrow «ma non…» «Forse, signori, gradite un whisky al selz.» Il domestico dai capelli lucidi stava tra loro, con un vassoio di boccali, di bicchieroni pieni di ghiaccio e di bottiglie aperte di apollinaris. «Magari» disse il giudice Planet. Il domestico camminò via, lasciandoli ciascuno con un bicchiere
tintinnante. Fuori, il cielo cominciava a soffondersi del bagliore serotino. L’aria era violacea nella stanza. I bicchieri misero più brio. Il giudice masticava l’estremità di un nuovo sigaro. «Dunque, sentite se vi ho ben compreso, signor Moorehouse. Voi pensate, per mezzo dei vostri appoggi con la pubblicità e l’alto mondo degli affari, di aprire un nuovo campo sotto forma di un’agenzia per comporre pacificamente e all’amichevole i conflitti col lavoro. E adesso come vorreste agire?» «Sono certo che il lavoro organizzato vorrebbe cooperare a un simile movimento» disse G.H. Barrow, piegandosi innanzi all’orlo della poltrona. «Se solo potessero esser sicuri che… insomma che…» «Che non gli dessero del fumo negli occhi» disse il giudice ridendo. «Precisamente.» «Ebbene, signori, io giocherò a carte scoperte. Il grande motto sul quale ho fondato i miei affari è sempre stato la cooperazione.» «Certamente sono con voi quanto a questo» disse il giudice, tornando a ridere e battendosi sul ginocchio. «La questione difficile è come attuare questo felice stato di cose.» «Ebbene, il primo passo è di stabilire contatti. Proprio in questo momento, sotto i nostri stessi occhi, noi vediamo che si è stabilito un amichevole contatto.» «Debbo ammetterlo» disse G.H. Barrow con un riso sforzato. «Non mi sarei mai aspettato di bere un bicchiere con un membro dello studio Planet e Wilson.» Il giudice si batté la grossa coscia. «Intendete per via di quei pasticci del Colorado…? Non abbiate timore. Non vi divorerò, signor Barrow… Ma, francamente, signor Moorehouse, non mi pare questo il momento adatto per lanciare il vostro progettino.» «Questa guerra in Europa…» cominciò G.H. Barrow. «È la grande occasione dell’America… Conoscete il proverbio dei due litiganti… Presentemente posso ammettere che ci troviamo nell’ora del dubbio e della disperazione, ma appena gli affari americani si riprenderanno dal primo sconquasso e cominceranno ad assestarsi… Signori, partivo appunto dall’Europa, mia moglie e io
partivamo il giorno che la Gran Bretagna dichiarò la guerra… Posso dire che l’abbiamo scampata bella… Di una cosa sola posso assicurarvi con relativa certezza: chiunque vinca, l’Europa sarà economicamente rovinata. Questa guerra è la grande occasione dell’America. Il fatto stesso della nostra neutralità…» «Non vedo chi se ne vantaggerà, se non i produttori di munizioni» disse G.H. Barrow. Ward parlò a lungo, poi guardò l’orologio che gli stava davanti, sul tavolo, e sorse in piedi. «Signori, temo mi dobbiate scusare. Ho appena il tempo di vestirmi per il pranzo.» Morton era già accanto al tavolo coi cappelli dei due. S’era fatto scuro nella stanza. «Accendete su, Morton» disse secco Ward. Uscendo, il giudice Planet diceva: «Be’, son state quattro chiacchiere piacevolissime, signor Moorehouse, ma temo che i vostri piani siano un tantino idealistici». «Raramente ho sentito un uomo d’affari parlare con tanta simpatia e comprensione della situazione operaia» disse G.H. Barrow. «Non faccio che esprimere i sentimenti della mia clientela» disse Ward, accomiatandosi con un inchino. Il giorno dopo parlò a un pranzo al Rotary sull’argomento “Disordini operai: come se ne potrà uscire”. Sedeva a una tavola nella gran sala dei banchetti dell’albergo, piena di odori di cibo e di sigarette e di camerieri scorrazzanti; sedeva allargandosi il cibo nel piatto con la forchetta, dando risposta a chi lo interrogava, scambiando qualche facezia col giudice Planet che gli stava di fronte, tentando di formulare frasi nella nebbia di parole che aveva in testa. Finalmente fu il momento di alzarsi in piedi. Dritto all’estremità della lunga tavola, con un sigaro in mano, guardò le due file di facce dalle grosse mascelle, che si volgevano a lui. «Quando ero ragazzo, laggiù sul Delaware…» si fermò. Un tremendo frastuono di piatti veniva da dietro le porte volanti, per cui ancora correvano camerieri con vassoi. L’uomo che era andato alla porta a zittirli ritornò a passi leggeri. Se ne sentivano le scarpe scricchiolare sul pavimento di legno. Qualcuno si piegò innanzi lungo la tavola. Ward ricominciò. Adesso procedeva, non sapeva quasi quel che dicesse, ma li aveva fatti ridere una volta. La tensione si rilassò. «Il
mondo americano degli affari è stato lento nel profittare delle possibilità della moderna pubblicità… l’educazione del pubblico e dei datori di lavoro e d’opera, tutti ugualmente servi del pubblico… la cooperazione… azioni che diano al dipendente un interesse nell’industria… evitando i gravi pericoli del socialismo, della demagogia e peggio… È in una situazione simile che la consulenza dei pubblici rapporti può entrare calma ed energica a dire cari signori discutiamo di questo a quattr’occhi… Ma la sua maggior importanza è in tempi di pace industriale… quando due ce l’hanno e stan per suonarsele, non è il momento di predicargli l’utilità pubblica… Il momento di una campagna educativa e di una crociata oratoria, che penetrerà fino agli strati più bassi del poderoso colosso della moderna industria americana, è proprio questo, oggi.» Ci fu un subisso di applausi. Ward sedette e cercò col suo azzurro sorriso la faccia del giudice Planet. Il giudice Planet aveva l’aria colpita.
Occhio fotografico (23) l’amica di mammà era una donnina tanto carina dai bei capelli biondi e aveva due figlie graziose quella bionda sposò un industriale petrolifero dalla zucca pelata e andò a stabilirsi a Sumatra quella bruna sposò uno di Bogotá e fu un lungo viaggio in piroga su per il fiume Magdalena e i nativi erano indiani e dormivano nelle amache e avevano malattie così tremende e quando la donna aveva un bambino era il marito che si metteva a letto e usavano frecce avvelenate e se ti capitava una ferita in quelle zone non guariva mai ma suppurava diventava bianca e marciva e la piroga si capovolgeva così facilmente nella calda acqua fumante piena di pesci famelici che se avevi addosso una scalfittura o una ferita non rimarginata era l’odor del sangue ad attirarli a volte facevano la gente a brani otto settimane ci volevano per risalire in piroga il fiume Magdalena e poi si arrivava a Bogotá il povero Jonas Fenimore tornò da Bogotá molto malato e si diceva che fosse elefantiasi lui era un buon diavolaccio e raccontava tante cose sulla giungla vaporante e gli uragani e i coccodrilli e le malattie orrende e i pesci famelici e si scolava tutto il whisky che c’era in dispensa e quando nuotava gli si potevano osservare sulle gambe certi noduli ispessiti e bruni come le galle sulle mele e gli piaceva il whisky e diceva sempre che la Colombia diventava uno dei paesi più ricchi del mondo e il petrolio e boschi unici al mondo quanto a cacciagione e farfalle tropicali ma il viaggio lungo il fiume Magdalena fu troppo lungo e troppo caldo e troppo pericoloso e lui morì
Cine-giornale XVI il filadelfiano aveva compiuto il tredicesimo giro e si trovava già di due miglia nel quattordicesimo. Si crede che la sua velocità fosse tra cento e centodieci miglia all’ora. La sua automobile ondeggiò un attimo e poi ripiombò a sinistra. Batté in un leggero rialzo di terreno e saltò. Quando l’automobile ricadde, fu sulle quattro ruote in cima a un alto argine. La sua spinta apparentemente non aveva trovato arresti. Wishart sterzò la macchina via dall’argine e cercò di riguadagnare la strada. La velocità, però, non permetteva la leggera svolta necessaria e l’automobile percorse il cortile rustico di un contadino dimorante sulla pista. Wishart evitò un albero, ma si trovò portato lateralmente contro un altro. Le gambe imbrogliate nei comandi gli vennero strappate dal tronco, mentre lui volava fuori Voglio andare nel Messico, vi dico, sotto le stelle e strisce a combattere il nemico PRENDE L’ISTANTANEA; MUORE le allegre seggioline e i tavolini stanno abbandonati sul marciapiedi perché c’è poca gente che si senta tanto ricca da permettersi anche un solo bicchierino L’IDRAULICO DAI CENTO AMORI PORTA SCIMMIE A CASA il rettore mancante ritrovato perdite nel resoconto dei raccolti lasciate andar nudo il bambino se volete che sia sano se mai questo mistero sarà risolto troverete che c’è una donna in fondo al mistero disse il poliziotto della ronda F.G. Garfinkle gli avvenimenti che portarono alla guerra attuale risalgono senza soluzione di continuità alla Rivoluzione francese UNIVERSITÀ CHE ESPELLE IL CHEWING GUM parvero barcollare come ubriachi colpiti d’improvviso tra gli occhi, dopo di che presero a correre verso di noi urlandoci chi sa che grido esotico che non potemmo comprendere E le donne dell’harem sapevano questi veli come si portavano al palazzo di Bagdad nei tempi passati.
Eleanor Stoddard Appena giunte a New York, Eleanor, che non era mai stata all’Est, dové dipendere da Eveline in ogni cosa. Freddy le venne a incontrare al treno e le portò a fissar le camere al Brevoort. Disse che era un po’ lontano dal teatro, ma molto più interessante che un albergo di quegli altri paraggi; tutti gli artisti, i radicali e la gente davvero interessante venivano qui; era un luogo molto francese. Viaggiando in tassì, Freddy cicalò del dramma bello e magnifico e della parte stupenda che ci aveva lui, e che idiota fosse il direttore Ben Freelby e che uno dei sostenitori non aveva versato che metà dei soldi promessi; ma Josephine Gilchrist, l’economa, aveva ora la somma virtualmente incassata e se ne interessavano gli Shubert e si sarebbe esordito fuori città, a Greenwich, entro un mese giusto da oggi. Eleanor guardava la Quinta Avenue, il freddo vento primaverile che alzava le gonnelle alle donne, un uomo che rincorreva la bombetta, gli omnibus verdi, i tassì, lo splendore delle vetrine; dopo tutto non era molto diverso da Chicago. Ma a pranzo, al Brevoort, fu molto diverso. Freddy pareva conoscer tanta gente e le presentava a tutti come se ne fosse orgoglioso. Erano tutti nomi che Eleanor aveva sentiti o letti nella sezione letteraria del «Daily News». Tutti parevano cordialissimi. Freddy parlò in francese col cameriere e la salsa hollandaise era la più squisita che lei avesse mai mangiato. Quel pomeriggio, recandosi alla prova, Eleanor diede la prima sbirciata a Times Square attraverso il finestrino del tassì. Nel teatro buio trovarono la compagnia seduta, in attesa del signor Freelby. Era una scena misteriosissima, con soltanto una unica grossa lampadina elettrica penzolante sul palco e gli scenari di chi sa che altro spettacolo tutti piatti e impolverati. Entrò un uomo grigio con una larga faccia malinconica e vasti cerchi sotto gli occhi. Era il famoso Benjamin Freelby; aveva uno stracco modo di fare, paterno, e invitò per quella sera Eveline e Eleanor a cena da lui, insieme con Freddy, affinché parlassero a loro agio delle scene e dei costumi. Per Eleanor fu un sollievo trovarlo così gentile e pensò che dopo tutto lei ed Eveline vestivano molto meglio
di una qualunque di quelle attrici di New York. Il signor Freelby fece un gran baccano perché non c’era luce; pretendevano che provasse al buio? Il direttore di scena, col manoscritto in mano, corse dattorno in cerca dell’elettricista e si mandò qualcuno a telefonare all’ufficio. Il signor Freelby passeggiava per il palco smaniando e sfuriando e diceva: «È mostruoso». Quando l’elettricista arrivò, forbendosi la bocca col dorso della mano, e accese finalmente le lampade della sala e qualche riflettore, il signor Freelby ebbe bisogno di un tavolino, di una sedia e di una lampadina per leggere sul tavolino. Nessuno pareva capace di trovargli una sedia all’altezza giusta. Quello continuava a smaniare in su e in giù, dandosi strattoni ai rudi capelli grigi e dicendo: «È mostruoso». Finalmente fu a posto e disse al signor Stein, direttore di scena, un individuo sparuto, seduto vicino a lui su un’altra sedia: «Cominceremo dal primo atto, signor Stein. Ha ciascuno la sua parte?». Alcuni attori salirono sul palco e si disposero e gli altri parlottavano a voce bassa. Il signor Freelby li zittì e disse: «Fate il favore, ragazzi, bisogna star cheti» e la prova cominciò. Da quel momento in avanti, tutto fu un rompicollo terribile. Pareva che Eleanor non andasse più a letto. Lo scenografo, il signor Bridgeman, negli studi del quale si dipingevano le scene, trovava da ridire su tutto; venne fuori che qualcun altro, un giovanotto smorto dagli occhiali, che lavorava per il signor Bridgeman, avrebbe dovuto disegnare le scene sui loro abbozzi e che i loro nomi non sarebbero apparsi affatto nel programma, eccetto per i costumi, poiché loro non appartenevano all’Unione degli scenografi. Quando non altercavano agli Studi Bridgeman, correvano per le vie in tassì con campioni di materiale. Mai si andava a letto prima delle quattro o cinque del mattino. Tutti erano così nevrastenici e a Eleanor toccava fare tutte le settimane un assedio vero e proprio alla signorina Gilchrist, per strapparle un assegno. Quando i costumi furon pronti, tutti in stile antico vittoriano, e andarono Eleanor con Freddy e il signor Freelby a vederli dai fornitori, li trovarono veramente belli, ma i fornitori non volevano consegnarli senza un assegno e nessuno riusciva a metter le mani sulla signorina Gilchrist e tutti scorrazzavano in tassì e alla fine, a notte
inoltrata, il signor Freelby disse che avrebbe emesso lui un suo assegno personale. La compagnia trasporti aveva i carri alla porta con le scene, ma non lasciava portar le quinte in teatro se non dietro un assegno. C’era anche il signor Bridgeman che diceva che gli era ritornato l’assegno rescritto “a vuoto”, e lui e il signor Freelby s’insultarono nell’ufficio del teatro. Finalmente comparve Josephine Gilchrist in tassì con cinquecento dollari in contanti per il signor Bridgeman e per la compagnia trasporti. Tutti s’aprirono a un sorriso, quando videro gli allegri biglietti arancione. Fu un grande sollievo. Quando furono assicurati che le scene entravano in teatro, Eleanor, Eveline, Freddy Seargeant, Josephine Gilchrist e il signor Freelby andarono da Bustanoby a mangiare un boccone e il signor Freelby offrì un paio di bottiglie di Pol Roger e Josephine Gilchrist disse che se lo sentiva nelle ossa che il dramma sarebbe stato un successo e la cosa non le capitava sovente, e Freddy disse che agli inservienti piaceva e questo era sempre un buon segno, e il signor Freelby che Ike Gold, il fattorino di Shubert, aveva assistito a tutta la prova con le lacrime giù per le guance, ma nessuno sapeva in che teatro avrebbero recitato dopo una settimana a Greenwich e una a Hartford e il signor Freelby disse che sarebbe andato a parlarne personalmente a J.J. per prima cosa l’indomani mattina. Telefonarono amici di Chicago che volevano assistere alla prova dei costumi. Ciò diede a Eleanor un grande senso d’importanza, specialmente quando telefonò Sally Emerson. La prova dei costumi si strascinò terribilmente, metà delle scene non erano ancora arrivate e i contadini del Wessex non avevano ancora il costume, ma tutti dissero ch’era un buon segno quando la prova dei costumi andava male. La sera della prima, Eleanor non cenò e non ebbe che mezz’ora per vestirsi. Era tutta agghiacciata dall’agitazione. Sperò che il nuovo abito da sera di tulle chartreuse che aveva ordinato a Tappé mostrasse bene, ma non ebbe il tempo di preoccuparsene. Bevette una tazza di caffè nero e le parve che il tassì non sarebbe giunto mai più a destinazione. Quando arrivò al teatro, l’entrata era tutta illuminata e piena di cilindri e schiene nude incipriate e diamanti e mantelli da sera, e tutti i primaioli si guardavano e accennavano agli amici e
parlavano di chi c’era e continuarono ad ammucchiarsi nel corridoio a mezza strada, durante tutto il primo atto. Eleanor e Eveline stavano irrigidite a fianco a fianco in fondo al teatro e si toccavano col gomito, quando un costume mostrava bene, e convennero che gli attori erano pietosi e Freddy Seargeant il peggio di tutti. Al ricevimento che Sally Emerson diede per loro in seguito, nell’alloggio studio delle sue conoscenze, i Carey, tutti dicevano che scene e costumi erano belli e che certamente il dramma avrebbe avuto un grande successo. Eleanor ed Eveline erano il centro di ogni cosa ed Eleanor si seccò alquanto, perché Eveline bevette un po’ troppo e fu chiassosa. Eleanor conobbe una folla di gente interessante e decise di fermarsi a New York a qualunque costo. Il dramma cadde dopo due settimane e Eleanor e Eveline non ebbero mai i settecentocinquanta dollari che la direzione doveva loro. Eveline ritornò a Chicago ed Eleanor prese in affitto un alloggio nell’Ottava Avenue. Sally Emerson aveva deciso che Eleanor aveva un grande ingegno e riuscì a far destinare mille dollari da suo marito al lancio della sua impresa di decorazioni in New York. Il padre di Eveline Hutchins stava male, ma Eveline scrisse da Chicago che sarebbe ritornata con lei appena possibile. Finché Sally Emerson si fermò a New York quell’estate, Eleanor uscì sempre insieme a lei e fece la conoscenza di molta gente ricca. Fu per mezzo di Alexander Parson che ebbe l’incarico di decorare la casa che i Moorehouse costruivano vicino a Great Neck. La signora Moorehouse passeggiò con lei per l’alloggio non ancor finito. Era una bionda slavata e badava a spiegare che avrebbe atteso lei stessa alla decorazione, soltanto che, da quando era stata operata, non ne aveva più avuto la forza. Era stata in letto quasi sempre, dal tempo del suo secondo bambino, e raccontò a Eleanor per disteso l’operazione. Eleanor detestava sentir parlare di disturbi femminili e annuiva freddamente di tanto in tanto, facendo commenti tecnici sui mobili e sulle tappezzerie, ogni tanto prendendo appunti professionali su un pezzo di carta. La signora Moorehouse la pregò di fermarsi a pranzo nella villetta, dove avrebbe abitato finché la casa fosse terminata. La villetta era una casona in stile olandese coloniale, piena di cani
pechinesi e cameriere con grembiale a falpalà e un maggiordomo. Entrando in sala da pranzo, Eleanor sentì la voce di un uomo in una camera vicina e annusò fumo di sigaro. A pranzo venne presentata al signor Moorehouse e a un certo signor Perry. Avevano giocato al golf e stavano parlando di Tampico e di pozzi di petrolio. Il signor Moorehouse si offrì di ricondurla in macchina in città dopo il pranzo e Eleanor provò sollievo a liberarsi dalla signora Moorehouse. Non le avevano ancor lasciato modo di esprimere le sue idee sulla decorazione della nuova casa, ma salendo il signor Moorehouse le fece molte domande in proposito e risero insieme di quant’eran brutte le case dei più ed Eleanor pensò che era molto interessante trovare un uomo d’affari che si occupasse di queste cose. Il signor Moorehouse le suggerì di preparare i preventivi e portarglieli all’ufficio: «Va bene giovedì?». Giovedì andava bene e il signor Moorehouse non aveva impegni quel giorno e, se lei voleva degnarsi, potevano mangiare insieme un boccone. «Le ore dei pasti sono le sole che posso dedicare alle cose dello spirito» disse con un lampo azzurro negli occhi, e così tutti e due ripeterono «giovedì», quando depose Eleanor all’angolo dell’Ottava Avenue con la Quinta Avenue. Eleanor pensò che quell’uomo aveva l’aria di possedere un certo senso umoristico e le piaceva molto più che non Tom Custis. Eleanor trovò che ci volevano molti incontri con Ward Moorehouse, via via che i lavori procedevano. Lo invitò a pranzo a casa sua nell’Ottava Avenue e fece preparare alla cameriera Augustine, della Martinica, pollo sauté con pepe di Caienna e pomodori. Presero cocktail con absinthe e una bottiglia di ottimo borgogna, e Ward Moorehouse amava abbandonarsi sul divano e parlare e lei amava star a sentire, e cominciò a chiamarlo J.W. Dopo di ciò, furono amici, e questo non aveva niente a che fare coi lavori della casa a Great Neck. Raccontò a Eleanor che lui era stato da ragazzino a Wilmington, Delaware e del giorno che la milizia aveva sparato sul vecchio negro avendolo scambiato per la flotta spagnola; raccontò del suo primo infelice matrimonio e che la seconda moglie era un’invalida, e del suo lavoro di giornalista e di impiegato pubblicitario, ed Eleanor, in un
abito bigio con un semplice tocco di colore risplendente sulla spalla, aveva l’aria di una così discreta e silenziosa personcina, che lui le spiegò il lavoro cui attendeva: tenere il pubblico informato sulla situazione dei rapporti tra capitale e lavoro e far fronte alla propaganda dei sentimentali e dei riformatori, sostenendo idee americane contro le insensate idee socialiste tedesche e le panacee del contadinume nord-occidentale malcontento. Eleanor giudicò queste idee molto interessanti, ma preferiva sentirlo parlare della Borsa e di come era stata fondata la Steel Corporation e delle difficoltà delle compagnie di petroli nel Messico e di Hearst e delle grandi fortune. Gli chiese consigli per un certo piccolo investimento che andava facendo e lui sollevò a fissarla gli occhi azzurri scintillanti in un bianco volto fermo, dove la prosperità cominciava allora a incurvare la quadratezza della mascella, e disse: «Signorina Stoddard, posso aver l’onore di diventare il vostro consigliere finanziario?». A Eleanor parve che quel leggero accento meridionale e quei modi signorili di vecchia scuola fossero molto attrattivi. Avrebbe voluto possedere un alloggio più distinto e conservare qualcuno dei candelabri di cristallo che aveva venduti. Fu mezzanotte, prima che Moorehouse se ne andasse, dicendo che aveva passato una bella serata ma che doveva rispondere a certe telefonate da fuori. Eleanor sedette davanti allo specchio, al suo tavolo di toeletta, strofinandosi crema in faccia alla luce di due candele. Desiderò di non avere il collo così scarno e si chiese come sarebbe stata dandosi ogni tanto, quando si lavava i capelli, una risciacquata all’henné.
Occhio fotografico (24) pioveva nella storica Quebec pioveva sul Château nella storica Quebec dove in una litografia il prode Wolfe dal tricorno sedeva su una barca e leggeva ai suoi uomini l’Elegia di Gray il prode Wolfe su per le balze a incontrare il prode Montcalm dal tricorno sulle pianure di Abraham con fiocchetti elaborati e orli di pizzo sulle uniformi nei quadrati vuoti e la cortesia e il comando di fuoco e gli orli di pizzo rovinati nel fango sulle pianure di Abraham ma il Château era il Château Frontenac locanda famosa in tutto il mondo storica nella pioggia grigia nella storica grigia Quebec e noi si saliva per Saguenay Piroscafo Panoramico Massimo Percorso Panoramico nel Mondo il conferenziere Chautauqua e la moglie e il baritono di Athens Kentucky dove hanno una collina che si chiama l’Acropoli esattamente come in Athens Grecia e cultura e la riproduzione del Partenone esattamente come in Athens Grecia pioggia di pietra su vie di pietra e fuori sulla banchina e il San Lorenzo gente coi paracqua dritti che passeggiano avanti e indietro sulla larga banchina di legno nella pioggia guardando i tetti di Quebec d’ardesia a punta e le calate del carbone e i silos del grano e le chiatte e l’Empress of Irland coi fumaioli color crema fumante giunta dall’Altra Sponda e Levis e colline verdi al di là del fiume e l’isola d’Orléans verde sul verde e la pioggia petrigna sui lucidi grigi tetti di Quebec d’ardesia a punta ma il conferenziere Chautauqua vuole il pranzo e litiga con la moglie e fa una scenata nella storica sala da pranzo dello storico Château Frontenac e giunge il maggiordomo e il conferenziere Chautauqua è un uomo grosso spesso coi capelli ricci furibondo con una voce abituata a schiamazzare nelle tende sull’Acropoli come in Athens Grecia e il Partenone come in Athens Grecia e la Vittoria Alata e il baritono ha troppi riguardi per il ragazzino che vuole andarsene e vorrebbe non aver detto che veniva e vuole liberarsi di tutto il gruppo ma piove nella storica Quebec e passeggiando per la via solo col baritono quello continuava a ripetere quante donne di malaffare c’erano in una città come questa e i ragazzi non dovevano andare con
le donne di malaffare e l’Acropoli e il bel canto e il Partenone e la cultura della voce e le belle statue di ragazzi greci e la Vittoria Alata e le belle statue ma finalmente me ne liberai e andai in tram a vedere le cascate di Montmorency famose nella poesia e nella storia e una chiesa piena di grucce lasciate dai malati a St. Anne de Beaupré e le grigie strade piovose piene di ragazze
Janey Nel secondo anno della Guerra europea il signor Carroll vendette i suoi interessi nella ditta Dreyfus e Carroll al signor Dreyfus e andò a stare a Baltimora. C’era una possibilità che il congresso democratico dello Stato lo nominasse governatore. Janey ne sentiva la mancanza all’ufficio e seguì tutti i resoconti politici del Maryland con grande interesse. Quando il signor Carroll non ebbe la nomina, Janey soffrì molto per lui. Per l’ufficio c’erano sempre più stranieri e i discorsi vi presero una piega chiaramente germanofila, che a Janey non piaceva niente. Il signor Dreyfus era molto gentile e generoso coi suoi dipendenti, ma Janey non poteva levarsi di testa la spietata invasione del Belgio, le atrocità orrende, e non voleva lavorare per un unno, tanto che cominciò a cercarsi in giro un altro posto. Gli affari erano fiacchi a Washington e lei sapeva che era una sciocchezza lasciare il signor Dreyfus, ma non poté tenersi e andò a lavorare per Smedley Richard, agente di immobiliari, in Connecticut Avenue a un dollaro di meno per settimana. Il signor Richard era un omone, che parlava sempre dei doveri del gentiluomo e le fece la corte. Per un paio di settimane, Janey lo tenne in rispetto, ma, la terza, quello bevette e cominciava a metterle addosso le grosse mani bovine, e un giorno le chiese un dollaro in prestito e alla fine della settimana disse che per un giorno o due non avrebbe potuto pagarla, così Janey non fece altro che non ritornare e fu disoccupata. Faceva paura esser disoccupati; Janey era atterrita all’idea di dover ritornare a vivere da sua madre tra i pensionanti e i modi strepitosi delle sorelle. Leggeva gli avvisi nello «Star» e nel «Post» tutti i giorni e si rivolgeva a tutti quelli che trovava, ma c’era sempre qualcuno arrivato avanti lei, benché si presentasse all’indirizzo per prima cosa ogni mattina. Segnò persino il suo nome in un’agenzia d’impiego. La donna alla scrivania era una tale corpulenta, dai denti guasti e dal sorriso cattivo, fece pagare a Janey due dollari come tassa di registrazione, le mostrò la lista giacente di stenografe esperte e disse che le ragazze dovevano sposarsi e che cercare di guadagnarsi da vivere eran storie e sciocchezze, perché non si poteva. L’aria viziata
della stanza e i visi contratti delle ragazze in attesa su panche la facevano star proprio male e così andò a sedersi un po’ al sole in Lafayette Square, raccogliendo tutto il suo coraggio per informare Alice, che era ancora con la signora Robinson, di non aver sinora trovato un impiego. Un giovanotto rosso in viso le sedette accanto e tentò di attaccare discorso; così lei dovette alzarsi e camminare. Entrò in uno spaccio e prese una cioccolata al latte, ma l’inserviente cercò di scherzare e lei scoppiò a piangere. L’inserviente fece una faccia atterrita e disse: «Vi chiedo scusa, signorina, non volevo offendere». Aveva ancora gli occhi rossi, quando incontrò Alice che usciva dal Riggs Building; Alice volle pagarle un pranzetto da trentacinque cents al Brown Teapot, benché Janey non avesse voglia di mangiare nulla. Alice aveva un’aria da Lodicevoio che esasperò Janey e disse che era troppo tardi ormai per cercar di tornare dalla signora Robinson, perché la signora Robinson non aveva più tutto il lavoro che aveva una volta per le sue ragazze. Quel pomeriggio, Janey si sentiva troppo giù per cercar lavoro e vagabondò per l’istituto smithsoniano cercando di interessarsi dei campioni di perleria indiana, delle canoe da guerra e dei pali da totem, ma ogni cosa le dava fastidio e risalì in camera sua e pianse a calde lacrime. Pensò a Joe e Jerry Burnham e chi sa perché non riceveva da loro mai lettere, e pensò ai poveri soldati nelle trincee e si sentì sola. Quando Alice fu a casa, lei si era già lavata la faccia e dato cipria e rossetto e si affaccendava svelta per la stanza; canzonò l’amica sulla depressione economica e disse che, se non trovava un impiego a Washington, sarebbe andata a Baltimora o New York o Chicago a cercarlo. Alice disse che quei discorsi la facevano disperare. Uscirono e per risparmiare presero come cena un pane ripieno al salame e un bicchiere di latte. Tutto l’autunno, Janey girò cercando lavoro. Arrivò al punto che prima cosa di cui era conscia al mattino svegliandosi era il nero abbattimento di chi non ha nulla da fare. Mangiò il pranzo natalizio con madre e sorelle e disse loro che le avevan promesso venticinque settimanali per dopo Capodanno, lo disse per impedire loro di farle coraggio. Non voleva dare quella soddisfazione. A Natale, ricevette dalla posta un pacco in carta strappata, da parte
di Joe, con dentro un chimono ricamato. Riesaminò più e più volte tutto il pacco sperando di trovarci una lettera, ma non c’era altro che un pezzetto di carta con sopra scarabocchiato “Buon Natale”. Il pacco era timbrato Saint-Nazaire in Francia e aveva a stampa OUVERT PAR LA CENSURE. Le fece sentire vicinissima la guerra e sperò che Joe laggiù non fosse nei pericoli. Un gelido pomeriggio di gennaio Janey, mentre era distesa sul letto leggendo La vita è fatta così, sentì la voce della signora Baghot, la padrona di casa, che la chiamava. Ebbe paura fosse per l’affitto che quel mese non avevano ancor pagato, ma era Alice al telefono. Alice le disse di venire senz’altro, ché c’era uno che telefonava di aver bisogno di una stenografa per qualche giorno. Nessuna delle ragazze era presente e Janey avrebbe ben potuto andar a vedere, se quel lavoro lo voleva. «Che indirizzo? vado subito.» Alice le diede l’indirizzo. La voce dell’amica all’altro capo del filo vacillava per l’agitazione. «Ho tanta paura… se la signora Robinson se ne accorge, sarà furente.» «Non pensarci, spiegherò io a quel tale» disse Janey. Quel tale era al Continental Hotel in Pennsylvania Avenue. Aveva una camera da letto e un salotto sparpagliati di fogli scritti a macchina e di opuscoli avvolti in carta. Portava occhiali cerchiati di tartaruga, che continuamente si toglieva e metteva, come non fosse ben sicuro se ci vedeva meglio con o senza. Si mise a dettare senza guardar Janey, appena lei si fu tolta il cappello ed ebbe preso taccuino e matita dalla borsetta. Parlava a scatti, come se facesse un discorso, camminando nel contempo avanti e indietro, sulle lunghe gambe sottili. Era un qualche articolo da segnare “per immediata pubblicazione” tutto su capitale e lavoro e le otto ore e la confraternita dei Macchinisti ferrovieri. Fu con un leggero senso di scontento che Janey dedusse che si doveva trattare di un capopartito operaio. Quand’ebbe finito di dettare, uscì bruscamente dalla stanza e le disse per favore di dattilografarlo al più presto, lui sarebbe tornato in un attimo. C’era sul tavolo una Remington, ma Janey dovette cambiare il nastro e scrisse in gran fretta per paura che quello tornasse e non trovasse finito. Poi stette là seduta in attesa con l’articolo e le copie tutte ammucchiate sul tavolo, pulite e leggere. Passò un’ora e quello non veniva. Janey
divenne irrequieta, gironzolò per la stanza, guardò negli opuscoli. Trattavano tutti di lavoro e di economia e non la interessavano. Allora guardò fuori della finestra e cercò di allungare il collo per vedere che ora faceva l’orologio sulla torre dell’ufficio postale. Ma non vi riuscì e andò al telefono a chiedere all’ufficio, se il signor Barrow era nell’albergo, per favore di dirgli che il suo manoscritto era pronto. Dal banco risposero ch’erano le cinque e che il signor Barrow non era ancora rientrato, quantunque avesse lasciato detto che sarebbe tornato subito. Riattaccando il ricevitore, Janey fece cadere una lettera in carta color lavanda dal sostegno. Raccogliendola, siccome non aveva niente da fare ed era stufa di giocherellare con se stessa, la lesse. Se ne vergognò, ma una volta cominciato non poté fermarsi. Caro G.H. mi dispiace farlo ma sul serio, bimbo, sono nei pasticci e ho bisogno di denari. Allungami duemila caviglie (dollari 2000) altrimenti giuro che non ti tratto più da quella signora che sono e faccio scandalo. Mi dispiace farlo, ma so che li hai, altrimenti non ti darei fastidio. Sul serio stavolta la bambina che una volta amavi Queenie Janey arrossì e rimise la lettera esattamente com’era prima. Tremendi gli uomini: sempre del marcio. Era buio fuori e a Janey veniva fame e inquietudine, quando trillò il telefono. Era il signor Barrow, che disse che era tanto spiacente di averla tenuta ad aspettare e che lui era al Shoreham nell’appartamento del signor Moorehouse e se non le seccava venir subito, no, senza il manoscritto, ma aveva dell’altro da dettarle là: J. Ward Moorehouse era, doveva conoscerlo quel nome. Janey non conosceva quel nome, ma il pensiero di andare a scrivere sotto dettatura al Shoreham la entusiasmava e quella lettera e tutto. Era una sovraeccitazione come quando andava a spasso con Jerry Burnham. Indossò cappello e soprabito, si rifece un po’ il viso nello specchio sul camino e uscì nella pungente aria serotina di gennaio all’angolo della F e della Quattordicesima, dove attese il tram. Avrebbe voluto avere un manicotto; il vento sferzante le mordeva le mani nei guanti sottili e le gambe sopra il collo della scarpa. Avrebbe
voluto essere una ricca donna sposata alloggiata a Chevy Chase e attendere la sua macchina di lusso che venisse a portarla a casa, dov’erano marito, figli e un ruggente fuoco scoperto. Ricordò Jerry Burnham e si chiese se avrebbe potuto sposarlo destreggiandosi bene. Oppure Johnny Edwards; era andato a New York quando lei l’aveva respinto e faceva gran soldi nell’ufficio di un sensale. Oppure Morris Byer. Ma era un ebreo. Quest’anno non aveva avuto spasimanti. Cominciava a restare in soffitta, ecco la verità. All’angolo del Shoreham scese dal tram. Nel vestibolo faceva caldo. Gente distinta stava tutt’intorno, chiacchierando con voci distinte. C’era odore di fiori di serra. Al banco le dissero di salire senz’altro all’appartamento numero otto primo piano. Un uomo dalla bianca faccia rugosa sotto una testa piatta di lucido nero le aprì l’uscio. Portava un abito nero lucido e camminava circospetto come un pattinatore. Janey disse di essere la stenografa per il signor Barrow e quello la introdusse a cenni nella stanza vicina. Janey si fermò all’uscio aspettando che qualcuno la vedesse. In fondo alla stanza c’era un grande camino dove fiammeggiavano due ceppi. Davanti stava un largo tavolo con mucchi di riviste, giornali e dattiloscritti. A un’estremità c’era un servizio da tè in argento, all’altra un vassoio con caraffe, uno shaker da cocktail e dei bicchieri. Ogni cosa aveva un bel lustrato splendore d’argento, sedie, tavoli, servizio da tè e la catena dell’orologio, i denti e i lucidi capelli precocemente grigi di un uomo che volgeva la schiena al fuoco. Appena lo vide, Janey pensò che doveva essere un bell’uomo. Il signor Barrow e un altro, piccolo e pelato, sedevano in profonde poltrone da ciascun lato del camino, ascoltando con grande attenzione quel che diceva il primo. «È molto importante per l’avvenire del nostro paese» diceva con una sommessa voce convinta. «Posso assicurarvi che i grandi dirigenti e i potenti interessi dei circoli industriali e finanziari seguono questi sviluppi col massimo interesse. Non fate il mio nome, ma posso assicurarvi confidenzialmente che anche il presidente…» Il suo occhio incontrò quello di Janey. «Questa dev’essere la stenografa, venite, signorina…» «Williams mi chiamo» disse Janey.
Gli occhi di quell’uomo avevano l’azzurro di una fiamma all’alcool, con un bagliore fanciullesco nel fondo; doveva essere quel J. Ward Moorehouse di cui lei doveva conoscere il nome. «Avete matita e carta? Benissimo, sedete al tavolo. Morton, sarebbe bene portar via il servizio.» Morton fece sparire senza rumore il servizio. Janey sedette all’estremità del tavolo e tirò fuori taccuino e matita. «Non fareste bene a deporre cappello e soprabito? altrimenti non li sentirete all’uscita.» C’era in quella voce qualcosa di familiare, diverso, quando parlava con lei, da quando parlava con gli uomini. Desiderò di poter lavorare per lui. Comunque, era contenta di esser venuta. «Ora, signor Barrow, quel che ci occorre è una dichiarazione che calmi l’inquietudine. Dobbiamo far comprendere alle due parti in questa controversia il valore della cooperazione. È una grande parola la cooperazione… Anzitutto butteremo giù all’ingrosso… Voi siate così gentile da parlare dal punto di vista del lavoro organizzato, e voi, signor Jonas, da quello giuridico. Pronti, signorina Williams… Emesso da J. Ward Moorehouse, Consulenza pubblici rapporti, Shoreham Hotel, Washington D.C., 15 genn. 1916…» Poi Janey ebbe troppo da fare a scrivere la dettatura per poter afferrare il senso di ciò che si diceva. Quella sera, quando giunse a casa, trovò Alice già a letto. Alice voleva dormire, ma Janey cicalava come una gazza e del signor Barrow e dei disordini operai e di J. Ward Moorehouse e che uomo distinto era così gentile e cordiale e che idee interessanti aveva per la collaborazione tra capitale e lavoro, e come parlava familiarmente dell’opinione del presidente e di Andrew Carnegie e di quel che intendessero fare gli interessi Rockefeller o il signor Schick o il senatore La Follette e che begli occhi azzurri da ragazzo aveva e com’era distinto e il servizio da tè d’argento e come appariva giovane nonostante il capo precocemente grigio e il fuoco scoperto e lo shaker d’argento dei cocktail e i bicchieri di cristallo. «Ma, Janey» ruppe Alice, sbadigliando. «Insomma, te ne sei presa una cotta. Non ti ho mai sentita parlare così di un uomo, in tutta la mia vita.» Janey arrossì e fu molto offesa con Alice. «Oh Alice, sei così
sciocca… È inutile parlare con te di nessuna cosa.» Si spogliò e spense la luce. Fu solamente a letto che si ricordò di non aver cenato. Non ne disse nulla, perché certamente Alice sarebbe uscita in qualche sciocchezza. Il giorno dopo finì il lavoro per il signor Barrow. Per tutta la mattina ebbe voglia di interrogarlo sul signor Moorehouse: dove stesse, se era o no sposato, di dove veniva, ma rifletté che non sarebbe servito a molto. Quel pomeriggio, pagata che fu, si trovò a camminare per H Street davanti al Shoreham. Diceva a se stessa di voler guardare nelle vetrine. Non lo vide, ma vide una gran macchina di lusso, nero lucido, con un monogramma che non si poteva discernere senza curvarsi e sarebbe stato ridicolo, curvarsi. Decise che quella era la sua auto. Camminò per la via, verso l’angolo di fronte al grande squarcio tra le case, dove abbattevano l’Arlington. Era un nitido pomeriggio di sole. Janey girò Lafayette Square guardando la statua di Andrew Jackson su un cavallo impennato, tra gli alberi brulli. C’erano bambini e balie, aggruppati sulle panche. Un uomo dalla barbetta brizzolata, con una borsa nera sotto il braccio, sedette su una delle panche e immediatamente si rialzò andandosene a gran passi; un diplomatico straniero, pensò Janey, e quant’era bello vivere nella Città Capitale, dove c’erano diplomatici stranieri e uomini come J. Ward Moorehouse. Girò ancora una volta intorno alla statua di Andrew Jackson impennato verde e maestoso su un cavallo verdemaestoso, nella luce rossastra del pomeriggio invernale, e poi ritornò verso il Shoreham, camminando in fretta, come fosse in ritardo per un appuntamento. Chiese a un ragazzo dell’albergo dov’era la pubblica stenografa. Questi la mandò in una camera del secondo piano dove Janey chiese a una donna, occhi acidi, lunghe mascelle (la quale, nel piccolo settore d’entrata a tappeto verde, visibile attraverso l’uscio semiaperto, si cavava gli occhi a scrivere a macchina), se sapeva di qualcuno che avesse bisogno di una stenografa. La donna occhi acidi le sbarrò gli occhi addosso. «Ma insomma, questa non è un’agenzia, mi pare.» «È vero, ma speravo, non si sa mai» disse Janey, sentendo che tutto
l’abbandonava d’improvviso. «Permettete che mi sieda un momento?» La donna occhi acidi continuava a fissarla. «Be’, dov’è che vi ho già veduta…? No, non ditemelo voi… Voi… voi lavoravate dalla signora Robinson il giorno che ci venni per prendere il lavoro extra. Vedete che vi ricordo perfettamente.» La donna sorrise un giallo sorriso. «Vi avrei riconosciuta anch’io,» disse Janey «solamente che sono troppo stanca di girare in cerca di lavoro.» «A chi lo dite!» sospirò la donna. «Non sapete qualche posto?» «Vi dirò come fare… Telefonavano per una ragazza che scrivesse sotto dettatura, al numero otto. Le adoperano come… come sessanta là dentro, a fondare qualche impresa o che so io. Se mi date ascolto, cara mia, voi ci andate, vi togliete il cappello come se veniste da qualche posto e cominciate a scrivere e non vi cacceranno via, cara mia, neanche se ci fosse l’altra, le adoperano così svelti.» Prima di capire quel che faceva, Janey aveva baciato la donna occhi acidi sull’orlo della mascella e si era precipitata per il corridoio al numero otto e l’uomo dai capelli lucidi la introduceva, avendola riconosciuta e domandato «Stenografa?». «Sì» disse Janey, e un minuto dopo aveva estratto taccuino e matita, deposto cappello e soprabito e stava seduta all’estremità dello scurolucente tavolo di mogano in faccia al fuoco crepitante; e la fiamma lustreggiava sulle caraffe d’argento, sui boccali di acqua calda, sulle teiere e sopra le scarpe nere, lucidate alla perfezione, e gli occhi azzurrofiamma di J. Ward Moorehouse. Stava seduta e scriveva sotto la dettatura di Moorehouse. Alla fine del pomeriggio, l’uomo dai capelli lucidi entrò e disse: «Signore, è ora di vestirvi per il pranzo» e J.W. Moorehouse ringhiò e disse: «Diavolo». L’uomo dai capelli lucidi venne, pettinato, un po’ più accosto sullo stesso tappeto. «Chiedo scusa, signore, la signorina Rosenthal è caduta e si è fratturata una coscia. Caduta sul ghiaccio davanti al palazzo del Tesoro, signore.» «Sulla forca… Scusatemi, signorina Williams» disse, e sorrise. Janey sollevò gli occhi a guardarlo, con un’aria indulgente e comprensiva e sorrise anch’essa. «Hanno pensato a lei?»
«Il signor Mulligan l’ha portata all’ospedale, signore.» «Bene… Scendete, Morton, e mandatele dei fiori, sceglieteli belli.» «Sissignore… Per cinque dollari, signore?» «Due e mezzo è il massimo, Morton, e metteteci la mia carta da visita.» Morton scomparve. J. Ward Moorehouse passeggiò in su e in giù davanti al camino per qualche tempo, come fosse per dettare. La matita di Janey attendeva sul taccuino. J. Ward Moorehouse si arrestò e guardò Janey. «Conoscete nessuno, signorina Williams… Ho bisogno di una ragazza come si deve e intelligente, stenografa e segretaria, una persona di cui fidarsi… Maledetta quella là che si va a rompere la coscia.» A Janey turbinò il cervello. «Ma anch’io sono in cerca di un posto simile.» J. Ward Moorehouse la fissava sempre con uno strano sguardo azzurro. «Vi spiace dirmi, signorina Williams, com’è che avete perduto il vostro ultimo impiego?» «Affatto. Ho lasciato Dreyfus e Carroll, forse li conoscete… Non mi piaceva quel che andava accadendo là dentro. Sarebbe stato diverso se il vecchio signor Carroll fosse restato, quantunque il signor Dreyfus fosse senza dubbio molto gentile.» «È un agente del governo tedesco.» «Per questo dico che non mi piaceva restarci, dopo il proclama del presidente.» «Be’, qui siamo tutti per gli alleati e così andrà benissimo. Mi sembrate proprio la persona che cerco… Naturalmente non sono certo, ma tutte le mie migliori decisioni sono quelle prese in gran fretta. Cosa ne dite di venticinque settimanali, per cominciare?» «Va tanto bene, signor Moorehouse, sarà un lavoro molto interessante, ne son certa.» «Domani alle nove, favorite, e inviate per me questi telegrammi uscendo: Signora J.W. Moorehouse Great Neck Long Island New York Forse vado Messico spiega ai Saltworth impossibile trovarmi
pranzo. Spero tutto bene affettuosamente Ward. Signorina Eleanor Stoddard 45 E Undicesima Strada New York Scrivetemi che cosa desiderate dal Messico come sempre J.W.» «Vi spiacerebbe viaggiare, signorina Williams?» «Non ho mai viaggiato, ma son certa che mi piacerebbe.» «Può darsi debba portare un manipolo d’impiegati con me… affari di petrolio. Vi avvertirò tra un giorno o due… James Frunze presso J. Ward Moorehouse 100 Quinta Avenue New York Avvertitemi subito Shoreham sviluppo situazione A e B Barrow irrequieto pubblicate dichiarazione su unità di interessi americanismo contro scarti socialismo forestiero JWM… Grazie, per oggi è tutto. Scrivete questo a macchina e spedite, poi andate pure.» J. Ward Moorehouse uscì per un uscio al fondo, togliendosi la giacca mentre usciva. Quando Janey ebbe scritto i messaggi e stava filando nel vestibolo dell’albergo per spedirli alla Western Union, ebbe un barlume di lui in marsina, col cappello di feltro grigio e un soprabito color marrone sul braccio. Si precipitava in un tassì e non ebbe il tempo di vederla. Era tardissimo quando Janey giunse a casa. Aveva le guance accese, ma non sentiva stanchezza. Alice era seduta a leggere, sulla sponda del letto. «Oh sono stata talmente in pensiero» cominciava, ma Janey le gettò le braccia al collo e le disse che aveva il posto di segretaria privata di J. Ward Moorehouse e che andava al Messico. Alice scoppiò a piangere, ma Janey era così felice che non poté fermarsi a badarle, e continuò a contarle ogni cosa di quel pomeriggio al Shoreham.
Il mago dell’elettricità Edison nacque a Milan, Ohio, nel 1847. Milan era una cittadina sul fiume Huron che per qualche tempo fu il porto donde partiva il grano di tutta la Riserva Occidentale: e le ferrovie portaron via l’industria dei trasporti e la famiglia Edison andò a Port Huron nel Michigan per crescere col paese suo padre falegname faceva assicelle da tetti e pasticciava in varie piccole speculazioni; commerciava in cereali e foraggio e legnami e costruì una torre di legno alta cento piedi; turisti ed escursionisti pagavano un quarto di dollaro a testa per salire sulla torre e guardare la vista sul lago Huron e sul fiume St. Clair e Sam Edison divenne un solido e rispettabile cittadino di Port Huron. Thomas Edison non andò a scuola che per tre mesi perché il maestro giudicò che non fosse una cima. La madre gli insegnò in casa quel che sapeva lei e lesse con lui scrittori del diciottesimo secolo. Gibbon e Hume e Newton, e gli lasciò metter su un laboratorio in cantina. Ogni volta che leggeva intorno a qualcosa, scendeva in cantina e faceva esperimenti. Quand’ebbe dodici anni, sentì il bisogno di denaro per comprarsi libri e prodotti chimici; ottenne una concessione come giornalaio su un treno giornaliero da Detroit e Port Huron. A Detroit c’era una biblioteca pubblica e lui la lesse. Mise su un laboratorio sul treno e, ogni volta che leggeva intorno a qualcosa, faceva esperimenti. Mise su un torchio e stampò un giornale intitolato «The Herald»; quando scoppiò la guerra civile organizzò un servizio di notizie e fece denaro sulle grandi battaglie. Poi lasciò cadere un bastoncino di fosforo e diede fuoco alla vettura e venne scacciato dal treno. A quel tempo aveva nel paese una fama considerevole come il ragazzo editore del primo giornale pubblicato su un treno in viaggio. Il «Times» di Londra parlò di lui. Imparò telegrafia e trovò un posto da operatore notturno a Stratford Junction nel Canada, ma un giorno lasciò passare un treno
merci fuori dello scambio e dovette andarsene. (Durante la guerra civile uno che conoscesse la telegrafia trovava posti dappertutto.) Edison viaggiò in giro per il paese prendendo posti e lasciandoli e andandosene, leggendo tutti i libri sui quali poteva metter le mani, ogni volta che leggeva intorno a un’esperienza scientifica la ripeteva, ogni volta che riusciva a metter le mani su una macchina vi pasticciava, ogni volta che lo lasciavano solo in un ufficio telegrafico faceva scherzi coi fili. Ciò gli costò molte volte il posto e lui doveva andarsene. Fu operatore nomade per l’intero Middle West: Detroit, Cincinnati, Indianapolis, Louisville, New Orleans, sempre in bolletta, cogli abiti macchiati dai prodotti chimici, sempre a praticare scherzi col telegrafo. Lavorò per la Western Union a Boston. A Boston escogitò il modello del suo primo brevetto, un registratore automatico dei voti a uso del Congresso, ma non avevano bisogno di registratore automatico dei voti nel Congresso, e così Edison pagò il viaggio a Washington e fece qualche debito e questo fu tutto ciò che ne ricavò; mise insieme segnalatori e suonerie contro gli scassinatori e si asportò la pelle della faccia con acido nitrico. Ma New York era già quel grande mercato di azioni, di idee, di oro e di dollari. (Questa parte è scritta da Horatio Alger:) Quando Edison giunse a New York era in una bolletta totale e aveva debiti a Boston e Rochester. Questo, quando l’oro era sopra la parità e Jay Gould tentava di mettere con le spalle al muro il mercato dell’oro. Wall Street era impazzita. Un uomo detto Law aveva messo insieme un indicatore elettrico (l’invenzione di Callahan) che mostrava il prezzo dell’oro negli uffici dei sensali. Edison, in cerca di un impiego, senza un soldo e senza un luogo dove andare, era stato a bighellonare intorno all’ufficio centrale passando la giornata con gli operatori, quando il trasmettitore generale si fermò con uno schianto nel bel mezzo di una giornata febbrile di mercato nervosissimo; tutti nell’ufficio persero la testa. Edison salì su, riparò la macchina e si
assicurò un posto a 300 dollari al mese. Nel ’69, l’anno del Venerdì Nero, aprì una ditta di macchine elettriche insieme con un tale detto Pope. Da allora innanzi visse di suo, inventò un segnalatore che si vendette. Aveva una bottega di macchine e un laboratorio; ogni volta che gli veniva in mente un progetto, faceva esperimenti. Guadagnò 40.000 dollari con lo Universal Stock Ticker. Affittò una bottega a Newark e lavorò intorno a un telegrafo automatico e ai sistemi per spedire contemporaneamente due e quattro messaggi sullo stesso filo. A Newark pasticciò con Sholes intorno alla prima macchina da scrivere e inventò il mimografo, il reostato a carbonio, il microtasimetro e per primo fabbricò carta di paraffina. Qualcosa che lui chiamava forza eterica lo preoccupava, era in imbarazzo a proposito della forza eterica ma fu Marconi che fece i soldi con le onde hertziane. La radio avrebbe frantumato l’antico universo. La radio avrebbe ucciso il vecchio Dio euclideo; ma Edison non fu mai uomo da preoccuparsi di concetti filosofici; lavorava tutto il giorno e tutta la notte pasticciando con ruote dentate e pezzetti di filo di rame e prodotti chimici in bottiglie, ogni volta che gli veniva in mente un progetto faceva esperimenti. Tutto con lui andava. Non era un matematico. Io posso affittare i matematici ma i matematici non possono affittare me, diceva. Nel 1876 si trasferì a Menlo Park dove inventò il trasmettitore a carbonio che fece del telefono una cosa commerciale, che rese possibile il microfono lavorava tutto il giorno e tutta la notte e produsse il fonografo la lampada elettrica a incandescenza e sistemi di generazione, distribuzione, regolazione e misurazione della corrente elettrica, tubi, interruttori, isolatori d’illuminazione elettrica, con la corrente diretta e lampadine a bassa unità e l’arco multiplo, che vennero installati a Londra, Parigi, New York e Sunbury Pa., il sistema a filo triplo
il separatore magnetico per minerali una ferrovia elettrica. Edison li faceva lavorare, quelli dell’ufficio Brevetti, a riempirgli brevetti e dichiarazioni. Per trovare un filamento alla sua lampada elettrica, che fosse possibile, che desse una seria garanzia commerciale, sperimentò ogni specie di carta e di stoffa, filo, lenza, fibra, celluloide, legno di bosso, guscio di cocco, abete, noce americano, alloro, trucioli di acero, legno di rosa, fungaccio, sughero, lino, bambù e il pelo della barba di uno scozzese dalla testa rossa; ogni volta che gli veniva un’idea, faceva esperimenti. Nel 1887 si trasferì ai grandi laboratori di West Orange. Inventò perforatrici e il fluoroscopio e la pellicola a rocchetto per le macchine cinematografiche e l’accumulatore ad alcali e il forno lungo per bruciare il cemento Portland e il cinetofono che fu il primo film parlato e la casa in cemento armato che dovrà fornire a buon prezzo, artistiche, identiche e sanitarie, le case ai lavoratori dell’epoca dell’elettricità. Thomas A. Edison a ottantadue anni lavorava sedici ore al giorno; e non si preoccupò mai di matematica o del sistema sociale o di concetti filosofici generalizzati d’accordo con Henry Ford e Harvey Firestone che non si sono mai preoccupati di matematica o del sistema o di concetti filosofici generalizzati; lavorava sedici ore al giorno cercando di trovare un surrogato della gomma; ogni volta che leggeva intorno a qualcosa, faceva esperimenti; ogni volta che gli veniva un’idea andava nel laboratorio per vagliarla a fondo al fuoco dell’esperimento.
Occhio fotografico (25) quelle notti di primavera le ruote dei tram stridono raschiando in un frastuono di vetture libere sulle rotaie curve di Harvard Square il pulviscolo è sospeso nel baglione brulicante della luce elettrica tutta la notte fino all’alba non posso dormire non ho il coraggio di uscire dalla campana di vetro quattro anni sotto la maschera dell’etere respira profondo adagio ora è così che si diventa un bravo ragazzo uno due tre quattro cinque sei prendi ottimi punti in qualche materia senza fare lo sgobbone interèssati di letteratura ma resta un gentiluomo non farti vedere con ebrei o socialisti e tutti i contatti amichevoli torneranno utili domani grida un saluto con buona grazia a chiunque attraversa il cortile siedi guardando nel crepuscolo dei quattro anni più belli della tua vita raffrèddati nella cultura come una tazza di tè dimenticata tra un incensiere e un volume di Oscar Wilde freddo e non forte come una limonata al chiaretto bevuta a un concerto popolare in Symphony Hall quattro anni non seppi che uno poteva fare quel che tu Michelangelo volevi dire Marx a tutti i professori, per un piccolo Swift fracassare tutti i Greenough al tiro vandalico ma rivoltolato con gli occhi brucianti tutta la notte primaverile leggendo la Tragica storia del dottor Faustus e impazzito nell’ascoltare le ruote dei tram stridere raschiando in un frastuono di vetture libere per Harvard Square e i treni urlanti al di là dei pascoli maremmosi e la sirena strepitante di un piroscafo che lascia il bacino e la fiamma azzurra sventolare e gli operai marcianti con una banda rossa d’ottoni per le vie di Lawrence Massachusetts era come gli emisferi di Magdeburgo; la pressione esterna manteneva il vuoto interno e io non avevo il coraggio
di balzar su e uscir fuori e dire a tutti di andarsi a pigliare Rimbaud volante nella luna
Cine-giornale XVII un attacco di uno stormo di aeronavi nemiche sferrato prima di mezzanotte. Vennero sganciate bombe, senza andar troppo per il sottile, su località prive di importanza militare LE FERROVIE NON CEDERANNO DI UN DITO Dovremo far la traversata in condizioni non troppo vantaggiose per noi, disse il capitano Koenig del Deutschland a novanta miglia dalle isole Salomone, alle 2.30. Ogni piroscafo che passava suonava la sirena salutando. Tu mi hai reso quel che sono sarai lieta che son qui mi hai portato sempre in basso finché l’anima morì Sir Roger Casement è stato impiccato nel carcere di Pentonville stamattina alle nove. UN SOMMERGIBILE TEDESCO PASSA LIBERAMENTE LO STRETTO bagnanti vestite solo di un chimono scandalizzano una colazione di latte invece che caffè di prima qualità alla spiaggia divertimenti grosse perdite appaiono nei raccolti degli S.U. gli italiani applaudirono quando gli austriaci abbandonarono panini caldi per la fretta di andarsene muraglia gigantesca d’acqua giù per la vallata professore che dice che Beethoven dà l’impressione di una bistecca al sugo LA MAGIA CHE MUTA I RIFIUTI DELLA CITTÀ IN MINIERA D’ORO LA LUNA OCCULTERÀ IL PIANETA SATURNO STANOTTE FRATELLI CHE COMBATTONO AL BUIO
Mac I ribelli presero Juárez, Huerta fuggì, i piroscafi per l’Europa eran pieni di científicos che se la battevano a Parigi, e Venustiano Carranza era presidente a Città del Messico. Qualcuno procurò a Mac un posto sulla Mexican Central per scendere alla capitale. Encarnación pianse quando lui la lasciò e tutti gli anarchici vennero alla stazione a salutarlo. Mac voleva unirsi a Zapata. S’era infarinato di un po’ di spagnolo da Encarnación e di vaghe idee sulla politica della rivoluzione. Il viaggio durò cinque giorni. Cinque volte venne interrotto, mentre le squadre ferroviarie riassettavano le rotaie innanzi. Ogni tanto, nottetempo, entravan pallottole dai finestrini. Vicino a Caballos, una mano d’uomini a cavallo costeggiò in corsa tutto il treno agitando i cappellacci e intanto sparando. I soldati nella garitta del freno si svegliarono e risposero al fuoco e quelli si allontanarono in un nuvolone di polvere. I viaggiatori dovettero cacciarsi sotto i sedili, quando incominciò la sparatoria, o si appiattirono nel corridoio. Respinto l’attacco, una vecchia cominciò a gridare e si trovò che un bambino aveva avuto il capo trapassato da una pallottola. La madre era una donna corpulenta e fosca, vestita a fiorami. Andò su e giù per il treno col corpicino sanguinante avvolto in uno scialle e chiedeva di un medico, ma tutti potevano vedere che il bambino era morto. Mac pensava che quel viaggio non sarebbe più finito. Comprava cibi pepati e birra tiepida da vecchie indiane alle stazioni, tentò di bere pulque e di attaccar conversazione coi compagni di viaggio. Finalmente passarono Querétaro e il treno cominciò a prendere velocità giù per lunghi pendii nell’aria fredda e splendente. Poi cominciarono le vette dei grandi vulcani a prender forma nell’azzurro oltre interminabili campi a zigzag di alberi secolari e d’improvviso il treno si trovò a sbatacchiare tra muri di giardini, in mezzo a piante ciuffose. Venne a fermarsi con un cozzar di respingenti: Messico. Mac si sentì sperduto girando per le vie smaglianti tra gruppi di persone parlottanti, gli uomini tutti in bianco e le donne tutte in nero o blu scuro. Le vie erano polverose, assolate e quiete. C’erano negozi
aperti, carrozze, tram e lucide limousines. Mac era preoccupato. Non possedeva che due dollari. Era stato tanto tempo in treno che aveva dimenticato quel che voleva fare una volta giunto a destinazione. Gli occorrevano abiti puliti e un bagno. Poi che ebbe bighellonato un po’, vide un locale soprascritto “American Bar”. Aveva le gambe stracche. Sedette a un tavolino. Venne un cameriere e gli chiese in inglese che cosa desiderava. Mac non seppe pensare a nient’altro e così ordinò un whisky. Bevve il whisky e restò là seduto con la testa tra le mani. Al banco c’era un gruppo di americani e un paio di messicani col cappellaccio da una brenta, che giocavano da bere ai dadi. Mac ordinò un altro whisky. Un tale bovino, occhi rossi, in una strusciata camicia kaki, gironzolava a disagio per il bar. Il suo occhio cadde su Mac e si venne a sedere al suo tavolo. «È permesso sedersi qui un momento, amico?» domandò. «‘Sti porci fan troppo casino. Qui sombrero… cosa fa quel fetente d’un cameriere? Bicchiere birra. Bene. Oggi ho spedito via la vecchia e i bambini… Dove andate voi?» «Ma io arrivo ora» disse Mac. «Siete matto… Non è il posto per un bianco… ’Sti banditi saranno in città da un giorno all’altro… Sarà spaventoso, ve lo dico io. Non lasceranno vivo un solo bianco… Prima che mi facciano la pelle però, voglio fargliela a qualcuno… Dio santo, posso contare su venticinque uomini, no ventiquattro.» Tirò fuori una Colt dalla tasca deretana, si vuotò nella mano il tamburo e cominciò a contare le cartucce. «Otto.» Poi cominciò a rovistare nelle tasche e dispose le cartucce in fila sul tavolo di abete. Non ce n’era che venti. «Qualche ruffiano mi ha derubato.» Un tale alto e sparuto si avvicinò dal banco e mise una mano sulla spalla dell’uomo dagli occhi rossi. «Eustace, fareste bene a metter via, finché ne avremo bisogno… Sapete come si farà, eh?» si volse a Mac «appena comincia la sparatoria, tutti i cittadini americani si raccoglieranno all’ambasciata. Là venderemo la pelle fino all’ultimo.» Qualcuno gridò dal banco: «Ohi ragazzo, un altro giro» e l’uomo alto ritornò al banco. «Sembra che aspettiate dei pasticci» disse Mac. «Pasticci, Dio santo! Non conoscete ’sto paese. Arrivate ora?» «Sbarcato adesso da Juárez.»
«Impossibile. La ferrovia è tutta in aria a Querétaro.» «E va be’, l’avranno riparata» disse Mac. «Dite, che cosa si dice qui di Zapata?» «Dio santo, è il farabutto più sanguinario di tutti. Hanno arrostito uno, caporeparto di uno zuccherificio, a Morelos, a fuoco lento, e gli hanno violentato moglie e figlie sotto gli occhi… Dio santo, amico, non sapete che razza di paese è questo. Sapete che cosa dovremmo fare…? sapete che cosa faremmo, se ci fosse un uomo nella Casa Bianca invece di quel riformatore dalla pancia gialla e dalla bocca di patata…? Raccoglieremmo un esercito di centomila uomini e faremmo pulizia qui… È un fottuto paese niente male, ma non c’è uno di questi luridi messicani che valga la polvere e la pallottola da sparargli… affumicarli come le bestie, questo ci vorrebbe… Tutti, dal primo all’ultimo, sono degli Zapata, sotto.» «In che cosa lavorate voi?» «Sono un cercatore di petrolio e vivo in questo lurido buco da quindici anni e ne ho abbastanza. Sarei scappato oggi in treno a Veracruz, soltanto che ho delle concessioni da mettere a posto e il mobilio da vendere… Non si sa se un giorno o l’altro interromperanno la ferrovia e allora non potremo più uscire e il presidente Wilson ci lascerà fucilare come topi in trappola… Se soltanto il pubblico americano sapesse le condizioni di qui… Dio santo, siamo lo zimbello di tutte le nazioni… Qual è il vostro lavoro, amico?» «Tipografo… linotipista.» «Cercate un posto?» Mac aveva estratto un dollaro per pagare le sue consumazioni. «Credo bene che dovrò» disse. «Quest’è il mio penultimo dollaro.» «Perché non andate a vedere al “Mexican Herald”? Hanno sempre bisogno di tipografi che sappiano l’inglese… Non riescono a tener nessuno… Non è più un posto da bianchi qui… Lasciate, amico, questo bicchiere pago io.» «Be’, allora offro io un altro.» «Ha preso fuoco alla polvere ormai in questo paese, amico… tutto è andato al diavolo… non c’è che bere finché si può.» Quella sera, mangiato un po’ di cena in una trattoria americana,
Mac passeggiò per l’Alameda a cavarsi di capo il whisky, prima di salire al «Mexican Herald» a vedere se avevano lavoro. Soltanto per un paio di settimane, si diceva, finché avesse capito come andava il paese. Gli alberi alti sull’Alameda, le statue bianche, le fontane, le coppie benvestite che passeggiavano nel crepuscolo e le vetture strepitanti sull’acciottolato avevano un’aria bastevolmente pacifica, e così la fila di indiane dagli occhi impietrati che vendevano frutta e noccioline e canditi rosa, gialli e verdi, in baracchette sul marciapiede. Mac concluse che l’uomo con cui aveva parlato nel bar lo era andato infinocchiando, visto che lui era un novellino. Trovò bene un posto al «Mexican Herald» a trenta dollari messicani la settimana, ma in tipografia tutti parlavano come l’uomo del bar. Quella notte un vecchio americano polacco, correttore di bozze, lo portò in un alberghetto a prendersi una stanza e gli imprestò qualche cosa, tanto da tirare avanti fino al giorno della paga. «Fatevi pagare in anticipo più che potete,» disse il vecchio polacco «uno di questi giorni ci sarà rivoluzione e allora addio “Mexican Herald”… a meno che Wilson non intervenga in fretta e furia.» «Va tanto bene per me, voglio vederla la rivoluzione sociale» disse Mac. Il vecchio polacco si mise il dito lungo il naso, scosse il capo in modo particolare e se ne andò. Quando Mac si svegliò al mattino, era in una camera intonacata giallo splendido. I mobili eran verniciati di turchino e alle finestre c’erano tendine rosse. Tra le tendine, le lunghe imposte erano sbarrate di vivida luce violetta, che tagliava una zona più calda sulle coperte. Un canarino cantava da qualche parte e Mac poteva sentire il cic ciac cic ciac di una donna che faceva tortillas. Si levò e spalancò le imposte. Il cielo era senza una nube, sopra i tetti di tegole rosse. La via era vuota e piena di sole. Mac si riempì i polmoni della fresca aria leggera e sentì il sole bruciargli la faccia e il collo, stando là. Doveva esser presto. Ritornò a letto e si addormentò di nuovo. Quando Wilson ordinò che gli americani uscissero dal Messico, diversi mesi più tardi, Mac era stabilito in un piccolo alloggio in Plaza del Carmen con una ragazza di nome Concha e due candidi gatti persiani. Concha era stata stenografa e interprete in una ditta
americana e l’amante di un industriale di petroli per tre anni, così parlava un inglese discreto. Quello dei petroli era saltato sul treno di Veracruz nel panico al tempo della fuga di Huerta, lasciando Concha all’asciutto. Lei si era incapricciata di Mac dal primo momento che l’aveva veduto entrare nell’ufficio postale. Lo circondava di molti comodi, e quando Mac le parlava di andarsene a raggiungere Zapata non faceva che ridere e diceva che i peoni erano selvaggi ignoranti e buoni solo da governare con la frusta. Sua madre, una vecchia con uno scialle nero perpetuamente avvolto sul capo, veniva a far la cucina per loro e a Mac cominciò a piacere il cibo messicano, tacchino con densa salsa bruno cioccolata e enchiladas al formaggio. I gatti si chiamavano Porfirio e Venustiano e dormivano sempre al piede del letto. Concha era molto economa, faceva durare lo stipendio di Mac più che non sapesse far lui e non si lagnava mai quando lui andava in giro per la città e tornava tardi a casa, col mal di capo per la tequila bevuta. Invece di cercar di salire sugli zeppi treni per Veracruz, Mac diede mano a un po’ di denaro messo da parte e comperò i mobili d’ufficio che gli americani atterriti vendevano per qualunque somma. Li fece accatastare nel cortile dietro la casa dove vivevano. Comprarli era stata dapprima un’idea di Concha e Mac soleva scherzarci su, chiedendo quando mai se ne sarebbero liberati, ma lei accennava del capo e diceva: «Aspetta un poco». Concha era molto contenta quando lui invitava amici a mangiare con loro, la domenica. Li serviva con molta piacevolezza e mandava il suo fratellino Antonio a comperare birra e cognac e sempre teneva dolci in casa, da offrire se capitava qualcuno. Mac talvolta pensava quant’era meglio così di quando aveva vissuto con Maisie a San Diego, e cominciò a pensar sempre meno ad andarsene con Zapata. Il correttore di bozze polacco, di nome Korski, si rivelò un esiliato politico, socialista e persona ben informata. Era capace di star seduto tutto il pomeriggio, con un mezzo bicchiere di cognac, a parlare della politica europea; dal tempo dello sfacelo dei partiti socialisti europei all’inizio della guerra, non aveva più preso parte a nulla; da ora innanzi sarebbe stato uno spettatore. Aveva una teoria: che la civiltà e la dieta mista causavano la rovina della razza umana.
Poi c’era Ben Stowell, un cercatore di petroli indipendente, il quale tentava di concludere secondo la legge un affare col governo di Carranza, per far funzionare certi pozzi. Era in bolletta il più delle volte e Mac era solito prestargli denaro, ma quello parlava sempre a milioni. Si dava del progressista in politica e credeva che Zapata e Villa fossero gente onesta. Ben Stowell prendeva sempre la posizione opposta a qualunque affermazione di Korski e col suo atteggiamento antisociale esasperava il vecchio. Mac voleva far qualche soldo da inviare a Maisie per gli studi dei ragazzi. Gli dava un senso di soddisfazione mandare a Rose ogni tanto una scatola di giocattoli. Lui e Ben facevano lunghi discorsi sulle possibilità di far denaro nel Messico. Ben Stowell tirò fuori un paio di giovani politicanti radicali, che eran felici di star seduti tutto il pomeriggio a parlare di socialismo, bevendo e imparando l’inglese. Mac non parlava molto di solito, ma di tanto in tanto gli saltava la mosca e tirava ai due una bordata di ortodossa dottrina internazionale. Concha poneva fine a tutti i ragionamenti portando la cena e dicendo, con una scossa del capo: «Ogni povero, socialista, como no? ma quando diventa ricco, subito tutti molto capitalista». Una domenica Mac, Concha, certi giornalisti messicani, Ben Stowell e la sua ragazza, Angustias, ballerina al Lírico, andarono in gita col tram a Xochimilco. Noleggiarono una barca con dentro un tavolino, un tendone e un indiano che li portasse a punta lungo i canali orlati di pioppi, tra le ricche aiuole e gli orti. Bevettero pulque e avevano dietro una bottiglia di whisky e comperarono alle ragazze gigli calla. Uno dei messicani sonava la chitarra e cantava. Nel pomeriggio, l’indiano ricondusse la barca a un approdo e tutti si allontanarono a coppie nei boschi. Mac si sentì a un tratto pieno di nostalgia e parlò a Concha dei suoi bambini negli S.U. e di Rose specialmente e Concha scoppiò in lacrime e gli disse che amava tanto i bambini, ma che a diciassette anni era stata molto ammalata e avevano creduto che sarebbe morta e ora non poteva aver bambini, tranne Porfirio e Venustiano. Mac la baciò e le disse che avrebbe sempre avuto cura di lei. Quando furono di ritorno alla stazione del tram, carichi di fiori,
Mac e Ben mandarono a casa sole le ragazze e loro passarono in una cantina a bere una volta. Ben disse che era stufo assai di quella vita e avrebbe voluto far fagotto e ritornare negli Stati a sposarsi e metter su casa e famiglia. «Vedete, Mac,» diceva «ho quarant’anni. Santo Dio, non si può continuare a far disordini per tutta la vita.» «Io non faccio mica diverso.» Non parlarono molto, ma Ben venne con Mac fino all’ufficio del «Mexican Herald» e poi scese nel centro all’Iturbide per vedere certi industriali dei petroli che eran là. «Ebbene, è una vita straordinaria, se uno tiene duro» disse agitando la mano verso Mac e incamminandosi giù per la via. Era un uomo massiccio, dalla nuca di toro e le gambe arcuate. Diversi giorni dopo, Ben capitò in Plaza del Carmen, che Mac era ancora a letto. «Mac, venite a mangiare con me, oggi» disse. «C’è un tale che si chiama G.H. Barrow e vorrei fargli vedere un po’ la città. Potrebbe esserci utile… Voglio sapere cosa cerca, comunque.» Quel tale scriveva articoli sulla situazione messicana e si diceva avesse qualche rapporto con l’AFL. A pranzo s’informò con ansia se l’acqua era potabile e se non c’era pericolo a girare per le vie dopo il tramonto. Ben Stowell lo prese un po’ in giro e raccontò storie di generali e loro amici che irrompevano nei bar, sparavano a terra per far ballare i clienti e poi giocavano al tiro a segno nella sala. «Il tiro a segno, è come chiamano qui il Congresso» disse Mac. Barrow disse che andava a un comizio dell’Unión Nacional de Trabajadores, quel pomeriggio, e se volevano venire con lui per fargli da interprete. Era giorno di festa per Mac e dissero: «Sì, sì». L’altro disse di aver avuto istruzioni di tentare contatti con stabili elementi del lavoro messicano, sperandosi di unirli alla Pan-American Federation of Labor. Gompers in persona sarebbe venuto, se si fosse potuto concludere qualcosa. Disse che aveva fatto lo spedizioniere e il controllore ferroviario e che era stato nell’ufficio della confraternita Ferrovieri, ma ora lavorava per l’AFL. Avrebbe voluto che i lavoratori americani avessero più idee sull’arte di vivere. Era stato ai comizi della Seconda Internazionale ad Amsterdam e aveva imparato che i lavoratori europei conoscevano l’arte di vivere. Quando Mac gli domandò come diavolo la Seconda Internazionale non aveva fatto nulla per fermare la guerra mondiale,
rispose che il momento non era ancor venuto e parlò delle atrocità tedesche. «Le atrocità tedesche sono una gita scolastica, in confronto di ciò che capita tutti i giorni nel Messico» disse Ben. Allora Barrow passò a domandare se i messicani erano così immorali come si diceva. La birra che bevevano mangiando era robusta e tutti si lasciarono un po’ andare. Barrow chiedeva se non era troppo arrischiato andare qui con donne, per via dell’alta percentuale della sifilide. Mac disse che sì, ma che lui e Ben potevano indicargli certi posti sicuri, se voleva dargli un’occhiata. Barrow rise un po’ e assunse un’aria imbarazzata e disse che al più presto avrebbero dato quest’occhiata. «Bisogna vedere tutti i lati delle cose, quando si studiano le condizioni.» Ben Stowell batté il palmo della mano sull’orlo della tavola e disse che Mac era l’uomo che ci voleva per mostrargli l’altra faccia della vita messicana. Andarono al comizio, che era fitto di individui magri e foschi vestiti di cotone turchino. Dapprima non poterono entrare per via della folla addensata nei corridoi e in fondo al salone, poi Mac trovò un funzionario di sua conoscenza che li fece sedere in un palco. Il salone sapeva di chiuso, la banda sonava, ci fu un po’ di canto e i discorsi furono assai lunghi. Barrow disse che ascoltare una lingua straniera gli metteva sonno e suggerì di fare un giro per la città, aveva sentito che il quartiere dei postriboli era… gli interessavano le condizioni. Fuori del salone, s’imbatterono in Enrique Salvador, un giornalista che Ben conosceva. Aveva auto e autista. Strinse le mani e rise e disse che l’auto apparteneva al capo di polizia, amico suo; non voleva venire con lui fino a San Ángel? Percorsero il lungo viale oltre Chapultepec, gli Champs-Élysées di Messico, lo chiamava Salvador. Presso Tacubaya, Salvador additò il luogo dove le truppe di Carranza avevano avuto una scaramuccia la settimana prima con gli zapatisti e un angolo dov’era stato assassinato dai banditi un ricco negoziante di stoffe, e G.H. Barrow badava a domandare se era proprio sicuro inoltrarsi così nella campagna e Salvador disse: «Sono un giornalista. Amico di tutti». A San Ángel bevettero qualcosa e, di ritorno in città, girarono per il
quartiere di Pajaritos. G.H. Barrow si fece cheto e gli venne negli occhi uno sguardo acquoso quando vide i presepi illuminati, ciascuno col letto, qualche fiore di carta e un crocefisso, che si potevano vedere attraverso la porta aperta, dietro una tendina rossa o azzurra, e le fosche e tranquille ragazze indiane in corti camiciotti, in piedi fuori delle porte o sedute sulla soglia. «Vedete,» disse Ben Stowell «è facile come grattarsi in testa… Ma non vi consiglio di perder troppo la prudenza da queste parti… Salvador ci condurrà in un buon locale dopo cena. Dovrebbe conoscerli, perché è amico del capo di polizia ed è il capo di polizia che li tiene quasi tutti.» Ma Barrow voleva entrare in uno dei presepi, e così scesero e parlarono con una delle ragazze e Salvador mandò l’autista a prendere un paio di bottiglie di birra. La ragazza li accolse molto cortesemente e Barrow cercò di farle rivolgere domande da Mac, però a Mac non garbava far domande e così lasciò la cosa a Salvador. Quando G.H. Barrow le mise la mano sulla spalla nuda e cercò di levarle il camiciotto e le chiese quanto voleva per farsi vedere interamente nuda, la ragazza non comprese e si strappò via, gridò, lo ingiuriò e Salvador non volle tradurre ciò che disse. «Portiamolo via di qui, questo lazzarone,» disse Ben con voce bassa a Mac «prima che nasca un parapiglia o chi sa cosa.» Presero una tequila a testa, prima di cena, in un piccolo bar, dove non davano altro che tequila, tenuta in barilotti verniciati. Salvador insegnò a G.H. Barrow come si beveva, mettendo prima del sale nel cavo tra il pollice e l’indice, tracannando poi il bicchierino di tequila, leccando il sale e trangugiando per finire un po’ di salsa di chile, ma Barrow ingozzò male e fu per soffocare. A cena erano ben ubriachi e G.H. Barrow continuava a dire che i messicani comprendevano l’arte di vivere, e non ci voleva altro per Salvador, che parlò dello spirito indiano e dello spirito latino e disse che Mac e Ben erano i soli gringos che avesse mai conosciuti coi quali andasse d’accordo, e insisté che loro non pagassero la cena. L’avrebbe messa in conto al suo amico capo di polizia. Poi andarono a una cantina accanto a un teatro, dove si diceva ci fossero ragazze francesi,
ma le ragazze francesi non c’erano. C’erano tre vecchi nella cantina, che suonavano il violoncello, il violino e l’ottavino. Salvador li fece suonare La Adelita e tutti la cantarono, e poi La cucaracha. C’era un vecchio dal cappello a larga tesa, con una grossa e lucida busta da pistola sulla schiena, che buttò giù in fretta il suo bicchiere, quando loro entrarono, e uscì dal bar. Salvador bisbigliò a Mac che quello era il generale Gonzáles e che se n’era andato per non esser veduto bene con dei gringos. Ben e Barrow sedevano, con le teste accostate, a un tavolino nell’angolo, discorrendo del commercio del petrolio. Barrow diceva che doveva arrivare un agente per certi interessi dei petroli; sarebbe stato al Regis da un giorno all’altro e Ben diceva che voleva conoscerlo e Barrow gli metteva il braccio sulla spalla e diceva di esser certo che Ben era proprio l’uomo che l’agente avrebbe voluto conoscere per acquistare una conoscenza utile e reale delle condizioni. Intanto Mac e Salvador ballavano il danzón cubano con le ragazze. Allora Barrow si alzò un po’ malfermo sulle gambe e disse che non voleva aspettare le ragazze francesi: perché non andavano invece in quel locale dov’erano già stati e non assaggiavano un po’ di carne mora? ma Salvador insistette per portarli alla casa Remedios vicino all’ambasciata americana. «Quelquecosa de chic» disse in cattivo francese. Era una grande casa con scalinata di marmo, lampadari di cristallo, panneggi salmone damascati, tendine di pizzo e specchi dappertutto. «Personne que les henerales vieng aqui» disse, quando li ebbe presentati alla signora, che era una donna capelli grigi e occhi scuri, vestita di nero, con uno scialle nero: una monaca, piuttosto, a vederla. Non c’era che una ragazza rimasta libera e così aggiustarono con lei Barrow, fissarono il prezzo e lo lasciarono. «Uff, che liberazione» disse Ben, quando uscirono. L’aria era fredda e il cielo tutto stelle. Salvador aveva fatto salire i tre vecchi con gli strumenti nei sedili posteriori della macchina e disse che si sentiva romantico e voleva far la serenata alla sua novia e uscirono verso Guadalupe, a una velocità pazza, sulla larga strada selciata. Mac, l’autista, Ben, Salvador e i tre vecchi cantavano La Adelita e gli strumenti ciangottavano, tutti fuori tempo. A Guadalupe, si fermarono sotto certi platani contro il muro di
una casa dalle grosse finestre inferriate e cantarono Cielito lindo e La Adelita e Cuatro milpas, e Ben e Mac cantarono The Foggy Foggy Dew, e stavano cominciando Oh Bury Me Not on the Lone Prairie, quando venne una ragazza alla finestra e parlò a lungo sommessamente in spagnolo con Salvador. Salvador disse: «Ella dit que nous fare escandalo e bisogna andare. Très chic». A questo punto, una pattuglia di soldati s’era avvicinata e stava per arrestarli tutti, quando arrivò l’ufficiale e riconobbe la macchina e Salvador e li portò a bere una volta con lui nel suo alloggio. Quando tornarono tutti a casa di Mac erano ubriachi fradici. Concha, con la faccia stiracchiata dalla veglia, preparò un materasso per Ben nella stanza da pranzo e, quando tutti stavano per andare a dormire, Ben disse: «Perdio, Concha, siete una brava ragazza. Quando avrò fatto fortuna, vi comprerò il più bel paio d’orecchini di diamante di tutto il distretto federale». L’ultima cosa che videro, di Salvador, fu lui in piedi sul sedile anteriore dell’auto che girava l’angolo su due ruote, e guidava i tre vecchi nell’Adelita con grandi gesti come un direttore d’orchestra. Prima di Natale, Ben Stowell ritornò da un viaggio a Tamaulipas, soddisfatto. Le cose si mettevan bene per lui. Aveva fatto un accordo con un generale locale vicino a Tampico per sfruttare un pozzo di petrolio, a metà per uno. Attraverso Salvador aveva stretto amicizia con certi membri del gabinetto di Carranza e sperava di riuscire a concludere un affare con qualcuno dei maggiori concessionari degli Stati. Aveva contanti in quantità e prese una camera al Regis. Un giorno si presentò alla tipografia e pregò Mac di uscire un momento con lui sul viale. «Sentite, Mac,» disse «ho un’offerta da farvi… Conoscete la libreria del vecchio Worthington? Ecco, ieri notte mi sono sbronzato e gliel’ho comprata per duemila pesos… Lui spianta la baracca e torna a casa a riposarsi, dice.» «Ma no!» «E sono ben contento di non averlo più nei piedi.» «Ah, vecchio puttaniere, è alla Lisa che state dietro.»
«Magari è altrettanto contenta lei di non averlo più nei piedi.» «E già ch’è una bella ragazza!» «Ho avuto un sacco di notizie che vi dirò dopo… Forse le cose non dureranno più così igieniche al “Mexican Herald”… Ho una proposta da farvi, Mac… Dio sa quanti obblighi ho con voi… Sapete, quel carico di mobili d’ufficio che avete là dietro, fatti comperare da Concha.» Mac accennò. «Ebbene, ve li toglierò d’intorno e vi darò metà interessi in quella libreria. Apro un ufficio. Voi v’intendete di libri, me l’avete detto voi, i profitti del primo anno saranno vostri e in seguito faremo a metà. Certamente saprete farli rendere. Ci riusciva quel vecchio cretino di Worthington e teneva la Lisa sul patto… Ci state allora?» «’Cidenti, lasciate che ci pensi, Ben… ma ora bisogna che torni allo sballagrosse quotidiano.» Così Mac si trovò a tenere una libreria in Calle Independencia, con un po’ di cancelleria e qualche macchina da scrivere. Era bello non avere altro padrone che se stesso, per la prima volta nella vita. Concha, che era la figlia di un bottegaio, fu incantata. Teneva lei i libri e parlava coi clienti, in modo che Mac aveva ben poco da fare, oltre a stare seduto nel retro, leggendo e chiacchierando con gli amici. Quel Natale, Ben e Lisa, una spagnola alta, che diceva d’aver fatto la ballerina a Malaga, pelle candida come le camelie e capelli d’ebano, diedero ogni sorta di ricevimenti in un alloggio con bagno e cucina all’americana, preso in affitto da Ben nel nuovo quartiere verso Chapultepec. Il giorno che l’Asociación de Publicistas tenne l’annuale banchetto, Ben entrò di buon umore nella libreria e disse a Mac che lui e Concha venissero dopo cena e Concha portasse due o tre sue amiche, ragazze distinte e ben costumate, non troppo schizzinose, come lei ne conosceva. Dava un ricevimento a G.H. Barrow di ritorno da Veracruz e a un importante individuo di New York, che veniva trattando qualcosa, Ben non sapeva bene che cosa. Aveva veduto Carranza il giorno innanzi e al banchetto tutti gli si erano prosternati. «Dio santo, Mac, avreste dovuto essere a quel banchetto, avevan preso un tram e una tavola che lo teneva tutto, e una banda, e si andò a San Ángel e ritorno e poi in giro per la città.» «Li ho veduti partire,» disse Mac «mi aveva troppo l’aria di un
funerale.» «Ostia, però è stato bello. C’erano Salvador e tutti, e questo tal Moorehouse, l’hombre importante di New York, ostia, aveva l’aria di non sapere se arrivava o partiva. Sembrava che aspettasse da un momento all’altro l’esplosione di una bomba sotto la sedia, che magnifica cosa per il Messico se fosse capitato, a pensarci bene. C’erano tutte le figure più sporche della città.» Il ricevimento in casa di Ben non riuscì tanto bene. J.W. Moorehouse non fece amicizia con le ragazze come Ben aveva sperato. Portò con sé la segretaria, una biondina dall’aria stracca, e tutti e due avevano un’aria atterrita da morire. Ci fu un pranzo uso messicano e champagne e cognac in abbondanza e un grammofono suonò dischi di Victor Herbert e Irving Berlin e una piccola banda ambulante attratta dalla folla suonò motivi messicani in strada, di fuori. Dopo il pranzo cominciava a esserci un po’ di baccano nella sala e così Ben e Moorehouse portarono sedie sul balcone e fecero una lunga conversazione sulla situazione dei petroli, fumando il sigaro. J. Ward Moorehouse spiegò di esser venuto in carattere strettamente privato, capite bene, per stabilir contatti, per studiare la situazione, che cosa ci fosse dietro la testarda opposizione di Carranza agli investitori americani, e che i grandi uomini d’affari coi quali era in rapporti negli Stati non chiedevano che un gioco leale e che lui era convinto che se il loro punto di vista potesse venir ben compreso, attraverso un qualche ufficio d’informazioni o la cooperazione amichevole dei giornalisti messicani… Ben tornò in sala da pranzo e ne riportò Enrique Salvador e Mac. Tutti insieme discorsero della situazione e J. Ward Moorehouse disse che, parlando da vecchio giornalista qual era stato anche lui, ben comprendeva la situazione della stampa, non troppo diversa probabilmente a Messico che a Chicago o a Pittsburgh, e che quanto occorreva ai giornalisti era di dare a ciascun lato nuovo della situazione il suo vero significato, secondo uno spirito di gioco leale e di cooperazione amichevole, ma s’accorgeva che i giornali messicani erano stati mal informati delle mire del commercio americano nel Messico, allo stesso modo che la stampa americana era mal informata
delle mire della politica messicana. Se il signor Enrique voleva passare al Regis, lui sarebbe stato lieto di parlargli insieme più ampiamente o con chiunque di voi signori e se lui non ci fosse, per via del gran spesseggiare di appuntamenti e del limitato numero di giorni che poteva passare nella capitale messicana, la sua segretaria, signorina Williams, sarebbe stata dispostissima a fornir loro qualunque informazione desiderassero e alcune note preparate in via speciale, e strettamente confidenziali, sull’atteggiamento delle grandi società americane, con le quali manteneva rapporti puramente amichevoli. Dopo di che, si scusò, ma al Regis lo attendevano dei telegrammi e Salvador condusse a casa lui e la segretaria, signorina Williams, nell’auto del capo di polizia. «Corpo, Ben, quello è un lazzarone che sa fare» disse Mac a Ben, dopo che J. Ward Moorehouse se ne fu andato. «Mac,» disse Ben «il piccino è tutto rivestito di una crema di milioni. Perdio, mi piacerebbe stringere uno di quei rapporti che dice… Sacrodio, son capace di farlo… Mi vedrete, Mac. Ho intenzione di mettermi coi grandi hombres, io, da oggi.» Dopo ciò, la riunione non fu più tanto fine. Ben tirò fuori altro cognac in abbondanza e gli uomini cominciarono a portar le ragazze nelle camere da letto e nei corridoi e persino nella dispensa e in cucina. Barrow si appiccicò a una bionda detta Nadia, mezza inglese, e le parlò tutta la sera dell’arte di vivere. Dopo che tutti se ne furono andati, Ben trovò i due chiusi a chiave nella sua camera. Mac cominciava a gustare la vita del bottegaio. Si alzava quando ne aveva voglia e camminava per le vie assolate, oltre la cattedrale e la facciata del Palacio Nacional e su per l’Independencia, dove i marciapiedi eran stati allora spruzzati di acqua e una brezza mattutina soffiava, dolce di odor di fiori e di caffè tostato. Il fratellino di Concha, Antonio, aveva tolto le imposte e stava scopando il negozio, quando lui vi giungeva. Mac sedeva nel retro leggendo oppure gironzolava per il negozio cianciando con la gente in inglese e in spagnolo. Non vendeva molti libri, ma teneva tutti i giornali e le riviste americane ed europee e queste si vendevano, specialmente «The Police Gazette» e «La vie parisienne». Aprì un conto corrente alla banca e progettava di
prendere una rappresentanza di macchine da scrivere. Salvador gli diceva sempre che gli avrebbe fatto avere un contratto per rifornire di cancelleria un qualche dicastero governativo e così sarebbe diventato ricco. Una mattina osservò una gran folla nella piazza di fronte al Palacio Nacional. Andò in una delle cantinas sotto l’arcata e ordinò un bicchiere di birra. Il cameriere gli disse che le truppe di Carranza avevano perduto Torreón e che Villa e Zapata stringevano sul distretto federale. Quando giunse alla libreria, andavano in giro notizie che il governo di Carranza era fuggito e che i rivoluzionari sarebbero entrati in città prima di notte. I bottegai cominciarono a metter su le imposte. Concha e sua madre giunsero in pianto, dicendo che sarebbe stato peggio della terribile settimana quand’era caduto Madero e che i rivoluzionari avevano giurato di incendiare e saccheggiare la città. Antonio venne di corsa dicendo che gli zapatistas stavano bombardando Tacuba. Mac prese una carrozza e andò alla Camera dei deputati, per vedere se poteva trovare qualcuno di sua conoscenza. Tutte le porte erano aperte sulla via e per i corridoi c’eran fogli sparpagliati. Nell’anfiteatro non c’era nessuno, tranne un vecchio indiano con la moglie, che andavano attorno tenendosi per mano, contemplando reverenti la volta indorata, le pitture e le tavole ricoperte di felpa verde. Il vecchio teneva in mano il cappello, come fosse in chiesa. Mac disse al vetturino di condurlo al giornale dove lavorava Salvador, ma là il portinaio gli disse ammiccando che Salvador era andato a Veracruz col capo di polizia. Allora Mac andò all’ambasciata, dove non poté scambiare una parola con nessuno. Tutte le anticamere erano piene di americani, giunti dai ranchos e dalle concessioni: maledicevano il presidente Wilson e si atterrivano a vicenda con le storie dei rivoluzionari. Al consolato Mac trovò un siriano che si offrì di acquistare la sua provvista di libri. «No, niente» disse Mac e ritornò per Calle Independencia. Quando fu al negozio, ragazzi strilloni scorrazzavano giù per la via gridando: «Viva la revolución reivindicadora». Concha e sua madre furon prese dal panico e dicevano che bisognava prendere il
treno per Veracruz, altrimenti sarebbero stati tutti trucidati. I rivoluzionari saccheggiavano conventi e ammazzavano preti e monache. La vecchia cadde in ginocchio in un angolo della stanza e cominciò a cantilenare avemmarie. «Diavolo» disse Mac. «Vendiamo tutto e torniamo agli Stati. Vuoi venire negli Stati, Concha?» Concha annuì energicamente e si mise a sorridere tra le lacrime. «Ma che diavolo ne facciamo della mamma e di Antonio?» Concha disse che aveva una sorella sposata a Veracruz. Potevano lasciarli là, se mai arrivavano a Veracruz. Mac, col sudore che grondava, ritornò di corsa al consolato in cerca del siriano. Non poterono intendersi sul prezzo. Mac era disperato, perché le banche erano tutte chiuse e nessuno poteva ritirar denaro. Il siriano diceva che lui veniva dal Libano, che era un cittadino americano, un cristiano e che avrebbe imprestato a Mac cento dollari, se Mac gli dava un’obbligazione a due mesi per duecento, con un’ipoteca sulla sua parte della libreria. Disse che lui era un cittadino americano, un cristiano e che arrischiava la vita per salvare quella della moglie e dei bambini di Mac. Mac era così scalmanato che notò appena in tempo come il siriano gli consegnasse cento dollari messicani e l’obbligazione fosse per dollari americani. Il siriano invocò la protezione di Dio su tutti e due e disse che era un errore e Mac se ne andò con duecento pesos oro. Trovò Concha già preparata. Aveva chiuso il negozio e stava sul marciapiede fuori, con qualche fagotto, i due gatti in un cestino, e Antonio con la madre, tutti e due fatti su in una coperta. Trovò la stazione talmente zeppa di gente e di bagagli, che non poterono entrare dalla porta. Mac andò sui binari e trovò un tale di nome McGrath che lui conosceva, impiegato alla ferrovia. McGrath disse che poteva accomodarli, ma occorreva far presto. Li mise in un carrozzone di seconda, ch’era fuori su per i binari, e si offrì di andar lui a prendere i biglietti, che probabilmente avrebbe dovuto pagare il doppio. Il sudore grondava da sotto il nastro del cappello di Mac, quando finalmente ebbe messo a sedere le due donne e sistemato il cestino dei gatti, i fagotti di Antonio. Il treno era già pieno, benché non avesse ancor manovrato nella stazione. Dopo parecchie ore finalmente
partì, e una fila di soldati polverosi respingeva dalla banchina la gente che cercava di dar l’assalto alle vetture di marcia. Ogni posto era occupato, i corridoi pieni di preti e monache, c’erano persone ben vestite che pendevano dalle piattaforme. Mac non aveva molte cose da dire, seduto vicino a Concha, nell’afa spessa del treno lento. Concha sospirava molto e sua madre sospirava «Ay de mi Dios» e rosicchiavano ali di pollo e mangiavano pasta di mandorle. Il treno veniva di frequente fermato da gruppi di soldati in pattuglia sulla linea. Su tronchi laterali c’erano vagoni scoperti carichi di truppa, ma pareva che nessuno sapesse di quale partito fossero. Mac guardava le infinite file a zigzag di alberi secolari e le chiese in rovina e contemplava i due gran vulcani nevosi, il Popocatepetl e l’Ixtaccíhuatl, mutar punto nell’orizzonte; poi ci fu un altro cono brunodorato di vulcano spento, che lentamente girava davanti al treno; poi fu il picco biancazzurro dell’Orizaba, che cresceva nella distanza, sempre più alto nel cielo senza nubi. Dopo Huamantla corsero all’ingiù attraverso le nubi. Le rotaie echeggiavano sotto lo strepito allegro delle ruote in curva giù per i ripidi pendii nel labirinto nebbioso della valle, attraverso umide foglie di foresta. Si cominciava a star meglio. A ogni voltata del treno, l’aria diventava più tiepida e umida. Si cominciavano a veder alberi d’aranci e di limoni. Tutti i finestrini erano aperti. Alle stazioni giungevano donne che vendevano birra, pulque, pollo e tortillas. A Orizaba ci fu di nuovo il sole. Il treno si fermò un bel po’. Mac sedeva da solo a bere birra nel ristorante della stazione. Gli altri viaggiatori ridevano e parlavano, Mac era tutto seccato. Quando suonò la campana, non ebbe voglia di tornare con Concha e sua madre e i sospiri e le dita unte e le ali di pollo. Salì su un’altra vettura. Scendeva la notte, piena dei profumi di fiori e di terra calda. Era tardi, il giorno dopo, quando giunsero a Veracruz. La città era piena di bandiere e di grossi stendardi rossi, tesi da muro a muro nelle vie color arancio, limone e banana, con le persiane verdi, e le palme ondeggianti al vento marino. Gli stendardi dicevano: “Viva Obregón, Viva la revolución reivindicadora, Viva el partido laborista”.
Nella piazza principale una banda suonava e la gente ballava. Cornacchie atterrite volavano crocidando tra i foschi alberi ombrelliformi. Mac lasciò Concha e i fagotti e la vecchia e Antonio su di una panca e andò all’ufficio della Ward Line per informarsi della traversata per gli Stati. Là tutti parlavano della guerra dei sommergibili, dell’entrata dell’America nella Grande guerra e delle atrocità tedesche e Mac seppe che non ci sarebbero stati piroscafi per una settimana e che lui poi non aveva denaro bastante neanche per due biglietti di terza. Prese un solo biglietto di terza. Gli era venuto il sospetto che si stava facendo fesso da sé e decise di partire senza Concha. Quando ritornò dov’era seduta, lei s’era comprata mele e manghi. La vecchia e Antonio erano andati coi fagotti a cercare la casa della sorella. I gatti bianchi eran fuori del cestino e le stavano accanto raggomitolati sulla panca. Concha alzò gli occhi neri in viso a Mac con un vivo sorriso di fiducia e disse che Porfirio e Venustiano erano felici perché annusavano pesce. Mac le tese le mani per aiutarla ad alzarsi. In quel momento non seppe dirle che aveva deciso di tornare agli Stati senza di lei. Antonio giunse di corsa e disse che avevano trovato la zia, che li aveva ricoverati e che tutti a Veracruz erano per la rivoluzione. Tornando a traversare la piazza principale, Concha disse che aveva sete e voleva bere. Stavan guardandosi intorno a cercare un tavolino vuoto davanti a uno dei caffè, quando i loro occhi caddero su Salvador. Lui balzò in piedi e abbracciò Mac e gridò «Viva Obregón» e presero uno sciroppo di menta all’americana. Salvador disse che Carranza era stato assassinato nelle montagne dal proprio stato maggiore; che Obregón, col suo unico braccio, era entrato a cavallo in Messico, vestito di cotone bianco, come un peone, coperto di un gran cappello da peone, alla testa dei suoi indiani Yaqui; che non c’erano stati disordini; che si sarebbero ristabiliti i princìpi di Madero e di Juárez e che stava per cominciare una nuova era. Bevettero vari sciroppi alla menta e Mac non parlò del suo ritorno in America.
Domandò a Salvador dove fosse il suo amico, capo di polizia, ma Salvador non udì. Poi Mac chiese a Concha: «E se tornassi in America senza di te», ma Concha rispose che scherzava. Disse che le piaceva Veracruz e avrebbe voluto abitarci. Salvador disse che stavano per venire grandi giorni per il Messico e che lui tornava a Messico il giorno dopo. Quella sera, mangiarono cena tutti insieme in casa della sorella di Concha. Mac provvide il cognac. Bevettero tutti ai lavoratori, alle Unioni, al partido laborista, alla rivoluzione sociale e agli agraristas. La mattina dopo Mac si svegliò presto con un po’ di mal di capo. Sgattaiolò fuori casa da solo e andò a passeggiare lungo il molo. Cominciava a pensare che era sciocco buttar via così la sua libreria. Andò all’ufficio della Ward Line e restituì il biglietto. L’impiegato gli rifuse il denaro e Mac ritornò in casa della sorella di Concha, in tempo a prendere con loro, per colazione, cioccolata e pasticcini.
Proteo Steinmetz era un gobbo, figlio di un litografo gobbo. Nacque a Breslavia nel 1865, si diplomò con la lode massima a diciassette anni nella scuola superiore di Breslavia, andò all’università di Breslavia a studiare matematiche; la matematica per Steinmetz valse la forza dei muscoli e le lunghe passeggiate sulle colline e il bacio di una ragazza innamorata e le belle serate trascorse a tracannare birra con gli amici; sulla sua schiena rotta sentì il peso schiacciante dall’alto, della società, a quel modo che lo sentivano i lavoratori sulle loro schiene diritte, a quel modo che lo sentivano gli studenti poveri; fu membro di un circolo socialista, editore di un giornale intitolato «La Voce del Popolo». Bismarck sedeva a Berlino come un grosso fermacarte a mantenere la nuova Germania feudale, a schiacciare l’Impero per i suoi padroni, gli Hohenzollern. Steinmetz dové fuggire a Zurigo per paura di finire in prigione; a Zurigo la sua matematica scosse tutti i professori del politecnico; ma l’Europa dell’Ottanta non era il posto per uno studente tedesco in bolletta con la schiena rotta e una grossa testa piena di calcolo simbolico e sogni sull’elettricità che è matematica resa potenza e in più socialista. Con un amico danese partì per l’America terza classe su un vecchio bastimento francese di servizio, La Champagne, visse in principio a Brooklyn e andava a Yonkers dove trovò un posto a 12 dollari la settimana con Rudolph Eickemeyer che era un esule tedesco del ’48 inventore ed elettricista e padrone di una fabbrica dove costruiva macchinari per far cappelli e generatori elettrici. A Yonkers mise insieme la teoria delle terze armoniche e la legge dell’isteresi che fissa in una formula i molteplici rapporti tra il calore metallico, la densità e la frequenza quando i poli mutan luogo nel centro di una calamita sotto una corrente alternata.
È la legge dell’isteresi di Steinmetz che rende possibili tutti i trasformatori che s’appiattano in cassettine e case a torretta in tutte le linee ad alta tensione dappertutto. I simboli matematici della legge di Steinmetz sono il modello di tutti i trasformatori in tutti i luoghi. Nel 1892, quando Eickemeyer liquidò tutto alla corporazione che avrebbe formato la General Electric, Steinmetz venne incluso nel contratto insieme con altro macchinario di valore. Per tutta la vita Steinmetz fu un pezzo del macchinario di proprietà della General Electric. Dapprima il suo laboratorio fu a Lynn poi venne traslocato e il gobbetto insieme, a Schenectady, la città elettrica. La General Electric lo pigliava per il suo verso, lo lasciava fare il socialista, gli lasciava tenere una serra piena di cactus illuminata da luci a mercurio, e alligatori, corvi parlanti e una lucertola dell’Arizona come favorita, e il reparto Pubblicità parlava del mago, dello stregone, che conosceva i simboli che spalancano le porte della taverna di Alì Babà. Steinmetz si scarabocchiava una formula sul polsino e il mattino dopo mille nuove centrali elettriche erano sorte e le dinamo cantavano a dollari e il silenzio dei trasformatori era tutto dollari, e il reparto Pubblicità versava ogni domenica melliflue storie nelle orecchie del pubblico americano e Steinmetz divenne il piccolo mago dei salotti, che produceva una tempesta in miniatura nel laboratorio e faceva correre a tempo tutti i treni giocattolo e la carne conservarsi fredda in ghiacciaia e la lampada nel salotto e i grandi fari e i riflettori e i raggi girevoli di luce che guidano gli aeroplani di notte verso Chicago, New York, St. Louis, Los Angeles, e lo lasciavano fare il socialista e credere che la società umana si possa migliorare come si può migliorare una dinamo e lo lasciarono fare il germanofilo e scrivere una lettera offrendo a Lenin i suoi servizi perché i matematici sono gente così poco pratica che trova formule con le quali si possono costruire centrali, fabbriche, sistemi di sotterranea, luce, calore, atmosfera, sole, ma non rapporti umani che tocchino il denaro degli azionisti e gli stipendi dei direttori.
Steinmetz era un mago famoso e parlò con Edison battendo secondo il codice Morse sul ginocchio di Edison perché Edison era tanto sordo e se ne andò nell’Ovest a far discorsi che nessuno capiva e parlò con Bryan di Dio sopra un treno e tutti i giornalisti erano intorno quando lui ed Einstein s’incontrarono a faccia a faccia, ma non poterono afferrare quel che dicevano e Steinmetz era il più prezioso pezzo di macchinario che la General Electric possedesse finché si consumò e morì.
Janey Il viaggio a Messico e la vettura riservata, che il governo messicano mise a disposizione di J. Ward Moorehouse per ritornare nel Nord, furono piacevoli ma un po’ tediosi e ci fu tanta polvere nella traversata del deserto. Janey comprò per pochissimo graziosissime cose, certi gioielli di turchese e onice rosa, da portare a casa in dono ad Alice, alla mamma e alle sorelle. Viaggiando in vettura riservata, J. Ward la tenne occupata a scrivere sotto dettatura e c’era un grosso gruppo di uomini sempre a bere, fumar sigari e ridere di barzellette sconce nel fumatoio e sul belvedere. Uno era quel tal Barrow per cui lei aveva lavorato a Washington. Ora si soffermava sempre a parlarle insieme e a Janey non piaceva come gli diventavano gli occhi, quando si piegava al suo tavolino parlandole; pure, era un uomo interessante e divertentissimo da come lei si era immaginata un capopartito operaio, e la divertiva pensare che lei sapeva di Queenie e che salto avrebbe fatto Barrow se avesse saputo che lei sapeva. Scherzava molto con lui e pensava che magari aveva preso per lei una cotta, ma era un tipo d’uomo da comportarsi così con qualunque donna. Dopo Laredo, non ebbero più la vettura riservata e il viaggio non fu così bello. Proseguirono difilato fino a New York. Janey aveva una cuccetta bassa in una vettura diversa da quella di J. Ward e dei suoi amici e nella cuccetta disopra c’era un giovanotto che le piaceva moltissimo. Si chiamava Buck Saunders, veniva dal corridoio del Texas e parlava col più buffo degli accenti. Aveva governato bestiame e lavorato nei campi petroliferi dell’Oklahoma; si era messo da parte un po’ di denaro e andava a vedere Washington. Fu tutto allegro quando Janey gli disse che lei era di Washington, e gli spiegò bene tutto ciò che doveva vedere: il Campidoglio, la Casa Bianca, il Lincoln Memorial, il monumento a Washington, la Casa dei Veterani e il Mount Vernon. Gli raccomandò di andare a vedere le Grandi Cascate e gli parlò delle sue gite sul canale e come lei era stata colta una volta da un temporale vicino al Cabin’s John Bridge. Mangiarono insieme diversi pasti in vettura ristorante e Saunders le disse che era una ragazza in gamba, che toglieva la soggezione e che lui ne aveva una a
Tulsa, Ok., e avrebbe cercato lavoro nel Venezuela, a Maracaibo nei campi petroliferi, perché quella l’aveva scartato per sposare un contadinaccio ricco che si era trovato petrolio nei pascoli. G.H. Barrow stuzzicò Janey per quella sua bella conquista e Janey gli chiese della signora rossa scesa a St. Louis e risero e Janey sentì d’esser tremenda e che G.H. Barrow non era dopo tutto tanto male. Buck, scendendo dal treno a Washington, le diede una sua istantanea presa accanto a una gru da petrolio e disse che le avrebbe scritto tutti i giorni e sarebbe venuto a New York a trovarla, se glielo permetteva, ma Janey non ne seppe mai più nulla. Le piaceva anche Morton, il domestico londinese, perché le rivolgeva sempre la parola con tanto rispetto. Tutte le mattine giungeva e riferiva dell’umore di J. Ward. «Ha un’aria nera stamattina, signorina Williams» oppure «Fischiettava radendosi. Se si sente bene? Sembra». Quando giunsero a New York, stazione di Pennsylvania, Janey dovette fermarsi con Morton per vigilare che la cassetta delle schede andasse all’ufficio della Quinta Avenue, 100, e non fino a Long Island, dov’era la casa di J. Ward. Accompagnò Morton alla partenza in una Pierce-Arrow che veniva apposta da Great Neck per prendere il bagaglio e andò sola all’ufficio in un tassì con la sua macchina da scrivere, le carte e le schede. Era spaventata ed eccitata a guardar fuori del finestrino dell’auto gli altissimi edifici candidi e le vasche rotonde contro il cielo e i buffi di fumo all’insù e i marciapiedi affollati di gente e tutti i tassì, i carri, il luccichio, le spinte, il frastuono. Si domandava dove avrebbe trovato una camera da vivere e come le amicizie e dove avrebbe mangiato. Le dava un gran sbigottimento esser così sola a quel modo nella grande città e si stupì di aver avuto il coraggio di venirci. Decise di provare a cercar lavoro per Alice e di prendere insieme un alloggio, ma dove sarebbe andata per quella notte? Quando fu all’ufficio, tutto le parve naturale e rassicurante e così bene ammobiliato e lucidato, così splendido, e le macchine battevano così veloci e c’era tanto più movimento e confusione che negli uffici di Dreyfus e Carroll; ma tutti avevan l’aria di ebrei e Janey ebbe paura di non andare a genio, paura di non saper tenere il posto.
Una ragazza di nome Gladys Compton la condusse al suo tavolino, che, le disse, era stato quello della signorina Rosenthal. Era in un piccolo passaggio, a due passi dall’ufficio privato di J. Ward, di fronte all’uscio dell’ufficio del signor Robbins. Gladys Compton era ebrea e stenografa del signor Robbins e disse che cara ragazza era stata la signorina Rosenthal e come rincresceva a tutti, nell’ufficio, di quella disgrazia e Janey sentì che entrava negli abiti di un morto e che avrebbe avuto una cattiva gatta da pelare. Gladys Compton la fissava con occhi bruni e risentiti, leggermente strabici quand’erano intenti a qualcosa, le disse che sperava se la sarebbe potuta cavare nel lavoro, che talvolta era un vero ammazzamento, e se ne andò. Quando si chiuse, alle cinque, J. Ward uscì dal suo ufficio privato. Janey fu così contenta di vederselo vicino al tavolino. Le disse che aveva parlato con la signorina Compton e chiestole di prendersi un po’ di cura di Janey, le prime volte, e che sapeva quanto fosse difficile per una ragazza orientarsi in una città nuova, trovare un luogo adatto da viverci e tutto il resto, ma che la signorina Compton era una ragazza molto come si deve e le avrebbe dato aiuto e lui era certo che tutto sarebbe andato benissimo. Le fece un azzurro sorriso e le porse un pacco di biglietti scritti fittissimo, dicendo se voleva disturbarsi a venire all’ufficio un po’ presto domani mattina e farglieli trovare tutti dattilografati sulla scrivania alle nove. Non le avrebbe chiesto d’abitudine di fare un lavoro simile, ma tutte le dattilografe eran così stupide e ogni cosa talmente in baraonda per via della sua assenza. Janey non fu che troppo lieta di poterlo fare e si riscaldò tutta al suo sorriso. Janey e Gladys Compton uscirono insieme dall’ufficio. Cladys Compton le suggerì se, visto che lei non conosceva la città, non era meglio venisse a casa sua. Abitava in Flatbush con padre e madre e non era certo così ch’era abituata la signorina Williams; ma avevano una camera d’avanzo che potevan cederle finché lei non si fosse ambientata, e se non altro era pulita, cosa che non si poteva dire di molti altri luoghi. Passarono dalla stazione per ritirare la valigia di Janey. Janey si sentì togliere un peso a non doversi cercar la strada da sola in mezzo a tutta quella folla. Poi scesero nella sotterranea e
salirono su un diretto, zeppo fino agli sportelli, e Janey non credette di poter resistere così schiacciata stretto con tanta gente. S’immaginò di non arrivare mai più e i treni facevano un tale fracasso nella galleria che non si sentiva quel che la collega diceva. Finalmente uscirono in un’ampia via percorsa da un’aerea, dove le case eran tutte di un piano o due, e i negozi, drogherie e commestibili. Gladys Compton disse «Mangiamo kosher, signorina Williams, per via dei vecchi. Spero non vi importerà. Naturalmente Benny – Benny è mio fratello – e io non abbiamo pregiudizi». Janey non sapeva cosa fosse il kosher, ma disse che certo non le importava e raccontò all’altra ragazza quant’erano curiosi i cibi nel Messico, talmente pepati che quasi non si potevano mangiare. Giunti alla casa, Gladys Compton cominciò a pronunciare le parole meno correttamente e diventò molto gentile e premurosa. Suo padre era un vecchietto con gli occhiali sulla punta del naso, e la madre una donna grassa a forma di pera, con la parrucca. Tra loro parlavano in yiddish. Fecero tutto il possibile per mettere a suo agio Janey e le diedero una bella camera e dissero che con dieci dollari settimanali avrebbe pagato cibo e alloggio, finché le fosse piaciuto restare, e che quando avesse voluto andarsene, andasse e tutti amici. La casa era una baracca gialla per due famiglie in un lungo isolato di case tutte esattamente uguali, ma era ben riscaldata e il letto comodo. Il vecchio era orologiaio e lavorava da un gioielliere nella Quinta Avenue. In patria il loro nome era stato Kompshchski, ma dicevano che a New York nessuno sapeva pronunciarlo. Il vecchio avrebbe voluto assumere il nome di Freedman; ma sua moglie aveva pensato che Compton suonasse più fine. Fecero una buona cena con tè in bicchieri e brodo con ripieni e caviale rosso e Gefilte Fisch, e a Janey parve molto bello conoscere persone così. Benny, il ragazzo, andava ancora alla scuola media, uno spilungone giovane dai grossi occhiali, che mangiava con la testa abbassata nel piatto e aveva un modo brutale di contraddire a qualunque cosa uno dicesse. Gladys disse di scusarlo, che era molto bravo nei suoi studi e avrebbe studiato legge. Quando la riservatezza fu un po’ scomparsa, Janey prese a benvolere i Compton, specialmente il vecchio signor Compton, che era gentilissimo e
trattava ogni avvenimento con un amabile e desolato sorriso. Il lavoro all’ufficio era così interessante. J. Ward cominciava a fidarsi di lei nelle cose. Janey sentiva che sarebbe stata una bell’annata. La cosa peggiore era la corsa mattutina di tre quarti d’ora nella sotterranea fino a Union Square. Janey tentava di leggere il giornale e di ficcarsi in un angolo lontano dalla calca dei corpi. Le piaceva arrivare all’ufficio radiosa e vibrante con i vestiti a posto e i capelli in ordine, ma la lunga corsa sobbalzante la stremava, le metteva una voglia di tornare a vestirsi e di prendere un bagno. Le piaceva camminare per la Quattordicesima Strada tutta sgargiante e rilucente, all’alba, nella polvere assolata, e lungo la Quinta Avenue, fino all’ufficio. Lei e Gladys erano sempre tra i primi a entrare. Janey teneva fiori sul tavolino e talvolta entrava di soppiatto e poneva due o tre rose in un vaso d’argento sulla larga scrivania di mogano di J. Ward. Poi gli divideva la posta, metteva le lettere personali in una bella pila sull’angolo della cartella assorbente montata in una specie di cornice di cuoio rosso italiano miniato; leggeva le altre, dava un’occhiata al taccuino degli impegni e gli scriveva a macchina un piccolo elenco di appuntamenti, interviste, articoli da pubblicare, dichiarazioni alla stampa. Metteva l’elenco in mezzo alla cartella sotto un fermacarte di rame grezzo della Penisola superiore del Michigan, cancellando con un bel W. tutte le cose che poteva sbrigar lei senza bisogno di consultarlo. Quando, già di ritorno al suo tavolino, stava correggendo l’ortografia dei dattiloscritti usciti dall’ufficio del signor Robbins il giorno prima, le cominciava a nascere dentro un curioso formicolio; presto sarebbe entrato J. Ward. Diceva a se stessa che quella era una stupidaggine, ma ogni volta che la porta esterna dell’ufficio si apriva, lei alzava gli occhi in attesa. Cominciava a provare qualche preoccupazione: che gli fosse toccata una disgrazia venendo in macchina da Great Neck? Poi, quando non l’attendeva più, ecco che lui entrava affrettatamente con un vivace sorriso a tutti intorno, e l’uscio smerigliato dell’ufficio privato gli si richiudeva alle spalle. Janey notava se era vestito di scuro o di chiaro, di che colore aveva la
cravatta, se aveva i capelli tagliati da poco o no. Un giorno che J. Ward aveva una pillacchera di fango sulla gamba dei calzoni blu, Janey non poté levarsela dalla testa per tutto il mattino e cercò di trovare un pretesto per entrare a dirglielo. Qualche volta lui la guardava direttamente, passando, con un lampo negli occhi azzurri, oppure si fermava a farle una domanda. Allora Janey era felice. Il lavoro all’ufficio era così interessante. La faceva vivere in mezzo ai titoli di prima pagina, come quando faceva discorsi con Jerry Burnham, ancora da Dreyfus e Carroll. C’era l’affare dei prodotti salini Onondaga e certa letteratura sui sali da bagno e i prodotti chimici e la squadra di baseball impiegati e la cafeteria e le pensioni per la vecchiaia; Marigold Copper e la lotta contro le tendenze sovversive tra i minatori, la maggior parte stranieri, che bisognava educare ai princìpi dell’americanismo; la campagna della Camera di Commercio di Citrus Center, volta a educare i piccoli investitori del Nord nelle qualità solide e costruttive dell’industria della frutta in Florida, e il motto da lanciare “Mettete una pera avocado su ogni tavola” per la Avocado Producers Cooperative. Quell’azienda ogni tanto ne inviava una cassetta in modo che tutti all’ufficio avevano una pera avocado da portare a casa, tranne il signor Robbins che non ne voleva e diceva che sapevano di sapone. Attualmente l’affare più importante di tutti era la campagna per la Southwestern Oil contro l’insidiosa propaganda antiamericana nel Messico delle compagnie di petrolio inglesi e contro l’azione interventista degli interessi Hearst a Washington. A giugno, Janey si recò alle nozze della sorella Ellen. Fu una cosa curiosa ritornare a Washington. Viaggiando sul treno, Janey si ripromise molto di veder Alice, ma quando le fu insieme pareva non trovassero più troppe cose da dirsi. Si sentì disambientata in casa della mamma. Ellen sposava uno studente in legge dell’università di Georgetown, ex pensionante, e la casa dopo il matrimonio fu piena di studenti e giovani studentesse. Tutte giravano ridendo e ghignando e la signora Williams e Francie parevano molto compiaciute, ma Janey fu contenta quando venne il momento di ritornare alla stazione e riprendere il treno per New York. Quando disse addio ad Alice, non le parlò di venire anche lei a New York a cercarsi un alloggio.
Stette malissimo nel viaggio di ritorno, seduta nel vagone che sapeva di chiuso, a guardare città, campi e insegne. Tornare all’ufficio, la mattina dopo, fu come tornare a casa. Era appassionante a New York. L’affondamento del Lusitania aveva fatto sentire a tutti che l’entrata in guerra dell’America non era più che questione di mesi. C’erano molte bandiere lungo la Quinta Avenue. Janey pensava molto alla guerra. Ebbe dalla Scozia una lettera di Joe che era stato silurato sul piroscafo Marchioness; avevano passato dieci ore in una barca scoperta sotto una nevicata al largo del Pentland Firth, con la corrente che li spingeva in alto mare, ma poi avevano approdato e lui stava bene e tutto l’equipaggio aveva avuto premi e insomma lui guadagnava molto. Letta la lettera, Janey entrò a veder J. Ward con un telegramma giunto allora dal Colorado e gli disse del fratello silurato e lui s’interessò molto. Parlò di patriottismo e del dovere di salvare la civiltà e delle storiche bellezze della cattedrale di Reims. Disse che era pronto a compiere il suo dovere, quando venisse l’ora e che pensava che l’entrata in guerra dell’America fosse soltanto questione di mesi. Una donna vestita molto bene veniva spesso a far visita a J. Ward. Janey guardava con invidia quella bella carnagione, quegli abiti eleganti, non vistosi ma molto chic, e le unghie curate e i piedini sottili. Un giorno la porta si spalancò e Janey poté sentir lei e J. Ward parlare insieme familiarmente. «Ma J.W., caro,» diceva «quest’ufficio è un orrore. È come gli uffici che c’erano a Chicago nell’Ottanta.» J. Ward rideva. «Ebbene, Eleanor, perché non me lo rifate voi stessa? Soltanto che il lavoro sia fatto senza dare inciampo agli affari. Non posso traslocarmi, con la ressa di affari importanti che ho adesso.» Janey ne fu piena d’indignazione. L’ufficio era bello così com’era, distintissimo, lo dicevano tutti. Si chiese chi mai poteva essere questa donna che metteva idee in testa a J. Ward. Il giorno dopo, quando dovette preparare un assegno di duecento e cinquanta dollari come acconto a Stoddard e Hutchins, Decorazione d’interni, quasi disse ciò che ne pensava, ma dopo tutto non erano cose che la riguardassero. Dopo quella volta parve che la signorina Stoddard fosse sempre nell’ufficio. Il lavoro veniva fatto nottetempo, in modo che ogni
mattina Janey, giungendo, trovava qualcosa di mutato. Ricoprivano tutto di bianco e nero, con tendine e tappezzeria di un buffo color vino. A Janey non piaceva affatto, ma Gladys disse che era alla moderna e molto interessante. Il signor Robbins rifiutò di lasciar toccare il suo cantuccio privato, e lui e J. Ward quasi ci litigarono, ma alla fine si fece come voleva lui e girò la voce che J. Ward avesse dovuto aumentargli lo stipendio per impedirgli di passare a un’altra agenzia. Il giorno del Lavoro, Janey traslocò. Le dispiaceva lasciare i Compton, ma aveva trovato una donna di mezz’età, di nome Eliza Tingley, che lavorava per un avvocato allo stesso piano dell’ufficio di J. Ward. Eliza Tingley veniva da Baltimora e aveva sostenuto un esame di legge: Janey si disse che quella era certo una donna navigata. Lei e il fratello gemello, ragioniere diplomato, avevano preso un piano in una casa della Ventitreesima Strada Ovest, in quartiere Chelsea, e dissero a Janey di venire a stare con loro. Ciò voleva dire evitare la sotterranea e Janey sentì che la passeggiatina fino alla Quinta Avenue, ogni mattina, le avrebbe fatto bene. Eliza Tingley, dall’istante che l’aveva veduta al banco di trattoria al pianterreno, le era piaciuta. Tutto coi Tingley era libero e disinvolto, e Janey ci si sentiva come a casa propria. Di tanto in tanto alla sera bevevano qualcosa. Eliza era una buona cuoca e impiegavano molto tempo a mangiare e, prima di andare a letto, giocavano un paio di partite a bridge in tre. Il sabato sera andavano quasi sempre a teatro. Eddy Tingley prendeva i biglietti da un’agenzia a riduzioni, che lui conosceva. Si abbonarono al «Literary Digest», al «The Century» e al «Ladies Home Journal» e la domenica mangiavano pollo arrosto oppure anatra e leggevano la sezione rivista del «New York Times». I Tingley avevano molti amici e amavano Janey e la includevano in tutto quel che facevano e lei sentiva di vivere come desiderava. Fu tutto un fremito quell’inverno, con le continue voci di guerra. Tenevano una grande carta di Europa appesa alla parete della stanza comune e segnavano con bandierine le posizioni degli eserciti alleati. Erano corpo e anima per gli Alleati e nomi come Verdun e Chemindes-Dames davan loro piccoli brividi giù per la schiena. Eliza si
struggeva di viaggiare e faceva raccontare e ripetere a Janey ogni particolare del suo viaggio al Messico; cominciarono a progettare un giro all’estero insieme, per quando la guerra fosse finita, e Janey si mise a risparmiare il denaro. Quando Alice scrisse da Washington che forse avrebbe levato le tende e traslocato a New York, Janey le rispose che per il momento era tanto difficile per una ragazza trovar lavoro a New York e che non le pareva un’idea troppo felice. Tutto quell’autunno J.W. fu, in viso, pallido e stiracchiato. Prese l’abitudine di venire all’ufficio la domenica pomeriggio e Janey non fu che troppo lieta di correrci dopo pranzo, per dargli una mano. Discorrevano degli avvenimenti della settimana nell’ufficio e J. Ward le dettava un sacco di lettere private, dicendole che lei era un tesoro e lasciandola là, felice, a battere i tasti. Anche Janey era preoccupata. Benché continuamente ci fossero nuovi affari, la ditta finanziariamente non era nella migliore delle situazioni. J. Ward aveva tentato certi colpi disgraziati in Wall Street, e aveva il suo da fare a mandare avanti la baracca. Era ansioso di far suoi i titoli ancora nelle mani della vecchia signora Staple e parlava di biglietti di cui sua moglie s’era impadronita e della sua paura che la moglie se ne servisse imprudentemente. Janey capiva che quella moglie era una donna arcigna e antipatica, che cercava di adoperare il denaro di sua madre come mezzo per non lasciarsi sfuggire J. Ward. Non disse mai nulla ai Tingley a proposito di J. Ward in persona, ma parlava molto degli affari e i due convennero con lei che il suo lavoro era molto interessante. Per il Natale di quest’anno era in attesa, perché J. Ward le aveva lasciato intendere che le avrebbe dato un aumento. Un piovoso pomeriggio di domenica, Janey stava dattilografando una lettera confidenziale al giudice Planet, che accludeva un rapporto di un’agenzia di polizia inteso a descrivere l’attività degli agitatori operai tra i minatori del Colorado, e J. Ward passeggiava in su e in giù davanti alla scrivania, fissandosi con le ciglia abbassate le punte lucide delle scarpe, quando s’udì una bussata alla porta esterna dell’ufficio. «Chi sa chi può essere?» disse J. Ward. C’era qualcosa di imbarazzato e di nervoso nel modo come parlava. «Può darsi che il signor Robbins abbia dimenticato la chiave» disse Janey. Andò a vedere. Aprì la porta
e la signora Moorehouse le passò sui piedi. Indossava un impermeabile bagnato e portava il paracqua: aveva il viso pallido e le narici contratte. Janey chiuse riguardosamente la porta e andò al suo tavolino, sedendosi. Era seccata. Prese una matita e cominciò a disegnar volute sull’orlo di un foglio di carta da macchina. Non poteva fare a meno di sentire quel che accadeva nell’ufficio privato di J. Ward. La signora Moorehouse era piombata dentro, sbattendosi dietro l’uscio smerigliato. «Ward, non ne posso più… Non reggo più un altro minuto» urlava con tutta la sua voce. A Janey cominciò a battere il cuore. Udì la voce sommessa e conciliante di J. Ward, poi quella della signora Moorehouse. «Non mi lascio trattare così, ti dico. Non sono una bambina da trattarmi così… Tu approfitti del mio stato. La mia salute non può reggere a un trattamento simile.» «Ma senti, Gertrude, sul mio onore di gentiluomo» diceva J. Ward. «Non c’è nulla di nulla, Gertrude. Tu stando a letto immagini chi sa che cosa, e poi non dovresti capitarmi addosso in questo modo. Ho molto da fare io. Ho importanti transazioni che richieggono tutta la mia attenzione.» “È davvero troppo” diceva Janey tra sé. «Tu saresti ancora a Pittsburgh a lavorare per la Bessemer Products, Ward, se non fosse per me, e lo sai… Puoi disprezzare me, ma non disprezzi il denaro di papà… ma è finita, ti dico. Voglio chiedere il divorzio…» «Ma, Gertrude, lo sai benissimo che non c’è altra donna nella mia vita.» «E questa donna che è sempre in giro insieme con te, continuamente, come si chiama, Stoddard? Vedi che ne so più di quel che pensi… Non sono la donna che tu credi, Ward. Non riuscirai a farmi passare per stupida, capisci?» La voce della signora Moorehouse s’innalzò in uno strido arrangolato. Poi parve s’accasciasse e Janey la sentì singhiozzare. «Su, Gertrude» fece la voce carezzevole di Ward. «Ti sei tutta agitata per niente… Eleanor Stoddard ha avuto con me qualche rapporto di affari… È una donna d’ingegno e la trovo stimolante… intellettualmente, tu capisci… Abbiamo qualche volta pranzato insieme, di solito con amici comuni, ecco…» Poi la voce gli si fece così sommessa che Janey non poté udire che cosa diceva. Cominciò a
pensare che avrebbe dovuto andarsene. Non sapeva che fare. Si era mezzo levata in piedi, quando la voce della signora Moorehouse salì di nuovo a uno strido isterico. «Oh sei freddo come un sasso… Sei un sasso, tu. Vorrei che lo fossi, piuttosto che tu avessi una relazione con lei… Ma non m’importa, non mi lascerò usare come uno strumento per il denaro di papà.» L’uscio dell’ufficio si aprì, la signora Moorehouse venne via, diede a Janey un’occhiata amara, come sospettasse anche da parte sua rapporti con J. Ward, e uscì. Janey risedette al tavolino, cercando di pigliare un’aria indifferente. Dentro l’ufficio privato sentiva J. Ward andare in su e in giù con un passo pesante. Quando la chiamò, aveva la voce fiacca. «Signorina Williams.» Janey si alzò ed entrò nell’ufficio privato con matita e taccuino in mano. J. Ward cominciò a dettare come nulla fosse stato, ma a metà di una lettera al presidente della società Ansonia Carbide disse d’improvviso «Oh diavolo» e diede al cestino un calcio che lo mandò roteante contro la parete. «Scusatemi, signorina Williams, sono molto preoccupato… Signorina Williams, sono certo che voi non vorrete accennare ad anima viva… Voi capite, mia moglie non è più in se stessa, è stata malata… l’ultimo bambino… sapete che talvolta queste cose accadono alle donne.» Janey alzò gli occhi a guardarlo. Le eran venute le lacrime agli occhi. «Oh, signor Moorehouse, come potete pensare che non vi comprenda… Dev’essere terribile per voi, e la vostra è una grande opera, così interessante.» Non poté dir altro. Le sue labbra non potevano formar parole. «Signorina Williams,» diceva J. Ward «vi sono… uh… grato… uh.» Poi tirò su il cestino. Janey balzò in piedi e lo aiutò a raccogliere i rifiuti e i fogli spiegazzati che si erano sparsi sul pavimento. La faccia di J. Ward era rossa per lo sforzo di curvarsi. «Gravi responsabilità… una donna irresponsabile può molto nuocere, mi capite.» Janey assentì più volte. «Be’, dov’eravamo? Terminiamo e usciamo di qui.» Posero il cestino sotto la scrivania e ricominciarono con le lettere. Per tutta la strada verso casa, a Chelsea, Janey, dirigendosi tra la
fanghiglia e le pozzanghere delle vie, pensava a ciò che le sarebbe piaciuto aver detto a J. Ward per fargli comprendere che tutti quelli dell’ufficio sarebbero stati con lui, qualunque cosa accadesse. Quando fu a casa, Eliza Tingley le disse che un uomo le aveva telefonato. «Parso un tipo piuttosto rustico, non ha voluto lasciare il nome, detto solo di dire che aveva telefonato Joe e che avrebbe ritelefonato.» Janey si sentì addosso scrutatori gli occhi di Eliza. «È mio fratello Joe, credo… Lavora in marina mercantile.» Arrivarono certi amici dei Tingley, fecero due tavolini di bridge e passavano una serata molto lieta, quando il telefono trillò di nuovo: era Joe. Janey sentì di arrossire, parlandogli. Non poteva invitarlo a venire e pure desiderava vederlo. Gli altri la chiamavano che andasse a fare la sua giocata. Joe disse che era arrivato allora e aveva per lei qualche regalo; che era subito andato in Flatbush e gli ebrei di là gli avevan detto che lei ora stava in Chelsea; telefonava ora dal tabaccaio all’angolo dell’Ottava Avenue. Gli altri la chiamavano che andasse a fare la sua giocata. Janey si trovò a dire che era molto occupata in un certo lavoro e se voleva trovarsi alle cinque, domani, sotto l’ufficio dove lei lavorava. Gli chiese di nuovo come stava e Joe disse «Bene», ma pareva deluso. Quando Janey tornò al tavolino, tutti la stuzzicavano per via dell’amico e lei rise e arrossì, ma nel suo intimo si sentiva spregevole perché non aveva detto a Joe di venirla a trovare. La sera dopo nevicava. Uscendo dall’ascensore zeppo di gente, alle cinque, si guardò attorno nel vestibolo, ansiosa. Joe non c’era. Mentre diceva buona sera a Gladys, lo vide attraverso la porta. Era in piedi, fuori, le nuvole di fiocchi di neve gli turbinavano intorno al volto, che appariva solcato, rosso e logoro dalle intemperie. «Ciao, Joe» disse. «Ciao, Janey.» «Quando sei arrivato?» «Due giorni fa.» «Sei in gamba, Joe, come stai?» «Male alla testa oggi… Stanotte ero fradicio…» «Joe, mi è proprio dispiaciuto ieri, ma c’era tanta gente e io volevo
vederti da sola per poter parlare.» Joe grugnì. «Ma sì, Janey… Ostia, sei ben messa tu. Se qualche collega mi vede con te, crederanno che ho fatto una bella conquista.» Janey si sentì a disagio. Joe portava grosse scarpe di fatica e c’eran zacchere di vernice grigia sui suoi calzoni. Sotto braccio teneva un pacco fatto su in un giornale. «Andiamo a mangiare in qualche posto… Giuda, mi dispiace di esser così malandato. Ma abbiamo perduto tutto il vestiario, quando ci hanno silurati.» «Vi hanno di nuovo silurati?» Joe rise. «E già, al largo del Capo Race. È una gran vita. Quest’è il secondo colpo… Però ti ho portato lo scialle, perdio, altrimenti… So dove mangiare, andiamo da Lüchow.» «Ma la Quattordicesima non è…» «No, no, hanno una sala per le signore… Janey, non crederai che ti voglia portare in una tampa che non sia come si deve.» Mentre traversavano Union Square, un giovanotto male in arnese, dal maglione rosso, disse: «Ehi, Joe». Joe lasciò andare innanzi Janey di qualche passo e lui e il giovanotto si parlarono all’orecchio. Allora Joe gli fece scorrere un biglietto, dicendo: «Salute, Tex» e corse dietro a Janey, che proseguiva, un po’ a disagio. Non le garbava la Quattordicesima Strada, quand’era buio. «Cos’era, Joe?» «Qualche lurido marinaio, vassapere, l’ho conosciuto a New Orleans… Lo chiamo Tex, non so come si chiama… È molto mal ridotto.» «Sei stato a New Orleans?» Joe assentì. «Portavamo un carico di melassa sull’Henry B. Higginbotham… Piginbottom dicevamo noi. Proprio. Adesso è ferma davvero al fondo… 1 al fondo dei Grand Banks.» Quando entrarono nel ristorante, il capocameriere li guardò attento e li mise a un tavolino nell’angolo di una saletta interna. Joe ordinò un cenone con birra, ma a Janey non piaceva la birra, così lui dovette bersi anche la sua. Dopo che Janey gli ebbe comunicato tutte le notizie della famiglia e come lei aveva il suo lavoro e aspettava un
aumento a Natale e si trovava così bene coi Tingley che le facevano tante gentilezze, non parve ci fosse molto altro da dire. Joe aveva comprato biglietti per l’Hippodrome, ma c’era tempo d’avanzo, prima che cominciasse. Sedevano in silenzio bevendo il caffè e Joe tirava a un sigaro. Janey finalmente disse che era una vergogna che il tempo fosse così brutto e come dovevano star male i poveri soldati nelle trincee e che gli unni erano troppo troppo barbari e il Lusitania e com’era sciocca l’idea di Ford della nave della pace. Joe rise in quel curioso modo secco che aveva ora di ridere e disse: «Compassiona i poveri marinai in mare in una notte come questa». Si alzò a prendere un altro sigaro. Janey pensò come aveva fatto male Joe a farsi radere sulla nuca, quando si era fatto tagliare i capelli: aveva il collo arrossato, con tante rughettine. Pensò alla vita aspra che doveva aver passato e, quando fu di ritorno, gli domandò perché non cercava un altro lavoro. «Vuoi dire in un cantiere? Si guadagna un sacco di soldi in cantiere, ma accidenti, Janey, preferisco girare… È tutto per l’esperienza, come diceva quel tale che gli tagliavano la testa.» «No, ma c’è dei ragazzi nel mio ufficio che non sono a metà svegli come te e hanno posti bellissimi… e un avvenire da sperare.» «Tutto il mio avvenire è già passato» disse Joe con una risata. «Potrei andare a Perth Amboy e lavorare in una fabbrica di munizioni, ma preferisco saltare in aria all’aperto.» Janey proseguì a parlare della guerra e quanto avrebbe desiderato che entrassero per salvare la civiltà e il povero Belgio inerme. «Cambia disco, Janey» disse Joe. Fece un gesto come di troncare, con la sua manona rossa, al disopra della tovaglia. «Voi qui non capite la storia… Tutta questa lurida guerra è un trucco da cima a fondo. Perché non silurano navi della French Line? Perché le Rane hanno combinato tutto coi Geremia, 2 capisci, che se i Geremia lascian stare le navi francesi, i francesi non bombardano le fabbriche tedesche al di là del fronte. Quel che dobbiamo fare noi americani è restare a letto e vendergli munizioni e lasciare che saltino tutti all’inferno. E quegli angioletti fanno i soldi a palate a Bordeaux, a Tolosa, a Marsiglia, mentre i loro compatrioti si sparano nella pancia al fronte e lo stesso
succede cogli inglesi… Ti dico io, Janey, questa guerra è un porco giuda di un trucco, come tutto il resto.» Janey si mise a piangere. «Ma non c’è bisogno di bestemmiare così.» «Scusami, sorella,» disse Joe tutto umile «ma io non sono che un farabutto, ecco com’è, e non sono degno di stare insieme a una ragazza così ben vestita come te.» «No, non volevo dir questo» disse Janey, asciugandosi gli occhi. «Corpo, ma dimenticavo di farti vedere lo scialle.» Sviluppò una carta di giornale. Si sparsero sul tavolino due scialli spagnoli, uno di pizzo nero e un altro di seta verde ricamata a grossi fiori. «Oh, Joe, non devi darmeli tutti e due… Devi darne uno alla tua innamorata.» «Le ragazze che vengono con me non sono degne di queste cose… Li ho comperati per te, Janey.» Janey giudicò gli scialli molto belli e decise che ne avrebbe dato uno a Eliza Tingley. Andarono all’Hippodrome, ma non ci si divertirono molto. Janey non gustava troppo quegli spettacoli e Joe cadeva dal sonno. Quando uscirono dal teatro, faceva un freddo intenso. Violenta neve asciutta turbinava per la Sesta Avenue, cancellando quasi l’aerea. Joe la condusse a casa in tassì e la lasciò alla porta con un brusco «Addio, Janey». Janey rimase un momento sullo scalino con la chiave in mano e lo guardò allontanarsi a ovest verso la Decima e le banchine, con la testa affondata nel giubbone. Quell’inverno sventolarono tutti i giorni le bandiere sulla Quinta Avenue. Janey leggeva avidamente a colazione il giornale, all’ufficio si parlava di spie tedesche, sommergibili, atrocità e propaganda. Una mattina venne una missione militare francese a visitare J. Ward, begli ufficiali pallidi in uniformi azzurre e calzoni rossi e decorazioni. Il più giovane camminava con le grucce. Tutti erano stati feriti gravemente al fronte. Quando partirono, Janey e Gladys quasi litigarono, perché Gladys diceva che gli ufficiali erano un mucchio di pelandroni oziosi e che le sarebbe andata più a genio una missione di semplici soldati. Janey si chiese se non dovesse parlarne a J. Ward, della germanofilia di Gladys, se non fosse il suo dovere di patriota. I Compton potevano
essere spie, non vivevano infatti con un nome posticcio? Benny era un socialista o anche peggio, lei lo sapeva. Decise di tenere gli occhi ben aperti. Lo stesso giorno venne G.H. Barrow. Janey stette tutto il tempo nell’ufficio privato, con loro. Parlarono del presidente Wilson, della neutralità, della Borsa, e del ritardo nella trasmissione della nota sul Lusitania. G.H. Barrow aveva avuto un’intervista con il presidente. Era membro di un comitato che cercava di far da intermediario tra le ferrovie e le confraternite, che minacciavano uno sciopero. Janey lo trovò più simpatico di quando avevano viaggiato dal Messico insieme in vettura riservata, in modo che quando lui andandosene la incontrò nel vestibolo Janey fu contentissima di parlargli e, quando la invitò ad andare a cena con lui, Janey accettò e si sentì una monella. Per tutto il tempo che stette a New York, G.H. Barrow portò Janey a cena e a teatro. Janey si divertì e poteva sempre stuzzicarlo con Queenie, caso mai lui si prendesse troppa libertà al ritorno nel tassì. G.H. Barrow non riusciva a capire come lei avesse saputo di Queenie e le raccontò tutta la storia e come quella donna gli dava la caccia per i soldi, ma disse che adesso era divorziato dalla moglie e non poteva più fargli nulla. Dopo aver fatto giurare a Janey che non avrebbe mai rifiatato, le spiegò che per mezzo di un cavillo legale era stato sposato a due donne contemporaneamente e che Queenie era una delle due e ora aveva divorziato da tutte e due e non c’era nulla al mondo che Queenie potesse ancora fargli, ma i giornali eran sempre in cerca di fango e godevano in particolare a scoprir qualcosa di un liberale come lui, devoto alla causa del lavoro. Poi parlò dell’arte di vivere e disse che le donne americane non capivano l’arte di vivere; o almeno, le donne come Queenie. Janey lo compianse molto, ma, quando lui le chiese di sposarlo, si mise a ridere e disse che in verità avrebbe dovuto pigliar consiglio prima di rispondergli. Lui le raccontò tutto della sua vita e come era povero da ragazzo e poi i suoi impieghi da ferroviere e agente spedizioniere e controllore e l’entusiasmo con cui si era messo a lavorare per la confraternita e come i suoi scandalizzanti articoli sulle condizioni delle ferrovie gli avevano fatto un nome e una fortuna, tanto che tutti i suoi antichi colleghi dicevano che si era
venduto, ma questo Dio m’aiuti non era vero. Janey andò a casa e parlò ai Tingley della proposta, solamente si guardò bene dal dire qualcosa di Queenie e della bigamia, e tutti risero e ci scherzarono su e a Janey dava un certo senso di compiacenza ricevere una proposta da una persona tanto importante e si chiese come mai si innamoravano di lei sempre uomini tanto interessanti e rimpianse che tutti avessero sempre quell’aria dissoluta, ma, se le piacesse o no di sposare G.H. Barrow, non lo sapeva. All’ufficio, il mattino successivo, lo cercò nel Who’s who? e c’era: “Barrow, George Henry, pubblicista…” ma non credeva che sarebbe mai riuscita ad amarlo. All’ufficio quel giorno J. Ward aveva un’aria preoccupatissima e a Janey rincrebbe tanto di lui da dimenticarsi interamente di G.H. Barrow. Venne chiamata a un colloquio privato che J. Ward teneva col signor Robbins e un avvocato irlandese di nome O’Grady e le chiesero se permetteva loro di affittare una cassetta di depositi a suo nome, per tenervi certi atti, e le aprirono un conto privato al Bankers Trust. Formavano una nuova società. C’eran ragioni d’affari per cui un ripiego del genere poteva diventare categorico. Il signor Robbins e J. Ward avrebbero posseduto più di metà delle azioni della nuova impresa e vi avrebbero lavorato su una base di stipendio. Il signor Robbins pareva molto preoccupato e un po’ brillo e continuava ad accendere sigarette e dimenticarle sull’orlo della scrivania e diceva: «Sapete benissimo, J.W., che tutto ciò che voi fate, per me va». J. Ward spiegò a Janey che lei sarebbe stata un funzionario della nuova società, ma naturalmente in nessun modo responsabile di persona. Venne fuori che la vecchia signora Staple faceva causa a J. Ward per riavere una gran parte del suo denaro, che la moglie aveva cominciato in Pennsylvania le pratiche per il divorzio e gli proibiva di andare a casa a vedere i bambini e che J. Ward viveva al McAlpin. «Gertrude ha perduto la testa» disse il signor Robbins genialmente. Poi batté J. Ward sulla schiena. «Sembra che ormai la benzina sia sul fuoco» vociò. «Be’, vado a pranzo, bisogna mangiare… e bere… anche quando si è bancarottieri presuntivi.» J. Ward aggrottò i sopraccigli senza dir nulla e Janey giudicò di pessimo gusto parlare a quel modo,
e così forte poi. Tornata a casa, quella sera, disse ai Tingley che stava per diventare direttrice in una nuova società e quelli dissero che era meraviglioso come lei faceva carriera in fretta e che assolutamente doveva chiedere un aumento, anche se c’era la depressione negli affari. Janey sorrise e disse: «Ogni cosa a suo tempo». Sulla via del ritorno, era passata in un ufficio telegrafico nella Ventitreesima Strada e aveva telegrafato a G.H. Barrow tornato a Washington: RESTIAMO BUONI AMICI. Eddy Tingley tirò fuori una bottiglia di sherry e a cena lui ed Eliza fecero un brindisi «alla nuova dirigente» e Janey divenne vermiglia e fu tanto felice. Dopo, giocarono una partita a bridge, col morto. 1. “Fondo”, bottom. Nome deformato della nave, vale “porco al fondo”. (NdT) 2. Frogs, i francesi; Jerries, i tedeschi (Jerry, simile di pronuncia a German). (NdT)
Occhio fotografico (26) il giardino era zeppo e fuori Madison Square c’era un pieno di questurini che facevano circolare tutti e la squadriglia lanciabombe sguinzagliata non potevamo trovar da sederci e così corremmo su per le scale al loggione e guardammo nell’atmosfera azzurra le facce fitte come la ghiaia Sul palco degli oratori figure nere piccine e un uomo stava facendo un discorso e ogni volta che diceva Guerra c’erano fischi e ogni volta che diceva Russia c’erano applausi per via della rivoluzione non so chi parlava qualcuno diceva Max Eastman e qualcuno diceva qualcun altro ma applaudimmo e strillammo per la rivoluzione e fischiammo Morgan e la guerra capitalistica e c’era uno in borghese che ci guardava in faccia come se cercasse di ricordarci poi andammo a sentire Emma Goldman al Casino di Bronx ma la riunione fu proibita e le vie circostanti erano zeppe di gente e c’erano furgoni in marcia che giravano tra la folla e si diceva che i furgoni in marcia fossero pieni di questurini con le mitragliatrici e c’erano piccole Ford della polizia con i riflettori e caricavano la folla con le Ford e i riflettori. Tutti parlavano di mitragliatrici rivoluzione libertà civile libertà di parola Qualcuno finiva nei piedi di una guardia che lo picchiava e cacciava nell’auto della pattuglia e le guardie avevano paura e si diceva che chiedevano l’aiuto dei pompieri per disperdere la folla e tutti dicevano che era una vergogna e Washington e Jefferson e Patrick Henry allora? poi andammo al Brevoort Era molto più bello Chiunque era qualcuno c’era e c’era Emma Goldman che mangiava Frankfurter e Sauerkraut e tutti guardavano verso Emma Goldman e verso quelli che erano qualcuno e tutti erano per la pace e la repubblica cooperativa e la rivoluzione russa e parlammo delle bandiere rosse e delle barricate e dei punti adatti per piazzarvi le mitragliatrici e bevemmo vari bicchierini e mangiammo crostini al formaggio e pagammo il conto e andammo a casa, e aprimmo la porta con la chiave e indossammo il pigiama e ci coricammo e si stava bene a letto
Cine-giornale XVIII Ciao Piccadilly, addio Leicester Square, è lunga la via per Tipperary UNA DONNA COGLIE IL MARITO CON UNA RAGAZZA ALL’ALBERGO a un simile compito noi possiamo dedicare la vita e le ricchezze e tutto ciò che siamo, e tutto ciò che abbiamo, con l’orgoglio di chi sa che è venuto il giorno in cui l’America ha il privilegio di impiegare il sangue e la potenza per i princìpi che le diedero la vita e la felicità e la pace, di cui ha fatto tesoro. Dio aiutandola, essa non può far altro È lunga la via per Tipperary è lunga la via per andarci è lunga la via per Tipperary dov’è la mia bella bimba IN GUARDIA O TRADITORI quattro uomini multati a Evanston perché uccidevano uccelli WILSON IMPORRÀ LA MOBILITAZIONE gli speculatori sui cibi fan salire i prezzi dei prodotti in scatola verso il regime secco in guerra multe a coloro che fan finta di non sentire l’inno nazionale JOFFRE DOMANDA TRUPPE SUBITO Il caso Mooney fa da incentivo Salute Piccadilly, addio Leicester Square è lontano lontano Tipperary ma il mio cuore è ancor laggiù. LA CAMERA RIFIUTA A T.R. 1 IL PERMESSO DI ORGANIZZARE TRUPPE l’ambasciata americana venne minacciata oggi di assalto da una folla di socialisti radicali guidati da Nikolaj Lenin, un esiliato tornato recentemente dalla Svizzera attraverso la Germania GLI ALLEATI INTRECCIANO LE BANDIERE SULLA TOMBA DI WASHINGTON
1. Theodore Roosevelt. (NdT).
Eleanor Stoddard Eleanor pensò che la vita era molto eccitante quell’inverno. Lei e J.W. uscivano molto insieme, andavano a tutte le opere francesi e alle prime. C’era un ristorantino francese dove si mangiavano hors d’œuvre, verso est, nella Cinquantaseiesima Strada. Andarono a vedere i quadri francesi nelle gallerie lungo Madison Avenue. J.W. cominciava a interessarsi d’arte, ed Eleanor era incantata di uscire con lui, perché in tutto aveva un fare così romantico e soleva dirle che lei era la sua ispiratrice e che sempre gli venivano idee preziose dopo che le aveva parlato insieme. Sovente parlavano di com’eran stupidi quelli che dicevano che un uomo e una donna non possono avere una amicizia platonica. Si scrivevano bigliettini in francese ogni giorno. Sovente Eleanor pensava ch’era un obbrobrio che J.W. avesse una moglie tanto stupida e per giunta inferma, ma i bambini le parevano belli ed era carino che tutti e due avessero quei begli occhi azzurri come il padre. Aveva ora un ufficio tutto per sé, due ragazze che lavoravano con lei per imparare il mestiere e lavoro in quantità. L’ufficio era nel primo isolato oltre Madison Square, in Madison Avenue, e c’era scritto il suo nome. Eveline Hutchins non vi aveva più nulla a che fare, poiché il dottor Hutchins si era ritirato e gli Hutchins avevan traslocato a Santa Fe. Eveline le mandava di tanto in tanto una cassetta di oggetti d’arte indiana o vasellame o gli acquerelli che i ragazzi indiani facevano nelle scuole ed Eleanor trovò che si vendevano bene. Nel pomeriggio scendeva al centro in tassì e alzava gli occhi a guardare la torre del Metropolitan Life e il Flatiron Building e le luci contro il cielo di Manhattan color acciaio, e pensava a cristalli, fiori artificiali, disegni dorati su broccato color indaco o vino. La cameriera le preparava il tè e sovente c’erano amici che l’aspettavano, giovani architetti o pittori. Sempre c’erano fiori, gigli calla dai petali che parevano un gelato, o un vaso di ireos. Discorreva un poco prima di ritirarsi a mutar d’abito per la cena. Quando J.W. telefonava che non poteva venire, stava molto male. Se restava ancora qualcuno, venuto a prendere il tè, gli diceva di fermarsi a far penitenza con lei.
Sempre la vista della bandiera francese la eccitava, oppure quando una banda sonava il Tipperary; e una sera, che andavano a vedere per la terza volta The Yellow Jacket, Eleanor portava un mantello di pelliccia nuovo, che non sapeva come avrebbe pagato, e pensava a tutte le note nell’ufficio e alla casa in Sutton Square che faceva ricostruire contando su una speculazione e voleva chiedere a J.W. di quei mille che lui diceva di avere investito a suo nome e si chiedeva se non c’era ancor stata nessuna operazione. Avevano chiacchierato delle incursioni aeree, dei gas asfissianti, dell’effetto delle notizie della guerra nel centro, degli arcieri di Mons, della pulzella d’Orléans, ed Eleanor disse che credeva nel soprannaturale e J.W. lasciava cadere accenni di rovesci in Wall Street, con una faccia tirata e preoccupata; ma attraversavano Times Square in mezzo alla calca delle otto e alle insegne luminose, che lampeggiavano a intervalli. I graziosi omini a triangolo facevano esercizi sull’insegna Wrigley e d’improvviso un organetto prese a suonare La marsigliese e fu troppo bello; Eleanor scoppiò in lacrime e parlarono di Sacrificio e Consacrazione e J.W. le tenne stretto il braccio attraverso il cappotto di pelliccia e diede al suonatore dell’organetto un dollaro. Giunti al teatro, Eleanor corse alla sala per signore a vedere se aveva gli occhi rossi. Ma quando guardò allo specchio, gli occhi non erano niente rossi e c’era dentro un lampo di commosso sentimento, tanto che lei non fece che rinfrescarsi il viso e ritornò al vestibolo, dove J.W. l’attendeva coi biglietti in mano; fiammeggiavano i suoi occhi grigi e dentro c’eran lacrime. Poi una sera J.W. fece una faccia veramente preoccupata e disse, accompagnando Eleanor a casa dall’Opera dove avevano veduto la Manon, che sua moglie non comprendeva i loro rapporti e faceva scene e minacciava di divorziare. Eleanor s’indignò e disse che doveva avere un carattere ben volgare a non comprendere che i loro rapporti erano come la neve. J.W. disse ch’era vero e che quanto a sé era assai preoccupato e spiegò che la massima parte del capitale investito nella sua agenzia era della suocera, che poteva farlo fallire, se ne aveva voglia, e questo era un po’ peggio del divorzio. A tanto Eleanor si sentì gelare e increspare e disse che lei sarebbe uscita interamente dalla sua vita piuttosto che rovinargli la casa e che lui doveva
qualcosa ai suoi incantevoli bambini. J.W. disse che lei era la sua ispiratrice e che gli era necessaria nella vita e, quando furono di ritorno nell’Ottava Avenue, passeggiarono avanti e indietro per il candido salotto di Eleanor, tutto scintillante, nel profumo greve di gigli, almanaccando che cosa si poteva fare. Fumarono molte sigarette, ma apparentemente non arrivarono a nessuna decisione. Quando J.W. se ne andò, disse con un sospiro: «Magari in questo stesso istante mi fa sorvegliare da poliziotti» e partì disperato. Quando fu uscito, Eleanor passeggiò in su e in giù davanti al lungo specchio veneziano tra le finestre. Non sapeva come fare. Le decorazioni rendevano appena quel tanto. Aveva da finir di pagare l’ammortizzazione della casa in Sutton Square. Il fitto del suo alloggio era arretrato di due mesi e c’era da pagare il cappotto di pelliccia. Aveva contato sulla somma di mille dollari in azioni che J.W. aveva detto sarebbero state sue, se lui riusciva a fare in Borsa su quel petrolio del Venezuela il colpo che s’attendeva. Qualcosa doveva esser andato male, altrimenti J.W. ne avrebbe parlato. Quando andò a letto, Eleanor non dormì. Si sentiva triste e sola. Avrebbe dovuto tornare allo sfacchinamento di un grande magazzino. Stava perdendo la freschezza dell’aspetto e gli amici, e ora dover perdere anche J.W. sarebbe terribile. Pensò alla sua domestica di colore, Augustine, coi suoi amori disgraziati, che sempre veniva a riferire a Eleanor e desiderò di esser fatta così. Forse si era sbagliata fin da principio, a voler tutto così per filo e per segno e così bello. Non piangeva ma stette tutta la notte, con gli occhi spalancati e brucianti, a fissare la modanatura fiorita, intorno alla volta, che si poteva scorgere nella luce che filtrava attraverso le tendine di tulle lavanda. Due o tre giorni dopo, all’ufficio, stava esaminando certe poltrone spagnole antiche, che un negoziante di mobili vecchi cercava di venderle, quando giunse un telegramma: NOVITÀ SPIACEVOLI DEBBO VEDERVI SCONSIGLIABILE TELEFONARE VENITE TÈ CINQUE ALBERGO PRINCIPE GEORGE. Non era firmato. Disse all’uomo di lasciar lì le poltrone e, quando quello se ne fu andato, restò a lungo a guardare un vaso di zafferani color lavanda coi pistilli gialli, che teneva sulla scrivania. Si domandava se sarebbe servito
andare a Great Neck e parlare con Gertrude Moorehouse. Chiamò la signorina Lee che stava facendo certe tendine nella camera accanto e la pregò di incaricarsi lei dell’ufficio: avrebbe telefonato nel pomeriggio. Salì in un tassì e andò alla stazione di Pennsylvania. Era una giornata di primavera precoce. Qualcuno camminava per la via col soprabito sbottonato. Il cielo era uno sfumato di malva, con nuvole sottili come pelurie di cotone selvatico. Tra gli odori delle pellicce e soprabiti e scappamenti e corpi infagottati passava un sentore inaspettato di scorza di betulla. Eleanor sedeva eretta nella parte posteriore del tassì cacciandosi le unghie affilate nella palma delle mani inguantate di grigio. Detestava questi giorni traditori in cui l’inverno pareva primavera. Le facevano risaltare in viso le rughe, le facevano parere che tutto intorno crollasse, pareva non ci fosse più nessun solido appoggio. Sarebbe andata a parlare con Gertrude Moorehouse da donna a donna. Uno scandalo avrebbe rovinato tutto. Se le parlava un po’, le avrebbe fatto comprendere che non c’era mai stato nulla tra lei e J.W. Lo scandalo di un divorzio avrebbe rovinato tutto. Lei avrebbe perduto la clientela e sarebbe dovuta tornare a Pullman a vivere con gli zii. Pagò l’autista e scese le scale della ferrovia di Long Island. Le tremavano le ginocchia e si sentiva disperatamente stanca, mentre s’apriva una strada fra la calca al banco delle informazioni. No, non poteva prendere un treno per Great Neck fino alle 2.13. Fece coda un bel pezzo per prendere il biglietto. Un tale le pestò un piede. La fila di gente avanzava verso lo sportello con una lentezza esasperante. Quando fu allo sportello, passò qualche secondo prima che si rammentasse il nome del luogo per cui voleva il biglietto. L’impiegato la guardava attraverso lo sportello con stizzosi occhi a bottone da scarpa. Portava un paraocchi verde e aveva le labbra troppo rosse per il volto pallido. La gente dietro cominciava a spazientirsi. Un tale vestito di tweed, con una pesante valigia, stava già cercando di passarle innanzi. «Great Neck, andata e ritorno.» Appena comperato il biglietto, le venne il pensiero che non avrebbe avuto il tempo di andare fin là e ritornare per le cinque. Mise
il biglietto nella borsetta di seta bigia, che sopra aveva un piccolo ricamo di ambra nera. Pensò di uccidersi. Avrebbe preso la sotterranea fino al centro, poi l’ascensore fino in cima del Woolworth Building e si sarebbe buttata giù. Invece andò al posteggio dei tassì. Una luce rossastra pioveva tra la grigia colonnata, e il fumo azzurro degli scappamenti vi saliva spiegazzato come seta bagnata. Salì su un tassì e disse all’autista di portarla al Central Park. Qualche ramo era rosso e sulle lunghe gemme delle betulle c’era uno scintillio, ma l’erba era ancor scura e, nei rigagnoli, mucchi di neve sudicia. Un aspro vento abbrividito passava sugli stagni. L’autista badava a parlare. Eleanor non afferrava che cosa dicesse e si stufò di dar risposte casuali e gli disse di portarla al Metropolitan Museum of Art. Mentre stava pagando, uno strillone passò gridando un’edizione straordinaria. Eleanor comprò un foglio con un nichelino e lo stesso fece l’autista. «Voglio morir ammaz…» sentì esclamare dall’autista, ma corse presto su per i gradini, per la paura di dovergli parlare. Quando fu nella calma luce argentea del museo aprì il giornale. Un odor rancido di inchiostro di macchina ne esalava, l’inchiostro era ancora appiccicaticcio e le restò sui guanti. LA DICHIARAZIONE DI GUERRA È una questione di ore, affermano le corrispondenze da Washington. La nota tedesca non è per nulla soddisfacente. Lasciò il giornale su un banco e andò a guardare i Rodin. Guardati i Rodin, andò nell’ala cinese. Quando fu per scendere la Quinta Avenue in omnibus – s’accorgeva di aver speso troppo in tassì – si sentiva esaltata. Per tutta la strada verso il centro ebbe in testa l’età del Bronzo. Quando scoperse J.W. nella chiusa rosata del vestibolo dell’albergo, gli andò incontro con un passo elastico. J.W. aveva le mascelle serrate e gli occhi azzurri accesi. Sembrava più giovane dell’ultima volta che l’aveva veduto. «E così è venuta finalmente» disse. «Ho telegrafato ora a Washington offrendo i miei servigi al Governo. Vorrei vederli ora, che provassero a combinare uno sciopero ferroviario.» «È meraviglioso e terribile» disse Eleanor. «Io tremo come una
foglia.» Andarono a un tavolino in un angolo, dietro certe cortine pesanti, a prendere il tè. Si erano appena seduti che l’orchestra cominciò a suonare The Star-Spangled Banner e dovettero alzarsi in piedi. C’era un gran trambusto nell’albergo. Continuava a scorrazzare gente con nuove edizioni dei giornali, ridendo e parlando forte. Persone estranee l’una all’altra s’imprestavano i giornali reciprocamente, cianciavano della guerra, si accendevano a vicenda le sigarette. «Ho in mente, J.W.,» diceva Eleanor, bilanciando sulle dita appuntite un pezzo di panino alla cannella «che se andassi a parlare a vostra moglie da donna a donna, lei comprenderebbe meglio la situazione. Quando decoravo la casa, fu così gentile con me e andammo tanto d’accordo.» «Ho offerto i miei servigi a Washington» disse Ward. «Può darsi che ci sia ora all’ufficio un telegramma. Sono certo che Gertrude comprenderà che non è altro che il suo dovere.» «Debbo andare, J.W.» disse Eleanor. «Sento che debbo andare.» «Dove?» «In Francia.» «Non fate nulla di avventato, Eleanor.» «No, sento che debbo… Posso riuscire un’ottima infermiera… Non ho paura di nulla, dovreste saperlo, J.W.» L’orchestra suonò di nuovo The Star-Spangled Banner; Eleanor cantò nel coro con una stridula vocetta da soprano. Erano troppo eccitati per stare ancor là tranquilli e andarono all’ufficio di J.W. in tassì. L’ufficio era in grande agitazione. La signorina Williams aveva fatto mettere un’asta alla finestra centrale e stava allora inalberandovi la bandiera. Eleanor le andò incontro e si strinsero la mano con calore. Il vento freddo agitava le carte sulla scrivania e fogli dattilografati navigavano per la stanza, ma nessuno vi badava. Giù per la Quinta Avenue si avvicinava una banda suonando Hail, Hail, the Gang’s All Here. Per tutto il corso le finestre degli uffici erano vivamente illuminate, le bandiere sventolavano contro le aste nel vento freddo, impiegati e stenografe acclamando, gettando i fogli che navigavano e turbinavano nel pungente vento vorticoso.
«È il Settimo Reggimento» disse qualcuno, e tutti applaudirono e gridarono. La banda echeggiò forte sotto la finestra. Si poteva udire la cadenza dei passi dei militi. Tutte le automobili nell’ingorgo del traffico presero a suonare le trombe. Gente in cima agli omnibus agitava bandierine. La signorina Williams si piegò a baciare Eleanor sulla guancia. J.W. era accanto e guardava fuori, al disopra del loro capo, con un sorriso d’orgoglio in viso. Passata la banda e ripreso il traffico, chiusero la finestra e la signorina Williams andò in giro a raccogliere e ordinare le carte disperse. J.W. ricevette un telegramma da Washington in accettazione dei suoi servizi nel comitato di Informazione pubblica, che il signor Wilson raccoglieva intorno a sé, e disse che partiva il mattino dopo. Chiamò al telefono Great Neck e domandò a Gertrude se gli permetteva di venir a cena con una persona amica. Gertrude disse che sì e sperava quanto a sé di potersi tenere in piedi fino al loro arrivo. Era eccitata dalla notizia della guerra, ma disse che il pensiero di tutte quelle sventure e quel macello le dava orribili sofferenze alla nuca. «Ho idea che, se vi porto a cena da Gertrude, tutto andrà bene» disse J.W. a Eleanor. «Raramente mi sbaglio in questi presentimenti.» «Oh, io so che comprenderà» disse Eleanor. Mentre uscivano dall’ufficio, incontrarono il signor Robbins nel vestibolo. Non si tolse il cappello né di bocca il sigaro. Pareva brillo. «Che diavoleria è, Ward?» disse. «Siamo o no in guerra?» «Se non ci siamo, ci saremo prima di domani» disse J.W. «È il più lurido tradimento della storia» disse il signor Robbins. «Per che cosa abbiamo eletto Wilson invece di quelle vecchie basette, se non per star fuori dal pasticcio?» «Robbins, non posso consentire con voi, nemmeno per un istante» disse J.W. «Penso che sia nostro dovere salvare…» Ma il signor Robbins era scomparso nell’uscio dell’ufficio, lasciandosi dietro un forte sentore di whisky. «Gli avrei detto quel che penso di lui» disse Eleanor «se non l’avessi visto in quello stato.» La corsa in Pierce Arrow fino a Great Neck fu esaltante. Un lungo riflesso rosso persisteva nel cielo. Traversare il Queensboro Bridge col vento freddo alle spalle fu come volare su luci e isolati e l’ammasso
violaceo di Blackwell Island e i piroscafi e gli alti fumaioli e la luce azzurrina delle officine d’elettricità. Parlarono di Edith Cavell e incursioni aeree e bandiere e riflettori e il calpestio degli eserciti avanzanti e Giovanna d’Arco. Eleanor si tirò la pelliccia fino al mento e pensò a ciò che avrebbe detto a Gertrude Moorehouse. Quando giunsero a casa, aveva un po’ spavento di una scena. Si fermò nel vestibolo a rifarsi il viso con uno specchietto che aveva con sé nella borsetta. Gertrude Moorehouse sedeva su una poltrona a rotelle, accanto a un fuoco scoppiettante. Eleanor diede uno sguardo in giro per la stanza e si compiacque di trovarla tanto graziosa. Gertrude Moorehouse si fece pallidissima, vedendola. «Desideravo parlarvi» disse Eleanor. Gertrude Moorehouse porse la mano, senza alzarsi. «Scusatemi se non mi alzo, signorina Stoddard» disse. «Ma sono assolutamente prostrata da queste terribili notizie.» «La civiltà chiede un sacrificio… a noi tutti» disse Eleanor. «Certo è terribile quel che hanno fatto gli unni: tagliar le mani ai bimbi e tutto il resto» disse Gertrude Moorehouse. «Desidero parlarvi di questo disgraziato malinteso dei miei rapporti con vostro marito… Credete che io sia una donna capace di trovarmi qui a fronteggiarvi, se in queste orribili voci ci fosse anche solo qualcosa? I nostri rapporti sono puri come la neve.» «Vi prego, non parlatene, signorina Stoddard. Vi credo.» Quando J.W. rientrò, eran sedute ai due lati del fuoco e parlavano dell’operazione di Gertrude. Eleanor si alzò. «Oh, ma è magnifico quel che avete fatto, J.W.» J.W. si schiarì la gola e guardò dall’una all’altra. «È poco meno che il mio dovere» disse. «Cos’è?» domandò Gertrude. «Ho offerto i miei servigi al Governo, che li adoperassero in qualunque modo credevano opportuno per tutta la durata della guerra.» «Non al fronte» disse Gertrude con aria allarmata. «Parto per Washington domani… Naturalmente presterò servizio senza stipendio.»
«Ward, è una nobile azione» disse Gertrude. J.W. le si accostò adagio finché fu accanto alla poltrona, e allora si chinò a baciarla sulla fronte. «Tutti dobbiamo fare i nostri sacrifici… Mia cara, avrò fiducia in te e in tua madre.» «Certo, Ward, certo… È stato tutto uno stupido malinteso.» Gertrude avvampò in viso. Si alzò in piedi. «Sono stata una brutta stupida sospettosa… ma tu non devi andare al fronte, Ward. Ne parlerò con la mamma…» Gli andò incontro e gli pose le mani sulle spalle. Eleanor rimase indietro, appoggiata alla parete, guardandoli. J.W. vestiva uno smoking liscio e aderente. L’abito da tè, color salmone, di Gertrude risaltava sul nero. I capelli lievi di lui erano grigio cenere nella luce del lampadario di cristallo, contro le alte pareti grigio avorio della stanza. Il volto era in ombra e pareva rattristato. Eleanor pensò a quanto poco la gente comprendesse un uomo simile, a quanto era graziosa la stanza, come una recita, come un Whistler, come Sarah Bernhardt. La commozione le annebbiò gli occhi. «Entrerò nella Croce Rossa» disse. «Non posso più star fuori di Francia.»
Cine-giornale XIX GLI STATI UNITI IN GUERRA IL GRIDO DELLA CITTÀ È QUESTO: SOSTENETE LA NAZIONE laggiù di là dal mare laggiù di là dal mare alla riunione annuale degli azionisti della Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company venne diviso un premio di 2.500.000 dollari. Il capitale attuale venne aumentato. I profitti di questo anno furono il 259 per cento LIETA SORPRESA DEGLI INGLESI vengono gli americani Arriviaaamo PROGETTO DI LEGGE PER TENERE LA POPOLAZIONE DI COLORE LONTANA DALLE AREE BIANCHE parecchi milioni pagati per il golf intorno a Chicago agitatori indù atterriscono tutto il territorio della nazione Armour Chiede Che Gli S.U. Salvino La Terra Dalla Carestia GLI INSULTI ALLA BANDIERA SARANNO PUNITI i deputati del lavoro sono un pericolo per la Russia gli atti hanno parvenza di pace vergognosa si dice a Londra e non ritorneremo che dopo la vittoria.
Occhio fotografico (27) c’erano preti e monache sull’Espagne l’Atlantico era verdebottiglia e burrascoso teli erano fissati sugli sportelli e tutte le luci di coperta erano nascoste e non si poteva accendere un fiammifero sul ponte ma i camerieri erano molto coraggiosi e dicevano che i boches non avrebbero affondato un bastimento della Compagnie Générale per via dei preti delle monache e dei gesuiti e del Comité des Forges che aveva promesso di non bombardare il Bassin de Briey dove c’erano le grosse fonderie e perché possedevano azioni della compagnia il Prince de Bourbon i gesuiti i preti e le monache e tutti erano molto coraggiosi tranne il colonnello e la signora Knowlton della Croce Rossa americana che avevano costumi impermeabili irraffreddabili insilurabili che parevano costumi da eschimesi e li portavano e stavan seduti sul ponte col costume tutto rigonfio mostrando solamente il viso c’erano nelle tasche borsette di pronto soccorso e nella cintura un recipiente impermeabile con cioccolata al latte biscotti e tavolette di latte maltato e al mattino si andava a passeggio per il ponte ed ecco che si trovava il signor Knowlton che gonfiava la signora Knowlton o la signora Knowlton che gonfiava il signor Knowlton i ragazzi Roosevelt erano coraggiosi nei nuovi rigidi berretti d’ordinanza con la visiera e medaglie di tiratore scelto sull’uniforme kaki e parlavano tutto il giorno di Noi dobbiamo entrare Noi dobbiamo entrare come se la guerra fosse stata una piscina e il barista era coraggioso e i camerieri erano coraggiosi e tutti erano stati feriti ed erano contentissimi di fare i camerieri e non andar più in trincea e la pasticceria era sopraffina finalmente fu la zona e una rotta a zigzag e stavamo seduti quieti nel bar e poi fu l’estuario della Gironda e una torpediniera francese che girò intorno alla nave nel dolce mattino color perla e i piroscafi andavano dietro al battello di ronda per via delle mine il sole rosso si levava sulle calde terre di viti e la Gironda era piena di navi mercantili
e di aeroplani nel sole e di navi da guerra la Garonna era rossa era d’autunno c’erano botti di vino nuovo e casse di bombe lungo le banchine di fronte alle case dai volti grigi e le alberature di tozzi velieri s’ammucchiavano contro il gran ponte in ferro rosso all’albergo delle Seven Sisters tutti erano in lutto ma gli affari andavan bene per via della guerra e ogni momento aspettavano che il Governo si trasferisse qui da Parigi su nel Nord si moriva nel fango e nelle trincee ma gli affari andavano bene a Bordeaux e i viticultori gli agenti di spedizione i fornitori di munizioni s’affollavano al Chapon Fin e mangiavano selvaggina e funghi e tartufi e c’era un grosso cartello MÉFIEZ-VOUS les oreilles ennemies vous écoutent! vino rosso crepuscolo e piazze dalla ghiaia gialla orlate di botti di vino e odore di cioccolata nel parco statue grigie e i nomi delle vie Via delle Speranze Perdute Via dello Spirito delle Leggi Via dei Passi Perduti e l’odore di foglie brucianti e le case Bourbon dai volti grigi crollanti nel crepuscolo rosso vino all’albergo delle Seven Sisters dopo che si era a letto tardi nella notte e improvvisamente ci si svegliava e c’era un agente del servizio segreto che faceva passare la vostra valigia e s’accigliava sul passaporto e guardava dentro i libri e diceva Monsieur, c’est la petite visite
Bob il combattente La Follette nacque alla periferia di Primrose; lavorò in una cascina nel distretto Dane, Wisconsin, finché ebbe diciannove anni. All’università del Wisconsin si guadagnò la vita. Voleva fare l’attore, studiava dizione e Robert Ingersoll e Shakespeare e Burke (chi spiegherà mai l’influsso di Shakespeare nel secolo scorso, Marco Antonio sulla bara di Cesare, Otello al Senato veneziano e Polonio, dappertutto Polonio) tornando a casa in biroccino, dopo presa la laurea, fu Booth, e Wilkes che scriveva i quaderni di Junius, e Daniel Webster, e Ingersoll che sfidava Dio, e tutti i grandi togati, gravi e incorruttibili come statue, magnificamente declamanti attraverso i secoli capitolini; era il campione oratore della classe, e vinse una gara interfederale con un’orazione sulla figura di Iago. Si mise a lavorare in un ufficio legale e concorse al posto di ufficiale giudiziario. I suoi amici di scuola gli fecero la propaganda per il distretto girando a cavallo alla sera. Lui si mise all’opposizione e vinse l’elezione. Era la rivolta dei giovani contro la macchina repubblicana dello Stato e padron Keyes il direttore delle Poste a Madison, quello che comandava il distretto, rimase così stupito che quasi cadde dalla sedia. Così La Follette ebbe uno stipendio per sposarsi. Aveva venticinque anni. Quattro anni dopo si presentò candidato al Congresso; l’università era di nuovo con lui; era il candidato dei giovincelli. Quando fu eletto era il più giovane rappresentante di tutta la camera. Venne presentato a tutti in Washington da Philetus Sawyer il re dei legnami, del Wisconsin, che era abituato ad accatastare e vendere i politicanti a quel modo che accatastava e vendeva fasci di legna. La Follette era un repubblicano e si era messo all’opposizione. Ora credevano di tenerlo. Nessuno poteva mantenersi onesto a Washington.
Booth dava Shakespeare a Baltimora quell’inverno. Booth non veniva più a Washington per via della triste memoria del fratello. Bob La Follette e sua moglie andarono a tutte le recite. Nel salotto del Plankinton Hotel di Milwaukee, durante la fiera dello Stato, padron Sawyer il re dei legnami cercò di corromperlo perché usasse il suo influsso sul cognato che era presidente nel processo del tesoriere di Stato repubblicano; Bob La Follette uscì dall’albergo bianco di furore. Da quella volta fu la guerra senza quartiere contro l’organizzazione repubblicana del Wisconsin finché non venne eletto governatore e distrusse l’organizzazione repubblicana; e questa fu la guerra decenne che fece del Wisconsin lo Stato modello dove gli elettori, i tedeschi e i finlandesi amanti dell’ordine, gli scandinavi teneri della propria opinione, impararono a usare i nuovi mezzi, le assemblee dirette, il referendum e la revoca. La Follette tassò le ferrovie. John C. Payne disse a un gruppo di politicanti nel vestibolo della Ebbitt House a Washington: «La Follette è un bell’idiota se crede di poter battere una ferrovia che ha cinquemila miglia di rotaia continua, s’accorgerà che si è sbagliato… Ci occuperemo di lui quando verrà il momento». Ma quando il momento venne, i contadini del Wisconsin e i giovani avvocati, dottori e uomini d’affari usciti allora dalla scuola si occuparono di lui e lo elessero tre volte governatore e poi al Senato degli Stati Uniti, dove lavorò tutta la vita facendo lunghi discorsi pieni di statistiche, lottando per salvare il governo democratico, per fare una repubblica di contadini e di uomini d’affari, solo, con la schiena al muro, combattendo la corruzione e il grosso commercio e l’alta finanza e i trust e le combinazioni e il mefitico letargo di Washington. Era uno del “gruppo esiguo di uomini testardi che non esprimevano altra opinione che la loro” che resistettero al progetto di Woodrow Wilson, della nave armata, che rendeva certa la guerra con la Germania; li chiamarono filibustieri
ma erano sei uomini di fegato che tentavano di tener indietro a mani nude un rullo compressore impazzito; la stampa iniettava odio ai lettori contro La Follette il traditore lo bruciarono in effigie nell’Illinois; a Wheeling rifiutarono di lasciarlo parlare. Nel 1924 La Follette concorse alla presidenza e senza denari né organizzazione politica mise insieme quattro milioni e mezzo di voti, ma era un uomo malato, il lavoro incessante e l’aria viziata delle stanze dei comitati e delle camere legislative lo soffocavano e l’odore sporco dei politicanti e morì un oratore arringante dal campidoglio di una repubblica che non era mai esistita; ma noi ricorderemo come sedeva fermo nel marzo 1917 mentre Woodrow Wilson veniva eletto per la seconda volta e per tre giorni tenne la gran macchina immobile. Non lo lasciavano parlare; le tribune lo mangiavano d’odio, il Senato era pronto a linciarlo, un uomo massiccio con una faccia tirata, una gamba sporta nella navata, le braccia conserte e un sigaro masticato in un angolo della bocca e un discorso mai pronunciato sul tavolino, un uomo caparbio che non esprimeva altra opinione che la sua.
Charley Anderson La madre di Charley Anderson teneva una pensione di ferrovieri vicino alla stazione della Northern Pacific a Fargo, N.D. Era una casa di legno, torrettata, con un porticato tutt’intorno, tinta di giallo senape con ornamenti bruno cioccolata, e dietro c’era sempre bucato steso sulle corde allentate che andavano da un palo presso l’uscio della cucina a una fila di pollai in rovina. La signora Anderson era una donna con gli occhiali, dalla parola pacata e dai capelli grigi; i pensionanti ne avevano soggezione e facevano le loro rimostranze sui letti, sul vitto, o che le uova non erano fresche, alla barcollante e bracciuta Lizzie Green, nativa del Nord Irlanda, ch’era la servente e faceva cucina e tutti i lavori di casa. Quando qualcuno della combriccola veniva a casa ubriaco, era Lizzie che, con un consunto soprabito maschile gettato sulla camicia da notte, usciva a fargli far silenzio. Uno dei guardiafreno cercò di fare il frescone con Lizzie una notte e si prese una tal botta sul muso che cadde a terra dal porticato anteriore. Fu Lizzie che lavò e strofinò Charley piccolo, che lo faceva andare a scuola in orario, gli metteva tintura d’arnica sulle ginocchia quando lui se le scorticava, e sapone dolce sui geloni, e gli rattoppava gli strappi dei vestiti. La signora Anderson aveva già allevato tre bambini, che se ne eran cresciuti e andati prima dell’arrivo di Charley, di modo che non se la sentiva più, pareva, di pensare a Charley. Il signor Anderson, anche lui, se n’era partito circa al tempo della nascita di Charley; aveva dovuto andare nell’Ovest per via dei polmoni deboli: non poteva resistere alle crude invernate, secondo che spiegava la signora Anderson. Essa teneva i conti; metteva in conserva o in scatola fragole, piselli, pesche, fagioli, pomodori, pere, susine, marmellata di mele, secondo che portava la stagione; faceva leggere ogni giorno a Charley un capitolo della Bibbia e sbrigava una quantità di lavoro per la chiesa. Charley era un ragazzotto tozzo, con scomposti capelli stopposi e occhi grigi. Era il cocco dei pensionanti e gli piaceva questo mondo, eccetto la domenica, che doveva andare in chiesa due volte e al catechismo e poi, subito dopo il pranzo, la mamma gli leggeva le
pagine favorite di Matteo o di Esther o di Ruth e gli faceva domande sui capitoli assegnati durante la settimana. La lezione aveva luogo a un tavolo coperto di una tovaglia rossa vicino a una finestra che la signora Anderson teneva assiepata con vasi di frassinella, di begonia e di felce, d’estate e d’inverno. Charley si sentiva le formicole nelle gambe e il gran pasto mangiato lo insonnoliva e aveva un terrore folle di commettere il peccato contro lo Spirito Santo, che sua madre lasciava intendere fosse lo star disattento in chiesa o al catechismo o quando lei gli leggeva la Bibbia. D’inverno, la cucina era del tutto tranquilla, eccetto il leggero ruggito della stufa, oppure il passo pesante o le fiatate sbuffanti di Lizzie, che rimetteva nella credenza i piatti lavati allora. D’estate era molto peggio. Magari gli altri ragazzi gli avevan parlato delle scorribande a nuotare nel Red River o a pescare o a giocare a “vienmi dietro” in legnaia o nelle carbonaie dietro le rimesse, e le mosche invischiate ronzavano flebili sui festoni di nastro moschicida e Charley ascoltava la piattaforma smistare carri merci oppure il treno di frontiera per Winnipeg fischiare alla stazione e la campana rintoccare, e si sentiva tutto sudato e prudere nel colletto rigido e continuamente guardava l’orologio di porcellana, dal sonoro tic-tac, sulla parete. Faceva passare il tempo troppo adagio guardar sovente l’orologio, cosicché si concedeva solo di guardare finché non gli paressero trascorsi quindici minuti, ma quando tornava a guardare ne eran passati solo cinque e Charley si sentiva disperato. Forse meglio di tutto era commettere subito il peccato contro lo Spirito Santo, venir dannato senz’altro una volta tanto e scappar via con un vagabondo come aveva fatto Dolphy Olsen, ma lui non aveva il coraggio. Quando fu preparato per la scuola media, cominciò a trovare cose curiose nella Bibbia, cose come quelle di cui parlavano i compagni quand’erano stufi di giocare al rospo nella buca tra le erbacce alte, dietro la barriera della legnaia; il pezzo su Onan e il levita e la sua concubina e il cantico di Salomone gli davano un senso strano e un forte batticuore, quando li leggeva, come ascoltare brani di discorsi tra i ferrovieri nella pensione; e sapeva cos’erano le puttane e che cosa capitava quando le donne ingrassavano così davanti e ne era turbato e
aveva cura, parlando con sua madre, di non lasciarle capire che lui sapeva di quelle cose. Il fratello di Charley, Jim, aveva sposato la figlia del padrone di una rimessa a Minneapolis. La primavera che Charley si stava preparando a dar l’esame dell’ottava classe, i due vennero a far visita alla signora Anderson. Jim fumava sigari anche in casa e diceva facezie alla madre e finché ci fu lui non si parlò di lettura della Bibbia. Jim condusse una domenica Charley a pescare su per il Sheyenne e gli disse che, se veniva alle Città Gemelle, 1 finite le scuole, lui gli avrebbe dato un posto da aiutante nell’autorimessa che stava aprendo in una parte della rimessa del suocero. Faceva bell’effetto, quando disse agli altri colleghi di scuola che aveva un posto in città, per l’estate. Era contento di andarsene perché sua sorella Esther tornava allora da un corso di puericoltura e lo tormentava continuamente e che parlava in gergo e che non teneva gli abiti puliti e che mangiava troppa torta. Si sentiva bene, il mattino che andò a Moorhead tutto solo, con una valigia imprestatagli da Esther, a prendere il treno per le Città Gemelle. Alla stazione tentò di comprare un pacchetto di sigarette, ma l’uomo dell’edicola lo canzonò e gli disse ch’era troppo giovane. Quando partì di casa, era una bella giornata di primavera, un po’ afosa. Avevano sudore ai fianchi, i grossi cavalli che tiravano la fila dei carri di farina attraverso il ponte. Mentre attendeva alla stazione, l’aria divenne soffocante e si levò una nebbia vaporosa. Il sole luccicava rosso sulle vaste schiene di silos, lungo il binario. Sentì uno dire a un altro «Credo che si avvicini un ciclone» e, quando salì in treno, si sporse mezzo dal finestrino aperto, osservando cumuli lividi che si ammucchiavano a nord-ovest, al di là del grano verdelucido che si stendeva fino alle nubi. Più o meno sperava che fosse un ciclone, perché non ne aveva mai veduti, ma, quando il lampo cominciò a schioccare come una frusta dalle nubi, ebbe un po’ di paura, benché, essendo in treno col controllore e gli altri viaggiatori, si sentisse più sicuro. Non era un ciclone, ma un pesante temporale e i campi di frumento diventarono color zinco, mentre la pioggia a grandi cortine sibilanti e abbattenti vi avanzava lenta tutt’attraverso. In seguito, uscì il sole e Charley aprì il finestrino e tutto sapeva di primavera: c’erano
uccelli che cantavano in ogni ciuffo di betulla e negli abeti foschi intorno ai laghetti luccicanti. Jim era là in attesa, alla Union Station, con un furgone Ford. Si fermarono allo scalo merci e Charley dovette aiutare a caricare una quantità di pesanti pacchi di pezzi di ricambio, spediti da Detroit e soprascritti “Autorimessa Vogel”. Charley cercò di darsi l’aria di chi ha vissuto tutta la vita in una grande città, ma i tranvai scampanellanti, gli zoccoli ferrati a chiodi dei cavalli ai carri, che sprizzavano scintille dall’acciottolato, le ragazze bionde tanto carine, i negozi, i grandi spacci tedeschi di birra e il brusio delle officine e dei lavoratori di macchine gli diedero alla testa. Jim era alto e smilzo nella tuta e aveva un insolito modo brusco di parlare. «Piccolo, attento a quello che fai in casa, il vecchio è un vecchio tedesco, il papà di Hedwig, e un po’ pignolo come tutti i vecchi tedeschi» disse Jim, riempito ch’ebbero il furgone, mentre si muovevano lenti in mezzo al traffico. «Sì, sì, Jim» disse Charley e cominciava a sentirsi un po’ preoccupato di quel che sarebbe stata la vita a Minneapolis. Avrebbe desiderato che Jim sorridesse un po’ di più. Il vecchio Vogel era un uomo massiccio, rosso in faccia, con disordinati capelli grigi e la pancetta, appassionato del bodino, degli stufati con sopra un abbondante sugo ben denso, e della birra; e la moglie di Jim, Hedwig, era la sua unica figlia. Sua moglie era morta, ma aveva una tedesca di mezza età, che tutti chiamavano zia Hartmann, a tenergli la casa. Costei stava sempre dietro agli uomini con uno strofinaccio e tra lei e Hedwig, che mostrava uno sguardo scontroso negli occhi azzurri perché nell’autunno doveva avere un bambino, la casa era talmente immacolata che si sarebbe potuto mangiare un uovo al tegame sopra qualunque punto del linoleum. Non lasciavano mai aprire le finestre per timore che entrasse la polvere. La casa dava sulla via e la rimessa era nel cortile posteriore, dove s’accedeva per un vicolo, oltre il quale c’era l’antica selleria, che era stata allora trasformata in autorimessa. Quando giunsero Jim e Charley, gli imbianchini erano su una scala a pioli intenti a tirar su la nuova insegna fiammante rossa e bianca, scritta AUTORIMESSA VOGEL. «Quel lazzarone» brontolò Jim. «Aveva detto che scriveva
“Vogel e Anderson”, ma al diavolo!» Tutto puzzava di stalla e un uomo di colore conduceva un ossuto cavallo, con indosso una coperta. Tutta l’estate Charley lavò automobili, ripulì tubi e riparò freni. Era sempre sporco e unto in una tuta unta, sempre al lavoro dalle sette del mattino e non se ne andava che tardi alla sera, quand’era troppo stanco per far altro che lasciarsi cadere sul giaciglio, che gli era stato assegnato nella soffitta sopra l’autorimessa. Jim gli dava un dollaro la settimana come denaro spicciolo e gli spiegava ch’era una grande generosità da parte sua, dato che giovava a Charley imparare il mestiere. La notte del sabato era l’ultimo a prendere il bagno e di solito non restava più che acqua rintiepidita, in modo che aveva il suo da fare a pulirsi. Il vecchio Vogel era socialista e mai andava in chiesa e passava tutta la giornata della domenica a bere birra cogli amici. A pranzo la domenica tutti parlavano in tedesco e Jim e Charley sedevano alla tavola cupi, senza dir nulla, ma il vecchio Vogel li torturava con la birra e diceva freddure, che facevano sempre ridere fragorosamente Hedwig e zia Hartmann, e dopo il pasto la testa di Charley vacillava per via della birra, che lui trovava orribilmente amara ma sentiva che bisognava bere, e il vecchio Vogel lo stuzzicava a fumare un sigaro e poi gli diceva di uscire a vedere la città. Charley usciva, con qualche vertigine, sentendo d’aver mangiato troppo, e prendeva il tram per St. Paul a vedere il nuovo campidoglio dello Stato o per il lago Harriet oppure al Big Island Park e faceva un giro sulla giostra delle automobili o camminava per i viali del prato, finché i piedi non gli facevano l’effetto di staccarsi. Non conosceva nessun ragazzo della sua età, in principio, e così si mise a leggere per avere una compagnia. Comperava tutti i numeri del «Popular Mechanics», dello «Scientific American», dell’«Adventure» e del «Wide World Magazine». Aveva già tutto progettato per mettersi a costruire una barchetta a vela sui disegni dello «Scientific American» e fare un viaggio giù per il Mississippi fino al Golfo. Si sarebbe sostentato tirando alle anitre e pescando. Cominciò a mettere da parte dollari per comperarsi un fucile. Comunque, gli andava a genio il lavoro dal vecchio Vogel, per via che non doveva leggere la Bibbia o andare in chiesa; pasticciare nei
motori gli piaceva e imparò a guidare il furgone Ford. Dopo qualche tempo fece conoscenza con Buck e Slim Jones, due fratelli quasi suoi coetanei, che stavano nello stesso isolato. Charley, che lavorava in un’autorimessa, era per loro un grande personaggio. Buck vendeva giornali, aveva un sistema suo di entrare nei cinematografi dalle porte di uscita e sapeva tutti i migliori steccati per vedere partite al pallone. Una volta che Charley ebbe conosciuto i due Jones, alla domenica correva a trovarli non appena aveva finito il pranzo e si divertivano un mondo a far corse a sbafo per tutto il vicinato sui furgoni da grano, a salire sui respingenti posteriori dei tram e farsi rincorrere dalle guardie, a montare sulle zattere di legname, andar a nuotare e risalire rampiconi le cascate, e Charley tornava tutto in sudore, con l’abito bello insudiciato, a farsi vociare da Hedwig per il ritardo alla cena. Ogniqualvolta il vecchio Vogel trovava i due Jones a ronzare intorno all’autorimessa, li scacciava, ma quando lui e Jim erano via, Gus, il mozzo di stalla negro, arrivava puzzolente di cavalli e raccontava loro storie di corse e donne allegre e bevute di whisky a Louisville e il verso giusto di pigliare una ragazza la prima volta e come lui e la sua ragazza fissa davan dentro tutta la notte senza fermarsi neanche un minuto. La festa del Lavoro, il vecchio Vogel portò Jim, la figlia e zia Hartmann a scorrazzare sul surrey dietro un bel paio di bai, che gli erano stati affidati per venderli, e Charley venne lasciato di guardia all’autorimessa, caso mai qualcuno arrivasse a cercare benzina o oli. Vennero Buck e Slim e dissero tutti tra loro che era la festa del Lavoro e che rabbia non poter andare da nessuna parte. C’era una doppia partita in Fair Grounds e una quantità di partite al pallone, dappertutto. La cosa cominciò con Charley che insegnò a Buck a guidare il furgone, poi per insegnargli meglio dovette accendere il motore, poi, prima ancora di pensarci, stava dicendo ai due che li avrebbe portati a fare un giro per l’isolato. Fatto il giro dell’isolato, Charley ritornò, chiuse l’autorimessa e se ne partirono esultanti verso Minnehaha. Charley prometteva a se stesso di guidare molto cautamente e ritornare a casa qualche ora prima dei suoi; ma, chi sa come, si trovò in velocità giù per un viale asfaltato e quasi investiva
un carrettino carico di bambine, che svoltò d’improvviso da una strada laterale. Poi, sulla via del ritorno, bevevano salsapariglia dalle bottiglie e se la spassavano, quando Buck improvvisamente disse che avevano una guardia in motocicletta alle spalle. Charley accelerò per sfuggire alla guardia, prese una curva troppo stretto e si arrestò con uno schianto contro un palo del telegrafo. Buck e Slim se la batterono a tutte gambe e rimase Charley a far fronte alla guardia. La guardia era uno svedese che bestemmiò, sacramentò, gli diede sulla voce e disse che lo avrebbe portato in gattabuia per aver guidato senza patente, ma Charley trovò la patente di suo fratello Jim sotto il sedile e spiegò che suo fratello gli aveva detto di ricondurre la macchina in rimessa, dopo che avevano consegnato un carico di mele a Minnehaha, e la guardia lo lasciò andare e gli disse di guidare più cauto un’altra volta. L’automobile andò benissimo, salvo che aveva un parafango acciaccato e l’asta del volante un po’ sulle ventitré. Charley andò a casa così lento che il radiatore bolliva quando giunse ed ecco il surrey fermo davanti alla casa e Gus che teneva i cavalli per la testa e tutta la famiglia intenta a smontare. Non c’era nulla da dire. Prima cosa che videro fu il parafango acciaccato. Tutti gli piombarono addosso, zia Hartmann strillava più di tutti, il vecchio Vogel era paonazzo in viso, tutti gli parlavano in tedesco, Hedwig gli dava strattoni alla giacca e schiaffi sulla faccia e dicevano che Jim doveva dargliene un fracco. Charley si seccò e disse che nessuno gliene avrebbe dato un fracco e allora Jim gli chiarì che era meglio, ad ogni modo, ritornasse a Fargo e Charley andò disopra, fece la valigia e se ne andò la sera stessa, senza dire ciao a nessuno, con la valigia in mano e cinque numeri arretrati dell’«Argosy» sotto il braccio. Aveva da parte appunto tanto denaro da prendere un biglietto per Barnesville. Dopo, dovette giocare a rimpiattino col controllore, finché saltò giù dal treno a Moorhead. Sua madre fu contenta di vederlo e gli disse ch’era un bravo ragazzo a ritornare in tempo per stare un po’ con lei, prima che si riaprisse la scuola, e parlò della sua prossima cresima. Charley non disse nulla del furgone Ford e decise dentro di sé che non lo avrebbero cresimato in nessuna chiesa, perdio. Mangiò una gran colazione che gli fu preparata da Lizzie e
andò nella sua camera a distendersi sul letto. Si chiese se non volere la cresima era il peccato contro lo Spirito Santo, ma il pensiero non lo atterrì come soleva fare le altre volte. Aveva sonno, essendo stato seduto tutta la notte in treno, e si addormentò subito. Charley si trascinò per un paio d’anni nella scuola media, mettendo insieme qualche soldo a lavorare di sera nell’autorimessa Moorhead, ma da quando era tornato dal suo viaggio alle Città Gemelle non gli piaceva più stare in casa. La madre non lo lasciava lavorare di domenica e lo tormentava sulla cresima, la sorella Esther lo tormentava su tutto e Lizzie lo trattava come fosse ancora un marmocchio, chiamandolo Cocco davanti ai pensionati. Era stufo di andare a scuola e così, la primavera che ebbe diciassette anni, dopo la premiazione tornò fino a Minneapolis, questa volta di suo, in cerca di lavoro. Siccome aveva denaro da mantenersi qualche giorno, prima cosa scese al Big Island Park. Spasimava di fare un giro sulla giostra delle automobili, sparare al tiro a segno, andare a nuotare e abbordar ragazze. Ne aveva abbastanza di paesucoli di campagna come Fargo e Moorhead, dove non succedeva mai nulla. Eri quasi buio, quando giunse al lago. Mentre il vaporetto si accostava alla banchina, poté udire l’orchestra di jazz traverso gli alberi, lo stridore e lo strepito della giostra delle automobili e strilli, quando una vettura dava un tuffo. C’era un padiglione da ballo e luci colorate tra le piante, un odore di profumi femminili, di meliga tostata, di canditi allo sciroppo, di polvere da sparo, e gli imbonitori erano al lavoro davanti ai baracconi. Siccome era lunedì sera, non c’era molta gente. Charley fece due giri sulle automobili e attaccò discorso col giovanotto che le manovrava, sulla possibilità di trovare lavoro in quei paraggi. Il giovanotto gli disse di fermarsi; Svenson, il padrone, sarebbe stato là alla chiusura alle undici e gli pareva bene che fosse in cerca di uno. Il giovane si chiamava Ed Walters e disse che quella non era una vigna troppo grassa, ma che Svenson era dritto; fece fare a Charley un paio di corse gratis, per mostrargli come funzionava la giostra, gli diede una bottiglia di limonata e gli raccomandò di esser pronto a tutto. Era il secondo anno che lui passava lavorando nei divertimenti e
aveva un sagace viso volpino e un fare giudizioso. A Charley picchiava il cuore, quando un omone dalla faccia incavata e dai ruvidi capelli rossi giunse a raccogliere gli introiti alla baracca dei biglietti. Era Svenson. Guardò Charley dalla testa ai piedi e disse che l’avrebbe tenuto in prova una settimana, si ricordasse che quello era un pacifico parco di divertimento per famiglie, lui non avrebbe sopportato alcun disordine e tornasse il mattino dopo alle dieci. Charley disse «arrivederci» a Ed Walters e prese l’ultimo vaporetto e l’ultimo tram per tornare in città. Quando uscì dal tram, era troppo tardi per ritirare la valigia dal bagagliaio della stazione; non voleva spendere denaro in una camera o andare da Jim e così dormì su una panca in faccia al Palazzo di Città. Era una notte tiepida e gli piaceva dormire su una panca come un vero vagabondo. I fanali gli pungevano gli occhi però e si sentiva nervoso per via della guardia; sarebbe stato un brutto guaio farsi arrestare come vagabondo e perdere il posto al parco. Gli battevano i denti, quando si destò nel mattino grigio, di buon’ora. I fanali spruzzolavano un lume rosa sopra un pallido cielo giallolimone; i grossi isolati di uffici con tutte le finestre vuote avevano un’aria buffa, grigia e abbandonata. Charley dovette camminare in fretta battendo i tacchi a terra per rimettersi il sangue in circolazione nelle vene. Trovò una baracca dove gli diedero una tazza di caffè e un panino per cinque cents e partì per il lago Minnetonka col primo tram. Era una nitida giornata estiva con un po’ di tramontana nel vento. Il lago era azzurrissimo, i tronchi delle betulle apparivano bianchi e le foglioline danzavano al vento verdigialle contro le fosche sempreverdi e il fosco azzurro del cielo. Charley pensò che quello era il più bel luogo che lui avesse mai veduto. Attese a lungo sonnecchiando nel sole, all’estremità della banchina, che il vaporino partisse per l’isola. Quando vi giunse, il parco era tutto chiuso, c’erano imposte su tutti i baracconi e le immobili vetture rosse e turchine della giostra parevano derelitte nella luce mattutina. Charley gironzolò un po’, ma gli bruciavano gli occhi, gli dolevano le gambe e la valigia era troppo pesante, e così trovò un posto riparato dal vento dietro la parete di una capannuccia, si distese nel sole tiepido sugli aghi dei pini e cadde
addormentato con la valigia accanto. Si destò con un sussulto. Il suo orologio faceva le undici. Provò un gelido senso di vertigine. Sarebbe schifoso perdere il posto per un’ora di ritardo. Svenson era là seduto nella baracca dei biglietti alla giostra, con un cappello di paglia sulla nuca. Non disse nulla dell’ora. Disse a Charley semplicemente di levarsi la giacca e aiutare MacDonald, il macchinista, a lubrificare il motore. Charley lavorò su quella giostra per tutta l’estate, finché il parco non chiuse in settembre. Viveva in un piccolo accampamento a Excelsior, con Ed Walters e un guappo di nome Spagnolo che teneva uno spaccio di canditi. Nell’accampamento vicino viveva Svenson con le sei figliole. Sua moglie era morta. La più adulta, Anna, andava sui trenta e faceva da cassiera al parco divertimenti; due servivano da cameriere al Tonka Bay Hotel, e le altre andavano a scuola e non lavoravano. Erano tutte alte, bionde e di bella carnagione. Charley s’innamorò della più giovane, Emiscah, che aveva circa la sua età. Avevano un gavitello e un trampolino e andavano tutti a nuotare insieme. Charley indossò per tutta l’estate una canottiera e un paio di pantaloni kaki, e venne tutto abbronzato. La ragazza di Ed si chiamava Zona e tutti e quattro solevano uscire in canoa, una volta chiuso il parco, specialmente nelle notti calde, quando c’era la luna. Non bevevano, ma fumavano sigarette, sonavano il grammofono, si baciavano e si raggomitolavano insieme in fondo alla canoa. Quand’erano di ritorno all’accampamento dei maschi, Spagnolo era già a letto e allora lo tormentavano e gli mettevano insetti sotto le coperte e lui bestemmiava, sacramentava e si dibatteva. Emiscah valeva tanto oro per far di queste sciocchezze, Charley ne era incantato e lei pareva lo trovasse simpatico. Gli insegnò a baciare alla francese, gli lisciava i capelli e gli si sfregava addosso come un gatto, ma non lo lasciò mai andare troppo oltre né a Charley sarebbe parsa comunque una cosa ben fatta. Una notte tutti e quattro uscirono e fecero un fuoco sotto un pino, in un tratto di boscaglia su per la collina, dietro gli accampamenti. Arrostirono altee e sedettero intorno al fuoco raccontando storie di fantasmi. Avevano coperte; Ed sapeva fare un letto con rami d’abete piantati in terra e
tutti e quattro dormirono nelle stesse coperte, si fecero il solletico e molte commedie e ce ne volle del tempo prima che s’addormentassero. Per un certo tempo Charley si trovò tra le due ragazze, che gli si raggomitolavano stretto vicino, e lui era troppo eccitato, non poteva dormire e lo preoccupava che le ragazze se ne accorgessero. Imparò a ballare e giocare al poker e, quando venne la festa del Lavoro, non aveva messo da parte neppure un soldo, ma aveva passato un’estate meravigliosa. Lui e Ed presero insieme una camera a St. Paul. Charley trovò un posto da aiutante meccanico nei laboratori della Northern Pacific e fece molto denaro. Imparò a manovrare un tornio elettrico e frequentò un corso alla scuola serale per prepararsi in ingegneria civile alla scuola superiore di meccanica. Ed pareva non avesse molta fortuna nei posti, tutto quel che pareva capace di fare era raggranellare qualche dollaro, di tanto in tanto, come di giocatore in un gioco di bocce. La domenica, sovente andavano a pranzo dagli Svenson. Il signor Svenson era padrone di un cinemino detto il Leif Eriksson nella Quarta Strada, ma gli affari non andavano troppo bene. Pigliava per stabilito che i giovani fossero fidanzati a due delle sue figlie ed era felicissimo di vederseli capitare in casa. Charley usciva ogni sabato sera con Emiscah e spendeva un mucchio in canditi e a portarla alle operette e alla trattoria cinese dove in seguito si poteva ballare. A Natale le diede il suo anello col sigillo e da allora Emiscah ammise di essergli fidanzata. Quando ritornavano a casa, seduti sul sofà nel salotto, si stringevano e si baciavano. Pareva ci pigliasse gusto, Emiscah, a sconvolgergli il sangue e poi scappare, andarsi ad aggiustare i capelli o mettere rossetto in viso, e stava via parecchio, mentre Charley la sentiva ridacchiare su per le scale con le sorelle. Lui passeggiava nel salotto, dove non c’era che una lampada in un paralume fiorato, e si sentiva nervoso e agitato. Non sapeva che fare. Non aveva voglia di sposarsi perché ciò gli avrebbe impedito di girare il paese e portarsi avanti nello studio. Gli altri colleghi del laboratorio non sposati saltavano il fosso o andavano con donne di strada, ma Charley aveva paura di prendersi una
malattia, non riusciva mai a trovare un momento – la scuola serale e tutto il resto – e d’altra parte era Emiscah che lui voleva. Datole un ultimo sgarbato bacio, sentendosi nella bocca la lingua di lei, con le narici piene dei suoi capelli e col sapore della bocca di lei nella sua, se ne andava a casa con le orecchie che ronzavano, nauseato e fiacco. In letto, non riusciva a dormire, ma si rivoltolava tutta la notte, convinto di diventar matto. Ed gli borbottava dall’altra sponda del letto, che porco giuda stesse tranquillo. A febbraio, Charley si sentì un forte mal di gola e il dottore da cui andò gli disse ch’era difterite e lo spedì all’ospedale. Durò in uno stato orribile per vari giorni, dopo che gli diedero il siero. Quando stava già meglio, Ed e Emiscah vennero a trovarlo, sedettero sulla sponda del letto e gli diedero un senso di conforto. Ed era tutto vestito a nuovo e disse che aveva un nuovo impiego e guadagnava gran soldi, ma non volle dire che cosa fosse. Charley si mise in mente che Ed e Emiscah da quando lui era malato si frequentassero piuttosto, ma non diede peso alla cosa. L’uomo del letto vicino, anch’egli convalescente di difterite, era un individuo sparuto, dai capelli grigi, che si chiamava Michaelson. Aveva lavorato in un negozio di coltellerie quell’inverno e la passava brutta. Fino a due o tre anni prima, aveva posseduto una cascina nell’Iowa, nella zona del granturco, ma una filza di cattivi raccolti lo aveva rovinato, la banca aveva agito senz’altro ed espropriato la cascina offrendogli di lasciarvelo lavorare come fittavolo, ma lui aveva risposto che sarebbe andato all’inferno prima di lavorare come fittavolo per chiunque e, levate le tende, era venuto in città, dove a cinquant’anni, con una moglie e tre bambini da mantenere, tentava di ricominciare tutto da capo. Era un grande ammiratore di Bob La Follette e aveva una teoria che i banchieri di Wall Street cospiravano per impadronirsi del governo e comandare il paese impoverendo il contadino. Parlava tutto il giorno con un’esile voce asmatica, finché l’infermiera non lo faceva star zitto, della Non-Partisan League, del Farmer-Labor Party, del destino del grande Nord-ovest, della necessità che avevano i lavoratori e i contadini di stringersi insieme per eleggere uomini onesti come Bob La Follette. Charley era entrato
quell’autunno in una sezione dell’AFL e i discorsi di Michaelson, interrotti da accessi di sfiato e di tosse, lo eccitavano e incuriosivano intorno alla politica. Decise di leggere di più i giornali e tenersi al corrente di ciò che avveniva nel mondo. Tra la guerra e tutto il resto, chi poteva dire quel che sarebbe successo? Quando la moglie e i figli vennero a trovare Michaelson, lui li presentò a Charley e disse che stare in letto vicino a un giovanotto sveglio come quello rendeva un piacere la malattia. Charley soffrì a vedere la miserabile aria smorta e malnutrita che quelli avevano, e i loro poveri indumenti in quella temperatura sottozero. Uscì dall’ospedale prima di Michaelson e l’ultima cosa che Michaelson disse, quando Charley gli si piegò sopra a stringergli la secca mano ossuta, fu: «Ragazzo, leggi Henry George, neh… Quello lo sa il male di questo paese, ostia se lo sa». Charley fu così contento di camminare sulle sue gambe giù per la via nevicosa, nel vento secco agghiacciato, e di cacciarsi di testa l’odor di iodoformio e di ammalati, che se ne dimenticò del tutto. Prima cosa che fece fu di andare da Svenson. Emiscah gli domandò dov’era Ed Walters. Lui disse che non era passato da casa e non lo sapeva. Emiscah s’attristò tutta, a quella risposta, e Charley si chiese che cosa significasse. «Non lo sa Zona?» domandò. «No, Zona ne ha un altro e non pensa che a quello.» Poi sorrise, gli batté sulla mano e lo coccolò un tantino; sedettero sul sofà e gli portò del dolce fatto da lei, si tennero per le mani, si diedero a vicenda baci appiccicaticci e Charley si sentì felice. Anna, quando entrò, disse che aveva un’aria patita e che ora avrebbero dovuto nutrirlo, e lui si fermò a cena. Il signor Svenson gli disse di venire a cena da loro ogni sera per qualche tempo, finché non si fosse rimesso in gambe. Dopo cena, giocarono tutti a carte nel salotto d’entrata e si divertirono molto. Charley, quando ritornò alla sua camera, s’imbatté all’entrata nella padrona, che disse che l’amico se n’era andato senza pagare l’affitto e che ora pagasse lui fino all’ultimo centesimo, altrimenti non lo lasciava salire nella camera. Charley discusse e disse che era uscito allora dall’ospedale e l’altra alla fine accettò di lasciarlo fermare ancora una settimana. Era una donnona dall’aria benigna, con le
guance raggrinzite e un grembiale giallo a fiorami, pieno di piccole tasche. Charley, salito nella camera, dove aveva dormito tutto l’inverno con Ed, la trovò tetramente fredda e solitaria. Si cacciò nel letto tra le lenzuola diacce e stette là rabbrividendo, debole, come un ragazzino, e quasi sul punto di piangere, chiedendosi come diavolo Ed se n’era andato senza lasciargli detto niente e perché Emiscah aveva fatto una faccia così strana, quando lui aveva detto di non sapere dove fosse Ed. Il giorno dopo, andò al laboratorio e riebbe l’antico posto, benché fosse talmente debole da non poter ancora servire a molto. Il caporeparto lo trattò nella circostanza molto umanamente e gli disse di non pigliarsela calda per due o tre giorni, soltanto che non l’avrebbe pagato per i giorni di malattia, perché lui, Charley, non era un impiegato anziano e non si era fatto fare il certificato dal medico della compagnia. Quella sera Charley andò al gioco di bocce dove Ed di solito lavorava. Il barista dal primo piano gli rispose che Ed aveva tagliato la corda alla volta di Chi 2 per via di un pasticcio a proposito di un orologio grattato. «E ha fatto bene, secondo me» aggiunse. «Quel tipo ha tutta l’aria di un farabutto.» Ricevette una lettera da Jim: diceva che la mamma gli aveva scritto da Fargo che era impensierita sul suo conto e che lui, Charley, si facesse vedere da Jim. Fu così che la domenica dopo andò dai Vogel. Prima cosa che disse, appena vide Jim, fu che il disastro della Ford era stato un brutto tiro da marmocchio, ci strinsero sopra la mano, Jim disse che nessuno ne avrebbe parlato e che faceva bene a fermarsi a pranzo con loro. Il pasto fu ottimo e ottima la birra. Il bimbo di Jim era un vero amore; faceva ridere Charley pensare di essere zio, persino Hedwig non pareva più scontrosa come una volta. L’autorimessa rendeva molto e il vecchio Vogel avrebbe ceduto lo stallaggio e si sarebbe ritirato. Quando Charley disse che studiava alla scuola serale, il vecchio Vogel gli prestò più attenzione. Qualcuno disse qualcosa su La Follette e Charley disse che era un grand’uomo. «A che cosa serve essere un grand’uomo quando si è dalla parte del torto?» disse il vecchio con schiuma di birra nei baffi. Diede un altro sorso al boccale e guardò Charley con smaglianti occhi azzurri.
«Ma questo è solo l’inizio… faremo ancora di te un socialista.» Charley arrossì e disse «Chi sa» e zia Hartmann gli ammonticchiò nel piatto un’altra porzione di Hasenpfeffer e vermicelli e purea di patate. Una cruda sera di marzo, Charley condusse Emiscah a vedere la Nascita di una nazione. Le battaglie, la musica e le trombe lo ridussero dentro come tanta gelatina. Tutti e due avevano le lacrime agli occhi, quando i due ragazzi s’incontrarono sul campo di battaglia e morirono, sul campo, l’uno nelle braccia dell’altro. Quando il Ku Klux Klan diede la carica attraverso lo schermo, Charley aveva la gamba contro la gamba di Emiscah e la ragazza gli piantò così forte le dita nel ginocchio, che gli fece male. Quando uscirono, Charley disse che perdinci quel che ci voleva per lui era di passare nel Canada, arruolarsi e attraversare l’oceano per vedere la Grande guerra. Emiscah gli disse di non fare lo sciocco e poi lo guardò così così e gli chiese se era britannofilo. Charley rispose che ciò non contava e che i soli che ci avrebbero guadagnato sarebbero stati i banchieri, chiunque vincesse. E lei: «Non è una cosa terribile? Non parliamone mai più». Quando ritornarono dagli Svenson, il signor Svenson era seduto nel salotto, in maniche di camicia, e leggeva il giornale. Si alzò su e venne incontro a Charley con un cipiglio grave e stava per dir qualcosa, quando Emiscah scosse il capo. Allora egli si strinse nelle spalle e uscì. Charley chiese a Emiscah che cosa bruciasse al vecchio. La ragazza lo afferrò, gli posò la testa sulla spalla e scoppiò a piangere. «Che c’è, micio; cosa c’è micio?» chiedeva lui. Emiscah non fece che piangere, piangere, finché Charley se ne sentì le lacrime sulle guance e sul collo e disse: «Sacramento, piantala, micio, mi rovini tutto il colletto». Emiscah si lasciò cadere sul sofà e Charley vedeva quanta fatica facesse per rimettersi. Le sedette accanto e si mise a batterle sulla mano. D’un tratto Emiscah si alzò e si fermò nel mezzo della stanza. Charley cercò di circondarla con le braccia per carezzarla, ma lei lo respinse. «Charley» disse con una vocetta sforzata «debbo dirti una cosa… Credo che avrò un bambino.» «Ma sei matta. Se non abbiamo mai neanche…» «Forse è di qualcun altro… Dio mio, voglio ammazzarmi.»
Charley la prese per le braccia e la fece sedere sul sofà. «Adesso calmati, e dimmi cos’è.» «Vorrei che mi picchiassi» disse Emiscah ridendo come una folle. «Su, dammi un pugno.» Charley si sentì tutto infiacchito. «Dimmi cos’è» fece. «Perdio, non può essere stato Ed.» Emiscah sollevò gli occhi spaventati, a guardarlo, con il viso contratto come quello di una vecchia. «No no… Ecco com’è stato. È da un mese che aspetto, e siccome non m’intendo abbastanza di queste cose ho chiesto a Anna e lei dice che debbo certamente avere un bambino e che dobbiamo sposarci subito; poi quella brutta vigliacca l’ha detto al papà e come facevo io a dire che non eri tu?… Credono che sia tu, capisci, e papà dice che già sono così i giovanotti al giorno d’oggi e tutto il resto, e dice che dovremo sposarci. Io credevo di non farmene accorgere e di non fartelo mai sapere, ma, così, ho dovuto dirtelo.» «Dio santo» disse Charley. Guardò il paralume rosa fiorato, con la frangia, intorno alla lampada sul tavolo accanto, e la tovaglia con la frangia e le sue scarpe e le rose sul tappeto. «Chi è stato?» «Quando tu eri all’ospedale, Charley. Avevamo bevuta tanta birra e mi ha portata all’albergo. È che io sono cattiva, ecco. Gettava i soldi da tutte le parti, siamo andati in tassì, credo che io ero impazzita. No, no, sono una ragazzaccia, Charley. Uscivo con lui tutte le sere, mentre tu eri all’ospedale.» «Perdio, era Ed.» Emiscah annuì, poi si nascose il viso e ricominciò a piangere. «Quel lazzarone fottuto» ripeteva Charley. Lei si raggomitolò sul sofà con il viso tra le mani. «È andato a Chicago… È proprio un farabutto» disse Charley. Sentì il bisogno di uscir fuori all’aria libera. Raccattò la giacca e il cappello e fece per infilarseli. Allora Emiscah si levò in piedi e gli si gettò addosso. Lo teneva stretto con le braccia serrate intorno al collo. «Davvero, Charley, ti ho sempre amato… Mi son sempre detta che eri tu, non lui.» Lo baciò sulla bocca. Charley la respinse, ma si sentì debole e stracco e pensò alle vie agghiacciate verso casa e alla fredda
camera d’entrata e pensò che cosa diavolo importava comunque? e si tolse di nuovo giacca e cappello, Emiscah lo baciò e lo carezzò e chiuse l’uscio del salotto e si carezzarono sul sofà e lei gli lasciò fare tutto ciò che volle. Poi, dopo un poco, accese la luce, si ricompose gli abiti e andò allo specchio ad aggiustarsi i capelli. Charley si rifece il nodo della cravatta. Emiscah gli ravviò i capelli quanto meglio poté con le dita, schiusero l’uscio del salotto con molta cautela e lei se ne andò nel corridoio a chiamare il babbo. Aveva la faccia accesa e di nuovo un’aria molto carina. Il signor Svenson, Anna e tutte le ragazze erano in cucina. Emiscah disse: «Papà, Charley e io ci sposiamo il mese venturo» e tutti dissero: «Congratulazioni». Tutte le ragazze baciarono Charley, il signor Svenson tirò fuori una bottiglia di whisky, tutti bevettero una volta e Charley andò a casa sentendosi come un cane bastonato. C’era un tale di nome Hendriks nel laboratorio, che pareva un tipo molto pratico. Charley gli chiese il giorno dopo se non conosceva qualcosa da dare a una ragazza, quello disse che aveva la ricetta di certe pillole e il giorno dopo gliela portò e disse a Charley di non dire al farmacista lo scopo a cui servivano. Era giorno di paga e Hendriks venne fino a casa di Charley, dopo che si fu lavato quella sera, a domandargli se aveva avuto le pillole senza incidenti. Charley aveva il pacchettino in tasca e stava appunto per marinare la scuola serale e portarlo a Emiscah. Ma prima, lui e Hendriks andarono a bere un bicchiere all’angolo. A Charley non piaceva il whisky puro e Hendriks gli disse di prenderlo con acqua zenzerata. Aveva un saporone e Charley si sentì triste e sventurato nell’intimo e non voleva più vedere Emiscah. Bevettero un altro poco e andarono a giocare un po’ alle bocce. Charley batté l’altro a quattro su cinque e Hendriks disse che ormai pagava lui tutta la sera. Hendriks era un tipo spalle quadre e testa rossa, con lentiggini in faccia e il naso storto. Cominciò a raccontare storie su casi buffi accaduti a lui con donne e come quello era comunque il suo passatempo fisso. Era stato dappertutto e aveva posseduto mulatte chiare e pelli nere giù a New Orleans, cinesine a Seattle, Wash., una squaw indiana purosangue a Butte, Montana, ragazze francesi ed
ebree tedesche a Colón e una caraibica di più di novant’anni a Port of Spain. Disse che le Città Gemelle erano balle e ciò che bisognava fare era scendere a cercar lavoro nei campi petroliferi di Tampico o nell’Oklahoma, dove era possibile guadagnare qualche soldo e vivere da bianco. Charley disse che se ne sarebbe andato da St. Paul senz’altro, se non fosse che voleva finire il corso alla scuola serale, e Hendriks gli disse che era un gran stupido, che studiare sui libri non aveva mai servito a nessuno, che quel che gli occorreva era divertirsi finché si trovava in gambe e poi che andasse tutto al diavolo. Charley disse che, comunque, se la sentiva la voglia di mandare tutto al diavolo. Andarono in diversi bar e Charley che non era abituato a bere in quantità, tranne la birra, cominciò a barcollare un po’, ma era una delizia rollare di bar in bar con Hendriks. Hendriks cantò My Mother Was a Lady in un locale e The Bastard King of England in un altro, dove un vecchio dal sigaro, rosso in viso, offrì loro qualche bicchiere. Poi cercarono di entrare in una sala da ballo, ma l’uomo alla porta disse che erano troppo sbronzi e li buttò fuori lunghi e distesi. Questa parve una cosa tanto da ridere e poi andarono nel retro di un locale che Hendriks sapeva e c’erano due ragazze che Hendriks conosceva e Hendriks combinò per dieci dollari a testa tutta la notte, poi bevettero ancora una volta, prima di andare dalle ragazze, e Hendriks cantò: Due commessi viaggiatori erano a pranzo al grand’otello pasteggiando chiacchieravano tra loro lì bel bello ma a una bella cameriera che arrivò col piatto in mano le parlarono da amici in questo modo un po’ villano. «È tremendo» disse una delle ragazze all’altra. Ma l’altra era un po’ bevuta e le venne una crisi di lacrime, quando Hendriks e Charley accostarono le teste e cantarono: Mia madre era una dama tanto quanto lo è la vostra e avrete una sorella che ha bisogno ora d’aiuto io sono qui in città che sto cercando un mio fratello voi non m’insultereste se ci fosse Jack mio bello. Poi piansero e l’altra le dava spintoni e le diceva: «Asciugati le lacrime, via, come sei sentimentale» e fu tanto da ridere.
Per qualche settimana Charley fu inquieto e triste. Le pillole fecero stare Emiscah orribilmente, ma alla fine la condussero in porto. Charley non andava sovente a trovarli, benché ancora dicessero: «Quando saremo sposati» e gli Svenson trattassero Charley da genero. Emiscah borbottò la sua parte intorno alle bevute e ai bighellonaggi di Charley con questo tal Hendriks. Charley aveva lasciato andare la scuola serale e stava cercando di trovare un lavoro che lo portasse lontano, in qualche parte, non importava dove. Poi un giorno fracassò un tornio e il caporeparto lo licenziò. Quando ne parlò a Emiscah, quella s’adirò e disse che le pareva ormai tempo di finirla col bere e bighellonare e di pensare un po’ di più a lei e Charley le rispose che davvero era ora di finirla, raccattò il cappello e giacca e via. Più tardi, mentre camminava per la strada, desiderò d’essersi ricordato di chiederle indietro l’anello col sigillo, ma a riprenderlo non tornò. Quella domenica andò a mangiare dal vecchio Vogel, ma non disse che aveva perduto il posto. Era un giorno di primavera, improvvisamente caldo. Charley aveva gironzolato tutta la mattina, col mal di capo per via di una sbronza presa con Hendriks la sera prima, e guardato gli zafferani e i giacinti nei parchi e le gemme rigonfie alle aiuole delle porte. Non sapeva cosa fare di se stesso. Aveva una settimana d’affitto arretrata, non andava più a scuola, non aveva più ragazza e si sentiva la voglia di mandare tutto al diavolo e arruolarsi sotto le armi per scendere al confine messicano. Gli doleva il capo e si sentiva stracco di trascinare i piedi su per i selciati nell’afa precoce. Uomini e donne benvestiti passavano in limousine o sedan. Saettò via un ragazzo su una motocicletta rossa. Charley desiderò di avere i mezzi per comprarsi una motocicletta anche lui e fare un viaggio in qualche luogo. La notte prima aveva cercato di convincere Hendriks a scendere nel Sud con lui, ma Hendriks diceva di aver trovato una sottana, un tipo in gamba, e tutte le notti ci faceva la sua e non aveva intenzione di mollarla. Al diavolo, pensò Charley, io voglio vedere qualche altro paese. Aveva un’aria così abbacchiata, che Jim gli chiese: «Che ti capita, Charley?» quando entrò nell’autorimessa. «Niente» disse Charley; e si mise a dar una mano alla ripulitura dei pezzi del carburatore di un
furgone Mack, dove Jim pasticciava. Il guidatore del furgone era un giovanotto dai capelli neri tagliati corti e la faccia abbronzata. A Charley piacque quel tipo. Diceva che andava il giorno dopo a caricare una partita di arredi di negozio a Milwaukee e cercava qualcuno che lo accompagnasse. «Volete me?» disse Charley. Il guidatore fece una faccia imbarazzata. «È mio fratellino, Fred, andrebbe bene… Ma, e il tuo posto?» Charley s’avvampò. «Mi son licenziato.» «Be’, venite con me dal padrone» disse il guidatore. «E se va a lui, va anche a me.» Partirono la mattina dopo, avanti giorno. A Charley rincresceva di scappar così di nascosto dalla padrona di casa, ma lasciò un biglietto sul tavolo dove diceva che le avrebbe mandato quanto le doveva, non appena trovato lavoro. Era bello abbandonare la città, le fabbriche e i silos, alle spalle, nella grigia e fredda luce mattutina. La strada seguiva il fiume e i promontori e il furgone ruggiva sguazzando nelle pozzanghere e rotaie fangose. Faceva freschetto, benché il sole, quando non era dietro le nuvole, fosse caldo. Charley e Fred dovevano urlare per farsi sentire, ma raccontavano storielle e cianciavano di questo e di quello. Passarono la notte a La Crosse. Giunsero appena in tempo in trattoria per ordinare bistecche, prima che chiudesse, e Charley si accorse di andar facendo colpo sulla cameriera, una di Omaha che si chiamava Helen. Aveva circa trent’anni e un’ombra di stanchezza sotto gli occhi, che fece credere a Charley che non fosse difficile. Stette lì intorno, finché non chiuse, e allora la portò a spasso. Camminarono lungo il fiume, il vento era tiepido e portava un odore vinoso di segheria, c’era una lunetta dietro nuvole fioccose e sedettero nell’erba novella, dov’era scuro, dietro cataste di legname tagliato di fresco e messo là a stagionare. La donna gli poggiò la testa sulla spalla e lo chiamò «bamboccino». Fred dormiva nel furgone, fatto su in una coperta sopra il telo, quando lui tornò. Charley si arrotolò nel suo soprabito dall’altra parte del furgone. Faceva freddo e le cassette di spedizione eran scomode a starci sopra, ma era stanco e si sentiva il volto bruciato dal vento e presto s’addormentò.
Furono di nuovo in cammino avanti giorno. Prima cosa che Fred disse fu: «E be’, ci sei riuscito, ragazzo?». Charley rise e accennò di sì. Si sentiva ben disposto e pensò tra sé che era ben fortunato a piantare le Città Gemelle, Emiscah e quel lazzarone di caporeparto. Il mondo intero gli giaceva steso innanzi come una carta e il furgone Mack lo attraversava ruggendo e le città lo attendevano da ogni parte, dove avrebbe trovato lavoro e guadagnato e conosciuto belle ragazze che l’attendevano per chiamarlo il loro bamboccio. Non si fermò molto a Milwaukee. Non avevano bisogno di aiutanti in nessuna delle autorimesse e così trovò un posto da lavapiatti, in una trattoria. Era un tristo lavoro unto e bisunto, che non finiva mai. Per risparmiare, non prese una camera, ma dormiva alla peggio in un furgone in una rimessa, dove lavorava un amico di Jim. Progettava di far la traversata in vaporetto non appena incassata la sua prima settimana. Uno dei lavoratori impiegati nella trattoria era un internazionale di nome Monte Davis. Fece abbandonare il lavoro a tutti, per via di una campagna per la libertà di parola che gli internazionali tenevano in città, e così Charley lavorò tutta una settimana e non ebbe un cent per il disturbo. Non mangiava da un giorno e mezzo, quando ritornò Fred con un altro carico sul Mack e gli pagò da mangiare. Bevettero poi della birra e fecero una gran discussione sugli scioperi. Fred diceva che tutte queste agitazioni di internazionali non erano che cretinerie e che le guardie facevan benissimo a metterli dentro, dal primo all’ultimo. Charley disse che i lavoratori dovevano unirsi per ottenere condizioni decenti di vita e che si avvicinava l’ora di una grande rivoluzione, come la rivoluzione americana, soltanto che sarebbe stata più grande e dopo non ci sarebbero più stati padroni e i lavoratori avrebbero diretto loro l’industria. Fred gli disse che parlava come uno straniero fottuto e se non aveva vergogna di se stesso e che un uomo bianco doveva credere nella libertà individuale e che, se gli andava male un lavoro, era capace porco giuda di trovarsene un altro. Si lasciarono risentiti, ma Fred era un bravo giovane e prestò cinque dollari a Charley per andare fino a Chi.
Il giorno dopo prese il vaporetto. C’era ancora qualche banco gialliccio di ghiaccio fradicio sul lago color azzurro freddo pallidissimo, con qualche bava d’onda. Charley non s’era mai trovato prima su una grande massa d’acqua e patì un po’, ma era bello vedere i camini e i grandi isolati di case, perlacei dove li batteva il sole, emergenti tra la foschia del fumo di fabbriche, i moli e i grossi barconi da minerale, solcanti tra le onde azzurre; e scendere dalla banchina con tutto nuovo dinanzi e tuffarsi nella folla, nella corrente delle automobili e degli omnibus verdi e gialli, sbarrati dal ponte levatoio di Michigan Avenue, e passeggiare nella brezza violenta, guardando le vetrine luccicanti, le belle ragazze e le gonne levate dal vento. Jim gli aveva detto di andare a trovare un suo amico, che lavorava in un rifornimento Ford in Blue Island Avenue, ma era tanto lontano che, quando vi giunse, l’uomo se n’era andato. C’era però il padrone e disse a Charley che, se tornava il mattino dopo, gli dava del lavoro. Charley, siccome non aveva dove andare e non voleva dire al padrone che era in bolletta, lasciò la valigia nella rimessa e gironzolò tutta la notte. Ogni tanto dava una strizzata di sonno su una panca di giardino, ma se ne svegliava rigido e intirizzito fino alle ossa e doveva fare una corserella per riscaldarsi. Pareva che la notte non finisse più e non aveva un soldo da pagarsi una tazza di caffè al mattino, e si trovò davanti alla rimessa nel mattino presto, a passeggiare in su e in giù, un’ora prima che qualcuno venisse ad aprirla. Lavorò nel rifornimento Ford parecchie settimane, finché una domenica s’imbatté in Monte Davis in North Clark Street e andò con lui a un comizio d’internazionali in faccia alla biblioteca Newberry. Le guardie sciolsero il comizio, Charley non si allontanò abbastanza svelto e, prima di sapere quel che gli accadeva, era stato semistordito da uno sfollagente e cacciato nell’auto della polizia. Passò la notte in cella con due individui barbuti ch’eran ubriachi fradici e, comunque, non pareva sapessero parlare inglese. L’indomani venne interrogato da un funzionario di polizia e, quando rispose che era un meccanico automobilista, un agente in borghese telefonò al rifornimento per avere informazioni; il funzionario lasciò Charley in libertà, ma, quando lui giunse alla rimessa, il padrone gli disse che non aveva
intenzione di tollerare nessun lurido non-voglio-lavorare alle proprie dipendenze, gli pagò quel che gli veniva e, anche lui, lo lasciò in libertà. Charley impegnò valigia e abito bello, fece un fagottino di qualche calza e due o tre camicie e andò a cercare Monte Davis per avvertirlo che aveva intenzione di andarsene, a piedi o a ruote, a St. Louis. Monte gli disse che c’era una campagna per la libertà di parola a Evansville e Charley decise che sarebbe andato a vedere. Salirono sul treno di Joliet. Passando davanti alle prigioni, Monte disse che la vista di una prigione gli dava sempre la nausea e una specie di presentimento. Diventò malinconico e disse che s’aspettava che ben presto i padroni lo acciuffassero, ma che ne sarebbero rimasti altri. Monte Davis era un giovanotto smorto, faccia scarna, di Muscatine, Iowa. Aveva un lungo naso storto, tartagliava e non riusciva a ricordarsi un tempo nella sua vita in cui non avesse venduto giornali o lavorato in una fabbrica di bottoni. Non pensava ad altro che all’IWW e alla rivoluzione. Fece una predica a Charley trattandolo da bagolone, perché Charley rideva di esser stato arrestato e lasciato in libertà due volte nella stessa giornata, e gli disse che doveva sentire la coscienza di classe e pigliare le cose sul serio. Alla periferia di Joliet saltarono su un furgone che li portò a Peoria, dove si separarono, perché Charley trovò un conduttore d’autocarro, da lui conosciuto a Chicago, che gli offrì di salire per tutto il viaggio fino a St. Louis. A St. Louis le cose non parvero mettersi troppo bene, e Charley entrò in rissa con una puttana incontrata in Market Street, la quale tentò di vuotargli le tasche; così, siccome un tale gli disse che a Louisville c’era lavoro in abbondanza, prese la strada verso l’Est. Nel tempo che giunse a New Albany, si mise a fare un caldo d’inferno e Charley aveva i piedi enfiati e coperti di ciocche, perché non era stato troppo fortunato nei trasporti clandestini. Si fermò a lungo sul ponte, guardando giù nella veloce corrente scura dell’Ohio, troppo stanco per andar oltre. Lo disgustava l’idea di camminare ancora in cerca di lavoro. Il fiume aveva il colore del pan pepato; Charley si mise a pensare al profumo dei panini pepati che Lizzie Green usava fargli nella cucina materna e pensò che era un imbecille maledetto a
vagabondare a quel modo. Sarebbe andato a casa e si sarebbe impiantato in mezzo ai cavalli, questo avrebbe fatto. Proprio in quel mentre un furgone Ford sconquassato passò con una gomma a terra. «Ohi, avete bucato» gridò Charley. Il conduttore frenò con uno schianto. Era un omone dalla testa a pallottola, in un maglione rosso. «Cosa diavolo c’entri tu?» «Porco cane, credevo che non ve ne foste accorto.» «Io mi accorgo di tutto, giovanotto… non ho avuto che noie tutto il giorno. Vuoi salire?» «Ma sì» disse Charley. «Là, non ci si può fermare sul ponte… Sempre così da stamattina. Mi levo prima di giorno e vado per caricare quattro botti di tabacco e quel negro fottuto perde la chiave del magazzino. Giuraddio, che se avessi avuto un fucile l’avrei disteso, quel lazzarone.» Alla testa del ponte fermò e Charley lo aiutò a cambiare la gomma. «Di dove vieni tu?» disse quello drizzandosi e spolverandosi i calzoni. «Sono di su, del Nord-ovest» disse Charley. «Scommetto che sei svedese, no?» Charley rise. «No, sono meccanico automobilista e cerco lavoro.» «Monta su, ragazzo, andiamo a vedere il vecchio Wiggins, è il mio padrone, se possiamo far qualcosa.» Charley restò tutta l’estate a Louisville, lavorando nei magazzini riparazioni Wiggins. Coabitava con un italiano, un tal Grassi, venuto in America per sfuggire al servizio militare. Grassi leggeva sempre i giornali e aveva una gran paura che gli S.U. entrassero in guerra. Allora, diceva, avrebbe dovuto battersela oltre la frontiera, nel Messico. Era un anarchico, un tipo tranquillo, che passava le serate canterellando tra sé e sonando la fisarmonica sugli scalini della pensione. Parlò a Charley delle grandi officine Fiat a Torino, dove aveva lavorato, e gli insegnò a mangiare gli spaghetti, a bere vino rosso e a cantare Funiculì funiculà sulla fisarmonica. La sua grande ambizione era di diventare pilota aviatore. Charley strinse rapporti con una ragazza ebrea, che lavorava da trasceglitrice in un magazzino di tabacchi. Si chiamava Sarah Cohen, ma si fece chiamare Belle. Charley la trovava abbastanza di suo gusto, ma ebbe cura di farle capire che lui non era di quelli che sposano. Belle disse che era una radicale che credeva nel libero amore, ma neanche questo gli andava molto. La portava a spettacoli, a passeggio nel Cherokee Park e le
regalò una spilla d’ametista, quando lei gli disse che l’ametista era il suo talismano. Quando pensava a se stesso, si sentiva parecchio abbacchiato. Era là a fare di giorno in giorno lo stesso lavoro, senza una probabilità di guadagnar mai di più o di imparare qualcosa o vedere il mondo. Quando venne l’inverno, si fece irrequieto. Aveva riscattato una vecchia vetturetta Ford, che stavano per trascinare tra i rifiuti, e l’aveva rattoppata con pezzi di ricambio buttati. Convinse Grassi a scendere con lui a New Orleans. Avevano un po’ di denaro da parte e sarebbero andati laggiù a cercar lavoro e assistere al Mardi Gras. La prima volta che si sentì un po’ bene, da quando era uscito da St. Paul, fu la giornata di pioggia e neve, in gennaio, quando partirono da Louisville, col motore che picchiava su tutti e quattro i cilindri e pneumatici di ricambio di terza mano in mucchio alle spalle, diretti al Sud. Scesero per Nashville, Birmingham e Mobile, ma le strade erano orribili e furon costretti a rifar tutta l’automobile via via che scendevano. Quasi morirono di gelo in una tormenta presso Guntersville e dovettero sostare per un paio di giorni, cosicché quando furon giunti alla St. Louis Bay e rotolarono lungo la strada costiera sotto un cielo turchino, godendo il sole caldo, guardando le palme e i banani e raccontando, Grassi, del Vesuvio e la Bella Napoli 3 e la sua ragazza a Torino, che non avrebbe visto mai più, per via di quella bastarda guerra capitalista, 4 il loro denaro era finito. Entrarono in New Orleans con un dollaro e cinque cents tra tutti e due e niente più che una tazza di benzina nel serbatoio, ma, per un colpo di fortuna, Charley riuscì a vendere l’automobile così com’era per venticinque dollari a un negro impresario di pompe funebri. Presero una stanza in una casa presso la gettata, a tre dollari la settimana. La padrona era una donna di Panama, giallastra; sul balcone fuori della stanza c’era un pappagallo e sulle spalle, a camminare per le vie, il sole era tiepido. Grassi era felice. «È come l’Italia» ripeteva. Fecero un giro e cercarono di informarsi sul possibile lavoro, ma, a quanto pareva, non si riusciva a saper nulla, tranne che il Mardi Gras era la settimana ventura. Passarono per Canal Street,
affollata di gente di colore, di cinesi, belle ragazze in abiti a colori vivi, frequentatori di corse, alti uomini anziani in abiti bianchi estivi. Si fermarono a prendere una birra in un bar aperto sulla via con tavolini all’esterno, dove ogni specie d’uomini sedeva fumando sigari e bevendo. Quando uscirono, Grassi comperò un giornale pomeridiano. Impallidì e mostrò il titolo LA GUERRA CON LA GERMANIA È IMMINENTE. «Se l’America entra in guerra con la Germania, le guardie arrestano tutti gli italiani per mandarli indietro in Italia alla guerra, capisci? Detto un mio amico che lavora da un console, detto lui, capisci? Io non voglio andare alla guerra capitalista.» Charley cercò di canzonarlo, ma in faccia a Grassi si fissò un’aria preoccupata e, appena imbrunì, lasciò Charley dicendo che ritornava alla cuccia a mettersi a letto. Charley camminò per le vie da solo. Veniva un odor tiepido di melassa dalle raffinerie di zucchero, profumi di giardini e di cucina all’aglio, al pepe e all’olio. Pareva che dappertutto ci fossero donne, nei bar, dritte agli angoli delle vie, fisse a invitare con gli occhi da dietro le imposte socchiuse di tutti gli usci e di tutte le finestre; ma Charley aveva venti dollari indosso e temeva che qualcuna glieli grattasse, e così non fece che passeggiare finché fu ben stanco e allora ritornò alla stanza, dove trovò Grassi già addormentato con le coperte in testa. Era tardi, quando si svegliò. Il pappagallo squittiva sul balcone fuori della finestra, un sole caldo empiva la stanza. Grassi non c’era. Charley s’era vestito e stava pettinandosi, quando Grassi entrò con un’aria molto eccitata. S’era trovato una cuccetta da aiuto macchinista su una nave mercantile diretta nell’America del Sud. «Quando sono a Buenos Aires, addio e più niente guerra» disse. «Se l’Argentina entra in guerra, addio un’altra volta.» Baciò Charley sulla bocca, volle a tutti i costi lasciargli la fisarmonica e aveva le lacrime agli occhi, quando se ne andò a raggiungere la nave che partiva a mezzodì. Charley girò tutta la città, chiedendo nelle autorimesse e nei laboratori meccanici se non c’era modo di lavorare. Le vie erano larghe e polverose, fiancheggiate da basse baracche con le imposte, le distanze eran forti. Si stancò, s’impolverò e si ridusse tutto in un
sudore. La gente con cui parlava era maledettamente cordiale, ma pareva che nessuno sapesse dove ci fosse lavoro. Decise, comunque, di fermarsi per tutto il Mardi Gras e poi ritornare nel Nord. Uomini con cui si trovò a parlare gli dissero di andare nella Florida o a Birmingham, Alabama o su a Memphis oppure a Little Rock, ma tutti erano d’accordo che, a meno che volesse imbarcarsi da marinaio, in tutta la città non c’era un posto solo. Le giornate scorrevano calde, lente, assolate, e impregnate di melassa delle raffinerie. Charley passò molto tempo a leggere alla biblioteca pubblica o sdraiato sulla gettata a guardare i negri scaricare le navi. Aveva troppo tempo per pensare e si chiedeva disperato che cosa avrebbe fatto di se stesso. Le notti non poteva dormir bene, perché non aveva fatto nulla, tutto il giorno, da esser stanco. Una notte sentì una chitarra sonare in un ritrovo detto l’Original Tripoli in Chartres Street. Entrò, sedette a un tavolino e ordinò da bere. Il cameriere era un cinese. Alcune coppie ballavano, che pareva facessero la lotta, all’estremità semibuia della sala. Charley decise che, se trovava una ragazza a meno di cinque dollari, la prendeva. Dopo non molto si trovò a offrire da bere e da mangiare a una ragazza che disse di chiamarsi Liz. Gli disse che non aveva ancor mangiato dal mattino. Le chiese del Mardi Gras e quella rispose ch’era una giornata perfida, perché le guardie facevan chiudere tutto a chiave. «Ieri notte hanno fatto la retata di tutte quelle del giro, al lungomare, le hanno mandate dalla prima all’ultima su per il fiume.» «Che cosa ne fanno?» «Le portano fino a Memphis e poi le lasciano andare… non c’è una prigione in tutto lo Stato che ci stiano tutte le troiette di questa città.» Risero insieme, bevvero un’altra volta e poi ballarono. Charley la teneva stretta. Era una ragazza magra con piccoli seni appuntiti e larghi fianchi. «Ostia, piccola, hai del movimento» disse Charley dopo ch’ebbero ballato un istante. «È il mio mestiere, no, far divertire i ragazzi?» Piaceva molto a Charley il modo come lo guardava. «Di’, piccola, quanto prendi?» «Cinque caviglie.» «Ostia, non sono un milionario io… e non hai mangiato qualcosa già?» «Va bene, tesoro di mammà, facciamo tre.» Bevvero un’altra volta. Charley osservò che la ragazza prendeva
sempre una specie di limonata. «Non bevi mai niente, Liz?» «Non si beve facendo la vita, bello, capisci? prima cosa, lo rigetteresti.» C’era un omone ubriaco, con una maglietta sporca, un’aria da fuochista da nave, che barcollava per la sala. Costui afferrò un polso a Liz e se la fece ballare insieme. Le sue braccia enormi, tatuate in rosso e turchino, la circondavano interamente. Charley vide che le pestava e strattonava il vestito, ballando con lei. «Lascia andare, lazzarone» gridava lei. Ciò punse Charley che accorse e le strappò via l’uomo. Quello si volse e gli tirò. Charley scartò e saltò in mezzo alla sala, coi pugni in guardia. L’omone era ubriaco fradicio, e mentre lui gli lasciava andare un’altra falciata, Charley sporse il piede e quello inciampò e cadde sul ventre rovesciando un tavolino e, insieme, un ometto scuro dai baffi neri. In un attimo l’uomo scuro era in piedi e brandiva un machete. I cinesi accorrevano da tutte le parti, miagolando come un mucchio di maledetti gabbiani. Il padrone, uno spagnolo grasso col grembiale, era uscito dal banco e gridava «Fuori tutti, dal primo all’ultimo». L’uomo dal machete corse contro Charley. Liz gli diede uno strattone da una parte e, prima che Charley capisse quel ch’era accaduto, lo trascinava per un seguito di cessi fetidi in un corridoio che dava in una porta posteriore sulla via. «Sei così stupido da attaccar lite per una lurida puttana?» gli diceva all’orecchio. Una volta in strada, Charley voleva ritornare a prendere cappello e giacca. Liz non lo lasciò andare. «Te li prenderò io domani mattina» disse. Camminarono insieme per la via. «Sei una brava ragazza, diavolo, mi piaci» disse Charley. «Arriva a dieci dollari e ti fermi tutta la notte.» «Ostia, piccola, sono al verde.» «Allora bisognerà che ti mandi via e che vada ancora un po’ a battere… Non c’è che uno al mondo che l’ha per niente e non sei tu quello.» Se la spassarono, insieme. Sedevano sulla sponda del letto discorrendo. Liz era animata e graziosa, in un suo modo fragile, nella leggera camicia rosa. Gli fece vedere un’istantanea del suo amico, macchinista in seconda su una nave cisterna. «Neh, che è bello? Non vado a battere, quando lui è in città. È così forte… Può rompere una noce col bicipite.» Gli indicò sul braccio il punto dove l’amico riusciva
a rompere una noce. «Di dove sei?» chiese Charley. «Cosa t’importa?» «Sei del Nord, si sente da come parli.» «Eh già. Sono dell’Iowa, ma non ci tornerò mai più… È una vita dannata, bello, e non dimenticare… Donne di piacere, un corno. Una volta credevo di esser una signora di società là a casa mia, e poi un mattino mi sono svegliata e ho trovato che non ero altro che una lurida puttana.» «Mai stata a New York?» Liz scosse il capo. «Non è poi una vita tanto brutta se una non beve e si guarda dai ruffiani» disse meditabonda. «Io ho in mente di andare a New York subito dopo il Mardi Gras. Non sembra possibile trovare un padrone in questa città qui.» «Il Mardi Gras non è niente, se uno è al verde.» «Mah, sono venuto giù per vederlo e tanto vale che lo veda.» Era l’alba, quando la lasciò. Litz scese le scale con lui. Charley la baciò e le disse che le avrebbe dato dieci dollari, se gli ricuperava il cappello e la giacca. Liz gli disse di passare da lei quella sera alle sei, ma di non ritornare al Tripoli, perché quel messicano era un poco di buono e gli avrebbe fatto la posta. Le vie di antiche case di stucco, inserite di balconi a ricami di ferro, erano colme di nebbia azzurrina. Poche mulatte, avvolte di fazzoletti, s’aggiravano nei cortili. Al mercato, vecchi di colore allargavano frutta e verdura. Quando fu di ritorno al suo covile, la donna di Panama era fuori sul balcone della sua stanza con in mano una banana e chiamava «Ven, Polly… Ven, Polly» con una vocetta guaiolante. Il pappagallo stava sull’orlo delle tegole del tetto, le fissava addosso un occhio vitreo e chiocciava dolce. «Qui tutta notte io» disse la donna di Panama con un sorriso lacrimoso. «Polly no quiere venir.» Charley si arrampicò sull’imposta e fece per afferrare il pappagallo, ma questi balzò lateralmente alla sommità del tetto e tutto ciò che Charley combinò fu che gli venne una tegola in testa. «No quiere venir» disse con tristezza la donna. Charley le fece un ghigno e andò in camera sua, dove si lasciò cadere sul letto e s’addormentò.
Durante il Mardi Gras, Charley bighellonò per la città, finché non gli dolsero i piedi. C’erano dappertutto folla, lumi, calca, sfilate, orchestre e ragazze che giravano in costume. Abbordò ragazze in quantità, ma appena sapevano che era al verde lo piantavano. Spendeva il suo denaro quanto più adagio poteva. Quand’era affamato, entrava in un bar e prendeva un bicchiere di birra, mangiando quanta più roba gratuita osava. L’indomani del Mardi Gras, le folle cominciarono ad assottigliarsi e Charley non aveva più un soldo per la birra. Gironzolò affamato e abbattuto, l’odore di melassa e quello dell’assenzio dei bar del quartiere francese, nella grave atmosfera umida, gli davano la nausea. Non sapeva che cosa fare di se stesso. Non aveva il coraggio di andarsene a piedi o ritentando i trasporti clandestini. Passò alla Western Union e tentò di telegrafare a Jim porto assegnato, ma l’impiegato disse che non accettavano a porto assegnato telegrammi che chiedevan denaro. La donna di Panama lo mandò via, quando lui non poté più pagare anticipata un’altra settimana; e così si trovò a scendere per Esplanade Avenue con la fisarmonica di Grassi da una parte e il fagottino del vestiario, avvolto in un giornale, dall’altra. Scese per la gettata, sedette nell’erba al sole e meditò a lungo. Non gli restava che gettarsi nel fiume o arruolarsi nell’esercito. Poi d’un tratto si ricordò della fisarmonica. Una fisarmonica valeva dei bei soldi. Lasciò il fagotto degli indumenti sotto certe tavole e girò con la fisarmonica da tutti gli strozzini che trovò, ma in nessun luogo gli offrirono più di quindici dollari. Nel tempo che impiegò a girare in tutte le botteghe di strozzini e di strumenti musicali, venne notte e dappertutto fu chiuso. Charley continuò a camminare incespicando sull’acciottolato, balordo e nauseato dalla fame. All’angolo di Canal Street e Rampart si fermò. Usciva una canzone da un’osteria. Gli venne in mente di entrare e sonare Funiculì funiculà sulla fisarmonica. Forse ne avrebbe ricavato un bicchiere di birra e qualcosa da mangiare. Aveva appena cominciato a sonare e l’uomo saltava già il banco per venirgli a dare la fuga, quando un individuo alto, gettato a un tavolino, gli fece un cenno.
«Fratello, venite qui a sedervi.» Era un omone dal lungo naso rotto e dagli zigomi sporgenti. «Fratello, sedetevi.» Il padrone ritornò dietro il banco. «Fratello, voi sonate ’sta fisarmonica peggio di un coniglio. Io non sono che un disperato di Okachobee City, ma se non sapessi sonare che così…» Charley si mise a ridere. «Lo so che non sono capace. E così.» Quello della Florida tirò fuori un bel mazzo di biglietti. «Fratello, sapete cosa si fa?… Voi mi vendete il fottuto strumento… Io non sono che un disperato, ma cristo…» «Ohi, Doc, non fare stupidaggini… Non hai bisogno di questa roba.» I suoi amici cercavano di fargli rintascare il denaro. Doc avventò il braccio in circolo con un gesto che gettò a terra tre bicchieri con uno schianto. «Voialtri merli, parlate quando vi tocca… Fratello, quanto chiedete della fisarmonica?» Il padrone era tornato e incombeva minaccioso al tavolino. «Intesi, Ben» disse Doc. «Paga tutto zio Henry… porta un altro giro di quel buon whisky. Fratello, quanto chiedete?» «Cinquanta dollari» disse Charley con un rapido calcolo. Doc gli porse cinque biglietti. Charley buttò giù un bicchiere, posò la fisarmonica sul tavolino e se n’andò alla lesta. Aveva paura che, se si fermava, a quell’altro passassero i fumi e cercasse di farsi rendere i denari; e poi, voleva mangiare. L’indomani prese un biglietto di terza sul piroscafo Momus diretto a New York. Il fiume era a un livello più alto che la città. Era curioso stare a poppa del piroscafo e abbassare gli occhi sui tetti, le vie e i tram di New Orleans. Quando il piroscafo salpò dalla banchina, Charley cominciò a star meglio. Scovò il dispensiere negro e si fece dare una cuccetta di coperta. Mettendo il fagotto sotto il guanciale, diede un’occhiata nella cuccetta sottostante. Ed ecco là Doc, profondamente addormentato, vestito leggero di grigio e cappello di paglia, con un sigaro spento in un angolo della bocca e la fisarmonica accanto. Stavan varcando le gettate di Ead e avevano in viso il vento del lago e sotto i piedi il primo malfermo rollio del golfo, quando Doc salì
in coperta barcollando. Riconobbe Charley e gli andò incontro con una manona tesa. «Che mi venga un accidente se questo non è il musicante… Buona quella fisarmonica, ragazzo. Credevo che siccome sono soltanto un giovincello di campagna eccetera mi aveste truffato, ma mi venga un accidente, se non valeva il suo denaro. Bevete una volta?» Andarono a sedersi sulla cuccetta di Doc e Doc ruppe il collo a una bottiglia di Bacardi; bevvero un po’ e Charley raccontò come aveva provato la più nera delle bollette: se non fosse stato per quei cinquanta dollari, lui sarebbe stato ancora seduto sulla gettata; e Doc disse che, se non fosse stato per quei cinquanta dollari, lui avrebbe viaggiato in prima classe. Doc disse che andava a New York per imbarcarsi alla volta della Francia come volontario di sanità; non tutti i giorni c’era modo di assistere a una guerra così grande e voleva arrivarci prima che tutto andasse a rotoli; pure non gli andava l’idea di sparar dietro a tanti bianchi coi quali non era in lite, e il suo gli pareva il sistema migliore; se gli unni fossero stati negri, l’avrebbe pensata diversamente. Charley disse che andava a New York perché credeva che ci fossero buone probabilità di studio in una città così grande e che lui era meccanico automobilista e voleva diventare ingegnere civile o qualcosa di simile, perché non c’era avvenire per un lavoratore che non aveva studiato. Doc disse che eran tutte balle e che quel che un ragazzo come lui doveva fare era arruolarsi come meccanico in servizio di sanità e avrebbe preso cinquanta dollari al mese e forse di più e questo sull’altra sponda era un bel gruzzolo e doveva vedere ’sta guerra fottuta, prima che tutto andasse a rotoli. Doc si chiamava William H. Rogers e veniva originariamente dal Michigan. Il suo vecchio era stato vignaiuolo a Frostproof e Doc aveva fatto i soldi in un paio di fortunati raccolti di vegetali tra le melme di Everglades e voleva andare a vedere le madamiselle, prima che tutto andasse a rotoli. Erano ubriachi bene, quando discese la notte, e sedevano a poppa con un tale male in arnese, dalla bombetta, che diceva di essere un
estone del Baltico. L’estone, Doc e Charley salirono dopo cena sul ponticello sopra il castello di poppa. Il vento era caduto, era una notte stellata con un lieve rollio e Doc disse: «Sacrodio, questo bastimento ha qualche cosa… Prima che scendessimo a cena, l’Orsa Maggiore era a nord e adesso ha girato a sud-ovest». «È quanto ci si può aspettare in una società capitalìsticeskaia» disse l’estone. Quando poi seppe che Charley aveva la tessera rossa e che Doc non credeva nello sparare addosso a nessuno tranne ai negri, fece un grande discorso su come la rivoluzione era scoppiata in Russia e lo zar doveva abdicare e quello era l’inizio della rigenerazione dell’umanità dall’Oriente. Disse che gli estoni avrebbero avuto la loro indipendenza e che presto tutta l’Europa sarebbe stata i liberi Stati Uniti sozialìsticeski d’Europa, sotto la bandiera rossa, e Doc disse: «Cosa vi dicevo, Charley… Tutta la storia andrà presto a rotoli… Quel che occorre è di venire con me a vedere la guerra, finché dura». E Charley disse che Doc aveva ragione e Doc disse: «Vi porterò agli uffici con me, ragazzo, e tutto quel che dovete fare è mostrare la vostra patente di automobilista e dire che siete uno studente universitario». L’estone se l’ebbe per male a questo punto e disse che era dovere di ogni lavoratore con coscienza di classe rifiutarsi di combattere in questa guerra e Doc disse: «Noi non combattiamo, vecchio. Noi non facciamo altro che portar via i giovanotti prima che li peschino, capisci? Mi spiacerebbe molto, se tutta la faccenda andasse a rotoli, prima che arrivassimo noi, no, Charley?». Poi discussero ancora un po’ sulla posizione dell’Orsa e Doc ripeteva che si era spostata a sud e, finito che ebbero il secondo litro, Doc stava dicendo che non credeva che i bianchi dovessero uccidersi l’un l’altro, ma i negri sì, e cominciò a girare il piroscafo in cerca di quel maledetto dispensiere negro per ammazzarlo in via dimostrativa e l’estone cantava La marsigliese e Charley diceva a tutti che ciò che gli occorreva era di entrare nella Grande guerra prima che andasse tutto a rotoli. L’estone e Charley ebbero il loro da fare a tenere Doc nella cuccetta, quando l’andarono a mettere a letto. Quello continuava a saltar fuori, vociando che voleva uccidere un paio di negri. Arrivarono a New York in una bufera di neve. Doc disse che la
statua della Libertà pareva avesse addosso una candida camicia da notte. L’estone si guardava intorno, ronzava La marsigliese e diceva che le città americane non erano artistiche perché non avevano le torrette sulle case, come nell’Europa baltica. Quando scesero a terra, Charley e Doc andarono insieme al Central Hotel di Broadway. Charley non era mai stato in un grand’albergo simile e voleva cercare un buco più modesto, ma Doc insistette che venisse con lui e disse che aveva denaro in abbondanza per tutti e due e che era inutile fare economia, perché presto tutto sarebbe andato a rotoli. New York era piena di motori stridenti, d’automobili rombanti e il fragore dell’aerea e gli strilloni che gridavano le edizioni straordinarie. Doc imprestò a Charley un abito presentabile e lo condusse all’ufficio Arruolamenti della sanità, che era nell’ufficio di un importante avvocato in un grande palazzo luccicante nel mezzo del quartiere della finanza. Il signore, che prendeva il nome dei giovanotti, era un avvocato di New York e disse loro che erano volontari e gentiluomini: si comportassero da gentiluomini e facessero onore alla causa degli Alleati, alla bandiera americana e alla civiltà, per cui i coraggiosi soldati francesi combattevano da tanti anni nelle trincee. Quando seppe che Charley era un meccanico, lo segnò, senza indugiare a scrivere al direttore della scuola e al pastore della chiesa luterana di Fargo, i cui nomi lui aveva dati come referenze. Disse loro delle iniezioni antitifiche e della visita medica, e di venire il giorno dopo a informarsi della data di partenza. Quando uscirono dall’ascensore, c’era un gruppo di uomini, nel vestibolo lucido di marmo, con la testa abbassata su un giornale: gli S.U. erano in guerra con la Germania. Quella sera Charley scrisse alla madre che lui andava alla guerra e per favore gli mandasse cinquanta dollari. Poi con Doc uscirono a dare un’occhiata alla città. C’erano bandiere su tutte le case. Passavano accanto a un palazzo d’affari dopo l’altro, in cerca di Times Square. Dappertutto la gente leggeva giornali. Nella Quattordicesima sentirono un rullar di tamburi e una banda, e si fermarono all’angolo per vedere che reggimento fosse, ma era soltanto l’Esercito della Salvezza. Quando furono giunti in Madison Square era ora di cena e le vie eran deserte. Cominciò a
piovigginare e le bandiere lungo Broadway e la Quinta Avenue pendevano flosce dalle aste. Entrarono nell’Hofbrau a mangiare. A Charley pareva troppo di lusso, ma Doc disse che pagava lui. Alla porta c’era un tale, su una scala a pioli, che avvitava le lampadine nell’insegna elettrica di una bandiera americana. Il ristorante all’interno era drappeggiato di bandiere americane e l’orchestra suonava The Star-Spangled Banner ogni due numeri, di modo che continuamente bisognava alzarsi in piedi. «Dove credono che siamo, in palestra?» borbottò Doc. C’era un gruppo di persone a un tavolino rotondo nell’angolo, che non si alzavano quando l’orchestra suonava The Star-Spangled Banner, ma se ne stavano sedute parlando e mangiando tranquille, come niente fosse. In giro per il ristorante si cominciò a fissarli e a far commenti. «Scommetto che sono… unni… spie tedesche… pacifisti.» C’era un ufficiale dell’esercito a un tavolino con una ragazza, che diventava rosso ogni volta che li guardava. Finalmente un cameriere, un tedesco anziano, andò alla loro volta e sussurrò qualcosa. «Corpo… neanche per sogno» venne la voce dal tavolino nell’angolo. Allora l’ufficiale si avvicinò e disse qualcosa sulla cortesia verso l’inno nazionale. Ritornò più rosso in viso che mai. Era un ometto dalle gambe storte, strette in gambali ben lucidati. «Farabutti di germanofili» sibilò sedendosi. Subito dovette balzar in piedi, perché l’orchestra suonava The Star-Spangled Banner. «Perché non chiami la polizia, Cyril?» disse la ragazza che aveva insieme. Ormai gente da ogni parte del ristorante veniva verso il tavolino rotondo. Doc fece voltare Charley. «Guardate, comincia il bello.» Un omone, con l’accento del Texas, strappò dalla sedia uno di quei tali. «O in piedi o fuori.» «Non avete nessun diritto di immischiarvi con noi» cominciò uno di quelli del tavolino. «Voi esprimete la vostra approvazione alla guerra alzandovi in piedi, noi esprimiamo la nostra disapprovazione…» C’era una donnona dal cappello rosso, con una piuma, al tavolino, che badava a ripetere: «Sta’ zitto, non parlargli». L’orchestra s’era fermata. Tutti applaudirono, più forte che poterono, e gridarono:
«Suonate di nuovo, ci vuole». I camerieri scorrazzavano in giro nervosamente e il proprietario era in mezzo alla sala, che si tergeva la testa calva. L’ufficiale s’avvicinò al direttore dell’orchestra e disse: «Fate il favore di suonare ancora il nostro inno nazionale». Alle prime note s’irrigidì sull’attenti. Gli altri si precipitarono al tavolino rotondo. Doc e l’uomo dall’accento inglese si davano spintoni. Doc si mise in guardia per colpirlo. «Venite fuori, se volete che ce le diamo» diceva l’uomo dall’accento inglese. «Lasciateli stare, ragazzi» gridava Doc. «Ne voglio, fuori, due per volta.» Il tavolino andò all’aria e il gruppo cominciò a indietreggiare verso la porta. La donna dal cappello rosso diede mano a una scodella di mayonnaise all’aragosta e teneva indietro la folla, distribuendone manate sui musi. In quel momento comparvero tre guardie e arrestarono i porci pacifisti. Tutti rimasero intorno a forbirsi dalla salsa i vestiti. L’orchestra suonò ancora The Star-Spangled Banner e tutti cercarono di cantare, ma non fu un grand’effetto, perché nessuno sapeva le parole. In seguito, Doc e Charley entrarono in un bar a prendere un whisky schietto. Doc voleva andare a vedere uno spettacolo di gambe e s’informò dal barista. Un ometto grasso, coi colori americani al risvolto della giacca, lo sentì, e disse che il miglior spettacolo di gambe in tutta New York era quello di Minsky in East Houston Street. Offrì loro qualche bicchiere, quando Doc disse che sarebbero andati a vedere cos’era ’sta guerra, e si offrì di condurli lui stesso da Minsky. Si chiamava Segal e disse che era stato socialista fino all’affondamento del Lusitania, ma che adesso era d’idea che si schiacciassero i tedeschi e si spiantasse Berlino. Si occupava di vestiario e quella sera era felice, perché aveva pressoché concluso un contratto per uniformi militari. «Della guerra abbiamo bisogno, che ci faccia diventare uomini» diceva, e si batteva la mano sul petto. Scesero al centro in tassì, ma, quando giunsero al teatro, era così pieno che non si trovava un posto. «Posti a stare in piedi, accidenti… Voglio donne» diceva Doc. Il
signor Segal pensò un momento con il capo reclinato da una parte. «Andremo al Little Hungary» disse. Charley si sentì smontato. Si era ripromesso di divertirsi a New York. Desiderò di essere a letto. Al Little Hungary c’eran molte ragazze tedesche, ebree e russe. Il vino usciva da certe bottiglie buffe bilanciate in un sostegno al centro di ciascun tavolino. Il signor Segal disse che da quel momento offriva lui. L’orchestra suonava musica straniera. Doc si stava ubriacando mica male. Eran seduti a un tavolo stretto tra gli altri tavoli. Charley girò d’attorno e invitò una ragazza a ballare con lui, ma per qualche ragione quella rifiutò. Attaccò discorso con un giovanotto dalla faccia piccola, al bar, che veniva da un comizio per la pace nel Madison Square Garden. Charley drizzò le orecchie, quando l’altro disse che ci sarebbe stata una rivoluzione a New York se rendevano nel paese la coscrizione obbligatoria. Si chiamava Benny Compton e aveva studiato legge all’università di New York. Charley andò a sederglisi accanto a un tavolino insieme con un altro, del Minnesota, cronisti del «Call». Charley s’informò da loro sulle probabilità di guadagnarsi di che frequentare la scuola meccanica. Aveva quasi deciso di disdire l’inscrizione in sanità. Ma pareva che quelli pensassero che non fosse troppo facile, se uno non aveva denaro in disparte, per cominciare. Quello del Minnesota disse che New York non era luogo per un povero diavolo. «Ostia, va a finire che vado alla guerra» disse Charley. «È dovere di ciascun radicale finire prima in carcere» disse Benny Compton. «Ma in ogni modo ci sarà una rivoluzione. La classe lavoratrice non sopporterà più questo a lungo.» «Se volete raggranellare un po’ di soldi, ecco come fare: andate a Bayonne e mettetevi in una fabbrica di munizioni» disse l’uomo del Minnesota con una voce stracca. «Un uomo che faccia questo è un traditore della sua classe» disse Benny Compton. «Il lavoratore è in un pasticcio tale e quale» disse Charley. «Porco giuda, non voglio già passare tutta la vita a rattoppare vecchie trappole per settantacinque al mese.»
«Non diceva Eugene V. Debs “io voglio elevarmi con le masse non sulle masse”?» «Ma tu, Benny, dopo tutto, non studi giorno e notte per riuscire avvocato e toglierti dalla classe lavoratrice?» disse quello del Minnesota. «Questo lo faccio per essere di qualche utilità nella lotta… Ho bisogno di essere uno strumento ben affilato. Dobbiamo combattere i capitalisti con le loro stesse armi.» «Io mi domando che cosa farò, quando sopprimeranno “The Call”.» «Non oseranno sopprimerlo.» «Lo faranno certo. Siamo entrati in guerra per difendere i prestiti Morgan… Se ne serviranno per far piazza pulita dell’opposizione qui, poco ma sicuro, quant’è vero che mi chiamo Johnson.» «A questo proposito ho certe notizie. Mia sorella è una stenografa… Lavora per J. Ward Moorehouse, la consulenza dei pubblici rapporti, sapete… quello che fa propaganda per Morgan e Rockefeller. Ebbene, mi diceva che tutto quest’anno Moorehouse ha lavorato con una missione segreta francese. I grandi interessi hanno una paura maledetta di una rivoluzione in Francia. Gli han passato diecimila dollari per i suoi servizi. Dirige un movimento per la guerra, attraverso un ufficio di pubblicità.» «E lo chiamano un paese libero.» «Non mi stupirebbe affatto» disse quello del Minnesota, versandosi il fondume della bottiglia. «Qualunque di noi in questo istante potrebbe benissimo essere un agente governativo o una spia.» I tre si guardarono reciprocamente. La cosa fece correre i brividi giù per la schiena di Charley. «È questo che sto cercando di spiegarvi… Mia sorella sa tutto il retroscena, per via che lavora nell’ufficio di costui… È il progetto dei grandi interessi, Morgan e gli altri, sconfiggere i lavoratori mandandoli alla guerra. Una volta che siete nell’esercito, non potete più strillare sulla libertà civile o la Dichiarazione dei diritti… Vi possono fucilare senza processo, capite?» «È una vergogna… Il Nord-ovest non sopporterà una cosa simile»
disse l’uomo del Minnesota. «Sentite, voi siete stato laggiù più di recente di me. La Follette esprime le idee di quella gente no?» «Senza dubbio» disse Charley. «E che diavolo allora?» «Per me è troppo difficile» disse Charley; e si mise ad aprirsi una strada tra i tavolini addossati, in cerca di Doc. Doc era ubriaco bene e Charley temeva che la serata degenerasse in spese, così salutò il signor Segal, che gli disse per favore di uccidere tedeschi in quantità da parte sua, e se n’uscirono dirigendosi a ovest lungo Houston Street. C’eran bancarelle tutto legno lungo il marciapiede, con lumi che facevan rosso lucido, nell’oscurità piovosa, le facce fitte del marciapiede. Uscirono all’estremità di un lungo corso affollato di gente, che traboccava da un teatro. In faccia al caffè Cosmopolitan un individuo parlava ritto su una cassetta da sapone. La gente che usciva dal teatro gli tumultuava intorno. Doc e Charley si aprirono la via a gomitate per vedere cos’era. Non riuscirono che ad afferrare brani di ciò che l’uomo con una rauca voce canina gridava. «Pochi giorni fa ero seduto all’istituto Cooper a sentire Eugene Victor Debs, ecco che cosa diceva.» «Che cos’è questa civiltà, questa democrazia, che i padroni chiedono a voi, lavoratori, di sacrificare la vita per salvare; che cosa significa per voi se non schiavitù; che cos’è…?» «Ohi, state zitto… Se non vi va, non avete che da tornare al vostro paese» scoppiarono voci dalla calca. «Libertà di lavorare, perché i padroni diventino ricchi… Opportunità di morire di fame, se vi licenziano dal posto.» Doc e Charley si sentirono spinti da dietro. Quell’uomo capitombolò dalla cassetta e scomparve. Tutta la bocca del corso s’empì di una folla che si dibatteva. Doc tirò pugni con un omone in tuta. Arrivò tra loro una guardia, che menava a destra e sinistra col bastone. Doc partì per schiaffeggiare la guardia, ma Charley gli prese il braccio e lo tirò via dalla mischia. «Cristo, oh, non siamo mica ancora alla guerra» disse Charley. Doc era rosso in faccia. «Non mi andava la faccia di quel tale» disse.
Dietro alle guardie, due automobili di polizia con grossi riflettori caricavano la folla. Braccia, teste, cappelli, spalle agitate, sfollagente, che s’alzavano e abbassavano, spiccarono nudi sul bianco terribile dei riflettori. Charley trascinò Doc contro la vetrina del caffè. «Dite, Doc, non vorremo finir dentro e perdere il piroscafo» gli sussurrò all’orecchio. «Cosa importa?» disse Doc «andrà tutto a rotoli prima che ci arriviamo noi.» «Oggi i lavoratori scappano davanti alle guardie, ma domani scapperanno le guardie davanti ai lavoratori» urlò qualcuno. Qualcun altro si mise a cantare La marsigliese. Si unirono voci. Doc e Charley si sentirono schiacciati, con le spalle contro il vetro. Dietro a loro, il caffè era pieno di facce natanti nel tortuoso fumo azzurro, come pesci in un acquario. Il vetro d’un tratto s’infranse. Gente nel caffè balzò in piedi. «Attenti ai cosacchi» urlò una voce. Un cordone di guardie si faceva strada giù per il corso. Il selciato vuoto alle loro spalle si allargava. Dall’altra parte, la polizia a cavallo usciva da Houston Street. Nello spazio aperto era fermo un furgone di polizia. Guardie vi cacciavano dentro uomini e donne. Doc e Charley sgambettarono a lato di un agente a cavallo che veniva giù per il marciapiede al trotto con gran fracasso e saettarono via, oltre l’angolo. Il Bowery era vuoto e oscuro. Camminarono a ovest, alla volta dell’albergo. «Accidenti,» disse Charley «quasi ci facevate rinchiudere stavolta… Sono in disposizione per andare in Francia ora e ci voglio andare.» Una settimana dopo erano sul Chicago della French Line, che filava attraverso i Narrows. Avevano ancora il mal di testa del festino d’addio e un po’ di nausea per l’odore del piroscafo e la musica dell’orchestra di jazz del molo rintronava ancora nelle loro orecchie. Il giorno era coperto di una bassa cappa di nubi plumbee: pareva volesse nevicare. I marinai erano francesi e i dispensieri pure. Bevettero vino al primo pasto. C’era tutta una tavolata di altri della sanità, che facevano la traversata. Dopo cena, Doc scese nella cabina per mettersi a letto. Charley
gironzolò per la nave con le mani in tasca, senza sapere cosa fare. A poppa, toglievano il telo di sul cannone da settantacinque. Passeggiò per il sottoponte, pieno di barili e cassette, e inciampò a prua in duglie di grossa gomena pelosa. A prua c’era un marinaretto francese, roseo in faccia, con un fiocco rosso sul berretto, messo per sentinella. Il mare era vitreo, con sudice chiazze ondulanti di alghe e rifiuti. C’erano gabbiani poggiati sull’acqua o appollaiati su schegge di legno galleggiante. Di tanto in tanto un gabbiano stendeva svogliato l’ali e fuggiva strillando. La prora tonda del vapore tagliava in due ondate uguali l’acqua densa, verdebottiglia. Charley cercò di attaccare discorso con la sentinella. Additò innanzi, «Est» disse «Francia». La sentinella non badò. Charley additò indietro nell’Ovest fumoso. «Ovest» disse, e si batté sul petto. «Casa mia a Fargo North Dakota.» Ma la sentinella non fece che scuotere il capo e si portò un dito alle labbra. «Francia lontano a est… sommergibili… guerra» disse Charley. La sentinella gli mise la mano sulla bocca. Finalmente fece comprendere a Charley che non doveva parlargli. 1. Minneapolis e St. Paul. (NdT) 2. Chicago. (NdT) 3. In italiano nel testo. (NdT) 4. In italiano nel testo. (NdT)
Millenovecentodiciannove Traduzione di Glauco Cambon
Cine-giornale XX Oh la fanteria la fanteria con le orecchie piene di porcheria… GLI ESERCITI SI SCONTRANO A VERDUN NELLA PIÙ GRANDE BATTAGLIA DEL MONDO 150.000 UOMINI E DONNE SFILANO ma sorge un’altra questione, e importantissima. La Borsa Valori di New York è oggi l’unico mercato di titoli libero in tutto il mondo. Se manterrà tale posizione, diventerà fors’anche il massimo centro mondiale per lo scambio di LA FLOTTA BRITANNICA INVIATA A ESPUGNARE IL CORNO D’ORO Cavalleria, artiglieria e il genio della malora non batteran la fanteria neanche in anni undicimila. I TURCHI MESSI IN FUGA DAI TOMMIES A GALLIPOLI quando torneranno a casa i nostri veterani, che penseranno mai di quegli americani che vanno cianciando di un vago nuovo ordine, e intanto annaspano nella sabbia di un bassofondo? La nebulosa follia di questa gente evocherà alla mente di chi ha visto e sofferto lo spettacolo da vicino la sconfinata nuova Terra di Nessuno europea, fetida di assassinio e della voluttà di rapina, incendiata dalla rivoluzione I CAMERIERI IN SCIOPERO CHIEDONO L’AIUTO DELLE DONNE Oh, la quercia e il frassino e il salice piangente e come cresce verde l’erba in Nord America… una posizione siffatta comporterà l’afflusso di grandi quantità di denaro dall’estero al fine di mantenere l’equilibrio economico del nostro paese Quando penso al vessillo che portano le nostre navi: la sola nota di colore, la sola cosa che in esse si muova, come se contenesse uno spirito determinato, in tutta la loro solida struttura; mi par di vedere strisce di pergamena con
sopra scritti i diritti della libertà e della giustizia, alternate a strisce di sangue versato per rivendicare questi diritti, e poi, in un angolo, il presagio del cielo azzurro in cui potrà liberamente muoversi esultando ogni nazione che difenda questi valori. Oh, inchioderemo l’Old Glory 1 in cima all’asta e ci arruoleremo ancora tutti, nel c…o della balena! 1. Letteralmente ”Vecchia Gloria”, la bandiera americana. (NdT)
Joe Williams Joe Williams indossò l’abito comprato di seconda mano e gettò la sua divisa, bene avvolta attorno a una pietra del lastrico, dall’orlo della banchina nell’acqua fangosa del bacino. Era mezzodì. Non c’era intorno anima viva. Provò un senso di disagio quando si accorse di non avere la sua scatola da sigari. Tornò al magazzino e la trovò là dove l’aveva dimenticata. Era una scatola che una volta aveva contenuto sigari Flor de Mayo, comperati a Guantánamo durante una celebre sbornia. Nella scatola, sotto la carta dorata merlettata, c’era la foto di Janey, fatta in occasione della licenza liceale, un’istantanea di Alec in motocicletta, una foto con la firma dell’allenatore e di tutti i giocatori della squadra juniores della scuola media superiore, tutti in tenuta da baseball: il capitano era lui; una vecchia istantanea rosa molto sbiadita del rimorchiatore di papà, il Mary B. Sullivan, presa al largo dei Virginia Capes con un grande veliero a rimorchio, la fotocartolina senza montatura di una certa Antoinette, ricordo di Villefranche, qualche lametta, una fotocartolina di lui e altri due marinai in divisa bianca, presa sullo sfondo di un arco moresco a Malaga, un po’ di francobolli esteri, un pacchetto di Merry Widows, e dieci conchigliette rosa e rosse raccolte sulla spiaggia di Santiago. Con la scatola ben salda sotto il braccio, sentendosi tutto rattrappito negli abbondanti panni borghesi, s’incamminò lentamente verso il faro e stette ad osservare la flotta che discendeva in formazione il Rio della Plata. Il cielo era coperto; gli snelli incrociatori svanirono presto nella scia delle loro fumate. Joe smise di guardarli per osservare un cargo rugginoso in arrivo. Aveva un forte sbandamento a tribordo, e sotto la linea d’immersione se ne poteva vedere la chiglia verde e viscosa d’alghe. A poppa c’era una bandiera greca bianca e blu, e una sporca bandiera gialla da quarantena a mezz’asta sull’albero di trinchetto. Improvvisamente qualcuno rivolse la parola a Joe in spagnolo, alle sue spalle. Era un tipo rubicondo e sorridente in cotonina azzurra e fumava un sigaro, ma per qualche motivo imprecisato provocò in Joe un senso di panico. «Non so niente» disse Joe, e si allontanò passando
fra i magazzini e dirigendosi a vie più lontane dalla riva. Gli ci volle del bello e del buono per trovare il posto dove stava Maria, tutti i caseggiati si rassomigliavano maledettamente. Lo riconobbe dal violino meccanico alla finestra. Una volta entrato nel soffocante locale impregnato di odor d’anice, se ne stette per un pezzo al banco con una mano attorno a un attaccaticcio boccale di birra, a guardare la strada che si poteva scorgere a strisce luminose attraverso lo schermo di palline della porta. Si aspettava di veder passare da un momento all’altro la macchia bianca di un marinaio in divisa con tanto di cinturone giallo. Dietro il banco, un giovane giallo dal naso adunco si appoggiava alla parete guardando un punto inesistente. Quando Joe si decise, alzò il mento di scatto. Il giovane si avvicinò e allungò confidenzialmente il collo oltre il banco, appoggiandosi a una mano e servendosi dell’altra per fregare con uno straccio la tela cerata. Le mosche che stavano raggruppate sugli anelli lasciati sulla tela cerata dai bicchieri di birra sciamarono verso la massa ronzante di consorelle sul soffitto. «Ehi, giovanotto, di’ a Maria che voglio vederla» disse Joe parlando dall’angolo della bocca. Il giovane dietro il banco alzò due dita. «Dos pesos» disse. «No perdio, devo solo parlarle e basta.» Maria si affacciò alla porta della retrobottega e gli fece un cenno. Era una donna giallastra dagli occhi grandi e lontani l’uno dall’altro, ficcati in borse bluastre. Sotto lo spiegazzato vestito rosa che le aderiva ai seni gonfi, Joe scorgeva gli anelli di carne increspata attorno ai capezzoli. Si misero a sedere a un tavolo nella saletta interna. «Due birre» gridò Joe attraverso la porta. «Embè, che cosa vuoi, hijo de mi alma?» domandò Maria. «Conosci Doc Sidner?» «Ma certo, io conoscerli tutti, gli yanki. Ma che cosa vuoi tu, che non partire con grande nave?» chiese Maria. «Non partire con grande nave… Fare a botte con gran figlio di puttana, ecco!» «Cì!» Quando Maria rideva, le mammelle le tremolavano come gelatina. Gli pose la mano grassoccia sulla nuca e avvicinò il volto di lui al proprio. «Povero bimbo… occhio nero.» «Certo che mi ha fatto un occhio nero.» Joe si scostò da lei. «Un maresciallo. L’ho ammazzato di botte, vedi… Così adesso la marina militare non è più un ambiente
raccomandabile per me… me la sono squagliata. Senti, Doc mi ha detto che tu conosci un tizio che sa falsificare i certificati “A.B.” 1 … marinaio scelto, sai? D’ora in poi mi do alla marina mercantile, Maria.» Joe tracannò la sua birra. Lei, sempre seduta, si mise a scuotere la testa dicendo: «Cì… pobrecito… Cì». Poi con voce lacrimosa: «Quanti dollari hai?». «Venti» rispose Joe. «Quello là volerne cinquanta.» «Allora, se non mi sbaglio, sono proprio fottuto.» Maria gli girò dietro la spalliera della seggiola e gli mise attorno al collo il braccio grassoccio, chinandosi su di lui ed emettendo piccoli versi chioccianti. «Aspetta un po’, che penziamo… sabes?» La voluminosa mammella premuta contro il collo e la spalla lo stuzzicava irritandolo; non gli piaceva essere toccato da lei a quel modo di mattina quando non ne aveva bevuto neanche un goccio. Ma rimase ugualmente a sedere finché lei non squittì d’improvviso come un pappagallo: «Paquito, ven acá». Dalla retrobottega entrò un uomo sporco dalla sagoma a pera, rosso in viso e nel collo. Parlò spagnolo con lei lì alle spalle di Joe. Finalmente lei diede dei colpetti affettuosi alla guancia di Joe dicendo: «Benissimo, Paquito sabe dove abitare quello là… chissà, forse accettare venti, sabes?». Joe si alzò. Paquito si tolse il sozzo grembiule da cuoco e accese una sigaretta. «Tu conosci i certificati di marinaio scelto?» disse Joe dirigendosi alla sua volta e guardandolo in faccia. L’altro fece un cenno affermativo. «Benissimo.» Joe abbracciò Maria dandole un pizzicotto. «Sei una buona ragazza, Maria.» Lei lo seguì con un ghigno benevolo fino alla porta del bar. Appena fuori, Joe scrutò attentamente la strada in lungo e in largo. Nessuna divisa in vista. All’estremità della via una gru si ergeva nera sopra i magazzini di cemento. Salirono in un tram e per un po’ non dissero una parola. Joe se ne stava lì seduto a guardare per terra, con le mani penzolanti tra i ginocchi, finché Paquito non gli diede una gomitata di avvertimento. Scesero in un quartiere suburbano popolare, tutto di case di cemento nuove e già sporche. Paquito sonò il campanello a una porta uguale a tutte le altre porte, e dopo un po’
venne ad aprire un uomo dagli occhi cerchiati di rosso e dai denti grossi di cavallo. Costui e Paquito parlarono a lungo in spagnolo sull’uscio semiaperto. Joe si appoggiò prima su una gamba e poi sull’altra. Dalla maniera in cui lo sbirciavano con la coda dell’occhio mentre parlavano egli arguì che stavano valutando a occhio e croce il limite delle sue possibilità di pagamento. Era proprio sul punto d’intervenire quando l’uomo sull’uscio gli rivolse la parola in cockney stretto. 2 «Tu dai a questo fesso cinque pesos per il disturbo, amico mio, e poi ce la vediamo fra noi due.» Joe sborsò tutti gli spiccioli che aveva in tasca e Paquito se ne andò. Joe seguì l’inglese nell’anticamera, che puzzava di cavoli, grasso fritto, e bucato. Appena entrato, l’altro posò la mano sulla spalla a Joe e disse, alitandogli in faccia odor di whisky mezzo digerito: «E allora, amico mio, quanto puoi spendere?». Joe si scostò. «Venti dollari americani, è tutto quello che ho» disse tra i denti. L’inglese scosse il capo. «Soltanto quattro sterlinozze… be’, vuol dire che non c’è nulla di male se vediamo un po’ di arrangiarci, vero, amico? Vediamo un po’.» Mentre l’inglese stava lì a guardarlo, Joe si tolse la cintura, tagliò un paio di cuciture con la lama piccola del suo coltello a serramanico e ne trasse due banconote americane color arancione nel verso, piegate per il lungo. Le aprì attentamente, e stava per consegnarle quando ci ripensò e se le mise in tasca. «Prima diamo un’occhiata al documento» disse con una smorfia. Gli occhi cerchiati di rosso dell’inglese si fecero lagrimosi; disse che bisognava aiutarsi l’un l’altro e aver riconoscenza quando uno si azzardava a fare il falsario per aiutare i suoi simili e fratelli in Dio. Poi domandò a Joe nome, età e luogo di nascita, e quanti anni di servizio aveva fatto in mare e compagnia bella, e se ne andò in una stanza interna, chiudendosi alle spalle la porta con la massima cura. Joe rimase in anticamera. C’era un orologio che ticchettava, in qualche punto. Il ticchettio si trascinava sempre più lento. Finalmente Joe sentì la chiave girare nella toppa, e l’inglese comparve con due documenti in mano. «Dovresti renderti conto di quello che faccio per te, amico…» Joe prese la carta. Corrugò la fronte e la studiò
attentamente; e gli parve perfetta. L’altra era una nota che autorizzava l’agenzia marittima Titterton a fare trattenute mensili sulla paga di Joe fino a quando non fosse stata raggiunta la somma di dieci sterline. «Però guarda un po’ qui,» disse lui «sono settanta dollari che sgancio.» L’inglese disse di pensare un po’ al rischio che correva lui, e che i tempi erano duri, e dopo tutto non c’era che prendere o lasciare. Joe lo seguì nella stanza interna tutta cosparsa di carte, si chinò sullo scrittoio e firmò con una stilo. S’inoltrarono in città con un’auto di piazza e scesero in Rivadavia Street. Joe seguì l’inglese in un piccolo ufficio nel retro di un magazzino. «Ecco qui un ragazzo in gamba per voi, Mr. McGregor» disse l’inglese a uno scozzese dall’aria biliosa che camminava su e giù masticandosi le unghie. Joe e McGregor si guardarono in faccia. «Americano?» «Sì.» «Non ti aspetterai per caso una paga come quelle americane, vero?» L’inglese gli si accostò per bisbigliargli qualcosa; McGregor diede un’occhiata al certificato e parve soddisfatto. «Benissimo, firma sul registro… Firma sotto l’ultimo nome.» Joe firmò e porse all’inglese i venti dollari. Così rimaneva al verde. «Be’, addio, amico.» Joe esitò un po’ prima di prendere la mano dell’inglese. «Tanti saluti» disse. «Va’ a prendere il tuo bottino e torna qui tra un’ora» disse McGregor con voce rauca. «Non ho bottino. Vengo da riva» disse Joe, soppesando la scatola da sigari. «Allora aspetta di fuori, e tra un po’ ti porterò a bordo dell’Argyle.» Joe rimase per un po’ sulla porta del magazzino a guardare in strada. Diavolo, ne aveva abbastanza di Buenos Aires. Sedette sopra una cassa da imballaggio segnata “Tibbett & Tibbett, Merce smaltata, Blackpool”, in attesa di Mr. McGregor, chiedendosi se egli fosse il capitano o il secondo. Ormai non c’era che lasciar passare il tempo, fino alla partenza da Buenos Aires. 1. Abbreviazione di able-bodied seaman, “marinaio abile”. (NdT) 2. Cockney: aggettivo che designa il popolano londinese e il suo aspro dialetto tutto a scatti. (NdT)
Occhio fotografico (28) quando arrivò il telegramma con la notizia che lei era moribonda (le ruote dei tram stridevano attorno alla campana di vetro come tutti i gessi assieme su tutte le lavagne in tutte le scuole del mondo) camminando per Fresh Pond odore di pozzanghere gemme di salice nel vento pungente urlanti ruote di tram incessante strepito sfrenato autocarri per i sobborghi di Boston Il dolore non è una divisa e va’ a buttar per aria il Booch e beviti vino a cena al Lenox prima di prendere il treno Sono tanto sazio di viole portale tutte via quando arrivò il telegramma con la notizia che lei era moribonda la campana di vetro strepitò da rompersi in uno stridio di gessi da lavagna (Avete mai provato a non poter dormire per una settimana di fila in aprile?) e Lui mi venne incontro sotto la grigia tettoia della stazione i miei occhi erano assaliti dai pungenti inchiostri vermigli bronzei e verdecromo che trasudavano dalle laboriose colline d’aprile I suoi baffi erano bianchi cose stanche che pendevano dalle guance di un vecchio È morta Jack Il dolore non è una divisa e il nel salotto il cereo odore dei gigli nel salotto (Lui e io bisogna che seppelliamo la divisa del dolore) poi l’odore del fiume Potomac barbagliante raggiunge le piccole onde marezzate d’argento a Indian Head c’erano tordi imitatori 1 nel cimitero e i margini delle strade vaporavano primavera tanto aprile da scuotere il mondo quando arrivò il cablogramma con la notizia che Lui era morto me ne andai per le vie piene di atmosfera pomeridiana Madrid fervida di crepuscolo in cubi frantumati di aguardiente vino rosso verde di acetilene rosa di tramonto ocra di tegole labbra guance rosse bruno colonna della gola salii sul treno notturno alla stazione Norte senza sapere perché Son così sazio di viole portale tutte via l’iridescente campana di vetro infranta i busti accuratamente copiati i particolari architettonici la grammatica degli stili
era la fine di quel libro e lasciai i poeti dell’antologia di Oxford nella rumorosa stanzetta che sentiva di olio di oliva rancido nella pensione Boston Ahora adesso maintenant Vita Nuova ma noi che avevamo udito la bella dizione di Copey e letto i libri ben rilegati e respirato profondamente (respira profondamente uno due tre quattro) i gigli di cera e il profumo artificiale di viole sotto la calotta d’etere e fatto colazione nella biblioteca dove c’era il busto di Ottavio adesso eravamo morti all’ufficio telegrafico sul sedile di legno sobbalzarombante nel treno che sfondava la mezzanotte salire in coperta dalla terza classe per respirare una boccata di Atlantico sul piroscafo proteso nella sua corsa (la ragazza svizzera dal volto ovale e suo marito erano miei amici) lei aveva gli occhi un po’ sporgenti e un modo lievemente brusco di dire Zut alors e di lanciarci un sorrisetto quasi un pesce a un leone di mare qualcosa che dava calore alla nostra tenebra quando venne l’ufficiale addetto all’immigrazione a chiederle il passaporto non poté mandarla ad Ellis Island la grippe espagnole era morta lavare quelle finestre Di servizio alle cucine pulire col coltellino candele di motori Assente senza permesso polverizzare le rose American Beauty in quel letto di puttana (la notte nebbiosa fiammeggiava dei proclami della Lega per i diritti dell’uomo) l’odor di mandorla degli alti esplosivi costellava di cantanti barbagli la vomitevole magniloquenza dolciastra dei morti in putrefazione l’indomani speravo che fosse il primo giorno del primo mese del primo anno 1. Uccelli americani della famiglia dei tordi, genere Mimus, così detti perché imitano il verso di altri uccelli. Nella traduzione va perduto l’intenso valore della parola mocking-bird, dove il verbo to mock suona anche “motteggiare”, “schernire”, in relazione a “cimitero”. (NdT)
Giocherellone Jack Reed era figlio di un commissario distrettuale americano, cittadino eminente di Portland, Oregon. Era un ragazzo promettente così i suoi lo mandarono a scuola a est e a Harvard. Harvard raccomandava la a larga e quei contatti tanto utili nella vita e la buona prosa inglese… se a Harvard non c’è niente da fare per gli istrici, vuol dire che a Harvard non c’è niente da fare per gli istrici assolutamente e i Lowell soltanto parlano ai Caboto e i Caboto e l’Antologia lirica di Oxford. Reed era un giovanotto di belle speranze, non era ebreo né socialista e non veniva da Roxbury; era robusto, avido, tutto gli faceva gola: un vero uomo deve amare tante cose nella vita. Reed era un vero uomo; gli piacevano gli uomini gli piacevano le donne gli piaceva mangiare e scrivere e le notti di nebbia e bere e le notti di nebbia e il nuoto e il calcio e le poesie con la rima e fare il capogruppo primeggiare come oratore forbito formare clubs (non proprio i migliori, aveva troppo sangue nelle vene per sentirsi a suo agio nei clubs di alta etichetta) e la voce di Copey mentre leggeva L’uomo che voleva essere re, l’autunno morente, Urn Burial, la buona prosa inglese, le lampade che si accendevano nel gran cortile sotto gli olmi nel crepuscolo, voci fioche nelle aule universitarie, l’autunno morente gli olmi il Discobolo i mattoni dei vecchi edifici e i portali commemorativi e le fraschette e i decani e gli istruttori che gridavano tutti con voci sottili continenza!, continenza!; il rugginoso ingranaggio cigolò, i decani tremarono sotto le loro berrette quadre, le ruote dentate girarono e venne il giorno della laurea, e Reed si trovò sbalzato nel vasto mondo: Washington Square! La parola “convenzionale” finisce per equivalere a un’imprecazione;
Villon che si cerca un alloggio per la notte nelle case italiane di Sullivan Street, Bleecker, Carmine; le ricerche fatte dimostrano che R.L.S. (R.L. Stevenson) fu un gran vanitoso, e in quanto agli elisabettiani, il diavolo se li porti. Imbarcarsi sopra un trasporto bestiame e vedere il mondo avere avventure da ricamarci sopra storie gustose ogni sera; un uomo deve amare… il polso accelerato la sensazione che oggi nelle sere di nebbia passi tassì occhi di donne… tante cose nella vita. L’Europa con un pizzico di kren, 1 inghiottire Parigi come un’ostrica; ma c’è qualcosa di più che l’Antologia inglese di Oxford, Linc Steffens parlava di Stato cooperativo, la rivoluzione in una voce saporosa e carezzevole come quella di Copey Diogene-Steffens con Marx per lanterna perlustrava l’Occidente in cerca di un uomo autentico, Socrate-Steffens continuava a porre il quesito: perché non rivoluzione? Jack Reed avrebbe voluto vivere in un guscio e scrivere versi; ma s’imbatteva ogni momento in vagabondi lavoratori tipi in gamba che gli piacevano, senza lavoro, senza fortuna, perché non rivoluzione? Non gli riusciva di concentrare l’attenzione sul suo lavoro con tanta gente sfortunata che c’era in giro; a scuola non aveva imparato a memoria la Dichiarazione di indipendenza? Reed era un americano dell’Ovest e le parole avevano un significato preciso per lui; quando diceva qualcosa con un compagno di studi al bar dello Harvard Club, era sincero e preciso dalla punta dei piedi alla punta di quei suoi arruffati capelli (aveva troppo sangue nelle vene per lo Harvard Club e il Dutch Club e la rispettabile bohème dilettante di New York). Vita, libertà, e ricerca della felicità; di questa roba non ce n’era gran che nelle filande quando, nel 1913, lui andò a Paterson a fare un articolo sullo sciopero, operai tessili
dimostranti presi a botte dai poliziotti, gli scioperanti in prigione; senza nemmeno rendersene conto fu anche lui uno scioperante e un dimostrante picchiato dai poliziotti in prigione; non voleva assolutamente farsi mettere alla porta dal suo direttore, voleva sapere dell’altro dagli scioperanti in prigione. Ne seppe abbastanza da presentare la sfilata dello sciopero di Paterson in Madison Square Garden. Imparò la speranza di una nuova società in cui nessuno più fosse disgraziato, perché non rivoluzione? Il «Metropolitan Magazine» lo inviò al Messico a fare articoli su Pancho Villa. Pancho Villa gli insegnò a scrivere e le montagne scheletriche e l’alto cactus a canna d’organo e i treni corazzati e le bande che sonavano in piazzette piene di ragazze dalla carnagione scura cinte di sciarpe azzurre e la polvere insanguinata e il crepitio delle fucilate nella notte enorme del deserto, e i bruni peones dalla calma voce morenti d’arma di fame intenti a uccidere per la libertà per la terra per l’acqua per le scuole. Il Messico gli insegnò a scrivere. Reed era un americano dell’Ovest e le parole avevano per lui un significato preciso. La guerra fu una raffica che spense di colpo tutte le lanterne di Diogene; gli uomini buoni presero a imbrancarsi, a chiedere mitragliatrici. Jack Reed fu l’ultimo di quella grande stirpe di corrispondenti di guerra che eludeva la censura e rischiava la pelle per un servizio. Jack Reed fu il miglior scrittore americano del suo tempo, se uno avesse voluto sapere qualcosa sulla guerra non avrebbe avuto altro da fare che leggere i suoi articoli sul fronte tedesco, sulla ritirata serba, Salonicco; dietro le linee nel vacillante impero degli zar,
eludendo la polizia segreta, in carcere a Cholm. I pezzi grossi dell’esercito non vollero lasciarlo andare in Francia perché si diceva che una notte, scherzando nelle trincee germaniche con gli artiglieri tedeschi, egli avesse tirato la cordicella di un cannone unno puntato sul cuore della Francia… una vera ragazzata, ma dopo tutto importava davvero chi fosse a far fuoco coi cannoni o da che parte essi fossero puntati? Reed era coi ragazzi che venivano fatti a pezzi in quell’inferno, coi tedeschi i francesi i russi i bulgari i sette piccoli sarti del ghetto di Salonicco, e nel 1917 era coi soldati e i contadini a Pietrogrado in ottobre: Smolny. Dieci Giorni che Scossero il Mondo; non più Villa Messico pittoresco, non più ragazzate da Harvard Club, progetti di teatri alla greca, versi rimati, buoni articoli da corrispondente di guerra vecchio stile, adesso non c’era più nulla di divertente; adesso era tutto atroce. Delegato di ritorno agli Stati Uniti, accuse, il processo Masses, il processo Wobbly, Wilson che riempiva le prigioni, passaporti falsi, discorsi, documenti segreti, passare di soppiatto attraverso il cordone sanitario, nascondersi nelle carboniere dei piroscafi; lo misero in prigione in Finlandia e gli sottrassero tutte le sue carte, nessuna opportunità di scrivere versi adesso, non più belle chiacchierate a cuore aperto col primo che s’incontrava, l’ex universitario dal sorriso simpatico che con la sua loquela convinceva il giudice e si traeva d’impiccio; allo Harvard Club son passati tutti nell’Intelligence Service e contribuiscono ad accaparrare il mondo al gruppo bancario MorganBaker-Stillman;
quel vecchio vagabondo che sorbisce il caffè in una scatola di conserva vuota è una spia dello stato maggiore. Il mondo non è più una cosa divertente, soltanto mitraglia e incendi fame pidocchi cimici colera tifo niente filaccia per bendaggi niente cloroformio o etere migliaia di morti da ferite incancrenite, cordone sanitario e dappertutto spie. Le finestre dello Smolny ardono incandescenti come un altoforno, niente sonno allo Smolny, Smolny la gigantesca lamineria che funziona ventiquattro ore al giorno e vomita uomini nazioni speranze millenni impulsi paure, materia prima per le fondamenta di una società nuova. Un uomo deve far tante cose nella vita. Reed era un americano dell’Ovest le parole avevano per lui un significato preciso. Egli gettò se stesso e tutto quello che aveva nella fornace dello Smolny, dittatura del proletariato; URSS La prima repubblica di lavoratori era costituita e si regge tuttora. Reed scrisse, intraprese missioni, c’erano spie dappertutto, lavorò sino all’esaurimento, prese il tifo e morì a Mosca. 1. Radicchio dalle radici piccanti, usato come droga; in inglese horseradish. (NdT)
Joe Williams Venticinque giorni di viaggio sul piroscafo Argyle (Glasgow, capitano Thompson), carico di pelli, passati a scrostare la fuliggine, a spalmare di piombo rosso piastre d’acciaio che eran tante griglie roventi al sole, a verniciare il fumaiolo dall’alba al tramonto, beccheggiando e rollando nel sudicio mare grosso; cimici nelle cuccette del puzzolente castello di prua, un’infame brodaglia come rancio, con patate piene di occhi e fagioli muffi, scarafaggi schiacciati sulla mensa, ma un tantino di limonina al giorno in conformità ai regolamenti; poi pioggia e caldo soffocante e Trinidad azzurreggiante fra la nebbia sull’acqua rossastra. Al passaggio del Boca si mise a piovere e le isole nascoste sotto cumuli di fogliame smeraldino di felci ingrigiarono sotto l’acquazzone. Quando la nave attraccò alla banchina a Port of Spain, tutti erano zuppi di pioggia e sudore fino alle ossa. Mr. McGregor, che camminava su e giù con indosso un sudovest, imporporato in viso, aveva perso la voce per il gran caldo e doveva contentarsi di sibilare gli ordini. Poi la cortina di pioggia si riaprì, comparve il sole e ogni cosa vaporava. A parte l’afa, eran tutti ingrugnati, perché correva la voce che si dovesse andare al Pitch Lake a caricare asfalto. Il giorno dopo non accadde nulla di nuovo. Le pelli della stiva di proravia esalarono un gran puzzo quando s’aprirono i boccaporti. Abiti e coperte, appesi ad asciugare sotto lo sguardo torrido del sole tra un acquazzone e l’altro, s’infradiciavano daccapo prima che li si potesse ritirare. Quando pioveva non c’era dove ripararsi; il telone sopracoperta sgocciolava a non finire. Nel pomeriggio Joe fu di franchigia, ma non c’era poi molto sugo a scendere in città, dato che nessuno aveva avuto un’ombra di paga. Joe si mise a sedere sotto una palma su una panchina in una specie di parco presso la rasciuga, con lo sguardo fisso sui piedi. Cominciò a piovere, e lui cercò riparo sotto un telone davanti a un bar. Nel bar c’erano ventilatori; dalla porta aperta fiatò un fresco di limoni e rum e whisky, di bibite al ghiaccio. Joe aveva voglia di birra, ma non aveva il becco d’un quattrino. La pioggia era appesa come uno schermo di
palline all’orlo del telone. Accanto a lui c’era un uomo dall’aria giovanile che indossava un abito bianco e una paglietta, e aveva tutta l’aria di essere americano. Lanciò a Joe diverse occhiate, finché ne incontrò lo sguardo e sorrise: «Siete am-m-mericano?». Balbettava un po’. «Sì» rispose Joe. Una pausa. Poi l’uomo porse la mano: «Benvenuto nella nostra città». Joe notò che era un po’ emozionato. Quando gli strinse la mano, sentì che l’altro lasciava la mano molle. A Joe quel modo di stringere la mano non garbò affatto. «Abitate qui?» gli domandò. L’altro rise. Aveva occhi azzurri e la faccia tonda e amichevole, con le labbra sporgenti alla birichina. «No, se Dio vuole!… Mi trovo qui solo per un paio di giorni, in crociera per le Indie Occidentali. Avrei f-f-fatto molto meglio a risparmiare il mio d-d-denaro e starmene a casa. Volevo andare in Europa ma non si p-p-può per via della guerra.» «Ma sì, non si fa che parlare di questo, della guerra, su quella dannata limoniera». 1 «Perché poi ci abbiano ficcati in questo buco non riesco a capirlo, e adesso la nave ha un guasto, e ci vorranno due giorni buoni prima che si possa partire.» «Dev’essere il Monterey.» «Proprio lui. È una nave impossibile, solo donne a bordo. Mi fa tanto piacere d’incontrare uno come voi, un tipo col quale si possono fare quattro chiacchiere. Qua pare che non ci siano altro che negri.» «Veramente a Trinidad ce n’è di tutti i colori, a quanto sembra.» «Sentite un po’, questa pioggia ha l’aria di andare avanti per un pezzo. Entrate a bere qualcosa con me.» Joe lo guardò sospettosamente. «Va bene» disse poi «ma è meglio vi dica sin d’ora che non posso ricambiare, da parte mia… Sono al verde e quei maledetti scozzesi non ci anticipano niente sulla paga.» «Siete un marinaio, vero?» domandò l’altro quando furono dentro. «Lavoro a bordo di una nave, se è questo che volete dire.» «Che cosa preferite?… Qui fanno bene il punch alla Planter. Mai assaggiato?» «Prendo una birra… Di solito bevo birra.» Il barista era un cinese dalla faccia larga col sorriso alla crepacuore, come quello di una scimmia molto vecchia. Servì le bibite con molta delicatezza, come per paura di rompere i bicchieri. La birra era fredda e gustosa nel suo
bicchiere gocciolante. Joe la tracannò d’un fiato. «Sentite un po’, sapete niente della classifica di baseball? L’ultima volta che ho avuto un giornale fra le mani pareva che la squadra dei Senators avesse buone probabilità di vincere il campionato.» L’altro si tolse la paglietta e si passò un fazzoletto sulla fronte. Aveva capelli neri e ricciuti. Continuava a guardare Joe come se dovesse decidere qualcosa tra sé e sé. Poi finalmente disse: «A proposito, io mi chiamo… Wa-Wa-Wa-… Warner Jones». «Sull’Argyle mi chiamano Yank… In marina mi chiamavano Slim.» «Ah, eravate nella marina da guerra, allora? Volevo ben dire che non avevi tanto l’aria da marina mercantile, Slim.» «Davvero?» L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones ordinò una replica delle rispettive bibite. Joe era sulle spine. Ma diavolo, non ti possono certo arrestare come disertore su suolo britannico. «Dunque, non hai detto che sapevi qualcosa sulla classifica del baseball? Oramai le squadre devono essere piuttosto avanti col campionato.» «Ho i giornali su all’albergo… ti piacerebbe dargli una scorsa?» «Ma certo.» La pioggia cessò. La strada era già asciutta quando uscirono dal bar. «Senti un po’, io ho voglia di fare un giretto dell’isola in macchina. Mi han detto che c’è da veder scimmie allo stato selvaggio e un sacco di roba interessante. Perché non vieni con me? Ormai sono stufo di girare da solo.» Joe ci pensò un minuto. «Questo vestito non è il più indicato…» «Diavolo, ma qui non siamo nella Quinta Avenue! Forza, vieni.» L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones fermò una Ford ben lucidata, guidata da un giovane cinese. Il cinese aveva gli occhiali e un abito blu scuro, e pareva uno studente universitario; parlava con accento inglese. Disse che li avrebbe portati in giro per la città e poi al Laghetto Azzurro. Stavano già per partire quando l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones disse: «Aspettate un minuto», corse nel bar e prese una fiaschetta di Planter’s Punch. Parlò senza tirare il fiato per tutto il tempo che ci misero a uscir di
città passando davanti ai villini inglesi e agli edifici pubblici in mattone, e dopo in aperta campagna sulla strada maestra, attraverso cespuglieti, boschi azzurri così densi e fumanti che a Joe pareva di aver sulla testa un tetto di vetro. Disse come gli piacevano le avventure e i viaggi, e sognava di potersi imbarcare come diceva lui e andare un po’ dappertutto e vedere il mondo, e che doveva essere meraviglioso vivere solo dei propri muscoli e del proprio sudore, come faceva Joe. Joe disse: «Come?». Ma l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones non gli badò e proseguì come se nulla fosse e disse che responsabilità aveva, prendersi cura della mamma, roba da impazzire alle volte, e aveva dovuto andare da un dottore, e il dottore gli aveva consigliato di fare un viaggio, ma il vitto non era buono a bordo e gli procurava indigestioni, e la nave era piena zeppa di vecchie con figlie da maritare a tutti i costi, e a lui dava ai nervi vedersi correre appresso le donne a quel modo. Il peggio poi era di non avere un amico con cui scambiare quattro parole e confidarsi quando si sentiva solo. Gli sarebbe piaciuto tanto di avere per amico un ragazzo simpatico di bell’aspetto, che avesse visto un po’ di mondo e non fosse un rammollito e conoscesse la vita e sapesse apprezzare la bellezza, un tipo come Joe insomma. La mamma era tremendamente gelosa e gli proibiva di avere amici intimi, e quando veniva a sapere che ne aveva qualcuno si ammalava o tentava di tagliargli i rifornimenti, perché lo voleva sempre attaccato alle sue gonnelle, ma lui ne aveva fin sopra i capelli e d’ora in poi avrebbe fatto ciò che gli pareva e piaceva, e in ogni modo non era costretto a farle sapere tutto quello che faceva. Continuava ad offrire sigarette a Joe e al cinese, il quale ogni volta diceva immancabilmente: «Grazie tante, signore. Io ho desistito dal fumare». 2 Avevano visto il fondo della fiaschetta di punch, e l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones cominciava a stringersi a Joe sul sedile, quando il cinese fermò la vettura al termine di un sentiero e disse: «Se volete vedere il Laghetto Azzurro dovete camminare in quella direzione per quasi sette minuti, signore. È la principale attrazione dell’isola di Trinidad». Joe balzò dall’auto e andò a orinare accanto a un grosso albero
dalla corteccia rossa e pelosa. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones gli venne vicino. «Due menti e un solo pensiero» disse. Joe disse: «Eh?» e andò a domandare al cinese dove si potevano vedere delle scimmie. «Il Laghetto Azzurro» disse il cinese «è uno dei loro punti di ritrovo favoriti.» Scese dall’auto e le girò attorno appuntando con attenzione nel fogliame, in alto, le nere capocchie di spillo che aveva per occhi. D’un tratto indicò un punto. Dietro una massa tremante di foglie c’era qualcosa di nero. Ne sortì una risatina stridente, e tre scimmie balzarono volando di ramo in ramo a salti lunghi e bilanciati. In un attimo si dileguarono, e non si vide più altro che i rami agitantisi a intervalli per i boschi là dov’esse saltavano. Joe era eccitato. Non gli era mai capitato di vedere scimmie in libertà a quel modo. Si avviò per il sentiero, a passo così rapido che l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones doveva sudare sette camicie per stargli accanto. Joe voleva vedere altre scimmie. Dopo qualche minuto di salita cominciò a sentire il rumore di una cascata. Qualcosa gli rammentò le Grandi Cascate e Rock Creek, e dentro s’intenerì tutto. C’era un bacino sotto una cascata, circonchiuso da alberi giganti. «Sa il Cielo se ho voglia di fare un bagnetto» disse. «Ma non ci saranno serpenti, Slim?» «I serpenti non ti molestano, se non sei tu il primo a molestarli.» Ma quando furono sull’orlo del laghetto videro che c’era gente a far merenda sul prato, ragazze in abiti leggeri rosa e blu, due o tre uomini in pantaloni bianchi, tutti riuniti sotto ombrelloni a strisce. Li servivano due camerieri indù, portando piatti da una capannetta di vimini. Dall’altra riva giungeva un cinguettio di voci inglesi colte e raffinate. «Perbacco, qui non si può fare neanche una nuotatina, e non ci sono scimmie da vedere.» «E che ne diresti se ci unissimo al gruppo?… Io potrei presentarmi, e tu saresti mio fratello minore. Ho una lettera per un colonnello Tizio, ma non mi son sentito di portargliela.» «Ma perché diavolo debbono venire a rompere le scatole da queste parti?» disse Joe, riavviandosi per il sentiero donde era venuto. Non
vide più scimmie, e quando fu tornato all’automobile era già cominciata a cadere la pioggia a grossi goccioloni. «Così il loro maledetto picnic finirà male» disse ghignando all’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones quando quest’ultimo lo raggiunse, la faccia scorsa da rivoli di sudore. «Dio mio, che camminatore sei, Slim.» Sbuffò e gli diede colpetti affettuosi sulla schiena. Joe salì sulla macchina. «Se non mi sbaglio stiamo per prendercela tutta.» «Signori» disse il cinese «io torno in città perché mi accorgo che un acquazzone è imminente.» Non avevano fatto mezzo miglio di strada che la pioggia era divenuta così fitta da togliere al cinese la visuale; e costui dovette fermare la macchina in una piccola rimessa a lato della strada. La pioggia martellando sul tetto di lamiera rumoreggiava sonora come un piroscafo che molla vapore. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones attaccò a parlare; doveva strillare per vincere il rumore della pioggia. «Chissà quante ne hai viste, Slim, con quella vita movimentata che fai.» Joe scese di macchina e affrontò l’improvvisa cortina di pioggia; la spruzzata in pieno viso gli parve quasi fresca. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones gli si accostò porgendogli una sigaretta. «Ti piaceva la vita di marina militare?» Joe prese la sigaretta, l’accese e disse: «Non tanto». «Ho avuto un sacco di amici tra i ragazzi della marina… Scommetto che ti piaceva far baldoria quand’eri in permesso, non è vero?» Joe disse che di solito non aveva tanti soldi di paga da poter fare baldoria, qualche volta giocava a pallone, quella sì era una cosa che andava. «Ma, Slim, da quel che sapevo i marinai non badano tanto a quel che fanno quando sbarcano in un porto.» «Ci son senz’altro di quelli che si danno da fare per combinare un po’ di gazzarra, ma di solito non hanno abbastanza quattrini da andar molto lontano.» «Io e te forse potremo fare un po’ di bordello a Port of Spain, Slim.» Joe scosse il capo. «No, devo tornare a bordo.» La pioggia aumentò sino a far rombare la lamiera a un punto tale che Joe non capiva più che cosa stesse dicendo l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones, poi diminuì e cessò interamente. «Be’, almeno
potrai venire all’albergo nella mia stanza, Slim, a farti un paio di bevute con me. Qui non mi conosce nessuno. Posso fare tutto quello che voglio.» «Mi piacerebbe vedere la pagina sportiva di quel giornale americano, se non ti spiace.» Salirono in macchina e tornarono in città per strade ridotte a canali. Comparve il sole, ardente, e tutto si avvolse di vapore azzurro. Era pomeriggio inoltrato. Le vie della città erano affollate; indù in turbante, cinesi in abiti Hart, Schaffner e Marx piuttosto attillati, bianchi rossi in viso vestiti di bianco, stracci di luce variopinta. Joe si sentì a disagio nel passare per l’atrio dell’albergo nella sua tenuta blu di marinaio, bagnata da far pietà, senza contare poi che lui aveva bisogno di una buona sbarbata. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones gli passò un braccio sulle spalle nel salir le scale. La stanza era ampia, fornita di finestre alte e strette con persiane, e odorava di rum al lauro. «Dio mio, ma ho un caldo da scoppiare e sono bagnato come un pulcino» disse. «Vado a farmi una bella doccia… ma prima faremmo meglio a ordinarci due gin soda… Perché non ti svesti e non ti metti a tuo agio? Con questo tempo l’unico vestito sopportabile è la pelle.» Joe scosse il capo. «I miei vestiti puzzano troppo» disse. «Allora, ce l’hai quel giornale?» Il servo indù venne con le bibite mentre l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones era nella stanza da bagno. Joe prese il vassoio. L’espressione dell’indù, con quella bocca sottile e quegli occhi neri che guardavano un punto dietro la tua persona nella stanza, aveva qualcosa che feriva Joe. Gli veniva voglia di picchiare quel bastardo color tabacco. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones tornò, con l’aria di chi s’è ben rinfrescato, in vestaglia di seta. «Mettiti a sedere, Slim, che ci facciamo una bevuta e una chiacchierata.» L’uomo si passò dolcemente le dita sui capelli e si adagiò in una poltrona. Joe si mise a sedere in una sedia dall’altra parte della stanza. «Dio mio, un’altra settimana ancora di questo caldo, in questo posto, e morirei. Non capisco come fai a resistere, coi lavori manuali e compagnia bella. Devi essere un tipo ben solido!» Joe voleva domandare dei giornali, ma l’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones aveva ripreso a parlare, dicendo come gli sarebbe
piaciuto di essere solido anche lui, e vedere il mondo a quella maniera, conoscere tipi d’ogni specie, andare in ogni sorta di bettole, Joe doveva certo vederne di belle, chissà che spasso tutti quei tipi assieme per tutti quei giorni in mare, col bello e col brutto, eh? e poi le notti a riva, a far bisboccia e gazzarra, una ragazza in quattro. «Se io facessi una vita così, non me ne importerebbe un accidente di quello che farei; niente reputazione da perdere, niente pericolo di ricatti, solo tener gli occhi aperti e non farsi mettere in gattabuia, eh? Ma davvero, Slim, mi piacerebbe un mondo venire con te e fare una vita così.» «Eeh?» disse Joe. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones chiamò il cameriere per ordinare altre bibite. Quando il servo indù se ne fu andato Joe domandò ancora dei giornali. «Slim, ti prego di credermi, li ho cercati dappertutto. Devono avermeli buttati via.» «Be’, allora bisognerà che ritorni a bordo della mia dannata limoniera.» Joe mise la mano sulla porta. L’uomo che aveva detto di chiamarsi Jones gli corse appresso, gli prese la mano e disse: «No, non te ne vai. Hai detto che mi avresti tenuto compagnia. Sei un ragazzo tanto simpatico. Non te ne avrai a male. Non puoi andartene a questo modo, ora che mi hai fatto venire tanta voglia della tua amicizia, e anche del tuo amore, vedi? A te non capita mai, Slim? Io sarò bravo. Ti darò cinquanta dollari.» Joe scosse il capo e liberò la mano dalla stretta. Dovette dargli uno spintone per poter aprire la porta; si precipitò di corsa per la scalinata di marmo bianco sinché fu in strada. Era quasi buio; Joe camminò a passo lesto. Il sudore gli colava a rigagnoli. Nel camminare imprecava tra i denti. Si sentiva abbattuto e mortificato, e aveva davvero tanta voglia di leggere qualche giornale americano. Bighellonò un poco in quella specie di parco dove si era seduto il pomeriggio, poi si incamminò verso la banchina. Tanto valeva tornare a bordo. L’odor di frittura delle rosticcerie gli rammentò che aveva fame. Era già entrato in una di queste, quando gli venne in mente che non aveva un centesimo in tasca. Seguì il suono di un organetto di Barberia e si trovò nel quartiere dei bordelli. Sugli usci delle baracchette c’erano negre d’ogni tipo e colore, meticce cinesi e donne
indiane, qualche grassa tedesca o francese sciupata; una mulattina che tese la mano sino a toccargli la spalla mentre passava era tremendamente graziosa. Si fermò e le rivolse la parola, ma quando le disse che era al verde lei scoppiò a ridere dicendo: «Gira alla larga di qui, signor Senzasoldi… qui non c’è posto per un Senzasoldi». Tornato a bordo, non riuscì a trovare il cuoco, altrimenti avrebbe provato a farsi dare con le buone maniere un po’ di rancio, così si sfogò con un po’ di tabacco da masticare. Il castello di prua era un forno. Se ne andò in coperta vestito di una semplice tuta e si mise a passeggiare su e giù con l’uomo di guardia, che era un giovanotto di Dover dalla faccia rosea, chiamato da tutti Tiny. 3 Tiny disse di aver sentito il Vecchio e Mr. McGregor parlare in cabina: l’indomani si sarebbe andati a St. Luce a caricar limoni, poi finalmente a casa, Inghilterra, ah, non vedeva l’ora, lui, di rimetter piede nella sua bella isoletta e dare un calcio a quel guscio della malora, altroché! Joe disse che per lui personalmente era un vero affare: stava di casa a Washington, distretto Columbia. «Io voglio dare un calcio a questa sporca vita e trovare un posto che renda. A questa maniera il primo bastardo d’un turista con un po’ di soldi in tasca si crede in diritto di farti fare lo schiavetto bianco.» Joe raccontò a Tiny di quel tale che aveva detto di chiamarsi Jones, e lo fece sbellicare dalle risa. «Cinquanta dollari, son dieci sterlinozze. Per dieci sterline quasi quasi l’avrei accontentato, il signorino.» Quella notte non c’era un filo d’aria. Le zanzare cominciavano a tormentare braccia e gambe di Joe. Dall’acqua pigra dei moli si levò una dolce nebbiolina calda che attutiva le luci del porto. I due fecero un paio di giri senza aprir bocca. «Caspita, ma che cosa voleva da te, Yank?» disse Tiny ridacchiando. «Oh, che il diavolo se lo porti» disse Joe. «Non ne voglio più sapere di questa vita. Qualunque cosa succeda, dovunque ci si trovi, il marinaio è sempre fottuto. Non è così, Tiny?» «Neanche per sogno… dieci sterlinozze! Diamine, quel signorino della malora dovrebbe vergognarsi. A casa mia quello che fa lui si chiama corrompere la morale. Varrebbe la pena di andare al suo albergo con un paio di compagni a fargli sputar soldi. A Dover ce n’è
più d’uno, di quei vecchi pederasti, che la paga per molto meno. Quelli là vengono a passare le vacanze e corrono appresso ai bagnini… Ricattarlo, ecco quello che farei io, Yank.» Joe non disse nulla. Dopo un po’ disse: «Cristo, e pensare che quando ero bambino morivo dalla voglia di andare ai tropici». «Questo non è tropico, è un porco buco d’inferno, ecco che cosa è.» Fecero un altro paio di giri. Joe andò ad appoggiarsi al parapetto, e sporgendosi guardò nella tenebra untuosa. Dio stramaledica queste zanzare. Quando sputò la cicca masticata si sentì un piccolo tonfo in acqua. Ridiscese nel castello di prua, s’infilò nella sua cuccetta, si tirò la coperta sulla testa e rimase lì fermo a sudare. «Maledizione, volevo vedere la classifica del baseball.» L’indomani si fece rifornimento di carbone, e un giorno dopo l’altro fecero verniciare a Joe le cabine degli ufficiali, mentre l’Argyle rimetteva il muso nel Boca passando fra le isole piene di felci color verde viscoso, e che rabbia, aveva il certificato di marinaio scelto e guarda un po’, lo stavano trattando da comune, e andava in Inghilterra, e una volta là che cosa faceva? E i compagni dicevano che con ogni probabilità te lo avrebbero schiaffato in campo di concentramento: straniero com’era, e per di più sbarcato in Inghilterra senza passaporto, con fior di guerra in piedi, e un mucchio di spie tedesche in giro, eccetera; ma ora la brezza era piena di salsedine, e quando si affacciò all’oblò vide oceano azzurro e non più l’acqua sporca di Trinidad, e pesci volanti a centinaia balzare lontano dalle fiancate della nave. La rada di St. Luce era pulita e chiusa dalla terra, case bianche col tetto rosso sotto le palme da cocco. Eran poi banane che bisognava caricare, e ci volle un giorno e mezzo per montare scomparti nella stiva di poppa e travi a cui appendere le banane. Era ormai buio quando accostarono al molo delle banane e montarono le due passerelle e il piccolo argano per calare i caschi di frutti in stiva. La banchina era gremita di donne di colore che ridevano e urlavano e strillavano alla ciurma, e grossi negri che se ne stavano tra i piedi senza far niente. Eran le donne a caricare. Dopo un po’ cominciarono a
salire per una passerella, ciascuna con un grosso casco verde di banane sulla testa e sulle spalle; c’erano vecchie negre obese e giovani mulatte graziose; avevano la faccia lucida di sudore sotto i grossi caschi di frutti, i seni pendevano dondolando, visibili attraverso gli abiti laceri, squarci di carne bruna in una manica. Ogni volta che una arrivava in cima alla passerella due grossi negri le toglievano delicatamente il carico dalle spalle, il caposquadra le dava un foglietto di carta ed essa tornava di corsa alla banchina scendendo per l’altra passerella. Eccezion fatta per gli addetti all’argano, l’equipaggio di coperta non aveva nulla da fare. I suoi membri se ne stavano lì attorno con un senso di disagio, ad osservare le donne, il luccichio bianco dei denti e degli occhi, i seni, i movimenti a pompa delle cosce. Se ne stavano lì a guardar le donne, a grattarsi, appoggiando alternativamente il peso del corpo sull’una e sull’altra gamba; non si scambiavano nemmeno gran che i soliti frizzi osceni. Era una notte nera e immota, fumava caldo attorno a loro il profumo delle banane e il tanfo del sudore di negra; ogni tanto un fiato di fresco da certe casse di limoni accatastate sul molo. Joe si accorse che Tiny gli faceva segno di seguirlo. Lo raggiunse nell’ombra. Tiny gli accostò la bocca all’orecchio: «Qua c’è fior di puttane, Yank, vieni con me». Andarono a prua e si calarono sulla banchina lungo una corda. La corda scorticò loro le mani. Tiny si sputò sulle mani e se le fregò. Joe fece lo stesso. Poi s’infilarono di soppiatto nel magazzino. Un topo saettò via sfiorando loro i piedi. Era un deposito di guano e puzzava di concime. Una porticina nel retro si apriva sul buio pesto, e sotto i piedi si sentiva la sabbia. Il soffitto del magazzino riceveva un fioco riverbero dai fanali della strada. Voci di donna, una risatina. Tiny era sparito. Joe si trovò sotto la mano una spalla nuda di donna. «Ma prima mi devi dare uno scellino» disse una vocina con l’accento dialettale delle Indie Occidentali. A lui la voce s’era fatta roca: «Ma certo, tesoro, certo che te lo darò». Quando si fu assuefatto al buio, vide che non erano soli. Tutt’intorno era un concerto in sordina di risatine e ansiti pesanti. Dalla nave giungeva il cigolio intermittente dei verricelli, e il vocio confuso delle donne che caricavan banane.
La donna chiedeva il denaro. «Suvvia, ragazzo bianco, adesso fa’ come hai detto.» Accanto a lui Tiny si stava riabbottonando i calzoni. «Torniamo in un lampo, ragazze.» «Si capisce, abbiamo lasciato i soldi a bordo.» Uscirono di corsa dal magazzino con le ragazze alle calcagna, salirono la scala di corda che qualcuno aveva calato dalle murate della nave, e si issarono sul ponte col fiato mozzo, tenendosi la pancia dal ridere. Quando guardaron giù le donne correvano su e giù per la banchina lanciando loro sputi e imprecazioni come tante gatte selvagge. «Addio madame» le salutò Tiny scappellandosi. Afferrò Joe per il braccio e assieme a lui fece quattro passi sul ponte; per un po’ andarono a fermarsi presso la testata della passerella. «Ehi, Tiny, mi taglio un dito se la tua non aveva l’età da esser tua nonna» bisbigliò Joe. «Possa restar cieco d’un occhio, la mia era quella carina.» «Tu sei matto… Avrà avuto un sessant’anni.» «Ma guarda che imbroglione… la mia era quella carina, altroché!» disse Tiny, allontanandosi offeso. Dietro le colline frangiate s’era levata una luna rossa. I caschi di banane che le donne portavano su per la passerella formavano un tortuoso serpente verde sotto il barbaglio delle luci. D’improvviso a Joe venne un senso di sonno e di disgusto. Scese a lavarsi con acqua e sapone prima di infilarsi nella sua cuccetta. Si addormentò ascoltando le voci scozzesi e britanne dei compagni che parlavano delle ragazze del magazzino, quante ne avevano avute, quante volte, e quanto faceva in tutto contando l’Argentina, Durban o Singapore. Le operazioni di carico proseguirono tutta notte. A mezzodì erano già salpati per Liverpool, e il capo faceva andare le caldaie a tutto vapore per accelerare la traversata, e i membri dell’equipaggio non facevano che parlare del sospirato riposo in patria. In quel viaggio ebbero banane a sazietà; ogni giorno l’addetto al controllo del carico portava su caschi passati di maturazione per appenderli in cucina. Tutti brontolavano perché la nave non era armata, ma il Vecchio e Mr. McGregor sembravano preoccuparsi più delle banane che dei corsari nemici. Non facevano che guardare sotto la copertura di tela che era stata rizzata con un ventilatore in cima sul boccaporto, per vedere se le banane non maturavano troppo in fretta.
Giù nel castello di prua si faceva un gran ridere sulle banane guaste. Passato il tropico incocciarono una tramontana molesta che soffiò per quattro giorni, dopodiché il tempo si mantenne brutto sino all’ultimo. Nel castello di prua brontolavano tutti perché non si era provveduto a disinfestare la nave con fumigazioni insetticide, e ad armarla, e ad aggregarla a un convoglio. Corse voce che sommergibili tedeschi incrociassero al largo di Capo Lizard, e dal Vecchio all’ultimo marinaio diventarono tutti nervosi come tante pile elettriche. Cominciarono tutti a prendersela con Joe per la neutralità americana, e si finiva sempre per fare lunghe discussioni tra lui, Tiny e un vecchio di Glasgow che a bordo chiamavano Haig. Joe disse che lui non vedeva proprio quale interesse avessero gli Stati Uniti a entrare in guerra, e ciò per poco non provocò una cazzottatura. Dopo avvistate le luci delle isole Scilly, Sparks disse che erano in contatto con un convoglio e avrebbero avuto un caccia tutto per loro nel mar d’Irlanda fino a quando non fossero stati al sicuro nella Mersey. Gli inglesi avevano vinto una grande battaglia a Mons. Il Vecchio offrì a tutti un goccio di rum, e tutti si ringalluzzirono, tranne Joe, il quale si domandava preoccupato che cosa gli sarebbe capitato sbarcando in Inghilterra senza passaporto. Aveva sempre freddo, privo com’era di abiti pesanti. Quella sera spuntò improvvisamente dal crepuscolo nebbioso un cacciatorpediniere, alto come una chiesa sulla grande ondata bianca che gli si arricciava attorno alle fiancate. Sul ponte a tutta prima si sentirono rizzare i peli della schiena, perché l’avevano preso per un vascello tedesco. Il caccia inalberò la bandiera inglese e rallentò per mettersi al passo con l’Argyle, mantenendosi alla sua altezza e a breve distanza. La ciurma si ammassò sopracoperta e salutò il caccia con tre acclamazioni. Qualcuno poi voleva cantare God Save the King, ma l’ufficiale che si trovava sul ponte di comando del caccia si mise a prendere a male parole il Vecchio, chiedendogli col megafono perché diavolo porco non seguiva una rotta a zigzag; e non sapeva che era proibito fare qualsiasi fottuto rumore a bordo di un mercantile in tempo di guerra? La campana batté otto colpi e ci fu il cambio di guardia. Joe e Tiny
presero a ridere arrivando in coperta proprio nel momento in cui incontrarono Mr. McGregor, tutto imporporato per la stizza. Quest’ultimo si fermò netto davanti a Joe e gli chiese che c’era da ridere. Joe non rispose. Mr. McGregor lo fissò duramente e cominciò a dire con quella sua voce bassa e misera che probabilmente Joe non era affatto un americano, ma una sporca spia tedesca, e gli disse di presentarsi al prossimo cambio di guardia in camera dei fuochi. Joe disse che lui si era arruolato come marinaio scelto e non avevano diritto di fargli fare il fuochista. Mr. McGregor disse che in trent’anni di navigazione non aveva mai messo le mani addosso a nessuno, ma se Joe diceva un’altra parola, perdio, gli avrebbe assestato un pugno da stenderlo a terra. Joe si sentì avvampare, ma rimase immobile coi pugni serrati, senza dir nulla. Per vari secondi Mr. McGregor stette lì a fissarlo, rosso come un tacchino. Passarono sul ponte due marinai di guardia. «Consegnate questo individuo al nostromo e mettetegli i ferri. Può darsi che sia una spia… E tu adesso va’ con loro buono e calmo, o sarà peggio per te.» Joe passò quella notte raggomitolato in un pertugio che puzzava di sentina, coi ceppi ai piedi. Il mattino dopo il nostromo lo mise in libertà e gli disse abbastanza gentilmente di andare dal cuoco a farsi dare un po’ di crema d’avena, ma di tenersi però alla larga dal ponte. Disse che appena avessero attraccato a Liverpool lo avrebbero consegnato all’ufficio Controllo stranieri. Quando traversò il ponte per andare in cucina, le caviglie rigide ancora per via dei ferri, notò che si era già nella Mersey. Era una mattinata rossastra e soleggiata. C’erano da ogni parte navi alla fonda, neri velieri dall’aria mozza e motobarche di pattuglia che tagliavano l’increspata acqua verde pallido. In alto la grande cappa di fumo bruno era bucata qua e là da bianchi getti ricciuti di vapore che giungevano a prendere il sole. Il cuoco gli diede un po’ di crema d’avena e un boccale di tè amaro neanche caldo. Quando uscì dalla cucina si era più a monte, si vedevano le città su entrambe le rive, il cielo era tutto coperto di fumo bruno e nebbia. Era circa la una, e l’Argyle filava a tutto vapore. Joe scese nel castello e si gettò nella cuccetta. I compagni lo
guardarono tutti senza parlare, e quando lui rivolse la parola a Tiny, che era nella cuccetta sotto la sua, l’altro non rispose. Ciò ferì Joe più d’ogni altra cosa. Voltò la faccia al muro, si tirò la coperta sulla testa e si addormentò. Lo svegliò qualcuno a forza di scossoni. «Vieni con me, bel tipo» disse un alto poliziotto inglese con elmetto azzurro e sottogola verniciato, che lo teneva per la spalla. «Va bene, va bene, un attimo solo» disse Joe. «Vorrei lavarmi.» Il poliziotto scosse la testa: «Più presto fai e più calmo stai, tanto meglio sarà per te». Joe si tirò il berretto sulle orecchie, prese la scatola da sigari di sotto il materasso e seguì il poliziotto sopracoperta. L’Argyle era già ormeggiata alla banchina. E così, senza salutare nessuno e senza prender paga, scese la passerella col poliziotto a un passo di distanza. Il poliziotto lo teneva ben saldo per il bicipite. Traversarono la banchina lastricata e passando per un gran portale di ferro arrivarono dove aspettava la Black Maria. 4 Un crocchio di sfaccendati, facce rosse nella nebbia, abiti neri e sporchi; uno disse: «Guardalo là, il porco tedesco». Una donna fischiò, si levarono due urla e un miagolio di scherno mentre i lucidi sportelli neri gli si chiudevano alle spalle, la vettura partì senza scosse e lui la sentiva filare per le vie selciate. Joe sedeva raggomitolato nell’oscurità. Era contento di trovarcisi solo, lì dentro. Così aveva modo di riprendersi. Mani e piedi eran freddi. Gli ci voleva tutta per non tremare. Almeno avesse avuto addosso abiti decenti. Invece non aveva che una camicia e un paio di pantaloni macchiati di vernice, e un paio di pantofole di feltro sporche. D’un tratto l’auto si fermò, due poliziotti gli dissero di scendere, e si vide spingere attraverso un corridoio imbiancato di fresco in una stanzetta dov’era seduto a un tavolo giallo verniciato un ispettore di polizia, un alto inglese dalla faccia lunga. L’ispettore balzò in piedi, avanzò verso Joe a pugni stretti come se stesse per colpirlo e disse a bruciapelo qualcosa in una lingua che Joe arguì dovesse essere tedesco. Joe scosse la testa, la cosa gli faceva un effetto ridicolo, e ghignò: «Non so niente». «Che cosa c’è in quella scatola?» gridò improvvisamente ai poliziotti l’ispettore, che si era rimesso a sedere al suo scrittoio.
«Dovreste perquisirli, questi cani, prima di portarli qua dentro.» Uno dei due poliziotti strappò la scatola da sigari di sotto al braccio di Joe e l’aprì, diede segni di sollievo quando constatò che non conteneva bombe e lasciò cadere ogni cosa sullo scrittoio. «Così tu sostieni di essere americano?» strillò il capo a Joe. «Certo che sono americano» disse Joe. «E si può sapere perché diavolo vuoi venire in Inghilterra in tempo di guerra?» «Io non ci volevo venire…» «Silenzio!» strillò l’altro. Poi fece segno ai poliziotti di andare, e disse: «Mandatemi il caporale Eakins». «Benissimo, signore» dissero rispettosamente i due poliziotti all’unisono. Quando se ne furono andati, lui si avvicinò ancora a Joe coi pugni chiusi. «Faresti meglio a confessare tutto, ragazzo mio… Abbiamo tutte le informazioni necessarie.» Joe doveva tenere i denti serrati per non farli battere di freddo. Era spaventato. «Mi trovavo in secca a Buenos Aires, vedete… dovetti accettare la prima cuccetta che mi capitò. Non crederete già che uno si imbarcherebbe sopra una limoniera se potesse farne a meno!» Joe cominciava a sentirsi offeso: questo gli ridonò una sensazione di caldo. L’uomo vestito in borghese prese una matita e con essa batté minacciosamente sul tavolo. «L’impudenza non ti gioverà a nulla, ragazzo mio… faresti meglio a tenere la lingua a posto.» Poi cominciò a esaminare le fotografie, i francobolli e i ritagli di giornale venuti fuori dalla scatola da sigari di Joe. Entrarono due uomini in kaki. «Spogliatelo e perquisitelo» disse l’uomo dello scrittoio senza alzare gli occhi. Joe guardò i due senza capire; avevano un po’ l’aria da infermieri. «Svelto, su» disse uno di loro. «Non vogliamo esser costretti a usare la forza.» Joe si levò la camicia. Con sua rabbia sentì che arrossiva; aveva vergogna perché non aveva biancheria sotto. «Bene, adesso togliti i calzoni.» Joe rimase nudo in pantofole, mentre gli uomini in kaki gli frugavano camicia e calzoni. Trovarono in una tasca un po’ di cascame pulito da macchine, una scatola ammaccata tipo Principe Alberto contenente un pezzo di tabacco da masticare e un coltellino a
serramanico con una lama rotta. Uno dei due esaminava la cintura e mostrò all’altro il punto in cui era stata ricucita. L’aprì con un coltello ed entrambi scrutarono avidamente l’interno. Joe ghignò: «Ci mettevo le banconote». Gli altri non mossero muscolo nel viso. «Apri la bocca.» Uno dei due posò la mano di peso sulla mascella di Joe. «Sergente, dobbiamo togliergli le otturazioni? Ne ha due o tre dalla parte interna.» L’uomo che sedeva allo scrittoio scosse il capo. Uno dei due uomini uscì dalla porta e tornò con in mano un guanto di gomma oliato. «Piegati in avanti» disse l’altro posando la mano sul collo di Joe e spingendogli la testa in giù mentre l’uomo del guanto di gomma gli tastava il retto. «Ehi, per Cristo!» sibilò Joe fra i denti. «Va bene, ragazzo, per adesso è finita» disse l’uomo che gli teneva la testa, lasciando la presa. «Spiacenti, ma siamo obbligati a farlo… è nel regolamento.» Il caporale si avvicinò allo scrittoio e si mise sull’attenti. «Tutto a posto, signore… Nulla di rilevante sulla persona del prigioniero.» Joe aveva un freddo cane. Non poteva fare a meno di battere i denti. «Guardategli nelle pantofole, cosa aspettate?» bofonchiò l’ispettore. A Joe non garbava per nulla di doversi togliere le pantofole, perché aveva i piedi sporchi, ma non c’era nulla da fare. Il caporale le fece a pezzi col temperino. Poi i due uomini si misero sull’attenti e attesero che l’ispettore alzasse gli occhi. «Tutto a posto, signore… nulla da segnalare. Devo dare al prigioniero una coperta, signore? Pare che abbia freddo.» L’uomo che stava dietro lo scrittoio scosse la testa e fece un cenno a Joe. «Vieni un po’ qua. Ora se sei disposto a rispondere sinceramente e a non darci fastidio te la caverai col campo di concentramento per la durata della guerra… Ma se ci dai fastidio, la cosa potrebbe finire molto, molto più seriamente. Vige per noi la Legge sulla difesa del regno, non dimenticarlo… Come ti chiami?» Quando Joe gli ebbe detto nome, cognome, nome del padre e della madre, delle navi su cui aveva fatto servizio, l’ispettore improvvisamente gli sparò in faccia a bruciapelo una domanda in tedesco. Joe scosse la testa. «Ehi, come fate a pensare che io sappia il tedesco?»
«Chiudi il becco!… In ogni modo sappiamo tutto di lui.» «Dobbiamo dargli il suo bottino, signore?» chiese timidamente uno dei due uomini. «Non avrà bisogno di bottino, ammenoché non sia proprio delicato.» Il caporale prese un mazzo di chiavi e aprì una massiccia porta di legno in una parete della stanza. Spinsero Joe in una celletta con una panca e priva di finestre. La porta gli si chiuse di colpo alle spalle, ed eccoti lì Joe a intirizzire nel buio. «Be’, stavolta ci sei sul serio, nel c…o della balena, Joe Williams» disse ad alta voce. Si accorse che poteva scaldarsi facendo esercizi ginnastici e fregandosi braccia e gambe, ma i piedi rimanevano intirizziti. Dopo un po’ sentì girare la chiave nella toppa; l’uomo in kaki gettò una coperta nella cella e richiuse la porta di colpo, senza dargli tempo di proferir verbo. Joe si raggomitolò nella coperta sulla panca e si sforzò di addormentarsi. Si svegliò di soprassalto sotto un incubo. Faceva freddo. Avevano fatto il cambio della guardia. Saltò giù dalla panca. Era buio pesto. Per un attimo credette di esser diventato cieco nella notte. Gli riaffiorò alla memoria il posto dove si trovava, e tutto quello che era avvenuto dacché avevano avvistato le isole Scilly. Aveva come un pezzo di ghiaccio sullo stomaco. Per un po’ camminò su e giù da parete a parete, e poi si riavvoltolò nella coperta. Era una buona coperta pulita e odorava di lysol o qualcosa del genere. Si addormentò. Si risvegliò ancora, affamato come un lupo e con la voglia di orinare. Frugò per un pezzo nella cella quadrata, finché trovò sotto la panca un secchio smaltato. Lo adoperò e si sentì meglio. Per fortuna il secchio era munito di coperchio. Cominciò a chiedersi come avrebbe fatto a passare il tempo. Cominciò a pensare a Georgetown e ai bei tempi in cui si divertiva un mondo con Alec e Janey e la banda che frequentava la sala da bigliardo Mulvaney e le conoscenze occasionali fatte nelle gite al chiaro di luna sul Charles McAlister, e passò in rassegna tutti i buoni pitchers 5 che gli era capitato di vedere personalmente o nei giornali, e cercò di ricordare la media dei punti fatti da ciascun giocatore delle squadre di Washington. In questo modo era giunto, riandando il passato, a tentar di ricordare le partite
giocate da lui al liceo, un tempo dopo l’altro, quando la chiave fu immessa nella toppa. Aprì la porta il caporale che lo aveva perquisito, e gli porse camicia e calzoni. «Puoi lavarti se vuoi» disse. «È meglio che ti metta in ordine. Ho l’incarico di portarti dal capitano CooperTrask.» «Perdio, non potete procurarmi qualcosa da mangiare, o un po’ d’acqua? Sto morendo di fame… A proposito, tanto per sapere, quanto tempo è che son qua dentro?» Joe batteva le palpebre nell’intensa luce bianca che entrava dall’altra stanza. Indossò camicia e calzoni. «Vieni con me» disse il caporale. «Non posso rispondere a nessuna domanda finché non hai conferito col capitano Cooper-Trask.» «Ma, e le mie pantofole?» «Tieni la lingua a posto e rispondi a tutte le domande che ti verranno rivolte, e sarà meglio per te… Vieni.» Quando seguì il caporale per lo stesso corridoio dal quale era venuto, tutti i tommies fecero tanto d’occhi sui suoi piedi nudi. Nel lavatoio c’era un lucido rubinetto di ottone che mandava acqua fredda, e un pezzo di sapone. Per prima cosa Joe fece una lunga bevuta. Gli girava la testa e gli tremavano i ginocchi. L’acqua fredda, e il fatto di lavarsi mani e viso e piedi, lo rimisero un po’ in sesto. L’unica cosa a sua disposizione per asciugarsi era una salvietta già sporca. «A proposito, ho bisogno di farmi la barba» disse. «Adesso è ora di andare» disse severamente il caporale. «Ma io ho un Gillette in qualche parte…» Il caporale gli lanciò un’occhiata irosa. Erano diretti alla porta di un ufficio ben ammobiliato; sul pavimento c’era uno spesso tappeto rosso e bruno. A uno scrittoio di mogano sedeva un uomo anziano dai capelli bianchi, la faccia tonda color manzo arrosto, e una quantità di distintivi e decorazioni sulla divisa. «È lui…?» cominciò Joe, ma vide che il caporale, dopo aver battuto i tacchi e fatto il saluto militare, si era irrigidito sull’attenti. L’uomo anziano alzò la testa e li guardò con paterni occhi azzurri. «Ah… così» disse. «Portalo più vicino, caporale, che gli dia un’occhiata… Non è un po’ in disordine, caporale? Faresti meglio a dare a questo povero diavolo scarpe e calze…» «Benissimo, signore» disse il caporale in tono indispettito, irrigidendosi nuovamente
sull’attenti. «Riposo, caporale, riposo» disse l’uomo anziano, inforcando un paio di occhiali ed esaminando certe carte che aveva sulla scrivania. «Questo è… ehm… Zentner… afferma di essere cittadino americano, eh?» «Il suo nome è Williams, signore.» «Ah, così… Joe Williams, marinaio…» Fissò su Joe quegli occhi azzurri in aria confidenziale. «È questo il tuo nome, ragazzo mio?» «Signorsì.» «Bene, come mai cerchi di entrare in Inghilterra in tempo di guerra senza passaporto o altro documento d’identità?» Joe raccontò come fosse in possesso di un certificato americano di marinaio scelto, e si fosse trovato disoccupato a B.A. … Buenos Aires. «E perché ti trovavi… ehm… in queste condizioni in Argentina?» «Ecco, signore, io ero con la Mallory Line, e la mia nave partì senza di me, e io avevo fatto un po’ di buriana, signore, e il capitano partì prima della data stabilita, cosicché mi trovai a terra.» «Ah… baldoria nella città vecchia di notte… una cosa del genere, vero?» L’uomo anziano rise; poi improvvisamente arricciò le sopracciglia: «Vediamo un po’… ehm… su quale piroscafo della Mallory Line viaggiavi?». «Sul Patagonia, signore, e non ero un passeggero, ero marinaio ingaggiato.» L’uomo anziano scrisse e scrisse sopra un foglio, poi tolse la scatola da sigari di Joe dal cassetto e prese a esaminare i ritagli e le fotografie. Ne estrasse una foto e la voltò in modo che Joe poté vederla. «Proprio una bella ragazza… è la tua donna del cuore, Williams?» Joe divenne scarlatto. «È mia sorella.» «Non c’è che dire, è un fiore di ragazza… che ne pensi tu, caporale?» «D’accordo, signore» disse il caporale con aria assente. «Ora, ragazzo mio, se sai qualcosa dell’attività degli agenti tedeschi in Sud America… molti di loro sono americani o impostori che si spacciano per americani… sarà molto meglio per te che tu dica tutto dall’a alla zeta.» «Sinceramente, signore,» disse Joe «io non ne so proprio niente. A Buenos Aires ci son stato solo pochi giorni.» «I tuoi genitori sono vivi?» «Mio padre è molto malato… Ma mia madre e le mie sorelle abitano a Georgetown.» «Georgetown… vediamo… non è nella
Guyana britannica?» «È un sobborgo di Washington, Columbia District.» «Certo, certo… oh guarda, sei stato nella marina militare…» L’uomo anziano mostrò la foto di Joe con gli altri due marinai. A Joe quasi mancarono i ginocchi, tanto che temette di cadere a terra. «No, signore, ero nella riserva.» L’uomo anziano rimise tutto nella scatola da sigari. «Ora puoi tenerti questa roba, ragazzo mio… Fareste meglio a dargli una colazioncina e a fargli prendere una boccata d’aria in cortile. Pare che non si regga tanto bene sulle gambe, caporale.» «Benissimo, signore.» Il caporale salutò e uscì con Joe. La colazione consistette in farina d’avena acquosa, tè vecchio e due fette di pane spalmate di margarina. Dopodiché Joe aveva più fame di prima. Eppure faceva bene uscire all’aria aperta, anche se piovigginava e il lastricato del cortiletto dove lo misero gli gelasse i piedi come ghiaccio sotto la lieve patina di fango. Nel cortiletto c’era un altro prigioniero, un ometto dal volto grassoccio con un cappello di feltro rigido e un soprabito bruno, e si avvicinò subito a Joe. «Ehi, siete americano?» «Certo» disse Joe. «Io mi chiamo Zentner… tratto forniture per ristoranti… sono di Chicago… Qveste sono cosse te l’altro monto. Io fengo qvi in qvesto tannato paese a comperare le sue tannate merci, a spendere ottimi tollari americani… Tre giorni fa ho fatto un’ordinazione per tiecimila tollari a Sheffield. E loro mi arrestano come spia e mi hanno tenuto qvi tutta notte e solo stamattina mi fogliono lasciar teleffonare al consolato. Sono cosse te l’altro mondo e io ci ho un passaporto e fisto e tutto qvello che fogliono. Posso far causa per qvesta offesa. Fado a Washington. Farò causa al goferno inglese: centomila tollari ti tanni per tiffamazione. Cittadino americano da qvarant’anni e mio vater, lui, non feniva talla Cermania ma talla Polonia… E foi, pofero racazzo, fedo che non afete scarpe. E poi parlano tegli atroci tedeschi, e se qvesta non è un’atrocità, che cossa è?» Joe tremava di freddo e correva tutt’intorno al cortile al trotto per tentar di scaldarsi. Il signor Zentner si tolse il soprabito bruno e glielo porse. «Ecco qva, ciovanotto, mettetevi su qvesto soprabito.» «Ma, Gesù,
è troppo bello; è troppo gentile da parte vostra.» «Nelle affersità pisogna aiutarsi l’un l’altro.» «Accidenti, se questa è la primavera inglese, figurarsi l’inverno!… Vi restituirò il soprabito quando rientrerò. Gesù, ho i piedi freddi… A proposito, voi vi hanno perquisito?» Il signor Zentner strabuzzò gli occhi. «Oltraccioso…» sbuffò indignato. «Che fercogna, trattare così un acquirente ti un paese neutrale e amico. Ma fedrete un po’ se non lo tico all’ampasciatore. Farò causa. Chieterò i tanni.» «Sui due piedi» disse Joe ridendo. Comparve sull’uscio il caporale e gridò: «Williams». Joe restituì il cappotto e strinse la mano grassoccia del signor Zentner. «Ehi, per grazia di Dio, non dimenticate di dire al console che qui c’è un altro americano. Si parla nientedimeno che di mandarmi in campo di concentramento per tutta la durata della guerra.» «Ma certo, non preoccupatefi, racazzo mio. Fi farò fenir fia ti qui» disse il signor Zentner gonfiando il petto. Stavolta Joe fu portato in una cella regolare dove c’era un po’ di luce e di spazio per girare. Il caporale gli diede un paio di scarpe e un paio di calze di lana piene di buchi. Le scarpe non riuscì a infilarsele, ma le calze gli scaldarono un po’ i piedi. A mezzodì gli portarono una specie di stufato che consisteva quasi tutto in patate piene d’occhi, e un altro po’ di pane e margarina. Il terzo giorno, quando il guardiano venne con l’intruglio di mezzogiorno, portò anche un pacco di carta bruna aperto. C’era dentro un vestito completo, camicia, biancheria di flanella, calzini e persino una cravatta. «C’era anche un biglietto dentro, ma è contro il regolamento» disse il guardiano. «Con questo po’ po’ di abbigliamento sarai un vero damerino.» A pomeriggio inoltrato il guardiano disse a Joe di seguirlo, così lui si mise il colletto pulito che era troppo stretto, e la cravatta, si tirò su i calzoni che gli eran troppo larghi alla vita, e seguì l’altro per vari corridoi e attraverso un cortile pieno di tommies sino a un piccolo ufficio con una sentinella alla porta e un sergente allo scrittoio. Accomodato in una sedia c’era un giovane dall’aria indaffarata con un
cappello di paglia sui ginocchi. «Ecco il vostro uomo, signore» disse il sergente senza neanche guardare Joe. «Interrogatelo pure voi.» Il giovane dall’aria indaffarata si alzò e si diresse verso Joe. «Bene, mi avete procurato davvero un sacco di fastidi, ma comunque ho compulsato i documenti che vi riguardano e mi sembra che siate davvero quello che avete dichiarato… Come si chiama vostro padre?» «Come me, Joseph P. Williams… Scusate, siete il console americano voi?» «Sono del consolato… Ma ditemi un po’, come vi salta in testa di scendere a terra senza passaporto? Noi abbiamo altro da fare che occuparci di tutti quegli sciocchi dannati i quali non sanno andare più in là del proprio naso! Accidenti, questo pomeriggio avevo una partita a golf, ed ecco, invece, son stato qui due ore buone ad aspettare per tirarvi fuori della ghiacciaia.» «Gesù, ma non sono stato io a scendere a terra. Sono venuti a prendermi.» «Spero che la lezione vi serva, allora… La prossima volta avrete i documenti in ordine.» «Sissignore… Certo che li avrò.» Mezz’ora dopo Joe era in strada, con la scatola da sigari e gli abiti vecchi involtati sotto il braccio. Era un pomeriggio di sole; la gente rossa in viso e vestita di scuro, donne dal volto lungo con cappelli di poco prezzo, le vie piene di grossi autobus e alte vetture tranviarie; tutto aveva un’aria tremendamente spassosa, finché d’un tratto gli venne in mente che era Inghilterra, che la vedeva per la prima volta in vita sua. Gli toccò aspettare a lungo in un ufficio vuoto al consolato, mentre il giovane dall’aria indaffarata compilava un mucchio di documenti. Aveva fame e non faceva che pensare alle bistecche e alle patatine fritte. Finalmente fu chiamato allo scrittoio, ricevette un documento e seppe che c’era un posto fissato per lui sul piroscafo americano Tampa, proveniente da Pensacola, e che avrebbe fatto bene a rivolgersi subito agli agenti e accertarsene e salire a bordo, che se lo pescavano ancora in giro per Liverpool non gli sarebbe andata liscia. «A proposito, c’è mezzo di trovar da mangiare qui, signor
console?» «Ma cosa credete, che sia un ristorante?… No, non siamo attrezzati per assegnazioni di cibarie. Dovreste esserci grato per quello che abbiamo fatto sinora.» «Sull’Argyle non mi hanno mai pagato e son quasi morto di fame in quella prigione, ecco tutto.» «Be’, ecco qua uno scellino, ma è proprio tutto quello che posso fare.» Joe guardò la moneta. «Chi è questo, re Giorgio? Be’, grazie, signor console.» Camminava per la strada con l’indirizzo dell’agente in una mano e lo scellino nell’altra. Si sentiva umiliato e debole e aveva un dolore allo stomaco. Vide il signor Zentner dall’altra parte della strada. Fendette di corsa il traffico intenso e andò verso di lui con la mano tesa. «Ho avuto i vestiti, signor Zentner, siete stato così gentile a mandarmeli.» Il signor Zentner era accompagnato da un ometto in divisa da ufficiale. «Lieto di essere stato utile a un concittadino» e proseguì per la sua strada. Joe entrò in una rosticceria, comprò sei pence di pesce fritto e con gli altri sei prese un grosso boccale di birra in un locale dove aveva sperato invano di trovare una colazione al banco per saziarsi. L’ufficio dell’agente, quando riuscì a rintracciarlo e ad arrivarci, era chiuso; e allora, ecco, fu un errare senza meta per le vie cittadine nella bianca sera nebbiosa. Dalle parti del porto domandò a parecchia gente se sapeva dov’era attraccato il Tampa, ma nessuno lo sapeva, e poi avevano un modo così buffo di parlare che stentava a capirli. Più tardi, proprio all’accendersi delle luci in strada, quando si sentiva già prendere dallo scoraggiamento, Joe vide davanti a sé in una stradicciola secondaria tre marinai americani. Li raggiunse e domandò loro se sapevano dov’era il Tampa. O che diavolo, e come potevano non saperlo, non era la loro nave, caspita? e loro erano in franchigia e volevano vedere un po’ quella città della malora, e lui non doveva fare altro che seguirli. E non gli faceva effetto incontrare dei connazionali dopo quei due mesi di limoniera, dopo la prigione e tutto? Andarono in un bar a bere whisky, e lui raccontò tutto quanto della prigione, e come i fottuti poliziotti lo avessero prelevato a bordo dell’Argyle e lui non aveva mai avuto paga o altro, e lo fecero bere, e uno di loro, un certo Will Stirp di Norfolk, Virginia, tirò fuori una banconota da
cinque dollari e gli disse di accettarla, glieli avrebbe restituiti quando poteva. Era come arrivare in Terra Promessa, incontrar tipi come quelli, e fecero un giro di bevute, tanto per cominciare; erano quattro americani in quella pidocchiosa città di limonai, 6 perbacco, e ciascuno di loro offrì da bere agli altri, perché erano quattro americani pronti a tener testa al mondo intero. Olaf era svedese, ma aveva appena avuto la cittadinanza, così contava anche lui, e l’altro si chiamava Maloney. La barista dal viso ad accetta li truffò sul resto, ma loro glielo fecero sputare; aveva dato solo quindici scellini invece di venti per una sterlina, ma loro si fecero restituire i cinque scellini. Andarono in un’altra rosticceria; in quel porco paese pareva non si potesse trovar altro da mangiare che pesce fritto, e allora ci bevvero sopra, ed erano loro, i quattro americani, e si sentivano benone in quella pidocchiosa città di limonai. Si lasciarono attaccar bottone da un galoppino di bordello, perché a causa della guerra era già ora di chiusura per i locali, e non c’era più un buco aperto, e pochissimi lampioni accesi, e questi poi curiosamente incappucciati per via degli Zeppelin. Il galoppino era un miserabile dalla faccia pallida di topo, e disse di conoscere un posto dove si poteva avere un po’ di birra e belle ragazze e stare in buona compagnia e in santa pace. Nel salotto di quella casa c’era una grossa lampada dipinta a rose rosse, e le ragazze erano magre e avevano i denti da cavallo, e c’erano dei maledetti limonai già su di giri, e loro erano i quattro americani. I limonai cominciarono a punzecchiare Olaf dandogli dell’unno fottuto. Olaf disse che lui era svedese, ma che in ogni modo avrebbe preferito essere un unno fottuto che un limonaio. Qualcuno diede un urtone a qualcun altro e la prima cosa di cui Joe si accorse fu che stava battendosi con un tizio più grosso di lui, e si sentirono i fischi della polizia, e tutta la banda al completo si trovò impacchettata sulla Black Maria in quattro e quattr’otto. Will Stirp continuava a dire che loro erano quattro americani, non avevano fatto altro che divertirsi da cristiani in buona compagnia, e i poliziotti non avevano nessuna ragione di intervenire. Ma furono tutti portati davanti al tavolo del commissario e passati in guardina; tutti e
quattro gli americani furono chiusi nella stessa cella, e i limonai in un’altra. Il posto di polizia era pieno di ubriachi che strillavano e cantavano. Maloney aveva il naso insanguinato. Olaf si addormentò. Joe non riusciva a dormire; continuava a dire a Will Stirp che aveva una paura dell’altro mondo, stavolta certo lo avrebbero schiaffato in campo di concentramento per tutta la durata della guerra, e ogni volta Will Stirp diceva che loro erano quattro americani, o non era forse un Cittadino Americano nato libero, lui?, e a loro non gli avrebbero fatto proprio un bel niente, perché non potevano. Libertà dei mari, che Dio la spacchi! Il mattino dopo comparvero in aula, e fu una cosa buffissima, senonché Joe aveva paura; c’era una solennità da riunione di quaccheri, e il pretore portava una piccola parrucca, e loro si buscarono tre scellini e sei pence a testa di multa, più le spese processuali. Vale a dire circa un dollaro a testa. Fortuna che avevano ancora un po’ di soldi in tasca. E il pretore con la piccola parrucca fece loro un sacramento di paternale, e si era in guerra, perbacco, e loro non dovevano mai e poi mai ubriacarsi e comportarsi male in terra inglese, ma avrebbero dovuto invece trovarsi a fianco dei loro fratelli che stavano combattendo, inglesi del loro stesso sangue, ai quali gli americani dovevano tutto, persino la loro stessa esistenza di grande nazione, per difendere la civiltà e le libere istituzioni e il coraggioso piccolo Belgio contro gli unni invasori che violavano le donne e affondavano pacifiche navi mercantili. Quando il pretore ebbe terminato, i funzionari della Corte dissero a bassa voce: «Avete sentito?», e assunsero tutti un’aria molto fiera e solenne, e misero in libertà gli americani dopo che questi ebbero pagato la multa e il sergente di polizia ebbe guardato i loro documenti. Trattennero Joe un po’ di più perché i suoi documenti erano del consolato e non avevano il bollo del posto di polizia giusto, ma dopo un po’ lo lasciarono andare con l’ammonimento di non scendere a terra un’altra volta. Joe tirò un respiro di sollievo quando vide il capitano e fu ricevuto a bordo ed ebbe preparata la sua cuccetta e fu mandato a terra a
prendere il suo fagotto, lasciato alla bella barista dai capelli di lino nel primo locale in cui era andato la sera prima. Finalmente era a bordo di una nave americana. Aveva una bandiera americana dipinta su ambo le pareti dello scafo, assieme al nome “Tampa, Pensacola, Florida”, scritto a lettere bianche. Il cuoco era un ragazzo di colore, e tanto per cominciare presero pappa di farina di grano e sciroppo di karo, e caffè, altro che quello schifoso tè, e il cibo aveva un ottimo sapore. Joe si sentì meglio di quanto gli fosse mai capitato di sentirsi dacché era partito di casa. Le cuccette erano pulite, e che meraviglia quando il Tampa si staccò dalla banchina a suon di sirena e prese il largo sulla corrente di ardesia della Mersey. Quindici giorni per arrivare a Hampton Roads, con un sole magnifico e un mare come l’olio ogni giorno sino agli ultimi due, e poi un secco vento di nord-ovest che alzò un po’ di mare al largo dei Capi. Scaricarono le poche balle di cotonate che costituivano il carico alla stazione dell’Unione a Norfolk. Che giornata imperiale per Joe, quando scese a terra con la paga in tasca per vedere un po’ la città in compagnia di Will Stirp, che era del luogo. Andarono a trovare la famiglia di Will Stirp e arrivarono in tempo per vedere una partita di baseball, dopodiché fecero una scarrozzata in tram fino a Virginia Beach con alcune amiche di Will Stirp. Una di loro si chiamava Della; ed aveva una carnagione molto scura, e Joe francamente se ne incapricciò. Al momento di indossare i costumi da bagno in cabina egli domandò a Will se lei era di quelle… E Will si risentì e disse: «Ma non hai tanto cervello da distinguere una ragazza per bene da una puttanella?». E Joe disse: «Be’, sai com’è, al giorno d’oggi non si sa mai». Fecero una bella nuotata e giocarono sulla spiaggia in costume da bagno e accesero un fuoco e arrostirono pasticcini di altea e poi riaccompagnarono le ragazze a casa. Della si lasciò baciare da Joe quando si dissero buona notte, e lui cominciò quasi a far progetti seri su di lei. Tornati in città non sapevano semplicemente che cosa fare. Volevano bere qualcosa e mangiare un po’ di uva secca, ma temevano di cascarci e vuotarsi le tasche. Andarono in una sala da bigliardo che
Will conosceva e tirarono qualche colpo a buche, e Joe ci sapeva fare e liquidò tutti i giocatori del posto. Dopo se ne andarono e Joe offrì da bere, ma era ora di chiudere, ed ecco si ritrovarono daccapo in strada. Non c’era una puttana a pagarla a peso d’oro; Will disse che conosceva una casa di appuntamenti, dove però ti pelavano come un pollo, e i due stavan già per tornare a casa quando si imbatterono in due compari che strizzarono l’occhio. Li seguirono per un bel tratto di quella via, svoltando poi in una traversa scarsamente illuminata. Le ragazze erano roba fina, ma nervose e spaventate, temevano di esser sorprese da qualcuno. I due marinai trovarono una casa vuota con un portico nel retro dov’era buio pesto, le portarono lì e dopo tornarono sui loro passi e dormirono a casa dei genitori di Will Stirp. Il Tampa era andato in bacino di carenaggio a Newport News per riparazioni a una piastra smossa. Joe e Will Stirp ricevettero la loro liquidazione e girarono tutti i santi giorni per Norfolk senza saper che cosa fare. Nei pomeriggi di sabato e domenica Joe giocava un po’ a baseball con una squadra raccogliticcia di ragazzi che lavoravano al cantiere navale, e di sera usciva con Della Matthews. Lei era stenografa alla First National Bank e continuava a dire che non avrebbe mai sposato un marinaio, non era gente da potersene fidare, facevano una vita d’inferno e senza possibilità di carriera. Joe disse che lei aveva ragione, ma in fin dei conti si era giovani una volta sola, e in ogni modo che cosa importava il resto, diavolo? Lei gli domandava notizie dei suoi, e perché lui non faceva una scappata a Washington per vederli, tanto più che suo padre era malato. Lui rispose che il vecchio poteva crepare per quello che gliene importava, non lo poteva vedere, ecco tutto. Lei disse che era un uomo tremendo. Quella volta le stava offrendo un soda dopo il cinema. Lei era tutta graziosa e pacioccona nel suo vestitino rosa vaporoso, e aveva gli occhietti neri eccitati e scintillanti. Joe disse che era meglio non parlarne più, di quella faccenda, ma lei gli piantò in faccia due occhi cattivi e rabbiosi e disse che aveva una gran voglia di dargli una buona scrollata, e che le cose avevano sempre una grande importanza, ed era una vera malvagità parlare in quel modo, e lui era un bravo ragazzo e veniva da una famiglia per bene ed era stato educato bene e
avrebbe dovuto pensare a farsi strada nel mondo invece di essere uno spostato e un fannullone. Joe si sentì mortificato e disse ah sì? e la lasciò sulla porta di casa senza una parola. Dopo quella volta stette quattro o cinque giorni senza vederla. Poi passò dal posto dove lavorava Della e una sera l’aspettò all’uscita. Aveva pensato a lei e alle sue parole più di quanto non avesse voluto. A tutta prima lei tentò di passargli davanti, lasciandolo con un palmo di naso, ma lui le fece una smorfia di sorriso e lei non poté a meno di sorridergli in risposta. Lui era piuttosto al verde di quei tempi, ma la portò con sé ugualmente e le comperò una scatola di canditi. Parlarono del gran caldo che faceva e lui disse che la settimana dopo sarebbero andati alla partita di baseball. Le disse come il Tampa fosse in procinto di salpare alla volta di Pensacola per caricar legname e indi rifare la traversata. Stavano aspettando il tram per Virginia Beach e camminavano su e giù difendendosi dalle zanzare. Quando lui disse che avrebbe fatto la traversata, lei ne fu tutta sconvolta. Prima ancora di rendersi ben conto di quello che faceva, Joe le disse che non si sarebbe reimbarcato sul Tampa, ma si sarebbe cercato un posto lì a Norfolk. Quella notte era di plenilunio. Scherzarono un bel po’ sulla spiaggia in costume da bagno accanto a un focherello che Joe aveva acceso con alcuni detriti per scacciare le zanzare. Lui stava seduto alla turca e lei stava sdraiata con la testa sulle ginocchia di lui, e intanto lui non faceva altro che carezzarle i capelli e chinarsi su di lei per baciarla; lei diceva com’era curioso a vedersi il suo volto rovesciato quando la baciava in quel modo. Disse che si sarebbero sposati non appena lui si fosse trovato un buon posto fisso, e tra tutti e due si sarebbero fatti una posizione. Sin da quando aveva preso la licenza media superiore in testa a tutta la classe, lei sentiva che avrebbe dovuto lavorar sodo e farsi una posizione. «La gente di qui è tremendamente insignificante, Joe, non si accorge neanche di vivere.» «Sai, Della, tu mi ricordi mia sorella Janey, sul serio! Dio sa se anche lei non si sta facendo una buona posizione… Ed è anche molto carina…» Della disse che sperava di conoscerla un giorno o l’altro, e Joe disse
che sì, certamente, e la fece alzare e l’attirò a sé, la strinse tra le braccia e la baciò. Era tardi, la spiaggia era fredda e solitaria sotto la grande luna. Della si mise a tremare e disse che se non si vestiva subito le veniva un accidente. Dovettero fare una bella corsa per non perdere l’ultimo tram. Le rotaie sferragliavano mentre la vettura correva sobbalzando per le distese sabbiose seminate di pini, piene di grilli e cavallette zirlanti. Della d’un tratto si rannicchiò su se stessa e scoppiò a piangere. Joe continuava a domandarle che avesse, ma lei non rispondeva, non faceva che piangere e piangere. Fu per lui un sollievo lasciarla sulla porta di casa e camminare solo per le vie vuote e senz’aria verso la pensione dove alloggiava. La settimana seguente non fece altro che scarpinare per Norfolk e Portsmouth in cerca di un posto che offrisse buone prospettive. Andò persino a Newport News. Di ritorno sul traghetto non aveva in tasca nemmeno i soldi per pagarsi il biglietto, e dovette profittare della ressa per sfuggire al controllo. La padrona della pensione cominciò a chiedergli l’affitto della settimana seguente. Tutti i posti ai quali Joe si presentò richiedevano pratica o uno speciale addestramento, oppure bisognava aver terminato la scuola media superiore, e comunque posti non ce n’erano molti, cosicché alla fine egli dovette imbarcarsi ancora, in una grossa chiatta che aspettava di essere rimorchiata sino a Rockport, ad est, con un carico di carbone. Erano cinque chiatte a rimorchio; non fu un brutto viaggio, in fondo, a bordo della sua erano giusto in tre: lui, un vecchio di nome Gaskin e suo figlio, un ragazzo di circa quindici anni che si chiamava Joe anche lui. Il solo incidente fu in una burrasca al largo di Capo Cod, quando si ruppe la gomena del rimorchio, ma il capitano del rimorchiatore era un tipo sveglio e riuscì a riagganciarli con un altro cavo prima ancora che si fossero ancorati. A Rockport scaricarono il carbone e si ancorarono in rada in attesa di venir rimorchiati a un altro molo a caricare blocchi di granito per il viaggio di ritorno. Una notte che Gaskin e il suo ragazzo eran scesi a terra e Joe era di guardia, il secondo macchinista del rimorchiatore, un tipo dalla faccia lunga, di nome Hart, accostò a poppa con una
scialuppa e chiese a Joe con un bisbiglio se voleva qualche donnina. Joe stava lungo disteso sulla cabina a fumarsi la pipa, pensando a Della. Le alture, la rada e la costa rocciosa sfumavano in un caldo crepuscolo rosa. Hart balbettava, aveva un modo nervoso di parlare. Joe dapprima non se ne dette per inteso, ma dopo un po’ disse: «Portale qui». «Hai qualche bigliettone?» «Ma sì, ne ho un bel mazzo.» Joe andò a pulire la cabina. Le avrebbe prese in giro e basta, pensava. Non stava bene darsi bel tempo con le ragazze, ora che doveva sposare Della. Udì rumor d’auto e uscì in coperta. Avanzava dal mare un banco di nebbia. A poppa c’era la barca con Hart e le sue due ragazze. Trasbordarono ridendo e gli cascarono addosso di peso quando le aiutò a scavalcare il parapetto. S’eran portate un po’ di liquore, due libbre di carne tritata all’amburghese e qualche croccante. Non erano bellezze, ma avevano un bel personale, buone braccia e spalle tornite, e sopportavano benissimo il liquore. Joe non aveva mai visto ragazze come quelle. Erano una compagnia divertente. Tra tutte e due avevano quattro parti di liquore e lo bevvero dalle coppe. Gli altri due barconi sonavano il clacson ogni due minuti, ma a Joe non passava neanche per l’anticamera del cervello. La nebbia era come un telone bianco tirato sui finestrini della cabina. Giocarono a strip poker, ma non durò molto. Lui e Hart si scambiarono le ragazze tre volte quella notte. Le ragazze avevano un diavolo per capello, erano incontentabili, ma verso le dodici erano calme ormai, cossero la carne e prepararono una cenetta e si mangiarono tutto il pane e burro del vecchio Gaskin. Poi Hart uscì sul ponte, e le ragazze cominciarono a preoccuparsi del ritorno a casa, con tutta quella nebbia e il resto. Ridendo tutti quanti a crepapancia issarono Hart sul ponte e gli versarono addosso un secchio d’acqua. Quell’acqua del Maine era così fredda che lui se ne venne arrabbiato come un aquilotto, e voleva farla a pugni con Joe. Le ragazze lo calmarono e lo fecero salire in barca, e con lui si allontanarono nella nebbia cantando Tipperary. Joe barcollava anche lui. Mise la testa in un secchio d’acqua, pulì la cabina, gettò a mare le bottiglie, e cominciò a far funzionare regolarmente il clacson. Andassero a quel paese tutti quanti, seguitava
a dirsi, lui non aveva intenzione di fare il santarello per nessuno. Si sentiva in forma, gli ci voleva qualcos’altro da fare che far andare quel maledetto clacson. Il vecchio Gaskin rivenne a giorno quasi fatto. Joe si accorse che aveva subodorato qualcosa, perché da allora in poi non gli rivolgeva più la parola se non per dare ordini, e non permetteva al figlio di rivolgergliela; tanto che, quando ebbero scaricato i blocchi di granito a East New York, Joe chiese la sua paga e si licenziò. Il vecchio Gaskin borbottò che quella era una vera liberazione, e che lui non ne voleva sapere di orge e puttane a bordo della sua barca. E così eccoti Joe con quarantacinque dollari in tasca a spasso per Red Hook in cerca di una pensione. Dopo due giorni passati a leggere inserzioni e a girare per Brooklyn in cerca di un posto, si ammalò. Andò da un medico di cui gli aveva parlato un vecchio cliente della pensione. Il dottore, un ebreo dalla barbetta di capra, gli disse che era gonorrea e che bisognava venire ogni pomeriggio per la cura. Gli disse che lo guariva garantito per cinquanta dollari, pagabili a metà in anticipo, e che gli consigliava di farsi fare la prova del sangue per vedere se aveva anche la sifilide; ciò gli sarebbe costato quindici dollari. Joe sborsò i venticinque ma disse che quanto alla prova del sangue ci avrebbe pensato su. Si fece fare la medicazione e uscì in strada. Il dottore gli aveva raccomandato di camminare il meno possibile, ma a lui non andava proprio a genio di tornare subito a quella fetente pensione, e così si mise a girare senza meta per le chiassose vie di Brooklyn. Era un pomeriggio caldo. Nel camminare, sudava a rivoli. Se gli salti addosso in tempo, il primo o il secondo giorno, non è così grave, continuava a dire tra sé e sé. Sbucò in un ponte sotto la ferrovia soprelevata; doveva essere il ponte di Brooklyn. Sul ponte faceva più fresco. Attraverso la ragnatela dei cavi, le navi e il gruppo di alti edifici si stagliavano scuri sullo scintillio del porto. Joe si mise a sedere sopra una panchina all’altezza del primo pilone e allungò le gambe. Ecco qua, era andato a lavorare e si era buscato quel regalo. Lo assalì una depressione tremenda; adesso che cosa avrebbe scritto a Del? e la pensione da pagare, e il lavoro da trovare e queste
dannate medicazioni da fare. Gesù, che disastro. Si avvicinò un piccolo strillone con un giornale della sera. Lui ne comperò uno e se lo spiegò sul grembo per guardarne i titoli: FATE AFFLUIRE ALTRE TRUPPE AL CONFINE MESSICANO. E che diavolo poteva farci lui? Non poteva nemmeno arruolarsi nella guardia nazionale e andarsene al Messico; se sei malato non ti prendono; e poi, quand’anche l’avessero fatto, sarebbe stata daccapo la solfa della maledetta marina militare. Scorse gli avvisi economici, quelli che ti suggerivano la maniera di arrotondare lo stipendio con due ore di piacevole lavoro a casa di sera, quelli sul pelmanismo e sui corsi per corrispondenza. Che diavolo poteva mai fare lui? Rimase lì seduto finché venne buio. Poi prese il tram per Atlantic Avenue e salì quattro scale per giungere alla stanza dove aveva un lettino sotto la finestra e si ritirò. Quella notte si scatenò un gran temporale. Ci fu un sacco di tuoni e di fulmini vicinissimi. Joe, supino nel suo letto, osservava guizzare sul soffitto i lampi così fulgidi da offuscare le luci dei lampioni. Le molle strepitavano ogni volta che l’occupante dell’altro lettino si rigirava nel sonno. Cominciò a piover dentro, ma Joe si sentiva così debole e malato che gli ci volle un bel po’ per trovare la forza di alzarsi a sedere sul letto e chiudere la finestra. Al mattino la padrona, una grossa svedese ossuta con frange di lino sulla faccia segaligna, gli fece una scenata per il letto bagnato. «Che posso farci io, se piove?» brontolò lui, guardandole i piedoni. Quando poi ne incontrò lo sguardo, si accorse che lei lo stava prendendo in giro, e scoppiarono entrambi a ridere. Era una brava donna, si chiamava Mrs. Olsen e aveva allevato sei bambini, tre maschi ormai adulti che si erano dati alla vita di mare, una ragazza che faceva l’insegnante a St. Paul e un paio di gemelle tra i sette e gli otto anni che si cacciavano sempre nei guai. «Ancora un anno, e le mando da Olga a Milwaukee. Conosco i marinai.» Papà Olsen era rimasto a terra per anni e anni in qualche posto dei mari del Sud. «E tanto vale che se ne stia là. A Brooklyn lo mettevano sempre in guardina. Ogni settimana dovevo tirar fuori i soldi per farlo uscire.» Joe finì per aiutarla nella pulizia domestica e a farle lavori di
verniciatura e falegnameria. Quando rimase al verde essa gli permise di rimanere ancora, e gli prestò persino venticinque dollari per pagare il dottore, quando seppe da lui della malattia. Se lui la ringraziava, gli dava di gran manate sulla schiena: «Tutti i ragazzi ai quali presto soldi finiscono per rivelarsi giusto dei gran lazzaroni» diceva ridendo. Era una gran brava donna. Faceva un tempaccio invernale, pioggia e nevischio. Di mattina Joe stava seduto nella cucina fumosa a studiare un corso di navigazione che si era fatto dare dall’istituto Alexander Hamilton. Il pomeriggio oziava nel disordinato ufficio del medico, acre di disinfettante, in attesa del suo turno, e intanto sfogliava numeri vecchi del «Geographic Magazine», del 1909. Era una squallida accozzaglia, quella che aspettava lì dentro. Nessuno diceva mai gran che agli altri. Un paio di volte gli capitò d’incontrare per strada gente con cui aveva scambiato quattro parole mentre aspettava il suo turno, ma gli passava davanti come se non lo vedesse. Di sera talvolta andava a Manhattan a giocare a dama all’istituto dei Marinai o a girellare per l’Unione dei marinai a raccogliere informazioni circa le navi sulle quali c’era possibilità di trovare imbarco non appena il dottore lo avesse guarito. Momenti svagati, quelli, senonché la signora Olsen era tanto buona con lui, e lui le si affezionò più ancora di quanto avesse fatto con sua madre. Quella maledetta mezza cartuccia di medico cercò di tirarla in lungo con la cura per spillargli altri venticinque dollari, ma Joe lo mandò a quel paese e s’imbarcò come marinaio scelto sopra una nave cisterna nuova di zecca, la Montana, diretta senza carico a Tampico e poi in Oriente, Aden secondo alcuni dei ragazzi di bordo e Bombay secondo altri. Ne aveva abbastanza del freddo e del nevischio e delle sudice strade di Brooklyn e delle tavole di logaritmi del corso di navigazione che non riusciva a ficcarsi in testa, e della voce riprovatrice o incoraggiante della signora Olsen; essa cominciava a comportarsi come se volesse amministrargli lei la vita. Era una gran brava donna, ma era ora di levarsi di torno. Il Montana doppiò Sandy Hook sotto la sferza di una rabbiosa tempesta di neve proveniente da nord-ovest, ma tre giorni dopo si era
in piena corrente del Golfo a sud di Hatteras, con un mare lungo che consolava e tutte le vesti e le camicie appese ad asciugare a corde legate alle sartie. Faceva bene ritrovarsi in mare aperto. Tampico era un postaccio d’inferno; dicevano che il mescal ti dava alla testa se ne bevevi troppo; c’erano grandi sale da ballo piene di messicani che ballavano col cappello e con la pistola al fianco, e bande e organetti di Barberia che andavano a tutto spiano in ogni bar, e risse e ubriachi del Texas, gente che lavorava ai pozzi di petrolio. Le porte di tutte le casette galanti erano aperte, dimodoché si poteva vedere il letto coi guanciali bianchi e l’immagine della Vergine a capo e le lampadine coi paralumi fantasia e l’ornamentazione di carta colorata; le ragazze brune dal viso largo sedevano di fronte all’esterno in sottovesti di pizzo. Ma tutto era così maledettamente caro che tanto per cominciare i marinai spesero tutto il denaro che avevano e dovettero tornarsene a bordo ancor prima di mezzanotte. E le zanzare entravano nel castello di prua, alternandosi alle mosche tropicali che ci venivano di giorno, e faceva un caldo da morire, e nessuno riusciva a prender sonno. Quando le cisterne furono ben riempite, il Montana uscì nel golfo del Messico affrontando una tramontana che risciacquava i ponti e sferzava di spruzzaglia il ponte di comando. A neanche due ore dalla partenza perdettero un uomo, caduto in mare, e un ragazzo di nome Higgins si fracassò un piede per bloccare l’ancora di tribordo che si era sganciata. Giù in castello rimasero tutti molto male quando il capitano non volle calare una scialuppa, benché i più anziani dicessero che con un mare simile nessuna barca poteva resistere. Il capitano si limitò a incrociare in curva larga e prese un paio di ondate sul baglio che per poco non sfondarono i ponti di acciaio. In quel viaggio non vi furono altri incidenti degni di rilievo, senonché una notte Joe, mentre stava al timone e la nave era immersa in un silenzio di tomba rotto soltanto dal gorgoglio irregolare dell’acqua che la prua fendeva puntando a est attraverso il mare lungo, d’un tratto sentì odor di rose o forse caprifoglio. Il cielo era azzurro come una tazza di latte cagliato con un pezzo di luna esangue che riaffiorava di tanto in tanto. Sì, era proprio caprifoglio, e aiole concimate, e fogliame umido, come
quando d’inverno si passa davanti alla porta aperta di un fiorista. Gli infondeva una curiosa sensazione di tenerezza, come se avesse avuto accanto a sé sul ponte una ragazza in carne e ossa, come se ci avesse avuto Del con la capigliatura intrisa di qualche profumo. Curioso, l’odore dei capelli delle brune. Prese il binocolo ma non scorse nulla all’orizzonte, solo la nuvolaglia rappresa che andava alla deriva a occidente nel fioco lume della luna. Vide che stava deviando dalla rotta, per fortuna il secondo non aveva scelto quel momento per controllare la scia a poppa. Rimise la prua a est-nord-est, di ½ a est. Finito il suo turno, quando si fu infilato in cuccetta, rimase sveglio un bel pezzo a pensare a Del. Cielo, lui aveva bisogno di denaro e di un buon posto e di una ragazza sua, e non di tutte quelle puttanelle dei porti. Aveva bisogno di sistemarsi a Norfolk e sposarsi, ecco tutto. L’indomani verso mezzodì avvistarono il grigio pan di zucchero filato che era Pico con una banda di nuvole bianche proprio sotto il picco, e Fayal azzurra e irregolare al Nord. Passarono tra le due isole. Il mare si inazzurrava profondamente; aveva l’odore dei viali di campagna fuori Washington quando c’erano il caprifoglio e il lauro in fiore. I campi a riquadri verdeblu e gialloverde coprivano le ripide colline come una trapunta vecchio stile. Quella notte avvistarono altre isole a est. Cinque giorni di mare grosso, ed ecco lo stretto di Gibilterra. Otto giorni di mare agitato e pioggia fredda, ed ecco la costa egiziana, un caldo mattino di sole, si entrò nel porto di Alessandria verso l’una mentre il banco di nebbia gialla apparso a prua si solidificava in alberi, moli, edifici, palme. Le vie puzzavano di pattumiera, si bevve liquore locale in bar gestiti da greci che erano stati in America e si pagò un dollaro a testa per veder tre ragazze di tipo ebreo ballar nude la danza del ventre in una stanza retrostante. Ad Alessandria si videro le prime navi mimetizzate, tre esploratori inglesi striati come zebre, e un trasporto tutto dipinto a chiazze verdi e blu. Vedendo tutto ciò, i marinai di guardia in coperta si allinearono lungo il parapetto e risero a crepapelle. Quando ricevette la paga a New York, un mese dopo, gli fece tanto bene andare dalla signora Olsen e rimborsarle quanto le doveva. Essa
aveva un altro giovane a pensione, uno svedese dai capelli di lino che non sapeva una parola d’inglese, e così non badò gran che a Joe. Lui si trattenne un po’ in cucina e le domandò come andavano le cose e le parlò della comitiva del Montana, poi andò alla stazione di Pennsylvania per veder di prendere il treno per Washington. Metà nottata la passò tutto insonnolito nello scompartimento fumatori della vettura ordinaria a pensare a Georgetown, e ai tempi della scuola, e alla brigata del bigliardo di 4½ Street e alle gite sul fiume con Alec e Janey. Era un luminoso mattino d’inverno quando scese alla Union Station. Evidentemente non riusciva a decidersi ad andare a Georgetown, dove c’erano i suoi. Bighellonò per la stazione, si pagò una buona sbarbata, una lucidatina alle scarpe e una tazza di caffè, lesse il «Washington Post», contò il suo denaro; aveva ancora più di cinquanta argomenti di ferro, 7 un bel gruzzolo per un tipo come lui. Poi disse a se stesso che la prima cosa da fare era aspettar d’incontrare Janey, forse stando un po’ in giro l’avrebbe vista uscire a mezzogiorno dal lavoro. Girò per i paraggi del Campidoglio e Pennsylvania Avenue, arrivò alla Casa Bianca. Sull’Avenue vide lo stesso ufficio Arruolamenti nel quale si era arruolato in marina. Gli fece quasi accapponar la pelle. Andò a sedersi in Lafayette Square nel sole d’inverno, e lì stette a guardare i giochi dei bimbetti ben vestiti e le balie e i grassi storni saltellanti fra l’erba e la statua di Andrew Jackson, finché non gli parve giunta l’ora di andare a prender Janey. Il cuore gli batteva tanto che non riusciva più a guardar diritto. Doveva essere più tardi di quanto pensasse, perché nessuna delle ragazze che sbucavano dall’ascensore era lei, eppure stette circa un’ora ad aspettare nel vestibolo del Riggs Building sinché un fetente detective o qualcosa del genere gli si avvicinò per chiedergli che diavolo mai cercava da quelle parti. Così dopo tutto gli toccò andare a Georgetown per sapere di Janey. Mamma era a casa con le sorelline, e non facevano che parlare di come avrebbero rimesso la casa a nuovo coi diecimila dollari dell’assicurazione del vecchio, e volevano mandarlo su per Oak Hill a vederne la tomba, ma Joe disse di no, a che scopo farlo?, e se la svignò
al più presto. Lo tempestarono di domande, e che cosa faceva e come gli andava, e lui non sapeva che diavolo rispondere. Gli dissero dove abitava Janey, ma non sapevano che orario d’ufficio avesse. Sostò al Belasco ad acquistare qualche biglietto per il teatro e poi tornò al Riggs Building. Ci arrivò nel momento preciso in cui Janey usciva dall’ascensore. Era elegante e teneva il mento alzato alla spavalda; come le donava! Era così contento di vederla che temette di uscire in un grido. La voce di lei era mutata. Aveva un modo svelto e freddo di parlare e un tono schernevole che lui non conosceva. La invitò a cena e a teatro, e lei gli disse tante cose della sua vita, come si trovava bene da Dreyfus e Carroll e che gente interessante veniva a conoscere. Lui si sentiva un po’ uno sfaccendato vicino a lei. Poi la riaccompagnò all’appartamento ch’essa condivideva con un’amica e prese il tram per tornare alla stazione. Si sistemò nello scompartimento fumatori della vettura ordinaria e si accese un sigaro. Che malinconia. L’indomani a New York andò da un tizio che conosceva e uscirono assieme a far qualche bevuta e a pescarsi qualche sottana, e il giorno seguente si trovò seduto in una panchina in Union Square col mal di testa e neanche il becco di un quattrino in tasca. Cercò le metà dei biglietti della rivista a cui era andato con Janey al Belasco e le ripose accuratamente nella scatola da sigari assieme all’altro ciarpame. Il primo battello sul quale imbarcò era il North Star, diretto a SaintNazaire con un carico registrato come scatolame mentre tutti sapevano che si trattava di munizioni, e indennità speciale all’equipaggio per la zona pericolosa che si doveva attraversare. Era uno strano guscio, aveva fatto servizio sui Grandi Laghi come trasporto minerali, faceva acqua al punto da esigere continuamente lavoro alle pompe, ma a Joe la ciurma era simpatica e il mangiare era proprio buono e il vecchio capitano Perry era il più bel lupo di mare anziano che si potesse immaginare, aveva vissuto a terra per un paio d’anni ad Atlantic Highlands, ma era tornato sulla breccia per via del gran denaro che c’era da fare adesso, a tentar di metterne da parte un bel gruzzolo per la figlia; lei in ogni modo avrebbe riscosso l’assicurazione, diceva lui al secondo con una risatina che era quasi
uno starnuto. Fu una traversata invernale liscia liscia, vento in poppa sino alla baia di Biscaglia. Faceva molto freddo, e il mare era in bonaccia, quando avvistarono la costa francese, bassa e sabbiosa alle foci della Loira. Alzarono la bandiera e segnalarono il nome della nave, e Sparks lavorava fuor di turno, e tutti certo erano inquieti per via delle mine, finché poi giunse la vedetta francese di pattuglia e fece da guida per il tortuoso passaggio tra le mine sino al fiume. Quando videro le guglie e le lunghe file di case grigie e i boschetti di comignoli di Saint-Nazaire nel crepuscolo fumoso, i ragazzi si presero a manate sulla schiena e dissero che quella notte si sarebbero dati alla pazza gioia. Invece andò che si ancorarono fuori, in pieno estuario, e il capitan Perry e il comandante in seconda andarono a riva col galleggiante e non si attraccò che due giorni dopo, perché non c’era posto ai moli. Quando scesero a terra per dare un’occhiata alle mademoiselles e al vin rouge dovettero tutti mostrare i passaporti da marinai, all’atto di lasciare la banchina, a un uomo dalla faccia rossa con un tremendo paio di baffoni neri a punta; aveva una divisa blu orlata di rosso. Blackie Flannagan gli s’era messo carponi alle spalle, e qualcuno stava già per farlo ruzzolare con una spinta quando il capo li avvertì con un grido dall’altra parte della strada: «Perdio, che il diavolo vi fotta, non vedete che è un poliziotto? Non vorrete mica farvi impacchettare addirittura sulla banchina?». Joe e Flannagan si staccarono dagli altri e fecero un giro per la città. Le strade erano pavimentate a selciato, strette e curiose, e le vecchie portavan tutte berretti aderenti di pizzo bianco, e ogni cosa sembrava lì lì per cadere. Persino i cani sembravano cani poliziotti. Finirono per entrare in un posto con l’insegna “American Bar”, ma non aveva nemmeno lontanamente l’aspetto dei bar degli Stati Uniti. Tanto per cominciare comperarono una bottiglia di cognac. Flannagan disse che la città gli ricordava Hoboken, ma Joe disse che somigliava piuttosto a Villefranche, dov’era stato con la marina militare. I dollari americani comperavano parecchio, se si badava bene a non farseli truffare.
Entrò nel locale un altro americano, attaccarono discorso e lui raccontò di essere stato silurato con la Oswego proprio alle foci della Loira. Gli diedero un po’ di cognac e lui descrisse la scena, il sommergibile aveva fatto saltare in aria di colpo la povera Oswego, e quando il fumo si era dissipato la nave era spaccata in due e si ripiegava come un coltello a serramanico. Ci bevvero sopra un’altra bottiglia di cognac, e poi l’amico li portò in un posto che sapeva lui, e lì trovarono altri dell’equipaggio tutti occupati a bere birra e a ballare con le ragazze. Joe si divertiva un mondo a masticar francese con una delle ragazze, lui additava un oggetto e lei gli spiegava come si diceva in francese, quando chissà come si accese una rissa e vennero i poliziotti e tutta quanta la brigata dovette darsela a gambe. Tornarono a bordo lasciando i poliziotti con un palmo di naso, ma quelli si piantarono sulla banchina e blaterarono per mezz’ora buona, sinché il vecchio capitan Perry, che era appena tornato di città in carrozza, li mandò a quel paese. Il viaggio di ritorno fu lento ma liscio. Stettero appena una settimana a Hampton Roads, caricarono lingotti di acciaio e capsule esplosive e salparono per Cardiff. C’era da stare all’erta. Il capitano seguì una rotta settentrionale, e incocciarono banchi di nebbia. Poi, dopo una buona settimana di gelo con mare grosso in favore, avvistarono Rockall. Era al timone Joe. La recluta in coffa gridò: «Nave da guerra a prua», e il vecchio capitan Perry sul ponte di comando scoppiò a ridere guardando lo scoglio al binocolo. Il mattino seguente avvistarono le Ebridi a sud. Capitan Perry stava giusto indicando il Butt of Lewis al secondo quando la vedetta di prua lanciò un allarme spaventato. Era proprio un sommergibile. Se ne poté vedere prima il periscopio con la sua scia di spuma, poi la torretta gocciolante. Il sommergibile era appena emerso, che cominciò a sparare sulle fiancate del North Star con un cannoncino che i boches azionavano mentre ancora il ponte era a fior d’acqua. Joe corse a poppa a inalberare la bandiera, quantunque essa fosse dipinta a metà carena su ambo i fianchi della nave. I campanelli della sala macchine trillarono mentre capitan Perry lanciava il bastimento a poppa a tutto
vapore. I tedeschi smisero di sparare e quattro di loro presero una barchetta smontabile e salirono a bordo. Tutti i membri dell’equipaggio avevano indossato il salvagente, e alcuni stavano scendendo a prendersi il bottino, quando l’ufficiale del Kaiser salito in coperta gridò in inglese che avevano cinque minuti di tempo per abbandonare la nave. Capitan Perry consegnò tutti i documenti, le scialuppe di salvataggio furono calate in un battibaleno perché gli argani erano ben oliati. Qualcosa disse a Joe di tornar di corsa sul ponte delle scialuppe a tagliare le funi delle zattere, dimodoché lui e capitan Perry e il gatto di bordo furono gli ultimi a lasciare la North Star. I tedeschi avevano collocato bombe nella sala macchine, e stavano remando come forsennati per tornare al sommergibile, come avessero avuto il diavolo alle calcagna. La barca del capitano si era appena staccata che lo scoppio li investì di fianco a prua con un gran colpo. La barca si rovesciò, e senza neppur sapere che cosa li avesse colpiti si trovarono immersi nell’acqua diaccia in mezzo a una quantità di assi e rottami. Due delle barche erano ancora a galla. La vecchia North Star affondava con la bandiera al vento e le bandierine di segnalazione garrenti alla brezza leggera. Dovevano essere in acqua da mezz’ora o un’ora. Quando la nave fu scomparsa nell’abisso riuscirono ad agguantare una zattera, e la barca del secondo e quella del capo li presero a rimorchio. Capitan Perry fece l’appello. Non mancava nessuno. Il sommergibile si era immerso e dileguato da qualche tempo. Le scialuppe cominciarono a dirigersi a riva. Sin verso sera la marea le portò con gran forza verso il Pentland Firth. Sullo smorire del crepuscolo scorsero gli alti promontori delle Orcadi. Ma quando la marea cambiò non riuscirono a vincerla. Gli uomini delle barche e quelli delle zattere si avvicendarono ai remi, ma non ce la facevano assolutamente contro il tremendo riflusso. Qualcuno disse che in quel punto la corrente aveva una velocità di otto nodi all’ora. Fu una gran nottataccia. Ai primi albori avvistarono un esploratore diretto alla loro volta. Il suo riflettore li abbagliò di colpo facendo sembrare tutto un’altra volta nero. Gli inglesi li presero a bordo e li ficcarono in sala macchine a riscaldarsi. Uno steward rosso in viso scese con un secchio di tè
fumante al rum e lo servì con un mestolo. L’esploratore li portò a Glasgow, tutti scombussolati dal mare corto delle acque irlandesi, e rimasero lì sulla banchina sotto la pioggerella mentre capitan Perry andava a cercare il console americano. Joe aveva i piedi intirizziti a furia di star fermo, e cercò di passare il cancello di ferro antistante al magazzino per dare un’occhiata alla strada, ma un uomo anziano in divisa gli puntò una baionetta sul ventre costringendolo a fermarsi. Joe tornò nel gruppo e disse che eran prigionieri come se fossero tedeschi. Cristo, se li offese la cosa! Flannagan si mise a raccontare come una volta a Marsiglia poliziotti francesi lo avessero arrestato perché si era azzuffato con un irlandese del Nord in un bar e come fossero stati lì lì per sparargli giusto perché si diceva in giro che gli irlandesi erano tutti filotedeschi. Joe raccontò quello che gli avevano fatto i limonai a Liverpool. Erano tutti intenti a mugugnare sulla maniera indecente in cui andavano le cose, quando il secondo, Ben Tarbell, arrivò con un anziano funzionario del consolato e disse loro di seguirlo. Dovettero sfilare per mezza città lungo vie completamente buie a causa dell’oscuramento antiaereo e viscide di pioggia, sinché giunsero a un lungo baraccone di cartone incatramato posto entro un reticolato. Ben Tarbell disse ai ragazzi che gli spiaceva ma per il momento dovevano rimaner lì: lui stava tentando d’interessare il console alla faccenda, e il vecchio aveva cablografato agli armatori di spedire un po’ di paga. Ragazze della Croce Rossa portarono cibo, per lo più pane e marmellata e pasta di carne, niente di veramente solido da poterci affondare i denti, e alcune coperte leggere. Rimasero in quel postaccio dodici giorni, giocando a poker, raccontandosi storie e leggendo giornali vecchi. Di sera talvolta una donna malconcia e mezzo ubriaca passava sotto il naso della vecchia sentinella, faceva capolino alla porta della baracca e invitava qualcuno di loro nella tenebra nebbiosa in qualche punto dietro le latrine. Alcuni non ci andavano neppure, erano disgustati. Erano rimasti chiusi là dentro così a lungo che quando il secondo finalmente si ripresentò per annunciare che si tornava a casa non ebbero nemmeno la forza di gridare. Riattraversarono la città
congestionata di traffico, illuminata a gas nella nebbia, per salire a bordo di un piroscafo da carico nuovo da 6000 tonnellate, il Vicksburg, che aveva appena scaricato cotone. Che sensazione curiosa fare il passeggero e poter fare tutto il giorno la vita di Michelaccio durante il viaggio di rimpatrio. La prima giornata di sole Joe se ne stava sdraiato sul coperchio del boccaporto quando gli si avvicinò il vecchio capitan Perry. Joe si rizzò in piedi. Capitan Perry disse che non aveva avuto agio di fargli sapere che cosa pensava di lui per la presenza di spirito manifestata col tagliare le funi di quelle zattere, e che metà degli uomini presenti a bordo gli dovevano la vita. Disse che Joe era un ragazzo in gamba e avrebbe dovuto mettersi a studiare la maniera di uscire dal castello di prua e che la marina mercantile americana aumentava di giorno in giorno per via della guerra e i giovanotti come lui erano quelli che ci volevano per la categoria ufficiali. «Ricordati di parlarmene, ragazzo mio,» disse «quando saremo arrivati a Hampton Roads, e io vedrò che cosa si potrà fare sulla prima nave che mi capiterà. Frequentando la scuola a terra, potresti prenderti in poco tempo il tuo diploma di ufficiale in terza.» Joe abbozzò un sorriso e disse che, certo, gli sarebbe piaciuto. La cosa gli diede un senso di benessere per tutto il viaggio. Non stava più nella pelle per la voglia di andare da Del a dirle che non era più nel castello di prua, che non faceva più parte della ciurma. Dio sa se ne aveva fin sopra i capelli di essere trattato come un cane vita natural durante. Il Vicksburg attraccò a Newport News. A Hampton Roads le navi erano così numerose che Joe non ne aveva mai viste tante. Per i moli tutti parlavano del Deutschland, che aveva appena scaricato coloranti a Baltimora. Quando ebbe la sua paga in tasca, Joe non volle neanche fare una bevuta coi compagni di nave, ma si precipitò alla stazione traghetti per andare a Norfolk. Porca miseria, se era lento il vecchio traghetto! Erano a un dipresso le cinque del pomeriggio di sabato quando arrivò a Norfolk. Andando per la via lo prese l’ansia di non essere ancora a casa. Del era in casa e si mostrò contenta di rivederlo. Disse che quella sera aveva un appuntamento, ma lui tanto fece e tanto disse che la
convinse a disdirlo. Dopo tutto, non erano fidanzati? Uscirono insieme e presero un gelato alla macedonia in una gelateria, e lei gli parlò del suo nuovo impiego presso i Dupont, e prendeva dieci dollari in più alla settimana, e i suoi conoscenti, tutti i ragazzi e parecchie ragazze, lavoravano nelle fabbriche di munizioni, e ce n’eran di quelli che guadagnavano quindici dollari al giorno e si comperavano l’automobile, e il ragazzo col quale aveva l’appuntamento per quella sera aveva una Packard. Ci volle gran tempo, a Joe, per arrivare a parlarle di quello che gli aveva detto il vecchio capitan Perry, e lei era tutta emozionata per il siluramento, e perché lui non andava a cercar lavoro nel cantiere a Newport News, dove c’era da far denaro sul serio? Non le garbava affatto l’idea di saperlo silurato da un momento all’altro, ma Joe disse che non ne voleva sapere di lasciare il mare ora che c’era una possibilità di farsi strada. Lei gli domandò quanto avrebbe preso come comandante in terza sopra una nave da carico, e lui disse centoventicinque al mese, ma poi c’erano sempre le indennità di zona e si stava costruendo un mucchio di navi, e a parer suo le prospettive in questo campo erano buone. Del arricciò il viso in un modo buffo e disse che non sapeva se le sarebbe andato a genio un marito sempre assente, però andò in una cabina telefonica e chiamò l’altro per disdire l’appuntamento preso con lui. Tornarono a casa di Del ed essa scaldò una cenetta. I suoi erano andati a pranzare da una zia a Fortress Monroe. Faceva tanto bene a Joe, vederla sfaccendare in cucina con un grembiule indosso. Lei si lasciò baciare due volte, ma quando lui le andò di dietro e l’abbracciò e le arrovesciò il viso per baciarla, disse di non farlo più, perché le faceva mancare il respiro. L’odore oscuro dei suoi capelli e la morbidezza della sua pelle, bianca come il latte, sotto le labbra, gli davano alla testa, lo facevano quasi impazzire. Fu un sollievo uscire ancora nel pungente vento di nord-ovest. Le comperò una scatola di canditi dal droghiere. Andarono a vedere un programma di commedia leggera e film al Colonial. I documentari di guerra belgi erano emozionanti, e Del disse se non era tremendo, e Joe cominciò a parlarle di quello che un conoscente gli aveva detto sulle esperienze occorsegli durante un’incursione aerea su Londra, ma lei non
ascoltava. Quando le diede il bacio di addio in anticamera Joe era eccitatissimo, la strinse in un angolo accanto all’attaccapanni e cercò di ficcarle la mano sotto la gonna, ma lei disse di no, prima bisognava sposarsi, e lui, la bocca sulla bocca, chiese quando si sarebbero sposati, e lei rispose che si sarebbero sposati non appena lui avesse il suo nuovo lavoro. Proprio allora udirono girar la chiave nella toppa vicino a loro, e lei lo tirò in salotto e gli sussurrò di non dire nulla ancora del loro fidanzamento. Era il papà di Del con la mamma e le due sorelline, e il vecchio guardò Joe in tralice, e le sorelline ridacchiarono e Joe se ne andò via imbarazzatissimo, sentendosi preso di mira. Era ancora presto, ma Joe era troppo agitato per poter dormire, e così girellò un poco e poi passò dagli Stirp per vedere se Will era in città. Will era a Baltimora in cerca di lavoro, ma la vecchia signora Stirp disse che se non aveva dove andare e voleva dormire nel letto di Will era benvenuto, però lui non riusciva a prender sonno a furia di pensare a Del, e com’era carina, e che sensazione averla fra le braccia, e come lo stordiva l’odore dei suoi capelli, e come la desiderava. La prima cosa che fece il lunedì mattina fu andare a Newport News a trovare capitan Perry. Il vecchio fu tanto buono con lui, gli domandò della scuola che aveva fatto e della sua famiglia. Quando Joe disse di essere il figlio del vecchio capitano Joe Williams, capitan Perry non sapeva più che cosa fare per lui. Jim e il papà di Joe erano stati assieme sull’Albert and Mary Smith ai bei tempi della navigazione a vela. Disse che c’era un posto per Joe come ufficiale subalterno sulla Henry B. Higginbotham non appena finiti i lavori di riparazione, e lui doveva andare a lavorare alla scuola di Norfolk, prepararsi agli esami di licenza e guadagnarsi il suo bravo diploma. Ci avrebbe pensato lui stesso a istruirlo sui punti importanti. Quando partì il vecchio disse: «Ragazzo mio, se lavorerai a dovere – e ricordati che sei figlio di tanto padre – e questa guerra continua, arriverai a essere capitano del tuo vascello in cinque anni, te lo dico io». Joe non vedeva l’ora di dire tutto a Del. Quella sera la condusse al cinema a vedere I quattro cavalieri dell’Apocalisse. Era proprio
emozionante, si tennero le mani in mano per tutto lo spettacolo e lui premette la gamba contro la tornita gambetta di lei. Veder quella pellicola in compagnia sua, e sullo schermo la guerra e tutto quanto snocciolato a barbagli, e la musica come in chiesa e i suoi capelli contro la guancia, e starle così vicino, sudando un po’ nel buio caldo, gli diede alla testa anzichenò. Quando il film fu terminato egli sentì che ammattiva se non la poteva avere senz’altro. Per via lei lo prese un po’ in giro, e lui si risentì e disse accidenti, o si sposavano subito o lui faceva una brutta fine. Lei lo aveva tenuto a bada abbastanza ormai. Scoppiò a piangere e gli mostrò il viso tutto bagnato di lacrime e disse che se l’avesse amata sul serio non avrebbe parlato così, e non era quello il modo di parlare a una signorina per bene, e lui si sentì tremendamente colpevole. Quando furono tornati a casa di lei, tutti erano andati a dormire, e loro andarono nel ripostiglio dietro la cucina senza accendere la luce, e lei gli lasciò effondere tutto il suo amore. Davvero, disse, lo amava tanto che gli avrebbe lasciato fare tutto quello che voleva, ma dopo lui non l’avrebbe più rispettata. Disse che era stufa di vivere coi suoi, con la madre che la controllava da mane a sera, e il mattino dopo lei avrebbe detto ai suoi che lui aveva avuto un posto come ufficiale di marina mercantile, e bisognava che si sposassero prima della sua partenza, e lui doveva prendersi l’uniforme subito subito. Quando Joe uscì per andare a cercarsi un alloggio, camminava leggero come il vento. Sposarsi così sui due piedi non era stato nei suoi piani, ma caspita, bisognava pur avere una ragazza tutta per sé. Cominciò a lambiccarsi il cervello per trovare le parole con cui informare Janey della cosa, ma poi concluse che a lei non avrebbe fatto piacere, e quindi era meglio non scriverle nulla. Janey era diventata un po’ troppo superbiosa, ma dopo tutto stava riuscendo bene nella vita. E quando lui fosse stato capitano a bordo della sua nave, lei lo avrebbe approvato e ammirato. Quella volta Joe rimase a terra due mesi. Frequentava la scuola ogni giorno, alloggiava all’YMCA e non toccava bicchiere o bigliardo. La paga che si era messo da parte coi due viaggi della North Star bastava giusto giusto. Ogni settimana o giù di lì andava a Norfolk
News a parlare col vecchio capitan Perry, il quale gli diceva che specie di domande gli avrebbe fatto la commissione d’esame e quali documenti gli ci sarebbero voluti. Joe si sentiva piuttosto preoccupato per il suo certificato di marinaio scelto, ma adesso ne aveva un altro, più le buone referenze dei capitani con cui aveva viaggiato. Che diavolo, aveva fatto quattro anni di mare, era ora d’imparare come si fa a dirigere una nave. L’esame lo preoccupava da farci una malattia, ma allorché si trovò davvero al cospetto di quei vecchi uccellacci della commissione vide che il diavolo non era così nero come lo aveva immaginato. Quando ebbe in mano il diploma di ufficiale in terza e lo mostrò a Del, fu una grande soddisfazione per tutti e due. Joe si comperò l’uniforme al primo anticipo di paga. Da quel momento si diede da fare tutto il giorno al bacino di carenaggio per conto del vecchio capitan Perry, che non aveva ancora messo assieme un equipaggio. Poi di sera lavorava a imbiancare la stanzetta da letto con cucina e bagno che aveva preso in affitto per sé e Del come abitazione per i periodi di licenza. La famiglia di Del insistette per il matrimonio religioso, e Will Stirp, che guadagnava quindici dollari al giorno in un cantiere di Baltimora, venne a far da compare. Joe si sentì tremendamente goffo alla cerimonia, e Will Stirp aveva preso whisky e gli puzzava il fiato come una distilleria, e un paio di amici convenuti erano sbronzi, e ciò seccava mortalmente a Del e ai suoi, e per tutta la cerimonia Del fece la sostenuta. Quando fu finita Joe si accorse di essersi sciupato il colletto, e il papà di Del diede la stura a un sacco di frizzi, e le sorelline ridacchiavano tanto nei loro abitini bianchi di organdis che gli veniva voglia di strangolarle. Tornarono a casa Matthews, e tutti erano impacciatissimi ad eccezione di Will Stirp e dei suoi amici, che misero in tavola una bottiglia di whisky e fecero alzare il gomito al vecchio Matthews, il quale passò la misura. La signora Matthews li mise tutti fuori dell’uscio, e tutte le befane del Ladies Aid strabuzzarono gli occhi e dissero: «Te lo saresti mai immaginato?». E Joe e Del partirono in un tassì guidato da uno che lui conosceva, e tutti quanti gettavan loro manciate di riso, e Joe si accorse di avere una scritta di questo tenore: “Sposino novello” attaccata alla coda del vestito, e Del piangeva e piangeva, e quando
arrivarono all’appartamento Del si chiuse nel bagno e non rispondeva quando lui la chiamava, e lui temeva che fosse svenuta. Joe si tolse l’abito nuovo di sergia, colletto e cravatta, e si mise a camminar su e giù senza saper che fare. Erano le sei di sera. Doveva essere a bordo per mezzanotte, perché all’alba si salpava per la Francia. Non sapeva proprio che fare. Gli venne in mente che forse lei aveva bisogno di mangiare, e le scaldò un po’ di uova e lardo sul fornello. Quando ormai era tutto freddo e Joe camminava su e giù imprecando a bassa voce tra i denti, Del uscì dal bagno fresca come una rosa, come se nulla fosse. Disse che non aveva voglia di mangiare, perché non andiamo al cinema invece?… «Ma tesoro» disse Joe «io devo partire alle dodici.» Lei si rimise a piangere, e lui si sentì tutto scombussolato e mortificato. Lei gli sgattaiolò vicino e disse: «Vuol dire che non vedremo tutto il programma. Torneremo in tempo». Lui l’afferrò e cominciò a stringersela, ma lei lo respinse risolutamente dicendo: «Dopo». Joe non riuscì assolutamente a fare attenzione alla pellicola. Quando rientrarono erano le dieci in punto. Lei si lasciò svestire, ma poi saltò in letto e si avvolse nelle coperte piagnucolando che non voleva avere bambini, e lui doveva aspettare che lei avesse trovato il modo di prevenire tale inconveniente. Tutto quello che gli lasciò fare fu di soffregarlesi contro attraverso le coperte, e poi d’un tratto furono le dodici meno dieci e lui dovette vestirsi a precipizio e correre al molo. Un vecchio negro lo portò in barca sin dove la sua nave stava alla fonda. Era un’odorosa notte di primavera senza luna. Sentì in alto il grido dell’oca selvatica e cercò di aguzzar gli occhi per veder profilarsi gli uccelli contro le pallide stelle. «Sono oche, padrone» disse il vecchio negro con voce dolce. Quando si fu issato a bordo, tutti presero a canzonarlo e dichiararono che aveva l’aria esaurita. Joe non sapeva che dire, e così fece lo spaccone, ribatté le canzonature e mentì spudoratamente. 1. In americano lime-juicer, da lime juice, la limonina, che è di prescrizione come antiscorbutico sulle navi inglesi. Termine spregiativo usato per designare navi o persone inglesi; anche limey. (NdT)
2. Il cinese parla un inglese scolastico e imparaticcio, in punta di forchetta. Questa sfumatura, messa in evidenza dall’autore, va riprodotta. (NdT) 3. In inglese: “piccolino”. (NdT) 4. “Maria Nera”: gergo per “vettura carceraria”. (NdT) 5. Il pitcher è il giocatore che, nella squadra di baseball, ha il compito di passare la palla. (NdT) 6. Lime-juicer è usato col valore di “inglese”; ma per rendere in qualche modo il colore vivace del testo, che si rifà al gergo dei marinai americani, traduco come sopra. (NdT) 7. Mi prendo la libertà d’inventare questa espressione per rendere in qualche modo il senso e il colorito dell’espressione americana iron men, letteralmente “uomini di ferro”, dollari. (NdT)
Cine-giornale XXI Addio Broadway salve Francia siamo dieci milioni BAMBINO DI OTTO ANNI UCCISO DA UN RAGAZZO COL FUCILE la polizia ci ha già notificato che tutte le riunioni a scopo di divertimento a Parigi debbono essere brevi e calme e non esposte al pubblico, e che abbiamo già tenuto più balli del dovuto la capitalizzazione aumenta del 140% mentre il volume degli affari sale al 520% I TEDESCHI PERDONO IL CONTROLLO DELLO ZUCCHERO HAWAIANO gli sforzi fatti dal governo bolscevico per concordare il ritiro delle truppe statunitensi e alleate dalla Russia durante le trattative di armistizio non riscuotono seria considerazione UN AVIATORE BRITANNICO AFFRONTA SESSANTA NEMICI I serbi avanzano di dieci miglia; occupano 10 città; minacciano Prilep Buongiorno Mister Zip Zip Zip sei davvero irresistibile buongiorno Mister Zip Zip Zip coi capelli corti come coi capelli corti come coi capelli corti come i miei LENIN SAREBBE VIVO Il pubblico plaudente, commosso fino alle lacrime dalla cerimonia delle decorazioni al valore all’ippodromo ho avuto da fonte attendibile vari particolari sulla enorme brutalità di Hindenburg; sono troppo atroci per poter essere pubblicati. Si tratta di donne e fanciulle oltraggiate, del suicidio e del sangue di innocenti che bagna i piedi di Hindenburg
LA GUERRA DIMINUISCE MATRIMONI E NASCITE Oh cenere a cenere e polvere a polvere se lo shrapnel non ti becca ti becca l’ottantotto
Occhio fotografico (29) le gocce di pioggia cadono a una a una dall’ippocastano sul pergolato sulla tavola e la ghiaia fangosa nella birreria giardino abbandonata e il mio cranio rasato dove le mie dita si muovono delicatamente passando e ripassando sulle bozze e sulle cavità pelose primavera e abbiamo appena fatto una nuotata nella Marna lontano in qualche punto di là dalle nuvole obese all’orizzonte stanno martellando sopra un tetto di latta nella pioggia nella primavera dopo una nuotata nella Marna con quel martellamento a nord che ci inculca nelle orecchie il pensiero della morte il pensiero vinoso della morte punge nel sangue primaverile che pulsa nel collo adusto su e giù per il ventre sotto la cinta stretta mi affluisce rapido come cognac alle dita dei piedi e ai lobi delle orecchie e alle dita che carezzano il cranio rasato coperto di peluria dita timide pulsanti scoprono i confini del duro cranio immortale sotto la carne un teschio con gli occhiali, uno scheletro intero siede nel pergolato sotto le lucide gocce intermittenti dentro la divisa kaki nuova dentro il mio corpo ventunenne che ha nuotato nella Marna in calzoncini striati rosso-blu a Châlons in primavera
Richard Ellsworth Savage Da piccolo, Dick non aveva mai sentito parlare del babbo, ma la sera quando faceva i compiti su nella stanzetta all’ultimo piano gli veniva fatto di pensarci; si buttava sul letto e vi rimaneva supino tentando di ricordarsi della sua prima infanzia, di Oak Park e di tutto com’era prima che la mamma fosse colpita da tutta quell’infelicità e loro due fossero costretti a venire a est dalla zia Beatrice. Ecco l’odore di rum al lauro e di sigaro, e lui sedeva sulla spalliera di un divano imbottito accanto a un omone in paglietta che quando rideva faceva traballare tutto il divano; lui si aggrappava al dorso di Papà e lo colpiva coi pugnetti sul braccio e il muscolo era duro come una sedia o un tavolo e quando Papà rideva gli faceva tremare la schiena, «Dicky, non sporcarmi coi piedi il vestito estivo», e lui camminava a quattro gambe nel sole che filtrava dalle tendine di merletto della finestra, e cercava di cogliere dal tappeto le grandi rose purpuree; stavano tutti davanti a un’automobile rossa e Papà aveva la faccia rossa e sentiva di ascelle e tutt’intorno si alzava un fumo bianco, e la gente diceva Valvola di sicurezza. Dabbasso Papà e Mammà erano a pranzo e c’era compagnia e vino e un nuovo maggiordomo e doveva essere divertentissimo perché ridevano tanto e i coltelli e le forchette facevano continuamente clic clic; Papà lo colse in flagrante che spiava dai cortinaggi, in pigiama, e uscì tremendamente buffo ed agitato, odorava di vino, e lo picchiò, e Mammà venne anche lei e disse: «Henry, non battere il bambino», e stettero lì a sibilarsi qualcosa rabbiosamente a bassa voce dietro i cortinaggi per via degli invitati, e Mammà aveva preso Dick e lo aveva portato di sopra piangendo nel suo abito da sera tutto pizzi e sbuffi e grandi maniche rigonfie di seta; il contatto della seta lo innervosiva, gli mandava brividi giù per la spina dorsale. Lui e Henry avevano soprabiti bruni con le tasche, come quelli degli adulti, e berretti bruni, e lui aveva perso il bottone posto in cima al suo. Da quelle parti c’era sole e vento; Dick si sentiva cogliere dalla stanchezza e da una specie di malessere quando si sforzava di riandare così il passato, al punto da impedirgli di concentrare la mente sulle lezioni dell’indomani, e allora lui tirava
fuori Ventimila leghe sotto i mari, che teneva sotto il materasso perché la mamma gli portava via i libri quando non erano di scuola, e ne leggeva un po’, ma bastava per fargli dimenticare tutto il resto, e così a furia di leggere non imparava le lezioni per il giorno dopo. Con tutto ciò riusciva bene a scuola, e gli insegnanti lo avevano in simpatia, specialmente Miss Teazle, la professoressa d’inglese, perché aveva bei modi e diceva cosette non tanto nuove ma spiritose. Miss Teazle diceva che lui mostrava una spiccata tendenza alla composizione inglese. Un Natale le mandò una poesiola da lui composta su Gesù Bambino e i Re Magi, e lei dichiarò che aveva buone capacità. Più gli piaceva la scuola, peggio si trovava a casa. Zia Beatrice non faceva che rimbrotti da mattina a sera. Come se lui non lo sapesse, che lui e la mamma mangiavano il suo pane e dormivano sotto il suo tetto; pagavano la pensione però, nevvero? Anche se non pagavano quanto il maggiore Glen e signora o il dottor Kern; ma in ogni modo compensavano ampiamente col lavoro che facevano. Un giorno che era venuto a far visita il dottor Atwood e zia Beatrice era fuori città, aveva sentito la signora Glen dire quale vergogna fosse che la povera signora Savage, una donna così ammodo e tanto religiosa, figlia com’era di un generale dell’esercito, dovesse lavorare come una negra per la sorella, che era soltanto una vecchia zitella pedante e si faceva pagar salato, quantunque in fondo tenesse molto bene la pensione e facesse ottimamente da mangiare, anzi, non pareva nemmeno una pensione, ma piuttosto una famiglia molto chic, una vera fortuna trovarla a Trenton, città commerciale così piena di lavoratori e forestieri; peccato davvero che le figlie del generale Ellsworth si fossero ridotte a tener pensione. Dick avrebbe voluto che la signora Glen dicesse qualcosa anche dei servizi che faceva lui, come portar fuori la cenere e di tanto in tanto spalare. Comunque secondo lui uno studente di scuola media superiore non avrebbe dovuto sottrarre il suo tempo agli studi per accudire alle faccenduole domestiche. Il dottor Atwood era il rettore della chiesa episcopale di St. Gabriel, dove Dick doveva cantare nel coro due volte ogni domenica mentre la mamma e il fratello Henry S., che aveva tre anni più di lui e
lavorava in un ufficio Reclutamento a Filadelfia e veniva a casa solo ogni fine settimana, stavano comodamente seduti in un banco. Alla mamma piaceva tanto St. Gabriel perché lì c’era tradizione di Chiesa Alta 1 e facevano processioni e usavano perfino incenso. A Dick stava sullo stomaco per via dei cori e del camice da tener pulito, e perché gli mancavano sempre i soldi per giocare a dadi dietro il banco in sagrestia, e lui era sempre quello che doveva star sulla porta e bisbigliare «Occhio alla penna» se veniva qualcuno. Una domenica, subito dopo il suo tredicesimo compleanno, era tornato a casa con la mamma dopo il servizio, e Henry aveva fame e per tutta la strada non aveva fatto altro che chiedersi se a pranzo c’era pollo fritto. Stavano tutti e tre varcando la soglia, con la mamma che si appoggiava un po’ al braccio di Dick e i papaveri purpurei e verdi del suo cappellino che giocherellavano nel sole di ottobre, quando lui vide il viso sottile di zia Beatrice comparire preoccupato dietro la porta a vetri dell’ingresso principale. «Leona,» diceva con voce agitata in tono di rimprovero «c’è qui lui.» «Chi, Beatrice cara?» «Ma lo sai meglio di me… Io non so che fare… dice che vuol vederti. L’ho fatto aspettare nell’atrio inferiore per via dei… ehm… dei nostri amici.» «Santo Cielo, Beatrice, ma non ne ho già sopportate abbastanza da quell’uomo?» La mamma si lasciò cadere sulla panca sotto l’attaccapanni a corna di cervo nell’atrio. Dick e Henry spalancavano tanto d’occhi sui volti sbiancati delle due donne. Zia Beatrice arricciò le labbra e disse in tono sdegnoso: «Voi ragazzi fareste meglio a uscire e fare un giro qui attorno. Io non posso aver tra i piedi qui per casa due pezzi di quarantotto così con niente da fare. Tornate per l’ora di pranzo, all’una e mezza in punto… e adesso filate». «Oh bella, ma che cos’ha zia Beatrice?» domandò Dick mentre s’incamminavano per la strada. «Ha la bua, poverina… oh che pena mi fa» disse Henry in tono ironico. Dick continuò a camminare abbozzando calci al selciato. «A proposito, potremmo andare a prendere una bibita al selz… ne hanno di ottime da Dryer.» «Hai moneta?»
Dick scosse la testa. «Be’, non penserai che te l’offrirò io, alle volte?… Corbezzoli, Trenton è una città che non vale una cicca… A Filadelfia ho visto una spezieria con un banco di mescita lungo mezzo miglio.» «Addirittura!» «Scommetto che tu non ti ricordi di quando abitavamo a Oak Park, Dick… Adesso Chicago è una bella città.» «Invece sì che mi ricordo… e tu ed io andavamo al kindergarden, e c’era Papà, e tutto quanto.» «Diavolo cane, ho voglia di fumare.» «Mamma ti sentirà il fiato.» «Non me ne importa un fico.» Quando tornarono a casa zia Beatrice andò loro incontro sull’ingresso principale con un’aria da cane bastonato, e disse loro di scendere nel seminterrato. Mammà aveva qualcosa da dir loro. Le scale del retro odoravano di pranzo domenicale e ripieno di pollo alla salvia. Scesero con la massima lentezza possibile, doveva trattarsi di Henry e del suo vizio di fumare. Lei era nel buio atrio del seminterrato. Dalla luce che la fiamma a gas gettava sul muro Dick non riusciva a capire chi fosse l’uomo. Mammà venne loro incontro, ed essi videro che aveva gli occhi rossi. «Ragazzi, è vostro padre» disse con voce flebile. E il volto le si coprì di lacrime. L’uomo aveva la testa grigia e informe, coi capelli molto corti, le palpebre rosse e senza ciglia e gli occhi dello stesso colore del viso. Dick si spaventò. Era qualcuno che aveva conosciuto da piccolo; non poteva essere Papà. «Per grazia di Dio, basta con le cateratte, Leona» disse l’uomo con voce lamentosa. Come scrutava il volto dei ragazzi il corpo gli vacillò un poco, quasi fosse debole di ginocchi. «Son due bei pezzi di ragazzi, Leona… Scommetto che non hanno una grande opinione del loro povero vecchio papà.» Stettero tutti lì senza una parola nel buio atrio del seminterrato, nel ricco odore di pranzo domenicale che fiottava dalla cucina. Dick sentì che doveva dir qualcosa, ma aveva un groppo alla gola. Uscì a balbettare: «Se… se… sei… sei stato malato?». L’uomo si rivolse a Mammà: «È meglio che tu li metta al corrente
di tutto quando me ne sarò andato… non risparmiarmi… nessuno mi ha mai risparmiato… Non guardatemi come se fossi uno spettro, ragazzi, non vi farò del male». Un tremito di riso nervoso gli scosse la parte inferiore del volto. «Per tutta la vita sono sempre stato io a subire mortificazioni… Be’, qui siamo molto lontani da Oak Park… io volevo soltanto vedervi, addio… Scommetto che i tipi come me è bene escano dalla porta di servizio… Ti aspetto alla banca alle undici precise, Leona, e sarà l’ultima volta che dovrai disturbarti per me.» La fiamma a gas si arrossò quando la porta si aprì inondando l’atrio di riverbero solare. Dick tremava per la paura che quell’uomo lo baciasse, ma tutto quanto egli fece fu di dare a entrambi i ragazzi un colpetto tremolante sulla spalla. Il vestito gli era largo e floscio, e parve che gli riuscisse faticosissimo portare i piedi con le loro molli scarpe sformate su per i cinque gradini sino alla strada. Mammà chiuse la porta con un colpo secco. «Va a Cuba» disse «ed è l’ultima volta che lo vediamo. Spero che Iddio gli possa perdonare tutto, la vostra povera mamma non potrà mai… almeno è uscito da quel posto orribile.» «Dov’era, mamma?» domandò Henry con voce disinvolta da uomo d’affari. «Atlanta.» Dick corse via sino all’ultimo piano, entrò nella sua stanzetta e si buttò sul letto singhiozzando. Nessuno di loro scese a mangiare, benché avessero fame e le scale fossero ricche dell’odor di pollo arrosto. Mentre Pearl lavava i piatti, Dick entrò di soppiatto in cucina e la convinse a dargli un piattone di pollo ripieno e patate dolci; lei gli disse di filar via e andare a mangiarlo nel cortile del retro, perché la sua giornata di lavoro era finita e aveva i piatti da lavare. Lui andò a sedersi sopra una scala polverosa nel lavatoio, e si mise a mangiare. Faceva una fatica dell’altro mondo a mandar giù il pollo, per via dello strano groppo che aveva in gola. Quand’ebbe finito, Pearl si fece aiutare da lui ad asciugare i piatti. Quell’estate gli trovarono posto come cameriere addetto alle stanze in un alberghetto di Bay Head, gestito da una signora della parrocchia del dottor Atwood. Prima che partisse, il maggiore Glen e la sua signora, che erano i pensionanti più cospicui di zia Beatrice, gli
diedero un biglietto da cinque dollari come argent de poche, e una copia del Little Shepherd of Kingdom Come da leggere in treno. Il dottor Atwood gli chiese di fermarsi dopo il catechismo per l’ultima domenica e gli raccontò la parabola del talento, che Dick conosceva benissimo perché il dottor Atwood ci faceva sopra una predica almeno quattro volte l’anno, e gli mostrò una lettera del rettore di Kent con la quale si dichiarava di accettarlo come borsista per l’anno prossimo, e gli disse di lavorar sodo perché Iddio si aspettava da ciascuno di noi un rendimento proporzionato alle nostre capacità. Poi gli disse qualcosetta che un adolescente deve pur sapere, e che lui doveva evitare le tentazioni e servir sempre Iddio con mente e corpo mondi, e tenersi puro per la dolce fanciulla che un giorno avrebbe sposata, e il resto portava soltanto alla pazzia e alle malattie. Dick ascoltò tutto quanto e se ne andò con le guance in fiamme. Al Bayview non c’era poi male, ma gli ospiti e il personale eran tutti vecchi; della sua età c’era soltanto Skinny Murray, l’altro cameriere addetto alle stanze, un ragazzo alto dai capelli color sabbia che non sapeva spiccicare una parola. Aveva un paio d’anni più di Dick. Dormivano in due brandine in una stanzetta senz’aria proprio sotto il tetto; ci faceva ancora così caldo all’ora di andare a letto, con tutto il sole che riceveva di giorno, che loro ci stavano il meno possibile. Di là dalla sottile parete divisoria si sentivano le cameriere nella stanza attigua muoversi attorno e ridere quando andavano a letto. Dick non poteva soffrire quel rumore e l’odore delle ragazze misto a odor di cipria da poco prezzo che filtrava dalle crepe del muro. Nelle notti più torride lui e Skinny toglievano dalla finestra la schermatura e strisciando per la grondaia si portavano a una specie di terrazzino che sovrastava a uno dei portici superiori. Là erano tormentati dalle zanzare, ma era cento volte meglio che non l’insonnia nelle loro brandine. Una volta le ragazze, trovandosi affacciate alla finestra, li videro strisciare lungo la grondaia e fecero un gran chiasso, vociando che loro avevano visto tutto e l’avrebbero detto alla direttrice, e i due presero uno spavento da morire e passarono la notte a concertarsi sul da fare in caso di licenziamento. Sarebbero andati a Barnegat a lavorare sui pescherecci; ma il giorno dopo le ragazze non
dissero niente della cosa. Per Dick fu un disappunto, perché a lui dava tremendamente fastidio servire la gente e correr su e giù per le scale alle chiamate di campanello. Fu Skinny ad aver l’idea di procurarsi qualche soldo extra vendendo i canditi alla cioccolata, perché quando Dick ne ricevette un pacco dalla mamma lo vendé a una cameriera per un quarto di dollaro. Così ogni settimana la signora Savage mandava un pacco di candito fresco alla cioccolata o al latte con le noci, e Dick e Skinny lo vendevano agli ospiti in scatolette. Skinny comperava le scatole e faceva il più del lavoro, ma Dick lo persuase che non sarebbe stato onesto prendersi più del dieci per cento sui proventi, perché erano lui e sua madre a fornire il capitale iniziale. L’estate successiva organizzarono la vendita del candito in grande stile. Il lavoro era più che mai sulle spalle di Skinny, in quanto Dick era stato a una scuola privata e tutt’inverno aveva fatto comunella con figli di ricconi. Fortunatamente nessuno di loro venne a Bay Head a passar l’estate. Lui parlò a Skinny della scuola e gli recitò ballate su san Giovanni Ospitaliero e san Cristoforo, composte da lui, che erano state pubblicate nel giornale della scuola; gli parlò del servizio all’altare e della bellezza della fede cristiana e come avesse fatto l’outfield 2 nella squadra del penultimo anno. Dick tanto fece e tanto disse che si portò appresso ogni domenica Skinny nella cappelletta episcopale detta Santa Maria al Mare. Dick soleva fermarsi dopo il servizio divino per discutere questioni di dottrina e liturgia col signor Thurlow, il giovane pastore appena uscito dal seminario teologico, che finì con l’invitarlo a pranzo e presentargli la moglie. I Thurlow abitavano in un villino dal tetto spiovente, non intonacato, situato in mezzo a un terreno sabbioso presso la stazione. La signora Thurlow era una morettina dal naso aquilino sottile e coi capelli a frangetta; fumava sigarette e non poteva soffrire Bay Head. Diceva sempre com’era scocciata e com’era fatta apposta per scandalizzare le vecchie parrocchiane di riguardo, e intanto Dick diceva a se stesso che era una donna meravigliosa. Era lettrice appassionata dello «Smart Set» e del «Black Cat», nonché di libri che chiamava progressisti, e si burlava dei tentativi fatti da Edwin per
«rimettere il cristianesimo nelle spiagge», come diceva lei. Edwin Thurlow la guardava di sotto le ciglia scolorite di quei suoi occhi pallidi e sussurrava dimesso: «Hilda, non dovresti parlare così»; poi si volgeva dolcemente a Dick e diceva: «Can che abbaia non morde, sai». Diventarono amicissimi e Dick prese a frequentar casa loro ogniqualvolta riusciva a svignarsela dall’albergo. Portò con sé Skinny una volta o due, ma a quanto pareva la conversazione era troppo elevata per lui, che infatti non si fermava mai a lungo ma si toglieva garbatamente di mezzo adducendo il motivo dei canditi da vendere. L’estate successiva la speranza di vedere i Thurlow fece accettare di buon grado a Dick l’idea di rimanere al Bayview a lavorare; la signora Higgins poi gli aveva conferito la mansione di ispettore delle camere con un aumento di paga, in grazia delle sue maniere signorili. Dick aveva sedici anni e stava mutando voce; sognava di combinar certe cose con le ragazze e faceva un gran pensare al peccato, e aveva un rancore segreto per Spike Culbertson, il capitano della sua squadra a scuola, un biondo dai capelli di paglia. Aveva in odio tutto ciò che riguardava la sua vita, la zia e l’odore della sua pensione, il pensiero del padre, i cappellini della mamma con tutti quei fiori, l’eterna mancanza di denaro che gli impediva di comperarsi abiti buoni o andare come gli altri in luoghi di villeggiatura eleganti. Ogni cosa lo metteva tremendamente in agitazione, tanto da rendergli ben arduo il mascherarla. L’ondeggiare delle anche e dei seni delle cameriere quando servivano in tavola, la biancheria delle ragazze nelle vetrine, l’odore delle cabine ai bagni e l’odore salso e pungente di un costume bagnato e la pelle abbronzata dei giovanotti e delle ragazze in costume da bagno, lunghi distesi sulla spiaggia al sole. Tutt’inverno aveva scritto lettere a Edwin e Hilda su tutto ciò che gli passava per la testa, però quando li vide in persona si sentì goffo e imbarazzato. Hilda usava un nuovo profumo che gli solleticava il naso; anche quando sedeva a tavola con loro a colazione, mangiando prosciutto freddo e insalata di patate comperati in salumeria e parlando di litanie primitive e musica gregoriana, non poteva fare a meno di svestirli mentalmente, pensandoli nudi nel letto; e allora lo vinceva una sensazione indescrivibilmente odiosa.
La domenica pomeriggio Edwin andava ad Elberon a dirigere il servizio divino in un’altra cappelletta estiva. Hilda non ci andava mai e sovente invitava Dick a fare una passeggiata con lei o a prendere il tè in casa sua. Lui cominciò a desiderare queste assenze di Edwin, che erano tante occasioni di stare a tu per tu con Hilda. Cominciarono ad avere tra loro due un piccolo mondo in cui Edwin non c’entrava per nulla, un mondo dal quale parlavano di lui solo per prenderlo in giro. Dick cominciò a vedere Hilda in quei suoi sogni strani e orrendi. Hilda cominciò a dire come lei e Dick fossero veramente fratello e sorella, come la gente apatica che non aveva mai un effettivo desiderio di alcuna cosa non potesse capire gente del loro stampo. In quelle occasioni Dick non aveva gran che da dire. Lui e Hilda sedevano sull’uscio del retro a fumare Egyptian Deities fino a sentirsi un po’ male. Hilda diceva che non le importava un fico se i parrocchiani della malora la vedevano o meno, e parlava e parlava, del suo profondo desiderio che qualcosa avvenisse nella sua vita, desiderio di abiti eleganti, viaggi all’estero, denaro da spendere ed emancipazione dalle noiose incombenze di massaia, e diceva come alle volte le capitasse di sentirsi capace di uccidere Edwin per quella sua aria dolce da vitello. Edwin di solito tornava col treno delle 10.53 e Dick, siccome la domenica sera era libero dal lavoro, cenava solo con Hilda e poi faceva con lei una passeggiatina sulla spiaggia. Hilda lo prendeva per il braccio e gli si teneva vicina; lui si chiedeva se per caso essa non tremava a ogni contatto di gambe. Per tutta la settimana non faceva che pensare a quelle sere domenicali. A volte si riprometteva di non andarci più a cominciare dalla prossima domenica. Sarebbe rimasto nella sua stanza a leggere Dumas oppure sarebbe uscito a spasso con qualche conoscente; stare a tu per tu con Hilda in quel modo gli procurava troppo abbattimento, dopo. Poi, una notte senza luna – avevano fatto quattro passi lungo la spiaggia spingendosi oltre i fuochi rosei dei gitanti, e sedevano a fianco a fianco sulla sabbia parlando delle India’s Love Lyrics che Hilda aveva lette ad alta voce quel pomeriggio – lei d’improvviso gli balzò addosso, gli arruffò i capelli, gli ficcò le ginocchia nello stomaco e cominciò a passargli le mani sul corpo sotto la camicia. Era forte per
essere una ragazza, ma lui era appena riuscito a respingerla che dovette afferrarla per le spalle e tirarsela giù da sopra di sé. Nessuno dei due disse nulla, ma giacquero nella sabbia col respiro affannoso. Alfine ella sussurrò: «Dick, io non devo mettere al mondo bambini… non possiamo permettercelo… ecco perché Edwin non vuole dormire con me. Diavolo, io ti voglio, Dick. Non vedi che situazione spaventosa?». Mentre così parlava, le sue mani lo ardevano carezzandogli il petto, le costole, la curva del ventre. «No, Hilda, no.» Avevano zanzare attorno alla testa. Il lungo fruscio invisibile della risacca giungeva quasi a lambir loro i piedi. Quella notte Dick non si sentì di andare incontro a Edwin alla stazione, come faceva di solito. Tornò al Bayview con le ginocchia tremanti, e si buttò sul letto nella stanzetta soffocante posta sotto il tetto. Pensò al suicidio, ma aveva paura di andare all’Inferno; tentò di pregare, di ricordare almeno la Preghiera del Signore. Lo prese una tremenda paura quando si accorse di non riuscir neppure a ricordare la Preghiera del Signore. Forse era a causa del peccato contro lo Spirito Santo che loro due avevano commesso. Il cielo ingrigiava ormai e gli uccelli cinguettavano quando egli s’addormentò. Tutto il giorno successivo, mentre sedeva con gli occhi fondi al banco inoltrando le richieste d’acqua ghiacciata e asciugamani che gli ospiti gli rivolgevano, rispondendo a domande sulle stanze e gli orari dei treni, rimuginava entro di sé una poesia sul mio peccato scarlatto e il tuo peccato scarlatto e gli uccelli neri che stridono sui marosi infuriati e le anime dannate effuse in sospiri cocenti. Quando fu terminata, mostrò la poesia ai Thurlow; Edwin dal canto suo voleva sapere dove fosse andato a pescare certe idee morbose, ma si rallegrava che in fondo trionfassero la fede e la Chiesa. Hilda rise istericamente e disse che era un ragazzo curioso, ma forse un giorno sarebbe diventato uno scrittore. Quando Skinny venne per una vacanza di due settimane a prendere il posto di uno dei nuovi camerieri che era malato, Dick fece un po’ lo spaccone con lui a proposito di donne e peccati e disse come stesse facendo all’amore con una donna sposata. Skinny disse che non stava bene perché c’era in giro un mucchio di donne facili disposte a
darti tutto l’amore che vuoi. Ma quando Dick scoprì che l’altro non era mai stato con una ragazza, benché di due anni più anziano, cominciò a darsi tante arie in fatto di esperienza e peccato che una sera, essendo scesi entrambi dal farmacista a prendere un soda, Skinny fermò un paio di ragazze, e i due se le portarono a spasso per la spiaggia. Le ragazze avevano trentacinque anni suonati, non uno di meno, e Dick non fece altro che dire alla sua del suo amore sfortunato e come lui dovesse rimaner fedele al suo amore anche se questo gli era infedele in quel momento stesso. Lei disse che lui era troppo giovane per prender le cose sul serio a quel modo, ed era una vergogna che una donna rendesse infelice un ragazzo simpatico come lui. «Gesù, io sì che farei felice un uomo se mi capitasse l’occasione!» disse scoppiando a piangere. Tornando al Bayview, Skinny era preoccupato dal timore di aver preso qualcosa, ma Dick disse che la materia non contava e che il pentimento era la chiave della redenzione. Andò poi che Skinny s’ammalò sul serio, perché più avanti in quell’estate stessa scrisse a Dick che pagava un dottore cinque dollari la settimana per farsi guarire, e che era una umiliazione tremenda. Dick e Hilda continuarono a peccare le sere di domenica mentre Edwin dirigeva il servizio divino a Elberon, e quando Dick tornò a scuola quell’autunno si sentì uomo di mondo. Nelle vacanze natalizie andò dai Thurlow a East Orange, dove Edwin era assistente del rettore della chiesa di San Giovanni Apostolo. Colà, al tè del rettore, conobbe Hiram Halsey Cooper, un avvocato e politico di Jersey City che si interessava di Chiesa Alta e prime edizioni di Huysmans, e invitò Dick a casa sua. Quando Dick ci andò, il signor Cooper gli offrì un bicchierino di sherry, gli mostrò edizioni originali di Beardsley e Huysmans ed Austin Dobson, sospirò sulla propria giovinezza perduta e gli offrì un posto nel suo ufficio per quando avesse terminato la scuola. Risultò che la defunta moglie del signor Cooper era una Ellsworth, cugina della madre di Dick. Dick gli promise di mandargli copie di tutte le sue poesie e gli articoli pubblicati nel giornale della scuola. Tutta la settimana che trascorse coi Thurlow cercò di trovarsi con Hilda a quattr’occhi, ma lei fece in modo di evitarlo. Lui aveva sentito
parlare dei preservativi e voleva parlargliene, ma fu soltanto all’ultimo giorno che Edwin dovette uscire per visite parrocchiali. Stavolta fu Dick a prendere l’iniziativa e Hilda a tenerlo a bada, ma poi la fece svestire, e risero assieme per la gioia e la malizia nel fare all’amore. Stavolta non si preoccuparono gran che del peccato, e quando Edwin tornò per cena domandò di che scherzo si trattasse, tanto erano di buonumore. Dick attaccò a raccontare storielle dell’altro mondo, inventate di sana pianta, su zia Beatrice e i suoi pensionanti, e finirono per lasciarsi alla stazione tra un’ilarità sfrenata. Quell’estate fu la convenzione di Baltimora. Il signor Cooper aveva preso in affitto una casa in quella città e aveva molti clienti. La mansione di Dick consisteva nello stare in segreteria, esser gentile con tutti, e prendere i nomi della gente. Portava un abito di sergia turchina e faceva buona impressione a tutti con quei capelli neri ondulati che Hilda soleva dirgli erano un’ala di corvo, quegli ingenui occhi azzurri e quella carnagione bianca e rosea. Di che si trattasse in verità non sapeva, le cose si svolgevano un po’ all’infuori del suo raggio d’azione, ma ci mise poco a capire quale fosse la gente che il signor Cooper desiderava effettivamente vedere e quale invece dovesse essere semplicemente presa in giro menando il can per l’aia. Poi, quando rimanevano loro due soli, il signor Cooper tirava fuori una bottiglia di Amontillado e ne versava un bicchiere ad entrambi, sedeva in una grossa poltrona di cuoio fregandosi la fronte come per cacciarsi di testa la politica e si metteva a parlare di letteratura, dei tempi del Novanta, di quanto avrebbe desiderato ritornar giovane. S’era d’accordo che lui avrebbe anticipato a Dick il denaro necessario a seguire e completare i corsi di Harvard. Dick era appena tornato a scuola come anziano l’autunno seguente, che ricevette un telegramma dalla madre: “Vieni subito a casa tesoro povero papà morto”. Non provò dolore ma una sorta di vergogna, un timore d’incontrare insegnanti o compagni, che avrebbero potuto fargli domande. Alla stazione pareva che il treno non venisse mai. Era sabato, e c’erano due suoi compagni di classe alla stazione. Finché venne il treno egli non pensò ad altro che ad evitarli. Stette lì rigido seduto al suo posto nella vettura vuota, a osservare le
rossicce colline d’ottobre, abbottonato e risoluto a non attaccar discorso. Fu un sollievo uscire dalla Grand Central Station nelle affollate vie di New York, dove nessuno conosceva lui e lui non conosceva nessuno. Durante il traghetto si sentì felice e in clima d’avventura. Cominciò a temere la stessa idea di rimetter piede a casa, e lasciò partire intenzionalmente il primo treno per Trenton. Andò nella vecchia sala da pranzo della stazione di Pennsylvania e prese per colazione ostriche fritte e grano dolce, ordinando un bicchiere di sherry; con una bizzarra paura che il cameriere negro non lo volesse servire. Rimase lì seduto un bel po’ a leggere «The Smart Set» e a bere lo sherry, sentendosi uomo di mondo e viaggiatore autonomo, ma sotto sotto c’era il ricordo del volto bianco e tremante di quell’uomo, della maniera in cui aveva ripassato i gradini della porta di servizio, quel giorno. Il ristorante a poco a poco si vuotò. Il cameriere certo pensava che era buffo da parte sua rimaner seduto lì tanto tempo. Pagò il conto e senza rendersene chiaramente ragione si trovò sul treno di Trenton. Nella casa di zia Beatrice tutto aveva lo stesso aspetto e lo stesso odore di una volta. La mamma stava sdraiata sul letto con le gelosie abbassate e un fazzoletto imbevuto d’acqua di colonia sulla fronte. Gli mostrò una foto che il babbo aveva mandato dall’Avana: un uomo risecchito che pareva troppo mingherlino nel vestito estivo con la paglietta di panama. Aveva lavorato al consolato come impiegato e lasciava un’assicurazione sulla vita di diecimila dollari in favore di lei. Mentre parlavano entrò Henry, tutto afflitto e preoccupato. Se ne andarono loro due nel cortiletto retrostante a fumare. Henry disse che avrebbe portato la mamma con sé a Filadelfia, per sottrarla alle seccature di zia Beatrice e a quella dannata pensione. Voleva che venisse anche Dick e frequentasse l’università di Filadelfia. Dick disse di no, lui andava a Harvard. Henry gli chiese dove si sarebbe procurato il denaro necessario. Dick rispose che si sarebbe arrangiato benissimo da sé, non voleva un soldo della maledetta assicurazione. Henry disse che per quanto riguardava lui non si sognava di toccarla, era della mamma, e così entrambi risalirono le scale con una gran voglia di prendersi a cazzotti. Però Dick si sentiva meglio, ora poteva
dire ai compagni di scuola che suo padre era stato console all’Avana ed era morto di febbre tropicale. Quell’estate Dick lavorò dal signor Cooper per 25 dollari la settimana stendendo i piani e i preventivi per un museo d’arte che Cooper voleva fondare a Jersey City, e gli fece tanto piacere dedicandogli una traduzione in versi della poesia oraziana su Mecenate da lui elaborata con l’aiuto di un bigino, e il signor Cooper gli fece un dono di mille dollari per gli studi universitari; per questione di tatto e per far sentire a Dick le sue responsabilità, lo fece sotto forma di credito quinquennale al quattro per cento. Dick trascorse le sue due settimane di vacanza a Bay Head coi Thurlow. Non stava più nella pelle per la voglia di vedere Hilda, ma poi constatò che tutto era cambiato. Edwin non aveva più quel pallore ascetico di una volta; era stato nominato assistente in una ricca chiesa di Long Island, dove la sola cosa a preoccuparlo era il fatto che parte della sua congregazione apparteneva alla Chiesa Bassa e non voleva canti né incenso. Lui però si consolava pensando che gli permettevano di tenere candele sull’altare. Anche Hilda era mutata. Dick constatò con dispiacere che lei e il marito si tenevano per mano durante la cena. Quando rimasero soli un momento lei gli disse che era molto felice con Edwin ora, e stava per avere un bambino, ed era meglio mettere una pietra sul passato. Dick si mise a camminare su e giù ficcandosi le mani nei capelli, e a parlare amaramente di morte e Inferno scatenato sulla faccia della terra e di andarsene al diavolo al più presto possibile, ma Hilda gli fece una bella risata in faccia e gli disse di non fare lo sciocco, lui era un bel ragazzo e avrebbe avuto un sacco di belle ragazze disposte a far pazzie per lui. Prima di partire Dick s’intrattenne lungamente con gli ospiti sulla religione, e lanciando occhiate amare a Hilda dichiarò di aver perso la fede e di credere soltanto in Pan e in Bacco, i vecchi dèi del piacere e del vino. Edwin trasecolò, ma Hilda disse che erano stupidaggini, in una parola, crisi dell’adolescenza. Dopo la partenza egli scrisse una poesia oscurissima piena di riferimenti classici che intitolò “A una comune prostituta”, e la mandò a Hilda aggiungendovi come poscritto che lui stava consacrando la vita alla Bellezza e al Peccato.
Dick doveva sostenere l’esame di geometria, da ripetersi perché fallito nella sessione primaverile, e quello del corso superiore di latino, che voleva dare per ottenere crediti extra, cosicché andò a Cambridge una settimana prima dell’apertura del collegio universitario. Spedì baule e bagagli dalla South Station per mezzo della compagnia trasporti, e proseguì in metropolitana. Indossava un abito grigio nuovo e un cappello nuovo di feltro grigio, e temeva di perdere l’assegno vistato che aveva in tasca e doveva adoperare per versare un deposito alla banca. Il colpo d’occhio di Boston rosso mattone e il palazzo del Governo con la sua cupola d’oro dietro il Charles d’ardesia gli fecero venire in mente quei luoghi all’estero che lui e Hilda avevano fantasticato di visitare: il treno sbucava all’aria aperta in quel momento per attraversare il ponte. Kendall Square… Central Square… Harvard Square. Il treno non proseguiva; bisognava scendere. Il cartello indicatore al cancello d’entrata, recante la scritta “Al Cortile del collegio”, non si sa perché gli fece venire i brividi sulla schiena. Gli bastarono due ore di Cambridge per accorgersi che il suo cappello di feltro avrebbe dovuto essere bruno e vecchio, altro che nuovo, e che prendersi una stanza nel Cortile era un grave errore per una matricola. Forse fu in conseguenza del fatto di abitare nel Cortile che Dick venne a conoscere proprio tutta la gente meno indicata, un paio di ebrei socialisti del primo anno di legge, uno studente diplomato del Middle West che doveva laurearsi in filosofia con una tesi in gotico, un membro dell’YMCA, di Dorchester che andava in chiesa ogni mattina. Si presentò agli allenamenti di voga per matricole, ma non fu preso in nessun equipaggio e allora si mise a remare per conto suo in sandolino tre pomeriggi alla settimana. I tipi che incontrava giù al noleggio barche gli riuscivano abbastanza simpatici, ma per la maggior parte abitavano in Costa d’Oro o a Beck, 3 e così la conversazione con loro si esauriva con un «Come va?» e un «Arrivederci». Partecipava a tutte le riunioni di calcio, alle serate per fumatori e a quelle per bevitori di birra, ma non poteva mai andarci senza uno dei due amici ebrei o uno studente diplomato, dimodoché non ebbe mai occasione di farvi la conoscenza di qualcuno che
contasse realmente. Un mattino di domenica, in primavera, si imbatté in Freddy Wigglesworth all’Unione nel momento preciso in cui stavano tutt’e due entrando a far colazione; sedettero allo stesso tavolo. Freddy, vecchia conoscenza di Kent, era ora al penultimo anno. S’informò sull’attività e sulle conoscenze di Dick, e ne apparve sconcertatissimo. «Ragazzo mio,» disse «adesso non ti resta aperta che la via del “Monthly” o dell’“Advocate”… Non credo che “Crime” farebbe per te, vero?» «Ci avevo pensato a far vedere un po’ della mia roba in giro, ma non ne avevo il coraggio.» «Ma perché non sei venuto da me l’autunno scorso?… Ma, santo Dio, sarà la vecchia scuola a metterti sulla buona carreggiata. Non ti ha detto nessuno che nel Cortile ci abitano soltanto quelli dell’ultimo anno?» E Freddy scoteva tristemente il capo nel sorseggiare il suo caffè. Dopo andarono in camera di Dick, che lesse ad alta voce qualcuna delle sue poesie. «Be’, non c’è male, mi sembra» disse Freddy Wigglesworth tra una boccata e l’altra di sigaretta. «Sono un po’ letterarie, però… Fammene dattilografare qualcuna e io le farò avere al rettore… Trovati all’Unione alle otto in punto la sera di lunedì venturo, che andremo insieme da Copey… Be’, ciao, devo andare.» Quando se ne fu andato, Dick passeggiò su e giù per la stanza, col cuore che gli saltava in gola. Aveva una gran voglia di parlare con qualcuno, ma ne aveva abbastanza di tutti quelli che conosceva a Cambridge, e così sedette e scrisse a Hilda e a Edwin una lunga lettera con intermezzi in rima informandoli della sua brillante vita universitaria. Finalmente giunse la sera di lunedì. Già tentando di convincersi a non provare disappunto per un’eventuale dimenticanza di Freddy Wigglesworth, Dick si diresse all’Unione con un’ora buona di anticipo. Il cicaleccio cavernoso e l’odore del Mem, 4 le barzellette di quegli storditi che erano al suo tavolo e la testa calva e sudata del signor Kanrich emergente sugli ottoni dell’orchestrina in galleria, ispiravano quella sera una particolare sensazione di noia. C’erano
tulipani nei lindi giardini di Cambridge, e di tanto in tanto un fiato di lillà nel vento. A Dick davano fastidio i vestiti; gli pesavano le gambe nel girare per quei caseggiati gialli coi cortiletti erbosi che conosceva già tanto bene. Il martellamento del sangue nelle vene gli pareva troppo rapido e ardente per essere sopportabile. Se non usciva presto dal complesso di Cambridge diventava matto. Naturalmente, alle otto precise, quando salì lentamente la gradinata dell’Unione, Wigglesworth non era ancora venuto. Dick salì in biblioteca e prese un libro, ma era troppo nervoso per leggerne anche soltanto il titolo. Ridiscese al pianterreno e girellò per la sala. Gli si avvicinò un compagno, suo vicino di banco nel primo laboratorio di fisica, e attaccò discorso su qualcosa, ma Dick non riuscì a smozzicare una risposta. Il compagno gli diede un’occhiata perplessa e si allontanò. Erano le otto e venti. Certo che non veniva, Dio lo stramaledicesse, e che stupido era stato lui ad aspettarlo, come se uno snob incancrenito dello stampo di Wigglesworth potesse venire a un appuntamento con un compagno come lui. Freddy Wigglesworth gli stava davanti con le mani in tasca. «Be’, si va da Copey?» gli stava dicendo. C’era con lui un altro compagno, un ragazzo dall’aria di sognatore con capelli biondi e vaporosi e occhi azzurri chiarissimi. Dick non poteva fare a meno di osservarlo, era così avvenente. «Questo è Blake, è mio fratello minore… Siete dello stesso corso.» Blake Wigglesworth guardò Dick solo di sfuggita quando si strinsero la mano, ma la bocca gli si contrasse in un sorriso da una parte sola. Quando attraversarono il Cortile nel giovane crepuscolo estivo, gli studenti si affacciavano dalle finestre gridando «Rinehart oh Rinehart», e gli storni strepitavano negli olmi, e si sentivano stridere le ruote dei tram da Massachusetts Avenue, ma c’era assoluto silenzio nella stanza dal soffitto basso, illuminata a candele, dove un ometto male in arnese leggeva ad alta voce un racconto che si seppe poi essere L’uomo che voleva essere re di Kipling. Tutti stavano seduti sul pavimento e ascoltavano con la massima attenzione. Dick decise entro di sé che avrebbe fatto lo scrittore. Al secondo anno di università, Dick e Blake Wigglesworth
cominciarono a girare assieme. Dick aveva una stanza nella zona Ridgely, e Blake era sempre da lui. Dick d’un tratto si accorse di amare la vita universitaria; e che il tempo volava. L’«Advocate» e il «Monthly» gli pubblicarono una poesia ciascuno quell’inverno; lui e Ned, come chiamava Blake Wigglesworth, prendevano il tè e conversavano su opere e poeti durante il pomeriggio e accendevano candele per illuminare la stanza. Non mangiavano quasi più al Mem, benché Dick fosse iscritto lì. Dick si trovò senza soldi in tasca quand’ebbe pagato pensione, insegnamento e camera, ma Ned aveva un assegno piuttosto generoso che bastava ai bisogni di entrambi. I Wigglesworth stavano bene; invitarono spesso Dick a Nahant per il pranzo della domenica. Il padre di Ned era un critico d’arte a riposo e aveva una barba bianca alla Van Dyck; nel tinello c’era un caminetto di marmo all’italiana con sopra appeso un dipinto raffigurante una madonna e due angeli con gigli che i Wigglesworth ritenevano di Botticelli, sebbene Blake, per pura cattiveria stando alla signora Wigglesworth, insistesse nell’attribuirlo a Botticini. Ogni sabato sera Dick e Ned presero a cenare al Thorndike a Boston, regalandosi anche un po’ di spumeggiante nebiolo in bottiglia. Poi andavano al teatro o all’Old Howard. L’estate successiva Hiram Halsey Cooper faceva campagne elettorali per Wilson. Ad onta delle lettere sarcastiche di Ned, Dick a un certo punto si trovò preso fino al collo dagli slogan come “Libertà nuova”, “Troppo orgogliosi per combattere”, “Neutralità a parole e a fatti”, “Armonia industriale fra capitale e lavoro”, e per dodici ore al giorno dattilografava articoli, incoraggiava i direttori dei giornali di provincia a dedicare più spazio ai discorsi del signor Cooper, che bollavano il Privilegio e mettevano alla gogna gli Interessi. Fu un vero ristoro tornare agli olmi moribondi del Cortile, lezioni che non peroravano e non attaccavano nessuna causa, edizioni originali di Beardsley e La collina dei sogni e il tè del pomeriggio. Aveva ottenuto una borsa di studio dal dipartimento inglese, e lui e Ned avevano una stanza in due in una casa che dava su Garden Street. Avevano un bel gruppetto di amici che si interessavano di letteratura, arti belle e cose del genere, e così si trovavano tutti nella loro stanza a pomeriggio
inoltrato e ci rimanevano sino a tarda notte alla luce delle candele tra il fumo delle sigarette e l’incenso avvolgentesi attorno a un budda di bronzo che Ned aveva comperato nel quartiere cinese in un momento di ubriachezza, bevevano il tè, mangiavano torte e chiacchieravano. Ned non diceva mai nulla ammenoché il discorso non venisse ad aggirarsi sul bere o sui velieri; ogniqualvolta si tirava in ballo la politica o la guerra o altra roba del genere, aveva un modo tutto suo di chiudere gli occhi e arrovesciare il capo dicendo Blahblahblahblah. Il giorno delle elezioni Dick era così emozionato che marinò tutte le lezioni. Nel pomeriggio lui e Ned fecero una passeggiata dalle parti di North End spingendosi fino all’estremità del molo T. Era un giorno grigio e rigido. Parlavano di un certo piano tutto loro, del quale non facevano mai cenno in presenza degli altri, che consisteva nell’impossessarsi di una yole o di una tartana dopo la laurea e seguire la costa giù giù sino alla Florida e alle Indie Occidentali passando poi per il canale di Panama per entrare nel Pacifico. Ned aveva comperato un libro sulla navigazione e prese a studiarlo. Quel pomeriggio Ned era urtato, perché Dick non riusciva a rimanere in argomento di navigazione a vela e continuava a porsi ad alta voce il problema di come avrebbero votato lo Stato tale e tal altro. Mangiarono immusoniti al Venice, che una volta tanto era affollato, una cena a base di scaloppine fredde e spaghetti; il servizio era disperante. Appena terminato un fiasco di Orvieto bianco, Ned ne ordinava un altro; uscirono dal ristorante a passi rigidi e attenti, appoggiandosi un poco l’uno all’altro. Facce disincarnate turbinavano loro accanto sullo sfondo rosa e oro di Hanover Street. Si trovarono un bel momento sul Common ai margini della folla che osservava il bollettino affisso alla sede del «Boston Herald». «Chi vince? Forza che vinciamo!… Evviva i nostri!» continuava a strillare Ned. «Ma siete così ignorante da non sapere nemmeno che è la sera delle elezioni?» disse storcendo la bocca un uomo alle loro spalle. «Blahblahblahblah» gli ragliò in faccia Ned. Dick dovette tirarlo via di lì e portarlo fra gli alberi per evitare una cazzottatura. «Se continui su questo tono finiremo per buscarle» gli sussurrava preoccupato Dick all’orecchio. «E poi io voglio vedere i
risultati. Wilson potrebbe vincere.» «Urrà… andiamo da Frank Locke e beviamoci sopra.» Dick voleva rimaner lì con la folla a vedere i risultati; era emozionato e non aveva più voglia di bere. «Sai, si tratta di non fare la guerra.» «Meglio farla invece,» disse Ned farfugliando un po’ «è così divertente… ma guerra o no, facciamoci sopra una bevutina.» Il barista di Frank Locke non volle servirli, benché li conoscesse da un pezzo, e loro si erano avviati mogi mogi per Washington Street in cerca di un altro bar quando videro passare di corsa un ragazzo con un cartellone extra a lettere nere di quattro pollici: HUGHES ELETTO. «Urrà!» strillò Ned. Dick gli mise una mano sulla bocca, e tra loro due si accese una zuffa lì in mezzo alla via mentre un crocchio di uomini ostili si andava raccogliendo attorno. Dick ne sentiva le voci piatte e nemiche: «Ragazzi dell’università… uomini di Harvard». Gli cadde il cappello. Ned mollò la presa per lasciarglielo raccogliere. Un vigile si stava facendo strada a gomitate tra la folla per venire da loro. Si raddrizzarono e se ne andarono via composti, col viso congestionato. «Tutto blahblahblahblah» bisbigliò Ned tra i denti. Si diressero a Scollay Square. Dick era offeso. Non gli andavano a genio neanche gli sguardi della folla di Scollay Square, e voleva tornare a Cambridge, ma Ned attaccò discorso con un tipo losco e con un marinaio malfermo sulle gambe. «Ehi Chub, portiamoli da Mamma Bly» disse il tipo losco dando una gomitata nel fianco al marinaio. «Calma, amico, calma» continuava a borbottare incerto il marinaio. «Ma sì; andiamo dovunque non ci sia tutto questo blahblahblahblah» gridava Ned oscillando da una gamba all’altra. «Ehi Ned, tu sei ubriaco, torna con me a Cambridge» lo supplicò Dick parlandogli all’orecchio con accento disperato e tirandolo per il braccio. «Vogliono ubriacarti e portarti via il tuo denaro.» «Non possono ubriacarmi, ubriaco lo sono già… blahblahblahblah» nitrì Ned, e intanto prese il berretto bianco del marinaio mettendoselo in testa al posto del proprio. «Be’, fa’ come diavolo ti pare, io me ne vado.» Dick lasciò andare
di colpo il braccio di Ned e si allontanò a passo rapidissimo. Segui Beacon Hill, con le orecchie che gli ronzavano, la testa in fiamme e il cuore palpitante di rabbia. Andò a piedi sino a Cambridge e si ritirò nella sua stanza pieno di brividi e di stanchezza, quasi sul punto di scoppiare a piangere. Si mise a letto, ma non c’era verso di dormire; vi giacque tutta notte in preda al freddo e allo sconforto, ascoltando ogni rumore della strada, e non giovò a nulla mettersi anche lo scendiletto sopra le coperte. La mattina si alzò col mal di testa e un’aspra sensazione di esausta arsura che lo pervadeva. Stava prendendo un po’ di caffè con un sandwich abbrustolito al banco situato al pianterreno del Lampoon Building, quando entrò Ned fresco come una rosa con la bocca torta in un sorriso. «Be’, mio giovane politicante, è stato eletto il professor Wilson, e per noi militaristi è una bella sconfitta: la puntata sul partito della sciabola e delle spalline è andata a vuoto.» Dick grugnì e continuò a mangiare. «Io ero in pensiero per te,» proseguì Ned con un’aria leggera che tirava gli schiaffi «dove sei sparito?» «E cosa credi che abbia fatto? Me ne son venuto a casa a dormire» rispose rabbioso Dick. «Quel Barney poi era un tipo divertentissimo, è allenatore di pugilato, e se non fosse debole di cuore sarebbe campione dei medioleggeri del New England. Siamo andati a finire in un bagno turco… che posto curioso!» A Dick venne voglia di prenderlo a schiaffi. «Ho laboratorio stamattina» disse roco, uscendo dal locale. Quando ritornò a Ridgely era ormai il crepuscolo. C’era qualcuno nella stanza. Era Ned che si aggirava nella stanza immersa nel crepuscolo azzurro. «Dick» prese a mormorare non appena la porta gli si fu chiusa alle spalle «non prendertela così.» Stava in mezzo alla stanza con le mani in tasca, dondolandosi sui tacchi. «Non prendertela, Dick, per quello che si fa quando si è bevuto… Non prendertela mai per quello che si fa noi compagni. Fa’ il bravo compagno e preparami una tazza di tè.» Dick riempì il pentolino e vi accese sotto la spiritiera. «Uno studente ha da fare un mucchio di corbellerie, Dick.» «Ma gente come quella… andar a pescare un marinaio in Scollay Square… è così maledettamente rischioso!» disse lui debolmente.
Ned si rivolse a lui ridendo disinvolto e felice: «E pensare che tu non ti stancavi mai di darmi dello snob; dannato snob di Backbay, dicevi». Dick non rispose. Si era adagiato nella poltrona accanto al tavolo. Stava facendo del suo meglio per non piangere. Ned si era sdraiato sul letto e stava sollevando prima una gamba e poi l’altra sulla propria testa. Dick rimase seduto a fissare l’azzurra fiamma alcoolica del fornello sinché il crepuscolo non si estinse nell’oscurità, e la luce cinerea della strada cominciò a filtrare nella stanza. Quell’inverno non passò sera che Ned non fosse ubriaco. Dick redigeva il «Monthly» e l’«Advocate», aveva poesie ripubblicate nel «Literary Digest» e nel «Conning Tower», frequentava riunioni della Boston Poetry Society ed era invitato a pranzo da Amy Lowell. Aveva sempre da discutere con Ned perché lui era pacifista e Ned invece diceva che, diavolo, personalmente andava in marina, e in ogni modo era tutto Blah. Nelle vacanze di Pasqua, dopo l’approvazione della legge sull’armamento delle navi, Dick ebbe un lungo colloquio col signor Cooper, che voleva procurargli un posto a Washington, perché secondo lui un ragazzo di tanto ingegno non doveva pregiudicarsi la carriera andando nell’esercito, e si parlava già di coscrizione. Dick arrossì molto opportunamente e disse che sarebbe stato certo contro la sua coscienza dare qualsiasi contributo alla guerra. Parlarono un bel po’, senza concludere nulla, di doveri verso lo Stato, responsabilità dei capipartito ed estremo frangente. Alla fine il signor Cooper gli fece promettere di non compiere alcun passo importante senza prima consultarsi con lui. A Cambridge, quando ci ritornò, tutti facevano esercitazioni militari e frequentavano conferenze sull’arte della guerra. Dick doveva terminare in tre anni il suo corso quadriennale e aveva da lavorar sodo, ma i corsi universitari non gli dicevano più nulla ormai. Trovò tuttavia il tempo di limare una serie di sonetti intitolata “Morituri te salutant”, e la mandò a un concorso indetto dal «Literary Digest». Vinse il premio, ma gli editori gli scrissero che avrebbero preferito una nota di speranza nell’ultima sestina. Dick inserì la nota di speranza e mandò i cento dollari alla mamma per il
trasferimento ad Atlantic City. Venne a sapere che se prestava un servizio d’importanza bellica poteva laurearsi quella primavera stessa senza fare esami, e un giorno senza dir nulla a nessuno andò a Boston e si iscrisse al servizio volontario d’ambulanza. La notte in cui disse a Ned che andava in Francia, presero entrambi una solenne sbornia di Orvieto in camera loro, e fecero un gran parlare di quello che era il fato della Giovinezza, della Bellezza, dell’Amore e dell’Amicizia: venir maciullati da una morte prematura mentre i vecchi imbecilli grassi e pieni di sussiego avrebbero fatto baldoria sulle loro carcasse. Il mattino presto uscirono e si misero a sedere con l’ultima bottiglia nel cimitero, sopra una delle lapidi vecchie, sull’angolo di Harvard Square, e dopo ogni sorsata arrovesciarono il capo belando all’unisono Blahblahblahblah. Salpare per la Francia di 1° giugno sul Chicago fu come dover interrompere un libro all’improvviso. Ned, la mamma, il signor Cooper, la signora letterata assai più anziana di lui con la quale aveva dormito piuttosto scomodamente nell’appartamento a due piani di Central Park South, e la sua poesia e i suoi amici pacifisti e le luci dell’Esplanade tremolanti di riflesso nel Charles, gli sbiadivano nella mente come capitoli di un romanzo incompiuto. Soffriva un poco il mal di mare, e lo sgomentavano alquanto la nave, la folla rumorosa e le allampanate crocerossine che si facevano venire la pelle d’oca raccontandosi storie di bambini belgi infilzati, ufficiali canadesi crocifissi e vecchie monache violentate; interiormente lui era tutto raggomitolato, compresso come una molla d’orologio caricato al limite massimo, dall’ansia di sapere che cosa lo aspettava sull’altra riva dell’Atlantico. Bordeaux, la rossa Garonna, le vie color pastello fiancheggiate da vecchie case alte coi tetti a mansarda, sole e ombra così delicatamente blu e giallo, i nomi delle stazioni tutti presi da Shakespeare, i romanzi con le copertine gialle nelle librerie, le bottiglie di vino nelle buvettes, eran qualcosa che non s’era mai immaginato. Lungo tutto il percorso fino a Parigi i campi di un fioco verdazzurro ardevano costellati di papaveri scarlatti come i primi versi di una poesia; il trenino sussultava a ritmo di dattili; tutto pareva ridursi in rima.
Quando arrivarono a Parigi era troppo tardi per presentarsi all’ufficio Norton-Harjes. Dick lasciò il bagaglio nella stanza che gli avevano assegnata in comune con due camerati all’Hôtel Mont Thabor, e uscì con loro a far quattro passi. Non era ancora buio. Non c’era quasi più traffico, ma i boulevards eran pieni di gente a spasso nell’azzurro crepuscolo di giugno. Come si fece più scuro, donne si protesero da dietro gli alberi verso di loro, mani di ragazze li afferrarono per le braccia, qua e là una sozza parola inglese scoppiò come un uovo scagliato sulla cantilena nasale del francese. Passeggiavano tutti e tre a braccetto, un po’ spaventati e molto all’erta, le orecchie ancor rintronate dalla predica impartita loro la sera prima a bordo della nave da un ufficiale medico sui pericoli di contrarre infezioni luetiche o gonorroiche. Tornarono presto all’albergo. Ed Schuyler, che conosceva il francese per essere stato in collegio in Svizzera, crollò il capo nel pulirsi i denti al lavabo e sputacchiò attraverso lo spazzolino: «C’est la guerre». «Be’, i primi cinque anni saranno i più duri» disse Dick ridendo. Fred Summers era un meccanico automobilista del Kansas. Era seduto sul letto, vestito solo della sua biancheria di lana. «Amici,» disse girando gli occhi solennemente dall’uno all’altro «questa non è una guerra… È un puttanaio, che Dio lo spacchi!» Al mattino s’alzarono di buon’ora e dopo aver trangugiato in fretta e furia il caffè coi panini si precipitarono in rue François Premier a rapporto, sconvolti dall’emozione. Ricevettero le indicazioni del caso sul posto dove ritirare la divisa e furono ammoniti a tenersi alla larga dal vino e dalle donne, con l’ordine di ripresentarsi nel pomeriggio. Nel pomeriggio ebbero l’ordine di tornare il mattino per le tessere di riconoscimento. Le tessere di riconoscimento significarono un’altra giornata persa. Nel frattempo fecero una bella scarrozzata per il Bois, andarono a vedere Notre-Dame e la Conciergerie e la Sainte-Chapelle, e presero il tram per la Malmaison. Dick stava dando una spolveratina al suo francese da scuola media e sedeva al sole mite fra le consunte statue bianche delle Tuileries a leggere L’Île des pingouins e Les Dieux ont soif. Lui, Ed Schuyler e Fred stavano sempre assieme, e, dopo essersi concessi ogni sera pranzi luculliani per il timore che fosse ogni
volta l’ultima occasione di fare un pasto a Parigi, facevano un giretto per i boulevards nell’affollato crepuscolo bleu horizon; adesso erano arrivati al punto di attaccar discorso con le ragazze e prenderle un po’ in giro. Fred Summers si era comperato una scatola di preservativi e disinfettanti e una serie di fotografie pornografiche. Diceva che la sera prima della partenza lui aveva intenzione di darsi alla pazza gioia. Una volta al fronte poteva lasciarci la pelle, e allora? Dick disse che gli piaceva parlare con le ragazze, ma che la faccenda in sé era troppo commerciale e gli rivoltava lo stomaco. Ed Schuyler, cui avevano ormai appioppato il nomignolo di Frenchie, francesino, e che stava acquistando maniere piuttosto continentali, disse che le ragazze di strada erano troppo ingenue. L’ultima notte fu luna piena, e così vennero i Gotha. Loro tre stavano mangiando in un ristorantino di Montmartre. La cassiera e il cameriere li fecero scender tutti in cantina quando le sirene ulularono per la seconda volta. Laggiù fecero la conoscenza di tre donne piuttosto giovani, Suzette, Minette e Annette. Quando passò la piccola autopompa ad annunciare col suo rauco verso la fine dell’incursione, era già ora di chiudere e non fu più possibile andare al bar; e così le ragazze li condussero in una casa dalle imposte ermeticamente chiuse dove furono fatti entrare in una vasta stanza tappezzata di carta color fegato a rose verdi. Un vecchio con un grembiale di sergia verde portò lo champagne, e le ragazze cominciarono a sedersi sulle ginocchia dei tre amici e a far le gattine. Summers si prese la più carina e la cacciò diritto filato nell’alcova, dov’era il letto con un grande specchio sopra che correva per l’intera sua larghezza. Poi tirò le tendine. Dick ebbe quella più vecchia e grassa, e si disgustò. La donna aveva una carne di gomma. Le regalò dieci franchi e se ne andò. Seguendo a passo lestissimo la buia strada in pendio lì fuori, s’imbatté in alcuni ufficiali australiani che gli offrirono una sorsata di whisky da una bottiglia e lo portarono in un’altra casa di prostituzione dove cercarono di far allestire uno spettacolo, ma la maîtresse disse che le ragazze erano troppo occupate, e gli australiani erano comunque troppo bevuti per fare attenzione e presero a buttar per aria tutto quanto. Dick riuscì a svignarsela poco prima che
arrivassero i gendarmi. Era diretto all’albergo quando ci fu un altro allarme aereo e lui si vide sospingere in un sotterraneo della metropolitana da una frotta di belgi. Laggiù c’era una ragazza molto carina, e Dick stava tentando di spiegarle che avrebbe dovuto venire all’albergo con lui, quando si fece avanti il suo accompagnatore, un colonnello degli spahis con un gran mantello rosso ricamato d’oro, fremendo di furia sin nei mustacchi incerati. Dick spiegò che era un equivoco, e tutt’intorno fu uno scambio di scuse, e furono tutti braves alliés. Girarono parecchi isolati in cerca di qualche posto ove fare una bevuta assieme, ma era tutto chiuso, e così si separarono con rammarico sulla porta dell’albergo di Dick. Lui salì in camera di ottimo umore; e qui trovò gli altri due un po’ immusoniti, intenti ad applicarsi argirolo e pasta Mecˇnikov. Dick le sballò grosse sulle avventure della serata. Ma gli altri due gli dissero che era stato un bel villanzone a offendere in quel modo la suscettibilità di una signora. «Amici» cominciò Fred Summers, piantando i suoi occhi tondi in faccia a ciascuno degli altri due «non è una guerra, è un…» Ma non riuscì a trovar la parola, e spense la luce. 1. Chiesa Alta è una corrente della chiesa anglicana, che insiste sulla gerarchia e il cerimoniale. (NdT) 2. Letteralmente “fuori campo”: una delle due zone in cui è diviso un campo di baseball (l’altra, quella interna, si chiama diamond, ossia “rombo”); il nome indica anche i giocatori ivi dislocati. (NdT) 3. Nomignoli dati dagli studenti alle varie parti del complesso universitario, come avviene nei collegi universitari italiani. (NdT) 4. La mensa universitaria. (NdT)
Cine-giornale XXII L’ANNO VENTURO PROMETTE UNA RINASCITA DELLE STRADE FERRATE DEBS PRENDE 30 ANNI DI CARCERE C’è una lunga lunga pista tortuosa nel paese dei miei sogni dove cantan gli usignoli e la bianca luna splende le generazioni future sorgeranno e chiameranno benedetti quegli uomini che avranno il coraggio delle proprie idee e un esatto concetto di ciò che è il valore della vita umana contrapposto al guadagno materiale, e che, pervasi dallo spirito di fratellanza, non si lasceranno sfuggire la grande opportunità LE OBBLIGAZIONI COMPERANO PROIETTILI COMPERATE OBBLIGAZIONI LE AZIONI DEL RAME INFLUENZATE DALLE PROSPETTIVE INCERTE Le donne votano da vere veterane della politica ripristinare piatti a base di carne tradizionalmente celebrati come l’hash, 1 il gulasch, 2 i pasticci di carne e il lardo. Ogni soldato tedesco si porta in tasca una piccola spazzola per abiti; la prima cosa che fa quando arriva in un campo di concentramento è tirar fuori questa spazzola e mettersi a spolverare con essa i propri indumenti Il datore di lavoro deve dimostrare l’indispensabilità del dipendente Una lunga, lunga notte di attesa ancor, perché s’avverino i miei sogni GLI AGITATORI NON POSSONO OTTENERE PASSAPORTI AMERICANI i due uomini provenienti dal distretto del Transvaal durante la traversata dichiararono che secondo la loro opinione le bandiere britannica e americana non esprimevano nulla, e per quanto riguardava loro potevano anche finire in fondo al mare, e riconobbero di essere dei cosiddetti nazionalisti, qualcosa di molto simile
all’Internazionale dei lavoratori di qui. “Io non ho intenzione alcuna” scrisse Hearst “di incontrarmi col governatore Smith né in pubblico né in privato, né politicamente né socialmente, giacché non trovo nessuna soddisfazione SI UCCIDE IN MARE; UNA VERA FOLLA IN CITTÀ A CACCIA DEGLI IMBOSCATI Oh, il vecchio Zio Sam lui ha la fanteria lui ha la cavalleria lui ha l’artiglieria e allora, perdio, tutti in Germania povero Guglielmone! 1. Hash: un piatto di carne a spezzatino con patate, di solito saltato in padella. (NdT) 2. Gulasch: stufatino di manzo, vitello, verdura ecc., con paprica o altre spezie; parola di origine indiana. (NdT)
Occhio fotografico (30) ricordando le grigie dita rattrappite il denso sgocciolio di sangue dalla tela il gorgoglio delle casse toraciche sforzantisi di respirare i fangosi brandelli di carne che si mettono nell’ambulanza vivi e si tirano fuori morti siamo seduti in tre sulla fontana disseccata di cemento del giardinetto dalle mura rosate, a Récicourt No ci dev’essere qualche modo ci hanno insegnato Terra dei Liberi coscienza Datemi la libertà oppure Bene, ci danno la morte pomeriggio di sole attraverso i deboli residui di iprite sento l’odore della scatola le rose bianche e il bianco phlox 1 dall’occhio cremisi tre lumache striate di bruno e bianco stanno appese con delicatezza infinita a un ramo di caprifoglio sopra la mia testa su nell’azzurro un pallone-salsiccia 2 bruca sonnacchiosamente come una mucca legata vespe ubriache si aggrappano alle pere troppo mature che cadono spiaccicandosi ogniqualvolta i cannoni vicini vomitano le loro pesanti granate che si avventano in cielo rombando con un ronzio di freccia che ti fa venire in mente le beccacce spaventate dal tuo passaggio nei boschi campagnoli benestanti costruirono amorosamente le mura e la piccola ritirata col sedile ben pulito e la lunetta nella porta proprio come la ritirata di una vecchia fattoria in patria piantarono amorosamente il giardino e assaporarono i frutti e i fiori e altrettanto amorosamente progettarono questa guerra vadano all’inferno Patrick Henry in kaki si sottopone a un’ispezione alle armi leggere e versa tutta la cinquina al Prestito della Libertà oppure datemi Arrivés lo shrapnel pizzicando le sue arpe da esili batuffoli di nuvole ci invita delicatamente alla gloria e noi beati e contenti ad osservare i cauti movimenti delle lumache nel sole pomeridiano a parlare a bassa voce di La Libre Belgique Le lettere di Junius 3 L’Areopagitica 4 Milton diventò cieco per la libertà di parola Se sceglierete le parole giuste la Democrazia capirà anche i banchieri e i ministri del culto Io tu noi dobbiamo Quando tre uomini son solidali
i regni impallidiscono noi siamo beati e contenti parlando a bassa voce nel pomeriggio di après la guerre felici del fatto che le nostre dita il nostro sangue i nostri polmoni la nostra carne sotto lo sporco kaki feldgrau bleu horizon 5 potrebbero continuare a raddolcirsi crescere sinché noi si cada dall’albero maturi come le pere troppo mature i colpi in arrivo sai e cantanti barbagli sfrigolanti granate a gas loro è il potere e la gloria oppure datemi la morte 1. Phlox: genere di piante dai fiori a colori vivaci, indigene del Nord America. (NdT) 2. Un drachen, pallone frenato osservatore. (NdT) 3. Junius è lo pseudonimo di un ignoto autore di lettere aperte scritte tra il 1768 e il 1772 contro il gabinetto inglese, di contenuto aspramente polemico. (NdT) 4. Celebre opera miltoniana. (NdT) 5. A questo punto mi sembra indispensabile far notare al lettore un punto climaterico in cui questa prosa lirico-impressionista di Dos Passos culmina attingendo un respiro di universalità: a questo punto il “noi” non si riferisce più soltanto ai tre amici dell’inizio, ma abbraccia tutti i combattenti (kaki: gli americani e gli inglesi; feldgrau: i tedeschi; bleu horizon: i francesi), accomunati nella morte e nel destino. La citazione biblica lievemente mutata (“Thine is the power and the glory”, tue sono la potenza e la gloria) in modo da non accennare più al Dio cristiano-ebraico con cui si può parlare direttamente trattandolo come persona, ma a potenze indefinibili e oscure, probabilmente quelle stesse che opprimono la vita e la società, o le leggi implacabili del divenire biologico, o economico, viene ad approfondire nella maniera più cupa e grandiosa questo senso di destino, di religiosa irreligiosità. E a tal proposito, si noti la somiglianza di clima con The Hollow Men e The Waste Land di T.S. Eliot: anche qui la citazione “For Thine is, ecc.” e il senso di annientamento. (NdT)
Randolph Bourne Randolph Bourne venne al mondo come abitante di questa terra senza il piacere di scegliersi dimora o carriera. Era un gobbo, d’una famiglia di gobbi, nipote di un ministro del culto, ed era nato nel 1886 a Bloomfield, New Jersey; quivi frequentò la scuola media inferiore e superiore. All’età di diciassette anni andò a lavorare come segretario presso un uomo d’affari di Morristown. Si fece strada nella Columbia University lavorando in una fabbrica di pianoforti automatici a Newark, lavorando come correttore di bozze, accordatore di pianoforti, accompagnatore in uno studio vocale a Carnegie Hall. Alla Columbia University studiò con John Dewey, vinse una borsa di studio con la quale visitò l’Inghilterra Parigi Roma Berlino Copenaghen, scrisse un libro sulle scuole Gary. In Europa sentì molta musica, molto Wagner e Scriabin e si comperò un mantello nero. Questo ometto simile a un passerotto esile pezzetto contorto di carne in mantello nero sempre alle prese con dolori e disturbi, mise un ciottolo nella sua fionda e con esso colpì Golia in piena fronte. La guerra – scrisse – è la salute dello Stato. Mezzo musicista mezzo pedagogista (la salute precaria, la povertà, la deformità fisica, i dissensi familiari non avevano privato il mondo delle sue attrattive per Randolph Bourne; lui era un uomo felice, amava i Maestri cantori e gli piaceva sonare Bach con quelle mani lunghe che scorrevano così agevolmente la tastiera, e gli piacevano le belle fanciulle la buona tavola e le serate di conversazione. Quando stava per morire di polmonite un amico gli portò uno zabaione; guarda questo giallo, com’è bello, continuava a dire lui mentre la vita se ne andava in un riflusso di delirio e febbre. Era un uomo felice).
Bourne afferrò con intensità febbrile le idee che circolavano allora nella Columbia University, trascelse occhiali rosa dalla turgida farragine dell’insegnamento di John Dewey, e questi gli servirono per vedere chiaramente stagliarsi il fulgido campidoglio della democrazia riformata, La Nuova Libertà di Wilson; ma lui era un grande matematico; lui doveva ridurre tutto ad equazioni; col risultato che nella pazza primavera del 1917 cominciò a diventare impopolare tra gli esponenti del suo partito, la Nuova Repubblica; perché Nuova Libertà significava ora Coscrizione, e Democrazia voleva dire Vincere la guerra, e Riforma equivaleva a Salvaguardare i prestiti Morgan, e Progresso Civiltà Educazione Dovere, Comperate un’obbligazione Liberty, e A morte gli unni In prigione gli obiettori di coscienza. Si dimise dal «New Republic»; soltanto «The Seven Arts» ebbe il fegato di pubblicare i suoi articoli contro la guerra. I sostenitori del «Seven Arts» portarono altrove il loro denaro; gli amici evitavano di farsi vedere in compagnia di Bourne, suo padre gli scrisse pregandolo di non infamare il nome della famiglia. L’avvenire dalle tinte d’arcobaleno della democrazia riformata scoppiò come una bolla di sapone. I liberali corsero in frotta a Washington, alcuni dei suoi amici gli chiesero i suoi buoni uffici per potersi attaccare alla greppia del maestrucolo Wilson; la guerra era una meraviglia, combattuta sulle sedie girevoli dell’ufficio di Mr. Creel a Washington. Lui fu messo in caricatura, pedinato dal servizio di spionaggio e dal servizio di controspionaggio; un giorno che passeggiava con due amiche a Woods Hole venne arrestato, gli fu sottratto nel Connecticut un baule pieno di lettere e manoscritti (Forza, senza remissione! tuonava il maestrucolo Wilson).
Non campò abbastanza da vedere quel gran circo che fu la Pace di Versailles o la stucchevole mediocrità orpellata della Banda dell’Ohio. Sei settimane dopo l’armistizio morì mentre stava abbozzando un saggio sui fondamenti del radicalismo futuro in America; se gli uomini hanno un’anima che sopravviva Bourne ha un’anima un’esile animella intrepida ravvolta in un mantello nero che va saltellando per le sudice vie di vecchio mattone e arenaria bruna rimaste oggidì nel quartiere degli affari di New York e grida con un acutissimo risolino inudibile: La guerra è la salute dello Stato.
Cine-giornale XXIII Se non ti va il buon Zio Sam se non ti vanno i tre colori i sorrisi della patriottica contea dell’Essex saranno radunati e immortalati a Branch Brook Park, Newark, N.J., domani pomeriggio. Le bande suoneranno mentre una grande folla marcerà felice al ritmo degli inni e canzoni di guerra. Ci saranno le madri dei figli della nazione; le spose, molte delle quali avranno al seno bimbi nati dopo la partenza dei padri per il fronte, avranno un posto nella parata fotografica della contea dell’Essex; parenti e amici degli eroi che stanno facendosi alfieri del messaggio della Libertà sfileranno davanti a una batteria di obiettivi, e sorrideranno tutti per la registrazionemessaggio n. 7 detta “Sorrisi oltremare”. Costoro dovranno cominciare a sorridere alle 2.30. TORME SFRENATE SACCHEGGIANO CITTÀ UN GIORNALISTA FA DA BATTISTRADA ATTRAVERSO LO SBARRAMENTO era pietoso a vedersi, ogni sera al crepuscolo, lo spettacolo dell’intera popolazione che sgomberava la città per andare a dormire nei campi sino all’alba. Vecchie e bimbetti, sciancati trasportati su carri o carriole, uomini che si portavano sedie essendo di quelli troppo deboli e vecchi per camminare LE MILIZIE DI JERSEY ARRUOLANO ARTIGLIERI DI SESSO FEMMINILE l’agitazione fu originata dalla richiesta di una giornata lavorativa di otto ore avanzata dai portuali Se non ti vanno le stelle della gloriosa bandiera allora ritorna al tuo paese oltremare al paese dal quale sei venuto qualunque sia il suo nome Se non ti vanno i tre colori non essere un serpente in seno non mordere la mano che ti nutre
Eveline Hutchins La piccola Eveline, Arget, Lade e Gogo abitavano all’ultimo piano di una casa in mattoni gialli sul North Shore Drive. Arget e Lade erano le sorelle della piccola Eveline. Gogo era il fratellino minore di Eveline. Al piano di sotto c’era lo studio del dottor Hutchins, dove «non bisogna disturbare Papà», e la stanza di Mammina, dov’essa stava tutta mattina a dipingere, con un camiciotto profumato di lavanda. Al pianterreno erano il tinello e la sala da pranzo, dove venivano i parrocchiani e i bambini piccoli dovevano farsi vedere ma non farsi udire, e all’ora di pranzo si sentiva odore di buone cose da mangiare e rumore di coltelli e forchette e voci argentine di invitati e la vociona paurosa di Papà, e quando risonava la voce di Papà tutte le voci della compagnia tacevano. Papà era il dottor Hutchins, ma Padre Nostro sei nei Cieli. Quando Papà si metteva accanto al letto di sera per accertarsi che le bambine dicessero le preghiere, Eveline chiudeva gli occhi per la paura. Solo quando si era ficcata sotto le coperte in modo da coprirsi fin sul naso si sentiva bene. George era un caro pupo, sebbene Adelaide e Margaret lo molestassero dicendogli che lui era il loro Assistente, come il signor Blessington era l’assistente di Papà. Era sempre George il primo a prendere le malattie, e dopo le prendevano tutti. Che bello quando presero tutti assieme la rosolia e gli orecchioni. Si stava sempre a letto e c’erano giacinti nei vasi e porcellini d’India e Mammina veniva a leggere Il libro della giungla e faceva disegni così curiosi e Papà veniva e faceva con la carta curiosi becchi d’uccello che si aprivano e raccontava storie inventate lì per lì e Mammina diceva che lui aveva detto le preghiere per voi bambini in chiesa e loro allora si sentivano bene e adulti. Quando furono tutti in piedi un’altra volta a giocare nella stanza dei bambini George prese ancora qualcosa, la polmonite per aver patito freddo al petto, e Papà fu molto solenne e disse di non affliggersi se Iddio chiamava a sé il fratellino. Ma Iddio ridonò loro il piccolo George, solo che da allora fu delicato e dovette portare gli occhiali; e quando Mammina permise ad Eveline di aiutare a fargli il
bagno perché anche Miss Mathilda aveva la rosolia, Eveline notò che lui aveva una cosa curiosa là dove lei non aveva niente. Domandò a Mammina se erano orecchioni, ma Mammina la sgridò e le disse che era stata una bambina scostumata a guardare certe cose. «Silenzio, figliola, non fare domande.» Eveline arrossì tutta e pianse, e per vari giorni Adelaide e Margaret non le rivolsero più la parola perché era una bambina scostumata. L’estate partivano tutti per il Maine con Miss Mathilda in vettura saloncino. George ed Eveline dormivano nelle due cuccette superiori, Adelaide e Margaret in quelle inferiori; a Miss Mathilda faceva male il treno, e tutta notte non chiudeva occhio sul divano di fronte. Il treno andava a scossoni regolari, torotón torotón, e gli alberi e le case passavan via di corsa, quelli davanti in fretta e quelli lontani molto lentamente, e di notte la locomotiva gemeva, e i bambini non capivano perché il capotreno, così alto bello e forte, fosse tanto gentile con Miss Mathilda che era tanto antipatica e aveva tanta nausea. Il Maine odorava tutto di boschi e alla stazione c’erano Papà e Mammà, e indossavano tutti calzoncini kaki da montagna e andavano al campeggio con Papà e le guide. Eveline imparò a nuotare prima degli altri. Di ritorno a Chicago si trovava l’autunno e Mammina amava il bel fogliame autunnale che faceva diventare Miss Mathilda così traurig 1 per via dell’inverno imminente, e brina sull’erba oltre le ombre delle vetture ferroviarie guardando dal finestrino la mattina. A casa Sam strofinava la vernice a smalto e Phoebe e Miss Mathilda mettevan su le tendine e la stanza dei bambini odorava tanto traurig di naftalina. Un autunno Papà cominciò a leggere ad alta voce un po’ degli “Ideali del re” 2 ogni sera dopo che loro si erano ficcati tutti sotto le coperte. Per tutto quell’inverno Adelaide e Margaret furono re Artù e la regina Ginevra. 3 Eveline voleva essere Elina la Bella, ma Adelaide diceva che non poteva, perché aveva i capelli da topo e la faccia da gazza, e così dovette rassegnarsi ad essere la Vergine Evelina. La Vergine Evelina soleva entrare nella stanza di Miss Mathilda quando quest’ultima era fuori, per contemplarsi lungamente allo specchio. Non aveva affatto i capelli grigio topo, erano proprio biondi,
invece, bastava che glieli lasciassero portare ricci invece che a treccine corte, e gli occhi, anche se non erano azzurri come quelli di George, avevano tante macchioline verdi nell’iride. La fronte l’aveva nobile. Un giorno Miss Mathilda la sorprese a guardarsi allo specchio in quel modo. «Se ti guarderai troppo, ti accorgerai un bel momento di guardare il diavolo» disse Miss Mathilda coi suoi bruschi modi tedeschi. Quando Eveline aveva compiuto già i dodici anni, traslocarono in una casa più grande in Drexel Boulevard. Adelaide e Margaret andarono in collegio a New Hope, a est, e Mammà dovette andare a trascorrere l’inverno presso amici a Santa Fe per motivi di salute. Che bellezza far colazione alla mattina solo con Papà e George e Miss Mathilda, la quale, facendosi piuttosto anziana, badava ora più alla casa e a leggere i romanzi di Sir Gilbert Parker che ai bambini. A Eveline la scuola non andava tanto a genio, ma le piaceva farsi aiutare dal babbo nei compiti di latino la sera e farsi risolvere da lui le equazioni algebriche. Le faceva un’impressione meravigliosa quando teneva dal pulpito quelle prediche così gentili e buone, e lei si sentiva orgogliosa di essere la figlia del pastore ai corsi sulla Bibbia di domenica pomeriggio. Meditava moltissimo sulla paternità di Dio e la samaritana e Giuseppe di Arimatea e Baldur il bello e la Fratellanza Umana e l’apostolo prediletto di Gesù. Quel Natale essa girò per le case dei poveri a portar canestri di regali. La miseria era spaventosa, e i poveri facevano impressione, e perché il buon Dio non faceva nulla per i problemi e i mali di Chicago, e per le sue condizioni? chiedeva lei al padre. Lui sorrideva e diceva che lei era troppo giovane per preoccuparsi di queste cose. Adesso lei lo chiamava Babbo ed era la sua Amica. Il giorno del suo compleanno Mammà le inviò un bel volume illustrato, La damigella benedetta di Dante Gabriel Rossetti con illustrazioni a colori riprodotte dai suoi quadri e da quelli di BurneJones. Prese l’abitudine di ripetersi continuamente il nome Dante Gabriel Rossetti, le piaceva tanto, come traurig. Cominciò a dipingere e scrivere poesiole sui cori degli angeli e i bambini poveri nel Natale. Il primo quadro che fece ad olio fu un ritratto di Elina la Bella, e lo
mandò alla mamma per Natale. Tutti dissero che c’era molto ingegno. Quando venivano a pranzo gli amici del babbo, dicevano sempre, non appena lei era stata presentata: «Ah, così questa è il genio della famiglia?». Ad Adelaide e Margaret tutto ciò non andava giù, quando tornarono da scuola. Dissero che la casa era trasandata e che a Chicago non c’era stile, e non era una cosa tremenda essere figlie di un pastore, ma naturalmente il babbo non era come i soliti pastori in cravatta bianca, era unitario e aveva idee più larghe, piuttosto da autore eminente o da scienziato. George si stava facendo un ragazzetto musone con le unghie sporche e non sapeva neanche tenere la cravatta a posto e si rompeva sempre gli occhiali. Eveline gli stava facendo un ritratto, che lo raffigurava così com’era da piccolo, quando aveva gli occhi azzurri e i riccioli giallo oro. Mentre dipingeva, lei ogni po’ gridava che gli voleva tanto bene, a lui e ai bambini poveri che vedeva per strada. Tutti dicevano che lei doveva studiare pittura. Fu Adelaide a fare per prima la conoscenza di Sally Emerson. Una Pasqua c’era da mettere in scena Aglavaine e Sélysette in chiesa a scopo di beneficenza. Miss Rodgers, l’insegnante di francese della scuola del dottor Grant, era incaricata di istruirle nella recitazione, e disse loro di rivolgersi per le scene e i costumi alla signora Philip Payne Emerson, che aveva visto la rappresentazione originale all’estero; l’interessamento di quella persona, poi, avrebbe avuto un valore incalcolabile per il buon andamento della cosa: tutto ciò a cui s’interessava Sally Emerson andava bene. Le ragazze Hutchins non stavano più in sé per l’emozione quando il dottor Hutchins chiamò al telefono la signora Emerson per domandarle se Adelaide poteva venire da lei qualche mattina a chiederle consiglio in materia di certo spettacolo da dilettanti. Si erano già seduti tutti a tavola quando venne di ritorno Adelaide, gli occhi luccicanti. Non volle dire altro senonché la signora Philip Payne Emerson conosceva intimamente Maeterlinck e sarebbe venuta a prendere il tè, ma continuava a ripetere: «Non ho mai conosciuto una donna di classe come quella». Aglavaine e Sélysette non fu proprio quel successo che le ragazze Hutchins e Miss Rodgers avevano sperato, quantunque tutti
riconoscessero che le scene e i costumi creati da Eveline dimostravano un’autentica abilità, ma la settimana dopo la recita Eveline ricevette dalla signora Emerson un invito a colazione riservato a lei sola. Adelaide e Margaret ne provarono tal rabbia che non le rivolgevano più la parola. Lei si sentiva piuttosto malferma quando uscì nel giorno polveroso, diaccio e chiaro. All’ultimo minuto Adelaide le aveva prestato un cappello e Margaret il collo di pelliccia, «tanto perché non facesse far loro cattiva figura». Quando giunse a casa Emerson era gelata fino alle ossa. Fu introdotta in un piccolo spogliatoio sparso d’ogni sorta di spazzole, pettini, anfore d’argento contenenti cipria e persino rossetto e acqua di colonia in bottiglie verdecupo e rosa, e vi fu lasciata sola a togliersi il soprabito. Quando si vide nel grande specchio le venne voglia di gridare, era così giovane, aveva la faccia da gazza e un vestito orribile. La sola cosa decente era la pelliccia di volpe, e così se la tenne addosso quando salì al salone del piano superiore col suo spesso tappeto grigio così soffice e il sole filtrante a vividi colori dalle finestre francesi e il piano a coda nero lustro. Sopra ogni tavola c’eran grosse bocce d’acqua con mazzi di frisie, e monografie di pittura tedesche o francesi color giallo e rosa. Persino i caseggiati fuligginosi di Chicago si acquattavano sotto il vento, e il sole a zero gradi appariva debolmente eccitante e straniero attraverso il grande motivo ornamentale delle tendine di pizzo giallo. Nell’esuberante profumo delle frisie c’era un’ombra di fumo di sigarette costose. Sally Emerson entrò fumando una sigaretta e disse: «Scusami, cara», una tremenda scocciatrice l’aveva tenuta mezz’ora inchiodata al telefono come una farfalla trafitta da uno spillo. Fecero colazione a un tavolino che il vecchio negro portò già preparato, ed Eveline si vide trattare proprio come una donna adulta e le fu servito un bicchiere di sherry. Lei osò appena sorseggiare un po’, ma era delizioso, e la colazione era tutta una crema e un’increspatura di formaggio grattato sui piatti, e lei chissà quanto avrebbe mangiato se non fosse stato per la timidezza. Sally Emerson disse quanto erano belli i costumi fatti da Eveline per lo spettacolo, e lei doveva coltivare il disegno, e a Chicago c’era gente dotata di genio artistico né più né meno che altrove, quello
che mancava era l’ambiente, l’atmosfera, cara mia, e i capi della società erano tutti teste di legno piene di vizi, e toccava alle poche persone veramente appassionate all’arte mettersi assieme per creare l’ambiente ricco e bello di cui abbisognavano, e Parigi, e Mary Garden, e Debussy. Eveline tornò a casa con la testa turbinante di nomi e immagini, piccoli brani d’opera, e nel naso l’odore eccitante delle frisie commisto a quello del formaggio arrostito e delle sigarette. Quando si ritrovò fra le pareti di casa sua, ogni cosa parve così buttata là alla rinfusa, nuda e brutta, che lei scoppiò a piangere e non volle saperne di rispondere alle domande delle sorelle; e ciò naturalmente le fece inviperire più che mai. Quel giugno, dopo la fine dell’anno scolastico, andarono tutti a Santa Fe a trovare la mamma. Che depressione a Santa Fe! Il sole era così caldo e le colline scavate dall’erosione erano così aride e polverose e Mammà era così sciupata e leggeva di teosofia e parlava di Dio e della bellezza d’animo degli indiani e dei messicani in un modo che turbava i bambini. Eveline lesse moltissimi libri quell’estate e si guardò bene dall’uscire. Lesse Scott, Thackeray, W.J. Locke e Dumas, e quando ebbe scovato in casa una vecchia copia di Trilby la lesse tre volte di fila. Fu così che imparò a vedere un mondo nelle illustrazioni del Du Maurier 4 anziché nelle solite figure di dame e cavalieri. Quando non leggeva, se ne stava supina a sognare lunghe storie di cui lei stessa e Sally Emerson erano le protagoniste. Per lo più non si sentiva bene, e cascava in lunghe sequele di pensieri orribili sul corpo delle persone, al punto da sentirne nausea. Adelaide e Margaret le dissero come regolarsi coi disturbi mensili, ma lei non disse che spaventoso turbamento essi le provocavano interiormente. Leggeva la Bibbia e cercava nelle enciclopedie e nei dizionari parole come “utero”. Poi una notte decise di farla finita, perché non ci resisteva più, e rovistò nella cassetta farmaceutica in camera da bagno finché trovò una bottiglia segnata “Veleno” che conteneva un composto di laudano. Ma prima di morire voleva scrivere una poesia, si sentiva così musicalmente traurig di morire, ma le rime non le volevano andare a posto, e finalmente reclinò il capo nel sonno sulla carta.
Quando si risvegliò era l’alba, e lei era curva sul tavolo accanto alla finestra, intirizzita nella vestaglia leggera. Si ficcò in letto rabbrividendo. Comunque si ripromise di tenersi la bottiglia per uccidersi non appena le cose sembrassero troppo schifose e orrende. E ciò le diede un certo sollievo. Quell’autunno Margaret e Adelaide andarono a Vassar. Eveline avrebbe voluto andare a est, ma tutti dicevano che era troppo giovane, sebbene avesse passato la maggior parte degli esami di collegio. Si fermò a Chicago e frequentò corsi artistici e conferenze di vario genere, e lavorò per la chiesa. Fu un inverno infelice. Sally Emerson pareva averla dimenticata. I giovani dell’ambiente della chiesa erano così noiosi e convenzionali. Eveline finì per non poter soffrire le serate di Drexel Boulevard, e tutta quella vaga filosofia emersoniana 5 che suo padre andava predicando con la sua enfasi oratoria. Le piaceva più di tutto il resto il lavoro che svolgeva alla Hull House. Là Eric Egstrom teneva corsi serali di disegno, e lei soleva vederlo nell’andito posteriore, a volte con una sigaretta in bocca, appoggiato al muro, e con un’aria molto nordica, pensava lei, in quella sua tunica grigia piena di macchie fresche di colore. A volte fumava una sigaretta con lui scambiando qualche parola su Manet o sugli innumerevoli mucchi di fieno di Claude Monet, sempre a disagio perché temeva che la sua conversazione non fosse abbastanza interessante e acuta, e qualcuno poteva venire e sorprenderla a fumare. Miss Mathilda diceva che non era bene per una ragazza aver la testa così per aria, e volle che imparasse a cucire. Quell’inverno Eveline non pensò ad altro che a frequentare l’istituto d’Arte e cercar di dipingere vedute del lungolago che avessero il colore di Whistler ma la ricchezza e la pienezza dei disegni di Millet. Eric non l’amava, se no non sarebbe stato così amichevole e distratto. Il suo grande amore lei l’aveva avuto; ora la vita era finita e bisognava dedicarsi all’arte. Cominciò a portare i capelli annodati sulla nuca, e quando le sorelle le dissero che non stava bene lei disse che lo faceva apposta. Fu all’istituto d’Arte che ebbe inizio la sua bella amicizia con Eleanor Stoddard. Eveline aveva il cappellino grigio nuovo che secondo lei richiamava qualcosa di un ritratto di Manet, e
attaccò discorso con quella ragazza così interessante. Quando tornò a casa era così entusiasta che ne scrisse a George, allora in collegio, dicendo che quella era la prima ragazza da lei incontrata che dimostrasse davvero di sentire la pittura e con cui si potesse davvero parlare di tante cose. E poi, faceva davvero qualcosa, e in maniera così originale, e aveva un modo così spiritoso di esporre le cose. Dopo tutto, se l’amore doveva esserle negato lei poteva costruire la sua vita sopra una bella amicizia. A Eveline la vita di Chicago finì per piacere tanto che fu per lei un vero disappunto quando venne il momento di partire per quel viaggio all’estero di un anno che da tanto tempo il dottor Hutchins progettava per la sua famiglia. Ma New York, e l’imbarco sul Baltic, e la preparazione degli scontrini per il bagaglio, e il curioso odore delle cabine, le fecero dimenticare tutto. La traversata fu agitata e la nave rollò alquanto, ma loro sedevano alla tavola del capitano e il capitano era un inglese gioviale e teneva loro alto il morale, tanto che non mancarono quasi un pasto. Sbarcarono a Liverpool con ventitré colli, ma perdettero per via durante il tragitto verso Londra la valigia che conteneva la cassetta delle medicine, e dovettero sprecare tutta la mattinata a rintracciarla all’ufficio Oggetti smarriti di St. Pancras. A Londra c’era nebbia a non finire. George ed Eveline andarono a vedere i marmi di Elgin e la Torre di Londra, consumarono i loro pasti in ristoranti di lusso e si divertirono un mondo a viaggiare in ferrovia sotterranea. Il dottor Hutchins li lasciò a Parigi per soli dieci giorni, e lì spesero quasi tutto in gite fuori città per visitare cattedrali. NotreDame, Reims, Beauvais e Chartres con le loro vetrate luminose e il loro odore d’incenso tra la pietra fredda e le alte statue grigie dal volto lungo per poco non fecero di Eveline una cattolica. Per tutto il tragitto sino a Firenze ebbero uno scompartimento riservato di prima classe e un cestino con pollo freddo e molte bottiglie di acqua minerale SaintGalmier, e un fornellino a spirito per farsi il tè. Era un inverno assai piovoso e la villa era fredda, e le ragazze si leticarono alquanto e a Firenze pareva non ci fosse altro che vecchie signore inglesi; la tranquilla Eveline si ritirò dalla vita e lesse Gordon Craig. Non conosceva nessun giovane e odiava i giovani italiani dai
nomi danteschi che ronzavano attorno a Margaret e Adelaide credendole ricche ereditiere. Tutto sommato, fu ben felice di tornare a casa un po’ prima con la mamma, mentre gli altri facevano un viaggio in Grecia. Salparono da Anversa sul Kroonland. Eveline credette che fosse il momento più bello della sua vita quando si sentì tremar sotto i piedi il ponte della nave mentre il piroscafo lasciava la banchina intronandole gli orecchi col fischio della sua sirena. La prima notte di viaggio sua madre non scese nel salone ristorante, cosicché Eveline provò un po’ d’imbarazzo a sedersi a tavola tutta sola, e cominciò a mangiare la minestra prima di accorgersi che il giovane di fronte a lei era americano e di bell’aspetto. Aveva occhi azzurri e capelli color lino, crespi e disordinati. Una strana combinazione: anche lui era di Chicago. Si chiamava Dirk McArthur. Aveva studiato un anno a Monaco di Baviera, ma ora se ne veniva via spontaneamente prima che lo cacciassero fuori. Lui ed Eveline fecero subito amicizia; e da quel momento si sentirono padroni della nave. Fu una bella traversata, per aprile. Giocarono a shuffleboard 6 e ping-pong, e passarono un sacco di tempo a prua a guardare le agili onde atlantiche arricciarsi e infrangersi sotto l’urto della nave. Una notte di luna, mentre il satellite stava affondando a occidente in un velo di spruzzaglia da quella parte stessa verso la quale avanzava il Kroonland tuffandosi nei grossi marosi, si arrampicarono sino alla coffa. Era un’avventura; Eveline non voleva far vedere che aveva paura. Non c’era nessuno di guardia, ed essi si trovarono soli, con un po’ di capogiro, nella comoda sacca di tela grezza che odorava un po’ di pipe da marinai. Quando Dirk le passò un braccio attorno alle spalle, ad Eveline cominciò a girare la testa. Non avrebbe dovuto permetterglielo. «Cielo, sei una ragazza in gamba, Eveline» disse lui col fiato sospeso. «Non ho mai conosciuto sinora una ragazza in gamba come te.» Senza averne proprio l’intenzione, lei voltò il viso verso di lui. Le loro guance si toccarono e la bocca di lui scivolò andando a baciarla forte forte sulla bocca. Lei lo respinse di scatto. «Ehi, non vorrai gettarmi a mare, per caso?» disse lui ridendo. «Su, Eveline, da brava, dammi un bacetto piccolo così per dimostrarmi che
non sei arrabbiata con me. Stanotte siamo soli, io e te, in tutto l’Atlantico.» Lei gli diede un bacio timido e spaventato sul mento. «Sai, Eveline, mi piaci tanto. Sei una ragazza meravigliosa.» Lei gli sorrise, e d’un tratto lui la strinse a sé in un abbraccio serrato, premendo le gambe con tutta forza contro le sue, le mani aperte sulla schiena di lei, cercando di aprirle le labbra con le proprie. Lei staccò la bocca. «No, no, per favore, no» sentì se stessa dire con la sua vocina acuta. «Va bene, scusami… Non farò più l’uomo delle caverne, Eveline, credimi. Ma non devi dimenticare che sei la più bella ragazza della nave… ma che dico, del mondo! Capirai bene che c’è da sentirsi turbati.» Lui scese per il primo. Calandosi per l’apertura esistente nel fondo della coffa, lei cominciò a sentirsi in preda alle vertigini. Stava cadendo. Le si strinsero attorno le braccia di lui. «Non è nulla, bimba, ti era scivolato un piede» le disse burberamente all’orecchio. «Ora ti tengo salda.» Le girava la testa, pareva che non riuscisse a muovere gambe e braccia; sentiva se stessa implorare con la sua vocina gemente: «Non lasciarmi cadere, Dirk, non lasciarmi cadere». Quando finalmente misero piede sul ponte, Dirk si appoggiò all’albero di trinchetto ed emise un lungo sospiro: «Uh… che paura mi hai fatto prendere, signorina!». «Mi spiace tanto» disse lei. «È stato sciocco da parte mia fare d’un tratto la bambina a quel modo… Devo essere svenuta per un minuto.» «Caspita, non avrei dovuto portarti lassù.» «Invece hai fatto bene» disse Eveline; poi si accorse di arrossire e scappò per il ponte all’ingresso della prima classe e in cabina, dove fu costretta a inventare lì per lì una storia qualunque per spiegare alla mamma come aveva fatto a rompersi la calza. Quella notte non poté dormire, e giacque sveglia nella sua cuccetta ascoltando il remoto pulsare delle macchine, il cigolio della nave e il ribollimento di onde vorticate che entrava dall’oblò aperto. Sentiva ancora la ruvida carezza della guancia di lui e l’improvvisa stretta dei suoi bicipiti attorno alle spalle. Ora sapeva di essere tremendamente
innamorata di Dirk, e avrebbe desiderato che lui la chiedesse in sposa. Ma il mattino dopo fu veramente lusingata quando il giudice Ganch, un alto legale canuto di Salt Lake City dalla faccia rossa e giovanile e dai modi vivaci, si mise a sedere sull’orlo della sua sdraia e le parlò della vita che aveva fatto da giovane nel West, del suo matrimonio infelice, della politica e di Teddy Roosevelt e del partito progressista. Lei avrebbe preferito stare con Dirk, ma si comportò gentilmente e provò un’emozione piacevole quando Dirk le passò accanto con una smorfia di dispetto mentre lei ascoltava i racconti del giudice Ganch. Avrebbe desiderato che il viaggio non finisse mai. A Chicago s’incontrò un sacco di volte con Dirk McArthur. La baciava sempre quando la riaccompagnava a casa, la teneva molto stretta quando ballava con lei e a volte le prendeva la mano e le diceva che era una bella ragazza, ma non faceva mai parola di un eventuale matrimonio. Incontratasi una volta a un ballo con Sally Emerson – ve l’aveva accompagnata Dirk – dovette confessare che non stava dipingendo più, e Sally Emerson mostrò tale disappunto che Eveline si sentì prendere dalla vergogna e si mise a parlare in fretta di Gordon Craig e di una mostra di Matisse vista a Parigi. Sally Emerson stava giusto per andarsene. Un giovane attendeva Eveline per un ballo. Sally Emerson le prese la mano e disse: «Ma Eveline, non devi dimenticare che da te ci aspettiamo grandi cose». E mentre ballava, tutto ciò che Sally Emerson rappresentava, e l’alone mirabile in cui soleva una volta raffigurarsi quella donna, assalì la memoria di Eveline; ma nel tornare a casa sull’auto di Dirk ogni pensiero le uscì di testa sotto l’abbaglio dei fari, il balzo in avanti della macchina con l’acceleratore, il ronzio del motore, il braccio di lui attorno a lei, la grande forza che la premeva contro di lui quando prendevano una curva. Era una notte calda, ed egli puntò ad ovest per interminabili sobborghi identici per sbucare alfine nella prateria. Eveline sapeva che avrebbero dovuto andare a casa, ora tutti erano tornati dall’Europa e avrebbero notato il suo ritardo, ma non disse nulla. Fu solo quando lui fermò la macchina che lei si accorse della tremenda sbornia a cui Dirk era in preda. Tirò fuori una bottiglia e le offrì da bere. Lei scosse il
capo. Si erano fermati di fronte a una fattoria bianca. Nel riverbero dei fari lo sparato, il volto e i capelli arruffati di lui erano tutti di gesso. «Tu non mi ami, Dirk» disse lei. «Ma certo che ti amo, più di ogni altra persona al mondo… eccettuato me stesso… ecco qual è il mio guaio… amo me stesso sopra ogni altra cosa.» Lei gli passò le nocche delle dita fra i capelli: «Sei abbastanza sciocco, lo sai?». «Eh già» disse lui. Stava per piovere, così lui girò la macchina e puntò su Chicago. Eveline non seppe mai con precisione il punto in cui si fracassò la macchina, solo che lei a un certo punto sgusciava fuori di sotto al sedile e aveva l’abito rovinato ed era illesa, ma la pioggia striava i fari delle auto che si fermavano lungo la strada da una parte e dall’altra. Dirk era seduto sui parafanghi della prima automobile che si era fermata. «Ti sei fatta niente, Eveline?» le domandò con voce incerta. «Oh niente, solo il vestito» disse lei. Lui sanguinava da un taglio sulla fronte e si teneva un braccio contro il corpo come se avesse freddo. Poi fu tutto un incubo, telefonare al babbo, portare Dirk all’ospedale, schivare i giornalisti, andare dal signor McArthur per convincerlo a far sì che la notizia non comparisse sui giornali del mattino. Erano le otto in punto di un caldo mattino di primavera quando Eveline rientrò a casa con un impermeabile prestatole da un’infermiera sopra l’abito da sera rovinato. La famiglia stava facendo colazione al completo. Nessuno disse una parola. Poi il babbo si alzò e si fece avanti, col tovagliolo in mano: «Mia cara, non voglio dire nulla della tua condotta per adesso, senza parlare dell’ansia e della mortificazione che hai provocato a noi tutti… Posso dire soltanto che con una scappatella del genere ti meritavi proprio di farti male sul serio. Adesso vai a riposare, se ci riesci». Eveline andò di sopra, chiuse la porta a doppia mandata e si buttò sul letto singhiozzando. Non appena fu possibile, la mamma e le sorelle la mandarono a Santa Fe. Laggiù faceva caldo e c’era polvere, ed era un posto che lei non poteva soffrire. Non poteva fare mai a meno di pensare a Dirk. Cominciò a dire alla gente che lei credeva nel libero amore, e stette per ore intere in camera sua a leggere Swinburne e Laurence Hope e a sognare che ci fosse Dirk. Arrivò a un punto tale che le pareva di
sentire le dita insistenti delle mani stenderlesi sulla parte inferiore della schiena, e la bocca sulla bocca, come quella notte sulla coffa del Kroonland. Fu quasi un sollievo per lei ammalarsi di scarlattina e rimanere a letto per otto settimane nel reparto infettivi dell’ospedale. Tutti le mandarono fiori; lesse un mucchio di libri sul disegno e la decorazione di interni, e dipinse ad acquarello. Quando andò a Chicago in ottobre per le nozze di Adelaide, aveva un’aria pallida e matura. Nel baciarla, Eleanor esclamò: «Mia cara, sei diventata tremendamente bella». Lei aveva in mente una cosa sola, vedere Dirk e riattaccare con lui. Ci vollero vari giorni prima che potessero combinare un appuntamento, perché il babbo gli aveva telefonato per proibirgli di farsi vedere in casa, e c’era stata una scenata al telefono. S’incontrarono nel vestibolo del Drake. Le bastò uno sguardo per capire che Dirk s’era dato ai bagordi dall’ultima volta. Ora era un po’ bevuto. Aveva un’aria tra pecorina e fanciullesca che le faceva venir voglia di piangere. «Be’, come va Barney Oldfield?» disse invece ridendo. «In malora va… ma caspita, sei affascinante, Eveline… Senti, in città danno Follies 1914, un grande successo di New York… Ho i biglietti, ti spiacerebbe venire?» «No, è proprio un’idea magnifica.» Egli ordinò tutto ciò che di più costoso poté trovare sulla lista, più lo champagne. Lei aveva un nodo alla gola, faticava a inghiottire. Doveva dirglielo subito, prima che fosse ubriaco fradicio. «Dirk… parlarti a questo modo forse non sarà da signorina per bene, ma così non può andare avanti… Il tuo atteggiamento della primavera scorsa era tale da farmi pensare che io ti piacessi… ebbene, fino a che punto ti piaccio? Voglio saperlo.» Dirk posò il bicchiere e arrossì. Poi trasse un profondo sospiro e disse: «Eveline, sai, io non sono di quelli che si sposano… amale tutte e non sposar nessuna. Sono fatto così, non posso farci nulla.» «Non voglio dire che tu debba per forza sposarmi» e la voce di lei si fece acuta e stridula, sfuggendo al suo controllo. Cominciò a ridacchiare. «Non intendo che si faccia di me a tutti i costi una donna onesta. Comunque, non ve n’è alcun motivo.» Adesso riuscì a ridere con maggior naturalezza. «Non parliamone più… Non ti seccherò
più.» «Sei una ragazza in gamba, Eveline. L’ho sempre detto.» Quando scesero in platea lui era così sbronzo che lei dovette sorreggerlo con una mano sotto il gomito per impedirgli di barcollare. La musica, i colori volgari e i corpi sussultanti delle girls, tutto pareva irritarle qualche ferita interna, tanto che ogni cosa davanti a lei doleva come una sostanza zuccherina sopra un dente malato. Dirk continuava a parlare: «Vedi quella ragazza… la seconda da sinistra della fila di dietro: è Queenie Frothingham… Mi capisci, Eveline… Ma devo dirti una cosa, non sono stato mai io a far commettere a una ragazza il primo passo falso… Non ho da rimproverarmi questo». Venne la maschera a pregarlo di non parlare così forte perché stava disturbando gli spettatori. Lui le diede un dollaro e disse che sarebbe stato zitto come un topo, come un topino muto, e d’un tratto si addormentò. Alla fine del primo atto Eveline disse che doveva andare a casa, perché il dottore le aveva raccomandato di dormire molto. Lui dapprima insisteva per accompagnarla a casa in tassì, e poi tornò sui suoi passi per andare a godersi la rivista e Queenie. Eveline stette sveglia tutta notte a fissare la finestra. Il mattino dopo fu la prima a scendere a colazione. Quando scese il babbo, gli disse che voleva lavorare e gli chiese mille dollari in prestito per avviare un’impresa di decorazione d’interni. L’impresa di decorazioni che mise su con Eleanor Stoddard a Chicago non fruttò come Eveline aveva sperato, e in complesso Eleanor era piuttosto irritante; ma ci fu modo di conoscere gente tanto interessante, andare a ricevimenti, prime e inaugurazioni di mostre d’arte, e Sally Emerson ci pensava lei a tenerle all’avanguardia per quanto riguardava la società di Chicago. Eleanor si lamentava sempre del fatto che i giovani raccolti da Eveline erano tutti così poveri e non tanto una risorsa quanto un peso per l’azienda. Eveline aveva una gran fede nel nome che si sarebbero fatto tutti quanti; e allorché Freddy Seargeant, il quale aveva dato tanto fastidio e si era fatto sovvenzionare tante volte, riuscì a sfondare con un’opera come Tess dei d’Urberville a New York, Eveline si sentì così trionfante da
innamorarsi di lui, quasi. Freddy era innamoratissimo di lei, ed Eveline non sapeva decidersi sul partito da prendere nei suoi riguardi. Era un caro ragazzo e lei gli voleva un gran bene, ma non si sentiva di sposarlo, e quello sarebbe stato il suo primo intrigo amoroso, e Freddy non era proprio il tipo da farle perdere la testa. Le piaceva stare in sua compagnia fino a notte tarda bevendo vino del Reno al selz, al caffè Brevoort, dove bazzicava tanta gente interessante. Eveline stava lì a guardarlo attraverso i rabeschi del fumo di una sigaretta, chiedendosi se avrebbe avuto con lui un intrigo d’amore. Era un uomo alto ed esile, di circa trent’anni, con qualche spruzzatina di bianco nei fitti capelli neri e la faccia lunga e pallida. Aveva modi distinti, piuttosto da letterato, e pronunciava l’a larga, tanto da far pensare alla gente che fosse di Boston, dei Seargeant di Back Bay. Una sera si misero a far progetti su se stessi e il teatro americano. Con un po’ di appoggio si poteva metter su un teatro di prosa e dare autentiche commedie americane. Lui sarebbe stato lo Stanislavskij e lei la Lady Gregory, e chissà, fors’anche il Bakst d’America. Quando si chiuse il caffè, lei gli disse di girare dall’altra scala e salire in camera sua. La stuzzicava l’idea di trovarsi sola con un giovane in una camera d’albergo, e pensava all’impressione che ciò avrebbe fatto a Eleanor se lo avesse saputo. Fumarono e parlarono del teatro un po’ distrattamente, e alfine Freddy le passò un braccio attorno alla vita e le chiese se poteva restare tutta notte. Ella si lasciò baciare, ma intanto non riusciva a distogliere il pensiero da Dirk, e gli disse «stavolta no, per favore», e lui ne rimase mortificato e pentito e con le lacrime agli occhi la pregò di perdonarlo se aveva guastato un momento così bello. Lei disse che non intendeva dir questo, e lo invitò a tornare la mattina e far colazione con lei. Quando se ne fu andato, lei quasi si pentì di non averlo fatto rimanere. Il corpo le fremeva tutto come quando Dirk la cingeva con le braccia e lei aveva una tremenda voglia di sapere che cosa voleva dire fare all’amore. Prese un bagno freddo e andò a letto. Al risveglio, quando avesse rivisto Freddy, avrebbe deciso se ne era innamorata o no. Ma il mattino dopo ricevette un telegramma che
la richiamava a casa. Papà era gravemente ammalato di diabete. Freddy l’accompagnò al treno. S’era aspettata che la separazione la sconvolgesse, ma in un modo o nell’altro non fu così. Il dottor Hutchins migliorò ed Eveline lo portò a Santa Fe per la convalescenza. Anche la mamma era quasi sempre malata, e siccome Margaret e Adelaide erano sposate entrambe e George aveva avuto un posto all’estero nell’organizzazione di Hoover per gli aiuti al Belgio, il Belgian Relief, toccava evidentemente a lei assistere i due vecchi. Così passò un anno di sogni e d’infelicità ad onta del vasto paesaggio scheletrico, delle cavalcate e degli acquarelli che faceva per ritrarre i penitentes messicani e indiani. Girava per casa a ordinare i pasti, a badare alle faccende domestiche, irritandosi della storditezza che manifestavano le cameriere, e a compilare le liste per la lavandaia. L’unico uomo da lei conosciuto laggiù che le desse una sensazione di vita fu José O’Riely. Nonostante il cognome irlandese era spagnolo, un giovane snello dal volto color tabacco e dagli occhi verdecupo che chissà come si era sposato una grassa messicana la quale gli partoriva uno strillante marmocchietto bruno ogni nove mesi. Era pittore, e viveva di lavoretti da falegname, a volte anche posando come modello. Eveline gli rivolse la parola un giorno che lui le stava verniciando le porte della rimessa, e gli chiese di posare per lei. Lui non staccava gli occhi dal pastello che essa ne veniva facendo, e la ridusse a smettere tutto in un accesso di pianto, a furia di dirle che era una porcheria. Le chiese scusa nel suo goffo inglese dicendole che non era il caso di sconvolgersi, che aveva ingegno e lui stesso le avrebbe insegnato a disegnare. La portò a casa sua, una baracchetta disordinata della città messicana, la presentò a Lola, sua moglie, che la guardò con occhi neri, sospettosi e sgomenti, e le mostrò i suoi quadri, grosse pale d’altare dipinte su gesso che sembravan primitivi italiani. «Vedete» disse «io dipingo martiri, ma non cristiani. Dipingo i martiri della classe lavoratrice vittima dello sfruttamento. Lola non capisce. Vorrebbe che dipingessi ricche signore come voi e facessi denaro. Ma secondo voi chi ha ragione?» Eveline avvampò: non le garbava di essere messa nella categoria delle ricche signore. Ma i quadri la colpirono, e disse che avrebbe fatto loro buona propaganda tra i suoi
amici; era convinta di aver scoperto un genio. O’Riely gliene fu grato, e non volle più esser pagato per le pose e le critiche, ma si limitò a farsi prestare di quando in quando piccole somme, da amico. Già prima che lui cominciasse a farle la corte, lei decise che stavolta doveva essere una cosa seria. Diventava matta se non le capitava presto qualcosa. La difficoltà principale era quella del posto. Lei aveva lo studio proprio dietro la casa, e lì c’era il pericolo che papà, mamma o amici in visita li sorprendessero da un momento all’altro. E poi, Santa Fe era così piccola, e la gente aveva già notato la frequenza delle visite che lui faceva al suo studio. Una notte che l’autista degli Hutchins era via, si inerpicarono alla sua stanza sopra la rimessa. C’era buio pesto là dentro, e tanfo di pipe vecchie e panni sporchi. Eveline si atterrì al constatare di aver perso ogni autocontrollo; era come mettersi la maschera all’etere. Lui fu sorpreso di trovarla vergine e fu molto buono e gentile, quasi le chiedeva scusa. Ma lei non provò affatto quell’estasi che credeva, giacendogli tra le braccia sul letto dell’autista; era come se tutto fosse già avvenuto altre volte. Dopo, rimasero sdraiati sul letto a parlar lungamente a voce bassa e intima. Lui aveva cambiato modi; la trattava con gravità e indulgenza, come una bambina. Disse che non poteva soffrire quell’atmosfera di sotterfugio e di sporcizia, era degradante per tutti e due. Ci avrebbe pensato lui a trovare un posto all’aria aperta, dove potessero incontrarsi nel sole e non a quel modo come due criminali. Voleva ritrarla, la leggiadra snellezza del suo corpo e i graziosi seni tondi sarebbero stati l’ispirazione della sua pittura. Poi la guardò tutta attentamente per vedere se aveva i vestiti gualciti, e le disse di scappare in casa e mettersi a letto; e di prendere le precauzioni del caso se non voleva avere un bambino, quantunque per lui questo sarebbe stato un orgoglio, tanto più che lei era abbastanza ricca da mantenere un figlio. Quest’idea le fece orrore, e a lei parve rozzo e insensibile da parte sua parlarne con tanta leggerezza. Tutto inverno si diedero convegno due volte la settimana in una capannuccia abbandonata che si trovava fuori mano nella conca di un
piccolo cañón pietroso, dietro la città. Lei ci andava a cavallo, e lui passava da un’altra parte. La chiamavano la loro isola deserta. Poi un giorno Lola frugò nelle cartelle di lui e vi trovò centinaia di disegni della stessa fanciulla nuda; si presentò a casa Hutchins tremante e urlante di rabbia, coi capelli sparsi a ciocche sul volto, e cercò di Eveline, gridando ai quattro venti che l’avrebbe uccisa. Per il dottor Hutchins fu un colpo di fulmine; ma, dominando la tremenda paura che aveva, Eveline riuscì a restar calma e a dire al padre che aveva sì permesso ad O’Riely di ritrarla a disegno, ma non c’era stato nient’altro fra loro, e la moglie di lui era una stupida messicana ignorante e non sapeva immaginare un uomo e una donna soli in uno studio senza pensare a cose disgustose. Pur biasimandola per l’imprudenza, papà le credette, e riuscirono tra loro due a tenere la mamma all’oscuro di tutto, ma da quel giorno lei non poté avere con Pepé che un solo convegno. Lui fece spallucce e disse che non poteva farci nulla, non poteva certo abbandonare moglie e bambini e lasciarli morir di fame, povero com’era doveva pur vivere con loro, e un uomo ha pur bisogno di una donna che lavori per lui e gli faccia da mangiare; lui non poteva vivere di romanticismo, doveva mangiare, e Lola era una buona donna ma stupida e trasandata, e gli aveva fatto promettere di non incontrarsi più con Eveline. Eveline girò sui tacchi e lo piantò in asso che parlava ancora. Che fortuna, aver lì pronto un cavallo da poter inforcare e via! 1. In tedesco: “triste”; evidentemente si tratta di istitutrice svizzera o tedesca. (NdT) 2. In inglese Ideals of the King, deformazione acustico-semantica che nella mente infantile si produce da Idylls of the King, gli Idilli del re, titolo di una celeberrima serie di poemetti – ispirati alle leggende di re Artù – di Alfred Tennyson. (NdT) 3. Non si può riprodurre in italiano il gioco di parole che Dos Passos fa tra Guenever (Ginevra) e Whenever (“dovunque”), assonanza attribuita come la precedente alla psicologia infantile; qui c’è qualcosa dello stile di James Joyce. (NdT) 4. Illustratore e romanziere inglese dell’Ottocento; Trilby è un suo romanzo. (NdT)
5. Inutile dire che qui si accenna a R.W. Emerson, il noto filosofo americano dell’Ottocento. (NdT) 6. Gioco consistente nel far scivolare di colpo monete o dischetti sopra un tavolo liscio con due guide, verso linee prestabilite. (NdT)
Occhio fotografico (31) un materasso coperto di roba di Vantine fa da divano nello studio della fotografa siamo seduti sul divano e su cuscini sparsi a terra e l’attore inglese dal collo lungo legge ritmicamente il Cantico dei cantici e la fotografa in reggiseni di metallo e calzoni alla turca di seta balla ritmicamente il Cantico dei cantici la fanciulletta in rosa balla danze classiche al suono della zampogna ma la fotografa dai capelli allo henné balla ritmicamente il Cantico dei cantici con sussulti all’ombelico e strepiti metallici sul petto coperto di piastre, in stile più orientale datemi vini prelibati ristoratemi di mele perché sono stanca d’amore la sua mano sinistra è sotto il mio capo e la sua mano destra mi abbraccia 1 l’attrice quasi in pensione che abitava al piano di sopra lanciò uno strillo e poi un altro Ladri secondo piano uomini Buon Dio, la stanno assalendo noialtri uomini corriamo su per le scale povera donna è in preda a una crisi d’isterismo L’appartamento non è questo Le scale son piene di poliziotti fuori stanno fermando il furgone Benissimo, uomini da una parte, ragazze dall’altra ma che diavolo di posto è questo? Poliziotti che vengono a tutte le finestre poliziotti che escono dalla cucinetta la fotografa dai capelli allo henné li tiene a bada drappeggiata in una tendina agitando il telefono Parlo con l’ufficio del signor Wickersham? Procuratore distrettuale incidente spiacevole un po’ di amici una piccola recita danzante nella maniera più brutale una distinta attrice del piano di sopra in preda all’isterismo va bene ufficiale parlate col procuratore distrettuale vi dirà lui chi sono io chi sono i nostri amici I poliziotti se ne vanno il furgone imbocca sferragliando un’altra via L’attore inglese parla solo col massimo sforzo sono riuscito a dominarmi quei porci io sono tremendo quando perdo la pazienza
tremendo e il console turco e il suo amico lì presenti in incognito nazione belligerante dipartimento della Giustizia Controspionaggio radicali filotedeschi se la batterono indisturbati e noi due scendemmo le scale di corsa e ci dirigemmo al centro a passo lesto e traghettammo per Weehawken era una notte di nebbia enorme nella quale si movevano a tentoni le grandi forme cieche delle sirene dei piroscafi avanzanti dalla baia inferiore sulla prua del traghetto noi respiravamo la rancida brezza fluviale parlando ad alta voce tra scoppi di risa sbucando dalle tacite vie di Weehawken incredibili viadotti obliqui sfociano in alto nella nebbia 1. Impossibile rendere nella traduzione, qui come altrove, gli accorgimenti grafico-fonetici con cui l’autore, da buon yankee, descrive non senza intenti caricaturali la pronuncia inglese in ciò che ha di diverso da quella americana; così nelle scene in cui Joe Williams ha a che fare col falsario a Buenos Aires e coi poliziotti inglesi. (NdT)
Eveline Hutchins Le pareva di ammattire finché non riuscì a prendere il treno per tornare ad est. Mamma e papà non volevano lasciarla andare, ma lei mostrò loro un telegramma speditole da Eleanor dietro sua richiesta, col quale le si offriva un lauto stipendio nell’impresa di decorazioni. Disse che un’occasione simile non si sarebbe presentata due volte e bisognava coglierla al balzo, e poi tra poco veniva George in vacanza e loro non si sarebbero trovati soli. Quella notte poi rimase sveglia nella sua cuccetta inferiore, tremendamente felice nel rombo dell’aria e nel celere martellare delle ruote sulle rotaie. Ma dopo St. Louis cominciò a preoccuparsi: si era persuasa di essere incinta. Ne fu spaventosamente impaurita. La Grand Central Station appariva così immensa, così piena di volti squallidi che la fissavano mentre passava seguendo il facchino col bagaglio. Temeva di svenire prima di arrivare al tassì. Per tutta la strada in città i sobbalzi della vettura e il rimbombo del traffico nelle orecchie le fecero girar la testa per la nausea. Al Brevoort prese un po’ di caffè. Le alte finestre versavano luce rossastra, c’era un caldo odor di ristorante; cominciò a sentirsi meglio. Andò al telefono e chiamò Eleanor. Una cameriera francese rispose che Mademoiselle dormiva, ma non appena si fosse svegliata lei le avrebbe riferito il nome della persona che aveva telefonato. Poi telefonò a Freddy, che tradì molta emozione e promise di trovarsi lì al più presto, non appena fosse riuscito a venire da Brooklyn. Quando vide Freddy fu proprio come se quell’assenza di un anno non ci fosse stata. Lui aveva quasi un sostenitore per il balletto Maya e aveva le mani in pasta in un nuovo spettacolo musicale per cui voleva che Eveline facesse i costumi. Ma era molto pessimista circa le prospettive di una guerra con la Germania; lui era pacifista ed era certo di andare a finire in carcere se non ci si metteva di mezzo una rivoluzione. Eveline gli parlò delle conversazioni avute con José O’Riely, che era proprio un grande pittore, e chissà, probabilmente era un anarchico. Freddy si turbò e le chiese se era sicura di non essersene innamorata, e lei arrossì e disse di no, e Freddy disse che era cento volte più bella dell’anno prima.
Andarono assieme a trovare Eleanor, che aveva un lussuoso appartamento nel quartiere est della città. Eleanor stava sbrigando la corrispondenza, seduta in letto. Aveva i capelli accuratamente pettinati, e indossava una vestaglia di raso rosa guarnita di pizzo ed ermellino. Presero con lei caffè e tartine abbrustolite serviti dalla cameriera martinicana. Eleanor fu felice di rivedere Eveline e le disse che aveva un aspetto magnifico, e fece un gran mistero dei suoi affari e di tutto. Disse che stava per diventare produttrice teatrale e parlò del «mio consulente teatrale» tale e tal altro, sinché a un certo punto Eveline non seppe più che pensare; pure si vedeva bene che a Eleanor le cose andavano a gonfie vele. Eveline voleva domandarle qualcosa sui sistemi anticoncezionali, ma non riuscì a portare il discorso su quell’argomento, e fu meglio così, perché quando presero a parlare di guerra litigarono subito. Quel pomeriggio Freddy la portò a prendere il tè da una signora di mezza età che abitava nell’Ottava Strada Ovest ed era una pacifista entusiasta. La casa era piena di gente che discuteva e di giovani donne che accostavano le teste l’una all’altra sussurrandosi qualcosa d’importante. Quivi attaccò discorso con un giovane dall’aria stravolta e dagli occhi brillanti che si chiamava Don Stevens. Freddy doveva andare a una prova e lei si trattenne a parlare con Don Stevens. Poi d’un tratto si accorsero che tutti se n’erano andati lasciando loro due soli con la padrona di casa, una donna grassa, sbuffante e movimentata che per Eveline era troppo noiosa. Così Eveline salutò e se ne andò. Aveva appena messo piede in strada che Stevens la raggiunse col suo passo lungo e un po’ sgraziato, strascicandosi dietro il soprabito. «Dove andate a cena, Eveline Hutchins?» Eveline disse che non ci aveva pensato, e così senza neppure rifletterci finì per cenare con lui in un ristorante italiano nella Terza Strada. Lui mangiò in fretta una quantità di spaghetti e ci bevve sopra molto vino rosso, e la presentò al cameriere, che si chiamava Giovanni. 1 «È una massimalista come me» disse. «Questa signorina pare sia un’anarchica filosofica, ma le faremo passare questa ubbìa.» Don Stevens veniva dal Sud Dakota e aveva lavorato in giornaletti di provincia sin dai tempi della scuola media. A casa sua aveva fatto
anche il bracciante all’epoca dei raccolti, e partecipato a parecchie agitazioni dell’Internazionale lavoratori. Mostrò a Eveline con grande orgoglio la sua tessera comunista. Era venuto a New York per lavorare nel giornale «The Call», ma se ne era appena dimesso perché secondo lui quella gente non aveva fegato. 2 Scriveva anche per il «Metropolitan Magazine» e per «Masses», e prendeva la parola ai comizi antibellicisti. A parer suo c’era ben poca probabilità che gli Stati Uniti rimanessero neutrali; i tedeschi stavano vincendo, la rivoluzione in Russia era il principio della rivoluzione sociale mondiale, e i banchieri lo sapevano, così pure Wilson, restava da vedere se gli operai delle industrie dell’Est e i contadini e braccianti del Medio Occidente e Occidente si sarebbero schierati per la guerra. La stampa era tutta venduta e imbavagliata. I Morgan avevano due alternative: la guerra o la bancarotta. «È la più grande congiura della storia.» Giovanni ed Eveline ascoltavano col fiato sospeso, e Giovanni di tanto in tanto dava una sbirciata nervosa al locale per vedere se agli altri tavoli c’erano clienti dall’aria di agenti investigatori. «Alla malora, Giovanni, portaci un’altra bottiglia» esclamò Don nel bel mezzo di una lunga analisi delle proprietà estere di Kuhn Loeb and Co… Poi improvvisamente si rivolse a Eveline riempiendole il bicchiere: «Dove siete stata tutti questi anni? Avevo tanto bisogno di una bella ragazza come voi. Divertiamoci stanotte, questo potrebbe essere l’ultimo buon pasto che facciamo, tra un mese saremo fors’anche in prigione o al muro, non è vero, Giovanni?». Giovanni trascurava gli altri tavoli e il proprietario lo richiamò. Eveline continuava a ridere. Quando Don le chiese perché, disse che non lo sapeva, solo che lui era un tipo così divertente. «Ma è proprio Armageddon, alla malora.» Poi egli scosse il capo: «Ma già, è inutile, non è mai esistita una donna che ne capisca di idee politiche». «Chi te l’ha detto? Capisco benissimo, invece… E per me è una cosa terribile. Non so che fare.» «Non so che farei» replicò lui aggressivo. «Non so se combattere la mia battaglia e andare in prigione oppure fare il corrispondente di
guerra e vedere il maledetto bordello. Se si potesse contare su qualcuno che ti appoggiasse sarebbe un’altra cosa… Oh, diavolo, usciamo di qui.» Si fece segnare il conto a proprio debito e chiese ad Eveline di prestargli mezzo dollaro da lasciare a Giovanni, perché non aveva un centesimo in tasca. Così finirono per bere assieme un ultimo bicchiere di vino in una stanza fredda e disordinata al terzo piano di una casa sporca con le scale di legno in Patchin Place. Lui cominciò a farle profferte amorose, e quando lei obiettò che lo conosceva da appena sette ore disse che questa era un’altra stupida idea borghese di cui bisognava sbarazzarsi. Quando lei gli domandò informazioni sui sistemi anticoncezionali, egli le si mise a sedere accanto e per mezz’ora filata parlò di Margaret Sanger, che gran donna era, e il controllo delle nascite era la massima benedizione toccata in sorte all’umanità dall’invenzione del fuoco in poi. Quando poi le rinnovò le sue profferte in tono sbrigativo, come se fosse stata la cosa più naturale del mondo, lei rise e arrossendo si lasciò svestire. Erano le tre in punto quando, sentendosi debole, colpevole e oppressa, tornò in camera sua al Brevoort. Prese una grossa dose di olio di ricino e si mise a letto, restandovi sveglia sino all’alba a chiedersi quello che avrebbe potuto dire a Freddy. Aveva un appuntamento con lui alle undici per andare a cena dopo la prova. La paura di essere incinta era scomparsa, era come svegliarsi da un incubo. Quella primavera fu un gran progettare spettacoli e decorazioni di interni con Eleanor e Freddy, ma non se ne fece nulla, e dopo un po’ Eveline non poté più soffrire New York, figurarsi un po’: guerra dichiarata, le vie piene di bandiere e uniformi, e intorno a lei tutti quanti presi dalla mania patriottica, al punto di vedere spie e pacifisti in ogni angolino. Eleanor si stava procurando un posto alla Croce Rossa. Don Stevens si era iscritto al Friends Relief. Freddy annunciava una nuova decisione ogni giorno, ma finì per concludere che avrebbe rimandato ogni decisione al momento in cui lo avessero chiamato alle armi. Il marito di Adelaide aveva un posto a Washington nella nuova commissione marittima. Papà scriveva ogni due o tre giorni che Wilson era il più grande presidente da Lincoln in poi. A volte le
pareva di perdere la ragione, la gente intorno a lei sembrava tanto forsennata. Quando ne accennò a Eleanor, Eleanor sorrise con aria di superiorità e disse che aveva già fatto domanda per averla come assistente nel suo ufficio di Parigi. «Il tuo ufficio di Parigi, cara?» Eleanor annuì. «Non m’importa di che lavoro si tratti, lo farò di buon grado» disse Eveline. Un sabato Eleanor partì a bordo del Rochambeau, e due settimane dopo partì anche Eveline a bordo del Touraine. Era una serata estiva soffice di foschia. Aveva troncato in modo brusco, quasi rude, gli addii di Margaret e Adelaide, e di Bill, il marito di Margaret, recentemente promosso maggiore e incaricato dell’addestramento al tiro di precisione a Long Island, venuto personalmente a salutarla: era così ansiosa di lasciarsi alle spalle quest’America che le riusciva tanto piatta. La nave salpò con due ore di ritardo. La banda continuava a suonare Tipperary, Auprès de ma blonde e La Madelon. C’erano intorno molti giovani in divise svariate, tutti piuttosto sbronzi. I piccoli marinai francesi coi loro pompons rossi e le facce da bambini gridavano a dritta e a manca in rotolante e acuto dialetto bordolese. Eveline camminò su e giù per il ponte sino a stancarsi i piedi.Pareva che la nave non partisse mai. E Freddy, che era arrivato tardi, continuava a farle gran saluti dalla banchina, e lei temeva che venisse Don Stevens, e ne aveva abbastanza di tutta la vita di quegli ultimi anni. Scese in cabina e incominciò a leggere Le Feu di Barbusse, inviatole da Don. Si addormentò e, quando la sua grigia e magra compagna di cabina la svegliò dandosi d’attorno a sfaccendare, la prima cosa che percepì fu il vibrante pulsare delle macchine. «Avete perso il pranzo» disse la donna grigia. Si chiamava Miss Eliza Felton e faceva illustrazioni per libri di ragazzi. Andava in Francia a fare l’autista. Dapprima Eveline la giudicò troppo noiosa, ma col passare dei caldi e quieti giorni della traversata prese a gradirne la compagnia. Miss Felton era invadente e disturbava assai, ma amava il vino e sapeva tante cose sulla Francia, dove aveva vissuto per molti anni. Aveva infatti studiato pittura a Fontainebleau ai bei tempi dell’impressionismo. Ce l’aveva a morte
con gli unni per via di Reims e Lovanio e i poveri bambini belgi con le mani tagliate, ma d’altronde non approvava nessun governante di sesso maschile, chiamava Wilson un codardo, Clemenceau un fanfarone e Lloyd George un infingardo. Rideva delle misure precauzionali antisommergibili e diceva che la rotta francese era sicurissima appunto perché ci viaggiavano le spie tedesche. Quando sbarcarono a Bordeaux, fu di grande aiuto a Eveline. Vi si fermarono un giorno per vedere la città, invece di andar subito a Parigi assieme a tutto l’altro personale della Croce Rossa e ai lavoratori del Relief. Le file di grigie case settecentesche erano troppo graziose nell’infinito crepuscolo roseo d’estate, e i fiori in vendita e la gente cortese nei negozi e i delicati lavori di ferro battuto, e il buon pranzo al Chapon Fin. Il solo guaio della compagnia di Eliza Felton era che teneva lontani tutti gli uomini. Andarono a Parigi all’indomani col treno diurno, ed Eveline stentava a frenare la propria commozione di fronte alla bellezza del paese, delle case, delle vigne e degli alti filari di pioppi. A ogni stazione c’erano soldatini in azzurro pallido, e l’anziano e deferente capotreno pareva un professore universitario. Quando finalmente il treno scivolò per il tunnel nella stazione di Orléans, Eveline si sentì un nodo alla gola che le impediva di parlare. Era come se fosse venuta a Parigi per la prima volta in vita sua. «E adesso dove vai, cara? Vedi bene che dobbiamo portarci da noi le nostre cose» disse Eliza Felton col tono indifferente di chi si preoccupa delle necessità spicciole. «Be’, credo che dovrei andare a presentarmi alla Croce Rossa.» «Troppo tardi per oggi, lasciatelo dire da me.» «Potrei tentar di fare una telefonata a Eleanor.» «Cercare di servirsi del telefono a Parigi in tempo di guerra è come tentar di risuscitare i morti… la cosa migliore che puoi fare, mia cara, è venire con me in un alberghetto che conosco io sul Quai e presentarti alla Croce Rossa domattina; è quello che faccio io.» «Mi seccherebbe a morte farmi rimandare a casa.» «Ci vorranno settimane perché si accorgano di te… Li conosco bene, quei tonti.»
Così Eveline stette ad aspettare coi bagagli mentre Eliza Felton andava a pescare un camioncino. Vi caricarono i bagagli, e nell’ultimo riverbero malva del crepuscolo li portarono fuori dalla stazione all’albergo passando per le strade vuote. C’erano pochissimi lampioni, e quei pochi erano azzurri e incappucciati di latta per non essere visti dall’alto. La Senna, i vecchi ponti e la massa allungata del Louvre di fronte apparivano tenui e irreali; era come camminare in un quadro di Whistler. «Bisogna spicciarsi e procurarsi qualcosa da mangiare prima che chiudano tutto… Ti porterò da Adrienne» disse Miss Felton. Lasciarono le valigie al portiere dell’albergo del quai Voltaire e infilarono a passo lesto un labirinto di viuzze che l’oscurità andava sommergendo. Si ficcarono nella porta di un piccolo ristorante proprio nel momento in cui qualcuno cominciava ad abbassare la pesante saracinesca. «Tiens, c’est Mademoiselle Elise!» esclamò una voce di donna dal fondo del localino pesantemente tappezzato. Una francese di bassa statura dalla testa voluminosa e dagli occhi grossi e sporgenti venne di corsa ad abbracciare Miss Felton e la baciò ripetutamente. «Vi presento Miss Hutchins» disse Miss Felton con la sua voce secca. «Molto piacerre… com’è carrina… e che begli occhi, eh?» A Eveline dava un senso d’imbarazzo il modo in cui quella donna la guardava, il modo in cui il suo grosso volto incipriato stava piantato, come un uovo in una tazzina, nella blusa a collo alto con frangia. Essa servì loro un po’ di minestra e di vitello freddo con pane, scusandosi un mondo perché non aveva burro né zucchero e lamentandosi con la sua voce cantilenante della severità della polizia, e dei profittatori che facevano incetta di viveri, e della brutta situazione militare. Poi si fermò di colpo; i loro occhi si posarono tutti contemporaneamente sulla scritta murale: MÉFIEZ-VOUS! LES OREILLES ENNEMIES VOUS ÉCOUTENT! «Enfin c’est la guerre» disse Adrienne. Stava seduta accanto a Miss Felton e le dava affettuosi colpetti sulla mano con la propria mano grassoccia ricoperta di anelli con gioielli falsi. Fece portar loro il caffè. Si bevvero bicchierini di Cointreau. Essa si sporse verso Eveline e le diede colpetti sul collo. «Faut pas s’en faire, hein?» Poi arrovesciò la
testa ed emise una stridula risata isterica. Continuava a versare bicchierini di Cointreau, e Miss Felton stava evidentemente diventando alticcia. Adrienne continuava a vezzeggiarle la mano. Eveline si sentiva girare la testa nell’angusto locale soffocante, chiuso e oscuro. Si alzò e disse che tornava all’albergo, che aveva il mal di testa e un sonno da morire. Le altre cercarono con ogni blandizia di persuaderla a rimanere, ma lei uscì passando sotto la saracinesca semiabbassata. Fuori, la strada era a metà illuminata dalla luna e a metà immersa in una tenebra di pace. Tutt’a un tratto a Eveline venne in mente che non sapeva la strada dell’albergo, eppure non poteva rientrare in quel ristorante, quella donna le faceva ribrezzo, e così proseguì a passo lesto tenendosi dalla parte illuminata, impaurita dal silenzio e dalle rade ombre di passanti e dalle vecchie case squallide che sbadigliavano coi loro portoni d’inchiostro. Finalmente sbucò in un boulevard dove c’erano uomini e donne a spasso, voci, e ogni tanto un’automobile coi fari azzurri che correva silenziosa sull’asfalto. Improvvisamente si accese in distanza l’urlo allucinato di una sirena, poi un altro e un altro ancora. In qualche punto perduto nel cielo c’era un debole ronzio come d’ape, prima più forte, poi più tenue, poi ancora più forte. Eveline guardò la gente che aveva attorno. Nessuno pareva allarmarsi o affrettare il passo. «Les avions… les boches…» così diceva la gente col tono normale di chi non si scompone. Eveline si trovò ferma sul marciapiede a scrutare il cielo latteo che i riflettori venivano rapidamente screziando. Vicino a lei c’era un paterno ufficiale francese con un arabescatissimo chepì, e i baffoni cadenti. In alto il cielo cominciò a luccicare come mica; era una cosa bella e lontana, come fuochi d’artificio visti dall’altra parte del lago sulla Quarta Strada. Involontariamente essa uscì a dire: «Che cos’è?». «È uno shrapnel, mademoiselle. Sono i nostri cannoni antiaerei» disse l’altro in accurato inglese, e poi le offrì il braccio e le propose di accompagnarla a casa. Essa notò che odorava di cognac, ma era molto simpatico e paterno di modi e faceva gesti buffi per significarle che venivan giù proiettili sulle loro teste e le raccomandava di mettersi al riparo insieme a lui. Lei lo pregò di
accompagnarla all’Hôtel du Quai Voltaire, perché aveva smarrito la strada. «Ah charmant, charmant» disse l’anzianotto ufficiale francese. Mentre loro due se ne stavano lì a chiacchierare, tutti gli altri s’erano dileguati. Adesso si sentivano latrare cannoni da tutte le parti. Ora avevano infilato di bel nuovo le viuzze, tenendosi addossati al muro. A un certo punto lui la tirò di colpo in un portone e qualcosa cadde con rimbombo metallico sul selciato dirimpetto. «Schegge di shrapnel, non buono» disse picchiettandosi in cima al chepì. Fece una risata, subito imitato da Eveline e da quel momento andarono d’accordo ch’era un piacere. Erano sboccati sulla riva del fiume. Chissà perché, il fitto fogliame degli alberi dava un senso di sicurezza. Dalla parte dell’albergo lui additò improvvisamente un punto nel cielo: «Guarda, sono i Fokker, ils s’en fichent de nous». Mentr’egli parlava, gli aeroplani tedeschi roteavano sulle loro teste inargentandosi le ali di luna. Per un attimo furono come sette esili libellule d’argento, poi svanirono. In quel momento stesso giunse dall’altra riva lo scoppio lacerante di una bomba. «Permettez, mademoiselle.» Entrarono nell’atrio di un albergo e nel buio pesto fecero a tastoni la scala della cantina. Quando ebbe fatto scendere Eveline dall’ultimo gradino della polverosa scala di legno, l’ufficiale salutò gravemente la promiscua adunanza di persone in vestaglia o in camicia da notte e soprabito, raggruppate attorno a un paio di candele. C’era un cameriere, e l’ufficiale si provò a ordinare da bere, ma il cameriere disse: «Ah, mon colonel, c’est défendu», e il colonnello storse il viso per il dispetto. Eveline sedette sopra una specie di tavolo. Era così presa dall’emozione di osservare la gente e ascoltare le lontane esplosioni delle bombe da non accorgersi quasi che il colonnello le stava premendo il ginocchio un po’ più del necessario. Le mani del colonnello divennero un problema. Quando l’incursione fu terminata, passò sulla strada qualcosa che faceva un verso bizzarro, tra lo squacquero dell’anatra e il raglio dell’asino. A Eveline fece un effetto così comico da provocarle un riso irrefrenabile, che sconcertò alquanto il colonnello. Quando lei cercò di congedarlo con un bel «Buonanotte» per poi salire in camera a prendersi un po’ di sonno, voleva salire
anche lui. Essa non sapeva che fare. Era stato così simpatico e gentile che non voleva usargli sgarbatezza, ma comunque non c’era verso di fargli capire che aveva voglia di andare a letto e dormire; lui rispondeva che avrebbe fatto la stessa cosa. Quand’essa tentò di spiegargli che aveva un’amica in camera con sé, lui domandò se era affascinante come Mademoiselle, perché in tal caso ne sarebbe stato deliziato. Eveline non seppe più farfugliare una parola in francese; non riuscì a far comprendere al portiere che voleva la chiave della sua stanza e che mon colonel non veniva su con lei, e stava già per cadere in una crisi di pianto quando un giovane americano in borghese con la faccia rossa e il naso all’insù, comparso dall’ombra, disse in pessimo francese agitando le mani: «Monsieur, moi frère de madmosel, non vedete che la ragazza è stanca e ha voglia di darvi il bonsoir?». Poi infilò il braccio sotto quello del colonnello e disse: «Vive la France… Salite in camera mia e beviamo qualcosa assieme». Il colonnello si irrigidì manifestamente incollerito. Senza star a vedere il seguito, Eveline corse su per le scale fino in camera sua, vi si precipitò dentro e chiuse la porta a doppia mandata. 1. In italiano nel testo. (NdT) 2. Credo opportuno richiamare il lettore alla straordinaria vivacità dell’espressione idiomatica americana lilylivered, “dal fegato di giglio”, che ricorda un po’ il linguaggio shakespeariano. (NdT)
Cine-giornale XXIV non si può immaginare l’entità colossale dei prestiti che l’Europa dovrà contrarre per rifarsi delle distruzioni apportate dalla guerra ELIMINA DA SOLO 28 UNNI Le Voci di Pace Cominciano ad Avere le Loro Ripercussioni sul Mercato Meridionale del Ferro UN RAGAZZO DEL POSTO CATTURA UN UFFICIALE UN TERZO DELLE ASSEGNAZIONI DI GUERRA FRODATO Ci son sorrisi che ci rendono felici sorrisi che ci tingono d’azzurro riesaminiamo la questione delle tariffe si supponga che gli Stati Uniti stiano manovrando flotte comprendenti 3000 fra navi da carico e da passeggeri per il servizio fra USA e porti stranieri CAPOBANDA ASSASSINATO PER VIA Ci son sorrisi che cancellano le lacrime come i raggi del sole la rugiada ci son sorrisi che hanno un tenero senso che solo gli occhi dell’amore san vedere I VOTI DEI SOLDATI HANNO VINTO LE ELEZIONI supponiamo ora che in questo delicato gioco di leggi economiche intervenga il fattore decisivo costituito dal possessore di un terzo del tonnellaggio mondiale, il quale consideri con equanimità sia profitti sia perdite, non calcoli come componente nel costo di gestione l’interesse sull’investimento di capitale, costruisca navi indipendentemente dalla possibilità di un loro impiego redditizio e imponga tariffe commisurate in modo non rigoroso alle leggi della domanda e dell’offerta; entro quanto tempo i trasporti oceanici del mondo intero subirebbero un completo collasso? IL PRINCIPE EREDITARIO IN FUGA Ma i sorrisi che mi riempiono il cuore di sole sono i sorrisi che
mi dai tu le insistenti voci di pace sono un fattore di instabilità e l’epidemia d’influenza ha dissuaso gli acquirenti campagnoli dal visitare i grandi centri
Occhio fotografico (32) à quatorze heures précisément i boches cannoneggiavano quotidianamente quel ponte con la loro solita precisione in quanto a tempo e spazio à quatorze heures précisément Dick Norton col monocolo all’occhio allineò il suo reparto a poca distanza dal ponte per consegnarlo alla Croce Rossa americana i maggiori della Croce Rossa erano grassocci e bianchi sotto le loro divise coi cinturoni e i lucidi gambali di cuoio così questa era la terra d’oltremare così questo era il fronte bene bene Dick Norton si aggiustò il monocolo e prese a dire che ci aveva assunti come gentiluomini volontari e come gentiluomini volontari ci salutava Huam! il primo arrivé l’odor di mandorle il senso domenicale di strada deserta senza un poilu in vista Dick Norton si aggiustò il monocolo i maggiori della Croce Rossa si sentirono addosso una pioggia di fango fiutarono la lyddite zaffata di latrine e truppe agglomerate Huam huam huam come il Quattro luglio le schegge cantano le orecchie risuonano il ponte è sempre in piedi e Dick Norton che si aggiusta il monocolo è sempre in piedi parla diffusamente di gentiluomini volontari e servizio d’ambulanza e la belle France l’auto del Comando è lì ma dove sono i maggiori che devono prendere il comando che dovevano fare un discorso a nome della Croce Rossa? Il più lento bianco e paffuto dei maggiori è ancora visibile cammina a quattro zampe coi gambali inzaccherati di fango strisciando verso il rifugio poi non vedemmo più nemmeno l’ombra dei maggiori della Croce Rossa e non sentimmo più parlare di gentiluomini o volontari
Il lieto guerriero I Roosevelt abitavano da sette generazioni l’isola di Manhattan; possedevano una grossa casa di mattoni nella Ventesima Strada, una tenuta su a Dobbs Ferry, appezzamenti di terreno in città, un banco riservato nella chiesa riformata olandese, interessi, titoli e obbligazioni, si sentivano padroni di Manhattan, si sentivano padroni dell’America, il loro figliolo, Theodore, era un giovanetto malaticcio, soffriva d’asma, era molto miope; aveva mani e piedi così piccoli da rendergli arduo l’apprendimento del pugilato; le braccia aveva assai corte; suo padre era qualcosa come un umanitario, offriva pranzi di Natale agli strilloni, deplorava le condizioni di vita di certa gente, i tuguri, l’East Side, Hell’s Kitchen. Il giovane Theodore ebbe i suoi ponies, fu abituato a far passeggiate nei boschi e campeggi, addestrato al pugilato e alla scherma (un gentiluomo americano deve sapersi difendere), istruito nella Bibbia, incaricato di opera missionaria (un gentiluomo americano deve fare del suo meglio per aiutare chi è meno fortunato di lui); la rettitudine era un suo appannaggio di nascita; aveva la passione del naturalista, delle letture sugli uccelli e gli animali selvatici, della caccia; finì per diventare un buon tiratore a dispetto dei suoi occhiali, un buon podista a dispetto dei piedi piccoli e delle gambe corte, un cavaliere provetto, un lottatore aggressivo a dispetto delle braccia corte, un politico d’avanguardia a dispetto della sua appartenenza a una ricca famiglia olandese di New York. Nel 1876 andò a Cambridge per studiare a Harvard, ed era un facoltoso giovane loquace ed eccentrico, provvisto di favoriti e di idee precise su tutto quello che v’è sotto il sole, a Harvard girava in carrozzella, raccoglieva uccelli imbalsamati, impagliava esemplari da lui stesso abbattuti nelle gite sugli Adirondack, pur essendo astemio e avendo una mentalità da attivista
cristiano, con bizzarre idee sulla riforma del costume, frequentava il Porcellian e il Dickey e i circoli che gli spettavano di diritto in quanto figlio di una delle ricche famiglie olandesi di New York. Diceva agli amici che aveva intenzione di consacrare la vita a una missione sociale: Io voglio predicare non già la dottrina dell’ignobile quietismo, ma la dottrina della vita strenua, vita di fatica e sforzo, di lavoro e lotta. Sin da quando aveva undici anni scrisse copiosamente, riempì diari, taccuini, fogli volanti con la sua grossa calligrafia impulsiva, parlando di tutto ciò che faceva, pensava e diceva; naturalmente studiò legge. Si sposò giovane e andò in Svizzera a scalare il Cervino; la morte immatura della prima moglie lo sconvolse tutto. Se ne andò nelle terre incolte ed erose del Dakota occidentale a fare il ranchero, sul Little Missouri; quando tornò a Manhattan era ormai conosciuto come Teddy, il grande tiratore del West, il cacciatore d’alci, l’uomo dal cappello alla Stetson, che aveva preso tori al lazo, lottato a corpo a corpo con un orso grigio, ricoperto le mansioni di vicesceriffo: (Un Roosevelt ha un preciso dovere verso il suo paese; il dovere di un Roosevelt è di aiutare i meno fortunati di lui, che sono venuti da meno tempo a queste rive); nel West, il vicesceriffo Roosevelt provò il fardello dell’uomo bianco, collaborò ad arrestare malfattori, uomini malvagi; il servizio era una cosa magnifica. Durante questo periodo aveva continuato a scrivere, a riempire le riviste di racconti di caccia e d’avventure, a riempire i comizi politici delle sue opinioni, delle sue denunce, delle sue frasi fatte: “Vita strenua”, “Ideali realizzabili”, “Governo giusto”, quando gli uomini temono il lavoro o temono la guerra giusta, quando le donne temono la maternità, vacillano sull’orlo dell’abisso, ed è bene che spariscano dalla faccia della terra, dove costituiscono un giusto bersaglio per il disprezzo di tutti gli uomini e le donne che sono forti, intrepidi e di alto sentire. T.R. sposò una donna ricca e nel segno della giustizia si crebbe una famiglia a Sagamore Hill.
Fece un periodo nella Legislatura di New York, gli fu conferito da Grover Cleveland il poco remunerativo incarico di commissario alla Riforma del servizio civile, fu commissario riformista della polizia di New York, perseguitò i malfattori; sostenne a spada tratta che bianco era bianco e nero nero, scrisse The Naval War of 1812, fu nominato sottosegretario alla Marina, e quando saltò in aria la Maine diede le dimissioni per assumere il comando dei Rough Riders, 1 tenente colonnello. Questo era il Rubicone, la Lotta, l’Old Glory, la Giusta Causa. Il pubblico americano non fu tenuto all’oscuro del valore dimostrato dal colonnello sotto il fischiar delle pallottole, quando andò alla carica senza i suoi uomini su per la collina di San Juan e dovette tornare indietro a prenderli, quando colpì al volo uno spagnolo che fuggiva. Ma purtroppo i regolari avevano conquistato per primi l’altura salendo dall’altra parte. Santiago si arrese; fu una campagna fortunata. T.R., dopo il combattimento della collina di San Juan, conquistò di colpo la carica di governatore dello Stato imperiale; ma dopo i combattimenti, volontari, corrispondenti di guerra, collaboratori di riviste cominciarono a desiderare il rimpatrio; non era una cosa esaltante starsene raggomitolati sotto le tende da campagna nella pioggia tropicale o abbrustolire al sole mattutino delle riarse alture cubane, mietuti dalla malaria e dalla dissenteria, e con la spada di Damocle della febbre gialla sulla testa. T.R. si rivolse al presidente senza tante storie e chiese che i guerrieri dilettanti, i giusti volontari, fossero rimandati a casa lasciando le estenuanti corvées del riassetto ai regolari che stavano scavando trincee e spalando rifiuti e combattendo malaria dissenteria e febbre gialla per apprestare una Cuba decente allo Sugar Trust e alla National City Bank. Quando sbarcò in patria, una delle sue prime interviste ebbe luogo con Lemuel Quigg, emissario del capoccia Platt che aveva in tasca i voti dello Stato di New York settentrionale;
ed ebbe anche occasione di vedere personalmente il capoccia Platt, ma poi se ne dimenticò. Le cose andavano a gonfie vele. Scrisse una vita di Cromwell, che secondo la gente gli assomigliava. Da governatore attaccò proditoriamente il meccanismo elettorale Platt; un uomo probo può essere debole di memoria. Il capoccia Platt credette di relegarlo nel dimenticatoio eleggendolo vicepresidente nel 1900; Czolgocz lo elesse presidente. T.R., sotto la pioggia scrosciante, si lanciò in calesse come un diavolo scatenato sulle strade fangose diramantisi dal monte Marcy negli Adirondack per arrivare a prendere il treno per Buffalo, dove McKinley stava morendo. Da presidente trasferì Sagamore Hill, la sana felice casa americana normale, alla Casa Bianca, portò diplomatici stranieri e grassi ufficiali dell’esercito in passeggiata al Rock Creek Park, dove li obbligò a una sarabanda infernale attraverso roveti, saltando il torrente di sasso in sasso, guadando in vari punti, inerpicandosi su per le sponde schistose, e agitò minacciosamente il Bastone del Castigamatti contro i malfattori della plutocrazia. Le cose andavano a gonfie vele. Egli predispose l’ingranaggio della rivoluzione di Panama, all’ombra della quale si attuò quel famoso trucco grazie a cui le vecchie e nuove compagnie del Canale rimasero giocate e quaranta milioni di dollari sparirono nelle tasche dei banchieri internazionali, ma l’Old Glory garrì sulla Zona del Canale e il canale fu aperto. Egli mandò a carte quarantotto qualche trust, invitò Booker Washington a colazione alla Casa Bianca, e patrocinò la salvaguardia del patrimonio faunistico. Vinse il premio Nobel per la Pace per aver combinato la Pace di Portsmouth che pose termine alla guerra russo-giapponese e mandò la flotta atlantica in giro per il mondo a dimostrare a tutti che l’America era una grande potenza. Dopo il suo secondo periodo di carica cedette la presidenza a Taft, lasciando a quel pachidermico avvocato il delicato compito di versare olio legale sui sentimenti offesi
dei padroni del denaro e andò in Africa a far caccia grossa. La caccia grossa era una cosa magnifica. Ogni volta che un leone o un elefante si abbatteva di schianto nel sottobosco della giungla, fulminato da un preciso proiettile a fungo, i giornali uscivano con titoli cubitali; quando parlò col Kaiser a dorso di cavallo il mondo non ignorò le sue parole, idem quando tenne una conferenza ai nazionalisti al Cairo per dir loro che il mondo era dei bianchi. Andò in Brasile, percorse il Mato Grosso in piroga in acque infestate dalla piranha, piccolo pesce cannibale, abbatté tapiri, giaguari, esemplari di pecari labbro bianco. Fece le rapide del fiume del Dubbio giungendo alle frontiere delle Amazzoni, ammalato con un ascesso suppurato alla gamba, steso nella piroga sotto il riparo di un telone, con a fianco un uccello trombettiere addomesticato. Di ritorno negli Stati Uniti combatté la sua ultima battaglia nel 1912 quando si presentò alle elezioni come candidato repubblicano, progressista, campione dello Square Deal, 2 paladino della Gente Semplice; il Bull Moose 3 saltò fuori dal rullo compressore Taft e formò il partito progressista per la causa della giustizia al Colosseum di Chicago, mentre i delegati che intendevano restaurare il governo democratico ondeggiavano con le lacrime agli occhi cantando A vanti so ol dati cristia aani mar ciando co me in gue eerra. Forse il fiume del Dubbio era stato troppo per un uomo della sua età; forse le cose non andavano più a gonfie vele come una volta; T.R. perdette la voce durante la campagna triangolare. A Duluth un maniaco lo colpì al petto con una rivoltellata, e gli salvò la vita soltanto lo spesso fascicolo di manoscritti del discorso che doveva tenere. T.R. tenne il discorso col proiettile ancora in corpo, udì gli applausi sgomenti, sentì che la gente semplice pregava per la sua
guarigione, ma in un modo o nell’altro l’incanto era rotto. I democratici irruppero vittoriosi; la guerra mondiale sommerse la voce giusta del Lieto Guerriero nel ruggito degli esplosivi. Wilson non consentì a T.R. di comandare una divisione; questa non era guerra da dilettanti (forse i regolari si ricordavano della silurata di Santiago). Tutto quello che poté fare fu scrivere articoli sulle riviste contro gli unni e mandare al fronte i figli; Quentin cadde in combattimento. Non era più il bel mondo da dilettante entusiasta. Nessuno seppe che il giorno stesso dell’armistizio Theodore Roosevelt, lieto dilettante dal sorriso di squalo e dall’indice tremolante, naturalista, esploratore, articolista, insegnante delle scuole domenicali, cowboy, moralista, politico, retto oratore di cattiva memoria, impuntato a denunciare i bugiardi (l’Ananias Club) e a fare allegramente a cuscinate coi figlioli, fu portato all’ospedale Roosevelt gravemente ammalato di reuma infiammatorio. Le cose non andavano più a gonfie vele; T.R. aveva fegato da vendere sopportò il dolore, l’oscurità, quel senso di essere dimenticato, con la stessa fermezza con cui aveva sopportato il proiettile del pazzo e i viaggi massacranti sostenuti nell’esplorazione del fiume del Dubbio, il calore, la fetida mota della giungla, l’ascesso suppurato alla gamba, e morì tranquillamente nel sonno a Sagamore Hill il 6 gennaio 1919 e lasciò sulle spalle dei figli il fardello dell’uomo bianco. 1. “Rudi cavalieri”; era questo un corpo volontario di cavalleria. (NdT) 2. Appr. “giustizia e lealtà”. (NdT) 3. Nomignolo corrente degli appartenenti al Progressive Party: la parola bull significa “toro”, per caratterizzare l’irruenza dei progressisti. (NdT)
Occhio fotografico (33) 11.000 prostitute di mestiere dissero che i propagandisti della Croce Rossa infestano le vie di Marsiglia la Ford andò in panne tre volte in rue de Rivoli a Fontainebleau ci prendemmo il caffelatte a letto la foresta era così dolorosamente rossa e gialla bruna di novembre sotto la fina pioggia di lavanda al di là la strada si inerpicava per colline color tortora l’aria sapeva di mele Nevers (Dumas nom de Dieu) Athos Porthos e d’Artagnan avevano ordinato all’albergo una buona minestra di brodo ristretto a forza di lente giravolte entrammo nella rossa Macon che sentiva di mosto e vendemmia fais ce que voudras saute Bourguignon nella valle del Rodano il primo sole paglierino striava la strada bianca di ombre di pioppi ischeletriti a ogni sosta bevevamo vino forte come le bistecche ricchi come il palazzo di Francesco I un mazzo di ultime rose sferzate dal nevischio non traversammo il fiume per entrare in Lione dove Jean-Jacques ancor giovincello soffrì di clorosi i paesaggi della Provenza eran tutti presi di sana pianta dal De bello gallico le città eran dizionari di radici latine Orange Tarascona Arles dove Van Gogh si tagliò le orecchie il viaggio in colonna divenne qualcosa come un giro di piacere a itinerario fisso ci fermavamo a giocare a dadi nelle bettole ragazzi si va a sud a bere il vin rosso che i papi preferivano mangiare cibi grassi conditi con aglio ed olio d’oliva direzione sud cèpes provençale la tramontana infieriva sulla piana di Camargue sospingendoci alla rinfusa in Marsiglia dove le undicimila indulgevano alla propria civetteria negli specchi appannati del promenoir all’Apollo ostriche e vino di Cassis petite fille tellement brune tête de lune qui aimait les “vinter” 1 sports alla fine erano altrettante distributrici automatiche svestite come statuette focesi piantate a gambe divaricate intorno agli orli schiumosi dell’antichissimo porto la Riviera fu una delusione ma c’era una chiesa color candito col campanile a punta sopra ogni colle dopo Sanremo Porto Maurizio azzurre bottiglie di selz erette nel sole color cinzano accanto a un bicchiere di VERMOUTH TORINO Savona era uno scenario da
Mercante di Venezia quale soltanto il Veronese avrebbe potuto dipingere Ponte Decimo a Ponte Decimo le ambulanze furono parcheggiate in una piazza di pietra desolata invasa dalla luna case di operai la brina imbiancava tutto nel piccolo bar l’articolista di grido ci insegnò a bere cognac e maraschino, metà e metà su, prendetene un altro 2 venne a galla che lui non scriveva quello che sentiva di voler scrivere Che cosa si può mai dire della guerra a quelli che son rimasti a casa? venne a galla che non ci teneva affatto a quello che scriveva, ci teneva a sentire Cognac e maraschino non era più giovane (Ci fece tanto male a noi avidi di ciò che sentivamo noi volevamo dirglielo a tutti quanti che mentivano veder nuove città andare a Genova) Un altro? venne a galla che lui avrebbe voluto essere uno scugnizzo bruno seduto sulle falde di un colle a suonare il flauto nel sole andare a Genova fu una bazzecola c’era il tram Genova la nuova città che non avevamo mai vista piena di dogi marmorei e scalinate da fiaccarti il collo e leoni nel chiaro di luna Genova l’antica città ducale era in fiamme? tutti i palazzi di marmo e le quadrate case di pietra e i campanili sormontanti le colline avevano una parete in fiamme falò sotto la luna i bar erano pieni di inglesi borghesi imbacuccati a spasso sotto i portici fuori il porto sotto la luna di Genova il mare era in fiamme l’uomo dell’Intelligence Service di Sua Maestà disse che era una nave cisterna americana aveva incocciato una mina? un siluro? perché non l’affondano? Genova i nostri occhi avvampavano all’incendio della nave cisterna Genova che cosa cercate, la vampa nel sangue sotto la luna per le vie di mezzanotte? nei volti dei ragazzi e delle fanciulle Genova occhi la domanda nei loro occhi attraverso i cortili di pietra in sfacelo sotto la luna di Genova su e giù per le scale da fiaccarti il collo occhi in fiamme sotto la luna svoltato l’ultimo angolo in pieno viso la vampa dell’immenso falò marino 11.000 prostitute di mestiere dissero che i propagandisti della Croce Rossa infestano le vie di Marsiglia
1. La deformazione grafica di winter (“inverno”), assai più marcata nel testo, dove, seguendo le regole fonetiche inglesi, è riportata come «veentair», quindi con alterazione anche dei timbri vocalici, è intenzionale nell’autore; riproduce errori di pronuncia francesi. (NdT) 2. Anche qui, impossibile rendere il colorito delle alterazioni di pronuncia: il testo porta «havanuzzerone» come deformazione fonetica di have another one (cioè another glass, “un altro bicchiere”). (NdT)
Joe Williams Fu un viaggio cane. Dal primo momento sino all’ultimo, Joe fu ossessionato dal pensiero di Del e dalla preoccupazione di non essere all’altezza della situazione, e l’equipaggio di coperta era un branco di permalosi. Le macchine continuavano a guastarsi. Lo Higginbotham era costruito come una scatola di formaggio, e così lento che in certi giorni non si fecero più di trenta o quaranta miglia con venti moderati in prua. Il solo suo svago fu quello di prender lezioni di pugilato dal secondo macchinista, un tipo che si chiamava Glen Hardwick. Era un ometto nerboruto, e un discreto pugile dilettante, ad onta dei suoi quarant’anni. Quando arrivarono a Bordeaux, Joe era ormai in grado di tenergli testa molto bene. Aveva un peso superiore e braccia più lunghe, e, stando a Glen, un diretto destro naturale che come peso leggero gli avrebbe fatto far carriera. A Bordeaux il primo funzionario portuale che salì a bordo cercò di baciare capitan Perry su ambe le guance. Il presidente Wilson aveva appena dichiarato guerra alla Germania. La città non sapeva più che cosa fare per les américains. Di sera, quando erano in franchigia, Joe e Glen Hardwick facevano assieme le loro perlustrazioni. Le ragazze di Bordeaux erano maledettamente carine. Un pomeriggio ai giardini pubblici ne conobbero un paio che non erano affatto puttane. Erano ben vestite e avevano l’aria d’essere di buona famiglia, che diavolo, si era in guerra. A tutta prima Joe pensò che ormai, ammogliato com’era, avrebbe dovuto farci sopra una croce, ma caspita, Del non gli aveva negato soddisfazione? E per chi lo aveva preso, per un santo di gesso? Finirono per andare a un alberghetto che le ragazze conoscevano, cenare e bere beaucoup vino e champagne e fare una nottata d’incanto. Joe non si era mai divertito tanto con una ragazza in vita sua. La sua ragazza si chiamava Marceline, e quando si svegliarono al mattino il cameriere portò loro caffè e tartine e fecero colazione, tutti e due seduti in letto, e il francese di Joe cominciò a venire a galla, e lui imparò a dire C’est la guerre e On les aura e Je m’en fiche e Marceline disse che sarebbe sempre stata la sua ragazza finché lui era a Bordeaux e lo chiamò petit lapin.
A Bordeaux si fermarono solo i quattro giorni necessari ad aspettare il turno di scarico, ma per tutto quel tempo non fecero che bere vino e cognac, e il mangiare era squisito, e tutti si profondevano in gentilezze perché l’America era entrata in guerra, e quelli furono quattro giorni memorabili. Nel viaggio di ritorno lo Higginbotham fece falle così brutte che il vecchio non si preoccupò neppure più dei sommergibili. Potevano considerarsi davvero fortunati se ce la facevano ad arrivare a Halifax. Il bastimento era leggero e rollava come un guscio, tanto che nonostante gli appositi accorgimenti non si riusciva a tenere i piatti sulla mensa. In una nottataccia di nebbia, a sud di Capo Race, Joe stava facendo un giro di ponte a metà nave, ben imbacuccato nel suo pastrano, quando si sentì improvvisamente gettare a terra. Non si poté nemmeno sapere da che cosa fossero stati colpiti, se da una mina o da un siluro. E se riuscirono a cavarsela fu solo perché le scialuppe erano in perfetto ordine e il mare liscio come un olio. Le quattro scialuppe finirono per dividersi. Lo Higginbotham sparì nella nebbia e non lo si vide nemmeno affondare, ma l’ultima volta che lo si poté scorgere aveva già il ponte principale a fior d’acqua. Avevano freddo ed erano bagnati. Nella barca di Joe nessuno parlava gran che. I rematori dovevano faticare alquanto per spingerla diritta nella maretta che s’alzava. Ogni ondata un po’ più grossa delle precedenti li inondava di spruzzaglia. Avevano indosso vestiti piuttosto pesanti e salvagente, ma il freddo penetrava. Finalmente la nebbia ingrigiò un poco e fu giorno. La barca di Joe e quella del capitano riuscirono a tenersi in contatto sino al tardo pomeriggio, allorché furono raccolti da una grossa goletta adibita alla pesca dei merluzzi, diretta a Boston. Quando furono presi a bordo, capitan Perry era piuttosto malconcio. Il capitano della goletta da pesca fece tutto il possibile per lui, ma quando raggiunsero Boston quattro giorni dopo egli aveva già perso la conoscenza e morì durante il trasporto all’ospedale. I dottori dissero che era polmonite. L’indomani Joe e il secondo andarono all’ufficio del rappresentante di Perkins e Ellerman, gli armatori, per veder di
ottenere la paga per sé e l’equipaggio. C’era in ballo uno dei soliti maledetti pasticci burocratici perché la nave aveva cambiato proprietario a metà Atlantico: l’aveva comperata per una speculazione un tizio a nome Rosenberg, e ora non c’era verso di trovarlo e la Chase National Bank rivendicava la proprietà e i sottoscrittori stavano piantando grane. Il rappresentante disse che certamente le paghe sarebbero state versate com’era giusto, perché Rosenberg aveva contratto un’obbligazione in merito, ma ci sarebbe voluto tempo. «E che diavolo dovremmo fare intanto secondo quella gente, mangiar erba?» L’impiegato disse che a lui spiaceva molto, ma la questione bisognava trattarla direttamente col signor Rosenberg. Joe e il secondo stettero a fianco a fianco sul marciapiede fuori dell’agenzia e imprecarono per un po’, quindi il secondo se ne andò a South Boston a mettere al corrente della faccenda il primo nocchiero, che abitava in quei paraggi. Era un caldo pomeriggio di giugno. Joe cominciò a fare il giro delle agenzie di navigazione per vedere di procurarsi un ingaggio. Se ne stancò presto, e allora andò a sedersi su di una panchina al Common, e stette a guardare i passeri, i marinai che andavano a zonzo e le commesse che rincasavano dal lavoro con una secca e svelta cadenza di tacchi sull’asfalto. Per due settimane Joe girò per Boston completamente al verde. L’Esercito della Salvezza si prese cura dei superstiti dando loro fagioli, minestre acquose e un mucchio di inni stonati che non erano proprio l’ideale per Joe, in quei momenti. Non ne poteva più dalla voglia di procurarsi i soldi necessari a recarsi a Norfolk dalla sua Del. Le scriveva ogni giorno, ma le lettere che riceveva di ritorno fermo posta parevano un po’ freddine. Era preoccupata dell’affitto e aveva bisogno di abiti primaverili e temeva che in ufficio si seccassero eventualmente di saperla sposata. Joe stava seduto sulle panchine al Common e girellava per le aiole ai giardini pubblici, e si presentava regolarmente all’agenzia per cercare un posto, ma poi si stufò di stare in ballo per niente a quel modo, e andò ad imbarcarsi come quartiermastro su una nave della United Fruit, la Callao. Pensava che sarebbe stato un viaggetto da nulla
e che una volta tornato avrebbe potuto avere la sua paga in due settimane. Nel viaggio di ritorno dovettero rimanere alla fonda parecchi giorni in rada a Roseau in Dominica, in attesa che i limoni da caricare venissero imballati nelle apposite casse. Ce l’avevano tutti a morte con le autorità portuali, una masnada di negri inglesi, per via della quarantena, dei limoni che non erano mai pronti e della lentezza con cui venivano da riva le chiatte. L’ultima notte che rimasero in porto Joe e Larry, uno degli altri quartiermastri, scambiarono quattro chiacchiere con certi giovani negri di una barca che avevano accostato a poppa per vendere frutta e liquori alla ciurma; ed ecco, venne loro in mente di offrire un dollaro a testa ai negri per farsi portare a riva in un punto discosto dalla spiaggia dove gli ufficiali non potessero vederli. La città odorava di negri. Non c’erano luci nelle vie. Un giovincello nero come un tizzo li abbordò per offrir loro polli di montagna. «Scommetto che vuol dire donne di colore, vuoi vedere?» disse Joe. «Questa è la notte delle sorprese.» Il negretto li condusse in un bar gestito da una massiccia mulatta, e le disse qualcosa di incomprensibile nel gergo dell’isola, e lei disse che c’era da aspettare qualche minuto, così loro si misero a sedere e ordinarono un paio di bibite al grano e all’olio. «Quella dev’essere la maîtresse» disse Larry. «Ma se non sono più che carine, per me possono andarsene al diavolo. A me la carne scura non va giù.» Dalla retrobottega venne uno sfriggolio e un odor di frittura. «Dio santo, mangerei un boccone di gusto» disse Joe. «Ehi, ragazzo, dille che vogliamo qualcosa da mangiare.» «Un po’ di pazienza e mangerete i polli di montagna.» «Ma che diavolo dici?» Terminarono le loro bibite nel momento preciso in cui la donna tornò con un piattone di frittura. «E che cos’è quella roba?» chiese Joe. «Questi sono i polli di montagna, mister; da noi le rane le chiamiamo così, ma non sono come le rane che avete voi negli Stati Uniti. Sono stata laggiù e lo so. Quelle non le mangeremmo nemmen per sogno, noialtri. Ma queste qui sono rane magnifiche, paiono polli. Se le mangerete le troverete ottime.» I due sbottarono in un uragano di risa. «Gesù, si vede che abbiamo bevuto» disse Larry, asciugandosi le lacrime.
Poi decisero di andare a caccia di ragazze. Ne videro uscire un paio dal locale interno dove c’era la musica, e le seguirono per la via buia. Rivolsero loro la parola e le ragazze mostrarono i denti, sussultarono tutte sotto i loro panni e ridacchiarono. Ma sbucarono da qualche parte tre o quattro negri arrabbiati da non dirsi e cominciarono a parlare nel dialetto locale. «Cristo, Larry, faremmo meglio a tenere gli occhi aperti» disse Joe fra i denti. «Quei diavoli hanno i rasoi.» Si trovarono ora in mezzo a una torma strillante di omoni neri, quando udirono alle spalle una voce americana: «State calmi, ragazzi, ci penso io». Un ometto in calzoni kaki da cavallerizzo e cappello di panama si stava aprendo la strada tra la folla, continuando a parlare in creolo. Era un tipo piccolo di statura, faccia triangolare culminante in un pizzetto. «Mi chiamo Henderson, DeBuque Henderson di Bridgeport, Connecticut.» Strinse le mani a entrambi. «Be’, che c’è, ragazzi? Ora tutto è a posto, qua mi conoscono tutti. Bisogna fare attenzione in quest’isola, ragazzi, è gente molto suscettibile questa, molto suscettibile… Voi ragazzi è bene veniate a bere qualcosa con me… il mio rum… è di mia fabbricazione… faccio tutto da me.» Li prese entrambi a braccetto e li portò via in fretta. «Be’, io ero giovane ai miei tempi… sono ancora giovane, anzi… si capisce, volevo vedere l’isola… e avevo ragione, è l’isola più interessante in tutto il mar dei Caraibi, solo che non c’è un cane… non si vede mai un bianco.» Quando giunsero a casa sua egli li fece passare per uno stanzone imbiancato che odorava di vaniglia. Di lì si vedeva la città con le sue rade luci, le colline oscure, il bianco scafo del Callao con le chiatte tutt’intorno ancora, illuminato dai fanali. Il vecchio compatriota versò loro un bicchiere di rum a testa; poi un altro. Aveva un pappagallo che non la finiva più di strillare, appollaiato su di un posatoio. Si era alzata dalle montagne la brezza carica di densi profumi di fiori, e scompigliava al vecchio i bianchi capelli divisi in ciocche ispide, gettandoglieli sugli occhi. Egli additò il Callao tutto illuminato con la sua cerchia di chiatte. «United Fruit… Società riunita frutti… Società riunita ladri… è un monopolio… se non state ai prezzi che vi fanno loro, vi lasciano marcire i limoni sul molo.
Voialtri ragazzi lavorate per una masnada di ladri, ma lo so bene che non ne avete colpa. Ecco qua, a voi.» Senza nemmeno pensarci, Larry e Joe si misero a cantare. Il vecchio parlava di macchinari per la filatura del cotone e per la macinazione della canna da zucchero, e intanto versava rum da una bottiglia. Erano piuttosto brilli. Non seppero nemmeno loro come fu che tornarono a bordo. Joe ricordava il castello di prua immerso nell’oscurità e il russare dei compagni dalle cuccette che gli turbinavano davanti, poi il sonno che lo aveva colpito come un sacco di sabbia e il sapore dolce e fastidioso del rum in bocca. Un paio di giorni dopo Joe prese la febbre con dolori tremendi alle giunture. Aveva perso i sensi quando lo sbarcarono a St. Thomas. Era dengue, e passarono due mesi prima che trovasse la forza di scrivere a Del per comunicarle dove si trovava. L’infermiere dell’ospedale gli disse che era rimasto senza conoscenza cinque giorni e che lo avevano già dato per spacciato. Ai dottori la cosa era spiaciuta moltissimo perché quello era un ospedale militare; dopo tutto lui era un bianco, privo di sensi, e non lo si poteva certo buttare in pasto ai pescicani. Fu solo in luglio che Joe si sentì abbastanza in forze da poter passeggiare per le ripide stradine della città, fatte di polvere di corallo. Fu dimesso dall’ospedale, e si sarebbe trovato in un bel guaio se un cuoco delle caserme di marina non si fosse dato da fare per lui e non gli avesse trovato un posticino in una parte libera dell’edificio. Faceva caldo, non c’era una nuvola in cielo, e lui si stancò ben presto di guardare i negri e le nude colline e la chiusa rada azzurra. Passò un sacco di tempo seduto sul vecchio molo del carbone all’ombra di un pezzo di tettoia a lamiera, a guardare attraverso l’assito la chiara acqua di un profondo verdazzurro, nella quale banchi di pesci tropicali cercavano nutrimento attorno ai piloni. Non c’era nulla che lo scuotesse dal suo torpore. Il pensiero gli riandava a Del e a quella ragazza francese di Bordeaux e alla guerra, e la United Fruit era una combriccola di ladri, e poi tutti quei pensieri gli giravano e gli giravano in testa come i pesciolini argentei, blu e gialli attorno alle oscillanti capigliature d’alghe di cui s’inanellavano i piloni, e allora insensibilmente lo sorprendeva il sonno.
Quando arrivò in porto un piroscafo da frutta diretto a nord, egli abbordò sulla banchina un ufficiale e gli narrò la sua triste storia. Gli diedero un passaggio per New York. Per prima cosa cercò di Janey; chissà, se lei lo giudicava opportuno, avrebbe rinunciato a quella vita da cani per assumere un posto fisso in terraferma. Telefonò all’ufficio Pubblicità J. Ward Moorehouse, dov’essa lavorava: ma la ragazza che gli rispose dall’altro capo del filo gli disse che Janey era la segretaria del principale e s’era recata fuori città, a ovest, per affari. Se ne andò e prese una stanzetta dalla signora Olsen a Redhook. Lì si faceva un gran parlare della coscrizione in atto: se ti pescavano per strada senza i documenti in regola ti impacchettavano come renitente alla leva. E naturalmente un bel mattino, proprio mentre Joe usciva dalla metropolitana a Wall Street, un poliziotto gli si avvicinò chiedendogli i documenti. Joe disse che lui era della marina mercantile ed era appena tornato da un viaggio e non aveva avuto ancora tempo di mettersi in regola, e poi era esentato dal servizio, ma il poliziotto gli rispose che queste cose bisognava dirle al giudice, ormai. Furon tutti avviati in colonna alla dogana passando per Broadway; i soliti galletti nella folla di travetti e commessi di negozio che gremiva i marciapiedi gridarono «Imboscati» al loro indirizzo, e le ragazze fischiarono e lanciarono urla di scherno. Alla dogana vennero stipati in alcuni locali a pianterreno. Era una torrida giornata di agosto. Joe si fece largo a gomitate tra la folla sudata e brontolona, per portarsi vicino alla finestra. Erano per lo più forestieri, c’erano scaricatori di porto e fannulloni cronici da città di mare; ce n’eran tanti che facevano gli spacconi, ma Joe si ricordava della marina militare e tenne il becco chiuso, ascoltò solamente; rimase lì dentro tutta la santa giornata. I poliziotti non permettevano a nessuno di telefonare, e c’era un gabinetto solo, e bisognava andarci sotto scorta. Joe si sentiva piuttosto malconcio, non aveva ancora superato gli effetti del dengue. Stava già per uscire quando scorse un volto noto. Diavolo, quello era Glen Hardwick! Glen era stato raccolto da un bastimento inglese e portato a Halifax. Si era ingaggiato come secondo ufficiale sul Chemang, che portava muli a Bordeaux e un carico vario a Genova. Questa nave poi
l’armavano con un cannone da tre pollici e artiglieri di marina, perché non s’imbarcava anche lui, Joe? Aspettavano solo qualche ufficiale a posto, per imbarcarsi. «Cristo, pensi dunque che io potrei imbarcarmici?» domandò Joe. «Ma certo, vanno matti per gli ufficiali di rotta; ti prenderebbero anche senza licenza.» Quando finalmente arrivarono al tavolo dell’interrogatorio, l’incaricato lasciò andare Glen senza difficoltà, e disse che Joe poteva andare anche lui non appena qualcuno portasse lì la sua licenza, ma che dovevano segnarsi nei ruoli di leva anche se erano esentati dal servizio. «Dopo tutto, ragazzi, dovreste ricordarvi che c’è una guerra in corso» disse l’ispettore. «Effettivamente dovremmo saperlo» disse Joe. La signora Olsen arrivò tutta sossopra coi documenti di Joe, e Joe si precipitò all’agenzia a East New York, e lo ingaggiarono come nostromo. Il capitano era Ben Tarbell, che aveva svolto le mansioni di secondo sullo Higginbotham. Joe voleva sbarcare a Norfolk per vedere Del, ma caspita, non era quello il momento di fermarsi a riva. Si limitò a mandarle cinquanta dollari avuti in prestito da Glen. Comunque non ebbe tempo di tormentarsi per quella faccenda, perché salparono l’indomani con ordini segreti circa il punto in cui bisognava raggiungere il convoglio. Navigare in convoglio era abbastanza interessante. Gli ufficiali dei caccia di scorta e del Salem che faceva da nave comando erano maledettamente altezzosi, ma i capitani dei piroscafi mercantili si scambiavano scherzi e saluti da una plancia all’altra con le bandierine di segnalazione. Che spettacolo curioso, l’Atlantico disseminato di lunghe file di cargo, tutti pezzati di bianco e grigio come pali indicatori per opera degli artisti della verniciatura mimetica. In quel convoglio c’erano vecchie carcasse sulle quali in tempo di pace uno non si sarebbe fidato di andare nemmeno a Staten Island, e uno dei nuovi battelli di legno della commissione marittima faceva acqua in un modo così pietoso, rabberciato com’era in legno fresco, che si dovette affondarlo a metà strada. Joe e Glen si fumavano la pipa in compagnia nella cabina di Glen e facevano un gran chiacchierare. Conclusero che in terraferma non c’era niente che valesse una cicca, e che il solo ambiente indicato per
tipi come loro era l’acqua salsa; in terraferma la gente si era montata la testa con quella guerra della malora. Joe se ne sentì pieni i santissimi di gridare ordini a quella schiuma che aveva come equipaggio. Una volta entrati in zona di guerra, quando tutte le navi presero a seguire la rotta a zigzag e tutti cominciarono a sbiancar di paura, le cose cominciarono ad apparire un po’ buffe a Joe. C’era un falso allarme di sommergibili ogni minuto, idrovolanti che sganciavano bombe di profondità e cannonieri emozionati che sparavano su vecchi barilotti, ciuffi d’alghe, barbagli dell’acqua. Entrare di nottetempo nella Gironda tra l’incrociarsi dei riflettori e i segnali a intermittenza e l’affaccendarsi dei motoscafi di vedetta fu certamente un gran sollievo per gli equipaggi. Fu un sollievo sbarcare quei sozzi muli col loro trepestio e il loro puzzo che aveva impregnato ogni cosa, assieme alle grida e alle imprecazioni degli stallieri. Glen e Joe scesero a riva per poche ore e non riuscirono a trovare Marceline e Loulou. La Garonna cominciava ad assomigliare al Delaware con tutti i moli d’acciaio e calcestruzzo costruiti all’americana. All’atto della partenza si dovette rimanere molte ore alla fonda per riparare un fumaiolo rotto, e la vista di una vedetta che passava rimorchiando cinque scialuppe di salvataggio piene zeppe di gente fece capire che i tedeschi dovevano darsi molto da fare, là fuori. Stavolta niente convoglio. Partirono alla chetichella nel cuore di una notte nebbiosa. Quando uno dei marinai di coperta uscì dal castello di prua con una sigaretta accesa all’angolo della bocca, il secondo lo stese a terra con un diretto e disse che all’arrivo lo avrebbe fatto arrestare come spia tedesca. Costeggiarono la Spagna sino a Finisterre. Il capitano aveva appena cambiato rotta puntando a sud, quando avvistarono un periscopio a poppa, sicuro come l’oro. Il capitano afferrò personalmente la ruota del timone e urlò nel portavoce a quello delle macchine di mettercela tutta – non era certo possibile far molto – e i cannonieri cominciarono a far fuoco da poppa. Il periscopio scomparve, ma un paio d’ore dopo raggiunsero una lurida tartana, probabilmente un peschereccio spagnolo, diretta a riva, probabilmente a Vigo, che correva con una vela spiegata per parte nel vento sostenuto spirante con intensità sempre maggiore da ovest-
nord-ovest. Avevano appena tagliato la scia della tartana che un colpo sordo squassò la nave e un’improvvisa colonna d’acqua inzuppò tutti i presenti sul ponte di comando. Ogni cosa funzionò con la precisione di un meccanismo. Il numero 1 era il solo compartimento allagato. Fortunatamente l’equipaggio uscì tutto dal castello di prua e si allineò sul ponte coi salvagente indosso. Il Chemang si era appruato un po’, ecco tutto. I cannonieri erano certi si trattasse di una mina calata dalla vecchia tartana nera che li aveva incrociati a prua, e le spararono un paio di colpi, ma la nave rollava tanto nel mare grosso che i colpi andarono a vuoto. Comunque, la tartana si dileguò dietro l’isola che blocca l’imboccatura della rada di Vigo. Il Chemang vi entrò verso l’una. Quando entrarono nel braccio di mare prospiciente la città di Vigo, l’acqua stava guadagnando terreno sulle pompe nel compartimento n. 2, e nella sala macchine ce n’eran già quattro piedi. Si dovette arenare il battello sui banchi di sabbia dura a dritta della città. E così, eccoteli a terra un’altra volta col fagotto sulle spalle, davanti al consolato che doveva pensare a trovar loro un buco dove infilarsi. Il console era uno spagnolo e non parlava inglese così bene come avrebbe dovuto, ma li trattò molto bene. Il partito liberale di Vigo invitò ufficiali ed equipaggio a una corrida che si doveva svolgere nel pomeriggio. Intanto le solite faccende burocratiche; il capitano ricevette un cablogramma con l’ordine di consegnare la nave agli agenti di Gomez e C. di Bilboa, che l’avevano comperata così come si trovava e le stavano cambiando registro. Quando arrivarono all’anfiteatro, metà della folla li applaudì gridando: «Viva los Aliados», e l’altra metà fischiò urlando: «Viva Maura». Temettero che scoppiasse una rissa lì per lì, ma uscì nell’arena il toro e tutti s’acquetarono. La corrida fu una cosa tremenda, ma quei ragazzi dalla montura luccicante di ornamenti erano agilissimi ballerini, e i vicini di posto porgevano continuamente ai nostri marinai piccoli otri neri di vino e bottiglie di cognac, tanto che l’intera ciurma a un certo punto era piuttosto brilla e Joe ebbe il suo daffare a tenerla a posto. Poi gli ufficiali furono invitati a un banchetto dato in loro onore dalla locale società pro Alleati, e una
quantità di caballeros baffuti fece accesi discorsi di cui non si capiva una parola, e gli americani applaudirono e cantarono The Yanks Are Coming, Keep the Home Fires Burning e We’re Bound for the Hamburg Show. Il primo nocchiero, un vecchio che si chiamava McGillicudy, fece giochi di destrezza con le carte, e la serata fu un gran successo. Joe e Glen si presero una camera in due all’albergo. La cameriera era molto graziosa, ma non voleva saperne delle loro sciocchezze. «Be’, Joe,» disse Glen prima che si addormentassero «è una guerra coi fiocchi.» «Be’, se non sbaglio sono le tre» disse Joe. «Ma non è l’orologio, è stata una pallina» disse Glen. Trascorsero a Vigo due settimane d’attesa mentre i funzionari litigavano sulla questione del loro stato giuridico, e loro ne avevano piene le scatole. Poi furono messi tutti quanti in un treno che doveva portarli a Gibilterra, dove li avrebbe presi a bordo una nave della commissione marittima. Furono tre giorni di treno, coi soli duri sedili per dormire. La Spagna era semplicemente una catena dopo l’altra di grandi montagne polverose. Cambiarono a Madrid e a Siviglia, e ogni volta veniva a interessarsi di loro un inviato del consolato. Una volta arrivati a Siviglia seppero che si doveva andare ad Algeciras e non a Gibilterra. Giunti ad Algeciras si accorsero che di loro non avevano neanche sentito parlare. Puntarono i piedi al consolato mentre il console telegrafava a dritta e a manca, riuscendo finalmente a noleggiare due autocarri per spedirli a Cadice. La Spagna era un paese speciale, tutto rocce e vino e donne poppute dagli occhi neri e uliveti. A Cadice trovarono a riceverli l’agente consolare con un telegramma in mano. Li aspettava ad Algeciras per l’imbarco la nave cisterna Gold Shell, e così bisognò di nuovo imbottigliarsi negli autocarri, sobbalzando sui duri sedili, la faccia incipriata di polvere, la bocca piena e non un centesimo in tasca per comprarsi da bere. Quando salirono a bordo del Gold Shell, verso le tre, in una splendida notte di luna, alcuni di loro erano così stanchi che caddero al suolo e schiacciarono una poderosa dormita lì sul ponte, con la testa sui bottini. Il Gold Shell li sbarcò a Perth Amboy nel tardo ottobre. Joe ritirò la sua paga arretrata e prese la prima coincidenza per Norfolk. Ne aveva
fin sopra i capelli di gridare ordini a quel branco di ruffiani del castello di prua. Porca miseria, adesso basta con la vita di mare: adesso si sarebbe sistemato a terra e si sarebbe goduto un po’ di vita matrimoniale. Si sentiva come un principe quando partì col traghetto da Capo Charles, doppiando il Riprap, per sbucare dalla baia screziata di creste bianche nelle lisce acque brune di Hampton Roads, gremite di naviglio: quattro grosse navi da guerra alla fonda, torpediniere in partenza e un candido cutter della finanza, cargo e carboniere mimetizzati, una frotta di rossi barconi da munizioni ancorati al largo in disparte. Era uno scintillante giorno d’autunno. Si sentiva a posto; aveva in tasca trecentocinquanta dollari. Era vestito bene, cotto dal sole e aveva appena consumato un ottimo pranzo. Perdio, ci voleva un po’ d’amore adesso. Chissà, forse avrebbero avuto un bambino. Norfolk era proprio cambiata. Tutti in uniformi nuove, oratori che facevan discorsetti di due minuti all’angolo di Main e Granby, manifesti del Prestito della Libertà, bande che sonavano. Venendo dal traghetto, egli quasi non riconosceva la città. Aveva scritto a Del per informarla del suo arrivo, ma l’idea di rivederla lo preoccupava, era un po’ che non gli scriveva. Aveva ancora la chiave dell’appartamento, ma prima di aprire bussò. Non c’era nessuno. S’era sempre immaginato che lei gli corresse incontro sull’uscio. Eppure erano solo le quattro, doveva essere al lavoro. Doveva avere con sé un’altra ragazza, la casa non era molto in ordine… Biancheria stesa ad asciugare a un filo, capi di vestiario sparsi per tutte le sedie, una scatola di canditi con pezzi mezzo mangiati sul tavolo… Gesù, la notte prima evidentemente avevano fatto una festicciola in casa. C’erano una mezza torta, bicchieri con tracce di liquore, un piatto pieno di mozziconi di sigarette e persino un mozzicone di sigaro. Ma sì, aveva certo invitato amici. Andò nel bagno a sbarbarsi e pulirsi un po’. Certo Del era sempre socievole come una volta, e per tutto quel tempo aveva ricevuto un sacco di amici per giocare a carte e così via. Nel bagno c’era una scatola di rossetto per le guance e matite di rossetto per le labbra, e cipria sparsa sui rubinetti. Che buffo, farsi la barba in mezzo a tutta quella roba da donne!
Udì ridere la voce di lei, fuori sulle scale, assieme a una voce d’uomo; la chiave girò nella toppa. Joe chiuse la valigia e si alzò in piedi. Del si era tagliata i capelli alla maschietta. Gli volò incontro gettandogli le braccia al collo. «Ecco, questo è proprio il mio caro maritino.» Joe sentì sapor di rossetto sulle labbra di lei. «Dio mio, sei magro sai, Joe. Povero ragazzo, chissà come sei stato malato… Se avessi avuto denaro sarei saltata a bordo di un battello e sarei venuta a trovarti… Questo è Wilmer Tayloe… cioè, il tenente Tayloe, ha avuto i gradi proprio ieri.» Joe esitò un momento e poi tese la mano. L’altro aveva capelli rossi tagliati corti e il volto lentigginoso. Era tutto agghindato in una divisa di diagonale, con cinturone lucido e gambali. Sulle spalle aveva una riga d’argento per parte e speroni ai piedi. «Salpa domani per oltremare. Stava venendo a portarmi a pranzo. Oh Joe, tesoro, sapessi quante cose ho da dirti.» Joe e il tenente Tayloe rimasero lì a guardarsi in faccia imbarazzatissimi, mentre Del si dava da fare per mettere un po’ d’ordine in casa e intanto continuava a parlare a Joe. «Roba dell’altro mondo, non ho mai tempo di far niente, e Hilda lo stesso… Ricordi Hilda Thompson, Joe? be’, è venuta a stare con me per aiutarmi a mettere insieme l’affitto, ma ogni sera facciamo tutte e due lavoro di guerra allo spaccio della Croce Rossa, e poi io vendo obbligazioni Liberty… Non li odii gli unni, Joe? Ah, io li odio, sai, e Hilda lo stesso… Lei poi vorrebbe cambiar nome perché è tedesco. Le ho promesso di chiamarla Gloria, ma me ne dimentico sempre… Sai, Wilmer, Joe è stato silurato due volte.» «Be’, immagino che le prime sei volte sono le più brutte» balbettò il tenente Tayloe. Joe grugnì. Del sparì nel bagno e chiuse la porta. «Voialtri ragazzi mettetevi a vostro agio. In un minuto sarò bell’e vestita.» I due non dissero una parola. Le scarpe del tenente Tayloe scricchiolavano ogni volta che lui spostava il peso del corpo da un piede all’altro. Finì col cavare una fiaschetta dalla tasca posteriore. «Fatevi una bevuta» disse. «Il mio reparto salpa stanotte dopo le dodici.» «Sì, è meglio che accetti» disse Joe senza sorridere. Quando Della uscì dal bagno tutta azzimata, faceva proprio colpo. Era molto
più carina dell’ultima volta che Joe l’aveva vista. Intanto lui non faceva altro che ruminare internamente se doveva o meno assestare quattro cazzotti a quel maledetto sottotenentino, sinché alfine costui se n’andò, e Del gli disse di venire a prenderla allo spaccio della Croce Rossa. Quando se ne fu andato, lei venne a sedersi sulle ginocchia di Joe e si fece raccontare tutto e gli domandò se aveva già preso la licenza di secondo ufficiale e se aveva sentito la sua mancanza, e lei desiderava tanto che lui potesse guadagnare un po’ di più, perché le seccava a morte di coabitare con un’altra a quel modo, ma d’altra parte era il solo mezzo per pagare l’affitto. Bevve un poco del whisky che il tenente aveva dimenticato sul tavolo, gli scompigliò i capelli e gli fece un sacco di moine. Joe le domandò se Hilda sarebbe rientrata presto, e lei disse di no, aveva un appuntamento e si dovevano trovare allo spaccio. Ma Joe andò a sprangare la porta e per la prima volta essi furono veramente felici, abbracciati sul letto. Joe non sapeva proprio che fare in giro per Norfolk. Del stava in ufficio tutto il santo giorno, e tutta la sera allo spaccio della Croce Rossa. Rientrando lo trovava di solito a letto. Di consueto c’era qualche maledetto ufficiale dell’esercito o giù di lì che la riaccompagnava, e lui, Joe, li sentiva ciangottare e scherzare fuori dell’uscio, e stava disteso in letto immaginando che quel tizio la stesse baciando o coprendo di carezze. Quando poi entrava, a lui veniva voglia di picchiarla e dirgliene quattro, e allora litigavano e gridavano, e lei finiva sempre col dire che lui non la comprendeva ed era assai poco patriottico ad intralciarla così nel suo lavoro di guerra, e a volte si rappaciavano e Joe si sentiva pazzo d’amore e lei gli si rannicchiava tra le braccia, piccola e graziosa, e gli dava certi bacetti che lo facevano quasi piangere di felicità. Diventava sempre più bella, e sapeva vestirsi divinamente. Il mattino della domenica lei era troppo stanca per alzarsi, e allora lui le preparava da mangiare, e sedevano assieme in letto a far colazione come quella volta a Bordeaux con Marceline. Poi lei gli diceva che lo amava alla follia, e che ragazzo in gamba era, e quanto le sarebbe piaciuto che si sistemasse in un buon impiego a terra e facesse
un sacco di soldi, in modo da eliminarle il fastidio del lavoro, e come il capitano Barnes, la cui famiglia possedeva un milione, le avesse proposto di divorziare da Joe per sposare lui, e il signor Canfield, dell’agenzia Dupont, che guadagnava i suoi cinquantamila all’anno, le aveva offerto una collana di perle, ma lei non l’aveva accettata perché sarebbe stata una cosa fuori di posto. A sentirla parlare così, Joe stava male. Talvolta prendeva a parlarle di quello che avrebbero fatto se avessero avuto dei bambini, ma Del faceva sempre una faccia strana e gli diceva di troncare l’argomento. Joe girò a cercar lavoro, e per poco non ebbe un posto di caposquadra in una delle officine di riparazione al cantiere di Newport News, ma all’ultimo momento un altro lo scavalcò. Un paio di volte andò in gita con Del e Hilda Thompson, alcuni ufficiali dell’esercito e un guardiamarina di un caccia, ma tutti lo trattavano dall’alto in basso, e Del si lasciava baciare da tutti e spariva in una cabina telefonica col primo venuto purché avesse addosso una divisa qualsiasi, e per lui fu una pena d’inferno. Trovò una sala da bigliardo frequentata da qualche ragazzo di sua conoscenza, dove si poteva avere liquore di grano, e prese ad alzare il gomito alla disperata. Per Del era una cosa tremenda rincasare e trovarlo ubriaco, ma a lui oramai non importava più nulla. Poi una bella sera che era andato a un incontro di pugilato assieme a certi conoscenti e aveva poi alzato il gomito, Joe incontrò Del a spasso in compagnia di un altro di quei dannati ufficialetti. Era abbastanza scuro e c’era poca gente in giro, e quei due si fermavano in tutti i portoni bui, e l’ufficialetto la baciava e l’abbracciava. Quando, osservandoli alla luce di un lampione, poté accertarsi che si trattava effettivamente di Del, li affrontò e chiese bruscamente spiegazioni. Del doveva essere un po’ bevuta, perché sbottò in una risatina stridula che lo mandò su tutte le furie, e allora lui tagliò corto e mollò all’ufficialetto un destro fulmineo in pieno viso. Gli speroni tintinnarono e l’ufficialetto crollò lungo disteso come un sacco di patate sull’aioletta erbosa sotto il lampione, addormentato. A Joe la scena cominciò a fare un effetto buffo, ma Del era arrabbiata come un demonio e disse che lo avrebbe fatto arrestare per insulto alla divisa,
aggressione e maltrattamenti, e lui era semplicemente una faccia gialla, un fregnone d’imboscato, e che cosa stava a fare lì tra i piedi in patria quando tutti i ragazzi erano al fronte a combattere contro gli unni. Joe ritornò completamente in sé, aiutò l’altro a rialzarsi e disse sul muso a tutti e due che potevano andarsene all’inferno. Voltò le spalle all’ufficialetto, il quale doveva essere piuttosto alticcio, senza lasciargli il tempo di reagire altro che a soffi e farfugli, andò a casa diritto filato, fece le valigie e uscì. Will Stirp era in città, così Joe andò a casa sua e lo fece alzare per dirgli che aveva piantato baracca e burattini e domandargli in prestito venticinque dollari per andare a New York. Will disse che aveva fatto benone, e tipi come loro due dovevano amarle tutte e sposarne nessuna, un chiodo scaccia l’altro. Stettero su a parlare del più e del meno sin quasi all’alba. Poi Joe si addormentò e dormì fino al tardo pomeriggio. Si alzò in tempo per il piroscafo di Washington. Non prese una cabina, ma girò sul ponte tutta notte. Fece quattro chiacchiere con uno degli ufficiali e si mise a sedere nella cabina del pilota, che aveva un buon odore di pipe vecchie dell’anno prima. Ascoltando lo sciacquio dell’onda infranta sulla prora e osservando il bianco dito incerto dei riflettori tastare boe e fari, cominciò a riprendersi. Disse che andava a New York a trovare la sorella e a cercar di ottenere la licenza di secondo ufficiale dalla commissione marittima. I racconti dei suoi siluramenti fecero una grande impressione, perché nessuno di quelli del Dominion City aveva mai traversato lo stagno. Sapore dei bei tempi andati, quando stava a prua nel pungente mattino di novembre annusando il vecchio odor salso del Potomac, e intanto gli sfilavano davanti Alexandria rossa di mattoni, Anacostia, l’Arsenale e il cantiere della marina militare, e poi il Monumento emergeva roseo dalla nebbia nella prima luce. I moli avevano pressappoco lo stesso aspetto, gli yacht e le imbarcazioni a motore elettrico ancorate di fronte, il piroscafo di Baltimora che arrivava in quel momento, gli scassati vaporetti da diporto, i gusci d’ostrica sotto i piedi sul molo, gli scioperanti negri sparsi lì attorno. E poi saltar sul tram di Georgetown, e troppo presto trovarsi a camminare per la
strada rossomattone. Mentre sonava il campanello si chiedeva perché mai fosse venuto a casa sua. Mammetta era invecchiata, ma stava bene ed era tutta presa dai suoi pensionanti, e le ragazze erano entrambe fidanzate. Dissero che Janey andava a gonfie vele col suo lavoro, ma che New York l’aveva cambiata. Joe disse che andava a New York per veder di ottenere la sua brava licenza di secondo ufficiale, e certamente sarebbe andato a trovarla. Quando gli chiesero della guerra e dei sommergibili eccetera, non sapeva proprio che dir loro, così le prese un po’ in giro. Fu contento quando venne l’ora di andare a Washington a prendere il treno, benché fossero state tanto gentili e mostrassero di pensare che era per lui un successone diventar secondo ufficiale in così giovane età. Del suo matrimonio non parlò neppure. Sul treno di New York, Joe si mise a sedere nello scompartimento fumatori guardando dal finestrino fattorie, stazioni, cartelloni, e le sudice strade delle città industriali nel Jersey sotto la pioggia fitta, e tutto pareva ricordargli Del e i dintorni di Norfolk e i bei tempi dell’infanzia. Quando arrivò alla stazione di Pennsylvania a New York la prima cosa che fece fu depositare il bagaglio, poi infilò l’Ottava Avenue lucida di pioggia dirigendosi all’angolo della via dove abitava Janey. Capì che era meglio telefonare prima, e le telefonò da una tabaccheria. La voce di lei suonò piuttosto fredda; disse che era impegnata e non poteva vederlo prima dell’indomani. Egli uscì dalla cabina telefonica e s’incamminò per la strada senza saper dove andare. Aveva sotto il braccio un pacco con due scialli spagnoli che aveva comperati per lei e per Del nell’ultimo viaggio. Lo assalì un tale scoramento che gli venne voglia di buttare scialli e tutto in un fosso, ma ci ripensò e tornò al deposito bagagli per riporli in valigia. Poi andò a farsi una bella pipata nella sala d’aspetto. Maledizione, gli ci voleva a tutti i costi una bevuta. Andò a Broadway e si diresse a Union Square fermandosi dovunque gli paresse di ravvisare una mescita, ma in nessun posto gli volevano servir da bere. Union Square era tutta illuminata e piena di manifesti che invitavano ad arruolarsi in marina. Tutto un lato della piazza era occupato da un grosso modello di corazzata in legno. Lì attorno si
assiepava la folla, e una fanciulla vestita da marinaio teneva un discorso sul patriottismo. Riprese la pioggia fredda e la folla si dissipò. Joe imboccò una strada ed entrò in una mescita che si chiamava The Old Farm. Doveva assomigliare a qualche conoscenza del barista, perché costui lo accolse con un «Salve!» e gli versò una misura di liquore di segala. Joe attaccò discorso con due tizi di Chicago che bevevano whisky in boccali da birra. Dicevano che tutta questa oratoria bellica era una porca propaganda, e se gli operai l’avessero piantata di lavorare nelle fabbriche di munizioni per fare proiettili destinati a spaccare la testa ad altri operai la guerra della malora non ci sarebbe stata più. Joe disse che avevano proprio ragione, ma era anche vero che si faceva un sacco di soldi. I tizi di Chicago dissero che anche loro avevano lavorato in una fabbrica di munizioni, ma adesso non volevano più saperne, vivaddio, e se gli operai ci cavavano facilmente qualche dollaro voleva dire che i profittatori di guerra ci cavavano facilmente i milioni. I russi, quelli sì l’avevano imbroccata giusta, fare la rivoluzione e mettere al muro quei porci di profittatori, e anche da noi succederebbe se non stessero così in guardia, e sarebbe una bellissima cosa, perdio. Il barista si chinò verso di loro per dire che non avrebbero dovuto parlare a quel modo, la gente li avrebbe presi per spie tedesche. «Oh bella, ma se sei tedesco anche tu, George» rispose uno dei due. Il barista arrossì e replicò: «I nomi non significano nulla… Io sono un americano che ci tiene al suo paese. Parlafo ciusto per il fostro pene. Se foi folete antare a finire in gattabuia, per me in fin dei conti è la stessa cosa». Ma continuò ugualmente a servir loro da bere, e a Joe parve che fosse d’accordo con loro. Fecero un altro giro di bevute, e Joe disse che era verissimo tutto, ma che diavolo mai ci potevi fare? Gli altri dissero che il rimedio era iscriversi alla Internazionale comunista, avere una tessera rossa ed essere un lavoratore con coscienza di classe. Joe disse che quella roba andava bene solo per gli stranieri, ma se qualcuno avesse fondato un partito di bianchi per combattere gli speculatori e i maledetti banchieri lui si sarebbe schierato con quello. I due di Chicago se la presero a male e dissero che gli internazionalisti erano uomini bianchi né più né
meno di lui, e i partiti politici erano tutti una scemenza, e i meridionali erano tutti dei crumiri. Joe si scostò troncando la conversazione, e stava già squadrandoli per scegliere il primo da scazzottare, quando il barista girò l’angolo del banco e venne a interporsi. Era grasso, ma aveva un buon paio di spalle e occhi azzurri cattivi. «Sentite un po’, scioperati,» disse «ascoltatemi; io sono un tetesco, sì, ma tenco forse per il Kaiser? No, lui è uno Schweinehund, io sono sozialista e fifo ta trent’ani a Union City unt sono patrone tella mia casa unt paco le tasse unt sono un puon americano, ma qvesto non significa che foglia compattere per il panchiere Morgan, ah no. Conosco da trent’ani i laforatori americani nel partito sozialista, e tuto qvelo che fano è compattersi fra ti loro. Ogni figlio ti putana si crete qvalcosa ti più tel’altro figlio di putana. Foialtri fannulloni antatefene fuori ti qvi… è ora ti chiutere… io tefo chiutere e antare a casa.» Uno dei due di Chicago scoppiò a ridere. «Be’, si vede che abbiamo bevuto un po’ e ci fa effetto, Oscar… ma dopo la rivoluzione sarà un’altra cosa.» Joe voleva ancora farla a pugni, ma pagò da bere a tutti col suo ultimo dollaro, e il barista, che era ancor tutto rosso in viso per il discorso fatto, si portò alla bocca un bel bicchiere di birra. Ne soffiò via la spuma e disse: «Se mi sentono parlare così, perto il posto». Si strinsero tutti quanti la mano e Joe uscì nelle raffiche di pioggia portata dal vento di nord-est. Si sentiva alleggerito ma tutt’altro che bene. Tornò in Union Square. I discorsi per il reclutamento erano finiti. La finta nave da battaglia era al buio. Un paio di giovinastri laceri stavano accoccolati al riparo della tenda di reclutamento. Joe fu preso da una depressione spaventosa. Infilò la metropolitana e attese il treno di Brooklyn. Dalla signora Olsen era completamente buio. Joe suonò e di lì a poco essa scese in vestaglia rosa imbottita ad aprirgli la porta. Le seccava essere svegliata a quell’ora, e lo sgridò perché aveva bevuto, ma gli diede una camera e il mattino dopo gli prestò quindici dollari per tirare avanti sino a quando non avesse trovato un ingaggio alla commissione marittima. La signora Olsen aveva l’aria stanca e invecchiata, disse che aveva dolori alla schiena e non ce la faceva più col suo lavoro. Il mattino dopo Joe le mise a posto certi scaffali nella dispensa e
portò fuori un bel po’ d’immondizia prima di andare all’ufficio Reclutamento della commissione marittima a iscriversi alla scuola ufficiali. Quella mezza cartuccia che stava a tavolino non aveva mai fatto un miglio di mare in vita sua e gli rivolse un mucchio di domande cretine e gli disse di ripresentarsi la settimana dopo per sapere che cosa ne era della sua istanza. Joe ribollì e lo mandò a farsi fottere e uscì. Portò Janey a cena e a teatro, ma lei diceva le stesse cose che dicevano tutti quanti e lo sgridò per via delle imprecazioni, e in conclusione lui non si divertì gran che. Però gli scialli le piacquero, e lui si rallegrò che le andasse tanto bene a New York. Non riuscì però a portare il discorso su Della. Quando l’ebbe riaccompagnata a casa non seppe più che fare. Voleva bere, ma la serata con Janey gli aveva spazzato via i quindici dollari avuti in prestito dalla signora Olsen. Si diresse a ovest a un locale che conosceva nella Decima Avenue, ma era chiuso: restrizioni di guerra. Allora s’incamminò di bel nuovo verso Union Square, chissà, forse quel Tex che aveva visto prima quando aveva traversato la piazza assieme a Janey era ancora seduto lì e si potevano fare quattro chiacchiere con lui. Si mise a sedere sopra una panchina di fronte alla corazzata di legno e cominciò ad osservarla con occhio critico: non era poi fatta male. Diavolo, pensava, almeno non avessi mai visto l’interno di una vera nave da battaglia, quando Tex gli si venne a sedere accanto e gli mise una mano sui ginocchi. Nel momento stesso in cui lo toccò, Joe si accorse di non aver mai avuto simpatia per quell’uomo, aveva gli occhi troppo vicini l’uno all’altro. «Che cos’hai, Joe, così di umor nero? Dimmi la verità che sei a spasso.» Joe annuì, si chinò in avanti e si sputò attentamente fra i piedi. «Che ne pensi di quel modello di corazzata, è in gamba, vero? Cristo, siamo ben fortunati a non trovarci oltremare nelle trincee coi tedeschi davanti.» «Oh, per me ci andrei subito» brontolò Joe. «Non me ne importerebbe un fico.» «Sai, Joe, m’è capitato un buon lavoro. Veramente non dovrei parlarne, ma tu sei un ragazzo a posto. So che non dirai nulla. Ero a
spasso da due settimane, e lo stomaco aveva qualcosa che non andava. Caro mio, sono malato, e come! Non posso più fare lavori pesanti. Un ragazzo di mia conoscenza, che lavora in un ristorante, mi procurava sottomano qualcosa da mangiare. Be’, ero seduto sopra una panchina qui in piazza, quando un tipo ben vestito si mette a sedere anche lui e attacca un bottone. Mi sembrava uno di quei signorini che vanno in cerca del maschio, vedi, e tra me pensavo che per qualche dollarozzo te l’avrei accontentato, perdio, che ci vuoi fare se sei malato e non puoi lavorare?» Joe stava appoggiato allo schienale della panchina, gambe tese e mani in tasca, fissando duramente la sagoma della nave sullo sfondo degli edifici. Tex parlava rapidamente accostando la faccia a quella di Joe: «Salta fuori che quel figlio di puttana è un agente. Alla malora! Avevo una paura fottuta. Un agente del servizio segreto. Il suo principale è Burns… ma quello che interessa a lui sono i rossi, gli imboscati, le spie tedesche, la gente che non sa tenere il becco chiuso… e insomma, va a finire che mi offre da lavorare, venticinque dollari la settimana se il piccolo Willy si comporta bene. Tutto quello che ho da fare è bighellonare ascoltando i discorsi della gente, vedi? Se sento qualcosa che non va, riferisco al principale, e lui fa le investigazioni. Venticinque alla settimana e poi servo la patria, e se mi caccio in qualche guaio, Burns ci pensa lui a tirarmi fuori… Che ne dici, Joe, ti sembra che vada bene per lo stomaco?» Joe si alzò. «Adesso bisogna che torni a Brooklyn.» «Fatti vedere… ecco, tu mi hai sempre trattato bene… tu sei dei nostri, lo so, Joe… Ti metterò in contatto con quel tale, se vuoi. È uno che sa il fatto suo, un tipo educato e tutto, e sa dove si può trovare un mucchio di liquori e di donne, se ne vuoi.» «Maledizione, io me ne rivado in mare e mi levo da questo puttanaio!» disse Joe voltandogli le spalle e avviandosi alla metropolitana.
Occhio fotografico (34) la sua voce era mille miglia lontana da mane a sera insisteva a volersi alzare dal letto le sue guance erano di un rosa lustro e il respiro affannoso No ragazzo è meglio che tu te ne stia lì tranquillo non vogliamo farti prendere altro freddo ecco perché mi hanno mandato qui da te per impedirti di alzarti dal letto la stanza con la volta a botte tutto odora di febbre e imbiancatura disinfettante italiani malati fuori le sirene d’allarme sono in preda a un incubo (Mestre è un nodo ferroviario e il suo chiaro di luna sul Brenta e l’ospedale di base e il deposito munizioni disinfettante azzurro chiar di luna) da mane a sera insisteva a tentar d’alzarsi Ragazzo è meglio che tu te ne stia lì buono buono la sua voce era nel Minnesota manoncapitecheunohapurdalzarsi io ho un appuntamento unimpegnoimportanteper quei lotti quandomaisonstatoinlettoisolato perderò la mia cauzione PerCristo non ci pensate che sono rovinato? Ragazzo devi stare buono siamo in ospedale a Mestre tu hai un po’ di febbre che ti fa certi scherzi Ma non potete lasciarminpace? Siete d’accordo con loro eccocomestanlecose losochemivoglionfottere loro credono cheiosonunlattante porcamattina adarquellacauzione Glielo faròvederio Vifaròsaltarlaporcatesta la mia ombra sulla volta del soffitto goffa e massiccia barcollante e oscillante proiettata dall’unica candela che sfriggola rossa nel gelido ospedale invernale disinfettante notte in alto l’ombra sulla branda mi tocca tenergli giù le spalle sul letto Curley è forte nonostante (ecco ora i motori le batterie antiaeree sparano all’impazzata dev’esser bello lassù nel chiaro di luna lontano dall’odore di disinfettante e latrine e italiani malati) mi rimetto a sedere e mi accendo una Macedonia alla candela lui pare addormentato ha il respiro così affannoso respiro da polmonite sento il mio stesso respiro e il gocciolio dell’acqua i dottori e gli infermieri tutti giù nel ricovero non sentono nemmeno il gemito di un
italiano malato Gesù quest’uomo muore? hanno spento i motori i piccoli tamburi nelle mie orecchie ecco perché li chiamano timpani (lassù nell’azzurro chiar di luna l’osservatore austriaco sta cercando la cordicella che butta per aria tutto) la fiamma della candela sta eretta e silente non ancora ma bam sulla tempia svegliò Curley e il vetro tintinnante alle finestre la candela vacillò ma non si spense la volta balla con la mia ombra e con l’ombra di Curley diamine è forte teste piene del tanfo di febbre Ragazzo devi stare a letto (hanno proprio buttato per aria tutto) schegge grandinano intorno Ragazzo devi tornare a letto Ma ho un appuntamento Oh Cristogesummio non potete dirmi come devo fare per tornare al mio reparto mipardicapirechenonavevacattiveintenzioni èsoloperqueimaledetti lotti la voce smuore in un piagnucolio gli rimbocco le coperte fino al mento accendo la candela fumo un’altra Macedonia guardo ancora il mio orologio dev’essere quasi giorno dieci in punto non mi danno il cambio fino alle otto lontano una voce si leva e si libra vertiginosa come la sirena d’allarme ai-ai-utoOO.
Cine-giornale XXV le forze del generale Pershing hanno occupato oggi la fattoria Belle Joyeuse e i margini meridionali del Bois des Loges. Gli americani hanno incontrato soltanto scarsa reazione di mitragliatrici. L’avanzata ha avuto carattere di rettificazione della linea. Per il resto, l’attività odierna lungo il fronte è consistita principalmente in fuoco di artiglieria e bombardamenti. Intorno a Belluno operano pattuglie che hanno preceduto la marea alleata riversantesi nella zona del Grappa attraverso la stretta di Quero MARINAI RIBELLI SFIDANO GLI ALLEATI Bonjour ma chérie comment allez-vous? Bonjour ma chérie how do you do? dopo una lunga conversazione con un segretario di guerra e il segretario di Stato, il presidente Wilson è tornato oggi pomeriggio alla Casa Bianca mostrandosi altamente compiaciuto del fatto che gli avvenimenti stiano decisamente prendendo quella piega ch’egli aveva presagito Avez-vous fiancé? cela ne fait rien voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oui, oui, combien? AIUTATE L’AMMINISTRAZIONE ANNONARIA DENUNCIANDO I PROFITTATORI DI GUERRA Lord Robert, che è il braccio destro del ministro degli Esteri Balfour, ha aggiunto: «Quando verrà la vittoria, la responsabilità dell’America e della Gran Bretagna non ricadrà sugli statisti ma sul popolo». La comparsa della bandiera rossa nelle nostre strade è un evidente simbolo di sfrenata licenza e un’insegna di antilegalità ed anarchia, così come la bandiera nera rappresenta tutto ciò che di repulsivo esiste LENIN FUGGE IN FINLANDIA eccomi qui comodo come un pascià in questa giornata del 3 ottobre. Fu domenica che partecipai all’azione e fui colpito da un
proiettile di mitragliatrice sopra il ginocchio. Mi trovo in un ospedale di base, e godo di ogni comodità. Scrivo con la mano sinistra perché la destra ce l’ho sotto la testa IL MERCATO AZIONARIO SOSTENUTO MA RISTRETTO Un giorno o l’altro ammazzo il trombettiere un giorno o l’altro lo trovano morto gli butto per aria tromba e sveglia e ci metto sopra i piedi e il resto dei miei giorni lo passo tutto a letto
Un don Chisciotte dell’Indiana Hibben, Paxton, giornalista, nato a Indianapolis, Indiana, il 5 dic. 1880, figlio di Thomas Entrekin e Jeannie Merrill (Ketcham) H.; Maturità classica Princeton 1903, laurea in Lettere Harvard 1904. Nel Middle West, durante l’adolescenza di Hibben, gli uomini che riflettevano erano preoccupati; c’era qualcosa che non andava nella repubblica americana, forse la Parità Aurea, il Privilegio, gli Interessi, Wall Street? I ricchi diventavano ancor più ricchi, i poveri sempre più poveri, i piccoli proprietari agricoli venivano buttati fuori dal loro campicello, i lavoratori manuali lavoravano dodici ore al giorno per un pezzo di pane; i proventi erano per i ricchi, la legge era per i ricchi, i poliziotti erano per i ricchi; forse per questo i pellegrini si erano avventurati nella tempesta a testa bassa, avevano crivellato coi loro moschettoni gli indiani fuggenti e dissodato i terreni pietrosi del New England per questo forse i pionieri avevano attraversato gli Appalachi con lunghi fucili a tracolla sulle magre schiene, un pugno di grano nella tasca della giacca di pel di capra, per questo forse i braccianti agricoli dell’Indiana si erano ribellati quando avevano fucilato Johnny Reb allo scopo di liberare i negri? Paxton Hibben era un ragazzetto rissoso, appartenente a una delle migliori famiglie (gli Hibben avevano una rivendita all’ingrosso di derrate secche a Indianapolis); a scuola i compagni ricchi non lo vedevano di buon occhio perché andava coi compagni poveri e i poveri non lo vedevano di buon occhio perché i suoi erano ricchi però era l’alunno più brillante di Short Ridge High faceva lui il giornale vinceva tutti i contraddittori. A Princeton fu il giovane collegiale, direttore del «Tiger», beveva a più non posso, non negava di correre appresso alle ragazze, conseguiva votazioni brillanti ed era una spina nel cuore per i religiosi. La via più naturale da scegliere, per un giovane della sua
classe e posizione, era quella degli studi giuridici, ma Hibben voleva viaggi romantici alla Byron e alla De Musset, avventure ben studiate in terra straniera, e così siccome la sua famiglia era tra le migliori dell’Indiana e in relazioni di amicizia col senatore Beveridge, egli ebbe un posto nel corpo diplomatico: Terzo segretario e secondo segretario all’ambasciata americana di Pietroburgo e Città del Messico 1905-06, segretario della legazione e chargé d’affaires, Bogotá, Columbia, 1908-09; L’Aia e Lussemburgo 1909-12, Santiago del Cile 1912 (ritirato). Pusˇkin per De Musset; Pietroburgo fu il regno di fiaba di un giovane bellimbusto: guglie incrostate d’oro sotto un cielo di platino, la Neva grigia di ghiaccio che scorreva rapida e profonda sotto ponti scampanellanti di slitte; tornare in carrozza dalle isole con l’amante del granduca, la più bella e più amorosa cantante di canzonette napoletane; giocare una pila di rubli in un’alta sala luccicante di candelieri, monocoli, diamanti sgocciolati su spalle candide; candida neve, candide tovaglie, candide lenzuola, vino di Kakhet, vodka fresca come fieno appena mietuto, caviale di Astrakhan, storione, salmone finlandese, ptarmigan di Lapponia, e le più belle donne del mondo; ma era il 1905, Hibben una bella notte uscì dall’ambasciata e vide una vampa di rosso sulla neve spiaccicata del Nevskij Prospekt e bandiere rosse, sangue gelato nelle carraie, sangue sgocciolante dagli spazzaneve dei carri; vide le mitragliatrici sulle balconate del palazzo d’Inverno, i cosacchi caricare le folle inermi che chiedevano pace e nutrimento e un po’ di libertà, udì il muggito gutturale della Marsigliese russa; qualche venatura caparbia del vecchio sangue americano divampò in rivolta, egli girò per le vie tutta notte coi rivoluzionari, si guastò con
l’ambasciata e fu trasferito a Città del Messico dove non c’era ancora rivoluzione, solo peones e preti e l’immobilità dei grandi vulcani. I científicos lo nominarono membro del Jockey Club dove nel magnifico edificio di azzurre piastrelle Puebla egli perse tutto il suo denaro alla roulette e li aiutò a vuotare le ultime poche casse di champagne che rimanevano dal saccheggio di Cortez. Chargé d’affaires in Colombia (non dimenticò mai di dovere la sua carriera a Beveridge; credeva appassionatamente in Roosevelt, nella giustizia e nella riforma, e nelle leggi antitrust, il Bastone del Castigamatti che doveva far piazza pulita degli speculatori e dei malfattori plutocratici e far giustizia all’uomo della strada) contribuì a mettere in piedi la rivoluzione che portò via la Zona del Canale al vescovo di Bogotá; in seguito si schierò con Roosevelt nel processo Pulitzer per diffamazione; era un progressista, credeva nel Canale e in Theodore Roosevelt. Lo dirottarono all’Aia, dove si addormentò pacificamente durante le vaghe diatribe del tribunale internazionale. Nel 1912 si dimise dal corpo diplomatico e tornò in patria a far propaganda per Roosevelt, giunse a Chicago in tempo per sentir cantare Onward, Christian Soldiers all’adunanza del Colosseum da tutte quelle voci ammassate, e gli applausi, udì il ritmo di marcia della Marsigliese russa, il torvo silenzio dei peones messicani, gli indiani di Colombia che attendevano un liberatore, nell’eco dell’inno udì le cadenze misurate della Dichiarazione d’indipendenza. I bei discorsi sulla giustizia sociale finirono in nulla; Theodore Roosevelt era un pallone gonfiato come tutti gli altri, il Bull Moose, il toro progressista, era imbottito di segatura né più né meno del Grand Old Party. 1 Paxton Hibben si presentò come candidato progressista al Congresso nello Stato dell’Indiana, ma la guerra europea aveva già distratto le menti dalla giustizia sociale. Corrispondente di guerra del «Collier’s Weekly», 1914-15, inviato speciale della «United Press» in Europa, 1915-17; corrispondente di guerra
del «Leslie’s Weekly» nel Vicino Oriente e segretario della commissione russa per il Near East Relief, giugno-dicembre 1921. In quegli anni si dimenticò completamente della veste da camera di seta malva da diplomatico, dei bagni d’avorio e dei colloqui a tu per tu con le granduchesse, andò in Germania quale segretario di Beveridge, vide le truppe tedesche marciare per Bruxelles al passo dell’oca, vide Poincaré visitare le lunghe gallerie di Verdun, segnate dal fato, tra file di soldati in divisa azzurra, inaspriti e prossimi a ribellarsi, vide le ferite incancrenite, il colera, il tifo, i bimbetti col ventre enfiato dalla fame, i cadaveri verminosi della ritirata serba, gli ufficiali alleati ubriachi che inseguivano ragazze nude e malate su per le scale dei bordelli di Salonicco, soldati che saccheggiavano negozi e chiese, marinai francesi e britannici che facevano a bottigliate nei bar; camminò su e giù per la terrazza con re Costantino durante il bombardamento di Atene, si batté in duello con un membro della commissione francese che era uscito dal locale perché un tedesco si era seduto a un tavolo del Grande Bretagne; Hibben credeva che il duello fosse uno scherzo, finché tutti i suoi amici non cominciarono a mettersi in cilindro; lui stette al suo posto e si lasciò sparar contro due colpi dal francese, poi sparò a terra; ad Atene come in ogni altro posto si cacciava sempre nei guai, uomo truculento di corporatura mingherlina, sempre pronto a prender posizione per i suoi amici, per gli sfortunati, per qualche idea, sempre troppo irrequieto per potersi mai costruire una carriera rispettabile. Chiamato alle armi, primo tenente nella 1 a Armata dal 27 nov. 1917; capitano dal 31 maggio 1919; prestò servizio nel campo addestramento bellico Grant; in Francia col 332° Regg., 8 a Armata; Servizi commissariato oltremare; al Gran Quartier generale nell’ufficio dell’ispettore generale del corpo di spedizione americano; dimesso il 21 agosto 1919; capitano della Croce Rossa il 7 febbr. 1920; congedato il 7 febbr. 1925. La guerra in Europa era sanguinosa e sporca e monotona, ma la guerra a New York rivelò tali viscidi abissi di viltà ed ipocrisia che chi l’ha vista non potrà mai sentirsi ancora lo stesso uomo di prima; nei
campi di addestramento era un’altra cosa, i ragazzi credevano in un mondo destinato alla Democrazia; Hibben credeva nei Quattordici punti, credeva nella “Guerra per metter fine alla guerra”. Con la missione militare in Armenia agosto-dicembre 1919; inviato speciale in Europa per il «Chicago Tribune»; con il Near East Relief 1920-22; segretario della commissione della Croce Rossa russa in America 1922; vicedirettore per l’America della missione di aiuti Nansen 1923; segretario della commissione americana per gli aiuti ai bambini russi aprile 1922. Nell’anno della carestia nell’anno del colera nell’anno del tifo Paxton Hibben andò a Mosca con una commissione di soccorso. A Parigi stavano ancora disputando sul prezzo del sangue, litigando sulle bandierine, sulle frontiere fluviali riportate nelle carte in rilievo, sui destini storici dei popoli, mentre dietro le quinte i bravi giocatori di bridge, i Deterding, i Sacharov, gli Stinnes, se ne stavano beati e tranquilli e allungavano le mani sulle materie prime. A Mosca c’era ordine, a Mosca c’era lavoro, a Mosca c’era speranza; la Marsigliese del 1905, Onward, Christian Soldiers del 1912, la torva passività degli indiani d’America, dei fanti che attendevano la morte al fronte, entravano a comporre il tremendo ruggito dall’Internazionale marxista. Hibben credette nel mondo nuovo. Tornato lui in America qualcuno mise le mani sopra una fotografia del capitano Paxton Hibben in atto di deporre una ghirlanda sulla tomba di Jack Reed. Cercarono di buttarlo fuori dalla Croce Rossa; a Princeton, alla ventesima riunione della sua classe universitaria, i suoi compagni di corso stavano per linciarlo; erano ubriachi, e forse si trattava semplicemente di uno scherzo goliardico in ritardo di vent’anni, ma insomma gli misero un cappio al collo, a morte il rosso fottuto. In America non c’era più posto per i mutamenti, per le vecchie belle parole: giustizia sociale, progresso, rivolta contro l’oppressione, democrazia; buttate a mare i rossi,
niente denaro per loro, niente posti per loro. Membro della Authors’ League of America, della Society of Colonial Wars, della Vets of Foreign Wars, dell’American Legion, delle Royal and American Geographical Societies, insignito cavaliere dell’Ordine di San Stanislao (russo), ufficiale dell’Ordine del Redentore (greco), dell’Ordine del Sacro Tesoro (Giappone). Club: Princeton, giornalistico, civico (New York). Opere: Costantine and the Greek People 1920, Report on the Russian Famine 1922, Henry Ward Beecher. An American Portrait 1927. Morto nel 1928. 1. “Grande vecchio partito”, il partito repubblicano: è questo un epiteto con cui lo si designava dopo il 1880. (NdT)
Cine-giornale XXVI L’EUROPA SUL FILO DEL RASOIO Tout le long de la Tamise nous sommes allés tous les deux goûter l’heure exquise… in tali condizioni è sorprendente che il dipartimento della Giustizia consideri con benevolenza bella e buona coloro che si sono rifiutati al servizio militare obbligatorio, con indulgenza anarchici notori e con indifferenza la stragrande maggioranza di coloro che sono ancora fuor di prigione o esenti da deportazione anni e anni dopo che l’organizzazione della Steel Corporation americana Wall Street si è dedicata al problema di misurare le iarde cubiche d’acqua immessa nella proprietà L’acciaio rifinito si muove un po’ più facilmente Ragazzi di qui dove si va dove si va di qui ragazzi? Volo d’anitre selvatiche su Parigi L’INDUSTRIA DEI CONCIMI CHIMICI STIMOLATA DALLA GUERRA In un posto qualunque tra Harlem e un molo di Jersey City la vittoria dipende dai lavoratori dell’industria né più né meno che dai soldati. Il nostro mirabile primato di vari cento navi il giorno dell’Indipendenza mostra quello che si può fare quando tendiamo le nostre energie sotto lo sprone del patriottismo I BAGNI SAMARITAINE TRAVOLTI DALLA PIENA DELLA SENNA Forse io non lo so perché si fa la guerra ma puoi star sicura che presto lo saprò e così amore mio non avere paura ti porterò un re
come ricordo e poi anche un turco e il Kaiser se non basta e mi par che più di questo non si possa far nulla PROGETTI POSTBELLICI DI UTILIZZARE L’ETNA PER GLI ESPLOSIVI L’antica città immersa in un’atmosfera di tristezza anche le campane tacciono di domenica Ragazzi di qui dove si va dove si va di qui ragazzi?
Richard Ellsworth Savage Fu a Fontainebleau, allineati nella piazza antistante al palazzo di Francesco I, che videro per la prima volta le grosse ambulanze grigie Fiat che essi dovevano guidare. Schuyler aveva appena fatto una chiacchierata con gli autisti francesi che ce l’avevano a morte con loro perché ora dovevano tornare al fronte. Ma perché mai questi americani non potevano starsene a casa a badare ai fatti loro, invece di venir lì a occupare tutti i buoni posti da embusqués? Quella notte la sezione andò ad accantonarsi in baracche di cartone incatramato che puzzavano di disinfettante, in una cittadina della Champagne. Era il 4 luglio, combinazione, e così il maresciallo d’alloggio servì champagne a cena, e venne un generale coi baffi bianchi da tricheco a tener loro un discorso su come con l’aiuto dell’Amérique héroïque la victoire era certa, e propose un brindisi a le président “Vilson”. Il cuoco del reparto, Bill Knickerbocker, si alzò un poco nervosamente e brindò alla France héroïque, all’héroïque Cinquième Armée e alla victoire per Natale. I fuochi d’artificio li fornirono i boches, con un’incursione aerea che mandò tutti di corsa in rifugio. Una volta lì sotto, Fred Summers disse che c’era un cattivo odore, e comunque lui voleva da bere, così uscì con Dick a cercare un’osteria, tenendosi bene al riparo delle grondaie per sfuggire alle schegge di shrapnel dell’antiaerea. Trovarono un piccolo bar tutto pieno di fumo e di poilus francesi che cantavano La Madelon. Furono accolti da acclamazioni unanimi, e si videro offrire ben dodici bicchieri. Si fumarono le loro prime Caporal Ordinaire, e tutti fecero così entusiasticamente a gara nell’offrir loro da bere che all’ora di chiudere, quando le trombe sonarono l’equivalente della ritirata americana, Dick e Fred si trovarono a camminare un po’ malfermi per le strade buie a braccetto di due poilus che avevan promesso di trovare il loro accantonamento. I poilus dissero che la guerre era une saloperie e la victoire une sale blague, e domandarono con grande interesse se les américains sapevano niente della révolution en Russie. Dick disse che lui era pacifista e avrebbe salutato con entusiasmo qualunque mezzo per metter fine alla guerra, e si strinsero tutte le mani significativamente e
parlarono della révolution mondiale. Mentre stavano coricandosi sulle loro brandine da campo, Fred Summers improvvisamente scattò a sedere con la coperta addosso e disse in un suo tono buffo e solenne: «Ragazzi, questa non è una guerra, è un manicomio, che Dio lo stramaledica». Nella sezione c’erano altri due tipi che amavano bere e biascicar francese: Steve Warner, che aveva avuto un posto speciale all’università di Harvard, e Ripley, matricola della Columbia University. Si misero a girare assieme, in cerca di luoghi dove si potessero trovare omelette e pommes frites nei villaggi a portata di pedone, e ogni notte facevano il giro degli estaminets; divennero famosi col nomignolo di Grenadine Guards. 1 Quando la sezione si trasferì alla Voie Sacrée dietro Verdun e si acquartierò per tre piovose settimane in un paesino distrutto che si chiamava Érize-la-Petite, si misero vicini di branda in uno stesso angolo della vecchia fattoria sinistrata che fu loro assegnata come accantonamento. Pioveva tutto il giorno; gli autocarri passavano impastando la spessa melma delle strade e portavano uomini e munizioni a Verdun. Dick se ne stava seduto sulla sua branda a guardare attraverso l’uscio le sobbalzanti facce impillaccherate dei giovani soldati francesi che andavano all’attacco, ubriachi e disperati, e strillavano à bas la guerre, mort aux vaches, à bas la guerre. Una volta Steve entrò improvvisamente, il viso pallido sul mantello grondante, gli occhi che sbattevano, e disse con voce cavernosa: «Adesso so com’erano i carri della ghigliottina durante il Terrore, quelli sono proprio carri da ghigliottina!». Quando alfine giunsero a tiro d’artiglieria, Dick fu lieto di accorgersi che non aveva più paura di quanta ne avessero gli altri. La prima volta che andarono in linea, lui e Fred smarrirono la strada nei boschi tempestati di granate e stavano cercando di girare la macchina sopra un piccolo rialto nudo come la faccia della luna, quando tre granate di un ottantotto austriaco li sfiorarono come schiocchi di frusta. Non seppero nemmeno loro come avevano fatto a uscire dalla macchina e a buttarsi nel fosso, ma quando si dissipò il sottile fumo azzurro odorante di mandorla erano entrambi distesi bocconi nella mota. Fred ebbe un collasso nervoso, e Dick dovette passargli attorno
un braccio e continuare a sussurrargli all’orecchio: «Su su, ragazzo mio, bisognava pur farlo. Su Fred, che gliela faremo, a quei dannati». L’incidente gli parve buffo, ed egli continuò a ridersela per tutta la durata del viaggio di ritorno alla parte più tranquilla dei boschi, dove il posto di medicazione era stato astutamente collocato proprio davanti a una batteria da 405, in modo che il contraccolpo per poco non sbalzava i feriti dalle barelle ogniqualvolta sparava un cannone. Quando tornarono alla sezione dopo aver portato un carico di feriti al triage, 2 poterono mostrare tre frastagliati fori di schegge nel fianco della macchina. L’indomani cominciò l’attacco, con continui sbarramenti e controsbarramenti e nutriti bombardamenti a gas; la sezione fece servizio ininterrotto di ventiquattr’ore per tre giorni, e alla fine tutti avevano la dissenteria e i nervi a pezzi. Uno poi prese lo choc da bombardamento, quantunque per la troppa paura che aveva non fosse neanche andato in prima linea, e si dovette rimandarlo a Parigi. Un paio di uomini dovettero essere evacuati per dissenteria. Le Grenadine Guards superarono la prova dell’attacco abbastanza bene, senonché Steve e Ripley una notte avevano annusato un pizzico di iprite in più a P2 e vomitavano tutto quello che mangiavano. Nei periodi di ventiquattr’ore di riposo si riunivano in un giardinetto di Récicourt che era la base della sezione. A quanto pareva non v’era nessun altro che lo conoscesse. Il giardino era una dipendenza di una villa rosa, ma la villa era stata polverizzata come se un gran piede l’avesse schiacciata. Il giardino era intatto, solo un po’ infestato da erbacce per via dell’incuria, le rose e l’agrifoglio erano in fiore, e nei pomeriggi di sole vi erano farfalle e api ronzanti. Sulle prime scambiavano le api per colpi lontani in arrivo, e si gettavano bocconi non appena le udivano. In mezzo al giardino c’era una fontana di cemento fuori uso, e quivi sedevano quando ai tedeschi saltava il ticchio di bombardare la strada e il ponte vicino. C’era bombardamento regolare tre volte al giorno e ogni tanto qualche salva sparsa. Qualcuno veniva incaricato di far la fila al Copé per comperare meloni Francia del Sud e champagne da quattro franchi e cinquanta. Poi si toglievano le camicie per arrostirsi schiene e spalle se c’era il
sole, e sedevano nella fontana asciutta a mangiare i meloni e a bere il caldo champagne che sapeva di sidro e a confabulare sul come, tornati in America, avrebbero fondato un giornale clandestino tipo «La Libre Belgique» per dire alla gente che cos’era realmente la guerra. Quello che piaceva di più a Dick nel giardino era la piccola ritirata simile alle ritirate delle fattorie del New England, col sedile pulito e una mezzaluna nella porta, attraverso la quale nei giorni di sole le vespe che avevano un nido nel soffitto entravano e uscivano laboriose col loro ronzio. Lui stava lì seduto col ventre dolorante ascoltando le voci basse degli amici che conversavano nella fontana prosciugata. Le loro voci gli davano un senso di contentezza e di intimità casalinga mentre si puliva con qualche ritaglio ingiallito di un «Petit Journal» del 1914 che era ancora appeso a un chiodo nel cesso. Una volta tornò affibbiandosi la cintura e dicendo: «Sapete? Stavo pensando che bello sarebbe poter riorganizzare le cellule del nostro corpo in qualche altra forma di vita… è troppo brutto essere un uomo. Mi piacerebbe essere un gatto». Dick si mise a sedere sul cemento caldo della fontana come «un caro e comodo gattone domestico seduto accanto al fuoco». «Gran brutto segno» disse Steve allungando le mani sulla camicia e indossandola. Una nube aveva coperto il sole e d’improvviso si era messo a far freddo. I cannoni facevano un rumore quieto e distante. Dick si sentì d’un tratto solo. «Gran brutto segno, quando bisogna vergognarsi di appartenere alla propria razza. Ma io lo giuro, lo giuro, ho vergogna di essere un uomo… ci vorrà qualche immensa ondata di speranza, come una rivoluzione, per ispirarmi ancora un po’ di rispetto per me stesso… Dio mio, siamo uno schifoso, crudele, vizioso tipo ottuso di scimmia senza coda.» «Be’, se vuoi guadagnarti il rispetto di te stesso, Steve, e il rispetto di noialtre compagne scimmie, perché non scendi, ora che non stanno bombardando, a comperarci una bottiglia di acqua sciampagnosa?» disse Ripley. Dopo l’attacco a quota 304 la divisione andò in riposo dietro Barle-Duc per un paio di settimane, e poi in un settore calmo delle Argonne detto le Four de Paris, dove i francesi giocavano a scacchi coi boches in linea e dove una parte avvertiva sempre l’altra prima di collocare una mina sotto un tratto di trincea. Quando non erano di
servizio potevano andare nell’abitata e intatta città di SainteMenehould a mangiare pasticcini freschi, minestra di zucche e pollo arrosto. Allorché la sezione fu sciolta e ciascuno rimandato a Parigi, Dick non ne voleva sapere di lasciare i dolci boschi autunnali delle Argonne. L’esercito americano doveva rilevare il servizio d’ambulanza aggregato ai francesi. Ciascuno ebbe una copia della menzione d’onore rilasciata alla sezione; Dick Norton tenne loro un discorso sotto il fuoco dell’artiglieria, senza mai lasciar cadere il monocolo dall’occhio, accomiatandosi da loro quali gentiluomini volontari, e così ebbe fine la sezione. Eccezion fatta per qualche rara granata della Bertha, Parigi fu quieta e piacevole in quel novembre. C’era troppa nebbia per le incursioni aeree. Dick e Warner trovarono una stanza a buon mercato dietro il Panthéon; di giorno facevano un gran leggere, e di sera girellavano per caffè e mescite. Fred Summers si trovò un posto nella Croce Rossa per venticinque dollari la settimana e una ragazza fissa il giorno dopo l’arrivo a Parigi. Ripley e Ed Schuyler presero alloggi di considerevole stile sopra il Bar Henry. Pranzavano tutti assieme ogni sera e si sfinivano dal gran discutere su quello che avrebbero dovuto fare. Steve diceva che lui andava a casa e avrebbe fatto l’obiettore di coscienza e al diavolo tutto, Ripley e Schuyler dicevano che avrebbero fatto qualunque cosa pur di starsene fuori dell’esercito americano, e parlavano di arruolarsi nella Legione straniera o nella squadriglia Lafayette. Fred Summers disse: «Ragazzi, questa guerra è la più colossale speculazione del secolo, e io sono per la guerra e per le crocerossine». Alla fine della prima settimana lui aveva due impieghi nella Croce Rossa, ciascuno da venticinque dollari la settimana, e alloggiava presso una madrina francese di mezza età che possedeva una grossa casa a Neuilly. Quando Dick rimase a corto di soldi, Fred se ne fece prestare per lui dalla sua madrina, ma non volle mai lasciarla vedere a nessun altro: «Non voglio che voialtri sappiate che cosa sto combinando» diceva. Un bel giorno all’ora di colazione Fred Summers arrivò per dire che tutto era a posto, e c’era un impiego pronto per ciascuno di loro.
Gli italiani, disse, dopo Caporetto erano abbastanza giù di squadra, e non riuscivano a perdere il vizio di ritirarsi. Si pensava che l’invio di una sezione Ambulanze della Croce Rossa americana avrebbe contribuito a rialzar loro il morale. Per il momento era incaricato lui del reclutamento, e aveva segnato tutti i nomi della banda. Dick disse che lui parlava bene l’italiano e che sentiva di poter essere di grande aiuto al morale degli italiani, e così il mattino dopo si presentarono tutti all’ufficio della Croce Rossa all’ora di apertura e furono debitamente arruolati nella sezione n. 1 della Croce Rossa americana per l’Italia. 3 Seguirono due settimane di attesa durante le quali Fred Summers si portò appresso una misteriosa signora serba, conosciuta in un caffè dietro la place Saint-Michel, che voleva insegnar loro a prendere l’hascisc, e Dick fece amicizia con un montenegrino beone, già barista a New York, che promise loro di farli insignire di onorificenze montenegrine da re Nicola in persona. Ma il giorno in cui dovevano essere ricevuti a Neuilly per farsi appuntare le onorificenze, la sezione partì. La colonna di dodici Fiat e otto Ford corse a est sulla liscia massicciata stradale attraverso la foresta di Fontainebleau, e girò a sud per le colline vinose della Francia centrale. Dick guidava una Ford da solo, e aveva tanto da fare per ricordarsi del modo di adoperare i piedi che il paesaggio gli sfuggì quasi completamente. Il giorno dopo s’inoltrarono nelle montagne e scesero nella valle del Rodano, una ricca campagna vinicola con platani e cipressi, odorosa di vendemmia e di tarde rose autunnali e di sud. All’altezza di Montélimar, la guerra, la preoccupazione del carcere, della protesta e della rivolta parvero un incubo uscito d’altro secolo. Fecero una magnifica cena nella quieta cittadina bianca e rosa, a base di funghi, aglio e vino rosso forte. «Amici miei» continuava a dire Fred Summers «questa non è una guerra, questo è un viaggio di piacere, accidenti!» Dormirono da principi nei lettoni dell’albergo coperti di broccato, e quando partirono, il mattino dopo, uno scolaretto rincorse l’auto di Dick gridando Vive l’Amérique e gli porse una scatola di nougat, la specialità locale: era il paese della cuccagna. Quel giorno la colonna si sparpagliò sulla via di Marsiglia; la
disciplina andò a farsi benedire; gli autisti si fermarono a tutte le osterie che trovarono nelle strade assolate, a bere e giocare a dadi. Il propagandista della Croce Rossa e il corrispondente del «Saturday Evening Post», il famoso scrittore Montgomery Ellis, si presero una sbornia tremenda e si misero a vociare e a strillare dal retro della macchina comando, mentre il tenentino grassoccio correva su e giù per la colonna a ogni fermata rosso e ansante, isterico come una chioccia che abbia perso i suoi pulcini. Finalmente si riunirono tutti al grosso ed entrarono a Marsiglia in formazione. Avevano appena finito di parcheggiare le macchine in fila nella piazza principale, e i ragazzi si stavano gettando all’arrembaggio dei bar e caffè circonvicini, quando un certo Ford ebbe la brillante idea di guardare nel serbatoio con un fiammifero acceso e fece saltare in aria la sua vettura. La locale squadra pompieri venne al gran completo e quando la macchina n. 8 fu incinerata a dovere rivolse il getto d’acqua ad alta pressione sulle altre, e Schuyler, che parlava il miglior francese di tutti, dovette troncare a mezzo una conversazione con la venditrice di sigarette del caffè d’angolo per andare a scongiurare il comandante dei pompieri di smetterla, per l’amor di Dio. Con l’aggiunta di un certo Sheldrake, esperto di danze folcloristiche e già appartenente alla famosa 7 a sezione, le Grenadine Guards pranzarono così sontuosamente al Bristol, ritrovo di colonnelli britannici e impiegati governativi dell’India con tanto di caschi di sughero, che spesero tutto il loro denaro. Fortunatamente trovarono poi sulla Canebière un compagno di sezione che fu in grado di far loro un prestito. Proseguirono la serata al Promenoir dell’Apollo, così gremito di petites femmes, tutte le petites femmes del mondo, che lo spettacolo non lo videro nemmen per sogno. Tutto era bizzarro e pieno di donne, le chiassose e luminose vie principali coi loro caffè e cabaret, e i neri tunnel sudaticci che erano le vie addossate al porto, piene di letti in disordine, marinai, pelle nera e pelle bruna, ventri dimenantisi, seni sfacciati biancopurpurei, cosce rigogliose. A tardissima ora Steve e Dick si trovarono soli in un piccolo ristorante a mangiar prosciutto, uova e caffè. Erano ubriachi e sonnacchiosi, e bisticciavano mezzo addormentati per qualcosa che
non aveva importanza. Quando pagarono il conto, la cameriera, una donna di mezza età, li avvertì di mettere la mancia all’angolo del tavolo e li fece soprassaltare alzandosi in tutta calma le gonne per raccogliere le monete fra le gambe. «È uno scherzo, uno scherzo di quelli al pepe… Il sesso è una distributrice automatica» continuava a dire Steve, e la cosa apparve enormemente buffa, tanto buffa che al mattino presto andarono in un bar già aperto per tentare di raccontarla all’uomo che stava al banco, ma lui non li capì e scrisse su un pezzo di carta il nome di uno stabilimento dove si poteva faire rigajig, une maison propre convenable, et de haute moralité. Ululando dal ridere finirono per salire scale interminabili barcollando e incespicando a ogni piè sospinto. Il vento era diaccio come l’ultimo girone dell’Inferno. Si trovarono davanti a una stramba cattedrale dominando con la vista il porto, i piroscafi, grandi distese di un mare di platino circoscritto da montagne cineree. «Perdio, quello è il Mediterraneo.» Il freddo vento estroso e la vasta vampa metallica dell’alba rinfrescarono loro le idee, ed essi tornarono all’albergo in tempo per scuotere gli altri dal sonno dell’ubriachezza e presentarsi per primi al parcheggio. Dick aveva tanto sonno che non ricordava più le manovre da farsi coi piedi, andò a sbattere con la sua Ford contro la vettura precedente e fracassò i fari. Il tenente grasso lo cicchettò aspramente, gli tolse la macchina e lo mise sopra una Fiat con Sheldrake, dimodoché Dick non ebbe più nulla da fare se non guardare tra il velo della sonnolenza la Corniche e il Mediterraneo e le città dai tetti rossi e le lunghe file di piroscafi diretti a est sotto costa per tema dei sommergibili, scortati da qualche caccia francese coi fumaioli nei posti più impossibili. Al confine italiano furono accolti da folle di scolari con foglie di palma e canestri di arance, nonché da un operatore cinematografico. Sheldrake continuò a strofinarsi la barba, a inchinarsi e fare gran saluti alle grida di Evviva gli americani, sinché chissà come si buscò tra gli occhi un’arancia che per poco non gli provocò il sangue dal naso. Un altro uomo della colonna per un pelo non ebbe un occhio accecato da una foglia di palma gettata da un delirante cittadino di Ventimiglia.
Fu un’accoglienza grandiosa. Quella notte a Sanremo italiani entusiasti continuarono ad avvicinare i boys per via stringendo loro le mani e congratulandosi con loro per il presidente “Vilson”; qualcuno rubò tutti gli pneumatici di ricambio alla camionetta e la valigia del propagandista della Croce Rossa, rimasta nella vettura comando. Furono salutati con effusione e imbrogliati sul resto nei bar. Evviva gli alleati. Nella sezione tutti quanti cominciarono a stramaledire l’Italia e gli spaghetti di gomma e il vino acetoso, tranne Dick e Steve, che divennero di colpo amanti degli italiani e si comperarono grammatiche per imparare la lingua. Dick riusciva già abbastanza bene a finger di parlare italiano, specialmente in presenza di ufficiali della Croce Rossa, con l’espediente di aggiungere una o in fondo a tutte le parole francesi che conosceva. Non gliene importava più un fico di nulla. C’era sole, il vermut era una gran bevanda, le cittadine e le chiesette piccole come giocattoli in cima ai colli e le vigne e i cipressi e il mare azzurro erano come una successione di sfondi in un’opera vecchio stile. Gli edifici erano teatrali e di una sontuosità ridicola; su ogni muro cieco i dannati italiani avevano dipinto finestre, colonnati e balconi con grasse bellezze tizianesche appoggiate alle balaustrate e nuvole e sciami di amorini paffuti. Quella notte parcheggiarono la colonna nella piazza principale di una borgatina dimenticata nei pressi di Genova. Ricordandosi di Marsiglia, il tenente grasso proibì a chiunque di andare in città e fece dormir tutti nelle vetture, per tema dei ladri. Dick e Steve andarono con Sheldrake a bere qualcosa in un bar, e quivi incontrarono il corrispondente del «Saturday Evening Post», il quale ben presto fu brillo e cominciò a dire quanto invidiava il loro bell’aspetto, la loro vigorosa giovinezza, il loro sano idealismo. Steve lo controbatté su quasi tutto e obiettò amaramente che la giovinezza era l’età più schifosa, e che lui avrebbe dovuto ritenersi ben fortunato di aver già quarant’anni e poter così scrivere sulla guerra anziché farla. Ellis bonariamente rilevò che nemmeno loro combattevano. Steve irritò Sheldrake ribattendo: «Eh già, certamente, noi siamo porci imboscati». Dick e Steve lasciarono il bar e se la diedero a gambe per impedire a
Sheldrake di raggiungerli. Svoltato l’angolo scorsero un’auto targata Genova, e Steve ci saltò sopra senza dire una parola. A Dick non rimase altro che seguirlo. L’automobile girò attorno a un isolato e sbucò sul lungomare. «Porco giuda, Dick,» disse Steve «la dannata città è in fiamme.» Di là dalle nere sagome di barche tirate in secco, una fiamma rosa come un gigantesco lampione mandava un largo folgorio sull’acqua verso di loro. «Santo Dio, Steve, non ci saranno mica gli austriaci?» L’auto proseguì rumorosa; il vigile che venne a chieder loro la patente pareva abbastanza calmo. «Inglesi?» domandò. «Americani» disse Steve. L’altro sorrise e diede loro un colpetto sulla schiena e disse qualcosa sul presidente “Vilson” che essi non capirono. Scesero dall’auto in una grande piazza circondata da grandi arcate spazzate da un crudo vento agrodolce e sabbioso. Gente agghindata in soprabito camminava su e giù sul lindo pavimento a mosaico. La città era tutta di marmo. Le facciate rivolte al mare riverberavano la vampa rosea dell’incendio. «Qua i tenori, i baritoni e i soprano son tutti pronti per l’inizio dello spettacolo» osservò Dick. Steve borbottò: «Il coro probabilmente lo faranno quegli animali degli austriaci». Avevano freddo e andarono a prendere un grog in uno dei caffè lucenti di nichel e cristallo. Il cameriere disse loro in un inglese smozzicato che l’incendio era una nave cisterna americana che aveva urtato in una mina, e bruciava ormai da tre giorni. Un ufficiale inglese dalla faccia lunga si avvicinò dal bar e prese a dire come egli si trovasse in missione segreta; la ritirata era un vero spavento; non era ancora cessata; a Milano si parlava di portare la linea sul Po; la sola ragione per cui gli austriaci non avevano invaso tutta quanta la Lombardia era la grande disorganizzazione provocata nel loro esercito dalla rapida avanzata: tant’è vero che erano mal ridotti quasi come gli italiani stessi. I fottuti ufficiali italiani continuavano a parlare del Quadrilatero, e se non fosse stato per le truppe francesi e britanniche dislocate dietro le linee italiane avrebbero venduto da un pezzo le attuali posizioni. 4 Il morale dei francesi era abbastanza scosso, però. Dick gli disse come gli arnesi sparissero per incanto ogni volta che staccavano gli occhi dall’auto. L’inglese disse che da quelle parti c’era
un’attività ladresca formidabile; ecco l’oggetto della sua missione segreta; lui stava cercando di rintracciare un intero carico di scarpe sparito tra Ventimiglia e Saint-Raphaël: «Il carro bagagli si volatilizza in una notte… incredibile!». «Vedete quegli idioti là, a quel tavolo? Sono spie austriache, dal primo all’ultimo… ma per quanto faccia, non riesco a farli arrestare… incredibile! È una sporca commedia, ecco che cosa è, proprio come a Drury Lane. Meno male che siete intervenuti voialtri americani. Altrimenti a quest’ora avreste visto garrire su Genova la bandiera tedesca.» Si guardò improvvisamente l’orologio da polso, li consigliò di acquistare al bar una bottiglia di whisky se volevano bere un altro po’ perché era ora di chiudere, li salutò e uscì in fretta e furia. Si riavventurarono nella deserta città di marmo, per bui viali e strade a gradinate, col riverbero di qualche muro alto e sporgente sempre più vivido e rosso a misura che si avvicinavano al mare. Di tanto in tanto si perdevano; finalmente sbucarono sullo spettacolo dei moli, groviglio d’antenne di affollate feluche, e oltre le piccole onde del porto, screziate di cremisi, i frangiflutti, e più in là ancora la massa di fiamme della nave cisterna incendiata. Eccitati e brilli percorsero la città in lungo e in largo. «Perdio, queste città sono più antiche del mondo stesso» ripeteva continuamente Dick. Mentre osservavano un leone di marmo dalle forme canine, lisciato e lustrato da secoli e secoli di mani, che stava con aria paziente in fondo a una scalinata, li chiamò una voce americana, chiedendo se sapevano orientarsi in quella dannata città. Era un giovane marinaio imbarcato su un piroscafo americano appena arrivato con un carico di muli. Gli risposero che sì, sapevano orientarsi, e gli offrirono una sorsata dalla bottiglia di cognac appena comperata. Sedettero lì sulla balaustrata di pietra accanto al leone che pareva un cane, discorrendo tra un sorso e l’altro. Il marinaio mostrò loro certe calze di seta ricuperate sulla nave incendiata, e raccontò di essersi “suonata” una ragazza italiana, solo che lei si era addormentata e lui si era disgustato e l’aveva piantata in asso. «Questa guerra è un bordello, non è vero?» disse; e sbottarono tutti assieme in una risata. «Voialtri mi sembrate due tipi simpatici» disse il marinaio. Gli
porsero la bottiglia e lui ne tracannò una golata. «Siete due principi» soggiunse rauco «e voglio dirvi quello che penso, ecco… Questa maledetta guerra è tutta una truffa, non è regolare, è storta da cima a fondo. In qualunque modo vada a finire, i fregati saranno sempre quelli come noi, vedete? Be’, io dico che la va a rotta di collo, facciamo quello che ci pare e ciascuno vada all’inferno nella maniera che più gli piace… e sono le tre suonate, sentite?» Finirono il cognac. Cantando a squarciagola: «Vadano all’inferno, dico!», il marinaio lanciò la bottiglia con tutta la forza sulla testa del leone di pietra. Il leone genovese continuò a fissare innanzi a sé coi vitrei occhi di cane. I soliti sfaccendati dall’aria acida presero a far crocchio lì attorno per vedere di che si trattava, e così loro se ne andarono via, e il marinaio nel camminare sbandierava le sue calze di seta. Gli trovarono il suo bastimento attraccato alla banchina e gli strinsero le mani ripetutamente sulla passerella. Poi toccò a Dick e Steve rifare le dieci miglia di strada che li separavano da Pontedecimo. Infreddoliti e assonnati, camminarono sino a piagarsi i piedi, poi fecero il resto della strada con un autocarro italiano. Il selciato della piazza e i tetti delle macchine eran coperti di brina, quando arrivarono. Nell’infilarsi in barella accanto a Sheldrake, Dick fece rumore, e Sheldrake si svegliò: «Che diavolo succede?» disse. «Chiudi il becco» disse Dick. «Non vedi che stai svegliando la gente?» L’indomani andarono a Milano, grande città invernale con la sua smisurata cattedrale a portaspilli e la sua Galleria gremita di gente, i ristoranti, i giornali, le puttane, gli amari Cinzano e Campari. Seguì un altro periodo di attesa durante il quale la sezione si insediò quasi al completo nella saletta interna del Cova a giocare un’interminabile partita a dadi; poi si trasferirono in un posto che si chiamava Dolo, presso un canale gelato, perso nella pianura veneta. Per arrivare all’elegante villa adorna di sculture e pitture che era stata loro assegnata come alloggio, dovettero attraversare il Brenta. Una compagnia di guastatori britannici aveva già minato il ponte, pronta a farlo saltare non appena ricominciasse la ritirata. Promisero di aspettare che la 1 a sezione fosse passata, qualora dovessero
effettivamente far saltare il ponte. A Dolo c’era ben poco da fare; inverno inclemente; mentre quasi tutta la sezione se ne stava seduta attorno alla stufa a giocarsi la paga a poker, le Grenadine Guards si facevano punch caldi al rum con un fornello a benzina, leggevano il Boccaccio in italiano e discutevano di anarchia con Steve. La maggior parte del suo tempo Dick la passava a lambiccarsi il cervello sulla maniera di fare una scappata a Venezia. Si venne a sapere che il tenente grasso era seccato per la mancanza di cacao e perché il commissario della Croce Rossa di Milano non aveva mandato alla sezione Generi da prima colazione. Dick si fece avanti con l’idea che Venezia era uno dei massimi mercati mondiali di cacao, e che bisognava pur mandarci a comperare il cacao qualcuno pratico della lingua; e così un bel mattino Dick, fornito di regolari fogli di viaggio e timbri, salì sul vaporetto di Mestre. Sulla laguna c’era una crostina di ghiaccio che si stracciava con un suono di seta da ambo le parti dell’aguzza prora dove Dick stava appoggiato al parapetto, lagrimando per il vento pungente, osservando le lunghe file di pali e i chiari edifici rossi salenti dall’acqua verde per culminare in pallide cupole simili a bolle di sapone e in torri dalla cima a punta quadra che si stagliavano sempre più nette sul cielo di zinco. I ponti gobbi, gli scalini viscidi e verdi, i palazzi, i lungomare di marmo eran tutti vuoti. Il solo segno di vita era dato da un gruppo di torpediniere ancorato nel Canal Grande. Dick si scordò completamente del cacao nel passare per le piazze adorne di sculture, per le strette calli e le fondamenta costeggianti i canali gelati della grande città morta che giaceva lì sulla laguna fragile e vuota come una spoglia di serpente. Da nord si sentiva il lontano brontolio dei cannoni che si trovavano sul Piave, a quindici miglia da Venezia. Durante il viaggio di ritorno, prese a nevicare. Pochi giorni dopo si trasferirono a Bassano, dietro il monte Grappa, in una villa del tardo Rinascimento, tutta dipinta ad angeli, amorini e complicati drappeggi. Dietro la villa il Brenta ruggiva giorno e notte sotto un ponte coperto. Là passarono il tempo a evacuare i colpiti da congelamento ai piedi, a bere punch al rum a Cittadella, dove si trovavano l’ospedale di base e la casa di tolleranza,
e a cantare The Foggy Foggy Dew e The Little Black Bull Came Down from the Mountain mentre si mangiavano il rancio costituito da spaghetti di gomma. Ripley e Steve decisero di imparare il disegno, e passarono le giornate a disegnare particolari architettonici o il ponte coperto. Schuyler si esercitò in italiano parlando di Nietzsche col tenente italiano. Ed Summers si era buscato un brutto regalo da una signora milanese che a sentir lui doveva appartenere a una delle migliori famiglie, perché andava in carrozza, ed era stata lei a invitarlo, non viceversa, e così passò quasi tutto il tempo a confezionarsi rimedi empirici come picciuoli di ciliegia in acqua calda. Dick finì per sentirsi solo e malinconico e bisognoso d’intimità, e scrisse un mucchio di lettere in patria. Le lettere di risposta lo facevano star peggio di quanto si sarebbe sentito non avendone nessuna. “Dovete capire come stanno le cose,” scriveva ai Thurlow rispondendo a un’entusiastica tirata di Hilda sulla “guerra per metter fine alla guerra” “io non credo più nel cristianesimo e non posso discutere da quel punto di vista, ma voi sì, o almeno Edwin, e lui dovrebbe rendersi conto che esortando i giovani a cacciarsi in questo assurdo manicomio d’una guerra fa proprio di tutto per minare i princìpi e gli ideali in cui crede maggiormente. Come disse quel giovanotto con cui parlammo quella notte a Genova, non è una cosa regolare, è una lurida truffa imbastita da governi e politicanti per i loro egoistici interessi, è storta da cima a fondo. Se non fosse per la censura potrei dirvi cose tali da farvi vomitare.” Poi abbandonava di scatto questo tono disquisitorio, e allora gli sembravano tremendamente sciocche tutte le frasi sulla libertà e la civiltà che gli vaporavano dal cervello, e si accendeva il fornello a benzina, si faceva un bel punch al rum e si rianimava infilando una lunga chiacchierata con Steve sui libri, la pittura o l’architettura. Nelle notti di luna gli austriaci ravvivavano un po’ la situazione mandando bombardieri. Certe notti Dick si accorgeva che lo star fuori dal ricovero e fornir loro una possibilità di colpirlo gli dava una specie di amaro piacere, e comunque il ricovero non serviva a nulla contro una bomba centrata in pieno. Una giornata di febbraio Steve lesse nel giornale che era morta
l’imperatrice Taitù di Abissinia. Ci fecero un veglione. Si bevvero tutto il rum che avevano, e si sfogarono a far lamentazioni funebri sinché gli altri componenti la sezione non li credettero impazziti. Erano tutti seduti al buio attorno alla finestra aperta e illuminata dalla luna, avvolti nelle coperte e intenti a bere zabaglione caldo, quando alcuni aeroplani austriaci che da un po’ ronzavano in quei paraggi spensero i motori e sganciarono un carico di bombe proprio davanti a loro. I cannoni antiaerei latravano già da qualche tempo e gli shrapnel lampeggiavano in alto nel cielo lattiginoso, ma loro erano troppo sbronzi per accorgersene. Una bomba cadde in pieno Brenta e le altre riempirono d’una balzante vampata rossa lo spazio inquadrato dalla finestra e squassarono la villa con tre ruggiti. Dal soffitto caddero pezzi d’intonaco. Si poterono udir le tegole andare in pezzi cadendo dal tetto. «Cristo, questa è stata quasi la buona notte» disse Summers. Steve attaccò a cantare Come Away from That Window, My Light and My Life, ma gli altri lo sommersero con uno stonato Deutschland, Deutschland über Alles. Si sentirono tutti di colpo ubriachi fradici. Ed Schuyler se ne stava ritto sopra una sedia a declamare Il re degli elfi, 5 quando Feldmann, il figlio d’un albergatore svizzero, che era ora capo della sezione, si affacciò all’uscio e chiese loro che diavolo stavano facendo. «Fareste meglio a scendere nel ricovero, uno dei meccanici italiani è stato ucciso e un soldato che camminava per la strada ha avuto le gambe asportate… non è proprio il momento di far chiasso.» Gli offrirono da bere e lui se ne andò furente. Dopodiché ci bevvero sopra del marsala. A un certo punto nel primo grigiore dell’alba Ed si alzò e si avvicinò barcollando alla finestra per vomitare; pioveva a dirotto, le rapide schiumeggianti del Brenta aumentavano di candore attraverso la pioggia luccicante. L’indomani toccò a Dick e Steve andare in servizio di linea a Rova. Uscirono dal cortile alle sei con la testa come un pallone in fiamme, arcicontenti di svignarsela da quel po’ po’ di scandalo che ci sarebbe stato in sezione. A Rova le linee erano calme, solo qualche caso di polmonite o di malattie veneree da evacuare, e un paio di poveri diavoli che si erano sparati in un piede e dovevano essere mandati
all’ospedale sotto scorta; ma alla mensa ufficiali, dove consumarono il pasto, c’era molta agitazione. Il tenente Sardinaglia era agli arresti per aver mancato di rispetto al colonnello, ed eran già due giorni che stava lì a comporre una marcetta sul mandolino, da lui chiamata la marcia dei colonnelli medici. Il fatto lo raccontò Serrati, ridendo covertamente, mentre si aspettava l’arrivo a mensa degli altri ufficiali. Ed era tutto a causa della caffettiera. C’erano solo tre macchine 6 per tutta la mensa, una per il colonnello, una per il maggiore, e l’altra girava a turno fra gli ufficiali subalterni; bene, un bel giorno della scorsa settimana avevano molestato un pochettino quella bella ragazza, la nipote del fattore presso il quale erano alloggiati; lei non si era lasciata baciare da nessuno degli ufficiali ed era andata su tutte le furie quando l’avevano pizzicata nel didietro, e il colonnello ci s’era arrabbiato, tanto più quando Sardinaglia aveva scommesso cinque lire contro di lui che l’avrebbe baciata, e infatti le aveva bisbigliato qualcosa all’orecchio e lei lo aveva lasciato fare, e allora il colonnello era diventato paonazzo e aveva detto all’ordinanza di non dare la macchina al tenente quando veniva il suo turno; e Sardinaglia aveva preso l’attendente a schiaffi, si era scatenata una rissa, e come risultato adesso Sardinaglia era agli arresti in casa e gli americani avrebbero visto che circo era. Dovettero tutti fare di colpo la faccia seria perché entravano in quel momento fra un tintinnar di speroni il colonnello, il maggiore e i due capitani. L’ordinanza entrò salutando e disse in tono allegro pronto spaghetti, e tutti si misero a sedere. Per un po’ gli ufficiali stettero zitti, occupati a succhiare le lunghe cordicelle oleose degli spaghetti ammantati di pomodoro, si fece passare attorno il vino e il colonnello si era appena schiarita la gola per cominciare una di quelle sue barzellette alle quali tutti dovevano ridere, quando dall’alto venne un trillo di mandolino. Il colonnello divenne rosso in viso, e invece di parlare si mise in bocca una forchettata di spaghetti. Siccome era domenica, il pasto fu molto lungo: al dessert la macchina da caffè fu aggiudicata a Dick quale cortesia agli americani, e qualcuno tirò fuori una bottiglia di Strega. Il colonnello disse all’ordinanza di dire alla bella ragazza che venisse a bere con lui un bicchierino di Strega; l’attendente si mostrò piuttosto
contrariato, a quanto parve di capire a Dick; ma andò a prenderla. Lei era una bella e robusta campagnola olivastra. Con le guance infocate si avvicinò timidamente al colonnello per dirgli grazie tante, ma, per favore, non bevo mai bibite forti. Il colonnello l’afferrò e se la fece sedere sulle ginocchia e tentò di farle bere il suo bicchiere di Strega, ma lei tenne serrata la sua bella fila di denti eburnei e non ne volle sapere. Alla fine parecchi ufficiali la tenevano ferma e la stuzzicavano, e il colonnello le versò lo Strega sul mento. Tutti ridevano a crepapelle tranne l’ordinanza, che si fece bianco come il gesso, e Dick e Steve che non sapevano dove guardare. Mentre gli ufficiali superiori la molestavano e le facevano il solletico e le ficcavano le mani sotto la camicetta, gli ufficiali subalterni la tenevano per i piedi e le mettevano le mani su per le cosce. Finalmente il colonnello riuscì a dominare il riso abbastanza da poter dire: «Basta, adesso deve darmi un bacio». Ma la ragazza si svincolò con uno strattone e corse fuori dalla stanza. «Vai a riprenderla» disse il colonnello all’ordinanza. Dopo un po’ l’ordinanza tornò e si mise sull’attenti dicendo che non era riuscito a trovarla. «Buon per lui» sussurrò Steve a Dick. Dick notò che le gambe dell’ordinanza tremavano. «Ah, non ci riesci, eh?» ruggì il colonnello dando uno spintone all’ordinanza; un tenente sporse il piede e l’ordinanza vi inciampò cadendo. Tutti risero, e il colonnello gli diede un calcio; si era appena rialzato a quattro gambe, che il colonnello gli diede un altro calcio nel sedere mandandolo a ruzzolar bocconi un’altra volta. Gli ufficiali crepavano dal ridere, l’ordinanza strisciò verso la porta col colonnello alle calcagna che lo prendeva a calcetti prima da una parte e poi dall’altra, come un calciatore con un pallone. 7 Ciò rimise tutti di buonumore e ci fecero sopra una bevuta di Strega. Quando uscirono, Serrati, che prima rideva con gli altri, afferrò Dick per un braccio e gli sibilò all’orecchio: «Bestie… sono tutti bestie». Quando gli altri ufficiali se ne furono andati, Serrati li portò al disopra a trovare Sardinaglia, il quale era un giovane alto dalla faccia lunga che ci teneva a chiamarsi futurista. Serrati gli riferì quanto era avvenuto ed espresse il suo timore che gli americani ne fossero rimasti disgustati. «Un futurista non si deve disgustare di nulla, solo della
debolezza e della balordaggine» disse sentenziosamente Sardinaglia, e poi disse loro che aveva già scoperto con chi andava a letto la bella ragazza… con l’ordinanza. Questo sì che lo disgustava; dimostrava che le donne erano tutte troie. Quindi li invitò a sedersi sulla sua branda mentre lui sonava la marcia dei colonnelli medici. La trovarono bella. «Un futurista dev’essere forte e non disgustarsi di nulla,» disse sempre facendo trillare il mandolino «ecco perché ammiro i milionari tedeschi e americani.» Risero tutti di cuore. Dick e Steve uscirono a prendere alcuni feriti da portare all’ospedale. Dietro la fattoria, dove avevano parcheggiato la macchina, trovarono l’ordinanza seduta sopra una pietra con la testa fra le mani, e le lacrime gli avevano rigato la patina di sporcizia che gli copriva il volto. Steve gli si avvicinò, gli batté la mano sulla schiena per confortarlo, gli offrì un pacchetto di sigarette Mecca avuto in assegnazione dall’YMCA. L’ordinanza strinse forte forte la mano di Steve, e per poco non la baciava. Disse che dopo la guerra se ne sarebbe andato in America, dove la gente era civile e non era un branco di bestie come lì. Dick gli domandò dove fosse andata la ragazza. «Se n’è andata via» disse lui. «Andata via.» Di ritorno alla sezione trovarono l’ira di Dio. Era venuto l’ordine per Savage, Stevens, Ripley e Schuyler di presentarsi all’ufficio centrale di Roma per poi ritornare agli Stati Uniti. Feldmann non volle dir loro di che cosa si trattava. Notarono subito che gli altri uomini della sezione li guardavano con aria sospettosa e stavano sulle spine quando dovevano parlare con loro, tranne Fred Summers, il quale disse che non ci capiva niente e comunque tutta la porca faccenda era roba da manicomio. Sheldrake, il quale aveva trasferito in un’altra stanza branda e bottino, si avvicinò con l’aria di chi sta per dire: “ve lo dicevo io!”, e asserì di aver sentito parlare di espressioni sediziose; un ufficiale italiano del servizio segreto era venuto a chiedere informazioni su di loro. Augurò loro buona fortuna e disse che gli dispiaceva davvero. Lasciarono la sezione senza salutar nessuno. Feldmann li portò in camionetta a Vicenza coi loro bottini e le brande. Alla stazione ferroviaria consegnò loro il foglio di viaggio per Roma, disse che gli dispiaceva, augurò buona fortuna e se ne andò in fretta e
furia senza stringer loro le mani. «Figli di cani,» grugnì Steve «neanche se avessimo la lebbra.» Ed Schuyler leggeva i documenti militari, col volto raggiante. «Uomini e fratelli,» disse «mi sento proclive a tenere un discorso… questa è la più grossa speculazione che si sia mai vista… vi rendete conto, signori miei, che avviene precisamente questo: la Croce Rossa, altrimenti conosciuta come la gallina dalle uova d’oro, ci regala gratuitamente un giro turistico per l’Italia? A Roma dobbiamo presentarci solo tra un anno.» «Stiamo alla larga da Roma finché non viene la rivoluzione» propose Dick. «Entriamo a Roma con gli austriaci» disse Ripley. Arrivò un treno. Si ficcarono in uno scompartimento di prima classe; quando il controllore cercò di spiegare che i loro fogli di viaggio erano per la seconda classe, loro fecero a non capir l’italiano, e così lui finì per lasciarli dov’erano. A Verona smontarono per spedire a Roma il bagaglio pesante. Era ora di cena, così decisero di fare un giretto per la città e di pernottarvi. Al mattino andarono a vedere il teatro antico e la grande chiesa di San Zeno, tutta di marmo color pesca. Poi sedettero al caffè della stazione finché non passò il treno di Roma. Il treno era stipato di ufficiali in mantelline azzurro pallido e verde pallido; all’altezza di Bologna erano ormai stufi di star seduti per terra nel corridoio e decisero di andare a vedere le torri pendenti. Poi si recarono a Pistoia, Lucca, Pisa e ripresero la linea principale a Firenze. Quando i controllori scotevano il capo guardando il foglio di viaggio, loro spiegavano di essere stati male informati e di aver preso il treno sbagliato per ignoranza della lingua. A Firenze il capostazione li fece salire d’autorità sull’espresso di Roma, ma loro se la svignarono dall’altra parte quando era già in movimento e salirono sul treno locale per Assisi. Di lì andarono a Siena via San Gimignano, piena di torri come New York, in una carrozzella noleggiata per l’intera giornata, e terminarono il loro giro un bel mattino primaverile a Orvieto, pieni fino al collo di pittura e olio e aglio e panorami, guardando gli affreschi di Signorelli nella cattedrale di Orvieto. Giunti a Roma, alla stazione prossima ai bagni di Diocleziano, si sentirono piuttosto male all’idea di dover consegnare il loro foglio di viaggio; e rimasero di stucco quando l’impiegato non fece che bollarlo e
restituirlo dicendo: «Per il ritorno». Andarono in un albergo a mettersi in ordine, e poi diedero fondo alle finanze comuni in gozzoviglie: un pasto da gran signori, con vino di Frascati e di Asti per dessert, un’operetta e un cabaret di via Roma dove incontrarono una ragazza americana che soprannominarono la baronessa, la quale promise di mostrar loro la città. A fine serata nessuno aveva ancora abbastanza denaro da poter accompagnare in casa la baronessa o qualcuna delle sue graziose amiche, e così con le ultime dieci lire noleggiarono una carrozza per andare a vedere il Colosseo al chiaro di luna. Le rovine, le pietre scolpite, i nomi, i maestosi nomi romani, il vecchio fiaccheraio col suo cappello a tubo di stufa rivestito di tela cerata e la sua mantelletta verde, che indicava bordelli sotto l’ultimo quarto di luna in rovina, le grandi masse di muratura piene di archi e colonne che gremivano la notte, l’eco potente della parola Roma che smoriva nel passato con accordi pomposi, li mandarono a letto con la testa in un turbine, Roma pulsante negli orecchi a tal punto da non lasciarli dormire. Il mattino dopo Dick si alzò che gli altri dormivano ancora e andò alla Croce Rossa; lo aveva assalito un improvviso orgasmo che gli impedì persino di consumare la colazione. All’ufficio c’era un corpulento maggiore di Boston, che evidentemente aveva in mano la direzione, e gli chiese a bruciapelo che diavolo avesse. Il maggiore intercalava il discorso di «già, già» e «vedo, vedo», e manteneva la conversazione su di un tono piacevole, da ex harvardiano a ex harvardiano. Parlò delle indiscrezioni e dell’ipersensibilità italiana. In effetti al censore non andava giù il tono di certe lettere, eccetera eccetera. Dick disse che secondo lui la sua posizione doveva essere chiarita, e se, secondo la Croce Rossa, lui non aveva fatto il suo dovere, allora lo mandassero davanti a una Corte marziale, sapeva benissimo che tanti uomini come lui avevano idee pacifiste ma ora che il paese era in guerra eran disposti a dare il loro contributo di lavoro in qualsiasi forma, e con ciò egli personalmente non credeva affatto nella guerra, e sentiva di aver diritto a spiegare la propria posizione. Il maggiore disse Ah bene, lui capiva perfettamente, eccetera eccetera, ma i giovani dovevano pur comprendere l’importanza della
discrezione eccetera eccetera, e ora la faccenda era stata tutta soddisfacentemente spiegata come un’indiscrezione; e l’incidente era chiuso. Dick continuava a dire che lui si sentiva in diritto di spiegare la propria posizione, e il maggiore a dire che l’incidente era chiuso eccetera eccetera, sinché la scena cominciò a parere un po’ sciocca e lui lasciò l’ufficio. Il maggiore gli promise di provvedere personalmente al suo trasferimento a Parigi qualora volesse assumere un posto nell’ufficio di quella città. Dick tornò all’albergo mortificato e confuso. Gli altri due erano usciti, così lui e Steve fecero un giro per la città guardando le vie soleggiate che odoravano di olio fritto, vino e pietre vecchie, le chiese barocche con le loro cupole, le colonne, il Pantheon e il Tevere. Non avevano in tasca un centesimo per pagarsi da mangiare o da bere. Passarono il pomeriggio nella fame sonnecchiando cupi sulle calde aiole del Pincio, e tornarono in camera affamati e depressi trovandovi Schuyler e Ripley che, invece, bevevano vermut al selz ed erano di ottimo umore. Schuyler si era imbattuto in un vecchio amico di suo padre, il colonnello Anderson, che era in giro d’ispezione per la Croce Rossa, e a lui aveva confidato i suoi guai fornendogli anche informazioni su certi furtarelli dell’ufficio di Milano. Il maggiore Anderson gli aveva offerto colazione e whisky allungato all’Hôtel de Russie, prestandogli inoltre un centinaio di dollari e assegnandogli un posto nel reparto Pubblicità. «Così, uomini e fratelli, evviva l’Italia e i maledetti Alleati, siamo tutti a posto.» «E il dossier?» domandò con veemenza Steve. «Oh, scordatene ormai, siamo tutti italiani… chi mai è disfattista in un momento come questo?» Schuyler offrì da mangiare a tutti, li portò in gita a Tivoli e al lago di Nemi in un’auto del comando e finalmente li mise sul treno di Parigi col titolo di capitano sui rispettivi fogli di viaggio. Il primo giorno Steve andò all’ufficio della Croce Rossa e disse che voleva rimpatriare. A tutta prima non si voleva sbottonare con Dick, ma poi disse imbronciato: «All’inferno tutto, io vado a fare l’obiettore di coscienza». Ripley disse che qualunque cosa fosse accaduta lui non sarebbe mai andato alle armi né si sarebbe iscritto alla scuola di artiglieria francese di Fontainebleau. Dick si trovò una camera a buon prezzo in un alberghetto sull’Île Saint-Louis e passò le giornate a
intervistare i vari alti gradi della Croce Rossa. Aveva cablografato da Roma a Hiram Halsey Cooper e ne aveva ricevuto una risposta assai circospetta nella quale gli si suggerivano due nomi di persone con cui poteva parlare. I pezzi grossi se lo rimbalzavano da un ufficio all’altro. «Giovanotto» disse un funzionario calvo in un lussuoso ufficio all’Hôtel Crillon «le tue opinioni non contano, perché tradiscono una mentalità insensata e codarda. Il popolo americano è impegnato in una vera caccia al Kaiser. Noi stiamo tendendo a questo fine ogni nervo, ogni forza; chiunque metta un bastone fra le ruote della grande macchina che l’energia e la devozione di cento milioni di patrioti stan costruendo al purissimo fine di salvare la civiltà dagli unni, sarà schiacciato come una mosca. Mi sorprende davvero che un laureato come te non abbia un po’ più di buon senso. Non scherzare col fuoco.» Finalmente fu mandato al servizio segreto dell’esercito, dove trovò un giovane a nome Spaulding, vecchia conoscenza di università, che lo accolse con un sorriso untuoso. «Vecchio mio» disse «in tempi come questi non si può cedere ai propri sentimenti personali, non ti pare?… Secondo me è semplicemente criminale permettersi il lusso di opinioni private, perfettamente criminale. Siamo in guerra e dobbiamo fare tutti il nostro dovere, è proprio la gente come te che incoraggia i tedeschi a continuare la lotta, gente come te e i russi.» Il superiore di Spaulding era un capitano che portava speroni e gambali magnifici, giovane dall’aria severa e dal profilo delicato. Si avvicinò a Dick, faccia contro faccia, e gridò: «Che cosa faresti se due unni aggredissero tua sorella? Lotteresti, no?… ammenoché tu non sia un lurido cane». Dick tentò di far osservare che lui ci teneva a continuare il lavoro fatto sino allora, stava facendo il possibile per rientrare nella Croce Rossa e desiderava semplicemente un’opportunità di spiegare la sua posizione. Il capitano si mise a camminare su e giù vociando che chiunque rimaneva pacifista dopo la dichiarazione di guerra del presidente era un deficiente o, peggio, un degenerato, e lui avrebbe fatto in modo di rimandare Dick negli Stati Uniti togliendogli la possibilità di tornare sotto qualunque veste. «Il corpo di spedizione americano non è fatto per gli imboscati.» Dick lasciò perdere e andò all’ufficio della Croce Rossa per il
viaggio di ritorno; gli diedero un foglio di via per il Touraine, che salpava da Bordeaux di lì a due settimane. Le due ultime settimane di soggiorno parigino le passò prestando opera volontaria di portaferiti all’ospedale americano sito nell’avenue du Bois-de-Boulogne. Era giugno. Col bel tempo i bombardamenti della Bertha raddoppiavano d’intensità, c’erano incursioni aeree ogni notte, e quando il vento era favorevole si sentivano le cannonate del fronte. Correva voce che il governo francese stesse per trasferirsi a Bordeaux da un giorno all’altro. Era in corso l’offensiva tedesca, le linee erano così vicine a Parigi che le ambulanze scaricavano i feriti direttamente agli ospedali di base. Tutta notte i feriti gravi rimanevano sui larghi marciapiedi sotto gli alberi di fronte all’ospedale, stesi su giacigli di frasche; Dick aiutava a portarli all’accettazione su per le scale di marmo. Una notte lo misero di servizio fuori della sala operatoria, e per dodici ore filate gli toccò portar via secchi di sangue e garza da cui a volte sporgeva un osso frantumato o un pezzo di braccio o una gamba. Quando terminava il servizio, si avviava a casa nel primo mattino parigino profumato di fragole, stanco morto, e rivedeva nella mente volti e occhi, e i capelli intrisi di sudore, e dita rattrappite aggrumate di sangue e sporcizia, e le insistenze puerili, le imploranti richieste di sigarette, e i gemiti gorgoglianti dei colpiti ai polmoni. Un bel giorno vide una bussola tascabile in una vetrina di gioielliere in rue de Rivoli. Entrò e la comperò; gli si formò d’un tratto in testa bello e compiuto il piano di acquistarsi abiti civili, abbandonare sul molo di Bordeaux la divisa e dirigersi alla frontiera spagnola. Con l’aiuto di Dio e tutti i vecchi fogli di viaggio che aveva nella tasca interna era sicuro di poterci riuscire; passare la frontiera e poi, trovandosi ancora in un paese libero dall’incubo della guerra, decidere il da farsi. Preparò perfino una lettera da mandare a sua madre. E intanto, mentre riponeva nel sacchetto del bottino i libri e altre cianfrusaglie e se lo portava poi sulla schiena per i lungofiume sino alla Gare d’Orléans, lo perseguitava A Song in Time of Order di Swinburne: Finché tre uomini stanno assieme,
i regni ne han tre di meno. Caspita, bisognava scrivere un po’ di poesia: ciò che serviva alla gente eran poesie per incitarla alla rivolta contro i suoi governi cannibaleschi. Seduto lì nello scompartimento di seconda classe, era così affaccendato a costruirsi il suo sogno ad occhi aperti, nel quale campeggiava lui dimorante in una città spagnola, tutto occupato a compilar manifesti esortanti i giovani alla rivolta contro i loro macellai, poesie che sarebbero state pubblicate clandestinamente in tutto il mondo, che non vide neppure dileguarglisi alle spalle i sobborghi di Parigi e le verdazzurre campagne estive. Drizziamo al vento la nostra bandiera la vecchia bandiera rossa garrirà ancora quando i ranghi sparuti si assottiglieranno ancora quando i venti nomi si saran ridotti a dieci Persino il ritmo monotono del treno francese pareva inneggiare, quasiché le parole fossero mormorate all’unisono e a bassa voce da una folla in marcia: Finché tre uomini stanno assieme i regni ne han tre di meno. A mezzogiorno Dick aveva appetito e andò nella vettura ristorante a consumare un ultimo pranzo di lusso. Si mise a sedere a un tavolo di fronte a un giovane dall’espressione bonaria, che indossava una divisa da ufficiale francese. «Santo Dio, sei proprio tu, Ned?» Blake Wigglesworth arrovesciò la testa in quel suo modo buffo e rise gridando: «Garçon! Un verre pour le monsieur». «Ma quanto tempo hai fatto nella squadriglia Lafayette?» balbettò Dick. «Non tanto… non mi hanno voluto.» «E la marina?» «Mi han buttato fuori anche di lì, quegli imbecilli fottuti credono che abbia la tisi… garçon, une bouteille de champagne… E tu dove stai andando?» «Te lo spiegherò poi.» «Be’, io rimpatrio col Touraine.» Ned arrovesciò il capo in un’altra risata e le sue labbra formarono le sillabe blahblahblahblah. Dick notò
che, sebbene fosse molto pallido e smunto, la pelle sotto gli occhi e verso le tempie era arrossata, e gli occhi erano un po’ troppo lustri. «Ebbene, anch’io» finì per dire, con un senso di sdoppiamento. «Son capitato in un mare di guai» disse Ned. «Anch’io» disse Dick. «E come!» Alzarono il bicchiere e si guardarono negli occhi ridendo. Rimasero seduti nella vettura ristorante tutto il pomeriggio a parlare e bere, e arrivarono a Bordeaux ubriachi fradici. Ned aveva speso tutto il suo denaro a Parigi, e a Dick ne rimaneva ben poco, tanto che dovettero vendere brande e coperte a un paio di tenenti americani appena sbarcati, conosciuti al Café de Bordeaux. Parevano quasi risorgere i bei tempi di Boston, quando giravano da un bar all’altro e cercavano posti dove dessero da bere anche dopo l’ora di chiusura dei pubblici esercizi. Passarono quasi tutta la nottata in una elegante Maison Publique tutta tappezzata in raso carnicino, chiacchierando con la maîtresse, una donna segaligna dal labbro superiore lungo come quello di un lama, vestita di un abito da sera ricamato a pagliuzze nere; costei li prese in simpatia e li trattenne a mangiar zuppa di cipolle con lei. Erano così occupati a chiacchierare che si dimenticarono delle ragazze. Lei era stata nel Transvaal durante la guerra boera, e parlava un curioso inglese sudafricano. «Vous comprenez, avevamo una clientela finissima, tutti quanti ufficiali, molta eleganza, decoro. Quei tipi del Veldt… fuori di qui, maledizione! d’inferno… molta distinzione, sapete. Avevamo due sale, una per gli ufficiali inglesi, una per gli ufficiali boeri, molto distinti, non ci fu una rissa in tutta la guerra, non uno scontro… Vos compatriotes les Américains ce n’est pas comme ça mes amis. Beaucoup figli di cagna, bevono come spugne, fanno sempre parapiglia, scocciano l’anima, malattie, naturellement, il y a aussi des gentils garçons comme vous, mes mignons, des véritables gentlemen» e li vezzeggiava sulle guance con quelle sue mani callose e inanellate. Quando se ne andarono volle baciarli e li accompagnò alla porta dicendo: «Bonsoir mes jolis petits gentlemen». Per tutta quella traversata non erano mai in sé a partire dalle undici del mattino; il tempo era calmo e nebbioso; si sentivano
d’incanto. Una notte che stava solo a poppa vicino al cannoncino, Dick era intento a frugarsi le tasche in cerca di una sigaretta, quando avvertì qualcosa di duro nella fodera del cappotto. Era la piccola bussola che si era comperato per meglio passare il confine spagnolo. Con un senso di colpa la cavò di lì e la gettò in mare. 1. Grenadine: riferito al color granata, molto simile a quello del vino. (NdT) 2. In francese nel testo; vale “angolo di bosco”. (NdT) 3. Qui e altrove Dos Passos, riferendosi agli italiani, mette in bocca ai suoi personaggi il termine gergale lievemente spregiativo di wop, che in italiano non si può rendere neppure col termine “terrone”. (NdT) 4. Non si sorprenda qui il lettore di trovare così palesemente falsata la storia. Si sa che l’arresto dell’offensiva austro-tedesca al Piave è merito esclusivo del soldato italiano, a fianco del quale, nei momenti più drammatici della lotta, non comparve nemmeno uno degli sparuti reparti alleati giunti in Italia e trattenuti “a guardare come si mettevano le cose” nelle lontane retrovie. Una partecipazione alleata di modesto rilievo alla lotta si ebbe solo più tardi. Ma l’autore non intende tanto esporre convinzioni sue quanto piuttosto documentare attraverso i personaggi uno stato d’animo allora corrente. (NdT) 5. Celebre lirica di Goethe. (NdT) 6. In italiano nel testo; e così tutte le espressioni seguenti poste in corsivo. (NdT) Il corsivo è usato alla prima occorrenza del termine o dell’espressione. 7. In questo episodio l’autore si è fatto prendere la mano dal gusto o dall’intenzione del colore, dell’effetto, come è nel suo temperamento di realista. (NdT)
Cine-giornale XXVII INTENTA CAUSA AL MARITO E LO SMASCHERA: L’EROE FERITO ERA UNA MONTATURA Fra gli orrori della guerra spicca fulgida la croce rossa la rosa della terra di nessuno stando alle migliaia di persone che si erano radunate per vedere il varo ed assistettero al disastro, l’impalcatura semplicemente si rovesciò come una gigantesca tartaruga facendo precipitare gli occupanti in venticinque piedi d’acqua. Ciò accadde esattamente quattro minuti prima dell’ora fissata per il varo Oh questa battaglia di Parigi sta facendo di me un bel lazzarone GLI INGLESI INIZIANO LE OPERAZIONI ALLA FRONTIERA AFGANA quel ruolo di predominio che gli Stati Uniti secondo tutte le aspettative dovranno assumere nel commercio mondiale dipenderà moltissimo dall’intelligenza e dal successo con cui saranno utilizzati e sviluppati i loro porti Voglio andare a casa voglio andare a casa le palle fischiano i cannoni tuonano non voglio più andare in trincea oh mandatemi oltremare dove l’Allemand non mi può prendere voi avete bandito una crociata contro i giocattoli ma quand’anche si potessero concentrare e distruggere tutti i giocattoli tedeschi non si porrebbe fine con ciò a tutte le importazioni tedesche RAPINA VENTI AVVENTORI IN UN CAFFÈ LE ADUNANZE ANTILEGALITARIE NON DEVONO ESSERE CONSENTITE IN UN MOMENTO CRITICO GRAVIDO DI MINACCE SOVVERSIVE Dio mio son troppo giovane per morire voglio andare a casa Nancy si gode la vita notturna a marcio dispetto delle incursioni
LA POLIZIA CERCA UNA DONNA TATUATA COINVOLTA NEL DELITTO DEL BAULE UNA FIGLIA DEL REGGIMENTO SFREGIATA DA UN AMMIRATORE Un Giovane Accusato di Aver Fornito Denaro per Aiutare a Far Promuovere un Ufficiale della Riserva. A quanto sembra questi individui erano mercanti cinesi di Irkutsk, Chita e altrove che si stavano dirigendo a Harbin loro sede coi loro guadagni pronti per l’investimento in nuovi titoli azionari Oh questa battaglia di Parigi sta facendo di me un bel lazzarone toujours la femme et combien 300.000 NOBILI RUSSI UCCISI DAI BOLSCEVICHI I Banchieri del Nostro Paese, dell’Inghilterra e della Francia Salvaguarderanno gli Investitori Stranieri queste tre ragazze son venute in Francia tredici mesi fa e costituiscono la prima compagnia canzonettistica che abbia dato spettacoli al fronte. Si sono prodotte per i soldati americani utilizzando come palcoscenico un vagone scoperto che serviva di piattaforma a un grosso calibro di marina, a tre chilometri dalle linee, il giorno stesso in cui si ebbe alla sera l’avanzata di Château-Thierry. Dopodiché sono state assegnate alla zona di riposo di Aix-les-Bains, dove di giorno facevano le commesse allo spaccio e di sera si esibivano in numeri di rivista e ballavano Ma che scarsità di uomini in questo posto beaucoup rum beaucoup divertimenti Mammà non riconoscerebbe il suo figliolo oh se volete rivedere la statua della Libertà state alla larga da questa battaglia di Parigi
Occhio fotografico (35) c’erano sempre due gatti color latte caldo con un po’ di caffè, occhi blu e musi nerofumo, sulla finestra della lavanderia dirimpetto alla piccola cremeria dove facevamo la prima colazione in Montagne Sainte-Geneviève soffocata tra le vecchie case anguste grigioardesia del Quartiere latino che guardano su viuzze ripide rese graziose dalla nebbia stradine minute accese di gessi variopinti costellate di infinitesimali bar ristoranti negozi di vernici e stampe antiche letti bidets profumeria stantia microscopico sfriggolio di burro al fuoco la Bertha faceva un rumore secco non più forte di un petardo presso l’albergo dove morì Oscar Wilde noi corremmo tutti di sopra per vedere se la casa era in fiamme ma la vecchia a cui stava bruciando il lardo ce l’aveva con mezzo mondo tutti i grandi quartieri nuovi vicino all’Arc de Triomphe erano deserti ma nella gualcita e ingiallita Parigi della Carmagnole del faubourg Saint-Antoine della Commune noi cantavamo ‘suis dans l’axe ‘suis dans l’axe ‘suis dans l’axe du gros canon quando la Bertha prendeva la Seine c’era un concours de pêche nei bragozzi verdechiaro fra i vecchi pescatori per far retate dei pesci che lo scoppio in acqua aveva tramortiti
Eveline Hutchins Eveline andò ad abitare con Eleanor in un bell’appartamento che Eleanor era riuscita in qualche modo ad accaparrarsi sul quai de la Tournelle. Era l’abbaino di una grigia casa dalla facciata scrostata, costruita ai tempi di Richelieu e rifatta sotto Luigi XV. Eveline non si stancava mai di guardare dalla finestra, attraverso i delicati arabeschi del balcone in ferro battuto, la Senna dove vaporetti piccoli come giocattoli risalivano la corrente rimorchiando barconi dalla vernice lucente che avevano tendine di pizzo e gerani alle finestre delle cabine dipinte di rosso e verde, e l’isola antistante dove le paraboliche curve dei contrafforti volanti mostravano l’abside di Notre-Dame vertiginosa sugli alberi di un piccolo parco. Quasi ogni sera prendevano il tè presso la finestra a un tavolino intarsiato, quando rientravano dall’ufficio di rue de Rivoli dopo aver passato la giornata a incollare in albi da mandare in patria ad uso delle campagne pro Croce Rossa fotografie di fattorie francesi distrutte, orfani in tenera età e neonati morenti di fame. Dopo il tè lei andava in cucina a vedere Yvonne che cucinava. Con le derrate e lo zucchero che ricevevano dal commissario della Croce Rossa, Yvonne combinava un sistema di scambi in natura, tanto da eliminare praticamente il costo del vitto per le due amiche. A tutta prima Eveline cercò di dissuaderla, ma lei rispondeva con un torrente di obiezioni: credeva forse Mademoiselle che il presidente Poincaré o i generali o i ministri del gabinetto, quei porci di profittatori, non si riempissero le tasche? Era il sistema D, ils s’en fichent des particuliers, des pauvres gens… benissimo, le sue padroncine avrebbero mangiato lautamente né più né meno di quei vecchi cammelli di generali, e se avessero dato retta a lei i generali li avrebbero messi tutti in fila davanti a un plotone d’esecuzione, idem quegli imboscati di ministri e i ronds-de-cuir. Eleanor diceva che le sofferenze avevano dato un po’ alla testa alla vecchia, ma Jerry Burnham diceva che era invece il resto del mondo a trovarsi in quelle condizioni. Jerry Burnham era l’omino rosso in viso che col proprio aiuto prezioso aveva salvato Eveline dal colonnello la prima notte dopo
l’arrivo a Parigi. In seguito ebbero spesso occasione di riderci su. Lui lavorava con la «United Press» e si faceva vedere nel suo ufficio a intervalli di pochi giorni quando doveva occuparsi delle attività della Croce Rossa. Conosceva tutti i ristoranti di Parigi e portava Eveline a pranzare con lui alla Tour d’Argent o a far colazione alla Taverne Nicolas Flamel, e passeggiavano insieme al pomeriggio per le vecchie strade del Marais, per poi andare tardi al lavoro, di concerto. La sera quando si mettevano a un buon tavolino appartato in un caffè dove non c’era pericolo che qualcuno origliasse (tutti i camerieri erano spie, diceva lui), lui beveva una quantità di cognac al selz e sfogava i suoi sentimenti: il suo lavoro lo disgustava, e da corrispondenti non c’era più verso di veder nulla, e lui aveva continuamente fra capo e collo tre o quattro censure diverse, e gli toccava spedire roba addomesticata che era una menzogna sola dalla prima all’ultima parola, e quando uno faceva questo mestiere da un anno all’altro finiva col perdere il rispetto di sé; e se prima della guerra un giornalista era poco più di un farabutto, adesso non c’erano più termini per definirlo. Eveline cercava di fargli coraggio dicendogli che a guerra finita avrebbe dovuto scrivere un libro come Il fuoco 1 per dire la cruda verità. «Ma la guerra non finirà più… troppo lucrosa, mi capisci? Da noi stanno facendo soldi, gli inglesi stanno facendo soldi; anche i francesi, guarda un po’ Bordeaux e Tolosa e Marsiglia, fanno soldi, e i dannati politicanti, loro, han tutti quanti fior di conti in banca ad Amsterdam o Barcellona, quei figli di puttana.» Nel tardo autunno, una sera, Eveline tornò a casa arrancando nel fango e nella nebbia del crepuscolo e trovò al tè un soldato francese invitato da Eleanor. La cosa le riuscì gradita, a lei che si lagnava sempre di non poter mai fare la conoscenza di francesi tranne gli incaricati di mansioni assistenziali e le donne della Croce Rossa, tutta gente noiosa anzichenò; ma le ci volle qualche tempo per accorgersi che si trattava di Maurice Millet. Le venne fatto di chiedersi come aveva potuto innamorarsi di lui da bambina: aveva l’aria così anziana e pastosa, da uomo di mezza età, anzi aveva anche un po’ della zitella, nella sua divisa azzurra sparsa di macchie. C’eran pesanti borse violette sotto quei suoi grandi occhi frangiati di lunghe ciglia
femminee. Per Eleanor evidentemente era ancora un uomo meraviglioso, a giudicare dal rapimento con cui ella si beveva le sue frasi sull’élan suprême du sacrifice e l’harmonie mystérieuse de la mort. Faceva il portaferiti in un ospedale di base a Nancy, era diventato religiosissimo e si era quasi dimenticato l’inglese. Quando gli domandarono notizie della sua pittura, fece spallucce e non volle rispondere. A cena mangiò pochissimo e bevve solo acqua. Si fermò sino a tarda sera a parlare di miracolose conversioni di infedeli, estreme unzioni impartite sulla linea del fuoco, una visione del Cristo adolescente aggirantesi tra i feriti, che egli aveva avuto in un posto di medicazione durante un attacco coi gas. Après la guerre intendeva ritirarsi in un monastero, forse trappista. Quando se ne fu andato Eleanor disse che quella era stata la serata più ispiratrice della sua vita; Eveline non le obiettò nulla. Maurice tornò un altro pomeriggio prima della fine della sua licenza assieme a un giovane scrittore che lavorava al quai d’Orsay, un francese alto dalle guance rosee che pareva un distinto scolaro inglese, e si chiamava Raoul Lemonnier. A quanto sembrava, preferiva parlare inglese anziché francese. Aveva fatto due anni di fronte coi Chasseurs Alpins, ed era poi stato riformato per via dei polmoni o per via di suo zio ministro, non sapeva nemmeno lui. Era una vita scocciante, stando a quel che diceva. Ma il tennis lo trovava divertentissimo, e ogni pomeriggio poi andava a Saint-Cloud a remare. Eleanor scoprì che proprio questo le era mancato tutto autunno: una partita a tennis. Lui disse che gli piacevano le inglesi e le americane perché amavano lo sport. Lì invece, in Francia, ognuna credeva che si volesse detto fatto andare a letto con lei: «L’amore è una bella scocciatura» soggiunse. Stette presso la finestra con Eveline parlando di cocktail (adorava le bibite americane) e osservando le ultime falde purpuree del crepuscolo affondare su Notre-Dame e nella Senna, mentre Eleanor e Maurice, seduti al buio nel saloncino, parlavano di san Francesco d’Assisi, dopodiché Eleanor lo invitò a pranzo. Il mattino dopo Eleanor disse che probabilmente si sarebbe convertita al cattolicesimo. Mentre andavano all’ufficio, poi, indusse
Eveline a entrare con lei in Notre-Dame per sentir messa, ed entrambe accesero candele all’immagine di quella che a Eveline parve una Vergine un po’ troppo noiosa, vicino alla porta principale. Ma l’effetto era egualmente suggestivo: il lamento dei preti, le luci, l’odore d’incenso freddo. Sperò vivamente in cuor suo che il povero Maurice non morisse al fronte. Quella sera Eveline invitò a pranzo Jerry Burnham, Miss Felton reduce da Amiens e il maggiore Appleton, che era a Parigi per occuparsi di carri armati. Fu un bel pranzo, anatra arrosto con arance, sebbene Jerry, risentito dell’attenzione che Eveline riserbava a Lemonnier, dovesse a un certo punto ubriacarsi e indulgere alquanto al turpiloquio e parlare della ritirata di Caporetto, e dire che gli Alleati erano in cattive acque. Il maggiore Appleton ribatté che non bisognava dirlo anche se era vero, e diventò rosso in viso come un peperone. Eleanor s’indignò e disse che un’affermazione simile meritava l’arresto, e quando tutti se ne furono andati ebbe un litigio con Eveline. «Che cosa penserà di noi quel giovane francese? Tu sei una cara ragazza, Eveline mia, ma hai amici proprio volgari. Non capisco dove tu vada a pescarli; per esempio quella Felton si è scolata quattro cocktail, un quarto di Beaujolais e tre cognac, l’ho controllata io stessa.» Allora Eveline sbottò a ridere, e la risata fu contagiosa. Ma Eleanor disse che la loro vita stava prendendo un andazzo troppo bohémien, e non era bene con una guerra simile in piedi e una situazione così brutta in Italia e in Russia, e quei poveri ragazzi in trincea, e via di seguito. Quell’inverno Parigi s’andò poco per volta riempiendo di americani in divisa, automobili militari e derrate del magazzino della Croce Rossa; e il maggiore Moorehouse, vecchio amico di Eleanor, venne direttamente da Washington a dirigere il reparto Pubblicità della Croce Rossa. Ne parlavano tutti anche prima del suo arrivo, perché sin da prima della guerra era uno dei più famosi esperti di pubblicità di New York. L’ufficio andò sossopra quando si riseppe che era già sbarcato a Brest, e ciascuno si chiedeva con preoccupazione dove sarebbe calata la scure. Il mattino in cui arrivò, Eveline notò per prima cosa che Eleanor si
era fatta i ricci. Poi, verso mezzogiorno, tutto il personale del reparto Pubblicità fu chiamato nell’ufficio del maggiore Wood per presentarsi al maggiore Moorehouse. Era un uomo di grossa corporatura, con gli occhi azzurri e i capelli così chiari che parevan quasi bianchi. La divisa gli stava benissimo, e così pure il cinturone, e i gambali gli luccicavano come vetro. Eveline si disse subito che in lui c’era qualcosa di sincero e attraente, come in suo padre, e ciò le fece piacere. E aveva anche l’aspetto giovanile a onta delle guance grasse, e nel parlare tradiva un lieve accento meridionale. Tenne un discorsetto sull’importanza di quanto la Croce Rossa faceva per galvanizzare il morale di civili e combattenti, e sulle due mire che l’attività pubblicitaria avrebbe dovuto prefiggersi: stimolare le elargizioni tra chi era rimasto in patria e tener la gente informata sull’andamento del lavoro. Il guaio era che la gente non sapeva abbastanza dello sforzo che i lavoratori della Croce Rossa stavano facendo, e troppo facilmente dava retta alle critiche dei filotedeschi operanti sotto la maschera del pacifismo, dei maligni e degli imboscati, pronti sempre ad accusar mende e a cavillare e al popolo americano e alle martoriate popolazioni dei paesi alleati bisognava far sapere lo splendido sacrificio che stavano facendo i lavoratori della Croce Rossa, paragonabile nel suo campo al sacrificio dei cari ragazzi in trincea. «In questo momento stesso, amici miei, noi siamo esposti al fuoco, pronti al supremo sacrificio per impedire che la civiltà sia cancellata dalla faccia della terra.» Il maggiore Wood si appoggiò allo schienale della sedia girevole, provocandone un cigolio così acuto da far trasalire tutti; parecchi poi guardarono dalla finestra come se temessero di vedersi piombar lì una granata della grossa Bertha. «Vedete» disse focosamente il maggiore Moorehouse battendo gli occhi «è questo il sentimento che dobbiamo comunicare alla gente… lo stringimento alla gola, lo strappo che fortifica i nervi, la decisione di tirare diritto.» Eveline si sentì prendere dall’emozione, involontariamente. Lanciò una rapida occhiata laterale ad Eleanor, che era tutta fredda e liliale come quando ascoltava Maurice descrivere il Cristo adolescente dell’attacco coi gas. E non si capisce nemmeno che cosa stia pensando,
si disse Eveline. Quel pomeriggio, quando J.W., come Eleanor chiamava il maggiore Moorehouse, venne a prendere una tazza di tè da loro, Eveline si sentì osservatissima, e si sorvegliò attentamente; questione di sfumature, di diplomazia; dentro di sé ne rideva. Lui pareva un po’ sconvolto e non parlava molto, e sussultò in maniera piuttosto evidente quando gli parlarono delle incursioni aeree che si verificavano nelle notti di luna e del presidente Poincaré che girava personalmente ogni mattina a visitare le case colpite e a consolare i superstiti. Non si trattenne a lungo e se ne andò in vettura militare a conferire con qualche alto funzionario. A Eveline parve nervoso e in preda a disagio, come se avesse preferito fermarsi da loro. Eleanor lo accompagnò sul pianerottolo e per un po’ non si fece vedere. Quando tornò nella stanza, il suo volto era improntato alla consueta calma finemente cesellata; Eveline moriva dalla voglia di chiederle se il maggiore Moorehouse era il suo… il suo… ma non trovava le parole adatte. Per un certo tempo Eleanor non proferì verbo; poi scosse la testa e disse: «Povera Gertrude». «E chi è Gertrude?» La voce di Eleanor ebbe una impercettibile nota falsa: «La moglie di J.W. … è in un sanatorio con l’esaurimento nervoso… la tensione di questa terribile guerra, mia cara». Il maggiore Moorehouse andò in Italia a riorganizzarvi il reparto Pubblicità della Croce Rossa americana, e un paio di settimane dopo Eleanor ricevette da Washington l’ordine di passare all’ufficio di Roma. Così Eveline rimase sola nell’appartamento con Yvonne. Fu un inverno freddo e solitario, e il lavoro con tutti quegli incaricati di opere assistenziali era veramente noioso, ma Eveline riuscì a svolgere il suo compito e in pari tempo a divertirsi un po’ la sera con Raoul, il quale veniva a prenderla per portarla in qualche piccola boîte, sempre dicendo che era un posto tedioso. La portava ai Noctambules, dove a volte si poteva ordinar da bere anche dopo l’ora prescritta; oppure in un ristorantino sulla Butte di Montmartre, dove in una fredda notte lunare di gennaio stettero nel portico del SacréCœur a veder passare gli Zeppelin. Parigi si stendeva fredda e morta
come se le fughe di tetti e cupole fossero nella neve, e gli shrapnel lampeggiavano gelidi in alto e i riflettori erano antenne di grandi insetti che tastavano l’oscurità lattiginosa. A intervalli avvampavano le raffiche rosse delle bombe incendiarie. Per un momento scorsero in cielo due esili sigari d’argento. Parevano più alti della luna. Eveline si accorse che il braccio di Raoul, poc’anzi allacciato attorno alla sua vita, era scivolato più su, e ora lui le teneva la mano sul seno. «C’est fou, tu sais… c’est fou, tu sais» le diceva con voce cantilenata, pareva che non ricordasse più una parola d’inglese. Allora si misero a parlare in francese, ed Eveline si disse che lo amava alla follia. Quando la breloque 2 fu passata per le vie, se ne andarono a casa attraversando una Parigi immersa nel buio e nel silenzio. A un angolo di strada li fermò un gendarme per chiedere a Lemonnier i documenti. Li esaminò minuziosamente e con gran fatica alla pallida luce azzurra di un lampione, mentre Eveline se ne stava lì presso senza fiato, col cuore che le saltava in gola. Il gendarme riconsegnò i documenti, salutò profondendosi in scuse e se ne andò. Nessuno dei due disse alcunché al riguardo, ma Raoul evidentemente non metteva neppure in dubbio che sarebbe andato a dormire con lei nel suo appartamento. S’avviarono verso casa a passo lesto per le fredde vie nere, con un secco risonar di tacchi sul selciato. Lei gli si appoggiava al braccio; c’era qualcosa di ebbro, elettrico e inquieto nel modo in cui si toccavano ogni tanto le loro anche nel camminare. La casa di lei era una delle poche prive di portineria. Aprì la porta e rabbrividendo salirono le fredde scale di pietra. Gli raccomandò in un sussurro di far piano, per non svegliare la cameriera. «È molto seccante» bisbigliò lui; e le sfiorò l’orecchio con labbra calde. «Spero che non ti parrà troppo seccante.» Mentre si pettinava davanti alla toeletta, annusando le boccette di profumo con aria da intenditore, agghindandosi allo specchio senza fretta e senza imbarazzo di sorta, egli disse: «Charmante Eveline, ti piacerebbe essere mia moglie? Si potrebbe combinarla benissimo, sai. Mio padre, che è il capofamiglia, ha molta simpatia per gli americani. Naturalmente potrebbe essere una cosa molto noiosa, contratto e via dicendo». «Oh no, non mi passa neanche per l’anticamera del
cervello» sussurrò lei dal letto con un risolino rabbrividito. Raoul le lanciò un’occhiata furente e risentita, le diede una buonanotte molto sostenuta e uscì. Quando gli alberi cominciarono a buttare, lì presso la finestra, e le fioraie nei mercati a vendere narcisi e tromboncini, la sensazione della primavera le rese più squallidi che mai i lunghi mesi di vita parigina. Jerry Burnham era andato in Palestina, Raoul Lemonnier non si era più fatto vivo dopo quella volta, e il maggiore Appleton, quando si trovava in città, veniva sempre da lei ed era pieno di delicate attenzioni, ma era troppo noioso. Eliza Felton era conducente di un’ambulanza dipendente da un ospedale americano sito nell’avenue du Bois-de-Boulogne, e si faceva vedere la domenica quando non era di servizio, ma affliggeva la povera Eveline a furia di lagnarsi di questo: che Eveline non era una libera anima pagana quale aveva dapprima creduto. Diceva che nessuno le voleva bene, e si augurava un bel colpo di Bertha tutto per lei, così sarebbe finita ogni cosa e buonanotte sonatori. La faccenda divenne talmente insopportabile che Eveline non si sentì più di stare in casa la domenica, e spesso anzi passava il pomeriggio in ufficio a leggersi Anatole France. E poi gli estri di Yvonne erano urtanti; coi suoi commenti a fior di labbra essa tentava di regolare la vita di Eveline. Quando venne in licenza Don Stevens, con l’aria più stravolta che mai nella grigia uniforme del reparto quacchero, fu una cosa provvidenziale, ed Eveline si disse in cuor suo che forse ne era stata davvero innamorata, dopo tutto. A Yvonne lo presentò come suo cugino dicendole inoltre che erano cresciuti assieme come fratello e sorella, e lo sistemò nella camera di Eleanor. Don era eccitatissimo per via del successo bolscevico in Russia, mangiava a quattro palmenti, si beveva tutto il vino che c’era in casa, faceva frequenti allusioni misteriose a certe forze clandestine con le quali era in contatto. Secondo lui gli eserciti erano tutti in stato di ammutinamento potenziale, e ciò che era successo a Caporetto sarebbe successo su tutti i fronti, anche i soldati tedeschi erano maturi per la rivolta, e quello sarebbe stato l’inizio della rivoluzione mondiale. Le parlò degli ammutinamenti di Verdun, dei lunghi treni
di soldati che aveva visti partire per un attacco al grido di «À bas la guerre» e prendendo a fucilate i gendarmi al loro passaggio. «Eveline, siamo prossimi a eventi colossali… Le classi lavoratrici del mondo non si vogliono più prestare a questo gioco assurdo… accidenti, ne sarà quasi valsa la pena, di fare la guerra, se ne ricaveremo come risultato una nuova civiltà socialista.» Così dicendo si sporse dall’altra parte del tavolo e la baciò sotto il naso di Yvonne, che entrava in quel momento con frittelle al cognac bollente. Agitò l’indice in direzione di Yvonne e le strappò quasi un sorriso per la maniera in cui disse: «Après la guerre finie». Quella primavera e quell’estate la situazione si mostrò effettivamente precaria, quasiché Don avesse ragione. Di notte si udiva la gigantesca mareggiata dei cannoni che facevano sbarramento ininterrotto sul fronte vacillante. L’ufficio era pieno di strane informazioni: la 5 a Armata britannica aveva voltato le terga al nemico e si era data alla fuga, i canadesi si erano ammutinati e impossessati di Amiens, le spie sabotavano tutti gli aerei americani, in Italia gli austriaci stavano sfondando daccapo. Per ben tre volte l’ufficio della Croce Rossa ricevette l’ordine di mettere i documenti nei bauli e tenersi pronto a sgomberare da Parigi. Con questo po’ po’ di novità in ballo, era ben arduo per il reparto Pubblicità mantenere nelle sue edizioni il tono baldanzoso richiesto, ma Parigi continuò a formicolare in maniera rassicurante di facce americane, polizia militare americana, cinturoni da ufficiali e scatolame, e in luglio il maggiore Moorehouse, arrivato di fresco dagli Stati Uniti, venne in ufficio con un resoconto di prima mano sulla battaglia di Château-Thierry e annunciò che la guerra sarebbe finita entro un anno. Quella sera stessa invitò a pranzo Eveline al Café de la Paix, e per andarci lei dovette disdire un appuntamento precedente con Jerry Burnham che era tornato da poco dal Vicino Oriente e dai Balcani e rigurgitava di racconti sul colera e sugli orrori visti. J.W. ordinò un magnifico pranzo, e riferì che Eleanor lo aveva pregato di accertarsi se per caso Eveline non avesse bisogno di essere rianimata un po’. Parlò della gigantesca era di espansione che si sarebbe inaugurata per l’America dopo la guerra, l’America, la buona samaritana che
medicava le ferite dell’Europa dilaniata dalla guerra. Era come se stesse provando un discorso, e quando ebbe terminato guardò Eveline con un buffo sorriso di deplorazione dicendo: «E il bello è che è proprio vero»; allora Eveline rise e si accorse di avere tanta simpatia per J.W. Lei indossava un abito nuovo acquistato da Paquin con un po’ di denaro che le aveva mandato il padre per il compleanno, ed era un vero sollievo dopo la divisa. Il pranzo terminò prima che tra loro due si fosse stabilita una vera conversazione. Eveline voleva indurlo a parlare un po’ di sé. Uscendo di lì andarono da Maxim, ma il luogo era pieno zeppo di aviatori ubriachi e litigiosi, e la baraonda parve sgomentare J.W. a tal segno che Eveline gli propose di andare da lei a bere un bicchier di vino. Quando giunsero al quai de la Tournelle, nel momento preciso in cui scendevano dall’auto di J.W. essa avvistò Don Stevens che camminava per la strada. Per un istante sperò di non essere vista, ma lui si voltò e li raggiunse di corsa. Era in compagnia di un giovanotto in divisa di soldato semplice, che si chiamava Johnson. Salirono tutti assieme e sedettero un po’ imbronciati nel tinello. A quanto pareva, lei e J.W. non riuscivano a parlar d’altro che di Eleanor, e gli altri due se ne stavano imbarazzati e incupiti nelle loro poltrone, finché a un certo punto J.W. si alzò, scese dabbasso, montò in macchina e partì. «Maledizione, se c’è al mondo qualcosa che non mi va giù sono proprio i maggiori della Croce Rossa» sbottò a dire Don non appena l’uscio si fu richiuso alle spalle di J.W. Eveline s’incollerì. «Be’, un maggiore della Croce Rossa non è poi peggio di un falso quacchero» replicò gelidamente. «Dovete perdonarci l’intrusione, signorina Hutchins» disse Johnson, che aveva un’aria di svedese biondo. «Volevamo portarti in un caffè o in qualche altro posto del genere, ma ora è troppo tardi» riprese Don contrariato. L’altro lo interruppe: «Spero, signorina Hutchins, che ci perdoniate l’intrusione… voglio dire la mia intrusione… Mi sono permesso di pregare Don di portarmi con sé. Mi ha parlato tanto di voi, ed è un anno ormai che non vedo una ragazza americana veramente in gamba».
Aveva un tono deferente e un piagnucoloso accento del Minnesota che a tutta prima riuscirono antipatici a Eveline; ma quando lui si scusò e uscì, essa lo trovava già simpatico, e prese le sue parti quando Don disse: «È un carissimo ragazzo, ma ha qualcosa di sdolcinato». Contrariamente alle aspettative, Don non ottenne il permesso di passare la notte con lei, e se ne andò via accigliatissimo. In ottobre Eleanor tornò con un mucchio di pannelli italiani antichi avuti per un’inezia. Nell’ufficio della Croce Rossa c’erano impiegati in sovrabbondanza, così Eveline, Eleanor e J.W. fecero in auto militare il giro degli spacci della Croce Rossa nella Francia orientale. Fu un viaggio magnifico, il tempo si mantenne straordinariamente bello, quasi come l’ottobre americano, facevano dappertutto colazione e pranzo ai comandi di reggimento, di divisione e di corpo d’armata, e tutti gli ufficiali giovani erano tanto simpatici con loro, e J.W. era di ottimo umore e teneva tutti allegri; videro sparare le batterie campali, assistettero a un duello aereo, osservarono i palloni frenati e sentirono l’urlo di una granata nemica in arrivo. Durante quel viaggio Eveline cominciò a notare nei modi di Eleanor una certa freddezza che le fece male; c’era stata tanta cordialità fra loro nella prima settimana dopo il ritorno di Eleanor. A Parigi trovarono d’un tratto molta animazione, veniva a trovarli tanta gente che conoscevano: George, il fratello di Eveline, che faceva l’interprete al quartier generale del Service of Supply, un certo signor Robbins, amico di J.W., sbronzo in permanenza e così buffo nel modo di parlare, Jerry Burnham, una quantità di giornalisti e il maggiore Appleton, ora colonnello. Si facevano pranzetti e ricevimenti, e la difficoltà principale era quella di assortire gli invitati secondo il grado e saper trovare gente che legasse con l’ambiente. Fortunatamente i loro amici erano tutti ufficiali, o corrispondenti, parificati al grado di ufficiali. Solo una volta venne Don Stevens proprio mentre stava per iniziarsi un pranzo offerto al colonnello Appleton e al brigadier generale Byng, ed Eveline complicò tremendamente la situazione invitandolo a fermarsi, perché il generale considerava i quaccheri come imboscati della risma peggiore, e Don scattò e disse che un pacifista poteva essere miglior patriota di un ufficiale di stato
maggiore insediato a un posto comodo, e in ogni modo il patriottismo era un delitto contro l’umanità. L’incidente sarebbe stato spiacevolissimo se il colonnello Appleton, che aveva bevuto un bel po’ di cocktail, non avesse sfondato la seggiola dorata sulla quale stava, al che il generale scoppiò a ridere prendendo in giro il colonnello con una cattiva freddura sull’“avoir du poise” 3 e distolse l’attenzione di tutti dall’argomento. Ma Eleanor se la prese molto per la faccenda di Don, e dopo la partenza degli ospiti litigò aspramente con Eveline. Il mattino dopo Eleanor non le rivolgeva la parola; ed Eveline andò a cercarsi un altro appartamento. 1. Opera dello scrittore rivoluzionario Henri Barbusse, che parla della guerra mondiale con spregiudicato verismo. (NdT) 2. L’auto che percorreva le vie per dare il segnale di cessato pericolo. (NdT) 3. In francese, anche in senso morale, avoir du poids significa “aver del peso”; in inglese “avoirdupois” è una categoria di misure di peso. Il generale poi pronuncia male, legge la s, da buon anglosassone; ecco perché il testo dà “poise”. (NdT)
Cine-giornale XXVIII Oh le aquile che volano alte nel Mobile, nel Mobile 1 gli americani passano a nuoto un ampio fiume e scalano le ripide sponde di un canale nella brillante conquista di Dun. E notevole il fatto che la Compagnie Générale Transatlantique, meglio conosciuta col nome di French Line, non ha perduto un solo bastimento nel regolare servizio passeggeri svolto per tutta la durata della guerra LA BANDIERA ROSSA SVENTOLA SUL BALTICO «Ho attraversato l’Egitto per raggiungere Allenby;» disse «ho impiegato con l’aeroplano due ore per compiere quel viaggio che ai figli d’Israele costò quarant’anni di cammino; è cosa tale da far pensare molto ai progressi della scienza moderna.» Le vacche, beate loro, non volano nel Mobile, nel Mobile PERSHING COSTRINGE IL NEMICO AD ARRETRARE Canta per i feriti di guerra; non è stata fucilata come spia Je donnerais Versailles Paris et Saint-Denis Les tours de Notre-Dame Les clochers de mon pays AIUTATE LE AUTORITÀ ANNONARIE DENUNCIANDO I PROFITTATORI DI GUERRA La completezza dell’accordo raggiunto su quasi tutti gli argomenti della conferenza fu causa di soddisfazione e anche di una certa sorpresa fra i partecipanti. I ROSSI COSTRINGONO ALLA FUGA NAVI MERCANTILI GLI UNNI IN FUGA il completo accordo raggiunto dai delegati su quasi tutti i punti ha cagionato soddisfazione e persino sorpresa negli intervenuti Auprès de ma blonde qu’il fait bon fait bon fait bon auprès de ma blonde qu’il fait bon dormir
CHEZ LES SOCIALISTES LES AVEUGLES SONT ROIS Il governo tedesco chiede al presidente degli Stati Uniti d’America di fare passi per il ristabilimento della pace, di notificare la sua richiesta a tutti i belligeranti e di invitarli a designare plenipotenziari allo scopo di intraprendere negoziati. Come base di discussione per le trattative di pace il governo tedesco accetta il programma tracciato dal presidente degli Stati Uniti nel messaggio rivolto al Congresso il giorno 8 gennaio 1918 e nelle sue successive dichiarazioni, particolarmente nell’allocuzione del 27 settembre 1918. Per evitare ulteriore spargimento di sangue il governo tedesco chiede al presidente degli Stati Uniti di provvedere all’immediata stipulazione di un armistizio generale per terra per mare e per aria. 1. Nome geografico americano: o una città portuale dell’Alabama o una baia nel golfo del Messico. (NdT)
Joe Williams Da un po’ di tempo Joe bighellonava per New York e Brooklyn, facendosi prestare denaro dalla signora Olsen e sborniandosi a rotta di collo. Un bel giorno lei andò a lavorare e lo mise alla porta. Faceva un freddo cane, e per un paio di notti egli dovette ricorrere all’ospitalità di un’organizzazione di propaganda religiosa. Aveva una paura matta di essere arrestato per via della coscrizione, e ne aveva fin sopra i capelli di tutto quanto; finì con rimbarcarsi come marinaio sull’Appalachian, una grossa nave da carico nuova diretta a Bordeaux e Genova. In un modo o nell’altro si acconciò a sentirsi trattare ancora come un galeotto e a lavare i ponti e scrostar vernici. Nel castello di prua erano per lo più campagnoli che non avevano mai visto il mare e alcuni vecchi lazzaroni buoni a nulla. A quattro giorni dalla partenza incocciarono un mare d’inferno e imbarcarono un’ondata gigante che spazzò via due scialuppe di tribordo; il convoglio si sparpagliò, e risultò che la coperta non era stata debitamente calafatata, e l’acqua continuava a scendere nel castello di prua. Così Joe si addimostrò l’unico uomo a cui il secondo potesse tranquillamente affidare il timone, dimodoché smisero di fargli grattar via la vernice, e nei suoi turni di quattr’ore egli ebbe tutto il tempo possibile per riflettere sull’estrema disgustosità di tutto. A Bordeaux avrebbe voluto andar a trovare Marceline, ma nessun membro dell’equipaggio poté scendere a terra. Ci scese il nostromo, il quale alzò abbondantemente il gomito in compagnia di due fanti americani e tornò con una bottiglia di cognac per Joe, che gli era entrato in simpatia, e con un sacco di chiacchiere in linguaggio da latrina sulle botte che stavano prendendo i frogs, i limeys e i wops, 1 se non fosse stato per noialtri americani il Kaiser poteva entrare a cavallo in Parigi quando voleva, e così come stavano le cose si poteva ringraziare il Cielo… Faceva un freddo cane, Joe e il nostromo andarono a bere il cognac in cucina assieme al cuoco, un veterano che aveva conosciuto la febbre dell’oro del Klondike. La nave era tutta per loro, perché gli ufficiali erano scesi a riva per dare un’occhiatina alle mademoiselles, e gli altri dormivano tutti. Il nostromo
disse che era la fine della civiltà, e il cuoco disse che a lui non ne importava un fico, e Joe disse che anche a lui non importava un accidente, e il nostromo disse che erano due porci di bolscevichi e si addormentò come un sasso. Fu un viaggio divertente intorno alla Spagna, attraverso lo stretto e su su lungo la costa francese sino a Genova. Per tutto quel tragitto c’era una fila indiana di navi da carico mimetizzate, greche, britanniche, norvegesi e americane; rasentavano tutte la costa e procedevano coi salvagente ammucchiati sul ponte e le scialuppe pronte ai paranchi. Le incrociava un altro convoglio che tornava scarico, navi trasporto e carboniere provenienti dall’Italia e da Salonicco, bianche navi ospedale, ogni sorta di vecchie carrette sbucate da tutti i mari del mondo, cargo rugginosi talmente sconquassati che li si sentiva sbattere due ore dopo che carena e alberi erano sprofondati all’orizzonte. Una volta entrati nel Mediterraneo furono continuamente coperti da corazzate francesi e inglesi e da stupidi caccia con quei lunghi fumaioli, che ti salutavano e poi ti mandavano a bordo gli ufficiali a controllare i documenti della nave. A riva, neanche l’ombra della guerra. Dopo Gibilterra il tempo schiarì. La costa spagnola verdeggiava, con montagne rosa e gialle nel retroterra, sparsa di casette bianche come zollette di zucchero che qua e là s’aggruppavano in città vere e proprie. Traversando il golfo di Lione sotto una pioggia fina, con nebbia crescente e una maretta fastidiosissima, furono a un pelo dallo speronare una grossa feluca carica di barili di vino. Poi costeggiarono rollando la riviera francese sotto un ululante vento di nord-ovest: città dai tetti rossi chiare e luminose, addossate ad aride colline rocciose sullo sfondo di montagne cariche di neve nitidamente delineate. Dopo Monte Carlo fu una specie di fiera; le case erano tutte rosa, azzurre e gialle, e c’erano alti pioppi e alti campanili a punta in ogni vallata. Quella notte stavano di vedetta in attesa di avvistare il grande faro di Genova, allorché videro a prua una gran vampa rossa. Corse voce che gli austriaci avessero preso la città e la stessero bruciando. Il secondo ufficiale disse chiaro e tondo al capitano, lì sulla tolda, che andare avanti ancora significava farsi catturare e che il partito
migliore era virare di bordo e puntare su Marsiglia, ma il capitano gli rispose che non erano affari suoi, e tenesse il becco chiuso quando non gli si chiedeva la sua opinione. A misura che si avvicinavano, la vampa si faceva più intensa. Si vide poi che era una nave cisterna in fiamme fuori dalla catena dei frangiflutti. Era una grossa nave della Standard Oil, un po’ piegata sul fianco, che sprizzava fuoco spandendolo attorno sull’acqua. Si potevan vedere il frangiflutti, i fari e, dietro, la città agglomerata su per le colline con le finestre accese di riverberi rossi, e le navi affollate nel porto tutte illuminate dalla luce rossastra. Gettata l’ancora, il nostromo prese con sé in barca Joe e un paio dei più giovani, per andare a vedere se c’era qualcosa da fare sulla petroliera. Per quanto poterono vedere, a bordo del vascello non c’era nessuno. La poppa sporgeva dall’acqua. Si accostarono alcuni wops in motoscafo e blaterarono qualcosa, ma loro fecero finta di non capire. C’era lì anche una barca antincendio, ma non si poteva fare nulla. «E perché diavolo non la affondano?» continuava a dire il nostromo. Joe avvistò una scala di corda che pendeva in acqua e ci legò la barca. Prima ancora che gli altri avessero cominciato a gridargli appresso, lui era già a metà della scala. Quando saltò sul ponte scavalcando il parapetto, gli venne fatto di chiedersi che mai era venuto a fare. Maledizione, potesse saltare in aria sui due piedi! si disse a voce alta. Lassù era tutto illuminato a giorno. La parte anteriore della nave e il tratto di mare circostante bruciavano come un fornello. Arguì che la nave doveva avere incocciato una mina o un siluro. Evidentemente l’equipaggio se l’era svignata in fretta e furia, perché c’erano capi di vestiario d’ogni sorta e un paio di bottini ai paranchi di poppa dove prima stavano le scialuppe. Joe si scelse un bel maglione nuovo, e poi scese nel sottoponte. Sopra un tavolo trovò una scatola di sigari Avana. Ne tolse un sigaro e se lo accese. Gli dava un senso di benessere, stare lassù e accendersi un sigaro, con le maledette cisterne pronte a saltare in aria scaraventandolo in Scozia da un momento all’altro. Ed era anche un buon sigaro. In un pacco di carta vergata sopra il tavolo c’erano sette paia di calze femminili di seta. Che bello portarle a casa a Del, fu il suo primo pensiero. Ma poi
si rammentò che quella storia era finita. In ogni modo si ficcò le calze di seta nelle tasche dei pantaloni, e tornò sul ponte. Dalla barca il nostromo gli stava gridando di scendere, per l’amor di Dio, se non voleva esser piantato in asso. Ebbe giusto il tempo di raccogliere una borsa sulla scaletta d’un boccaporto. «Non è benzina, è petrolio greggio. Potrebbe continuare a bruciare per un’intera settimana» gridò a quelli della barca mentre scendeva lentamente per la scala di corda fumandosi intanto il suo sigaro e guardando il porto stipato di antenne, fumaioli e gru, i grandi palazzi marmorei, le vecchie torri e i portici e le colline retrostanti tutte arrossate dal riverbero. «E dove diavolo è l’equipaggio?» «Probabilmente a quest’ora sarà in terraferma, sbronzo fino ai capelli, e ci vorrei essere anch’io» disse il nostromo. Joe distribuì i sigari ma si tenne le calze di seta. Nella borsa non c’era niente. «Roba dell’altro mondo,» brontolò il nostromo «ma non hanno mezzi chimici?» «Questi accidenti di wops non saprebbero che farsene, anche se li avessero» disse uno dei marinai giovani. Ritornarono all’Appalachian e riferirono al capitano che la petroliera era stata abbandonata e che spettava alle autorità portuali sbarazzarsene. L’indomani per tutta la giornata la nave bruciò all’esterno dei frangiflutti. Verso sera un’altra delle sue cisterne saltò in aria come un fuoco d’artificio, e il fuoco si andò espandendo sempre più sull’acqua. L’Appalachian salpò le ancore e attraccò al molo. Quella sera Joe e il nostromo andarono a fare un giretto per la città. Le vie erano strette e avevano gradinate che salivano sino a sbucare in ampie arterie seminate di numerosi caffè con tavolini sotto i colonnati, dove i pavimenti erano tutti di marmo levigato a disegni geometrici. Faceva piuttosto freddo, ed essi entrarono in un bar e presero bevande calde color rosa al rum. Qui incontrarono un italiano di nome Charley che aveva abitato a Brooklyn dodici anni, e costui li portò in un locale dove mangiarono una quantità di spaghetti e vitello arrosto e bevvero vino bianco. Charley disse che nell’esercito “aitaliano” ti trattavano come un cane, e la paga era di cinque centesimi al giorno, e non si prendeva
nemmeno quella, e Charley era tutto per il presidente “Vilson” e i Quattordici punti, e presto avrebbero fatto la pace senza vittoria, e bigga 2 revoluzione in Italia, e bigga guerra contro i francesi e gli inglesi che trattavano gli “aitaliani” come pezze da piedi. Charley condusse lì due ragazze che presentò come sue cugine, Nedda e Dora, e una di esse si mise a sedere sulle ginocchia di Joe, e caspita come li mangiava di gusto, gli spaghetti, e bevvero tutti vino. La cena costò loro tutti i soldi che Joe aveva in tasca. Mentre poi si stava portando Nedda in camera su per una scala esterna in cortile, scorse la vampa della petroliera, che bruciava fuori del porto, riverberata sui muri bianchi e sulle tegole dei tetti. Nedda non voleva svestirsi se Joe prima non le faceva vedere il denaro. Joe denaro non ne aveva, e così tirò fuori le calze di seta. Lei si mostrò infastidita e scosse il capo, ma era tanto carina e aveva gli occhioni neri, e Joe moriva dalla voglia di averla e gridò a Charley di venire, e Charley salì la scala e parlò alla ragazza in italiano, e disse che sì le calze di seta le avrebbe prese senz’altro, e l’America non era forse la più grande nazione del mondo?, e tutti aleati e il presidente “Vilson” grand’uomo per l’Italia. 3 Ma la ragazza non ne voleva sapere ugualmente, finché non riuscirono a far venire una vecchia che stava in cucina, la quale salì starnutendo e palpò le calze, e senz’altro dovette dire che erano di pura seta e valevano molto, perché la ragazza mise le braccia al collo di Joe e Charley disse: «Proprio così, amico mio, lei dormirà con te tutta notte, sa fare all’amore divinamente». Ma verso mezzanotte, quando la ragazza si era ormai addormentata, Joe si stancò di rimanere a letto. Sentiva le esalazioni dei gabinetti in cortile, e un pollo continuava a strillare, pareva di averlo proprio sull’orecchio. Si alzò, si vestì e uscì in punta di piedi. Le calze di seta erano appese a una sedia. Le raccolse e se le ficcò un’altra volta in tasca. Le scarpe gli scricchiolavano maledettamente. Il portone era chiuso e sbarrato, e gli ci volle del bello e del buono per aprirlo. Non appena in strada, un cane lì presso cominciò ad abbaiare, e lui se la diede a gambe. Si smarrì in un dedalo di viuzze anguste, ma così a occhio e croce gli pareva che continuando a camminare in discesa
doveva pur giungere al porto, prima o poi. Scorse daccapo su alcuni muri il riverbero rosa della petroliera incendiata e si orientò su quello. In una ripida scalinata s’imbatté in un paio di americani in divisa kaki e domandò indicazioni sulla strada da seguire, ed essi gli fecero fare una sorsata da una bottiglia di cognac e dissero che erano diretti al fronte italiano, e c’era stata una grossa ritirata e tutto era andato per aria, e loro non sapevano nemmeno dove fosse quel bordello d’un fronte, e anzi sarebbero rimasti lì ad aspettare che quel bordello d’un fronte li raggiungesse lui. Joe raccontò la storiella delle calze di seta, e gli altri la trovarono buffissima e gli indicarono la strada per andare al molo dov’era attraccato l’Appalachian, e quando si salutarono si strinsero le mani ripetutamente e dissero che i wops erano porci, e lui disse che erano stati veramente dei principi a indicargli la strada, e loro dissero che era lui un principe, e così diedero fondo al cognac e lui salì a bordo e si buttò a peso morto nella sua cuccetta. Quando l’Appalachian salpò per il viaggio di ritorno, la petroliera ardeva ancora fuori del porto. Durante la traversata, a Joe venne lo scolo e per vari mesi non poté più bere nulla, e mise un pochettino la testa a partito quando arrivò a Brooklyn. Andò alla scuola nautica che si teneva nell’istituto Platt a cura della commissione marittima, e si prese il suo brevetto di secondo ufficiale e per tutto quell’anno viaggiò su e giù tra New York e Saint-Nazaire, a bordo di un vascello nuovo, di legno, costruito a Seattle, l’Owanda, che diede al suo equipaggio gran filo da torcere. Tenne un’attiva corrispondenza con Janey. Lei era oltremare con la Croce Rossa, ed era estremamente patriottica. Joe cominciò a pensare che forse aveva ragione. In ogni modo, a quel che dicevano i giornali, gli austriaci le stavano prendendo sode, e un giovane aveva davanti a sé un avvenire purché non si cacciasse nei guai facendosi scambiare per un filotedesco o un bolscevico e simili. Dopo tutto, come scriveva Janey, la civiltà bisognava pur salvarla, e toccava a noi. Joe depositò in banca i suoi risparmi e acquistò un’obbligazione Liberty. La sera dell’armistizio Joe si trovava a Saint-Nazaire. La città delirava. Tutti quanti a riva, i soldati americani usciti dai loro accampamenti, i soldati francesi tutti fuori dalle caserme, ognuno
dava manate sulla schiena all’altro, si trincava, ci si offriva da bere a vicenda, si sturavano bottiglie di champagne, si baciavano tutte le ragazze graziose, ci si lasciava baciare dalle vecchie, e si prendevano baci sulle due guance da veterani francesi con fior di basettoni. Gli ufficiali, il capitano, il primo nostromo e un paio di ufficiali di marina mai visti prima iniziarono una gran mangiata in un caffè, ma non arrivarono al secondo piatto perché in cucina tutti ballavano, e al cuoco davano continuamente da bere, sino al punto da fargli perdere la trebisonda, e così tutti rimasero lì seduti a cantare e a bere champagne dalle caraffe e ad acclamare le bandierine alleate che le ragazze portavano in giro. Joe cominciò a perlustrare le vicinanze in cerca di Jeanette, una ragazza con la quale se la faceva d’incanto tutte le volte che veniva a Saint-Nazaire. Voleva trovarla prima di aver perso il controllo di sé. Gli aveva promesso di coucher con lui quella notte, prima che si fosse sparsa la notizia dell’armistizio. Affermava di non aver mai couché con nessun altro quando l’Owanda era in porto, e lui la trattava bene e le portava beaucoup regali dall’Amérique, e du sucre e du café. Joe si sentiva benone, aveva in tasca un bel gruzzolo, e perdio, i soldi americani valevano qualcosa in quei giorni; e poi, con le mademoiselles valevano di più le due libbre di zucchero che si era messo nella tasca dell’impermeabile. Entrò in un cabaret tutto felpa rossa e specchiere, dove la musica sonava The Star-Spangled Banner, e tutti gridavano Vive l’Amérique e gli misero bicchieri colmi sotto il naso appena entrò, e poi si trovò a ballare con una ragazza grassa, e l’orchestra eseguiva qualche foxtrot della malora. Piantò in asso la ragazza grassa perché aveva scorto Jeanette. Era drappeggiata in una bandiera americana. Stava ballando con un grosso senegalese nero alto sei piedi. Joe non ci vide più. La staccò di forza dal negro, che era un ufficiale tutto ricamato d’oro, e lei disse: «Cosa c’è chéri», e Joe si scostò e colpì il negro maledetto con tutta la forza in pieno muso, ma il negro non si mosse. La faccia del negro aveva un’espressione nera, perplessa e sorridente come se stesse per fare una domanda. Si accostarono un cameriere e un paio di soldati francesi che tentarono di tirar via Joe. Tutti vociferavano a
perdifiato. Jeanette stava cercando di interporsi fra Joe e il cameriere, e ricevette un pugno alla mascella che la stese a terra. Joe liquidò un paio di frogs e stava arretrando verso la porta quando vide allo specchio che un individuo massiccio in blusa gli stava vibrando in testa un colpo di bottiglia a due mani. Cercò di scansarlo ma non fece in tempo. La bottiglia gli fracassò il cranio e lo fece fuori. 1. Nomignoli volgari con cui gli statunitensi indicavano rispettivamente francesi, inglesi e italiani. (NdT) 2. Deformazione fonetica di big, “grosso, grande”. (NdT) 3. Charley usa un inglese maccheronico frammisto di parole italiane sovente sgrammaticate. (NdT)
Cine-giornale XXIX l’arrivo della notizia provocò l’ingombro delle linee telefoniche cittadine Y fallait pas y fallait pas y fallait pas-a-a-a-y-aller GROSSI CALIBRI IMPIEGATI AD AMBURGO IPNOTIZZATO DA UNA COMUNE LEGULEIA alla dogana la folla cantò The Star-Spangled Banner sotto la direzione di Byron R. Newton, il ricevitore capo del porto MORGAN BATTE I TACCHI SUL DAVANZALE MENTRE FA PIOVERE SULLA FOLLA CHILOMETRI DI NASTRO DA NOTIZIARI TELEGRAFICI DI BORSA MARINAI RIBELLI SFIDANO GLI ALLEATI dalle parti della batteria la sirena del vascello antincendi New York emise un ululato quando giunse la notizia, e in men che non si dica si propagò nel porto un pandemonio Oh dimmi, vedi tu alla prima luce dell’alba? Allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé Non è il modo di fare il solletico a Maria non è il punto giusto «Abbiamo sostenuto una guerra contro il diavolo in persona, e valeva senz’altro la pena di soffrire tutto quello che abbiamo sofferto» ha detto William Howard Taft a una festa per la vittoria tenuta in questa città la notte scorsa Caterì Caterì, la bella Caterina è la mia adorata, la fanciulla del cuore, e quando rifulge la luna Unipress, N.Y. Parigi urgente Brest ammiraglio Wilson che aveva annunciato (16-) (4 pm) a un giornale di Brest l’avvenuta firma dell’armistizio notifica ora sua non confermabilità frattanto Brest delirante DUE VETTURE TRANVIARIE BLOCCATE
NEL SOBBORGO QUEENS DA BANDITI ARMATI Presso la stalla aspetterò alla porta della cucucucina SI CHIEDE UNA GRANDE CORTE SPECIALE PER PROCESSARE I BOLSCEVICHI i soldati e i marinai furono i soli a dare alla celebrazione una nota di colore. A loro sorrideva meravigliosamente l’idea di divertirsi un po’ bevendo a sazietà a dispetto dell’uniforme. Alcuni di questi reduci per poco non scatenarono un parapiglia quando raccolsero una bracciata di pietre e tentarono di mandare in pezzi all’angolo di Broadway con la Quarantaduesima Strada una scritta luminosa del seguente tenore: BENVENUTI IN PATRIA I NOSTRI EROI Oh dimmi, vedi tu alla prima luce dell’alba ciò che sì orgogliosamente acclamammo all’ultimo baglior del crepuscolo quando la vampa rossa dei razzi e le bombe esplose in aria dimostravano ai nostri occhi che la bandiera c’era ancora?
Occhio fotografico (36) quando vuotavamo le gamelle sottovento in mare ogni sera dopo l’ultima ispezione ci fermavamo un momento per aspirare una boccata del vento novembrino la sferza della spruzzaglia dietro le orecchie per dare un’occhiata alla spuma sventagliata dai marosi balzanti divoratori di navi e di uomini (nella loro vasta azzurrità purpurea si cullavano dolcemente le mine galleggianti sotto di loro scivolavano sommergibili con la chiglia orizzontale) un’occhiata al cielo velato di nuvolaglia inquieta per levar le mani una buona volta dagli unti manici dei recipienti pieni di sbobba che non si riusciva a mandar giù (nove pasti nove volte le stesse cose: buttare a mare il rancio avanzato e farsela a improperi col cambusiere londinese che tentava di rubare sulle albicocche in scatola ispezioni aaat-TENTI! click clack Riposo esplorare con la pila ogni angolino delle casseruole nove persone in fila lungo l’ondeggiante corridoio senz’aria soldati col mal di mare spaventati del mare con le proprie stoviglie in mano) Ehi soldato dimmi hanno firmato un armistizio dimmi la guerra è finita stiamo andando a casa sei matto questa è radiofante adesso te lo dico io come stanno le cose stavamo già portando le gamelle vuote giù per tre scale di ferro sino alla stiva ondeggiante e vomitante riportandole su piene ogni volta che la nave rollava un po’ le fiancate si rigavano di sbrodaglia
“Mister Vilson” L’anno in cui Buchanan fu eletto presidente nacque Thomas Woodrow Wilson dalla figlia di un pastore presbiteriano nel presbiterio di Staunton nella valle di Virginia; era il vecchio ceppo scozzese-irlandese; anche il padre era pastore presbiteriano e insegnante di retorica nei seminari teologici; i Wilson vivevano in un universo di parole saldate in firmamento incontrovertibile da due secoli di preti calvinisti, Dio era il Verbo e il Verbo era Dio. Il dottor Wilson era un uomo distinto che amava la casa i figli i buoni libri la moglie e la sintassi corretta e parlava quotidianamente con Dio in occasione delle preghiere familiari; egli allevò i figli fra Bibbia e dizionario. Negli anni della guerra civile negli anni del piffero e del tamburo e del fuoco a plotoni e dei proclami i Wilson vissero ad Augusta, Georgia; Tommy era un bimbo tardivo, non apprese a leggere e a scrivere che a nove anni, ma quando imparò a leggere la sua lettura favorita fu The Life of Washington del rev. Weems. Nel 1870 il dott. Wilson fu chiamato al seminario teologico di Columbia, Carolina del Sud; Tommy frequentò il collegio Davidson dove pervenne a spiegare una buona voce tenorile poi andò a Princeton e diventò un protagonista delle dispute accademiche e direttore del «Princetonian». Il primo articolo da lui pubblicato sul «Nassau Literary Magazine» fu un elogio di Bismarck. Poi studiò legge all’università di Virginia; il giovane Wilson voleva essere un Grand’Uomo, come Gladstone e i parlamentari inglesi del diciottesimo secolo; voleva incatenare con la sua oratoria alla causa della Verità i banchi gremiti di deputati; ma la pratica legale lo
irritava; si sentiva più a casa sua nell’aria libresca di biblioteche, sale di conferenze, cappella del collegio, fu un vero sollievo per lui abbandonare ad Atlanta la sua pratica legale e prendere una borsa di studio per la Storia all’università John Hopkins; quivi scrisse il Congressional Government. A ventinove anni sposò una ragazza che aveva gusto per la pittura (mentre le faceva la corte le insegnava a usare la a larga) ed ebbe un posto a Bryn Mawr, dove insegnava Storia ed Economia politica alle ragazze. Quando si laureò in filosofia all’università John Hopkins, passò a una cattedra alla Wesleyan, scrisse articoli, incominciò una storia degli Stati Uniti, perorò dal podio di conferenziere la Verità, la Riforma, il Governo responsabile, la Democrazia, salì tutti i gradini di una brillante carriera universitaria; nel 1901 gli amministratori di Princeton gli offrirono la presidenza; si buttò a riformare l’università, si fece ardenti amici e nemici, mise a scalpore l’università intera e il popolo americano cominciò a trovare nelle prime pagine dei giornali il nome di Woodrow Wilson. Nel 1909 tenne discorsi su Lincoln e Robert E. Lee e nel 1910 i caporioni democratici di New Jersey, assillati dai fustigatori del costume e dai riformatori, ebbero la brillante idea di offrire la nomina di governatore all’incensurabile rettore universitario che attirava uditori così vasti facendosi pubblicamente paladino della Giustizia. Il sig. Wilson quando prese la parola in presenza della convenzione di Trenton che lo eleggeva governatore confessò la sua fede nell’uomo della strada (i caporioni di provincia e i piccoli trafficoni della politica si scambiarono occhiate perplesse grattandosi la testa); proseguì con voce sempre più sicura: quello è l’uomo dal cui giudizio io per primo voglio essere guidato, in modo che, come si moltiplicheranno gli impegni e verranno i giorni in cui tutti sentiranno confusione e sgomento, noi si possa alzar lo sguardo alle
cime sovrastanti queste valli oscure che adombra il privilegio coi suoi massi ingombrandoci la via, per affisarlo là dove il sole splende attraverso il grande varco nelle rocce spaccate, il sole di Dio, il sole creato per rigenerare gli uomini, il sole creato per liberarli dalla loro passione e disperazione ed elevarci a quelle somme regioni che sono la terra promessa di chiunque aspiri alla libertà e all’attuazione dei propri desideri. I caporioni di provincia e i piccoli trafficanti della politica si scambiarono occhiate perplesse grattandosi la testa; poi applaudirono; Wilson giocò i sapientoni e scavalcò i caporioni e fu eletto da una grande maggioranza; e così lasciò a mezzo la riforma di Princeton per assumere la carica di governatore di New Jersey, ma si riconciliò con Bryan al pranzo dell’anniversario di Jackson; quando Bryan osservò: «Naturalmente io sapevo che voi non eravate con me nella questione valutaria», il signor Wilson rispose: «Signor Bryan, tutto quello che posso dire è che siete un grande omone». Fu presentato al colonnello House, quel mago Merlino dilettante della politica che tesseva le sue trame al Gotham Hotel, e alla convenzione di Baltimora il luglio seguente il risultato finale dello spettacolo di marionette inscenato per i delegati sudati da Hearst e House dietro le quinte e da Bryan vociferante per i corridoi con un fazzoletto sul colletto sciupato fu che Woodrow Wilson fu eletto presidente. Lo spostamento dei progressisti a Chicago da Taft a Theodore Roosevelt rese sicura la sua elezione; e così egli lasciò a mezzo la riforma dello Stato di New Jersey (pubblicità spietata fu il motto della campagna fantasma) e si insediò alla Casa Bianca quale nostro ventottesimo presidente. Mentre Woodrow Wilson si trascinava tutta Pennsylvania Avenue dalla parte di Taft, quel gran ciccione che da presidente aveva genialmente contribuito a disfare i risultati degli sforzi reazionari
compiuti da T.R. per sottomettere la finanza al controllo governativo, J. Pierpont Morgan si faceva il suo bel solitario nella stanza interna del suo ufficio di Wall Street, fumandosi venti sigari neri al giorno e maledicendo le follie della democrazia. Wilson infierì contro la speculazione e bollò a sangue il privilegio si rifiutò di riconoscere Huerta e inviò le sue milizie al Rio Grande per adottare una politica di vigile attesa. Pubblicò La nuova libertà e tenne personalmente le sue allocuzioni al Congresso, come un rettore di università che si rivolgesse al corpo insegnante e agli studenti. A Mobile disse: Colgo quest’occasione per dire che gli Stati Uniti non cercheranno mai di aumentare di un palmo i propri possessi territoriali mediante la conquista; e fece sbarcare i marinai a Veracruz. Stiamo assistendo a una rinascita dello spirito pubblico, a un risveglio di serena opinione pubblica, a una reviviscenza del potere popolare, all’inizio di un’epoca di pensosa ricostruzione… ma il mondo aveva cominciato a turbinare attorno a Sarajevo. Dapprima fu la neutralità di pensiero e di fatto, poi il famoso troppo orgogliosi per scendere in lizza quando l’affondamento del Lusitania e la minaccia ai prestiti Morgan e le storie dei propagandisti britannici e francesi eccitarono tutti i centri finanziari dell’Est a reclamare a gran voce la guerra, ma l’attrazione dei tamburi e dei cannoni era troppo forte; la gente migliore seguiva la moda di Parigi e la pronuncia di Londra, e T.R. e la Casa Morgan. Cinque mesi dopo la sua rielezione avvenuta al grido di Ci ha salvati dalla guerra, Wilson riuscì a far approvare al Congresso la legge sulle navi armate e dichiarò che esisteva uno stato di guerra fra gli Stati Uniti e gli imperi centrali: Forza senza risparmio né limite, forza all’estremo. Wilson diventò lo Stato (la guerra è la salute dello Stato), Washington la sua Versailles, arruolò nei ranghi del governo socializzato uomini da un dollaro l’anno venuti dalle grandi corporazioni e fece affluire in Francia il grande corteo di uomini, munizioni, derrate, muli e autocarri. Cinque milioni di uomini scattarono sull’attenti ad ogni ammaina
bandiera, all’esterno delle loro caserme di cartone incatramato, al suono dell’inno The Star-Spangled Banner. La guerra portò con sé la giornata lavorativa di otto ore, l’arbitrato obbligatorio, alti salari, alti saggi d’interesse, costi più contratti e il lusso di essere una Gold Star Mother. Se non ci stavi a combattere per accaparrare il mondo ai costi più la democrazia, te ne andavi diritto filato in prigione con Debs. 1 Lo spettacolo finì quasi troppo presto. Il principe Max del Baden si appellava ai Quattordici punti, Foch occupava le teste di ponte sul Reno e il Kaiser alla stazione di Potsdam correva a perdifiato per prendere il treno, portando il cilindro e stando ad alcuni anche i baffi finti. Con l’aiuto di Dio Onnipotente, il Diritto, la Verità, la Giustizia, la Libertà, la Democrazia, l’Autodecisione dei popoli, Né riparazioni né annessioni, e dello zucchero cubano e del manganese caucasico e del frumento del Nord-ovest e del cotone meridionale, del blocco britannico, del generale Pershing, dei tassì di Parigi e del cannone da settantacinque noi vincemmo la guerra. Il 4 dicembre 1918 Woodrow Wilson, il primo presidente che avesse mai lasciato il territorio degli Stati Uniti durante il periodo di carica, salpò per la Francia a bordo della George Washington ed era l’uomo più potente del mondo. In Europa sapevano che cosa fosse l’odore del gas e il lezzo dolciastro dei cadaveri mal seppelliti e la pelle grigia dei bimbi affamati; nei giornali lessero che “Mister Vilson” era per la pace, la libertà, i viveri in scatola, il burro e lo zucchero; lui sbarcò a Brest col suo stato maggiore di esperti e agenti pubblicitari dopo un viaggio agitato a bordo della Washington. C’era lì a riceverlo la France héroïque coi suoi discorsi, gli scolaretti inneggianti, i sindaci con le loro fasce rosse. (Vide “Mister Vilson” i gendarmi di Brest ricacciare con la forza la manifestazione dei lavoratori portuali che erano venuti a riceverlo con tanto di bandiere rosse?) Alla stazione di Parigi scese dal treno sopra un largo tappeto rosso
che lo condusse a una Rolls-Royce passando tra file di palme in vaso, cilindri, membri della Legion d’onore, petti decorati, marsine, nastri di ordini cavallereschi, fiori agli occhielli. (Vide “Mister Vilson” per le vie le donne in lutto, i mutilati nelle loro carrozzelle, i volti pallidi e ansiosi, udì la terribile angoscia delle acclamazioni rivoltegli mentre in gran fretta portavano lui e sua moglie all’Hôtel de Murat, dove in stanze piene di broccati, orologi dorati, mobili a intarsio e amorini dorati era stato allestito l’appartamento presidenziale?) Mentre gli esperti organizzavano la procedura della conferenza di pace, ricoprendo i tavoli di sergia verde, apprestando i protocolli, i Wilson fecero un giretto turistico per conto loro: il giorno di Santo Stefano furono ricevuti a Buckingham Palace; a Capodanno fecero visita al papa e al microscopico re italiano al Quirinale. (Sapeva “Mister Vilson” che nelle case dei contadini segnate dalla guerra, sul Brenta e sul Piave, bruciavano candele davanti alla sua fotografia ritagliata dai giornali illustrati?) (Sapeva “Mister Vilson” che il popolo europeo evocava dai Quattordici punti una sfida all’oppressione proprio come secoli addietro aveva evocato una sfida all’oppressione dai novantanove articoli che Martin Lutero aveva inchiodato al portale della chiesa di Wittenberg?) Il 18 gennaio 1919, frammezzo a una folla di uniformi, berretti a falda rialzata e galloni d’oro, decorazioni, spalline, ordini di benemerenza e cavalierato, le alte parti contraenti, le potenze alleate e consociate si riunirono nel Salon de l’Horloge al quai d’Orsay per dettare la pace, ma la grande assemblea della Conferenza della pace era un posto troppo pubblico per farvi la pace e così le alte parti contraenti formarono il Consiglio dei Dieci, passarono nella stanza dei Gobelin e nella cornice della storia di Maria de’ Medici, di Rubens, cominciarono a dettare la pace. Ma il Consiglio dei Dieci era un luogo troppo pubblico per farvi la pace e così formarono il Consiglio dei Quattro. Orlando se ne andò a casa in uno scatto d’ira
e rimasero in tre: Clemenceau, Lloyd George, Woodrow Wilson. Tre vecchi che facevano il mazzo, e distribuivano le carte: la Renania, Danzica, il corridoio polacco, la Ruhr, l’autodecisione delle piccole nazioni, la Saar, la Lega delle Nazioni, i mandati, la Mesopotamia, la libertà dei mari, la Transgiordania, lo Shantung, Fiume e l’isola di Yap: mitragliatrici e incendi fame, pidocchi, colera, tifo; il petrolio era la briscola. Woodrow Wilson credeva nel Dio di suo padre così disse ai parrocchiani della piccola chiesa congregazionalista di Lowther Street, dove suo padre aveva predicato, a Carlisle in Scozia, in un giorno così freddo che i giornalisti seduti nei vecchi banchi dovettero tutti tenersi addosso i cappotti. Il 7 aprile ordinò che la George Washington stesse a Brest con le macchine accese, pronta ad accogliere la delegazione americana rimpatriante; ma lui non partì. Il 19 aprile il baro Clemenceau e il baro Lloyd George lo attirarono in quel loro giochetto a tre che chiamarono il Consiglio dei Quattro. Il 28 giugno il trattato di Versailles era pronto e Wilson dovette tornare in patria a spiegare ai politici che intanto si erano arroccati a lui nel Senato e nella Camera, e alla serena opinione pubblica, e al Dio di suo padre, sin dove si era lasciato giocare e sin dove era riuscito ad accaparrare il mondo alla democrazia e alla Nuova Libertà. Dal giorno in cui sbarcò a Hoboken stette con le spalle addossate al muro della Casa Bianca, e parlò per salvare la sua fede nelle parole, parlò per salvare la sua fede nella Lega delle Nazioni, parlò per salvare la sua fede in se stesso e nel Dio di suo padre. Tese al massimo ogni fibra del suo corpo e del suo cervello, ogni
agenzia governativa sottoposta al suo controllo (se qualcuno non era d’accordo, era un manigoldo o un rosso; ai Debs non si perdonava). A Seattle gli operai sindacalisti che avevano i capi in prigione, a Seattle gli operai che avevano avuto i capi linciati, che erano stati abbattuti a fucilate come cani, a Seattle gli operai si allinearono in fila per quattro caseggiati al passaggio di Wilson, stettero in silenzio a braccia conserte a fissare il grande liberale mentre passava in gran fretta nella sua automobile, imbacuccato nel suo soprabito, stravolto dalla fatica, metà del volto in preda a convulsioni. Gli uomini in tuta, gli schiavi del lavoro lo lasciarono passare in silenzio, dopo tutti i battimani e gli applausi patriottici che gli erano stati tributati dagli altri caseggiati. A Pueblo, Colorado, egli era ormai un uomo ingrigiato appena capace di reggersi, con metà del volto in preda alle convulsioni: Ora che le nebbie di questa grande questione si sono dissipate, io credo che gli uomini vedranno la Verità in faccia, a occhio limpido. A una cosa il popolo americano si è sempre levato e ha sempre teso la mano: alla verità della Giustizia, della Libertà e della Pace. Noi abbiamo accettato quella verità e da essa ci faremo guidare, ed essa ci guiderà, e il mondo per tramite nostro, a tali pascoli di tranquillità e di pace che il mondo sinora non ha mai sognato. Quello fu il suo ultimo discorso; sul treno di Wichita ebbe un colpo. Rinunciò al giro di propaganda che doveva guadagnare in blocco il paese alla causa della Società delle Nazioni. E da allora in poi egli fu un povero paralitico incapace di parlare. Il giorno in cui lasciò la presidenza a Harding, il comitato unito del Senato e del Parlamento designò Henry Cabot Lodge, suo nemico personale, a fare la visita di prammatica all’ufficio esecutivo del Campidoglio e a porre la domanda di rito, se cioè il presidente avesse nulla da dire al Congresso riunito in seduta plenaria; Wilson riuscì ad alzarsi in piedi, facendo penosamente leva sui braccioli della poltrona. «Senatore Lodge, io non ho altre comunicazioni da fare, grazie… Buon giorno» disse. Il 3 febbraio 1924 morì. 1. Capo socialista americano. (NdT)
Cine-giornale XXX I CANNONI GIGANTI ELIMINATI? Predicatori zazzeruti spuntano ogni sera a tentar di indicarti il bene e il male ma se gli chiedi qualcosa da mangiare ti rispondono in tono così soave IL PRESIDENTE COLPITO IN MARE DA UNA LIEVE INFREDDATURA Uno speciale capocuoco e apposito personale di camerieri e aiutanti da cucina prelevati dal Biltmore Tutte le comodità L’orchestra suonerà durante i pasti e la banda della marina militare suonerà sul ponte Con un po’ di pazienza mangerete in quella terra gloriosa che sta oltre il cielo la città offre il quadro della più orrenda distruzione, specialmente intorno al palazzo della Posta centrale, totalmente distrutto dal fuoco: non rimangono quivi che rovine Lavorate e pregate Cibatevi di fieno Sono stati qui raccolti tre autocarri di dischi undici uomini sono morti e ventitré sono rimasti feriti, alcuni seriamente in seguito a un’esplosione di mercurio verificatasi nel reparto Confezione di una fabbrica di capsule della E.I. DuPont de Nemours Powder Company; la sera il sig. Wilson liberò piccioni viaggiatori… e in tutto questo periodo, come fu alto lo spirito della nazione, quale unità di propositi, quale zelo indefesso, quale altezza di ideali animò tutto il suo splendido spiegamento di forza, la sua instancabile operosità! Io ho detto che quelli di noi che stettero in patria a svolgere il lavoro di organizzazione e rifornimento avrebbero certo voluto trovarsi al fianco dei combattenti, ma noi non abbiamo motivo di vergognarci… in sala da pranzo il trattenimento musicale fu dato da un quartetto di marinai Avrete pasticci e leccornie lassù in Cielo
in Cielo dopo morti GORGAS VORREBBE ALLOGGIARE I SOLDATI IN CAPANNE 800 COMBATTENTI ACCLAMANO I BOLSCEVICHI Tutto era predisposto con ordine, ma la folla fu tenuta a distanza. La gente radunata sulle alture presso il molo emise un gran grido quando arrivò la lancia del presidente. Dagli Champs-Élysées si fece una deviazione per traversare la Senna sul ponte Alessandro III, che rammentava un’altra storica parata, quella in cui Parigi superò se stessa per onorare un sovrano assoluto nella persona dello zar. HA PARLATO A 1400 SINDACI DALLA BALCONATA DEL PALAZZO LA MARINA DA GUERRA BRITANNICA DEVE PRIMEGGIARE SU TUTTE DICHIARA CHURCHILL
Occhio fotografico (37) in ordine alfabetico e di grado tutto battuto a macchina con due freddi indici sulla Corona della compagnia Assegni Classe A e B Premi di assicurazione C e D Aaat-TENTI! scattare agli uncini e occhi puntati sulla mia gola comprimendo il pomo di Adamo accostando la sigla U.S. e il caduceo Riposo fuori fanno esercitazioni nel purpureo piovigginare d’un pomeriggio invernale a Ferrières-en-Gâtinais abbazia fondata da Clodoveo sugli scheletri di tre discepoli di notre Seigneur Jésus-Christ 3° prestito Liberty seg. d. Tes. Alziano Poliziano ed Ermaziano 4° prestito Lib. seg. d. Tes. dev’essere sul modulo tipo E o altro modulo Il quartiermastro del corpo 38 ora piove a dirotto e le grondaie gorgogliano s’alza un tintinnio da tutti i rivoli verdebottiglia Alcuino fu priore qui e ruote di macina girano dietro i muri di pietra coperti di muschio e Clotilde e Clodomiro furono sepolti qui promozioni da segnarsi solo sotto le apposite lineette sonnacchiosamente battuto a macchina sulla Corona smangiata di ruggine nell’accantonamento del circo viaggiante O’Rielly, solo soletto se non si considera il lavativo che fa il malato con ricca scena nella sua brandina e il tossicchiare secco di quel tubercoloso che l’ufficiale medico non ha mai trovato il momento di visitare perché è sempre ubriaco Lo iodio ti farà felice lo iodio ti farà star bene quattro e mezza viene il permesso vivo tra le pillole di carbonato di calcio che mi riempiono le tasche il sergente facente funzioni di quartiermastro e il sergente maggiore escono dal cancello dell’Army Air Service americano indossando i loro impermeabili sotto la pioggia illuminata di lampioni e senza un soldo in tasca se ne vanno al Cheval Blanc dove a furia di esibir galloni e biascicar francese scroccano bibite e omelettes avec pommes frites e stuzzicano Madeleine dalle guance fiorenti come mele si può?
nell’oscuro vestibolo della stanza retrostante i ragazzi stanno in fila in attesa di entrare dalla ragazza in nero che viene da fuori e snocciolarle dieci franchi per poi precipitarsi all’infermeria per la profilassi Mancanza disciplinare commessa da un soldato – ammalato – non era al suo posto – infrazione all’ordine generale 41/14 – notificato e inviato all’ospedale – reparto veneree fuori piove sul selciato della città dentro beviamo vin rosso parlezvous franceson possiamo coucher avec e il vecchio territoriale al tavolo vicino beve Pernod non autorizzato dalla legge e osserva Tout est bien fait dans la nature à la vôtre aux Américains Après la guerre finie torno in America, sì! Dans la mort il n’y a rien de terrible Quand on va mourir on pense à tout mais vite il primo giorno dell’anno messo in libertà dopo l’appello me ne andai a spasso con un tizio di Filadelfia per le purpuree strade solcate di carraie invernali sotto il purpureo ricamo degli alberi intrecciati pieni di cornacchie ridacchianti sulle nostre teste e poi su per le colline più rossicce verso un paesetto vogliamo farci una bella camminata trovare vino buono pieno di nomi merovingi macine di mulino fontane verdebottiglia dove l’acqua scende gorgogliando da vecchi mascheroni di pietra le mele rosse di Madeleine l’odore di foglie di faggio vogliamo fare una buona bevuta di vino il ragazzo di Filadelfia ha un sacco di soldi vino invernale più purpureo il sole erompe dalle nubi il primo giorno dell’anno nel primo paesetto sostiamo sui nostri passi a guardare una statua di cera il vecchio ha fulminato la bella forosetta che assomiglia a Madeleine ma è più giovane giace lì colpita al seno sinistro nel sangue nei solchi della strada leggiadra e paffuta come una piccola quaglia poi il vecchio si levò una scarpa e si appoggiò la canna dello schioppo al mento tirò il grilletto con l’alluce e si fece saltare le cervella noi stiamo a guardare il piede nudo e la scarpa e il piede calzato e la ragazza assassinata e il vecchio con un sacco di iuta sulla
testa e lo sporco alluce nudo col quale ha tirato il grilletto Faut pas toucher finché non viene il commissaire procès-verbal in questo primo giorno dell’anno il sole è fulgido
Cine-giornale XXXI lavatisi e vestitisi in fretta scesero a pianterreno alla brusca chiamata dei commissari, radunandosi in una stanza nel retro del seminterrato. Qui vennero messi in fila in semicerchio lungo il muro, e le giovani granduchesse tremavano all’insolita natura degli ordini dati e alla cupezza dell’ora. Subodorarono senz’altro lo scopo della venuta dei commissari. Rivolgendosi allo zar, Iarodskij, senza il minimo tentativo di attenuare l’annunzio, dichiarò che dovevano morire tutti e subito. La rivoluzione, affermò, era in pericolo, e il fatto che vivessero ancora i membri della casa regnante aumentava quel pericolo. Perciò era dovere di tutti i patrioti russi toglierli di mezzo. «Così termina la vostra vita» disse per concludere. «Io sono pronto» dichiarò semplicemente lo zar, mentre la zarina, stringendosi a lui, allentò la stretta quanto bastava a farsi il segno della croce, subito imitata dalla granduchessa Olga e dal dottor Botkin. Lo zarevic, paralizzato di paura, rimase intontito accanto alla madre, senza suppliche né proteste, mentre le sue tre sorelle e le altre granduchesse cadevano a terra tremando. Iarodskij estrasse la rivoltella e sparò il primo colpo. Seguì una raffica e i prigionieri si accasciarono al suolo. Dove i proiettili mancarono il segno, la baionetta diede il colpo di grazia. Il sangue commisto delle vittime non solo coprì il pavimento della stanza dove aveva avuto luogo l’esecuzione ma corse a fiotti per l’androne
Figlia I Trent abitavano in una casa di Pleasant Avenue, la più bella strada di Dallas che era la più grande e promettente città del Texas, che era il più grande Stato della Federazione e aveva la terra più nera e la gente più bianca, e l’America era il più grande paese del mondo e Figlia era la cocca di papà, l’unica. Il suo vero nome era Anne Elizabeth Trent, come quello della povera mammina morta prestissimo, ma papà e i ragazzi la chiamavano Figlia. Il vero nome di Buddy era William Delaney Trent, come quello di papà che era un legale di chiara fama, e il vero nome di Buster era Spencer Anderson Trent. D’inverno essi andavano a scuola, e d’estate scorrazzavano a briglia sciolta nel ranch che il nonno si era fatto da pioniere. Finché erano piccolini, non c’era neppur l’ombra di staccionate, e fuori nei letti dei corsi d’acqua si trovavano ancora tori senza marchio, ma all’epoca in cui Figlia frequentava la scuola media superiore tutto era ben cintato e da Dallas si stava costruendo una strada macadam e papà andava dappertutto con la Ford e non più col suo magnifico stallone arabo Mullah, avuto da un allevatore al Fat Stock Show di Waco quando l’allevatore era andato in rovina e non era stato in grado di pagare il suo onorario all’avvocato. Figlia aveva un cavallino color crema di nome Coffee, che accennava del capo e batteva lo zoccolo quando voleva un pezzo di zucchero, ma certe sue amiche avevano l’automobile, e Figlia e i ragazzi insistevano per far comperare al babbo un’auto, una vera automobile al posto di quella miserabile carcassa con la quale girava per il ranch. Quando papà comperò un’auto da turismo Pierce-Arrow, la primavera in cui Figlia si diplomò, lei fu la fanciulla più felice del mondo. Seduta al volante, con un vestito bianco e vaporoso, la mattina della cerimonia accademica, ad aspettare lì fuori il papà, il quale appena tornato dall’ufficio si stava cambiando, pensava che piacere le avrebbe fatto vedersi seduta lì nella temperata mattina di giugno, nella lustreggiante vettura nera, tra le lucide guarnizioni di
ottone e nichel, sotto il lucente vasto cielo del Texas in mezzo alla grande e ricca pianura del Texas che si estendeva per duecento miglia da ogni parte. Vedeva metà del suo volto nello specchio ovale del parafango. Quel volto era rosso e arso dal sole sotto i capelli bruno sabbia. Avesse almeno avuto i capelli rossi e la pelle bianca come il latte, come Susan Gillespie; ecco il desiderio che stava formulando quando vide arrivare Joe Washburn, scuro in volto e serio serio sotto il cappello di panama. Lei atteggiò il viso a una specie di sorriso timido, in tempo per fargli dire: «Come sei carina, Figlia, scusami se te lo dico». «Sto giusto aspettando papà e i ragazzi per andare alla cerimonia del diploma. O Joe, siamo in ritardo e sono tanto emozionata… Chissà che faccia ho.» «Be’, divertiti.» Ed egli riprese il cammino senza fretta, rimettendosi il cappello in testa. Qualcosa di più caldo del sole di giugno emanavano gli occhi nerissimi di Joe, e le era corso come un rossore sul volto, sulla nuca, sotto l’abitino leggero, e in mezzo al petto, dove i piccoli seni a cui essa cercava di non pensare mai cominciavano giusto a farsi notare. Finalmente papà e i ragazzi uscirono tutti, biondi, agghindati e abbronzati. Papà la fece sedere di dietro insieme a Bud, che se ne stava rigido e impalato. Il gran vento che s’era alzato buttava loro la sabbia in faccia. Scorgendo la sua scuola, tutta di mattone, e la folla e gli abiti leggeri e i padiglioni e la grossa bandiera con le strisce contorcentesi al vento, ella si emozionò a tal punto che poi non ricordava più quanto era avvenuto. Quella sera, indossando il suo primo abito da sera per il ballo, ella si risvegliò a una sensazione di tulle, cipria e folla, ragazzi tutti rigidi e intimiditi nel loro abito scuro, ragazze stipate nel guardaroba per osservare ciascuna il vestito dell’altra. Lei non disse una parola nel ballare, non fece che sorridere e inclinare un po’ la testa da una parte, sperando che qualcuno si facesse avanti. Per un bel po’ non seppe neanche con chi ballava, non fece che muoversi sorridendo in una nuvola di tulle rosa e luci colorate; davanti le affioravano volti di ragazzi, tentando di dirle cose galanti, oppure erano timidi e taciturni, volti di diverso colore in cima agli stessi corpi rigidi. Fu per lei una
vera sorpresa quando, al momento di tornare a casa, Susan Gillespie le si avvicinò per dirle con un risolino: «Mia cara, sei stata la reginetta del ballo». Quando lo ripeterono Bud e Buster, la mattina dopo, e la vecchia nera Emma, che li aveva allevati tutti dopo la morte di mammà, si affacciò dalla cucina e disse: «Cielo, signorina Annie, in città la gente non fa che dire che voi eravate la reginetta del ballo, la notte scorsa», lei si sentì pervadere da un rossore di felicità. Emma disse che l’aveva sentito dire da quell’insignificante omuncolo della latteria che aveva una zia alle dipendenze della signora Washburn, poi servì le focaccine e uscì con un sorriso largo come una tastiera di pianoforte, «Be’, Figlia,» disse papà con la sua voce quieta e profonda, battendole affettuosamente sulla punta della mano «anch’io lo pensavo, ma temevo di sbagliare sotto la suggestione dell’affetto.» Durante l’estate Joe Washburn, che si era appena laureato in legge ad Austin e doveva entrare per l’autunno nell’ufficio di papà, venne a passare due settimane con loro al ranch. Figlia fu semplicemente perfida con lui, persuase il vecchio Hildreth a dargli per le cavalcate un vecchio poney di scarto cieco d’un occhio, gli mise nel letto rospi cornuti, a tavola gli porgeva salsa piccante bollente invece di salsa fredda, oppure cercava di fargli mettere sale nel caffè al posto dello zucchero. I ragazzi se la presero a tal punto che non le vollero più rivolgere la parola, e papà disse che lei stava diventando un maschiaccio, ma a quanto pareva non c’era verso di farle cambiare condotta. Poi un bel giorno andarono tutti a cavallo fino al Clear Creek per cenare lì all’aperto, e nuotarono al chiaro di luna nella profonda vasca naturale che c’era sotto la scarpata. Figlia dopo un po’ ebbe un estro balzano e vi corse in cima e disse che si sarebbe tuffata dall’orlo della scarpata. L’acqua aveva un aspetto così buono, e la luna vi galleggiava sopra abbrividendo. Le gridarono tutti di non farlo, ma lei eseguì un tuffo impeccabile proprio dall’orlo. Ma accadde qualcosa. Aveva urtato con la testa, e le faceva un male tremendo. Stava inghiottendo acqua, stava lottando contro un gran peso che le premeva addosso, ed era Joe. Il chiaro di luna svanì in un turbine lasciando tutto buio, solo che lei aveva le braccia intorno al collo di Joe, e le sue dita si stavano
aggrappando ai ben rilevati muscoli delle braccia di lui. Quando tornò in sé vide il suo volto fiso nel proprio, e la luna ricomparsa in cielo, e si sentì versare roba calda sulla testa. Stava cercando di dire: “Joe voglio, Joe voglio…”, ma tutto quanto fu risucchiato di bel nuovo da una tenebra calda e viscosa, l’unica cosa che percepiva era la voce di lui profonda, profonda: «per poco non faceva annegare anche me…», e papà secco e iroso come in tribunale: «Gliel’avevo detto di non tuffarsi di là». Ritornò in sé a letto, stavolta, con la testa che le doleva tremendamente e il dottor Winslow al suo capezzale, e la prima cosa che le venne in mente fu Joe: dov’era? e si era comportata come una sciocchina lei, a dirgli che aveva preso una cotta per lui? Ma nessuno vi accennava, e tutti erano tanto buoni con lei, tranne papà, sempre in quel suo tono iroso da tribunale, veniva a farle solenni lavate di capo perché era stata temeraria, un vero maschiaccio, e aveva messo in serio pericolo la vita di Joe con quella stretta strangolatrice quando la stavano tirando fuor d’acqua. Aveva il cranio fratturato e dovette rimanere a letto tutta estate, e Joe fu tanto buono, per quanto l’avesse guardata in maniera un po’ buffa con quei suoi acuti occhi neri, la prima volta ch’era entrato nella stanza. Finché rimase al ranch venne sempre a leggerle qualcosa dopo colazione. Le lesse tutto Lorna Doone e metà Nicholas Nickleby, e lei se ne stava lì nel suo letto, tutta calda e comoda in braccio alla febbre, sentendosi ripercuotere nel dolore al capo il rimbombo della sua voce profonda, e sempre tesa a farsi forza per non uscire a gridargli come una sciocchina che era innamorata cotta di lui e perché lui non le voleva un po’ di bene. Quando se ne andò via lui, non ci fu più gusto a essere malata. A volte venivano a leggerle qualcosa papà o Bud, ma per lo più preferiva leggere da sé. Si lesse due volte tutto Dickens, e The Harbor di Poole che le mise in corpo la voglia di andare a New York. L’autunno seguente papà la portò a nord per un anno a una scuola di perfezionamento di Lancaster, Pennsylvania. Il viaggio in treno la divertì un mondo, dal principio alla fine, ma da Miss Tynge si stava malissimo, le ragazze erano tutte settentrionali e così antipatiche, la prendevano in giro per il suo modo di vestirsi e non facevano che
parlare di Newport, Southampton, e idoli delle matinées a lei completamente sconosciuti: non le andava proprio giù. Ogni notte, a letto, si metteva a piangere pensando quanto le era odiosa la scuola e come ora Joe Washburn non l’avrebbe più amata. Quando vennero le vacanze di Natale e le toccò fermarsi lì con le due signorine Tynge e alcune insegnanti che abitavano troppo lontano da casa per poterci tornare, si disse semplicemente che non resisteva più, e un bel mattino, prima che alcuno fosse in piedi, uscì di casa, alla stazione si comperò un biglietto per Washington e montò sul primo treno diretto a occidente, con uno spazzolino da denti e una camicia da notte in valigia. Dapprima, tutta sola com’era in treno, aveva addosso uno sgomento da non dirsi, ma a Havre de Grace, dove c’era da cambiare, salì nello scompartimento un giovane virginiano tanto simpatico, un cadetto di West Point; e assieme si divertirono un mondo a ridere e ciarlare. A Washington lui le chiese delicatamente il permesso di farle da guida, e la condusse in giro a vedere il Campidoglio e la Casa Bianca e l’istituto smithsoniano, e l’invitò a colazione al New Willard, e quella sera stessa la mise sul treno di St. Louis. Si chiamava Paul English. Gli promise che gli avrebbe scritto ogni giorno della sua vita. Era così emozionata che non riusciva a dormire, stesa lì nella cuccetta a guardare dal finestrino gli alberi e le colline giranti, ogni cosa immersa nel debole chiarore della neve, e di tanto in tanto le luci che saettavano via; ricordava benissimo il suo aspetto, la sua pettinatura, e la lunga stretta di mano confidenziale nel momento del commiato. A tutta prima lei era stata un po’ sulle spine, ma ben presto si erano trovati come due vecchi amici, e lui era tanto cortese e signorile. Era stata la sua prima conquista. Quando si presentò al babbo e ai ragazzi all’ora di colazione, in un soleggiato mattino d’inverno, due giorni dopo, sa il Cielo se loro ne furono sorpresi; papà tentò di sgridarla, ma Figlia si accorse che lui era contento né più né meno di lei. Comunque, che importava? era così bello trovarsi a casa! Dopo Natale lei, papà e i ragazzi andarono presso Corpus Christi a fare una settimana di caccia, se la passarono da principi e Figlia abbatté il suo primo daino. Quando furono nuovamente a Dallas,
Figlia disse che non ne voleva proprio sapere di tornare a perfezionarsi là dond’era fuggita; le sarebbe piaciuto invece andare a New York da Ada Washburn, che studiava alla Columbia University, e seguire corsi che le insegnassero realmente qualcosa. Ada era la sorella di Joe Washburn, già una zitella, ma vivace e simpatica, e stava attendendo alla sua tesi di pedagogia per diventare dottoressa in Filosofia. La cosa suscitò discussioni interminabili, perché papà ci teneva tanto a mandare Figlia a una scuola di perfezionamento, ma lei finalmente riuscì a convincerlo e partì per New York. Per tutto quel viaggio in treno non fece che leggere I miserabili e guardare dal finestrino il paesaggio invernale grigio-brunastro che appariva così privo di vita al confronto con le ampie colline del Texas, da poco lasciate, pallidamente verdeggianti di frumento invernale e alfalfa; e di ora in ora, man mano che si andava avvicinando a New York, crescevano in lei l’emozione e lo sgomento. A Little Rock salì nello scompartimento una donnona materna, vedova recente, che non la finiva più di parlare dei pericoli e dei trabocchetti che insidiano una donna giovane nelle metropoli. Fece una guardia così inesorabile a Figlia che non ci fu verso di poter attaccare discorso con quell’interessante giovane dagli intensi occhi neri che era salito sul treno a St. Louis e seguitava a esaminare certe sue carte contenute in una borsa bruna. Le parve che avesse qualcosa di Joe Washburn. Da ultimo, quando stavano ormai traversando il New Jersey e s’andavano sempre più infittendo le fabbriche e le fuligginose città industriali, a Figlia prese a battere il cuore così forte che non resistette più a star seduta, ma dovette continuare a uscire dallo scompartimento e camminar su e giù nell’aria inclemente del corridoio. Il grasso capotreno dai capelli grigi le domandò con un riso malizioso se c’era alla stazione il suo bello a riceverla, pareva tanto ansiosa di arrivare. Poi traversarono Newark. Ancora un’altra fermata e poi basta. Il cielo era di piombo su strade luride gremite d’auto, e una pioggerella fine picchiettava le chiazze di neve. Il treno cominciò a percorrere vasti acquitrini salmastri desolati, interrotti qua e là da un irregolare agglomerato di capannoni industriali o da un fiume nero navigato da imbarcazioni a vapore. A quanto pareva non c’era anima viva: c’era
un tal senso di freddo su quegli acquitrini che Figlia provò sgomento e solitudine solo a guardarli, e bramò casa sua. Poi d’un tratto il treno infilò una galleria, e il facchino ammucchiava tutti i bagagli all’estremità anteriore della vettura. Lei indossò il soprabito di pelliccia regalatole da papà per Natale e s’infilò i guanti sulle mani fredde per l’emozione, preoccupata che eventualmente Ada Washburn non avesse ricevuto il suo telegramma o non avesse potuto venire a riceverla. Ma no, eccola là sul marciapiede d’arrivo con tanto di occhiali a pince-nez e impermeabile, più zitella che mai nell’aspetto, in compagnia di una ragazza un po’ più giovane che era di Waco e studiava arte. Fecero una interminabile corsa in tassì per vie affollate, piene di fanghiglia e orlate di mucchi di neve gialli e grigi lungo i marciapiedi. «Se fossi stata qui una settimana fa, Anne Elizabeth, ti assicuro che avresti visto una vera e propria tormenta.» «Io finora credevo che la neve fosse come sulle cartoline di Natale» disse Esther Wilson, che era una ragazza interessante dagli occhi neri, il viso lungo e la voce profonda di uno speciale timbro tragico. «Ma era semplicemente un’illusione, come tante altre cose.» «New York non è posto per le illusioni» disse Ada seccamente. «A me fa tutto l’effetto d’una illusione» disse Figlia guardando dal finestrino del tassì. Ada e Esther avevano un bell’appartamento a University Heights, e la sala da pranzo l’avevano fissata come camera da letto per Figlia. New York non le piaceva, ma era emozionata; tutto era grigio e sporco, e la gente aveva l’aria forestiera, e nessuno badava a te, solo che di tanto in tanto un uomo cercava di attaccarti un bottone per strada o ti si strofinava addosso nella metropolitana, cosa questa veramente disgustosa. Si iscrisse come studentessa speciale e frequentò lezioni sull’economia e la letteratura inglese, e a volte scambiò due parole con qualche ragazzo vicino di posto, ma lei era tanto più giovane di tutti quelli che le capitava di conoscere, e a quanto sembrava la sua conversazione non era la più indicata per interessarli. Era tanto bello andare alle matinées con Ada o, in compagnia di Esther stipate come sardine in cima all’autobus, passare
al museo artistico i pomeriggi di domenica, ma le sue ospiti erano entrambe così posate e adulte, e non facevano che scandalizzarsi delle cose che lei diceva e faceva. Quel sabato che Paul English le telefonò per invitarla a una matinée, fu per lei un vero avvenimento. Si erano scambiati poche lettere, ma dal giorno trascorso assieme a Washington non si erano più visti. La mattinata la passò tutta a provarsi prima un vestito e poi l’altro, prima una pettinatura e poi l’altra, e stava ancora facendo il bagno caldo quando arrivò lui a prenderla, tanto che Ada dovette occuparsi lei di intrattenerlo per un bel po’. Quando lo vide, tutta l’emozione di poc’anzi svanì, era così rigido e impettito nella sua uniforme di gala. Per cominciare, si mise a prenderlo in giro e a fare la sciocca durante il tragitto in metropolitana, tanto che quando arrivarono all’Astor, dove la portò a colazione, lui era imbronciato come un cucciolo maltrattato. Lo piantò in asso a tavola per andare nella sala riservata alle signore a veder di migliorarsi l’acconciatura, e quivi attaccò discorso con un’anzianotta signora ebrea ingioiellata che aveva perso il suo taccuino, e quando tornò di là la colazione era fredda e Paul English si guardava l’orologio da polso con l’aria di chi sta sui carboni ardenti. Lo spettacolo non le piacque, e al ritorno, mentre il tassì passava per il lungofiume, lui fece l’audace, quantunque fosse ancora pieno giorno; lei allora lo prese a schiaffi. Lui disse che era la ragazza più antipatica che avesse mai conosciuta, e lei ribatté che ci teneva a esserlo, e d’altronde, se non gli andava a genio, sapeva benissimo come regolarsi. Anche prima d’allora essa aveva deciso tra sé di cancellarlo dal suo libro d’oro. Andò in camera sua, si sfogò a piangere e non volle cenare. Le faceva tanto male vedere che Paul English era diventato un cretino di quella fatta. Prospettiva poco consolante, quella di non aver nessuno che la accompagnasse fuori, e nemmeno la possibilità di fare conoscenze, obbligata com’era a tenersi sempre alle costole quelle due zitelle. Se ne stava lì supina sul pavimento a guardare il mobilio dal basso in alto come faceva da bambina, e a pensare a Joe Washburn. Entrò Ada e la trovò in una posizione bislacca, stesa per terra e con le gambe in aria; lei saltò su e le coprì la faccia di baci, l’abbracciò e disse
di essere stata una vera stupida, ma ora era tutto finito, e non c’era nulla in ghiacciaia? Quando conobbe Edwin Vinal a uno di quei ricevimenti serali di Ada che lei di solito evitava per via della gente che se ne stava seduta in giro con tanto sussiego e parlava con tanta solennità e profondità tra un sorso di cacao e un morso di tartine, tutto cambiò, e New York cominciò a piacerle. Lui era un tipo di giovanotto allampanato che seguiva le lezioni di sociologia. Stava seduto sopra una sedia dura, reggendo la tazzina di cioccolata con una mano impacciatissima, e si vedeva che non sapeva dove mettere le gambe. Non aprì bocca per tutta la sera, ma proprio sul punto di andarsene raccolse uno spunto di Ada sui valori e parlò a non finire, citando continuamente un tizio di nome Veblen. Figlia provò una specie di attrazione per lui e gli chiese chi era Veblen, e lui cominciò a parlare con lei. Non era aggiornata sull’argomento che le andava esponendo, ma si sentiva ravvivar tutta dentro al vederlo rivolgersi a lei in quel tono. Aveva capelli chiari e sopracciglia nere, ciglia di uguale colore intorno a occhi grigiopallidi screziati di macchioline d’oro. Le piaceva quel suo modo imbarazzato e sgraziato di muoversi. La sera dopo venne a trovarla e le portò un volume sulla Teoria della classe agiata, e le domandò se voleva andare con lui a pattinare al palazzo del ghiaccio St. Nicholas. Lei andò in camera sua a prepararsi e prese a baloccarsi con la cipria e lo specchio. «Ehi, Anne, per grazia di Dio, non abbiamo mica tutta la notte di tempo» le gridò lui dalla porta. Era la prima volta che si metteva i pattini da ghiaccio, ma era pratica di pattinaggio a rotelle, e così, sorretta da Edwin per un braccio, riuscì a fare il giro del gran salone, con l’orchestra che sonava e tutte le file di luci e di facce intorno al parapetto. Da quando era partita, non si era mai divertita tanto. Edwin Vinal aveva lavorato per un ente assistenziale e abitava in una casa di quell’ente; ora fruiva di una borsa di studio alla Columbia, ma diceva che i professori erano troppo teorici e pareva non si rendessero mai conto di aver a che fare con persone reali in carne e ossa come te e me. Figlia a suo tempo aveva lavorato per le chiese e aveva portato i cestini dei regali a famiglie povere per Natale, e disse
che le sarebbe piaciuto svolgere mansioni assistenziali anche a New York. Mentre si toglievano i pattini, egli le chiese se diceva sul serio, e lei lo guardò sorridendo e rispose: «Che io possa morire se non lo dico sul serio». Così la sera dopo egli le fece fare un giro di tre quarti d’ora in metropolitana e poi un bel tratto in una linea tranviaria radiale per portarla a una casa assistenziale di Grand Street, dove essa dovette aspettare mentre lui dava lezione d’inglese a una classe di bisunti giovani lituani o polacchi o roba del genere. Poi girarono per le strade, e Edwin la mise al corrente della situazione. Era come il quartiere messicano di San Antonio o Houston, solo che c’erano stranieri d’ogni nazione. Parevano tutti poco amici dell’acqua, e le strade puzzavano d’immondizia. Biancheria appesa dappertutto e scritte in ogni sorta di strane lingue. Edwin gliene mostrò alcune in yiddish e in russo, una in armeno e due in arabo. Le vie erano affollatissime, c’erano carrette lungo i marciapiedi e venditori ambulanti dovunque, e strani odori di cucina emanavano dai ristoranti, assieme a musica esotica di grammofoni. Edwin indicò due ragazze molto dipinte, dall’aria stracca, e disse che erano peripatetiche, poi alcuni ubriachi che uscivano incespicando da un pubblico locale, un giovanotto dal berretto a scacchi – un ruffiano che procurava clientela e affari a una casa equivoca – e certi ragazzi giallastri in viso, gente illecitamente armata dedita al traffico degli stupefacenti. Fu un sollievo sbucare nuovamente dalla metropolitana nel centro della città, dove un vento vivace soffiava per le ampie vie vuote impregnate dell’odore del fiume Hudson. «Be’, Anne, che impressione ti ha fatto questo viaggetto negli inferi della malavita?» «Non c’è male» disse lei dopo una pausa. «Un’altra volta credo che mi porterò una rivoltella nella borsetta… Ma in quanto a quella gente, Edwin, come puoi sperare di farne dei cittadini? Non si dovrebbe lasciar venire tutti questi stranieri a imbastardirci il paese.» «Hai completamente torto» la rimbeccò Edwin. «Quelle sarebbero tutte persone per bene se avessero una possibilità di vivere. E noi saremmo né più né meno come loro se non avessimo avuto la fortuna di nascere da famiglie per bene in prosperose cittadine americane.»
«Oh Edwin, perché dici certe sciocchezze, loro non sono bianchi e non lo saranno mai. Sono giusto come i messicani o giù di lì, o anzi, come i negri.» Si riprese e inghiottì l’ultima parola. Sopra una panchina immediatamente dietro di lei stava sonnecchiando il ragazzo di colore addetto all’ascensore. «Sei proprio la più retrograda piccola pagana che io abbia mai visto» disse provocante Edwin. «Tu sei cristiana, no? bene, non t’è mai venuto in mente che Cristo era un ebreo?» «Insomma, sto morendo di sonno e non posso discutere con te, ma so che hai torto.» Così dicendo entrò nell’ascensore, e il ragazzo di colore si alzò sbadigliando e stirandosi le membra. Nella zona di luce presto svanita tra il fondo dell’ascensore e il soffitto del vestibolo, scorse Edwin che le agitava contro un pugno. Senza proprio volerlo, gli mandò un bacio. Quando entrò nell’appartamento, Ada, che stava leggendo nella stanza di soggiorno, la rimproverò un poco per il ritardo, ma lei si difese dicendo che era troppo stanca e assonnata per poter ricevere rimproveri. «Che ne pensi di Edwin Vinal, Ada?» «Oh bella, mia cara, penso che è un giovane magnifico, forse un tantino irrequieto, ma si calmerà… Perché?» «Oh, così» disse Figlia, sbadigliando. «Buona notte, Ada cara.» Fece un bagno caldo, si profumò abbondantemente e andò a letto, ma non riusciva a dormire. Le dolevano le gambe affaticate sui lastrici bisunti, e sentiva le mura di quegli edifici trasudar libidine e sozzura, e un odore di corpi affollati avvolgerla prepotente; ad onta del profumo aveva ancora nelle nari l’acido tanfo di spazzatura, e il barbaglio dei lampioni e di quei volti le pungeva gli occhi. Quando s’addormentò, sognò di essersi tinte le labbra col rossetto e di camminare su e giù, su e giù con una rivoltella nella borsetta; le passava accanto Joe Washburn, e lei continuava a prenderlo per un braccio nel tentativo di fermarlo, ma lui seguitava per la sua strada senza degnarla d’uno sguardo, e così pure papà, e non volevano proprio guardarla, quand’ecco un grosso ebreo barbuto avvicinarlesi sempre più, e puzzava tremendamente di East Side, aglio e gabinetti, e lei cercava di prendere la rivoltella dalla borsetta per sparargli, e lui
la chiuse tra le braccia e a viva forza traeva a sé il suo volto. Lei non riusciva a prendere la rivoltella dalla borsetta, e dietro il fragore della metropolitana che le assordava le orecchie c’era la voce di Edwin Vinal: “Tu sei cristiana, no? Hai completamente torto… cristiana, no? Non t’è mai venuto in mente che Cristo sarebbe stato né più né meno come loro se non avesse avuto la fortuna di nascere da gente per bene… cristiana, non è vero?…”. La svegliò Ada, curva su di lei, in vestaglia. «Che c’è, bambina?» «Ho avuto un incubo… che stupidaggine!» disse Figlia, e scattò a sedere in letto. «Ho lanciato urla di terrore?» «Ci gioco la testa che voi due ragazzi siete andati a mangiare crostini al formaggio con la birra, ecco perché avete fatto così tardi!» disse Ada, e tornò in camera sua ridendo. Quella primavera Figlia fece l’allenatrice di una squadra di pallacanestro femminile presso una sezione della YWCA nel Bronx, e si fidanzò con Edwin Vinal. Gli disse che non intendeva sposarsi prima di un paio d’anni, e lui disse che non gliene importava del matrimonio carnale, la cosa importante per loro due era progettare una vita di servizio sociale in comune. Le sere di domenica, quando il tempo era bello, andavano a cuocersi una bistecca al Palisades Park e sedevano lì a guardare attraverso il fogliame degli alberi le luci che si accendevano sul grande orlo dentato della città, e parlavano del bene e del male e del vero amore. Tornando, stavano a prua del traghetto tenendosi per mano in mezzo alla folla di boy-scout e di gitanti reduci dalle scampagnate o dalle merende sul prato, e osservando il popolo di edifici illuminati sfumanti nella bruma rossastra del North River, e parlavano delle deplorevoli condizioni di vita esistenti in città. Edwin la baciava in fronte nel darle la buonanotte, e lei saliva con l’ascensore sentendo su di sé quel bacio come una consacrazione. Alla fine di giugno andò a casa a passare tre mesi al ranch, ma quell’estate vi si trovò malissimo. In un modo o nell’altro non riusciva a parlare al babbo del suo fidanzamento. Quando venne Joe Washburn a passare una settimana nel ranch, i ragazzi la fecero inviperire a furia di stuzzicarla, dicendole che era fidanzato con una ragazza di Oklahoma City; lei se la prese a morte con loro, al punto di
non rivolger loro la parola, e con Joe mantenne un atteggiamento di compassata cortesia. Volle montare a tutti i costi un piccolo cavallo pomellato molto estroso che si impennava e una o due volte la sbalzò di sella. Una notte mandò l’auto a cozzare in pieno contro una cancellata e ridusse i fari in frantumi. Quando papà la rimproverava per tutta quella irrequietezza, lei gli rispondeva che non metteva conto di prendersela, perché, tanto, lei tornava a est a guadagnarsi da vivere e presto l’avrebbe così liberato della sua presenza. Joe Washburn la trattava sempre con la grave gentilezza di una volta, e talora, quando faceva la matta, lei coglieva in quei suoi occhi penetranti un curioso lampo di umorismo e di comprensione che di botto la faceva sentir debole interiormente e sciocca. La sera prima ch’egli partisse, i ragazzi scovarono un serpente a sonagli sul mucchio di macigni dietro il recinto del bestiame, e Figlia sfidò Joe ad afferrarlo e staccargli la testa. Joe corse a prendere un bastone a forcella, prese il serpente con un colpo dietro la testa e lo scagliò con tutta la forza contro il muro del piccolo affumicatolo. Mentre si contorceva sull’erba con la spina dorsale spezzata, Bud gli staccò la testa con una zappa. Aveva sei sonagli e un bottone. «Figlia,» disse Joe marcando le parole e fissandola bene in volto con la sua espressione ferma e sorridente «a volte parli come se non avessi neanche un briciolo di buon senso.» «Tu sei un fifone, ecco che cosa sei» disse lei. «Figlia, sei pazza… adesso chiedi subito scusa a Joe» esclamò Bud, accorrendo rosso in viso col serpente morto in mano. Lei girò sui tacchi, andò in fattoria e si buttò sul letto. Non uscì dalla sua stanza finché Joe non fu partito, la mattina dopo. Una settimana prima di partire per tornare all’università, era buona come il pane, e cercò di rappattumarsi col babbo e i ragazzi cuocendo loro focaccine e accudendo alle faccende di casa, come a scusarsi del comportamento antipatico e pazzoide tenuto durante l’estate. Incontrò Ada a Dallas, e con lei prenotò uno scompartimento nella vettura letto. Aveva sperato che Joe venisse alla stazione a salutarle, ma lui era a Oklahoma City per affari inerenti al petrolio. Durante il viaggio, gli scrisse una lunga lettera per dirgli che quel giorno non sapeva che diavolo l’avesse presa, col serpente a sonagli, e
chiedergli di perdonarla. Quell’autunno Figlia lavorò sodo. Si era iscritta alla scuola di giornalismo, ad onta della disapprovazione di Edwin. Egli avrebbe voluto che studiasse per diventare insegnante o professionista di opere assistenziali, ma lei obiettò che il giornalismo offriva maggiori prospettive. Questo dissenso, più o meno, li allontanò: continuarono a vedersi spesso, ma non parlarono più gran che del loro fidanzamento. C’era un ragazzo di nome Webb Cruthers alla scuola di giornalismo, e Figlia e lui divennero buoni amici, sebbene Ada sostenesse che era un poco di buono e non volesse saperne di lasciarglielo portare in casa. Era più basso di lei, aveva capelli neri e dimostrava circa quindici anni, benché dicesse di averne ventuno. Aveva una pelle bianca come crema che gli aveva fatto affibbiare il nomignolo di Faccia di pupo, e un curioso modo di parlare confidenziale, come se non pigliasse sul serio nemmeno lui quel che diceva. Diceva di essere anarchico e non faceva che parlare di politica e di guerra. Anche lui la portava spesso a East Side, ma con lui c’era più sugo che non con Edwin. Webb voleva sempre entrare in qualche posto a bere qualcosa e scambiare quattro chiacchiere con la gente. La portò in rivendite di liqµori al banco, in birrerie romene e ristoranti arabi, e altri posti che non si era mai neppure sognata. Lui conosceva tutti in tutti gli ambienti, e a quanto pareva riusciva a farsi far credito, perché non aveva quasi mai denaro con sé; e quando se n’erano andati gli ultimi soldi che rimanevano in tasca a lei, Webb si faceva addebitare il resto. Figlia beveva al massimo qualche raro bicchiere di vino, e se lui cominciava a diventare troppo rumoroso lo persuadeva ad accompagnarla alla prima stazione della metropolitana per andare a casa. Poi, l’indomani, lui era un po’ fiacco e tremante, e le raccontava i postumi della sua sbornia e le buffe avventure che gli erano capitate da ubriaco. Aveva sempre in tasca opuscoli sul socialismo e il sindacalismo, e copie di «Mother Earth» o «The Masses». Dopo Natale, Webb si ingolfò in uno sciopero di operai tessili che si stava svolgendo in una città del New Jersey. Una domenica andarono a vedere di che cosa si trattasse. Scesero dal treno a una sporca stazione in mattoni sita in mezzo al quartiere degli affari,
vuoto, c’era poca gente in giro, e quella poca mangiava al banco nei vari locali; chiusi i negozi per la festa: la città non rivelò nulla di speciale, finché non si diressero ai lunghi e bassi edifici in mattone che costituivano le fabbriche. C’erano gruppi di poliziotti in blu, fuori nella larga strada fangosa, e all’interno, di là dalle porte di rete metallica, giovanotti in kaki dall’aria baldanzosa. «Quelli sono inviati speciali, figli di cani» borbottò tra i denti Webb. Andarono al quartier generale degli scioperanti a trovare una conoscente di Webb che faceva propaganda per loro. A sommo di una sudicia scala gremita di stranieri, uomini e donne dalla faccia grigia e dagli abiti stinti, trovarono un ufficio rumoroso di chiacchiere e macchine da scrivere. Il vestibolo era zeppo di mucchi di fogli volanti che un giovane dall’aria stanca distribuiva a pacchi a ragazzi in maglioni laceri. Webb trovò Sylvia Dalhart, una ragazza occhialuta dal naso lungo, che dattilografava a tutto spiano a uno scrittoio ingombro di giornali e ritagli. Lei gli agitò una mano in segno di saluto e disse: «Webb, aspettami fuori. Devo fare da guida ad alcuni giornalisti, e faresti bene a venire anche tu». Fuori, nel vestibolo, incontrarono una conoscenza di Webb, Ben Compton, un giovane alto dal naso lungo e sottile e dagli occhi cerchiati di rosso, il quale disse che avrebbe parlato al comizio e domandò a Webb se non voleva parlare a sua volta. «Gesù, che potrei mai dire a quei compagni? Io non sono altro che un perdigiorno di studente universitario, come te, Ben.» «Di’ loro che i lavoratori debbono conquistare il mondo, di’ loro che questa lotta fa parte di una grande battaglia storica. I discorsi sono la parte più facile del movimento. La verità è abbastanza semplice.» Aveva un modo esplosivo di parlare, con una pausa intercalata tra una frase e l’altra, come se la frase ci mettesse un po’ di tempo a risalire da qualche punto interno e profondo. Figlia, così a occhio e croce, lo giudicò attraente, per quanto fosse probabilmente un ebreo. «Be’, vuol dire che mi proverò a balbettare qualcosa sulla democrazia nell’industria» disse Webb. Sylvia Dalhart li stava già sospingendo per le scale. Aveva con sé un giovane pallido in impermeabile e cappello di feltro nero, che
masticava l’estremità di un mezzo sigaro spento. «Compagni lavoratori, questo è Joe Biglow del “Globe”.» La voce di quella donna aveva una certa ruvidezza occidentale che agli orecchi di Figlia sonava gradita e familiare. «Ora gli faremo da guida.» Girarono tutta la città, entrarono in case di scioperanti dove donne stanche in maglioni rimboccati sino ai gomiti cucinavano magri pasti domenicali di manzo in conserva e cavoli o carne stufata e patate, e in certe case poi avevano semplicemente cavoli e pane o soltanto patate. Poi andarono in un ristorantino presso la stazione a mangiar qualcosa. Il conto lo pagò Figlia, perché a quanto pareva nessuno aveva soldi, ed era tempo di andare al comizio. Il tram era gremito di scioperanti con rispettive mogli e bambini. Il comizio bisognava tenerlo nella città vicina, perché in quella di sede le fabbriche possedevano tutto e non c’era verso di prendere un locale, neanche a pagamento. S’era messo a far pioggia e nevischio, e si bagnarono i piedi camminando nella melma per andare al piccolo edificio di legno in cui si doveva tenere il comizio. Quando giunsero alla porta, vi trovarono davanti la polizia a cavallo. «Il locale è pieno,» disse loro un poliziotto all’angolo della strada «non può più entrar nessuno.» Se ne stettero lì nel nevischio ad aspettare qualcuno che avesse un po’ di autorità. C’erano migliaia di scioperanti, uomini, donne, ragazzi e ragazze, e i più anziani parlavano tra loro a voce bassa in lingue straniere. Webb continuava a dire: «Gesù, questa è una vera provocazione. Qualcuno dovrebbe pur farci qualcosa». Figlia aveva i piedi freddi e una gran voglia di andare a casa. Poi arrivò Ben Compton svoltando dal retro dell’edificio. La gente cominciò a fargli crocchio attorno: «Ecco Ben… ecco Compton, un buon ragazzo, Benny» si sentiva dire. Giovanotti giravano tra la folla bisbigliando: «Irrompete nel comizio… tenete duro». Egli cominciò a parlare attaccandosi a un lampione con un braccio. «Camerati, questo è un altro insulto in pieno viso alla classe lavoratrice. Nel locale non ci sono più di quaranta persone, e loro ci vengono a chiudere le porte e a dire che è pieno…» La folla prese a ondeggiare, su e giù, cappelli e ombrelli ballonzolanti nel piovasco
gelato. Poi Figlia vide che i due poliziotti trascinavan via Ben Compton, e udì lo sferragliare della vettura di polizia. «Vergogna, vergogna» urlava la gente. Cominciarono a retrocedere di fronte ai poliziotti; il flusso della folla tendeva ad allontanarsi dal locale. La gente si avviava quieta e depressa lungo la strada verso la linea tranviaria, incalzata dal cordone di polizia a cavallo. D’improvviso Webb le sussurrò all’orecchio: «Lasciami appoggiare alla tua spalla» e balzò su di un idrante. «Questo è un abuso e una provocazione,» gridò «voi avevate il permesso di usare il locale, l’avevate preso in affitto e nessun potere al mondo ha il diritto di impedirvene l’uso. All’inferno i cosacchi.» Due poliziotti a cavallo trottavano verso di lui, aprendosi un varco tra la folla. Webb smontò dall’idrante e afferrò la mano di Figlia: «Diamocela a gambe» le bisbigliò, e sgattaiolò via confondendosi nella fiumana agitata. Lei lo seguì ridendo e senza fiato. Arrivava un tranvai per la via principale. Webb lo prese al volo, ma lei non vi riuscì e dovette aspettare quello successivo. Frattanto i poliziotti cavalcavano lentamente tra la folla spartendola e disperdendola. A Figlia dolevano i piedi, con tutto lo sgambettare nella melma che aveva fatto quel pomeriggio, e pensava che doveva pur arrivare a casa al più presto se non voleva morir di freddo. Alla stazione, in attesa del treno, vide Webb. Si capiva che era spaventatissimo. Si era tirato il berretto fin sugli occhi e il bavero se l’era rialzato sul mento, e quando Figlia si accostò a lui finse di non conoscerla. Una volta saliti sul treno surriscaldato, egli s’infilò destramente nel corridoio e andò a sederlesi accanto. «Temevo che qualche sbirro mi riconoscesse alla stazione» bisbigliò. «Be’, che te ne pare?» «Una cosa tremenda… sono tutti così fifoni… le sole persone che mi son parse in gamba erano quei ragazzi messi a guardia delle fabbriche, quelli almeno avevan l’aria di sapere il fatto loro… E in quanto a te, Webb Cruthers, sei scappato come una lepre.» «Non parlare così forte… Allora secondo te avrei dovuto star lì e farmi arrestare, non è vero? Come è successo a Ben.» «Be’, in fondo non è cosa che mi riguardi.»
«Tu non capisci la tattica rivoluzionaria, Anne.» Sul traghetto si accorsero entrambi di aver freddo e fame. Webb disse di possedere la chiave della stanza di un suo amico nell’Ottava Avenue: era meglio andar lì a scaldarsi i piedi e farsi un po’ di tè prima di inoltrarsi in città. Camminarono per un bel tratto in un imbronciato silenzio; dall’approdo sino alla meta proposta nessuno dei due aprì bocca. La camera, odorosa di trementina e piuttosto in disordine, era poi un grande studio riscaldato da un fornello a gas. Faceva un freddo da Groenlandia, e così si avvolsero ben bene in coperte, si tolsero scarpe e calze e si abbrustolirono i piedi davanti al gas. Figlia si tolse la gonna sotto la coperta e l’appese sopra il fornello. «Bene, dichiaro che se viene il tuo amico» disse «siamo irrimediabilmente compromessi.» «Ma lui non si sogna nemmeno di venire,» disse Webb «è a Cold Spring a trascorrere il suo weekend.» Webb girava a piedi nudi, per metter l’acqua a bollire e il pane ad abbrustolire. «Faresti meglio a toglierti i calzoni, Webb, li vedo gocciolare di qui.» Webb arrossì e se li tolse, drappeggiandosi nella coperta come un senatore romano. Per un bel po’ non aprirono bocca, e tutto ciò che poterono udire sopra il lontano brusio del traffico cittadino fu il sibilo della fiamma a gas e il brontolio intermittente del pentolino che cominciava a bollire. Poi Webb tutt’a un tratto si mise a parlare in tono concitato, a scatti: «Ah, così tu dici che sono un fifone, vero? Be’, può darsi che tu abbia ragione, Anne… non che me ne importi un accidente… voglio dire, vedi, che certe volte bisogna fare i vigliacchi, e certe altre volte i forti. Adesso sta’ zitta per un minuto, lasciami dire… Tu mi piaci spaventosamente… ed è stato vile da parte mia non dirtelo prima, vedi? Io non credo nell’amore e in tutte le bazzecole del genere, ubbie borghesi; ma penso che quando due persone provano un’attrazione reciproca, penso che è vile da parte loro non… capisci bene quello che voglio dire». «No, Webb, io non la penso così» disse Figlia dopo una pausa. Webb le lanciò un’occhiata imbarazzata e perplessa nel porgerle una tazza di tè e qualche crostino imburrato con un pezzo di formaggio sopra. Mangiarono in silenzio per un po’; c’era una calma
tale che ciascuno dei due sentiva l’altro inghiottire il tè a piccoli sorsi. «Insomma, in nome di Dio, che cosa volevi dire?» sbottò Webb. Figlia si sentiva riscaldata e assonnata nella coperta; con lo stomaco pieno di tè caldo e il secco calore del gas che le lambiva le piante dei piedi. «Guarda un po’, e chi si sogna di voler dire qualcosa?» mormorò trasognata. Webb posò la tazzina e prese a camminare per la stanza, trascinandosi appresso la coperta. «Ssst!» disse improvvisamente nel mettere il piede sopra una puntina da disegno. Stette in bilico su di una gamba guardandosi la pianta del piede incrostata di sporcizia del pavimento. «Ma, Gesù Cristo, Anne… la gente dovrebbe essere libera e felice in fatto di sesso… su, da brava!» Aveva le guance rosse, e i capelli neri, bisognosi dell’opera di un parrucchiere, erano scarruffati. Continuava a stare in bilico su di una gamba e a guardarsi la pianta del piede. Figlia scoppiò a ridere: «Sei tremendamente buffo così, Webb». E si sentì pervadere da un’ondata calda. «Dammi un’altra tazza di tè e fammi qualche altro crostino.» Quand’ebbe avuto tè e crostini disse: «Be’, non ti pare che sia ora di andare?». «Ma Cristo, Anne, io ti sto facendo proposte indecenti» disse lui con voce stridula, mezzo ridendo e mezzo piangendo. «Per l’amor di Dio, dammi retta… Accidenti, ti costringerò ben io a darmi retta, piccola cagna.» Lasciò cadere la coperta e le si avventò addosso. Lei si accorse che era proprio deciso e impegnato con tutte le sue forze. La sollevò dalla sedia e la baciò sulla bocca. La costrinse a una lotta selvaggia, perché era forte e nerboruto, ma lei riuscì a ficcargli l’avambraccio sotto il mento e a respingergli la faccia quel tanto che bastò a mollargli un pugno sul naso, il quale prese a sanguinargli. «Non fare lo sciocco, Webb,» disse lei col fiato grosso «quella roba non mi va, almeno non per ora… va’ a lavarti la faccia.» Lui andò al lavabo e cominciò a bagnarsi il viso. Figlia s’infilò di fretta gonna, scarpe e calze e si accostò al lavabo dove lui si stava lavando la faccia: «È stato crudele da parte mia, Webb, mi spiace tanto. C’è sempre qualcosa che mi spinge a essere cattiva con le persone a cui voglio bene». Per un pezzo Webb non proferì verbo. Gli sanguinava ancora il naso.
«Vattene a casa,» disse «io mi fermo qui… Oh, non è niente… errore mio.» Ella indossò l’impermeabile gocciolante e uscì per le lucide vie serali. Per tutto il tragitto sull’espresso della ferrovia sotterranea provò un senso di calda tenerezza per Webb, come se si fosse trattato di papà o dei ragazzi. Non lo vide più per vari giorni, poi una sera egli telefonò per dirle se voleva venire con lui nelle squadre anticrumiraggio la mattina dopo. Era ancora buio quando si trovarono alla stazione traghetti. Avevano entrambi freddo e sonno, e non si dissero gran che in treno. Dal treno dovettero correre per le vie scivolose, se vollero arrivare alle fabbriche in tempo utile per essere ammessi alle squadre. I volti erano freddi e contratti nella prima luce azzurra. Le donne avevano scialli sulla testa, solo qualcuno degli uomini e dei ragazzi aveva il soprabito. Le fanciulle tremavano tutte nei loro spolverini fantasia di poco prezzo che non giovavano affatto a scaldarle. I poliziotti avevano già cominciato a disperdere la linea delle squadre. Alcuni degli scioperanti cantavano Solidarity Forever, altri gridavano Crumiri! Crumiri! Farabutti! e facevano lunghi e buffi ululati di scherno. Figlia si sentì prendere dalla confusione e dall’eccitazione. D’un tratto intorno a lei si misero tutti a correre abbandonando la linea, e venne così a trovarsi sola in un tratto di via sgombera dirimpetto alla cinta di filo metallico delle fabbriche. Dieci piedi davanti a lei una giovanetta scivolò e cadde. Figlia colse uno sguardo spaventato in quegli occhi rotondi e neri. Si fece avanti per aiutarla, ma due poliziotti la precedettero brandendo gli sfollagente. Figlia credeva che volessero aiutare la ragazza a rialzarsi. Ristette per un secondo immobile come una statua, allorché vide uno dei poliziotti avventare un calcio. Aveva colpito la fanciulla in pieno viso. Figlia non seppe più quello che succedeva, solo che voleva una rivoltella, una rivoltella!, e menava pugni all’impazzata nel faccione rosso del poliziotto e sui bottoni e sulla stoffa pesante del suo cappotto. Qualcosa le calò di peso sul capo da dietro; affranta e in preda alle vertigini si sentì caricare di peso nel furgone della polizia. Davanti a lei c’era la faccia sfondata e sanguinante della ragazza. Nell’oscurità là
dentro c’erano altri uomini e donne imprecanti e ridenti. Ma Figlia e la donna che le stava dirimpetto si guardavano intontite e non dicevano nulla. Poi la porta si chiuse alle loro spalle, e furono al buio. Al processo ella ebbe l’imputazione di ribellione, aggressione proditoria, resistenza a pubblico ufficiale e incitamento alla rivolta. Non si stava male nella prigione della contea. La sezione femminile era gremita di scioperanti, tutte le celle erano piene di ragazze che ridevano e ciarlavano, cantavano e si raccontavano come erano state arrestate, da quanto tempo erano dentro, e come avrebbero senz’altro conseguito una vittoria con quello sciopero. Nella cella di Figlia tutte le ragazze le fecero crocchio attorno e vollero sapere come aveva fatto a capitare lì. Lei cominciò a sentirsi davvero un’eroina. Verso sera la chiamarono, e trovò Webb, Ada e un avvocato attorno al tavolo del sergente di polizia. Ada era fuori dalla grazia di Dio: «Leggi un po’ qui, bamboccia, e dimmi che effetto farà a casa tua, secondo te!» e così dicendo le cacciò sotto il naso un giornale del pomeriggio. LA BELLA DEL TEXAS AGGREDISCE UN POLIZIOTTO, diceva un titolo. Seguiva la cronaca dalla quale risultava come lei avesse atterrato un poliziotto con un sinistro alla mascella. Fu rilasciata dietro cauzione di mille dollari; appena uscita, Ben Compton si staccò di colpo dal gruppo di cronisti in cui si trovava e le corse incontro. «Congratulazioni, signorina Trent,» disse «è stato un gesto veramente forte… ha fatto ottima impressione alla stampa.» Era con lui Sylvia Dalhart, che le gettò le braccia al collo e la baciò: «È stato un atto da gran fegataccio. Senti, noi dobbiamo mandare a Washington una delegazione per presentare una petizione al presidente Wilson, e ti ci vogliamo assolutamente. Il presidente rifiuterà di ricevere la delegazione, e tu avrai l’opportunità di metterti con le squadre attorno alla Casa Bianca e farti arrestare un’altra volta». «Insomma» disse Ada quando furono al sicuro sul treno di New York «te lo dico chiaro: secondo me, tu hai perso la testa.» «Tu avresti fatto lo stesso, Ada cara, se avessi visto quello che ho visto io… quando lo racconterò al babbo e ai ragazzi, ci vedranno rosso. È la cosa più odiosa che abbia mai vista o appresa.» E scoppiò a piangere.
Tornate all’appartamento di Ada trovarono un telegramma di papà, del seguente tenore: “Vengo subito. Non fare nessuna dichiarazione finché non sono arrivato”. A notte tarda giunse un altro telegramma: “Papà seriamente ammalato vieni subito fa procurare Ada miglior avvocato possibile”. La mattina, Figlia spaventata e tremante prese il primo treno per il Sud. A St. Louis ricevette un telegramma che diceva: “Non preoccuparti condizioni buone polmonite doppia”. Sconvolta com’era, le fece senz’altro bene vedere la vasta campagna del Texas, le prime messi di primavera, qualche fiordaliso in fiore. Al deposito bagagli c’era Buster a riceverla: «Be’, Figlia,» disse dopo averle preso i bagagli «hai quasi ammazzato papà.» Buster aveva sedici anni, ed era capitano della squadra calcistica della scuola media superiore. Mentre la conduceva a casa nella Stutz nuova, le disse come stavano le cose. Bud aveva fatto uno sconquasso all’università ed era a un pelo dall’espulsione, e si era messo nei pasticci con una ragazza di Galveston che cercava di ricattarlo. Papà era pieno di grattacapi perché si era compromesso troppo nella questione del petrolio, e il vedere Figlia sbandierata ai quattro venti nelle prime pagine dei giornali per aver atterrato un poliziotto era stato per lui poco meno che il colpo di grazia; la vecchia Emma stava diventando troppo vecchia per poter continuare a dirigere la casa, e toccava a Figlia lasciar perdere quelle sue idee balzane e stare a casa e assumerne le mansioni direttive. «Vedi questa macchina? Non è un amore?… Me la sono comperata io… Ho fatto un po’ di commercio nelle opzioni per conto mio su ad Amarillo, proprio per cavarmi quel gusto, e ho messo insieme cinquemila dollari.» «Ma guarda che ragazzo svelto. Bud, sulla mia parola, fa proprio bene trovarsi a casa. Ma in quanto a quel poliziotto, tu avresti fatto né più né meno come me, altrimenti vuol dire che non sei mio fratello. Una volta o l’altra ti racconterò tutto per filo e per segno. Credimi, fa proprio bene vedere facce del Texas dopo tutti quegli orientali antipatici dalla faccia di martora.» Quando entrarono, il dottor Winslow era nell’atrio. Le strinse le mani con calore e le disse che aveva un aspetto fiorente, e non si preoccupasse, perché ci avrebbe pensato lui a rimettere in sesto
papà, a tutti i costi. La camera del malato e l’inquieta faccia congestionata di papà le comunicarono un tremendo abbattimento, e il fatto che la casa fosse diretta da un’infermiera provetta non le andò affatto a genio. Quando papà cominciò a rimettersi un poco e a fare quattro passi, se ne andarono entrambi a trascorrere un paio di settimane a Port Arthur per cambiar aria, in casa di un vecchio amico del babbo. Papà le disse che le avrebbe regalato un’automobile se rimaneva a casa coi suoi, e che in un modo o nell’altro l’avrebbe cavata fuori da quello stupido impiccio in cui s’era ficcata lassù nel Nord. Lei riprese a giocare a tennis e golf a tutto spiano, e a frequentare la società. Joe Washburn si era sposato e abitava a Oklahoma; si stava arricchendo col petrolio. Lei si sentiva più a suo agio a Dallas quando lui non c’era; il vederlo la sconvolgeva tanto. L’autunno seguente Figlia andò ad Austin a terminare il suo corso di giornalismo, soprattutto perché pensava che la sua presenza colà avrebbe giovato a far rigare dritto Bud. Ogni venerdì pomeriggio tornavano a casa insieme nella sua Buick coperta, a passare il weekend. Papà aveva comperato una casa nuova stile Tudor un po’ fuori mano, e il suo tempo libero lei lo dovette impiegare tutto a scegliere il mobilio e a provvedere all’arredamento. Aveva sempre dattorno un sacco di vagheggini che venivano a portarla in gita, e si vide costretta a tenere un’agenda per gli impegni. Specialmente dopo la dichiarazione di guerra la vita sociale divenne quanto mai agitata e intensa. Lei usciva tutti i momenti e non aveva più tempo per dormire. Tutti quanti venivano chiamati come ufficiali o partivano per i corsi di allievi ufficiali. Figlia si diede a lavorare per la Croce Rossa e organizzò uno spaccio, ma non le bastava, e insistette a far domanda per essere mandata all’estero. Bud andò a San Antonio a seguire un corso di pilotaggio aereo, e Buster, che aveva appartenuto al corpo della riserva, non denunciò la sua vera età, fu arruolato come soldato semplice e inviato alla caserma Jefferson. Allo spaccio, Figlia viveva come in un turbine, e riceveva una o due proposte di matrimonio la settimana, ma rispondeva sempre che non aveva nessuna intenzione di fare la moglie di guerra.
Poi, un bel mattino, venne un telegramma del dipartimento della Guerra. Papà si trovava ad Austin per affari, così lo aperse lei. Bud era precipitato ed era morto. La prima cosa che venne in mente a Figlia fu quanto grave sarebbe stato il colpo per papà. Squillò il telefono: era una chiamata lontanissima, da San Antonio, pareva la voce di Joe Washburn. «Sei tu, Joe?» disse lei debolmente. «Figlia, debbo parlare con tuo padre» rispose la voce grave e cadenzata dell’altro. «So tutto… Oh, Joe!» «Era il suo primo volo da solo. Era un ragazzo magnifico. A quanto sembra, nessuno sa spiegarsi il fatto. Dev’essere stato un difetto di costruzione. Adesso telefono ad Austin. So dove trovarlo… Ho il numero… verrò presto a trovarti, Figlia.» Joe interruppe la telefonata. Figlia andò in camera sua e si cacciò a testa in giù nel letto ancor disfatto. Per un minuto tentò d’immaginare di non essersi ancora alzata, di aver solo sognato lo squillo del telefono e la voce di Joe. Poi pensò a Bud così intensamente che fu come se lui fosse entrato nella stanza: il suo modo di ridere, la forte pressione di quella mano lunga e sottile sulle sue quando aveva afferrato di colpo il volante perché avevano slittato girando un angolo a San Antonio, l’ultima volta che ve lo aveva ricondotto in macchina dopo una licenza, il limpido suo volto ansioso sopra lo stretto colletto kaki della divisa. Poi udì la voce di Joe: Dev’essere stato qualche difetto di costruzione. Scese dabbasso a balzò in macchina. Al rifornitore, dove completò la riserva di olio e benzina, l’addetto le domandò come se la passavano i ragazzi sotto le armi. Non aveva tempo di rispondergli in quel momento. «Oh, se la passano da papi» disse, con una smorfia di sorriso che le fece male come uno schiaffo. Telegrafò a papà nell’ufficio del socio per avvertirlo della sua venuta, e uscì di città in direzione di Austin. Le strade erano in brutte condizioni, le dava un certo senso di sollievo sentir sobbalzare la macchina tra le carraie fangose, e l’acqua spruzzata di colpo da ambo le parti mentre attraversava una pozzanghera a cinquanta all’ora. Mantenne per tutto il percorso una media di quarantacinque, e arrivò ad Austin prima di sera. Papà era già partito in treno per San Antonio. Stanca morta, ripartì a quella volta. Le scoppiò una gomma e
ci volle molto tempo per rimetterla a posto; era ormai mezzanotte passata quando fermò al Menger. Automaticamente si diede una guardata allo specchio prima di entrare. Aveva la faccia inzaccherata di fango e gli occhi rossi. Nell’atrio trovò papà e Joe Washburn seduti l’uno a fianco dell’altro con sigari spenti in bocca. I loro volti si rassomigliavano un po’. Doveva essere quell’espressione grigia e tirata che li faceva rassomigliare. Li baciò tutti e due. «Papà, dovresti andare a letto» disse con animazione. «Mi sembri proprio giù di squadra.» «Forse hai ragione… tanto non c’è più nulla da fare» disse lui. «Joe, tu aspettami, ora metto a letto papà» disse all’altro a voce bassa nel passargli accanto. Salì in camera col babbo, si prese una camera attigua, lo carezzò nei capelli e lo baciò affettuosamente, poi lo lasciò perché si mettesse a letto. Quando ridiscese nell’atrio, trovò Joe seduto allo stesso posto e con la stessa espressione. Le diede ai nervi vederlo così. Si sorprese lei stessa della propria voce aspra e concitata: «Vieni fuori un minuto, Joe, ho voglia di una passeggiatina». La pioggia aveva spazzato l’aria. Era una trasparente notte di prima estate. «Senti un po’, Joe, chi è responsabile delle condizioni di efficienza degli apparecchi? Devo ben saperlo.» «Figlia, che cosa dici mai… ti consiglio di metterti a dormire un po’, sei sovreccitata.» «Joe, rispondi alla mia domanda.» «Ma, Figlia, non vedi che la responsabilità non è di nessuno? L’esercito è una grossa istituzione. Gli sbagli sono inevitabili. Appaltatori d’ogni sorta fanno denari a palate. Qualunque cosa tu possa dire, sta di fatto che l’aviazione è ancora all’infanzia… i rischi li sapevamo pure, prima di arruolarci.» «Se Bud fosse morto in Francia, non mi avrebbe fatto quest’impressione… ma qui… Joe, qualcuno è direttamente responsabile della morte di mio fratello. Voglio andare a parlargli, ecco tutto. Non farò sciocchezze. Voi mi prendete tutti per matta, ma io penso a tutte le altre ragazze che hanno fratelli ai corsi di pilotaggio. L’uomo che ha collaudato quegli apparecchi è un traditore del suo paese e bisognerebbe metterlo al muro come un cane.» «Vedi, Figlia,» disse Joe nel riaccompagnarla all’albergo «adesso siamo in
guerra. Le vite individuali non contano, non è il momento di dare libero sfogo ai tuoi sentimenti personali o intralciare le autorità con critiche. Quando avremo dato agli unni la batosta che si meritano, avremo tutto il tempo di fare i conti con gli incompetenti e i furfanti… ecco come la penso.» «Va bene, Joe, buona notte… sii molto prudente. Quando credi che avrai il tuo brevetto?» «Oh, fra un paio di settimane.» «Come stanno Gladys e Bunny?» «Oh, benone» disse Joe; la sua voce assunse uno strano tono compresso, e lui arrossì: «Sono a Tulsa con la signora Higgins». Lei si mise a letto e ci rimase immobile, sentendosi disperatamente quieta e fredda; era troppo affaticata per dormire. Al mattino andò in rimessa a prendere l’auto. Tastò la sacca all’interno della portiera per accertarsi che ci fosse la sua borsetta con la solita rivoltella dall’impugnatura di madreperla, e si diresse al campo di aviazione. Al cancello la sentinella non voleva lasciarla passare, e così lei mandò al colonnello Morrissey, un amico di papà, un biglietto per dirgli che aveva urgente bisogno di vederlo. Il caporale fu cortesissimo e le porse una sedia nel piccolo ufficio del posto di guardia, e qualche minuto dopo annunciò di aver ottenuto la comunicazione telefonica col colonnello. Essa avrebbe voluto attaccar discorso, ma non riusciva a decidere che cosa dirgli. Vide il tavolo, l’ufficio e il caporale turbinarle davanti, e svenne. Riacquistò i sensi in un’auto militare, accanto a Joe Washburn che la stava riconducendo all’albergo. Le dava colpetti affettuosi sulla mano dicendo: «Ma sì, Figlia, ma sì». Lei gli si aggrappava piangendo come una bambina. La misero a letto in albergo, le somministrarono bromuro, e il dottore non le permise di alzarsi fino a dopo il funerale. Da allora si sparse la voce che fosse un po’ tocca di cervello. Si stabilì a San Antonio. Tutto era gaio e teso. Tutto il giorno lavorava in uno spaccio, e di sera usciva a cenare e a ballare sempre con un nuovo ufficiale di aviazione. Si erano messi tutti a bere come spugne. Era come quando andava ai balli della scuola media; sentiva di muoversi in un vivido barbaglio di tavolini apparecchiati, luci, balli, champagne e facce di diverso colore con identici corpi rigidi di uomini che
danzavano con lei; solo che adesso faceva la monella e si lasciava baciare nei tassì, nelle cabine telefoniche, nei cortili. Una sera incontrò Joe Washburn a un ricevimento offerto da Ida Olsen in onore di certi ragazzi che partivano per il fronte. Era la prima volta che le capitava di veder Joe abbandonarsi al bere. Non era sbronzo, ma si vedeva bene che aveva bevuto a garganella. Andarono a sedersi l’uno accanto all’altra sui gradini della porta di servizio in cucina, al buio. Era una notte tepida e chiara, piena d’insetti, e un forte vento caldo agitava i ramoscelli secchi sugli alberi. D’un tratto essa prese la mano di Joe: «Oh, Joe, è una cosa terribile». Joe si mise a raccontare della sua infelicità coniugale, e di quanto denaro stesse facendo con gli investimenti di petrolio e come non gliene importasse un accidente, e come dell’esercito ne avesse fin sopra i capelli. Lo avevano nominato istruttore e non lo lasciavano andare al fronte, e lì al campo lui si sentiva impazzire. «Oh, Joe, anch’io voglio andare oltremare. Qui faccio una vita così stupida.» «Ti stai comportando in una maniera un po’ sfrenata, Figlia, da quando è morto Bud» rispose la profonda voce cadenzata e tenera di Joe. «Oh Joe, vorrei esser morta» disse lei, e gli appoggiò il capo sulle ginocchia scoppiando a piangere. «Non piangere, Figlia, non piangere» disse lui, poi d’improvviso la baciò. I suoi baci erano duri e folli e la fecero piegare come un fuscello fra le sue braccia. «Non amo nessuno altro che te, Joe» disse improvvisamente calma. Ma lui aveva già ripreso il controllo di sé: «Figlia, perdonami» disse con una calma voce da legale «non so che cosa mi sia successo, devo essere matto… questa guerra ci fa ammattire tutti… Buona notte… Senti… can… cancella tutto questo dalla memoria, per favore». Quella notte non le riuscì di chiudere occhio. Alle sei del mattino salì in automobile, riempì i serbatoi di olio e benzina e partì per Dallas. Era un terso mattino autunnale, con nebbie azzurre nelle conche del paesaggio. Steli secchi di granoturco crepitavano sulle colline gialle e rosse d’autunno. Era tardi quando arrivò a casa. Papà era in piedi, e leggeva le notizie di guerra in pigiama e veste da camera. «Be’, adesso non andrà più per le lunghe, Figlia» disse. «La linea Hindenburg si sta sfasciando. Lo sapevo che i nostri ragazzi ce
l’avrebbero fatta, una volta preso l’aire.» Il volto di papà era più segnato di rughe, e i suoi capelli più bianchi di quanto ricordasse lei. Si scaldò un po’ di minestra in scatola, perché non aveva avuto ancora tempo di mangiare. Fecero una bella cenetta assieme e lessero una buffa lettera che Buster aveva scritto da Camp Merritt, dove il suo reparto attendeva la partenza per l’oltremare. Quando andò a letto nella sua stanzetta, fu come se fosse ancora una bambina, le era sempre piaciuto tanto poter fare quattro chiacchiere a tu per tu con papà in santa pace; si addormentò non appena la testa ebbe toccato il guanciale. Rimase a Dallas e si prese cura di papà; soltanto quando pensava a Joe Washburn, certe volte, sentiva di non poterci stare più nemmeno per un minuto. Venne l’armistizio immaginario e poi quello vero; per una settimana tutti si dettero alla pazza gioia come al Mardi Gras di New Orleans. Figlia si rassegnò decisamente a diventare una zitellona e a curare la casa per papà. Tornò a casa Buster, abbronzatissimo e pieno di gergo soldatesco. Essa prese a frequentare le conferenze della chiesa metodista meridionale, a occuparsi di mansioni chiesastiche, a legger libri della biblioteca circolante, a fare torte paradiso; quando venivano in casa le giovani amiche di Buster, faceva la parte di dama protettrice. Per la festa del Ringraziamento, Joe Washburn e sua moglie vennero a pranzo da loro. La vecchia Emma era malata, così Figlia s’incaricò personalmente di cucinare il tacchino. Fu solo quando si furono tutti seduti a tavola, con le candele gialle accese nei candelieri d’argento e le noci salate disposte nei piccoli vassoi d’argento e la decorazione di foglie d’acero rosa e azzurre, che si ricordò di Bud. Cominciò improvvisamente a sentirsi mancar le forze e si rifugiò di corsa in camera sua. Si distese bocconi sul letto ad ascoltare le voci gravi dei suoi. Joe venne all’uscio a vedere di che si trattava. Lei s’alzò di scatto ridendo, e spaventò incredibilmente Joe baciandolo sulla bocca come se niente fosse. «Sto bene, Joe» disse. «E tu come stai?» Poi corse a tavola e si mise a spargere il buonumore, dimodoché tutti gustarono il loro pranzo. Mentre si bevevano il caffè nell’altra stanza, essa li informò che si era impegnata di andare oltremare con il
Near East Relief, per un periodo di sei mesi, profittando per iscriversi dell’opera di reclutamento che quell’ente aveva svolto alla chiesa metodista meridionale. Papà montò su tutte le furie, e Buster disse che doveva stare a casa, ora che la guerra era finita, ma Figlia rispose che altri avevano dato la vita per salvare il mondo dai tedeschi, e lei quindi poteva ben dare sei mesi per opere di soccorso. Quando disse questo, pensarono tutti a Bud e tacquero. Non era poi vero che avesse effettivamente firmato quell’impegno, ma lo fece il mattino seguente, e s’interessò con buon esito presso la signorina Frazier, una missionaria reduce dalla Cina, che ci aveva le mani in pasta, per farsi mandare a New York quella settimana stessa, con l’ordine di salpare immediatamente: sua prima destinazione fu l’ufficio di Roma. Per tutto il tempo che ci mise a farsi fare il passaporto e la divisa era così eccitata che non notò neppure il muso lungo di papà e di Buster. A New York rimase solo un giorno. Quando la nave si staccò dagli ormeggi ululando con la sirena e prese a scendere il North River, stette sul ponte prodiero coi capelli al vento, annusando il curioso odore di piroscafo, di porto, di oltremare, e le pareva di aver solo due anni.
Cine-giornale XXXII LA VOCE D’ORO DI CARUSO ALEGGIA SULLE FOLLE CITTADINE NEL CANTO DELLA VITTORIA Oh Oh Oh, che bella guerra ma non vorrei fare il soldato, no dal Pic Umbral al versante settentrionale dello Stelvio seguirà il crinale delle Alpi Retiche sino alle sorgenti dell’Adige e dell’Isarco, passando quindi per i monti Reschen e Brennero e le alture di Oetz e Boaller; poi a sud traversando il monte Toblach Non appena è suonata la sveglia ci sentiamo pesanti come il piombo ma non ci alziamo finché non viene il sergente a portarci una tazza di tè a letto IPNOTIZZATO DA UNA COMUNE LEGULEIA le perdite subite dall’esercito assommano a 64.305, con i 318 di oggi; 11.760 sono stati i supremi olocausti in combattimento e 6193 sono i feriti gravi Oh Oh Oh, che bella guerra ma non vorrei fare il soldato, no, oh, che vergogna prendere la paga nei villaggi, nelle case dei contadini, gli americani sono trattati come ospiti alloggiati nelle stanze migliori, e le massaie offrono loro cortesemente i samovar più belli e lucenti, le più belle teiere Le chef de gare il est cocu nei distretti più popolosi una nota spettacolare fu apportata ai festeggiamenti da gruppi di allogeni in costume, e prevalse uno spirito carnevalesco GLI INGLESI ABOLISCONO I SOVIETI Le chef de gare il est cocu qui est cocu? Le chef de gare sa femme elle l’a voulu non c’è motivo di credere che questi funzionari di una solida agenzia d’informazioni che serve giornali di tutto il paese non abbiano
compreso la loro grande responsabilità in un momento di suprema importanza per il popolo di questa nazione. Persino annunciare in anticipo l’avvenimento in una questione di tale portata costituirebbe un grave abuso, del quale i responsabili dovrebbero poi rendere conto Nessuna lagnanza stamattina? Noi ci lagniamo?! Nemmen per sogno! Ma che sono quei pezzi di cipolla che galleggiano nel tè? UNA COLOMBA DI PACE TUTTA IN GIOIELLI DONATA ALLA SIGNORA WILSON e lo spartiacque dei colli di Polberdo, Podlaniscam e Idria. Di qui la linea gira a sud-est verso lo Schneeberg, lascia fuori tutto il bacino della Sava e dei suoi affluenti. Dallo Schneeberg scende verso la costa in modo da includere Castua, Mattuglie e Volosca
Occhio fotografico (38) timbrato firmato e consegnato per tutta Tours odor di tigli in fiore fa caldo la divisa è appiccicaticcia la stoffa grigio oliva mi irrita il collo sotto il mento solo quattro giorni fa me la sono svignata senza permesso strisciando sotto i carri merci alla stazione di Saint-Pierre-des-Corps al buffè aspettavo che il poliziotto militare di guardia levasse gli occhi dalla porta in modo da permettermi di sgattaiolar fuori con una sigaretta in bocca poi in una cameretta d’albergo piccola come una scatola a cambiare la data su quel vecchio foglio di viaggio ma oggi il mio congedo firmato e consegnato mi fa scintille in tasca come un fuoco d’artificio passo accanto al comando del Service of Supply Ehi militare hai il mantello sbottonato (vai a farti fottere caro) e giù per la via ombreggiata di tigli sino ai bagni, dove c’è un cortile con fiori nel mezzo l’acqua calda sgorga verde da teste di cigno d’ottone versandosi nella vasca di metallo bianco mi spoglio completamente mi insapono tutto con l’acre saponetta rosa scivolo nella vasca calda verde cupo attraverso la tendina bianca alla finestra un dito di sole pomeridiano si allunga sul soffitto l’asciugatoio è secco e caldo sa di vapore in valigia ho un abito borghese preso a prestito da uno che conosco l’ultima ruota del carro degli infimi gradi dell’Uncle Sam’s Medical Corps (numero matricolare… ma non riuscii mai a ricordarmelo lo avevo gettato nella Loira) scompare con un gorgoglio e un fischio nel tubo di scarico e dopo aver dato una lauta mancia e strizzato l’occhiolino alla donna grassa che raccoglie gli asciugatoi esco nel profumo di tigli di un pomeriggio di luglio e me ne vado al caffè dove ai tavolini esterni soltanto gli ufficiali possono poggiare sulle sedie le loro natiche in diagonale e mi ordino un cognac proibito a chi veste la divisa mentre aspetto il treno di Parigi e mi assido risolutamente in calzoni lunghi nella seggiola di ferro anonimo borghese
Cine-giornale XXXIII SOSTIENE DI NON RICORDARSI D’AVER UCCISO LA SORELLA Ho la malinconia ho la malinconia ho la malinconia alcoolica SI PROFILA UNA CRISI DEL SAPONE con la gaia luce del sole e la ripresa delle corse ippiche Parigi è rientrata nella sua vita normale. Migliaia e migliaia di bandiere di tutte le nazioni sono appese a dozzine di funi tese di pennone in pennone, con un effetto fantasmagorico invero stupefacente VENGONO ALLA LUCE LETTERE MINATORIE Voglio bene davvero alla mia patria ma questa guerra mi mette il malumore mi piace combattere, sono un combattente ma i combattimenti sono l’ultima cosa in questa partita di guerra la polizia ha trovato un vestibolo ingombro di pacchi misteriosi che all’indagine furono riscontrati pieni di opuscoli in yiddish, russo e inglese, e tessere dell’Internazionale operaia UN FORTE VENTO AUMENTA IL PERICOLO AI NAUFRAGHI MENTRE SI PARLA DI PACE INFURIA UNA GUERRA MONDIALE gli agenti dissero che gli arresti erano ordinati dal dipartimento di Stato. Il passaggio alla detenzione fu così improvviso che nessuno dei due ebbe tempo di farsi consegnare dalla nave il suo bagaglio. Poi venne un lamentoso messaggio di due affaristi di Lure: la partita era giunta a destinazione, i sacchi erano stati aperti e il loro contenuto era costituito da comune gesso da costruzioni. La voluminosa vettura restò capovolta, sospesa fra alcuni alberi, mentre i passeggeri precipitavano nel torrente sottostante da un’altezza di venti piedi Gran Dio, gran Dio, la guerra è un inferno dacché mi ha troncato l’orgia VIOLENZA PERPETRATA A SEOUL
Ho la malinconia alcoooooolica Il Dipartimento della Giustizia Ha in Mano il Bandolo della Matassa Stando al Procuratore Generale Palmer L’École du Malheur Nous Rend Optimistes L’Unione dei Popoli Liberi Impedirà Qualsiasi Esito Iniquo alla Conferenza della Pace di Parigi è chiaro come il sole che la Lega delle Nazioni giace a pezzi sul pavimento dell’Hôtel Crillon, e che la modesta alleanza che ne potrebbe vantaggiosamente prendere il posto è solo un vago abbozzo COME REGOLARSI COI BOLSCEVICHI? FUCILATELI! COME FANNO I POLACCHI! Le Folle di Amburgo Accorrono a Vedere Ford PROSPETTA L’IDEA DI STANZIARE GRANDI FONDI PER LO SVILUPPO DELL’ASIA Quando il sig. Hoover disse di ridurre le razioni io lo feci senza batter ciglio e poi quando disse di ridurre il carbone, ma ora con le sue riduzioni mi intacca anche l’anima Allons-nous Assister à la Panique des Sots? i sassi piovevano sul tetto e spaccavano le finestre, e uomini infuriati urlavano dal buco della serratura, mentre i convenuti stavano trattando questioni di enorme portata che richiedevano calma e ponderatezza, comunque il presidente non parlò ai capi dei movimenti democratici LIEBKNECHT UCCISO MENTRE LO CONDUCEVANO IN CARCERE
Eveline Hutchins Eveline si era trasferita in un posticino in rue de Bussy, dove si teneva giornalmente mercato all’aperto. Eleanor, per dimostrarle che non c’era rancore da parte sua, le aveva dato un paio dei suoi pannelli italiani per ornarne l’oscuro salotto. Al principio di novembre cominciarono a spargersi voci d’armistizio, e poi improvvisamente un bel pomeriggio il maggiore Wood irruppe nell’ufficio di Eleanor ed Eveline, le staccò a forza dai loro tavoli e le baciò entrambe gridando: «Finalmente!». Senza neppur rendersene conto, Eveline a un certo punto baciò il maggiore Moorehouse sulla bocca. L’ufficio della Croce Rossa si trasformò in un dormitorio di collegio quale si presenta la sera di una vittoria calcistica: era l’Armistizio. Di colpo tutti quanti sfoderarono bottiglie di cognac e si misero a cantare There’s a Long Long Trail A-winding o La Madelon pour nous n’est pas sévère. Lei, Eleanor, J.W. e il maggiore Wood erano in tassì, diretti al Café de la Paix. Per qualche ragione imprecisata, essi continuavano a scendere dai tassì e altra gente continuava a salirvi. Dovevano andare al Café de la Paix ma, ogniqualvolta salivano in un tassì, questo veniva bloccato dalla folla e l’autista spariva. Però arrivando trovarono tutti i tavolini occupati e file di gente che ballava e cantava sciamando in frotta in tutte e da tutte le porte. C’erano greci, legionari polacchi, russi, serbi, albanesi in gonnelle bianche, uno scozzese con la cornamusa, e un mucchio di fanciulle in costume alsaziano. Era seccante non poter trovare un tavolo. Eleanor disse che forse era meglio andare in qualche altro posto. J.W. era preoccupato e voleva attaccarsi al telefono. Soltanto il maggiore Wood pareva divertirsi. Era un uomo dai capelli grigi e dai baffetti brizzolati, e continuava a ripetere: «Ah, oggi possiamo sfogarci: è finita, se Dio vuole!». Lui ed Eveline salirono al piano superiore per vedere se c’era posto, e s’imbatterono in due soldati australiani seduti sopra un bigliardo in mezzo a dodici bottiglie di champagne. Senz’altro si misero a trincare con gli
australiani. Non c’era verso di trovar nulla da mangiare, sebbene Eleanor affermasse di morir di fame, e quando J.W. cercò di entrare nella cabina telefonica vi trovò un ufficiale italiano e una ragazza disperatamente avvinti. Gli australiani erano piuttosto ubriachi, e uno di loro diceva che l’armistizio probabilmente non era che un altro trucco di propaganda bugiarda e allora Eleanor propose di tentar di tornare a casa sua per mangiare un boccone. J.W. acconsentì, purché ci si fermasse alla Borsa per consentirgli di spedire certi cablogrammi. Doveva mettersi in contatto col suo agente. Agli australiani la loro partenza diede fastidio, tanto che furono un po’ sgarbati. Per un bel po’ stettero in giro davanti al teatro dell’Opéra in mezzo a folle tumultuose. I lampioni erano accesi; i grigi contorni dell’Opéra si avvivavano lungo i cornicioni di fiamme a gas. I nostri amici erano sospinti in qua e in là dagli ondeggiamenti della marea. Non c’erano autobus, non automobili; di tanto in tanto passavano accanto a un tassì arenato nella folla come una roccia in un torrente. Finalmente in una via laterale si trovarono a portata di mano un’auto della Croce Rossa che non aveva occupanti. L’autista, non del tutto scevro dei fumi del vino, disse che stava tentando di riportare la macchina in rimessa, e prima però li avrebbe condotti al quai de la Tournelle. Eveline stava giusto montando in macchina, quando chissà come ciò le parve troppo faticoso, e dovette rinunciarvi. Un minuto dopo camminava a braccetto con un piccolo marinaio francese in mezzo a un gruppo di persone per lo più in divisa polacca che seguiva una bandiera greca e cantava La Brabançonne. Dopo un altro minuto essa si rese conto di aver perso di vista l’auto e i suoi amici e si spaventò. Non le riusciva neanche di riconoscere le strade, in questa nuova Parigi piena di luci ad arco voltaico, bandiere, bande musicali e gente ubriaca. In un dato momento stava ballando col marinaretto sulla piazza asfaltata dirimpetto alla chiesa con due torri, poi con un ufficiale francese in mantellina rossa, poi con un legionario polacco che parlava un po’ d’inglese e aveva vissuto a Newark, New Jersey, e poi d’un tratto alcuni giovani soldati francesi si misero a ballarle intorno in girotondo, tenendosi per mano. Il gioco era che per rompere l’anello
bisognava baciare uno di loro. Quando lo capì, ne baciò uno e tutti applaudirono e gridarono Vive l’Amérique. Venne un altro gruppo e continuò a danzarle attorno finché lei non cominciò a provare un po’ di paura. Già le girava un poco la testa, quando scorse una divisa americana ai margini della folla. Ruppe l’anello travolgendo un piccolo francese grasso e cadde in braccio all’americano e lo baciò, e tutti risero e applaudirono e gridarono Encore! Lui si mostrò imbarazzato; l’uomo che era con lui era Paul Johnson, l’amico di Don Stevens. «Vedete bene che dovevo pur baciare qualcuno» disse Eveline arrossendo. L’americano rise e parve compiaciuto. «Oh, spero che non ve la siate presa, signorina Hutchins, spero che non ve la prendiate per questa folla e tutto quanto» disse Paul Johnson in tono di scusa. La gente girava loro attorno ballando e vociando, e le toccò baciare anche Paul Johnson perché li lasciassero andare. Lui chiese ancora scusa in tono solenne e disse: «Non è una cosa magnifica essere a Parigi, assistere all’armistizio e tutto, se non si bada alla folla e tutto il resto?… ma ve lo assicuro io, signorina Hutchins, che sono bravissima gente. Niente risse e roba del genere… A proposito, Don è in questo caffè». Don si trovava dietro a un piccolo bar di zinco all’ingresso del caffè e sbatteva cocktail per una gran folla di ufficiali canadesi e australiani, tutti molto sbronzi. «Non posso tirarlo fuori di lì» bisbigliò Paul. «Ne ha bevuto più del necessario.» Tirarono Don via dal bar. A quanto pareva, non c’era lì nessuno a pagare le consumazioni. Sulla porta egli si tolse il berretto grigio e gridò: «Vive les quakers… à bas la guerre!» e tutti applaudirono. Vagabondarono attorno per un po’, di tanto in tanto venivano fermati da un anello di persone che ballavano attorno a lei, e Don la baciava. Era rumorosamente ubriaco, e a lei non piaceva quel suo modo di comportarsi trattandola come la sua ragazza. Quando arrivarono in place de la Concorde lei cominciò a sentirsi stanca e propose di passare il fiume e tentar di guadagnare il suo appartamento, dove c’era in dispensa un po’ di vitello freddo e insalata. Paul stava dicendo tutto imbarazzato che forse era meglio che lui
non venisse, quando Don si staccò dalla comitiva per inseguire un gruppo di ragazze alsaziane che andavano saltellando per gli Champs-Élysées. «Adesso dovete pur venire» gli disse lei. «Per salvarmi dal fastidio di essere troppo baciata da uomini strambi.» «Ma, Miss Hutchins, non dovete credere che Don abbia voluto farvi uno sgarbo scappandosene via a quel modo. È molto eccitabile, specialmente quando beve.» Lei rise di cuore, ed entrambi proseguirono senza dir altro. Quando arrivarono all’appartamento, la vecchia concierge sbucò zoppicando dal suo covo e strinse le mani a tutti e due, «Ah madame, c’est la victoire,» disse «ma mio figlio caduto non risusciterà lo stesso, nevvero?» Per qualche ragione non ben chiara, Eveline non poté fare a meno di darle cinque franchi, e l’altra rientrò mormorando: «Merci, m’sieur, madame». Su nelle stanzette di Eveline, Paul era impacciatissimo. Mangiarono tutto quello che c’era, sino all’ultima briciola di pane raffermo, e conversarono un po’ vagamente. Paul si mise a sedere sull’orlo della seggiola e le parlò dei suoi viaggi avanti e indietro coi dispacci. Disse che cosa meravigliosa era stata per lui venire all’estero e vedere l’esercito e le città europee e conoscere gente come lei e Don Stevens, e sperava che lei scusasse la sua ignoranza riguardo a tutti gli argomenti di cui parlavano lei e Don Stevens. «Se questo è veramente l’inizio della pace, mi chiedo che cosa faremo noi tutti, signorina Hutchins.» «Oh, chiamami Eveline, Paul» «Io credo effettivamente, Eveline, che questa sia la pace secondo i Quattordici punti di Wilson. Ritengo che Wilson stesso sia un grand’uomo ad onta di tutto quello che dice Don, lo so bene che lui è molto più intelligente di me, ma pure… forse questa è l’ultima guerra. Santo Dio, pensaci un po’…» Lei sperava che la baciasse al momento del commiato, ma tutto quello che fece fu di stringerle impacciato le mani e dire tutto d’un fiato: «Spero che non ti dispiacerà se verrò a trovarti la prossima volta che mi troverò a Parigi». Per la Conferenza della pace, J.W. ebbe un appartamento al Crillon, con la sua bionda segretaria signorina Williams pronta a un tavolino in un piccolo atrio, e Morton, il suo cameriere inglese, che gli
serviva il tè nel tardo pomeriggio. A Eveline piaceva dare una capatina al Crillon a pomeriggio avanzato, dopo la passeggiata che faceva lungo i portici di rue de Rivoli uscendo dall’ufficio. Gli antiquati corridoi dell’albergo erano gremiti di americani in perpetuo viavai. Nel gran salone di J.W. c’era Morton che girava con infinita cautela a porgere il tè, e gente in divisa e in frac, e l’aria viziata dal fumo delle sigarette era piena di aneddoti detti a metà. J.W. la affascinava, nel suo vestito di diagonale scozzese grigio che aveva sempre una piega sui calzoni (aveva smesso di portare la divisa di maggiore della Croce Rossa), con quei suoi modi così garbati e distanti, temperati dall’aspetto preoccupato di uomo indaffaratissimo, oberato da continue chiamate telefoniche e da telegrammi o lettere che gli consegnava la segretaria, obbligato ogni tanto a sparire con qualcuno nel vano di una delle finestre prospicienti place de la Concorde per parlar sottovoce, o invitato a entrare un momento dal colonnello House; eppure, quando poi le porgeva un cocktail allo champagne poco prima di uscire tutti assieme per andare a pranzo, le sere in cui non doveva presenziare a qualche cerimonia ufficiale, o le chiedeva se desiderava un’altra tazza di tè, lei si sentiva negli occhi per un istante lo sguardo diretto di due fanciulleschi occhi azzurri dall’espressione curiosa, candida, perfino comica, che la stuzzicava. Provava il desiderio di conoscerlo meglio; e si rendeva pure conto che Eleanor li sorvegliava come fa un gatto col topo. Dopo tutto, continuava a ripetersi Eveline, non ne aveva alcun diritto. Non si poteva dire che tra loro due ci fosse realmente qualcosa. Quando J.W. aveva da fare, uscivano spesso con Edgar Robbins, il quale doveva essere una specie di assistente di J.W. Eleanor non lo poteva soffrire, diceva che vi era un che di offensivo nel suo cinismo, ma ad Eveline piaceva sentirlo parlare. Secondo lui la pace si profilava peggiore della guerra, ed era una vera fortuna che nessuno mai gli domandasse la sua opinione, soggiungeva poi, perché se l’avesse confessata sarebbe certamente andato a finire in galera. Il ritrovo favorito di Robbins era da Freddy, a ridosso di Montmartre. Là passavano le serate seduti nei localetti fumosi e affollati mentre Freddy, che aveva una gran barba bianca alla Walt Whitman, sonava
la chitarra e cantava. A volte si ubriacava e offriva da bere a tutti di tasca sua. Allora sbucava dalla stanza interna sua moglie, una donna scontrosa dall’aspetto di zingara, a gridargli contro. Le persone sedute ai tavoli si alzavano e recitavano lunghe poesie intitolate La Grand’ Route, La Misère, L’Assassinat, o cantavano vecchie canzoni come Les Filles de Nantes. Se si faceva il bis, tutti i presenti battevano le mani a tempo. Questo lo chiamavano dare un aiuto da buoni amici. Freddy finì per accorgersi del gruppo di americani, e quando arrivavano faceva loro un’accoglienza rumorosa: «Ah, les belles Américaines». Robbins se ne stava lì tutto immusonito a bere calvados su calvados, lasciando cadere di quando in quando un commento sugli ultimi avvenimenti della Conferenza della pace. Diceva che quel posto era una montatura, che il calvados era una porcheria e Freddy un vecchio pelandrone sporco, ma chissà perché intanto aveva sempre voglia di tornarci. J.W. ci andò un paio di volte, e talora vi accompagnavano qualche delegato della Conferenza della pace, al quale faceva allora un effettone quella loro profonda conoscenza della vita intima di Parigi. J.W. rimase affascinato dalle vecchie canzoni francesi, ma disse che quel posto lo faceva star sulle spine, e che ci dovevano essere le pulci. A Eveline piaceva osservarlo mentre ascoltava una canzone a occhi semichiusi e capo arrovesciato. Secondo lei Robbins non sapeva apprezzare le ricche potenzialità della natura di quell’uomo, e gli chiudeva sempre la bocca quando attaccava a sgranare un sarcasmo sul grosso formaggio, come lo chiamava. E agli occhi di lei era antipatico che Eleanor si mettesse a ridere di quelle uscite, specialmente considerando la devozione che le manifestava J.W. Quando Jerry Burnham tornò dall’Armenia e constatò che Eveline non faceva che girare con J. Ward Moorehouse, ne fu proprio sconvolto. La condusse a pranzo al Medicis Grill Room, sulla riva sinistra della Senna, e parlò solo di questo. «Ma guarda un po’, Eveline, ti credevo una persona che non si sarebbe lasciata abbindolare da un pallone gonfiato come quello. Quell’individuo non è altro che un megafono della malora… Davvero, Eveline, non è che io mi aspetti di vederti innamorata di me, so
benissimo che di me non t’importa un accidente, e d’altra parte perché dovrebbe importartene qualcosa?… Ma perdio, un maledetto agente pubblicitario poi…» «Vedi, Jerry,» disse Eveline con la bocca piena di antipasto «lo sai che ti voglio bene… Sei semplicemente noioso a parlarmi in questo modo.» «Tu non mi vuoi bene nel modo che piacerebbe a me… ma al diavolo questo argomento!… Vuoi vino o birra?» «Prendi un bel borgogna, Jerry, così ci scaldiamo un po’… Ma tu hai scritto personalmente un articolo su J.W. … L’ho visto ristampato in quella colonna dell’“Herald”.» «Avanti, su, dimmi pure quello che pensi… Cristo, Eveline, te lo giuro che voglio farla finita con questo sporco mestiere e… ma quella era tutta polvere negli occhi, roba vecchio stampo, e credevo che tu avessi tanto buon senso da arrivarci. Caspita, questa è ciò che si dice una buona sogliola.» «Deliziosa… ma, Jerry, proprio tu dovresti avere un po’ più di buon senso.» «Non lo so, credevo che tu fossi diversa dalle altre donne della classe elevata, dato che ti guadagni da vivere e compagnia bella.» «Non litighiamo, Jerry, divertiamoci un po’, guarda, siamo a Parigi e la guerra è finita ed è una bella giornata d’inverno e tutti son qui…» «Guerra finita, ci scommetto un occhio, sì!» ironizzò rudemente Jerry. Eveline si disse che era proprio noioso, e guardò attraverso la finestra il sole rossastro d’inverno e la vecchia fontana medicea e le delicate merlettature viola degli alberi nudi di là dall’alta palizzata di ferro del giardino del Lussemburgo. Poi guardò l’intensa faccia rossa di Jerry con quel suo naso voltato all’insù e i capelli da ragazzo, ricciuti e crespi, che stavano già ingrigiando; si chinò verso di lui e gli batté delicatamente due volte sul dorso della mano. «Capisco, Jerry, tu hai visto cose che io non sognavo neppure… Credo che la colpa sia dell’influsso corruttore che esercita su di me la Croce Rossa.» Lui sorrise e le versò altro vino, dicendo con un sospiro: «Sei la donna più affascinante che abbia mai conosciuto, Eveline…
ma come capita a tutte le donne, ciò che tu adori è la potenza; se sotto forma di denaro, allora è il denaro, se sotto forma di fama, è la fama, e se sotto forma di arte, allora sei una tremenda maniaca dell’arte… Credo di essere anch’io così, solo che mi prendo più in giro.» Eveline strinse le labbra e non disse nulla. D’improvviso si sentì assalita dal freddo, dallo sgomento e dalla solitudine, e non le riuscì più di formulare pensieri traducibili in parole. Jerry tracannò un bicchiere di vino e cominciò a parlare della sua intenzione di dare un calcio al mestiere e andare in Spagna a scrivere un libro. Non che pretendesse di aver rispetto per se stesso; ma coi tempi che correvano, fare il corrispondente di giornale era troppo! Eveline, dal canto suo, non voleva saperne di tornare in America, le pareva di capire che il dopoguerra vi sarebbe stato noiosissimo. Sorbito il caffè, fecero una passeggiata per i giardini. Nei pressi del Senato alcuni signori anziani giocavano a croquet nell’ultima chiazza purpurea di sole pomeridiano. «Oh, questi francesi li trovo proprio meravigliosi» disse Eveline. «Seconda infanzia» mugugnò Jerry. Vagabondarono senza meta per le strade, leggendo cartelloni teatrali giallo-rosa affissi ai chioschi, osservando vetrine di antiquari. «Dovremmo essere tutti e due nei rispettivi uffici» disse Jerry. «Ma io non ci vado» disse Eveline. «Telefonerò e dirò che ho un’infreddatura e che sono venuta a casa per mettermi a letto… E, tra parentesi, lo farò davvero.» «Ma no, giochiamo a hockey e diamoci ai divertimenti!» Andarono al caffè situato dirimpetto a Saint-Germain-des-Prés. Quando Eveline ebbe fatto la sua telefonata, Jerry le offrì un mazzo di viole e ordinò cognac al selz. «Eveline, bagniamo la mia decisione,» disse «credo che cablograferò davvero a quei figli di puttana per annunciare le mie dimissioni.» «E pensi che sia davvero una cosa da fare, Jerry? Dopo tutto è una magnifica opportunità di vedere la Conferenza della pace e tutto quanto.» Qualche minuto dopo lo lasciò e si diresse a casa. Non volle lasciarsi accompagnare. Nel passare davanti alla saletta dove erano stati assieme, guardò dai vetri e vide che stava ordinando ancora da bere. In rue de Bussy il mercato era animatissimo sotto la luce dell’acetilene. Tutto un odore di verdura fresca, burro e formaggio. Si
comprò qualche panino per la colazione del mattino dopo e qualche tartina per l’eventualità che qualcuno venisse a prendere il tè. Si stava bene nel suo salotto biancorosa, al fuoco della carbonella. Si ravvolse ben bene in una coperta da viaggio e si stese sul divano. Dormiva già, quando squillò il campanello. Erano Eleanor e J.W., che venivano a vedere come stava. Quella sera J.W. era libero e voleva portarle con sé all’opera a vedere Castore e Polluce, Eveline disse che si sentiva assolutamente fuori fase, ma che ad ogni modo sarebbe venuta. Mise sul fornello il pentolino del tè e corse in camera da letto a vestirsi. Si sentiva così felice che non poteva fare a meno di canticchiare mentre, seduta al tavolino da toeletta, si guardava allo specchio. Aveva la pelle bianchissima, e nel volto un’espressione calma e misteriosa che le piaceva tanto. Si diede pochissimo rossetto e con la massima cura, e si raccolse i capelli con un nodo sulla nuca; le davano fastidio, quei capelli, non erano ricci e non avevano un colore definito; per un momento le frullò per il capo l’idea di non andare. Poi entrò Eleanor con una tazza di tè in mano a dirle di spicciarsi, perché c’era da uscire e aspettare che lei si vestisse a sua volta, e l’opera cominciava presto. Eveline non aveva un vero mantello da sera, e così dovette mettersi sul vestito da sera una vecchia pelliccia di coniglio. A casa di Eleanor trovarono Robbins che aspettava; portava un abito scuro da mezza sera che addosso a lui sembrava ancor peggio di quanto fosse in realtà. J.W. era in divisa da maggiore della Croce Rossa. Eveline arguì che doveva essersi dato a esercizi fisici, perché la curva della guancia non gli spiccava come prima sul colletto alto e rigido. Mangiarono in fretta da Poccardi e bevvero una quantità di Martini mal fatti. Robbins e J.W. erano in vena, e le fecero ridere di cuore coi loro scherzi. Eveline ora capiva perché lavoravano così bene assieme. All’opera, dove arrivarono tardi, era tutta una meraviglia, uno scintillio di candelabri e divise. Miss Williams, la segretaria di J.W., era già nel palco. Eveline pensò come doveva essere bello lavorare per lui, e per un istante invidiò acerbamente Miss Williams, persino per quei suoi capelli ossigenati e per quella maniera di parlare fredda e vivace. Miss Williams si voltò e disse chinandosi un poco
indietro che avevano perso una scena unica: il presidente Wilson e signora erano appena entrati, accolti da un grande applauso, e c’era anche il maresciallo Foch, e forse anche il presidente Poincaré. Negli intervalli guadagnarono l’affollatissimo ridotto a forza di spintoni. Eveline si trovò a fianco di Robbins, camminò con lui su e giù; ogni tanto scorgeva Eleanor con J.W. e provava un po’ d’invidia. «Lo spettacolo è migliore qui che non sul palcoscenico» disse Robbins. «Perché, non ti piace l’allestimento?… Mi pare che sia una cosa magnifica.» «Be’, da un punto di vista puramente professionale, lo ammetto.» Eveline osservava Eleanor, che veniva presentata in quel momento a un generale francese in pantaloni rossi; era bella stasera, nel suo modo duro e freddo. Robbins tentò di aprire un varco per la comitiva verso il piccolo bar, ma ci rinunciarono, c’era troppa gente in fila davanti a loro. Robbins prese a parlare di punto in bianco di Baku e dell’affare del petrolio. «È proprio da ridere,» continuava a ripetere «mentre noialtri stiamo qui a disputare sotto la direzione del maestro di scuola Wilson, John Bull allunga le mani su tutte le future riserve di petrolio mondiali… giusto per non farle cadere in mano ai bolscevichi. Si son presi la Persia e tutta la marmitta, e adesso son pronto a tagliarmi una mano se non pretendono Baku.» Eveline era seccata, e tra sé pensava che Robbins aveva alzato il gomito un po’ troppo anche questa volta, tanto per cambiare, quando sonò il campanello. Tornati al palco, vi trovarono un uomo dal viso asciutto, non in abito da sera, seduto nella parte posteriore e intento a conversare con J.W. a voce bassa. Eleanor si chinò verso Eveline e le bisbigliò all’orecchio: «Quello è il generale Gouraud». Le luci si spensero; Eveline si accorse di dimenticarsi nella solenne profondità della musica. All’intervallo seguente si chinò verso J.W. per domandargli se gli piaceva. «Magnifico» disse lui, e con sua grande sorpresa essa vide che aveva le lacrime agli occhi. E si mise a parlare di quella musica con J.W. e l’uomo senza abito da sera, che si chiamava Rasmussen. Nell’alto ridotto sovraccarico di stuccature c’era gran folla e faceva un caldo impossibile. Il signor Rasmussen riuscì a far aprire una
finestra, e tutti insieme uscirono su di un balcone che dominava le file serrate di luci affievolentisi lungo la strada in aloni di nebbia rossastra. «Ecco l’epoca in cui mi sarebbe piaciuto vivere» disse J.W. con aria sognante. «La corte del Re Sole?» domandò il signor Rasmussen. «Ah no, nei mesi invernali doveva far troppo freddo, e chissà com’erano infami le tubature.» «Ah sì, era un’epoca gloriosa» disse J.W. come se non avesse neppur udito. Poi si rivolse a Eveline: «Siete sicura di non prender freddo?… dovreste mettervi un mantello, vedete». «Ma come stavo dicendo, Moorehouse,» disse Rasmussen in tono di voce diverso «so da fonte sicura che Baku non possono tenerla senza grossi rinforzi, e soltanto noi possiamo fornirli.» Il campanello squillò ancora, ed essi si precipitarono al loro palco. Dopo lo spettacolo andarono al Café de la Paix a bere un bicchiere di champagne, tranne Robbins che riaccompagnò Miss Williams al suo albergo. Eveline ed Eleanor si misero sul sedile a cuscini ai fianchi di J.W., e il signor Rasmussen in una sedia di fronte. La conversazione la sostenne quasi tutta lui, inghiottendo nervose sorsate di champagne tra una frase e l’altra oppure facendosi passare le dita nei capelli ispidi e neri. Era un ingegnere della Standard Oil. Non faceva che parlare di Baku e Mohommarah e Mosul, di come la compagnia anglo-persiana e la Royal Dutch stessero soppiantando gli Stati Uniti nel Vicino Oriente e tentando di affibbiarci quale mandato l’Armenia, che i turchi avevano saccheggiato sino all’ultimo filo d’erba lasciando soltanto una caterva di gente affamata da nutrire. «Bisognerà pure che li nutriamo, comunque» disse J.W. «Ma santo Dio, amico, si può benissimo fare qualcosa per rimediare, anche se il presidente ha dimenticato gli interessi americani al punto di lasciarsi abbindolare dai britannici in tutto e per tutto; si può provocare la reazione dell’opinione pubblica. Noi siamo sul punto di perdere il nostro primato mondiale nella produzione del petrolio.» «Oh, ma tanto la questione dei mandati non è ancora definita.» «Succederà questo: che gli inglesi presenteranno alla conferenza un fatto compiuto… ius primi occupantis… ma guarda, Baku starebbe meglio in mano nostra o in mano ai francesi.» «Ma… e i russi?» chiese Eveline. «Stando al principio dell’autodecisione i russi
non ne hanno alcun diritto. La popolazione è in maggioranza turca e armena» disse Rasmussen. «Ma perdio, preferisco vedere Baku in mano ai rossi che agli inglesi; certo che poi non dureranno molto.» «No davvero, so da fonte attendibile che Lenin e Trockij si sono divisi e la monarchia verrà ripristinata fra tre mesi.» Finita la prima bottiglia di champagne, il signor Rasmussen ne ordinò un’altra. Quando il caffè si chiuse, a Eveline oramai ronzavano le orecchie. «Facciamo nottata» diceva il signor Rasmussen. Si recarono in tassì a Montmartre, a L’Abbaye, dove c’erano balli e canti e divise dappertutto e ogni cosa era infestonata di bandiere alleate. J.W. chiese a Eveline di concedergli il primo ballo, ed Eleanor si mostrò un po’ imbronciata quando le toccò iniziare la danza fra le braccia del signor Rasmussen, il quale poi ballava malissimo. Eveline e J.W. parlarono della musica di Rameau, e J.W. ripeté che gli sarebbe piaciuto vivere ai tempi della corte di Versailles. Ma Eveline osservò che nulla poteva essere più emozionante di trovarsi a Parigi proprio ora che si stava rifacendo da cima a fondo la carta d’Europa, e J.W. disse che forse aveva ragione. Trovarono entrambi che l’orchestra era troppo cattiva per poterci ballare. Il ballo successivo Eveline lo fece col signor Rasmussen, il quale le disse quant’era carina, e lui aveva bisogno di una buona donna nella sua vita; e la sua vita l’aveva passata tutta nella macchia a grattar la terra in cerca d’oro o a saggiare campioni di schisto, e adesso ne aveva fin sopra i capelli, e se poi Wilson finiva per lasciarsi convincere dagli inglesi, a forza di prepotenza, a mollare in mani loro le future riserve petrolifere mondiali quando la guerra l’avevamo vinta noi americani per loro, bene, allora lui a faceva sopra una croce e piantava baracca e burattini. «Ma non potete far qualcosa in merito, non potete esporre le vostre idee al pubblico, signor Rasmussen?» disse Eveline appoggiandoglisi un poco; a Eveline turbinava in testa un bicchiere di champagne pazzerello. «Questo è affare di Moorehouse, non mio, e dalla guerra in poi non esiste più un pubblico. Il pubblico farà semplicemente quello che gli si dice di fare, e poi, al pari di Dio Onnipotente, è tanto lontano… l’unica cosa da farsi è mettere al corrente della situazione alcuni uomini
investiti di cospicue responsabilità. Moorehouse è la chiave per arrivare agli uomini chiave.» «E chi è la chiave per arrivare a Moorehouse?» chiese irrequieta Eveline. La musica era finita. «Volesse il Cielo che lo sapessi» disse in tono serio e limpido Rasmussen, a bassa voce. «Non sarete mica voi, per caso?» A ciò Eveline scosse il capo con un sorriso a labbra strette sul tipo di quelli di Eleanor. Quand’ebbero mangiato zuppa di cipolle e un po’ di carne fredda J.W. disse: «Andiamo in cima alla salita a farci suonare qualche canzone da Freddy». «Credevo che quel posto non ti piacesse» osservò Eleanor. «Infatti è così, mia cara,» disse J.W. «ma mi piacciono quelle vecchie canzoni francesi.» Eleanor era contrariata e assonnata. Eveline desiderava che lei e Rasmussen andassero a casa; sarebbe stato così interessante parlare a tu per tu con J.W. Da Freddy non c’era quasi nessuno; e dentro faceva freddo. Champagne non ce n’era, e nessuno di loro bevve i liquori ordinati. Il signor Rasmussen disse che Freddy assomigliava a un vecchio cercatore d’oro da lui conosciuto una volta nei monti Sangre de Cristo, e prese a raccontare una lunga storia sulla valle della Morte, che nessuno ascoltò. Avevano tutti freddo, sonno, e poca o punta voglia di parlare, nel ripercorrere Parigi a bordo del vecchio tassì a due cilindri, che puzzava di muffa. J.W. voleva una tazza di caffè, ma evidentemente non c’era nessun locale aperto. L’indomani il signor Rasmussen telefonò a Eveline in ufficio per invitarla a colazione, e lei ebbe un bel daffare a trovare una scusa plausibile per non andarci. E d’allora in poi, a quanto pareva, il signor Rasmussen la seguì dappertutto come un’ombra, mandandole fiori e biglietti per il teatro, presentandosi in automobile per portarla a spasso, inviandole con la posta pneumatica bigliettini pieni di teneri messaggi. Eleanor la prendeva in giro per il suo nuovo Romeo. Poi ricomparve a Parigi Paul Johnson, che si era fatto assegnare ai corsi della Sorbona, e cominciò a presentarsi regolarmente a casa di lei in rue de Bussy nel tardo pomeriggio, per mettersi poi a guardarla in silenzio dalla sua sedia, con aria lugubre. Lui e il signor Rasmussen stavano seduti lì a parlare di frumento e di bestiame mentre Eveline si vestiva per uscire con qualcun altro, di solito Eleanor e J.W. Eveline
constatò che a J.W. faceva sempre piacere averla con sé oltre ad Eleanor, quando uscivano di sera; era semplicemente che a quell’epoca ragazze americane a Parigi ce n’erano poche, diceva a se stessa, e che J.W. ci teneva a farsi vedere con loro due e ad averle con sé quando andava fuori a pranzo con persone importanti. Ora fra lei ed Eleanor correva una schermaglia di rigido e nervoso sarcasmo; solo occasionalmente, quando si trovavano sole tra loro, capitava che parlassero col tono di una volta, facendo assieme belle risate su certe persone e certi fatti. Eleanor non perdeva mai l’occasione di farsi beffe dei suoi Romei. Un giorno si presentò in ufficio suo fratello George con due strisce argentate da capitano sulle spalline. L’uniforme di diagonale gli aderiva come un guanto, aveva i gambali lucidissimi e portava gli speroni. Aveva fatto parte del servizio informazioni collegato agli inglesi, ed era di ritorno dalla Germania, dove aveva prestato mansioni di interprete alle dipendenze del generale McAndrews. Andava a Cambridge a seguire i corsi primaverili, chiamava tutti quanti marci imboscati e fetenti, e il pranzo che gli offrì Eveline a un ristorante lo trovò semplicemente splendido. Quando l’ebbe lasciata, non senza rimproverarle le sue idee poco ortodosse, lei scoppiò a piangere. Quel pomeriggio, mentre usciva dall’ufficio rimuginando cupamente tra sé come George fosse diventato un insopportabile pedante dalla mentalità di ufficiale di carriera, incontrò il signor Rasmussen sotto i portici di rue de Rivoli; aveva un canarino meccanico. Era un canarino impagliato, e lo si caricava dal fondo della gabbia: e allora agitava le ali e cantava. Rasmussen la fermò all’angolo per farglielo ascoltare. «Lo voglio inviare a casa mia ai miei bambini» disse. «Sono separato da mia moglie, ma vogliamo bene tutti e due ai bambini; abitano a Pasadena… Ho avuto una vita molto infelice.» Poi invitò Eveline a entrare al Bar Ritz a prendere un cocktail. Lì c’era Robbins con una giornalista di San Francisco dai capelli rossi. Sedettero tutti assieme a un tavolino di vimini e bevvero quattro Alexanders. Il bar era affollato. «Ma a che pro metter su una Lega delle Nazioni, se poi dev’essere dominata dalla Gran Bretagna e dalle sue colonie?» diceva corrucciato il signor Rasmussen. «Ma non vi pare
che una lega qualsiasi è meglio di nulla?» replicò Eveline. «Non è il nome che si dà alle cose quello che conta, ma chi manovra i fili dietro le quinte.» «Questa è un’osservazione molto cinica» disse la californiana. «Non è proprio il momento di fare del cinismo.» «In questi momenti, anzi,» replicò Robbins «se non fossimo cinici finiremmo per spararci una rivoltellata alla tempia.» In marzo Eveline aveva la sua licenza di due settimane. Eleanor doveva fare una scappata a Roma per interessarsi della liquidazione di quell’ufficio, e così decisero di prendere il treno assieme e andare a passare qualche giorno a Nizza. Avevano un gran bisogno di togliersi dalle ossa il freddo umido di Parigi. Eveline era eccitata come una bambina quel pomeriggio in cui ebbero tutto pronto per partire, comprese le valigie, le prenotazioni per la vettura letto e i fogli di viaggio controfirmati. Il signor Rasmussen insistette per accompagnarle alla stazione, e ordinò al ristorante della Gare de Lyon un gran pranzo che Eveline era troppo agitata per consumare, tra il puzzo del fumo di carbone e il pensiero di risvegliarsi nel paese del sole e del caldo. Apparve Paul Johnson quando erano ormai alla fine, per offrirsi di aiutarle a trasportare i bagagli. Aveva perso un bottone della divisa ed era tutto immusonito e in disordine. Disse che non aveva voglia di mangiare, ma trangugiò nervosamente parecchi bicchieri di vino. Sia lui sia il signor Rasmussen fecero una faccia di nubi temporalesche quando comparve Jerry Burnham, ubriaco da far paura, con un vistoso mazzo di rose. «Ma non è come portar acqua al mare, Jerry?» osservò Eveline. «Tu non conosci Nizza… laggiù avrai probabilmente da pattinare… belle evoluzioni in forma di otto sul ghiaccio.» «Jerry» disse Eleanor con la sua vocina fredda «ma tu stai pensando a St. Moritz.» «Ci penserete anche voi due» disse Jerry «quando sentirete quel bel vento freddo.» Frattanto Paul e il signor Rasmussen avevano preso i bagagli. «A parte gli scherzi, faremo meglio a spicciarci» disse Paul soppesando nervosamente la valigia di Eveline. «È quasi l’ora della partenza.» Si avviarono tutti in fretta per la stazione. Jerry Burnham si era
dimenticato di munirsi di biglietto d’ingresso, e così non poté accompagnarle al marciapiede di partenza; lo lasciarono a discutere coi funzionari e a frugarsi le tasche in cerca della sua tessera di giornalista. Paul collocò i bagagli nello scompartimento e strinse frettolosamente le mani ad Eleanor. Eveline incontrò il suo sguardo, serio e ferito come quello di un cane. «Non starai via molto, vero? Non rimane molto tempo» disse. A Eveline venne voglia di baciarlo, ma il treno ormai partiva. Paul si allontanò a gran passi. Tutto quello che poté fare il signor Rasmussen fu di porgere dal finestrino qualche giornale e le rose di Jerry, e agitare tristemente il cappello dal marciapiede in segno di saluto. Fu un sollievo che finalmente il treno si mettesse in movimento. Eleanor rideva a più non posso, appoggiata con la schiena ai cuscini. «Ma davvero, Eveline, sulla mia parola, sei proprio buffa coi tuoi Romei.» Eveline non poté trattenersi dal ridere anche lei. Si curvò in avanti e diede un colpetto affettuoso ad Eleanor: «Ma sì, pensiamo a divertirci, adesso». Il mattino dopo, quando Eveline si svegliò e guardò dal finestrino, erano nella stazione di Marsiglia. Le fece uno strano effetto, perché lei aveva espresso il desiderio di farvi una sosta per vedere la città, ma Eleanor aveva insistito che si proseguisse direttamente per Nizza, dicendo che non poteva soffrire la sporcizia dei porti di mare. In seguito però, quando andarono a prendersi il caffè nella vettura ristorante, contemplando dal finestrino i pini, le brulle colline e i promontori che ritagliavano azzurri squarci di Mediterraneo, Eveline si sentì riprendere dall’animazione e dalla contentezza. Si fissarono una buona stanza d’albergo e percorsero le strade nel freddo sole tra soldati e ufficiali feriti di tutti gli eserciti alleati, e andarono a spasso per la Promenade des Anglais all’ombra delle palme grigie, e poco per volta Eveline fu assalita da una gelida sensazione di disappunto. Ecco qua, aveva le sue due settimane di licenza e finiva per sciuparle a Nizza. Eleanor invece era sempre vispa e allegra, e propose di sedersi al grande caffè in piazza, dove stava sonando una banda, e sorbirsi un Dubonnet prima di colazione. Dopo
un po’ di tempo che eran sedute lì a guardare le uniformi e gli sciami di donne vestite con chiassosa esuberanza, e che d’altra parte non erano poi nulla di straordinario, Eveline si appoggiò allo schienale della seggiola e disse: «E ora che siamo qui, mia cara, che cosa faremo mai?». L’indomani Eveline si svegliò tardi; e l’idea stessa di alzarsi le ripugnava, perché non sapeva proprio come avrebbe fatto ad ammazzare il tempo, con quella lunga giornata che le si presentava davanti. Mentre se ne stava in letto a guardare le strisce di sole proiettate sul muro dal filtro delle persiane, udì nella camera vicina, quella di Eleanor, una voce maschile. Si tese tutta in ascolto. Era la voce di J.W. Quando si fu alzata e vestita, si accorse che il cuore le batteva forte. Stava infilando il suo miglior paio di calze di seta nera trasparente, quando entrò Eleanor: «Sai chi è venuto? J.W., in automobile, per darmi l’ultimo saluto prima della partenza per l’Italia… Ha detto che l’aria della Conferenza della pace cominciava a diventargli troppo opprimente, e che aveva bisogno di un cambiamento… Vieni, vieni, Eveline cara, prendi il caffè con noi». Non è capace di dissimulare il tono di trionfo; ma guarda un po’ se le donne non sono sciocche, pensò Eveline. «Che bellezza, vengo subito, cara» disse con la sua intonazione più musicale. J.W. indossava un vestito leggero di flanella grigia, con una cravatta blu rilucente, e il suo volto era arrossato per la lunga scarrozzata. Era di ottimo umore. Aveva impiegato soltanto quindici ore a venire da Parigi fin lì, con sole quattro ore di sonno, dopo la cena consumata a Lione. Tutti e tre si bevvero un bel po’ di caffè amaro con latte caldo e progettarono una gita in auto. Era una bella giornata. La grossa Packard li portò liscia e leggera lungo la Corniche. Fecero colazione a Monte Carlo, si recarono al casinò nel pomeriggio e proseguirono per Mentone, dove presero il tè in un tea-room inglese. L’indomani andarono a Grasse e videro le fabbriche di profumi, e il giorno successivo misero Eleanor sul rapido di Roma. J.W. doveva ripartire per Parigi subito dopo. A Eveline parve che l’affilato volto bianco di Eleanor denunciasse un certo desolato sconforto, mentre li fissava dal finestrino della vettura letto.
Quando il treno partì, Eveline e J.W. rimasero lì sul marciapiede nella stazione vuota, col fumo che si arricciolava latteo, intriso di sole, sotto la tettoia di vetro, e si scambiarono uno sguardo impacciato. «È una donnina impagabile» disse J.W. «Io le voglio molto bene» disse Eveline. Nel tono della propria voce avvertì una risonanza falsa. «Come mi piacerebbe che fossimo con lei.» Uscirono dalla stazione per tornare all’auto. «Dove vi posso portare, Eveline, prima di ripartire: all’albergo?» A Eveline il cuore aveva ripreso a martellare. «Be’, che ne direste di fare una colazioncina assieme prima che partiate? Permettetemi di invitarvi a colazione.» «È molto gentile da parte vostra… be’, mi pare che sia una buona idea, in qualche posto debbo pur fare colazione. E tra qui e Lione non c’è nemmeno un posto decente.» Pranzarono al casinò in vista del mare. Il mare era azzurro intenso. Fuori c’erano tre barche da pesca con vele latine, dirette all’imboccatura del porto. Nel ristorante tutto chiuso da invetriate c’era caldo e allegria, odor di vino e cibo cucinato al burro. Eveline cominciava a trovarsi a suo agio a Nizza. J.W. bevve più dell’ordinario. Si mise a parlare della sua fanciullezza trascorsa a Wilmington, e persino a canticchiare parte d’una canzone scritta da lui nei bei tempi. Eveline ne fu deliziata. Poi lui cominciò a parlare di Pittsburgh e delle sue idee in fatto di capitale e lavoro. Come dessert presero pesche al rum; Eveline senza pensarci due volte ordinò una bottiglia di champagne. Procedevano d’incanto. Presero a parlare di Eleanor. Eveline raccontò come avesse conosciuto Eleanor all’istituto d’Arte, e come Eleanor avesse significato tutto per lei a Chicago, essendo l’unica ragazza di sua conoscenza che condividesse realmente i suoi interessi spirituali, e che ingegno aveva, e che abilità affaristica. J.W. raccontò quanto Eleanor avesse significato per lui nei duri anni trascorsi con la sua seconda moglie Gertrude a New York, e come la gente avesse sempre frainteso la loro bella amicizia, che era sempre stata immune dalla sensualità e dalla degradazione. «Per essere sincera» disse Eveline fissando improvvisamente J.W. negli occhi «avevo sempre pensato che voi ed Eleanor foste amanti.»
J.W. arrossì. Per un istante Eveline temette di averlo disgustato. Lui corrugò la pelle attorno agli occhi, in un buffo modo fanciullesco. «No no, parola mia, no… ho sempre avuto troppo da fare col lavoro nella mia vita per sviluppare questo lato della mia natura… La gente ha ora altre vedute in materia.» Eveline annuì. L’intenso rossore che si era diffuso sul viso di lui pareva averle infocato le guance. «E ora» proseguì J.W., crollando tristemente il capo «ho passato la quarantina ed è troppo tardi.» «Ma perché troppo tardi?» Stava lì a guardarlo, le labbra un po’ dischiuse, le guance in fiamme. «Forse ci voleva la guerra per insegnarci a vivere» disse lui. «Ci eravamo attaccati troppo al denaro e alle cose materiali, ci volevano i francesi per mostrarci come si vive. E dove potreste ritrovarla negli Stati Uniti un’atmosfera bella come questa?» J.W. fece un gesto ampio e vago per includere nella sua allusione il mare, i tavoli gremiti di donne vestite a colori sgargianti e uomini in divise inappuntabili, le vivide squame di luce azzurra sui bicchieri e le posate. Il cameriere fraintese quel gesto e astutamente sostituì una bottiglia piena alla bottiglia vuota nel secchiello dello champagne. «Santo Cielo, Eveline, siete stata così cara che mi avete fatto dimenticare l’ora, il ritorno a Parigi e tutto quanto. Era proprio questo che mi era mancato tutta la vita prima di conoscere voi ed Eleanor… certo, con Eleanor è stato tutto su di un piano più elevato. Brindiamo… a Eleanor… la bella, intelligente Eleanor… Eveline, per tutta la mia vita le donne hanno rappresentato per me una grande ispirazione, le donne graziose, affascinanti, delicate. Molte delle mie idee migliori mi son provenute dalle donne, non direttamente, capite, ma attraverso lo stimolo mentale… La gente non mi capisce, Eveline, certi giornalisti in particolare hanno scritto cose molto cattive sul mio conto… Oh bella, ma sono anch’io un vecchio giornalista… Eveline, permettetemi di dirvi che siete tanto affascinante e comprensiva… questa piaga della mia vita… la povera Gertrude… ho paura che non sarà mai più se stessa… Vedete, la cosa mi ha creato una situazione sgradevolissima; se qualche membro della famiglia di lei vien nominato tutore, ciò significherebbe che la cospicua somma investita
dalla famiglia Staple nella mia azienda potrebbe venir ritirata… e questo mi lascerebbe in gravissimi impicci… e poi, ho dovuto abbandonare i miei affari messicani… laggiù per l’industria del petrolio ci vuole una cosa sola, ci vuole che qualcuno spieghi il punto di vista dell’industria stessa al pubblico messicano, al pubblico americano; la mia idea era appunto quella di persuadere le grandi aziende ad accaparrarsi il pubblico…» Eveline gli riempì il bicchiere. Le girava un po’ la testa, ma si sentiva magnificamente. Aveva voglia di chinarsi verso di lui e dargli un bacio, di fargli sentire quanto lo ammirava e lo capiva. Lui continuava a parlare col bicchiere in mano, come se stesse parlando a una seduta plenaria del Rotary Club «… a guadagnarsi la fiducia del pubblico… Dovetti buttare tutto a mare… quando capii che il governo del mio paese aveva bisogno di me. La mia posizione è molto difficile a Parigi, Eveline… hanno circondato il presidente con una muraglia cinese… temo che i suoi consiglieri non capiscano l’importanza della pubblicità, di guadagnarsi ad ogni passo la fiducia del pubblico. Questo è un grande momento storico, l’America è a un bivio… senza di noi la guerra sarebbe finita con una vittoria tedesca o una pace negoziata… E adesso i nostri stessi alleati stanno facendo di tutto per monopolizzare le riserve naturali del mondo alle nostre spalle… Ricordate le parole di Rasmussen… be’, ha perfettamente ragione. Il presidente è circondato da intrighi sinistri. Ma se persino i presidenti dei grossi complessi non si rendono conto che questo è il momento di spendere denaro, di spenderne a profusione! Se mi dessero i mezzi adeguati, io potrei mettermi in tasca la stampa francese nello spazio di un mese, e persino in Inghilterra mi par di capire che si potrebbe far qualcosa se si seguisse un criterio giusto. E poi, il popolo è tutto con noi, in tutti i paesi, è stufo di autocrazia e diplomazia segreta, è pronto ad accogliere a braccia aperte la democrazia americana, i democratici metodi commerciali americani. Il solo modo che abbiamo di assicurare al mondo i benefici della pace è dominarlo. Il signor Wilson non sa la potenza che può esercitare una moderna campagna pubblicitaria scientifica… Già, son tre settimane che sto tentando di ottenere un’intervista con lui!… e dire che a Washington lo chiamavo per nome, a momenti… Fu dietro
sua richiesta personale che con grande sacrificio personale piantai tutto quello che avevo in piedi a New York, portai con me buona parte del mio personale d’ufficio… e ora… ma Eveline, mia cara figliola, temo di starvi annoiando a morte con le mie chiacchiere.» Eveline si curvò verso di lui e gli carezzò la mano appoggiata all’orlo del tavolo. Le brillavano gli occhi. «Oh, è meraviglioso» disse. «Non è una giornata stupenda, J.W.?» «Ah, Eveline, come vorrei esser libero di innamorarmi di te.» «Ma non siamo liberi come allodole, J.W.? E poi, siamo in tempi di guerra… Io ritengo che tutte le pagliacciate convenzionali sul matrimonio eccetera siano proprio noiose, non ti pare?» «Ah, Eveline, se soltanto fossi libero… andiamo a prendere una boccata d’aria… Ma guarda un po’, abbiamo passato qui tutto il pomeriggio.» Eveline insistette per pagare il conto, benché con ciò dovesse vuotarsi le tasche. Nel lasciare il ristorante vacillavano un po’ tutti e due, Eveline aveva un po’ di vertigini e si appoggiò alla spalla di J.W. Lui continuava a carezzarle la mano e a dire: «Ma sì, vuol dire che faremo una bella scarrozzata». Verso il tramonto stavano girando l’estremità della baia in direzione di Cannes. «Bene, bene, dobbiamo riprenderci» disse J.W. «Non vorrai rimanertene qui tutta sola, vero, ragazzina? E se tornassi a Parigi con me? Sosteremmo in certi paesini pittoreschi, ne verrebbe fuori un capolavoro di viaggio. Da queste parti ci sono troppe possibilità di incontrare conoscenti. Rimanderò la macchina militare e noleggerò un’auto francese… non voglio espormi a inconvenienti.» «Ci sto senz’altro, Nizza mi annoia troppo.» J.W. ordinò all’autista di tornare a Nizza. La lasciò all’albergo avvertendola che sarebbe passato a prenderla alle nove e mezza del mattino, e le raccomandò di fare una bella dormita. Dopo che se ne fu andato, essa fu colta da un terribile abbattimento; prese una tazza di tè, inviatole in camera, che era freddo e sapeva di sapone, poi andò a letto. Sdraiata e insonne, andava rimproverandosi in cuor suo di agire come una cagnetta antipatica; ma oramai era troppo tardi per tornare indietro. Non riusciva a dormire, aveva tutto il corpo sbattuto e scosso
da movimenti convulsivi. A questo modo, l’indomani sarebbe stata uno straccio! Si alzò e rovistò la valigia sinché non trovò un po’ di aspirina. Ne ingerì una quantità e tornò a letto, rimanendovi perfettamente immobile; ma intanto continuava a veder facce che si delineavano dalla nebbia di un dormiveglia per poi dileguare nuovamente, e nelle orecchie le ronzavano lunghe cadenze di parole senza senso. A volte era la faccia di Jerry Burnham che sbocciava dalle brume e insensibilmente si tramutava in quella di Rasmussen o Edgar Robbins o Paul Johnson o Freddy Seargeant. Si alzò e si mise a camminare su e giù per un bel pezzo. Poi tornò un’altra volta a letto e si addormentò, e non si svegliò se non quando la cameriera bussò alla porta annunciandole la visita di un signore che l’aspettava. Allorché scese dabbasso, J.W. passeggiava in pieno sole davanti all’ingresso dell’albergo. Sotto le palme, accanto all’aiola di gerani, c’era una lunga e bassa automobile italiana. Presero assieme il caffè a un tavolino di ferro fuori dell’albergo, senza dirsi gran che. J.W. si lagnò della miserabile camera e del servizio che aveva al suo albergo. Non appena Eveline ebbe portato giù la valigia, partirono a sessanta miglia all’ora. L’autista andava come il vento in una tramontana ululante che aumentò d’intensità a misura che si inoltravano per la riviera. A Marsiglia arrivarono intirizziti e incrostati di polvere, giusto in tempo per una tarda colazione in una friggitoria situata al margine del porto vecchio. A Eveline aveva ripreso a girare la testa, tra la velocità, il vento sferzante, la polvere, le vigne, gli olivi e le montagne di roccia grigia che passavano via turbinando, intramezzate di quando in quando da uno squarcio di mare blu ardesia tagliato con la sega. «Dopo tutto, J.W., la guerra è stata tremenda» disse Eveline. «Ma ora è tempo di vivere davvero. Finalmente ricomincia ad accadere qualcosa.» J.W. borbottò tra i denti qualcosa come «un’ondata di idealismo» e continuò a mangiare il suo stufato di pesce e verdura. Oggi, a quanto pareva, non era molto loquace. «Ma da noi» disse «non avrebbero lasciato il pesce pieno di spine a questo modo.» «Be’, e secondo te che piega prenderà la questione del petrolio?» ricominciò Eveline. «E chi ne sa niente?» disse J.W. «È meglio che ci mettiamo
subito in viaggio, se vogliamo arrivare in quel posto prima di notte.» J.W. aveva mandato l’autista a comperare una coperta supplementare, e con lei ci si avviluppò ben bene, sotto il piccolo cappuccio posto nel retro della macchina. J.W. cinse col braccio Eveline e la tirò sotto. «Adesso siamo comodi e beati come una volpe nella tana» disse. Ci fecero sopra un risolino soddisfatto. Il Mistral si era fatto fortissimo e i pioppi erano tutti piegati in due sulla piana polverosa prima che l’automobile abbordasse la sinuosa salita di Les Baux. Prendendo il vento di fronte, calarono forzatamente di velocità. Era già buio quando entrarono nella città in rovina. Erano i due soli ospiti dell’albergo. Faceva freddo, e i ceppi di olivo che bruciavano sulle grate non davano calore, ma soltanto buffi di fumo ogniqualvolta imboccava il camino una raffica di vento; in compenso il pranzo fu eccellente, e con l’aiuto del vino brûlé si sentirono molto meglio. Per andare nella loro camera dovettero mettersi addosso i cappotti. Nel salire le scale J.W. la baciò sotto l’orecchio e sussurrò: «Eveline, bimba mia, tu mi fai risentir fanciullo». Molto tempo dopo che J.W. si fu addormentato, Eveline gli giaceva accanto sveglia, ascoltando il vento che sbatteva le imposte, strillava sugli angoli del tetto, ululava sulla piana deserta in lontananza. L’edificio odorava di freddezza arida e polverosa. Per quanto gli si stringesse contro, non riusciva a scaldarsi sul serio. Lo stesso stridulo carosello di facce, progetti, brani di conversazione seguitava a girarle e girarle in testa, impedendole di pensare con ordine e conseguenza, impedendole di prender sonno. L’indomani mattina, constatando che gli toccava prendere il bagno in un bacile, J.W. fece una faccia curiosa e disse: «Spero che non ti spiaccia di doverti adattare a queste scomodità, bimba cara». Traversarono il Rodano e andarono a far colazione a Nîmes, passando per Arles ed Avignone, poi puntarono di bel nuovo sul Rodano e arrivarono a Lione a notte tarda. All’albergo si fecero mandare la cena in camera e fecero bagni caldi, e bevvero nuovamente il vino brûlé. Quando il cameriere ebbe portato via il vassoio, Eveline si gettò sulle ginocchia di J.W. e si mise a baciarlo tutto. Ci volle un bel po’ di tempo prima che lo lasciasse dormire.
Il mattino dopo pioveva a dirotto. Rimasero ad aspettare un paio d’ore, sperando che cessasse. J.W. era preoccupato e tentò di mettersi in comunicazione telefonica con Parigi, ma senza risultato. Eveline stette seduta nello squallido salone dell’albergo a leggere vecchi numeri dell’«Illustration». Anche lei desiderava ritrovarsi a Parigi. Finalmente poi si decisero a partire. La pioggia si ridusse a una mera acquerugiola, ma le strade erano in pessimo stato, e al calar della notte erano arrivati soltanto a Nevers. J.W. cominciava a starnutire, e si mise a ingerir chinino per sventare un raffreddore. Fissò due stanze comunicanti, con bagno in mezzo, all’albergo di Nevers, dimodoché quella notte dormirono in letti separati. A cena Eveline tentò di fargli dir qualcosa sulla Conferenza della pace, ma egli la interruppe: «Perché parlar d’affari? ci risaremo in mezzo ben presto! Molto meglio parlare di noi stessi e l’uno dell’altra». A misura che si andavano avvicinando a Parigi, J.W. si innervosiva. Il naso gli s’era messo a far muco. A Fontainebleau fecero una colazione veramente buona. Di lì J.W. prese il treno, lasciando all’autista l’ordine di portare Eveline a casa in rue de Bussy e poi consegnare il suo bagaglio al Crillon. A Eveline quella scarrozzata solitaria per i sobborghi di Parigi diede un senso di acuta desolazione. Ricordava l’emozione di alcuni giorni prima, quando erano venuti tutti a salutarla alla Gare de Lyon, e concluse che era davvero molto infelice. Il giorno dopo andò al Crillon nel pomeriggio, circa all’ora solita. Nell’anticamera di J.W. non c’era nessuno ad eccezione di Miss Williams, la sua segretaria. Costei piantò in faccia ad Eveline due occhi così freddi ed ostili che Eveline immediatamente pensò che doveva sapere qualcosa. L’altra le disse che il signor Moorehouse aveva una brutta infreddatura e la febbre e non riceveva nessuno. «Be’, gli lascio un biglietto» disse Eveline. «Anzi, no, gli telefonerò più tardi. Non vi pare che sia meglio così, signorina Williams?» La signorina Williams annuì con un gesto secco. «Molto bene» disse. Eveline indugiava. «Vedete, sono appena rientrata dalla licenza… Sono tornata con due giorni di anticipo perché c’erano molte cose che
volevo vedere nei dintorni di Parigi. E invece, guarda un po’ che tempo infame; non è così?» Miss Williams corrugò pensosamente la fronte e le si avvicinò d’un passo. «Davvero… È una vera sfortuna, signorina Hutchins, che il signor Moorehouse si sia preso questa infreddatura proprio adesso. Abbiamo tante questioni importanti in sospeso. E alla Conferenza della pace la situazione cambia di minuto in minuto, dimodoché c’è bisogno di vigilanza continua… Noi riteniamo che sia un momento delicatissimo sotto ogni punto di vista… È un vero peccato che il signor Moorehouse sia bloccato proprio adesso. Ne siamo tutti assai costernati. E lui poi non ci si può rassegnare, è una cosa terribile per lui.» «Quanto mi dispiace,» disse Eveline «spero davvero che stia meglio domani.» «Il dottore dice di sì… ma ad ogni modo è una sfortuna che non ci voleva.» Eveline rimase perplessa. Non sapeva più che dire. Poi scorse una stelluccia d’oro che Miss Williams portava puntata al petto. Eveline voleva farsi amica la ragazza. «Oh, signorina Williams,» disse «non sapevo che aveste perduto una persona cara.» Alla signorina Williams il viso si fece più glaciale e corrugato che mai. Evidentemente stava cercando di dir qualcosa, con uno sforzo notevole. «Ehm… mio fratello era in marina» disse, e andò a sedersi al tavolino, dove prese a dattilografare molto in fretta. Per un secondo Eveline rimase dove si trovava, osservando le dita di Miss Williams frullare sulla tastiera. Poi disse debolmente: «Oh, quanto mi dispiace», girò i tacchi e uscì. Quando tornò Eleanor, con una quantità incredibile di antico damasco italiano nel baule, J.W. era già in piedi. Ad Eveline parve che Eleanor avesse un tono velato di freddezza e di sarcasmo che non aveva mai avuto prima. Quando andò al tè del Crillon, Miss Williams non le rivolse quasi mai la parola, ostentando invece verso Eleanor una gentilezza particolare. Persino Morton, il cameriere personale, pareva fare la stessa differenza. J.W. di tanto in tanto le dava una stretta di mano furtiva, ma non arrivarono più a uscire soli. Eveline cominciò a pensare al ritorno in America, ma il pensiero di tornare a
Santa Fe o a una fase qualsiasi della sua vita anteriore le riusciva odioso. Ogni giorno scriveva a J.W. lunghe lettere per dirgli quanto si sentisse infelice, ma non ne faceva mai parola quando lo vedeva. Una volta che gli domandò perché non le mandasse mai un rigo, lui rispose in fretta: «Io non scrivo mai lettere personali» e cambiò argomento. Verso la fine di aprile fece la sua ricomparsa a Parigi Don Stevens. Era in abiti civili, perché si era congedato dal reparto addetto alle ricostruzioni. Chiese ad Eveline di dargli alloggio in casa sua perché era al verde. Eveline aveva paura della concierge e di quello che avrebbero potuto dire Eleanor o J.W. se fossero venuti a saperlo, ma d’altra parte era in preda a una disperazione amara, e non le importava gran che di quanto poteva avvenire; dimodoché finì per acconsentire, e gli disse che lo avrebbe alloggiato presso di sé a patto che lui non ne facesse parola con alcuno. Don la prese in giro per le sue idee borghesi, le disse che di tutte queste ubbie si sarebbe fatta piazza pulita dopo la rivoluzione, e la prima prova di forza sarebbe venuta il 1º maggio. Le fece leggere l’«Humanité» e la condusse in rue du Croissant per mostrarle il piccolo ristorante dove era stato assassinato Jaurès. Un giorno venne in ufficio un giovanotto alto, dal viso lungo, in una specie di divisa: era poi Freddy Seargeant, che aveva appena ottenuto un posto nel Near East Relief ed era tutto entusiasta di andare a Costantinopoli. Eveline fu felice di rivederlo, ma quand’ebbe passato con lui l’intero pomeriggio cominciò ad accorgersi che i vecchi argomenti come teatro, decorazione, disegno e colore e forma non le dicevano più gran che. Freddy era incantato di Parigi, e delle barchette con cui i bambini giocavano negli stagni dei giardini delle Tuileries, e degli elmetti della Garde républicaine schierata a salutare il re e la regina del Belgio, che capitò loro di scorgere passando per rue de Rivoli. Eveline era in vena di cattiverie, e lo rimproverò di non essersi saputo conquistare i galloni di ufficiale; lui allora spiegò che un amico lo aveva sistemato a sua insaputa nel servizio mimetizzazioni, e personalmente poi non gliene importava un bel niente della politica, e la fine della guerra e il congedo erano arrivati troppo presto perché
egli potesse far qualcosa. Cercò di far accettare ad Eveline un invito a pranzo, ma lei aveva un misterioso impegno della stessa natura con J.W. e certe persone del quai d’Orsay, e non poteva venire. Eveline andò con Freddy all’Opéra-Comique a vedere Pelléas, ma l’opera le diede ai nervi dal principio alla fine, e in quanto a Freddy, per poco non lo schiaffeggiò alla fine, quando vide che piangeva. Dopo, mentre prendevano un’aranciata al ghiaccio al Café Néapolitain, scandalizzò il povero Freddy col dirgli che Debussy era tutto vecchio ciarpame, tanto che lui aveva un muso lungo una spanna quando la riaccompagnò a casa in tassì. All’ultimo momento lei si rabbonì e si studiò di essere gentile; gli promise di andare in gita con lui a Chartres la domenica prossima. Era ancora buio quando Freddy venne a prenderla, la domenica mattina. Uscirono e sorbirono un po’ di caffè, ancora intrisi di sonno, da una vecchia che teneva una piccola rivendita al numero di fronte. Ci mancava ancora un’ora al treno, e Freddy propose di andare a prendere Eleanor. Aveva tanto accarezzato l’idea di andare a Chartres con tutte e due, soggiunse; sarebbero ritornati i vecchi tempi, la vita faceva di tutto per separarli, ed era una cosa proprio incresciosa. E così presero un tassì e si diressero al quai de la Tournelle. Il busillis era come entrare in casa, perché il portone era chiuso e non c’era portinaia. Freddy si attaccò al campanello e sonò finché il francese che abitava al piano terreno uscì indignato in veste da camera e li fece entrare. Bussarono alla porta di Eleanor. Freddy continuava a gridare: «Eleanor Stoddard, tu adesso ci farai il piacere di saltar giù dal letto e venire con noi a Chartres». Dopo un po’ apparve il volto di Eleanor, freddo, bianco e sostenuto, mostrandosi nell’interstizio della porta in cima a una magnifica vestaglia blu. «Eleanor, ci rimane giusto mezz’ora per prendere il treno per Chartres, il tassì è giù che aspetta a motore acceso, e se non vieni ce ne ricorderemo fino al giorno del Giudizio.» «Ma sono svestita… è così presto!» «Sei tanto carina che puoi venire così come ti trovi.» Freddy entrò di prepotenza e la strinse in un abbraccio. «Eleanor, devi venire
assolutamente… Domani sera io parto per il Vicino Oriente.» Eveline li seguì in sala. Passando davanti all’uscio socchiuso della camera da letto, si trovò a faccia a faccia con J.W. Stava seduto in letto, vestito di un pigiama a strisce azzurre vivide. Lo sguardo dei suoi occhi cerulei la trapassò. Un impulso imprecisato spinse Eveline a chiudere la porta. Eleanor notò quel gesto. «Grazie, cara,» disse allora freddamente «c’è un tale disordine lì dentro!» «Oh, Eleanor, vieni!… dopo tutto non puoi aver dimenticato i vecchi tempi come questa cattiva!» disse Freddy con un piagnucolio suadente. «Fammici pensare» disse Eleanor, stuzzicandosi il mento con l’appuntita unghia del suo bianco indice. «Sapete che idea ho, miei cari? Voi due prendete subito quella vecchia caffettiera d’un treno, dato che siete già pronti, e io mi vesto e mi precipito a chiamare J.W. al Crillon; chissà che non mi ci porti in auto? E poi torniamo tutti insieme. Che ne dite?» «Che bella idea, Eleanor cara!» disse Eveline con voce cantante. «Splendida davvero. Lo sapevo bene che saresti venuta!… Be’, adesso bisogna che ci sbrighiamo. Nel caso che non ci incontrassimo, noi due ci troveremo davanti alla cattedrale per mezzogiorno… Va bene?» Eveline scese le scale come intontita. Per tutto il tragitto fino a Chartres, Freddy l’accusò aspramente di essere assente e di non aver più affetto per i vecchi amici. A Chartres pioveva a dirotto. La giornata che vi trascorsero fu tetra. Le vetrate a colori, tolte durante la guerra per misura di sicurezza, non erano state ancora rimesse a posto. Sotto la pioggia fitta gli alti santi del dodicesimo secolo erano tutti viscidi e grondanti. Freddy disse che la visione della Vergine nera circondata da candele nella cripta lo ricompensava di tutto lo strapazzo del viaggio, ma Eveline non era affatto d’accordo. Eleanor e J.W. non si fecero vedere. «Ma per forza! Con questa pioggia!» li scusò Freddy. Per Eveline fu una specie di sollievo constatare di aver preso un’infreddatura che l’avrebbe obbligata a mettersi a letto non appena tornata a casa. Freddy l’accompagnò in tassì fino alla porta, ma lei non volle lasciarlo salire, temendo che potesse trovare Don in casa.
Don infatti c’era, e fu premurosissimo; le rimboccò ben bene le coperte e le fece una limonata calda al cognac. Aveva le tasche piene di soldi, perché aveva appena venduto qualche articolo, e aveva ottenuto di farsi mandare a Vienna come inviato speciale del «Daily Herald» di Londra. Aveva in mente di partire al più presto dopo il 1º maggio… «ammenoché qui non succeda qualcosa» aggiunse solennemente. Quella sera stessa si trasferì in un albergo, ringraziandola di averlo accolto come un buon camerata anche se non lo amava più. Quando se ne fu andato, l’appartamento dava un senso di vuoto. Eveline quasi si rimproverava di non averlo trattenuto. Rimase a letto in preda alla febbre e alla desolazione, e finalmente si addormentò sentendosi malata, spaurita e sola. La mattina del 1° maggio si presentò Paul Johnson prima ancora che lei fosse alzata. Era in borghese: giovane, simpatico, biondo e avvenente. Disse che Don Stevens lo aveva tutto scombussolato con le sue storie di prossimi sollevamenti e sciopero generale, eccetera; era venuto a passare la giornata da lei se ad Eveline non spiaceva. «Ho pensato che era bene togliersi la divisa, e mi son fatto prestare quest’abito da un amico» spiegò. «Credo che farò sciopero anch’io» disse Eveline. «Dell’ufficio della Croce Rossa ne ho fin sopra i capelli.» «Davvero, Eveline? Che magnifica idea! Così potremo girare un po’ assieme e vedere l’agitazione… Se stai con me non ti succederà nulla… Voglio dire che sarò più tranquillo sapendo dove ti trovi, se ci sono torbidi… Tu sei irrequieta come una puledra, Eveline.» «Dio mio, come stai bene con quel vestito, Paul… Non ti avevo mai visto in borghese.» Paul arrossì e si mise le mani in tasca impacciato: «Santo Cielo, non vedo l’ora di rimettermi in borghese per sempre» disse serio serio. «Anche se questo significa tornare al lavoro… Da questi corsi della Sorbona non cavo niente… Son tutti quanti maledettamente inquieti, ecco cos’è… e io sono stufo di sentirmi dire che i tedeschi sono dei lazzaroni; pare che i galletti francesi non sappiano parlar d’altro.» «Be’, esci dalla stanza e leggiti un libro, io intanto mi alzo… Hai visto se la vecchia di fronte aveva il caffè in vendita?» «Sicuro che l’aveva» gridò Paul dalla sala, dove s’era ritirato nel
momento in cui i piedi di Eveline avevano fatto capolino dalle coperte. «Devo andare a prendertene un po’?» «Che bravo ragazzo sei!… Sì, fallo, io ho qui burro e brioches… prendi dalla cucina il pentolino smaltato.» Prima di cominciare a vestirsi Eveline si guardò allo specchio. Aveva ombre sotto gli occhi e i primi accenni di zampe di gallina. Più freddo dell’umida stanza parigina le venne il pensiero della vecchiaia. Ed era così orribilmente attuale ch’ella scoppiò d’improvviso a piangere. Dallo specchio la guardava amaramente la faccia d’una vecchia strega imbrattata di lacrime. Si premette con forza sugli occhi le palme delle mani. «Oh, che stupida vita faccio!» sussurrò a voce alta. Paul era già di ritorno. Lo sentì muoversi impacciato in sala. «Mi dimenticavo di dirti… Don dice che Anatole France si schiererà coi mutilés de guerre… C’è qui il caffè e latte che ti aspetta.» «Un minuto solo» gli gridò lei in risposta dal bacile, dove si stava sciacquando la faccia con acqua fredda. «Quanti anni hai, Paul?» gli domandò nell’uscir di camera vestita di tutto punto, sorridente e sicura di essere in ottima forma. «Libero come un uccello e ventunenne sono… ma faremmo bene a berci questo caffè prima che si raffreddi.» «Ma non li dimostri affatto, i tuoi anni.» «Oh, quanto a questo lo so ben io, di averli» disse Paul imporporandosi in viso. «Io ho cinque anni di più» disse Eveline. «Ah, se sapessi che rabbia mi fa, l’idea d’invecchiare!» «Ma cinque anni non sono nulla» balbettò Paul. Era così nervoso che si rovesciò una quantità di caffè sui calzoni. «Diavolo, che stordito sono mai!» brontolò. «Te li smacchio in un attimo» disse Eveline correndo a prendere un asciugamano. Lo fece sedere, gli si inginocchiò davanti e gli strofinò col panno la parte interna della coscia. Paul stava lì duro come un pezzo di legno e rosso come un peperone, a labbra strette. Balzò in piedi prima ancora che lei avesse finito. «Be’, usciamo un po’ e andiamo a vedere che cosa succede. Mi piacerebbe tanto saperne qualcosa di più, su tutte queste agitazioni e sulle loro cause.» «Caspita, ma potresti almeno dirmi grazie» disse Eveline alzando
il volto a guardarlo. «Ma davvero, santo Dio, grazie, Eveline, sei stata tanto gentile.» Fuori era come se fosse domenica. Qualche negozio era aperto nelle vie secondarie, ma teneva le saracinesche mezzo abbassate. Era una giornata grigia; imboccarono il boulevard Saint-Germain, frammezzo al solito passeggio elegante. Fu solo quando si videro passare accanto scalpitando uno squadrone della Garde républicaine con gli elmetti lucenti e le piume tricolori che ebbero sentore di atmosfera tesa. Dall’altra parte della Senna c’era più gente, con gruppetti di gendarmi qua e là. A un grosso crocevia videro un crocchio di vecchi in tenuta operaia con una bandiera rossa e questa scritta: L’UNION DES TRAVAILLEURS FERA LA PAIX DU MONDE. Un cordone di guardie repubblicane si lanciò su loro al galoppo con le sciabole sguainate e barbagli di sole sugli elmetti. I vecchi se la diedero a gambe o si addossarono ai portoni. Sui Grands Boulevards compagnie di poilus con copricapo di latta e sudice uniformi azzurre stazionavano attorno a fasci di fucili. La folla li applaudiva, tutto pareva pieno di bonarietà e buonumore. Eveline e Paul cominciarono a sentirsi stufi; era tutta la mattinata che camminavano. Venne loro in mente che bisognava trovare un posto dove far colazione. E poi si stava mettendo a piovere. Davanti alla Borsa incontrarono Don Stevens, che usciva allora dall’ufficio telegrafico. Era scuro e prostrato. S’era alzato alle cinque in punto. «Se devono fare un tumulto, perché non lo fanno in tempo, in modo che si possa cablografare subito?… Be’, ho visto Anatole France caricato in place de l’Alma. Ci sarebbe già di che imbastire un bell’articolo, se non fosse per questa maledetta censura. In Germania la situazione è piuttosto seria… Credo che là succederà qualcosa.» «E qui a Parigi non succederà nulla, Don?» chiese Paul. «E chi ci capisce niente?… Alcuni ragazzi hanno divelto quei graticci posti intorno agli alberi e li hanno scagliati sui poliziotti in rue Magenta… Burnham, che è da quelle parti, dice che ci sono barricate in fondo alla place de la Bastille, ma mi taglio la testa piuttosto di
andarci se prima non ho trovato qualcosa da mettere nello stomaco… Però non ci credo, per parte mia… Non ne posso più. Ma voi due borghesi, che fate in giro in un giorno come questo?» «Ehi, compagno lavoratore, non sparare!» disse Paul alzando le mani. «Lasciaci il tempo di procurar qualcosa da mangiare» rise Eveline. E intanto le veniva fatto di pensare che Paul le andava molto più a genio di Don. Perlustrarono una quantità di vie fuori mano sotto l’acquerugiola insistente, e alfine trovarono un piccolo ristorante dal quale giungevano voci e odor di cibo. Entrarono a schiena curva passando sotto la saracinesca semiabbassata. Dentro c’era poca luce ed era pieno di conducenti d’auto pubbliche ed operai. Si pigiarono tutti e tre all’estremità di un tavolo di marmo dove due vecchi stavano giocando a scacchi. Eveline aveva una gamba stretta contro quella di Paul. Lei non si mosse; e allora lui si fece rosso e spostò un poco la sedia, dicendo: «Scusa». Mangiarono fegato e cipolline, e Don attaccò discorso coi vecchi nel suo cattivo francese disinvolto. Quelli dicevano che i giovincelli d’oggi erano buoni a nulla; una volta, quando in piazza ci scendevano loro, si smottavano i selciati, si acciuffavano i poliziotti per le gambe e li si tirava giù da cavallo. Oggi era uno sciopero generale proclamato, e che cosa avevano fatto?… un bel niente!… quattro gatti di monelli avevano lanciato sassi rompendo una vetrina di caffè. Non era così che la libertà difendeva se stessa e la dignità del lavoro. I vecchi tornarono ai loro scacchi. Don offrì loro una bottiglia di vino. Eveline si appoggiava col busto alla spalliera della sedia, ascoltando solo a metà, e chiedendosi se quel pomeriggio avrebbe finito per andare a trovare J.W. Non lo vedeva da quella domenica mattina, e così pure Eleanor; ad ogni modo non gliene importava nulla. Si chiedeva altresì se Paul l’avrebbe sposata, e che effetto le avrebbe fatto avere una nidiata di pupi dall’aria di puledrini coperti di pelurie, identica a quella del padre. Le piaceva stare in quel ristorantino buio che sentiva di cibo, di vino e di Caporal Ordinaire, appoggiandosi allo schienale della sedia e lasciando che Don pontificasse sulla rivoluzione, rivolto all’attento Paul. «Una volta
tornato in patria credo che gironzolerò un pochettino per il paese, mi troverò lavoro come bracciante o giù di lì e vedrò davvicino come stanno le cose» uscì finalmente a dire Paul. «Per adesso non ne so un bel nulla, so soltanto quello che dice la gente.» Dopo mangiato si stavano centellinando qualche bicchier di vino, quando sentirono una voce americana. Erano entrati due membri della Military Police a bere qualcosa al banco. «Non parlate inglese» bisbigliò Paul. E rimasero rigidi come statue sulle loro sedie, sforzandosi di parer più francesi dei francesi, finché le due divise kaki non furono scomparse; e allora Paul disse: «Che spaghetto!… se mi pescavano in borghese mi prelevavano com’è vero Dio… E allora c’era da andar difilato in rue Sainte-Anne, e addio Parigi». «Eh sì, povero giovane, ti avrebbero certamente fucilato all’alba» disse Eveline. «Corri a casa a cambiarti… In ogni modo io vado alla Croce Rossa per un po’.» Don l’accompagnò in rue de Rivoli, mentre Paul infilava a spron battuto un’altra via per andare in camera sua a mettersi la divisa. «Quel Paul Johnson mi sembra proprio un caro ragazzo; dove l’hai pescato, Don?» disse Eveline con aria casuale. «È un po’ un semplicione… un cucciolotto, una specie di bambinone… Però nulla da dire, è un bravo ragazzo… L’ho conosciuto quando la sua sezione Autieri fu assegnata al nostro settore, alla Marna… Poi ha avuto questo posto che è una vera pacchia, al servizio postale, e adesso studia alla Sorbona… Perdio, ne aveva bisogno… privo com’è di idee sociali… Paul crede ancora che i bambini li porti la cicogna.» «Dev’essere delle tue parti, no?» «Ma sì, suo padre possiede un silo in qualche cittadina di provincia… piccolo borghese… ambiente scemo… Ma non è un cattivo ragazzo, ad onta di ciò… Gran peccato davvero che non abbia letto Marx, avrebbe servito a rinvigorirgli le idee.» Qui Don fece una faccia curiosa. «La stessa cosa vale anche per te, Eveline, ma il tuo caso l’ho dato per disperato da gran tempo ormai. Decorativa ma inutile.» Ora si erano fermati, e stavano parlando sull’angolo della via, sotto l’arcata. «Oh, Don, le tue idee mi sembrano un po’ noiosette» cominciò lei. Egli allora l’interruppe: «Be’, ciao, ecco che viene un autobus…
Non dovrei prendere un lurido autobus, ma di qui alla Bastille c’è troppa strada per farla a piedi». Le diede un bacio. «Non volermene.» Eveline agitò la mano in segno di saluto: «Divertiti a Vienna, Don». Lui saltò a volo sulla piattaforma dell’autobus. Eveline fece in tempo a vedere che l’addetta al controllo cercava di buttarlo giù perché l’autobus era al completo. Salì in ufficio e fece le viste di esserci stata tutto il giorno. Verso le sei imboccò la via che conduceva al Crillon e andò a trovare J.W. Lì tutto era come al solito, Miss Williams al suo tavolino, gelida e coi capelli di stoppa, Morton circospettissimo nella bisogna di porgere ai presenti tè e petits-fours, J.W. immerso in profonda conversazione con un personaggio femminile in cutaway, 1 nel vano della finestra, mezzo nascosto dai grossi drappeggi color champagne, Eleanor in un abito da pomeriggio grigioperla che Eveline non le aveva mai visto, occupata a cinguettare con tre ufficialetti di stato maggiore davanti al caminetto. Eveline sorbì una tazza di tè e scambiò quattro parole con Eleanor su argomenti a caso, poi disse di avere un altro impegno e se ne andò. Nel vestibolo incontrò passando lo sguardo di Miss Williams. Sostò un attimo al suo tavolo: «Indaffarata come sempre, signorina Williams?». «È molto meglio aver sempre da fare» rispose l’altra. «Così si evitano i guai… A Parigi mi sembra che si sciupi gran tempo… Non avrei mai immaginato che ci fosse un posto dove la gente stesse tanto seduta a far nulla.» «I francesi ci tengono alla loro libertà sopra ogni altra cosa.» «La libertà è una bellissima cosa, se si ha come impiegare il proprio tempo libero… ma questa vita di società serve soltanto a farci sprecar tempo… La gente viene a colazione e si ferma tutto il pomeriggio, non si sa proprio come regolarsi… così si viene a creare una situazione difficile.» La signorina Williams diede ad Eveline una occhiata severa. «Credo che voi non abbiate più molto da fare alla Croce Rossa, vero signorina Hutchins?» Eveline fece un sorriso soave: «No, noi non viviamo che per la nostra libertà, come i francesi».
Traversò i vasti asfalti di place de la Concorde, senza saper bene che fare, e prese per gli Champs-Élysées, dove gli ippocastani andavano in fiore. Lo sciopero generale doveva essere quasi finito, perché c’erano in giro dei tassì. Si mise a sedere su di una panchina, e un individuo in frac dall’aria cadaverica le sedette accanto e cercò di attaccar discorso. Lei si alzò e si allontanò di volata. Al Rond-Point, per poter attraversare la strada, dovette aspettare che passasse un reparto di artiglieria francese ippotrainata con due pezzi da settantacinque. L’uomo cadaverico le era accanto; si girò verso di lei e le porse la mano, togliendosi nel frattempo il cappello, come se fosse stato un vecchio amico. Lei borbottò: «Oh, ma che seccatore!» e saltò in una carrozza ferma al marciapiede. Per un attimo credette che salisse con lei anche l’altro, ma quegli non fece che rimaner lì a guardarla tutto ingrugnato, mentre la carrozza partiva sulla scia dei cannoni come se avesse fatto parte del reggimento. Appena a casa, si scaldò un poco di cioccolata e si ficcò a letto con un libro, sola soletta. La sera dopo, tornando a casa, trovò ad aspettarla Paul in divisa nuova e scarpe lucidissime a punta tonda. «Ma guarda un po’, Paul, mi sembri passato attraverso una lavatrice automatica.» «Ho un amico sergente nel magazzino del quartiermastro… e mi ha sganciato una divisa nuova.» «Sei troppo bello perché ti si possa descrivere a parole.» «Vuoi dire che lo sei tu, Eveline, non ti pare?» Se ne andarono ai boulevards a pranzare sui sedili di felpa color salmone tra le colonne pompeiane da Noël Peters, con accompagnamento di melliflue sviolinate. Paul aveva in tasca la paga mensile più l’equivalente in denaro delle razioni spettantigli, e si sentiva come un papa. Parlarono di quello che avrebbero fatto una volta tornati in America. Paul disse che suo papà voleva sistemarlo nell’ufficio di un sensale di grano a Minneapolis, ma lui per parte sua preferiva cercar fortuna a New York. Secondo lui un giovanotto doveva tentare un sacco di cose prima di scegliere un ramo di attività definitivo, in modo da poter individuare le sue vere tendenze. Eveline disse che lei per parte sua non sapeva proprio che cosa ambiva di fare. Una cosa sola sapeva: che non le andava di fare nulla di ciò che aveva
fatto per l’addietro; chissà, forse le sarebbe piaciuto vivere a Parigi. «Prima Parigi non mi piaceva gran che» disse Paul «ma adesso che vengo con te mi va a meraviglia.» Eveline volle stuzzicarlo un po’: «Oh, non ci credo che tu mi voglia bene davvero, sai, non lo dimostri proprio». «Ma santo Cielo, Eveline, tu sai tante cose e hai girato tanto il mondo. È così gentile da parte tua concedermi la tua compagnia, te ne sarò riconoscente per tutta la vita, quant’è vero Dio.» «Ma perché fai così… Non posso soffrire questa mania di fare gli umili» sbottò a dire Eveline irritata. Continuarono a mangiare in silenzio. Mangiavano asparagi con formaggio grattugiato. Paul mandò giù parecchie sorsate di vino e la guardò con un’espressione ferita e tonta che le dava ai nervi. «Oh, stanotte ho voglia di far baldoria» disse lei qualche tempo dopo. «Ho passato una giornata così infelice, Paul… Una volta o l’altra te lo dirò, quello che ho provato… sai, è come quando ti si sgretola fra le dita tutto ciò che desideravi, nell’atto stesso di ghermirlo.» «Benissimo, Eveline,» disse Paul, picchiando il pugno sul tavolo «facciamoci allegria e diamoci alla pazza gioia.» Mentre sorbivano il caffè, l’orchestrina attaccò a sonar polke, e la gente si mise a ballare fra i tavoli, incoraggiata dalle grida del violinista: «Ah, polka». Era un simpatico spettacolo, quello degli avventori di mezza età lanciati nel vortice della danza sotto gli occhi raggianti del massiccio capocameriere italiano, che dicevano chiaramente: «Se Dio vuole ritorna la gaîté, a Parigi!». Paul ed Eveline si obliarono e cercarono di unirsi al ballo. Paul era impacciatissimo, ma essergli tra le braccia era per lei un conforto, le faceva dimenticare quell’agghiacciante senso di solitudine che l’attanagliava. Finita la polka, Paul pagò il nutrito conto, ed uscirono a braccetto, stretti stretti come tutti gli amanti parigini, a passeggiare per il boulevard nella sera di maggio che odorava di vino, tartine calde e fragole selvatiche. Si sentivano la testa leggera. Eveline continuava a sorridere. «Su, che ci divertiremo un mondo» sussurrava ogni tanto Paul come per rialzarle il morale. «Stavo giusto pensando che cosa direbbero i miei amici se mi vedessero passeggiare per il boulevard a braccetto con un soldataccio ubriaco.» «Sulla parola, che non sono
ubriaco» disse Paul. «Sopporto il vino molto più di quanto tu creda. E nell’esercito non ci rimango più molto, specialmente se firmano questo trattato di pace.» «Oh, a me non importa niente,» disse Eveline «non me ne importa niente di quello che succede.» Sentirono sprazzi di musica da un altro caffè e scorsero ombre di ballerini alle finestre del primo piano. «Saliamo lì» disse Eveline. Entrarono e salirono in sala da ballo, un lungo locale pieno di specchi. Eveline disse che desiderava un po’ di vino del Reno. Studiarono a lungo la lista delle vivande, e infine, con una buffa occhiata laterale a Paul, lei propose Liebfraumilch. Paul arrossì: «Vorrei avere una liebe Frau» disse. «Già, ma probabilmente ne hai una… per ogni porto» disse Eveline. Lui crollò il capo. Quando poi ripresero a ballare, lui la tenne molto stretta. Non mostrava più l’imbarazzo di prima. «Sapessi come mi sento sola, in questi giorni» disse Eveline quando si rimisero a sedere. «Come? tu, sola, con la Conferenza della pace al completo che ti corre appresso, per non parlare dell’esercito americano?… Già, Don mi ha detto che sei una donna pericolosa.» Eveline fece spallucce: «E quando ha avuto modo di accorgersene, Don? Chissà che non sia pericoloso anche tu, Paul». Al ballo seguente essa appoggiò la guancia a quella di lui. Quando la musica cessò, pareva che lui stesse per baciarla, ma non lo fece. «Questa è la più bella serata della mia vita» disse «e vorrei davvero essere il tipo di cui desideravi la compagnia.» «E chissà che non arrivi ad esserlo, Paul… a quanto pare stai facendo progressi, impari in fretta… No, ma noi ci stiamo comportando da sciocchi… non posso soffrire le smancerie e i flirt… forse sono io che voglio l’impossibile, la luna in terra… forse invece voglio sposarmi e avere un bambino.» Paul era impacciato. Stettero seduti in silenzio ad osservare gli altri ballerini. Eveline vide un giovane soldato francese chinarsi a baciare sulle labbra la sua piccola compagna; e così baciandosi, i due proseguivano la danza. Eveline avrebbe voluto essere quella ragazza. «Prendiamo un altro po’ di vino» disse a Paul. «Credi che vada bene?» «Ma sì, che diavolo, non abbiamo detto che ci vogliamo dare alla pazza gioia?»
Salendo in tassì Paul era sbronzo anzichenò, rideva e l’abbracciava. Non appena furono nel buio dell’interno, nella parte posteriore della macchina, cominciarono a baciarsi. Eveline per un minuto gli resistette. «Andiamo a casa tua, è meglio» gli disse. «Ho paura della mia portinaia.» «Va bene… la mia camera è piccola da far pietà» disse Paul ridacchiando. «Ma caspiterina, bisogna pur trovare il modo.» Passati sotto le forche caudine dello sguardo inquisitore del custode all’albergo di Paul, salirono barcollando una lunga, fredda scala a chiocciola per entrare in una cameretta che dava sul cortile. «È una vita da papi, purché tu non ne rimanga indebolita» disse Paul agitando le braccia quand’ebbe chiuso a chiave la porta. Aveva ricominciato a piovere, e la pioggia faceva un rumore di cascata sulla tettoia di vetro che c’era in fondo al cortile. Paul gettò in un angolo il copricapo e la mantellina e si avvicinò a lei, gli occhi lucenti. Si erano appena messi a letto che lui si addormentò con la testa sulla spalla di lei. Essa sgattaiolò fuori dal letto per spegnere la luce e aprire la finestra, e poi si rannicchiò tremando contro il suo corpo, che era caldo e rilasciato come quello di un bambino. Fuori, la pioggia batteva a torrenti sulla tettoia di vetro. Chiuso in qualche punto dell’edificio, un cucciolo guaiva e uggiolava disperatamente senza sosta. Eveline non riusciva a prender sonno. Qualcosa chiuso dentro di lei piangeva come il cucciolo. Dalla finestra cominciò a distinguere un nero comignolo e una selva di camini contro il cielo di un violetto che sbiadiva. Finalmente si addormentò. La giornata dopo la passarono assieme. Lei aveva telefonato alla Croce Rossa che stava male come al solito, e Paul dal canto suo lasciò perdere la Sorbona. Stettero seduti tutta mattina nel fioco sole a un caffè presso la Madeleine, a far progetti sull’avvenire. Si sarebbero fatti rimandare a casa al più presto possibile, avrebbero trovato lavoro a New York e si sarebbero sposati. Paul avrebbe approfittato dei ritagli di tempo per studiare ingegneria. Gli era facile trovar posto presso una ditta di commercianti di grano e cibarie di Jersey City, amici di suo padre. Eveline poteva riaprire la sua impresa di arredi e decorazioni. Paul era contento e fiducioso, e si era liberato di quella sua maniera timida, di quel suo bisogno di chieder sempre scusa.
Eveline dentro di sé si andava ripetendo che Paul aveva stoffa, che lei era innamorata di Paul, che da Paul ci si poteva aspettare qualcosa di buono. Per il resto del mese di maggio continuarono a fare un po’ i leggeroni. Spesero tutta la paga nei primi giorni, dimodoché si dovettero adattare a mangiare a un ristorantino a prezzo fisso, affollato di studenti, operai e impiegatucci, dove si acquistavano blocchetti di scontrini che davano diritto ciascuno a un pasto per due franchi o due e cinquanta. Una domenica di giugno andarono a SaintGermain a fare una passeggiata nella foresta. Eveline aveva accessi di nausea e debolezza e dovette sdraiarsi molte volte sull’erba. Paul era preoccupatissimo. Finalmente raggiunsero un piccolo abitato sulla riva della Senna. La Senna scorreva veloce, striata d’azzurro e lilla, nella luce pomeridiana, lambendo gonfia le basse sponde orlate da filari di grandi pioppi. Passarono il fiume in un piccolo traghetto condotto da un vecchio che Eveline battezzò Padre Tempo. A metà strada lei disse a Paul: «Sai che cosa ho, Paul? Debbo avere un bambino». Paul emise un fil di voce: «Ah! questa non l’avevo prevista… Sì sono stato un bel manigoldo a non sposarti prima che avvenisse… Ci sposeremo sui due piedi. Mi interesserò di sapere che pratiche bisogna fare per ottenere il permesso di sposarsi, nel corpo di spedizione. In fondo va tutto bene, Eveline… ma caspita, mi cambia tutti i progetti». Avevano raggiunto l’altra riva, e attraversando Conflans si diressero alla stazione ferroviaria per prendere il treno di Parigi. Paul era impensierito. «Ebbene, non ti sembra che la cosa cambi anche i miei progetti?» disse seccamente Eveline. «È come scendere per le cascate del Niagara in un barile, ecco che cosa è.» «Eveline,» disse Paul serio serio con le lacrime agli occhi «che cosa vuoi che faccia per compensarti di tutto?… credimi, farò del mio meglio.» Il treno fischiò e giunse rombando. Erano così assorti nei loro pensieri che quasi non lo videro. Saliti in uno scompartimento di terza classe, sedettero a busto eretto l’uno di faccia all’altra, a contatto di ginocchia, guardando dal finestrino senza vedere i sobborghi di
Parigi, senza scambiare una parola. Finalmente Eveline disse con un nodo alla gola: «Il marmocchio lo voglio, Paul, dobbiamo affrontare e superare tutto». Paul annuì. Poi lei non poté più vedergli il volto. Il treno aveva infilato una galleria. 1. Abito attillato alla vita. (NdT)
Cine-giornale XXXIV IL MONDO INTERO A CORTO DI PLATINO Il serait Criminel de Négliger Les Intérêts Français dans les Balkans SI UCCIDE IN CELLA l’ultima quotazione mensile della United Cigar Stores, pari a dollari 167 per azione, significa 501 dollari per azione sul capitale iniziale, di cui gli attuali azionisti percepiscono il 27% su ogni azione, come per l’addietro. In pace e in guerra l’azienda ha mantenuto e accresciuto i suoi dividendi SEI PERSONE INTRAPPOLATE AL PIANO SUPERIORE E come farete a tenerli legati alla campagna dopo che han visto Parigi? Se Wall Street avesse bisogno del trattato, vale a dire se gli interessi commerciali della nazione desiderassero propriamente sapere sino a qual punto ci si sta compromettendo in questioni che non ci riguardano, perché mai dovrebbe prendersi il fastidio di corrompere tutta quella marmaglia di satelliti che forma il seguito del signor Wilson a Parigi? GLI ALLEATI INCITANO IL POPOLO MAGIARO A ROVESCIARE IL REGIME DI BÉLA KUN UN NUOVO BARBABLÙ: UNDICI DONNE SCOMPARSE Enfin la France Achète les stocks Américains Come farete a tenerli lontani da Broadway dal far chiasso e baldoria per tutta la città? nel pomeriggio i boulevards avevano un aspetto insolito. Le terrazze dei caffè erano per lo più deserte e sgombere di sedie e tavolini. In certi caffè i clienti furono ammessi uno per volta e serviti da camerieri fedeli, che però si erano tolti i grembiuli UNA PICCOLA POSSIDENTE INVOCA CON ALTE GRIDA IL SUO EX PRETENDENTE MENTRE TENTA DI UCCIDERSI IN UNA CASA AUTOMOBILE LE ASPIRAZIONI DELL’HEGGIAZ SUSCITANO CRITICHE A
PARIGI al fine di non scoprire anzitempo le batterie, si finge di sciogliere alcune formazioni; ma in realtà queste truppe vengono trasferite con armi e bagagli a Kolcˇak L’INTERNAZIONALE COMUNISTA PARTECIPA A UN COMPLOTTO PER ATTENTARE ALLA VITA DI WILSON Trovano diecimila sacchi di cipolle andate a male UN CITTADINO FACOLTOSO MUORE PER UNA CADUTA DALLE SCALE il tempo nebbioso celò alla vista la cannoniera appena ebbe lasciato la banchina, ma il presidente seguitò ad agitare il cappello e a sorridere mentre l’imbarcazione si dirigeva verso la George Washington IL CROLLO DEL REGIME SOVIETICO È SICURO
La dinastia Morgan Affido l’anima mia al mio salvatore, scrisse John Pierpont Morgan nel suo testamento, pienamente sicuro che, dopo averla redenta e lavata del Suo preziosissimo sangue, Egli la presenterà immacolata al cospetto del mio padre celeste, e supplico i miei figli di preservare e difendere a qualsiasi costo e a rischio di qualunque sacrificio la benedetta dottrina della totale espiazione del peccato mediante il sangue di Gesù Cristo una volta versato, e mediante quello solo, e alla dinastia Morgan rappresentata da suo figlio, egli affidò, morendo a Roma nel 1913, il controllo degli interessi Morgan a New York, Parigi e Londra, quattro banche nazionali, tre compagnie consorziate, tre compagnie di assicurazione sulla vita, dieci complessi ferroviari, tre compagnie tranviarie, una compagnia espressi, la marina mercantile internazionale, il potere, basato sul principio dei bracci convergenti, mediante direttorati collegati, sopra diciotto altre ferrovie, la U.S. Steel, la General Electric, l’American Tel and Tel, cinque grandi industrie; i cavi intrecciati del complesso Morgan-Baker-Stillman controllavano il credito come un ponte sospeso, il tredici per cento delle riserve bancarie mondiali. Il primo a far fortuna dei Morgan fu Joseph Morgan, un albergatore di Hartford, Connecticut, che organizzò linee di diligenza e acquistò le azioni della Aetna Life Insurance in un momento di panico provocato da uno dei grandi incendi di New York sugli anni intorno al 1830; suo figlio Junius seguì le sue orme, prima nel commercio delle derrate secche, poi come socio di George Peabody, un banchiere del Massachusetts che costituì a Londra una enorme impresa di sottoscrizioni e affari e divenne amico della regina Vittoria; Junius sposò la figlia di John Pierpont, un predicatore di Boston,
poeta, eccentrico e abolizionista; e il loro figlio maggiore, John Pierpont Morgan venne a New York a far fortuna dopo essere stato educato in Inghilterra, aver frequentato la scuola di Vevey, essersi dimostrato un matematico di prim’ordine all’università di Gottinga, giovane ventenne smilzo e lunatico, proprio in tempo per il panico del 1857. (Guerra e crolli in Borsa, fallimenti, prestiti di guerra, il clima che ci voleva per favorire lo sviluppo della dinastia Morgan.) Quando i cannoni cominciarono a tuonare a Fort Sumter, il giovane Morgan investì un po’ di denaro nel rivendere all’esercito nordista moschetti fuori uso, e cominciò a farsi sentire nella camera dell’oro nel quartiere degli affari di New York; metteva più conto commerciare in oro che non in moschetti; e per la guerra di Secessione, nient’altro da dire. Durante la guerra franco-prussiana Junius Morgan varò a Tours un grande prestito obbligazionario al governo francese. Contemporaneamente il giovane Morgan si batteva contro Jay Cooke e i banchieri ebreo-tedeschi di Francoforte per la conversione del debito di guerra americano (non gli andavano a genio né i tedeschi né gli ebrei). Il panico del 1875 rovinò Jay Cooke e fece di Junius Pierpont Morgan il capo croupier di Wall Street; si assodò ai Drexel di Filadelfia e costruì il palazzo Drexel, dove per trent’anni si insediò nel suo ufficio circondato da invetriate, con la faccia rossa e insolente, per scrivere a tavolino, fumare grossi sigari neri, oppure, se c’erano in ballo questioni importanti, farsi il solitario con le carte nell’ufficio interno; era famoso per le sue laconiche parole: Sì o No, e per quel suo modo di investire improvvisamente i visitatori, e per quel gesto speciale del braccio che voleva dire: Ma a me, che ne viene in tasca? Nel 1877 Junius Morgan si ritirò dagli affari; John Pierpont si fece nominare membro della direzione amministrativa della Central Railroad di New York, e varò la prima nave tipo Corsair. Gli piaceva andare in yacht e farsi chiamare commodoro dalle belle attrici.
Fondò la clinica ostetrica di Stuyvesant Square, ed era la sua passione andare nella chiesa di San Giorgio a cantare un inno tutto solo nella pace del pomeriggio. Nel panico del 1893 con suo non trascurabile profitto personale Morgan salvò il Tesoro americano; la riserva aurea si stava esaurendo, il paese era rovinato, gli agricoltori reclamavano a gran voce una base argentea, Grover Cleveland e il suo gabinetto camminavano su e giù nella camera azzurra alla Casa Bianca senza poter prendere una decisione, al Congresso facevano discorsi mentre le riserve auree si liquefacevano come cera nelle filiali del Tesoro; i poveri facevano la fame; l’esercito di Coxey marciava su Washington; per un bel po’ Grover Cleveland non seppe rassegnarsi a convocare il rappresentante dei nababbi di Wall Street; Morgan se ne stava nel suo appartamento all’Arlington a fumar sigari e farsi il solitario in santa pace, finché da ultimo il presidente lo chiamò; egli aveva un piano bell’e pronto per tamponare l’emorragia d’oro. D’allora in poi la parola di Morgan fu legge; quando Carnegie liquidò tutto, egli comperò lo Steel Trust. Era un uomo irascibile dal collo taurino, con gli occhietti da gazza e un’escrescenza sul naso; lasciava che i soci s’ammazzassero di lavoro sui particolari della gestione bancaria, e stava seduto nel suo ufficio appartato fumandosi sigari neri; quando c’era qualcosa da decidere diceva Sì o No, oppure voltava semplicemente le spalle e tornava al suo solitario. Ogni Natale il suo bibliotecario gli leggeva Una carola di Natale del Dickens dal manoscritto originale. Aveva la passione dei canarini e dei cani pechinesi, e gli piaceva portare in crociera nel suo yacht le belle attrici. Ogni nuovo Corsair superava in bellezza il precedente. Quando pranzò con re Odoardo sedette alla destra di Sua Maestà; mangiò a tu per tu col Kaiser; ci teneva a conversare coi cardinali o col papa, e non mancava mai a un sinodo episcopale; Roma era la sua città favorita. Gli piacevano la cucina raffinata, i vini vecchi, le belle donne e le
crociere in yacht, e gli piaceva passare in rassegna le sue collezioni, per sceglierne ogni tanto una tabacchiera ingioiellata e contemplarsela con quegli occhi da gazza. Fece una collezione degli autografi dei governanti di Francia, possedeva teche piene di tavolette babilonesi, sigilli, timbri, statuette, busti, bronzi gallo-romani, gioielli merovingi, miniature, orologi, arazzi, porcellane, iscrizioni cuneiformi, quadri di tutti i maestri antichi, olandesi, italiani, fiamminghi, spagnoli, manoscritti dei Vangeli e dell’Apocalisse, una collezione delle opere di Jean-Jacques Rousseau, e le lettere di Plinio il Giovane. I suoi agenti acquistavano tutto ciò che era raro o costoso o aveva bagliori d’impero, e lui se lo faceva portare e lo fissava tenacemente con quegli occhi di gazza. Poi l’oggetto veniva riposto in una teca di vetro. Nell’ultimo anno della sua vita risalì il Nilo in dahabiyeh, e passò molto tempo a contemplare le grandi colonne del tempio di Karnak. Il panico del 1907 e la morte di Harriman, suo grande rivale nel finanziamento delle ferrovie, avvenuta nel 1909, lo avevano lasciato sovrano incontrastato di Wall Street, il cittadino privato più potente del mondo; vecchio stanco della porpora, sofferente di gotta, si era degnato di andare a Washington a rispondere alle domande avanzate dal comitato Pujo durante il Money Trust Investigation: Sì, ho fatto quello che mi pareva meglio rispondere agli interessi del paese. Il suo impero era costruito in maniera così ammirevole che la sua morte, avvenuta nel 1913, non provocò un’increspatura nei traffici mondiali: la porpora passò a suo figlio, J.P. Morgan, che a Groton e Harvard e frequentando la classe dominante inglese aveva imparato ad essere un monarca più costituzionale: J.P. Morgan suggerisce… A tutto il 1917 gli Alleati avevano contratto prestiti per un miliardo e novecento milioni di dollari tramite la dinastia Morgan: noi
andammo a combattere oltremare per la democrazia e la bandiera; e al termine della Conferenza della pace la frase: J.P. Morgan suggerisce bastava a manovrare una forza di settantaquattro miliardi di dollari. J.P. Morgan è un uomo taciturno, alieno dalle dichiarazioni pubbliche, ma durante il grande sciopero dell’acciaio scrisse a Gary: Sentitissime congratulazioni per la vostra fermezza nella tesi fabbriche aperte, a proposito di cui, come sapete, sono pienamente d’accordo. Io ritengo che siano in gioco i princìpi americani di libertà, e che essi dovranno vincere se noi terremo saldamente le nostre posizioni. (Guerre e crolli in Borsa, fuoco di mitragliatrici e incendi, fallimenti, prestiti di guerra, fame, pidocchi, colera e tifo: ecco il clima propizio alla dinastia Morgan.)
Cine-giornale XXXV il Grand Prix de la Victoire, svoltosi ieri per la cinquantaduesima volta, rimarrà un evento memorabile per tutti coloro che vi assisterono, perché mai, nella storia della classica corsa, Longchamps ha offerto uno spettacolo così glorioso Tenete accesi i focolari perché i ragazzi ritorneranno IL LEVIATHAN NON RIESCE A PRENDERE IL MARE I bolscevichi aboliscono i francobolli UN’ARTISTA SI UCCIDE COL GAS A NEW HAVEN SANGUE SOPRA UNA BANCONOTA DA UN DOLLARO Mentre la nostalgia ci strugge il cuore Il potassio provoca una rottura delle trattative UN MAGGIORE MUORE AVVELENATO INGERIVA PER ERRORE POLVERE INSETTICIDA torbidi e rapine sboccarono nel più tremendo pogrom che si sia mai visto. Nello spazio di due o tre giorni il ghetto di Lemberg fu ridotto in ammassi di macerie fumanti. Testimoni oculari calcolano che i soldati polacchi abbiano ucciso più di mille ebrei, fra uomini, donne e bambini TROCKIJ SPARA A LENIN IN UNA RISSA FRA UBRIACHI voi conoscete bene la mia situazione, disse Brisbane nel chiedere aiuti I ragazzi son lontani ma rimpiangono la patria nella nera nuvolaglia splende un velo d’argento IL PRESIDENTE EVOCA IL GRIDO DEI MORTI Una lettera fornisce la chiave dell’attentato Nelle tre puntate precedenti della sua intervista Emile Deen ha descritto la situazione creatasi fra la Royal Dutch e la Standard Oil Company come l’inizio di una lotta per il controllo dei mercati mondiali, lotta che la guerra aveva soltanto momentaneamente interrotta. «I fattori basilari» ha detto «sono d’invidia, il malcontento e
il sospetto.» Lo straordinario sviluppo industriale della nostra nazione dalla guerra civile in poi, la colonizzazione di nuovi territori, il potenziamento delle risorse, il rapido aumento di popolazione, tutte queste cose hanno avuto come risultato la creazione di molte improvvise grandi fortune. C’è forse madre, padre, innamorata, parente o amico di uno qualunque dei due milioni di ragazzi che combattono all’estero che non ringrazi Dio per il contributo dato da Wall Street alla Croce Rossa con H.P. Davidson? LADRO DI TITOLI ASSASSINATO Spandete su tutto la luce della gioia perché i ragazzi ritorneranno
Occhio fotografico (39) il giorno sgorga da una quiete rossastra fiocamente palpitando affonda nella mia dolce tenebra si espande rosso per il caldo sangue appesantendomi le palpebre dolce e caldo poi si slancia enormemente azzurro giallo rosa oggi è Parigi sole roseo pulviscolare sulle nubi contro chiazze di uova di pettirosso una sirena esigua ulula acutissima il traffico urbano romba sonnacchioso scalpita sul selciato i tassi gracidano il giallo è confortatore dalla finestra aperta il Louvre ostenta la sua misurata architettura di pietra grigiorosa fra la Senna e il cielo e la certezza di Parigi il rimorchiatore lucido verde e rosso mugola controcorrente trainandosi appresso tre barconi neri e verniciati in mogano le finestre delle loro cabine hanno persiane verdi e tendine di pizzo e vasi di gerani in fiore per passare sotto il ponte un uomo panciuto in blu dovette abbassare orizzontalmente in coperta il piccolo fumaiolo nero Parigi entra nella stanza con gli occhi della cameriera col caldo turgore dei suoi seni sotto la tunica grigia con l’odore di cicoria nel caffè e latte bollito e il bianco fulgore che sgranocchia i crostini a mezzaluna spalmati di burro molto dolce privo di sale con la copertina gialla del libro che nasconde a metà il simpatico viso della mia amica Parigi 1919 paris-mutuel roulette che gira attorno alla Tour Eiffel rosso bianco un milione di dollari un miliardo di marchi un trilione di rubli svalutazione del franco o un mandato per Montmartre Cirque Médrano corsa di cavalli con ostacoli gravità dei violoncelli che si stanno accordando sul palcoscenico alla Salle Gaveau oboi e un triangolo la musique s’en fout de moi dice la vecchia marchesa tintinnante di diamanti nell’abbandonare la sala durante l’esecuzione di un pezzo di Stravinskij ma il puledro rosso saltò all’indietro e noi perdemmo tutto il nostro denaro
la peinture dirimpetto alla Madeleine Cézanne Picasso Modigliani Nouvelle Athènes la poesia dei manifesti sempre freschi sui chioschi e le frasi di battaglia scarabocchiate col gesso sui vespasiani L’UNION DES TRAVAILLEURS FERA LA PAIX DU MONDE rivoluzione attorno alla rotante Tour Eiffel che brucia i diagrammi del nostro ultimo anno le date volano dal calendario faremo tutto nuovo oggi è l’Anno Primo Oggi è il mattino solare del primo giorno di primavera Noi buttiamo giù il nostro caffè in una sorsata ci sciacquiamo in fretta e furia ci infiliamo i vestiti di volata ci precipitiamo dabbasso sbocchiamo ormai bene svegli nel primo mattino del primo giorno del primo anno
Cine-giornale XXXVI A GLORIA DELLA FRANCIA ETERNA Oh, un ufficiale tedesco traversò il Reno parlez-vous? I tedeschi battuti a Riga. I parigini riconoscenti acclamano i marescialli di Francia Oh, un ufficiale tedesco traversò il Reno gli piacevan le donne e amava il vino trucchi e imbrogli, parlez-vous? LE PIETOSE LAGNANZE DELLA MOGLIE PARLANO DELLE ASTUZIE DELLA RIVALE L’Arrivo di Wilson a Washington Suscita Disordini. Gli scioperanti di Parigi arringati durante una merenda sul prato. Un caffè danneggiato e bombe lanciate nelle vie di Fiume. I parigini pagano la carne qualcosa di più. Il Serait Dangereux d’Augmenter les Vivres, A Bethmann-Hollweg bolle il sangue. Forze misteriose fermano la marcia antibolscevica. NEI COMPLOTTI SI VEDE LA MANO DEGLI UNNI Oh mademoiselle di Armentières parlez-vous Oh mademoiselle di Armentières parlez-vous Non la toccan da quarant’anni trucchi e imbrogli, parlez-vous? A La Baule la giornata finale è contrassegnata da rovesci; gli iscritti ai sindacati operai colgono l’occasione per minacciare i datori di lavoro impreparati al mutamento. DEPONE UNA CORONA SULLA TOMBA DI LAFAYETTE. È morta la negra più ricca del mondo. I dormitori di Yale presi d’assalto da una folla di soldati infuriati. Una miniera d’oro a Banks. UN GIRO DI VITE A BERLINO Oh, la portò di sopra e a letto e lì fece saltare la sua verginità trucchi e imbrogli, parlez-vous?
STANDO AGLI UOMINI D’AFFARI LA PACE NON PORTERÀ RIBASSI NEI PREZZI SI UCCIDE A TAVOLINO IN UFFICIO IL BARBABLÙ MODERNO È ORA VITTIMA DELLA MALINCONIA Egli non è altri che il generale Minus del vecchio stato maggiore imperiale russo, il quale, durante il governo Kerenskij, fu comandante delle truppe nella zona di Minsk. I poliziotti di Parigi minacciano di fare causa comune con gli scioperanti, permettono loro di mandare per tutta la Francia barili recanti la mistica parola Mistelles. Si dice che uno speculatore abbia fatto nel corso di una settimana un colpo di quasi cinque milioni. Oh nei primi tre mesi tutto andò bene ma nei seguenti tre lei cominciò a gonfiarsi tracchi e imbrogli, parlez-vous? le larghe risorse finanziarie, i perfezionati ritrovati tecnici e le abbondanti materie prime dell’America dovrebbero aiutare il genio francese a ricostituire ed accrescere la potenza industriale della Francia; combinandosi in uno scenario incantevole, strade magnifiche, eccellenti alberghi e la buona cucina concorrono a far prescegliere la zona della fiera di Lione all’altezza del 45° parallelo. Favorita da grandi risorse minerarie, essa ha dinanzi a sé un avvenire quanto mai fulgido. Chiunque tentasse di impossessarsi dei poteri municipali qui verrebbe ucciso sul posto, ha dichiarato il sindaco Ole Hanson. Personalmente egli è un uomo piccolo di statura, ma ha grandi idee, una grande mente e grandi speranze. A prima vista colpisce la sua rassomiglianza con Mark Twain.
Richard Ellsworth Savage Dick e Ned si sentivano piuttosto male in arnese la mattina che avvistarono la nave faro di Fire Island. Dick non aveva la minima idea di sbarcare nella terra di Dio senza un soldo in tasca e con la coscrizione obbligatoria in vista, e per di più lo preoccupava seriamente il problema di come faceva sua madre a tirare avanti. A Ned tutto ciò che dava fastidio era il proibizionismo di guerra. Erano tutti e due un po’ malfermi sulle gambe per via di tutto il cognac che si erano scolati nella traversata. Erano già nei bassifondi verde ardesia della zona di Long Island; non c’era più niente da fare ormai. La densa bruma ad occidente e poi le basse case a mo’ di scatola che avevan l’aria di essere mezzo affogate nell’acqua, e poi la candida striscia di spiaggia dei Rockaways; le montagne russe di Coney Island; gli alberi verdissimi d’estate e le grigie case di legno guarnite di bianco a Staten Island; era tutta aria di casa, piena di acuta nostalgia. Quando si accostò la motobarca del controllo immigrazione, Dick ebbe la sorpresa di veder salire a bordo Hiram Halsey Cooper in divisa kaki e gambali. Dick si accese una sigaretta e si sforzò di dissimulare la propria ubriachezza. «Ragazzo mio, che sollievo vederti, finalmente!… Tua madre e io eravamo… ehm…» Dick lo interruppe per presentarlo a Ned. Il signor Cooper, che era in divisa di maggiore, lo prese per la manica e lo tirò in disparte sul ponte: «È meglio che vi mettiate la divisa per sbarcare». «Ma, signor maggiore, credevo che la mia fosse troppo malandata.» «Tanto meglio… Be’, suppongo che da quelle parti sia un vero inferno, vero?… e poca o nessuna opportunità di coltivare la musa, vero?… Stasera venite con me a Washington. Siamo stati in gran pensiero per voi, ma adesso è finita… ciò mi ha fatto riflettere sulla mia vecchiaia e sulla mia solitudine. Senti un po’, ragazzo mio, tua madre è la figlia del maggior generale Ellsworth, non è vero?» Dick annuì. «Per forza; la mia cara moglie era nipote di lui… Be’, spicciatevi, mettetevi la divisa e ricordate… di lasciar fare a me: non dite una parola.» Nel rimettersi la vecchia divisa Norton-Harjes, a Dick venne fatto di pensare come il signor Cooper fosse invecchiato di colpo e come
doveva fare lui a chiedergli quindici dollari in prestito per pagare il conto del bar. New York aveva un’aria stranamente vuota e solitaria nel sole del pomeriggio estivo; bene, rieccoci a casa nostra. Alla stazione di Pennsylvania c’erano poliziotti e agenti in borghese a tutti gli ingressi, e chiedevano i certificati di esenzione a tutti i giovani che non erano in divisa. Nel correre al treno col signor Cooper, scorse un gruppo di uomini dall’aria abbattuta, costretti in un angolo da un cordone di poliziotti sudati. Quando ebbero preso posto nella vettura del treno Congressional, il signor Cooper si asciugò la faccia con un fazzoletto. «Adesso capirete perché vi ho raccomandato di mettervi la divisa. Be’, chissà che inferno da quelle parti, eh?» «In qualche periodo me la son vista brutta, effettivamente,» disse Dick senza dare importanza alla cosa «ma con tutto questo non ho mai potuto rassegnarmi all’idea di tornare a casa.» «Eh, lo so, ragazzo mio… Di’ la verità che non ti aspettavi di rivedere il tuo vecchio mentore in divisa di maggiore… be’, dobbiamo portare tutti la nostra pietra al cantiere. Io sono nella sezione Acquisti dell’intendenza. Vedi, il capo del nostro ufficio Personale è il generale Sykes; combinazione, è stato collega di tuo nonno. Gli ho parlato di te, della tua esperienza fatta su due fronti, delle tue conoscenze linguistiche e… be’… naturalmente il tuo caso ha richiamato la sua attenzione, in una maniera incredibile… Credo che ti potremo ottenere la nomina a ufficiale senza difficoltà.» «Signor Cooper, ma siete…» balbettò Dick «siete straordinariamente gentile… non ci sono parole per descrivere la vostra gentilezza… interessarvi di me in questo modo.» «Ragazzo mio, bisognava proprio che te ne andassi via, perché io mi rendessi conto di quanto mi mancavi… le nostre chiacchierate sulla musa e gli antichi… bisognava proprio che te ne andassi via.» La voce del signor Cooper fu sommersa dal rombo del treno. Bene, rieccomi a casa, continuava a ripetere a Dick qualcosa dentro la testa. Quando il treno si fermò alla stazione di West Philadelphia, il solo suono che si sentisse era il quieto ronzio dei ventilatori; il signor Cooper si chinò a dare un colpetto sul ginocchio di Dick: «Mi devi
promettere una cosa sola… non parlar più di pace finché non avremo vinto la guerra. Quando verrà la pace, allora potremo parlarne nelle nostre poesie… E allora toccherà a noi tutti di lavorare per una pace duratura… In quanto a quel piccolo incidente d’Italia… non è nulla… dimenticalo… non ne ha saputo niente nessuno». Dick annuì; e si mortificò accorgendosi che arrossiva. Nessuno dei due disse altro finché non venne il cameriere ad annunciare: «Il pranzo è pronto nella vettura ristorante, più avanti». A Washington (rieccoti a casa, seguitava a dire una voce nella mente di Dick) il signor Cooper aveva una camera al Willard, dove sistemò Dick sul divano, perché l’albergo era pieno e non si trovava una camera a pagarla a peso d’oro. Quando si fu avvolto nel lenzuolo, Dick sentì il signor Cooper avvicinarsi in punta di piedi e fermarsi accanto al divano respirando a fatica. Aprì gli occhi e abbozzò un sorriso. «Be’, ragazzo mio» disse il signor Cooper «è una gran bella cosa riaverti a casa… dormi bene» e andò a letto. Il mattino dopo fu presentato al generale Sykes: «Questo è il giovane che vuol servire il suo paese» disse il signor Cooper con un gesto eloquente «come l’ha servito suo nonno… Infatti si è dimostrato così impaziente di farlo da andare in guerra prima del suo paese, arruolandosi nel servizio volontario d’ambulanza coi francesi e in seguito con gli italiani». Il generale Sykes era un vecchietto dagli occhi lucenti e dal naso di falco, estremamente sordo. «Sì, Ellsworth era un ragazzo d’oro, facemmo assieme la campagna contro Hieronimo… Ah, il vecchio West… A Gettysburg avevo solo quattordici anni, e lui, ora che ci penso, mi pare che non ci fosse neppure. Facemmo l’accademia di West Point nella stessa classe dopo la guerra, povero vecchio Ellsworth… E così hai sentito odor di polvere, vero, ragazzo mio?» Dick arrossì annuendo. «Vedete, generale,» gridò il signor Cooper «lui sente di aver diritto… come dire… a un lavoro di responsabilità maggiore di quello che poteva svolgere nel servizio d’ambulanza.» «Ha perfettamente ragione, quello non è il posto adatto per un giovane che ha stoffa… Voi conoscete Andrews, maggiore…» Il generale scribacchiava qualcosa in un taccuino. «Portatelo dal
colonnello Andrews con questo promemoria, e lui penserà a sistemarlo; dovrà decidere sulla qualifica, eccetera… capite… Buona fortuna, ragazzo mio.» Dick riuscì a fare un saluto passabile, e uscì nel corridoio col signor Cooper, il quale aveva il volto rischiarato da un largo sorriso. «Be’, questa è fatta. Adesso devo tornare al mio ufficio. Tu vai a riempire i moduli e a fare la tua visita medica… anzi, forse quella te la faranno al campo… In ogni modo ti aspetto al Willard alla una per la colazione. Vieni su, in camera.» Dick lo salutò sorridendo. Il resto della mattinata lo trascorse a riempir moduli su moduli. Dopo colazione andò ad Atlantic City a trovare sua madre. Era la stessa di prima. Alloggiava in una pensione del quartiere Chelsea e sapeva tutto in fatto di spie. Henry si era arruolato come soldato semplice di fanteria ed era in Francia. La mamma diceva che le ribolliva il sangue se pensava che il nipote del generale Ellsworth era un soldato semplice, ma confidava che presto riuscisse a guadagnarsi il grado di ufficiale. Era dall’epoca della sua infanzia che Dick non la sentiva parlare del padre, e la pregò di dirgli qualcosa di lui. Egli era morto quando lei era ancora bambina, lasciando la famiglia in condizioni non troppo floride, considerando la sua posizione sociale. Tutto quello che lei ricordava di lui era la visione di un uomo alto, in azzurro, col cappello di feltro floscio rialzato da una parte e la barbetta bianca; la prima volta che le era capitato di vedere un manifesto raffigurante Zio Sam, l’aveva scambiato per suo padre. Aveva l’abitudine di tenere gocce di marrubio in una piccola bomboniera d’argento che portava sempre in tasca; a lei aveva fatto una grande impressione il funerale militare, era stato così simpatico e così gentile quell’ufficiale dell’esercito che le aveva dato il proprio fazzoletto. Si era serbata la bomboniera per molti anni, ma poi bisognò venderla con tutto il resto quando il tuo povero padre… ehm… sbagliò. Una settimana dopo Dick ricevette una busta del dipartimento della Guerra indirizzata a Savage, Richard Ellsworth, sottotenente dell’intendenza; la busta conteneva la sua nomina e gli ordinava di recarsi entro 24 ore a Camp Merritt, N.J. Dick si trovò a capo di una compagnia complemento a Camp Merritt, e non avrebbe saputo che pesci pigliare se non fosse stato per il sergente. Una volta che furono a
bordo della nave trasporto le cose andarono meglio; gli fu assegnata una ex cabina di prima classe in compartecipazione con altri due sottotenenti e un maggiore; e Dick aveva la meglio su di loro perché era stato al fronte. La nave era il Leviathan; Dick ricominciò a sentirsi se stesso quando ebbe visto sparire all’orizzonte Sandy Hook; scrisse a Ned una lunga lettera in versi burleschi che cominciava così: Suo padre era una schiena di galera e sua madre era senza soldi, gli piaceva troppo il cognac e lo beveva a secchi, ma ora è un sottotenente sotto l’egida dello Stato… Ostenta una bella divisa e un’andatura marziale e questa è la sorte più tremenda che possa toccare a un ragazzo che aveva per nonno un maggior generale. Gli altri due ufficialetti di primo pelo che condividevano la cabina con lui erano anonimi giovincelli di Leland Stanford, ma il maggiore Thompson veniva dall’accademia di West Point ed era duro come una verga di ferro. Era un uomo di mezza età dalla faccia gialla e tonda, le labbra sottili e gli occhiali a pince-nez. Dick se lo conquistò facendogli procurare una pinta di whisky dal suo sergente, che aveva fatto amicizia coi cambusieri, in occasione del mal di mare che lo aveva preso a due giorni dalla partenza, e scoprì che era un appassionato ammiratore di Kipling e aveva sentito leggere da Copeland Danny Deever riportandone una grande impressione. Oltre a ciò era un’autorità in fatto di muli e carne equina, e aveva al suo attivo una monografia: “The Spanish Horse”. Dick gli fece sapere a sua volta di aver studiato con Copeland, e poi venne a galla che era nipote del defunto generale Ellsworth. Il maggiore Thompson prese a interessarsi di lui e a fargli domande sui somari che i francesi usavano per portare le munizioni in trincea, sui cavalli italiani da battaglia e sulle opere di Rudyard Kipling. La notte prima dell’arrivo a Brest, quando tutti quanti erano agitati e i ponti immersi nell’oscurità e nel silenzio per via della zona di guerra, Dick andò in gabinetto a rileggersi la lunga lettera umoristica che aveva scritto a Ned il primo giorno di mare. La fece in tanti pezzetti, li buttò nella tazza del watercloset e tirò accuratamente la catena: basta lettere. A Brest, Dick si portò in città tre maggiori e offrì loro da mangiare
e da bere, vino buono, all’albergo; nella serata il maggiore Thompson raccontò episodi delle Filippine e della Guerra spagnola; alla quarta bottiglia Dick insegnò loro a cantare Mademoiselle from Armentières. Alcuni giorni dopo venne tolto dalla sua compagnia complementi e mandato a Tours; se l’era fatto trasferire al proprio ufficio il maggiore Thompson, che sentiva un bisogno immenso di qualcuno con cui parlar francese e discorrere di Kipling. Fu un sollievo dare l’addio a Brest, dove tutti quanti erano intrisi di accidia perpetua per via dell’acquerugiola, della mota, della disciplina, dei saluti militari, dell’ordine chiuso e del timore di aver grane coi pezzi grossi dell’esercito. Tours era piena di graziosi edifici in pietra color crema, sepolti in dense masse di tardo fogliame estivo verdazzurro. Dick si faceva dare in denaro l’equivalente della sua razione, e stava in pensione presso una simpatica vecchia che ogni mattina gli portava il café au lait a letto. Fece conoscenza con un tizio della sezione Personale per tramite del quale cominciò a lavorare per far togliere dalla fanteria Henry. Lui, il maggiore Thompson e il vecchio colonnello Edgecombe con parecchi altri ufficiali pranzavano spesso assieme; andò a finire che non poterono più fare a meno di Dick, il quale sapeva ordinare un pasto comme il faut, s’intendeva di vini, sapeva parlar francese con le francesine e improvvisare versi umoristici, ed era nipote del defunto generale Ellsworth. Quando il servizio postale divenne organizzazione autonoma, il colonnello Edgecombe, che vi era preposto, staccò Dick dal maggiore Thompson e dai suoi sensali di cavalli; Dick diventò suo aiutante, col grado di capitano. Immediatamente fece in modo di far trasferire Henry alla scuola allievi ufficiali di Tours. Ma non si poté farlo arrivare che al grado di sottotenente. Quando il tenente Savage si presentò al capitano Savage nel suo ufficio, era bruno, asciutto e accigliato. Quella sera bevvero assieme una bottiglia di vino bianco nella stanza di Dick. La prima cosa che Henry disse quando la porta si richiuse alle loro spalle fu questa: «Be’, tra tutti questi armeggi e imbrogli della malora… non so se essere orgoglioso del mio fratellino o ammaccargli un occhio».
Dick gli versò da bere: «Dev’esserci stato lo zampino di mamma» disse. «Parola mia, avevo dimenticato che il nonno era generale.» «Se sapessi che cosa dicevamo di quelli del Service of Supply, noialtri combattenti al fronte!» «Ma ci dev’essere pur qualcuno che s’incarica dei viveri e del munizionamento e…» «E delle mademoiselles e del vin blanc!» lo interruppe Henry. «Hai ragione, ma io sono stato molto virtuoso… Il tuo fratellino sta molto attento a quello che fa, e, sulla mia parola, ho lavorato come un negro.» «A scrivere lettere d’amore per i maggiori dell’intendenza, scommetto… Diavolo, non c’è niente da fare. È nato con la camicia, lui!… In ogni modo sono contento che ci sia almeno uno della famiglia che abbia fortuna e tenga alto il nome del generale Ellsworth.» «Te la sei passata male nelle Argonne?» «Da cane… fin quando non mi mandarono alla scuola allievi ufficiali.» «Laggiù ce la siamo passata da papi col servizio ambulante nel 1917.» «Ah sì?» Henry bevve dell’altro vino e si mansuefece un poco. Di tanto in tanto dava un’occhiata in giro alla grande stanza con le sue tendine di pizzo e il pavimento di piastrelle ben raschiato e il lettone a quattro piazze, e schioccava le labbra mormorando: «Che lusso!». Dick lo portò fuori con sé e gli offrì un bel pranzo al suo localino favorito, poi andò a fissargli un appuntamento con Minette, che era la ragazza più attraente di Madame Patou. Quando Henry se ne fu andato di sopra con lei, Dick stette un po’ seduto in salotto a bere cattivo cognac e a mangiarsi di malinconia con una ragazza che chiamavano Dirty Gertie, la Sporcacciona; aveva i capelli tinti di rosso e la bocca dipinta, a ciabatta. «Vous triste?» disse lei, mettendogli sulla fronte la mano appicciaticcia. Lui annuì. «Fièvre… trop penser… penser non buono… moi aussi.» Poi disse che voleva uccidersi ma aveva paura; non che credesse in Dio, ma le faceva paura l’idea della quiete che ci sarebbe stata dopo la morte.
Dick la rincorò: «Bientôt guerre finie. Tout le monde content tornare a casa». La ragazza scoppiò a piangere e Madame Patou irruppe strillando e artigliando come un gabbiano. Afferrò la ragazza per i capelli e prese a scuoterla come un cencio. Dick si sentì montare una vampa d’indignazione. Riuscì a convincere la donna a smetterla con la ragazza, lasciò del denaro e uscì. Si sentiva in condizioni tremende. Tornato a casa, gli venne voglia di buttare giù qualche verso. Tentò di riconquistare quella soave e nutrita pulsazione di sentimenti che soleva sentire per l’addietro quando si metteva a scrivere una poesia. Ma non riuscì che a sentirsi abbattuto come uno straccio, e così andò a letto. Tutta notte, tra il sogno e il pensiero, non fece che vedersi davanti la faccia di Dirty Gertie, la Sporcacciona. Poi cominciò a ricordare i passatempi avuti con Hilda a Bay Head e fece una lunga conversazione con se stesso sull’amore: Tutto è così diabolicamente sozzo… sono stufo di puttane e di castità, voglio un po’ d’amore… Passò ad architettar progetti su quello che avrebbe fatto dopo la guerra; probabilmente tornare in patria e darsi alla politica a Jersey City; prospettiva abbastanza sozza. Giaceva supino fissando il soffitto già livido d’alba, quando udì la voce di Henry che lo chiamava per nome dalla strada; scese in punta di piedi la fredda scala a piastrelle e lo fece entrare. «Ma che idea t’è venuta, di farmi andare in camera con quella ragazza, Dick? Mi sento come un cane… Oh Cristo… ti spiace lasciarmi metà letto, Dick? In mattinata mi trovo una stanza.» Dick gli trovò un pigiama e si fece piccolo piccolo dalla sua parte di letto. «Il guaio è che tu, Henry,» disse sbadigliando «sei sempre un vecchio puritano… dovresti essere più continentale.» «Tanto per cominciare, però, tu non ci sei andato con quelle cagne.» «Io non ho morale, ma sono schizzinoso, caro mio, da buon figlio di Epicuro» ribatté assonnato Dick. «Sssst, mi sento come uno straccio da piatti sporco» bisbigliò Henry. Dick chiuse gli occhi e si addormentò. Ai primi di ottobre Dick fu inviato a Brest con un plico di dispacci che il colonnello diceva troppo importanti per poterli affidare a un
uomo di truppa. A Rennes dovette aspettare il treno due ore filate, e stava seduto a pranzare nel ristorante, quando gli s’accostò un fante col braccio al collo, dicendo: «Ciao, Dick, si può salutarti?». Era Skinny Murray. «Accidenti, Skinny, son felice di vederti… devono essere passati cinque o sei anni… Eh, s’invecchia. Ecco qua, siediti un po’… ah già, non posso.» «Forse avrei dovuto farvi il saluto militare, signor capitano» disse Skinny duro duro. «Se vuoi, Skinny… ma dobbiamo trovare un posto per parlare in santa pace… hai tempo tu? Vedi, la polizia militare arresterebbe me, se mi sorprendesse a mangiare e bere con un uomo di truppa… Lasciami finir di mangiare, che poi troviamo un bar di faccia alla stazione. Questo rischio mi sento di affrontarlo.» «Io ho un’ora di tempo… Sono diretto alla zona riposo di Grenoble.» «Ah cagnaccio, ne hai di fortuna eh?… sei stato ferito gravemente, Skinny?» «Un pezzo di shrapnel nell’ala, capitano» disse Skinny, irrigidendosi rapidamente nell’attenti mentre un sergente della polizia militare incedeva per il ristorante. «Quegli uccellarci lì mi fanno venire il mal di mare.» Dick si affrettò a terminare il suo pasto, pagò e traversò la piazza della stazione. Uno di quei caffè aveva una saletta interna che si presentava scura e quieta. Si stavano giusto sedendo a far quattro chiacchiere quando a Dick venne in mente la borsa dei dispacci. L’aveva lasciata a tavola. Bisbigliando senza fiato che tornava senz’altro, rifece di corsa la strada dalla piazza al ristorante della stazione. Al tavolo c’erano tre ufficiali francesi. «Pardon, messieurs.» Era ancora sotto il tavolo, dove l’aveva lasciata. «Se l’avessi perduta avrei dovuto spararmi» disse poi a Skinny. Parlarono di Trenton e Filadelfia e Bay Head e il dottor Atwood. Skinny era sposato e aveva un buon posto in una banca di Filadelfia. Si era arruolato volontario nei carri armati ed era stato preso di striscio da uno shrapnel prima che cominciasse l’attacco, una vera fortuna, perché la sua squadra era stata fatta fuori al completo da una cannonata centrata in pieno. Era appena stato dimesso dall’ospedale, e si sentiva abbastanza male in gamba. Dick prese nota del suo stato di servizio e disse che lo avrebbe
fatto trasferire a Tours; lui era giusto il tipo che occorreva come corriere. Poi Skinny dovette correre di volata per non perdere il treno, e Dick, con la borsa dei dispacci ben stretta sotto il braccio, andò a far quattro passi per la città variopinta, graziosa e non priva di gaiezza sotto l’acquerugiola autunnale. La voce del falso armistizio mise a rumore Tours come uno sciame di api; non si faceva che bere e darsi manate sulla schiena, e ufficiali e uomini di truppa ballavano la danza del ventre dentro e fuori gli uffici. Quando si venne a sapere che si trattava di un falso allarme Dick provò quasi un senso di sollievo. Nei giorni che seguirono, tutti gli addetti al comando del servizio postale avevano l’espressione misteriosa di saper di più di quanto non volessero rivelare. La sera dell’armistizio vero Dick cenò in un’atmosfera da delirio col colonnello Edgecombe e qualche altro ufficiale. Dopo pranzo Dick incontrò il colonnello nel cortile interno. Il colonnello aveva la faccia rossa e i baffi irti: «Be’, Savage, questo è un gran giorno per la razza» disse, ridendo a tutto spiano. «Quale razza?» domandò Dick con aria timida. «La razza umana» ruggì il colonnello. Poi tirò Dick in disparte: «Ti piacerebbe andare a Parigi, ragazzo mio? Sembra che a Parigi ci debba essere una Conferenza della pace, e che il presidente Wilson vi debba presenziare di persona… incredibile, vero?… e io ho ricevuto l’ordine di mettere questo reparto a disposizione della delegazione americana che verrà ben presto a dettare le condizioni di pace; come dire che faremo i corrieri della Conferenza della pace. Certo, qualora tu preferissi tornare a casa, si potrebbe combinare anche questo.» «Oh no, signore!» interloquì Dick prontamente. «La mia grande preoccupazione cominciava appunto ad essere quella di dovermene tornare a casa a cercarmi lavoro… La Conferenza della pace sarà un circo, e qualsiasi occasione di girare l’Europa è per me un invito a nozze.» Il colonnello gli diede un’occhiata indagatrice: «Non mi sembra la maniera più opportuna di vedere le cose, questa… il nostro primo pensiero dovrebbe essere il servizio… naturalmente tutto quello che ho detto è strettamente confidenziale.» «Sì, certo,
strettamente» disse Dick, ma non poté cancellarsi dal volto una smorfia di sorriso quando tornò a tavola dagli altri. Parigi ancora; e stavolta in divisa diagonale nuova con galloni d’argento sulle spalline e denaro in tasca. Una delle prime cose che fece fu di tornare a dare una guardata alla viuzza dietro il Panthéon dove aveva abitato con Steve Warner l’anno prima. Le case alte grigiogessoso, i negozi, i piccoli bar, i bambini dai grandi occhi, vestiti di tuniche nere, i giovinastri imberrettati e con il collo fasciato di sciarpe di seta, la cadenza dell’argot parigino: tutto gli dava un vago senso d’infelicità; si chiedeva che mai poteva esserne di Steve. Fu un sollievo ritornare all’ufficio, dove i soldati si movevano fra tavolini americani a copertura scorrevole appena arrivati dall’America e cartelle gialle. Il perno di questa Parigi era l’Hôtel Crillon in place de la Concorde, la sua arteria vitale la rue Royale, dove continuamente passavano, scortati dalla Garde républicaine con quei suoi elmetti piumati, dignitari in arrivo, il presidente Wilson, Lloyd George e i reali del Belgio; Dick cominciò a vivere in un delirio di viaggi a Bruxelles sull’espresso notturno, aragosta cardinale innaffiata di Beaune sui sedili felpati di rosso da Larue, cocktail allo champagne al Bar Ritz, conversazioni aggirantisi tutte sui fatti del momento, fra un sorso e l’altro di una mezza bottiglia al caffè Weber; era come ai tempi della convenzione di Baltimora, solo che a lui non importava più un accidente: gli faceva tutto l’effetto d’una solenne buffonata. Una sera, poco dopo Natale, il colonnello Edgecombe invitò Dick a pranzo da Voisin insieme a un famoso esperto nuovayorkese di pubblicità che si diceva fosse molto vicino al colonnello House. Si trattennero un momento in faccia al ristorante a guardare la tozza cupola della chiesa dirimpetto. «Vedete, Savage, questo tizio è marito di una mia parente, degli empori di Pittsburgh… abbastanza trattabile, per quel che mi sembra. Voi osservatelo bene. Per essere un giovane, dimostrate di avere occhio clinico per i caratteri.» Il signor Moorehouse poi era un omone dagli occhi azzurri e dalle guance paffute, calmo nel modo di parlare, che tradiva ogni tanto un tono da senatore meridionale. Erano con lui un uomo di nome Robbins e una
certa signorina Stoddard, una donna dall’aspetto fragile, l’epidermide diafana di alabastro e la voce acuta, trillante; Dick notò che era vestita finissimamente. Il ristorante sapeva un po’ troppo di chiesa episcopale; Dick parlava pochissimo, era molto gentile con la signorina Stoddard e teneva occhi e orecchie aperti, mangiando il cibo da granduchi e assaporando il vino pastoso a cui nessun altro pareva badare. La signorina Stoddard animava la conversazione con tutti, ma nessuno evidentemente voleva saperne di lasciarsi andare a dir qualcosa sulla Conferenza della pace. La signorina Stoddard parlò con notevole malizia degli arredi dell’Hôtel de Murat, e della cameriera negra dei Wilson, e del tipo di abiti che portava la moglie del presidente, ch’essa insisteva a chiamare la signora Galt. Arrivare alle sigarette e ai liquori fu una liberazione. Dopo pranzo il colonnello Edgecombe si offrì di accompagnare in macchina il signor Moorehouse al Crillon, perché era arrivata la sua vettura militare. Dick e il signor Robbins accompagnarono a casa in tassì la signorina Stoddard al suo appartamento, situato dirimpetto a Notre-Dame, sulla riva sinistra della Senna. La lasciarono sulla porta. «Chissà, forse avrò il piacere di avervi qualche pomeriggio per il tè, capitano Savage» disse lei. L’autista si rifiutò di portarli oltre, disse che era tardi e che lui era diretto a casa sua, a Noisy-le-Sec, e partì. Robbins prese Dick sottobraccio: «E adesso, per grazia di Dio, si va a fare una bella bevuta… Ragazzo mio, sono stufo di quei parrucconi di pezzi grossi.» «D’accordo,» disse Dick «e dove andiamo?» Percorrendo il nebbioso lungofiume, oltrepassando la mole ombrosa di Notre-Dame, parlarono di argomenti occasionali, di Parigi e del freddo che faceva. Robbins era un uomo di bassa statura, dalla faccia rossa improntata a un’espressione impudente di persona avvezza a comandare. Nel caffè faceva solo un po’ meno freddo che in strada. «Questo clima finirà per ammazzarmi» disse Robbins ficcando il mento sotto il bavero. «C’è un rimedio solo: biancheria di lana; ecco l’unica cosa che ho imparato nell’esercito» rispose Dick ridendo. Sedettero su un sedile felpato, presso la stufa, all’estremità del fumoso locale ornato a stuccature. Robbins ordinò una bottiglia di
whisky scozzese, bicchieri, limone, zucchero e una quantità d’acqua calda. Ci volle molto tempo perché arrivasse l’acqua calda, e così Robbins versò a ciascuno un quarto di caraffa di whisky così come stava. Quand’ebbe bevuto, il suo volto, che dianzi era appesantito dalla stanchezza, si rischiarò, ringiovanendolo di dieci anni. «La sola maniera di star caldi in questa maledetta città è buttar giù fuoco.» «Eppure io sono contento di ritrovarmi nella mia vecchia Parigi» disse Dick, sorridendo e stirando le gambe sotto il tavolo. «Oggi è l’unico posto decente in tutto il mondo» convenne Robbins. «Parigi è il perno del mondo… ammenoché non lo sia Mosca.» Alla parola Mosca un francese che giocava a dama al tavolino accanto levò gli occhi dalla scacchiera e diede un’occhiata scrutatrice ai due americani. Dick non riuscì a capire che cosa ci fosse propriamente in quello sguardo; esso gli comunicò un senso di disagio. Arrivò il cameriere con l’acqua calda. Non era abbastanza calda, e così Robbins fece una scenata e la rimandò. Nell’attesa, versò un paio di mezze caraffe di whisky puro. «Il presidente finirà per riconoscerli, i sovieti?» domandò a bassa voce Dick, quasi involontariamente. «Per me, scommetto di sì… Credo che stia già per mandare una missione ufficiosa. Dipende un po’ dal petrolio e dal manganese… prima era Re Carbone, ma ora è l’Imperatore Petrolio e Miss Manganese, regina consorte dell’acciaio. Tutta questa bella roba si trova nella repubblichetta rosa della Georgia… Spero di arrivarci presto, dicono che lì ci siano il miglior vino e le più belle donne del mondo. Perdio, bisogna proprio che ci vada… Ma il petrolio… Dio lo spacchi, ecco quello che il dannato idealista Wilson non riesce a capire: che mentre lo trattano a polli e capponi a Buckingham Palace, il vecchio allegro esercito inglese sta occupando Mosul, il fiume Karun, la Persia… adesso poi radiofante dice che sono a Baku… la futura metropoli mondiale del petrolio.» «Io credevo che i giacimenti petroliferi di Baku si stessero esaurendo.» «Levatelo dalla testa… ho appena parlato con uno che viene di là… un tipo curioso, Rasmussen, dovresti conoscerlo.» Dick replicò
che c’era già tanto petrolio nella madrepatria, in America. Robbins picchiò il pugno sul tavolo. «La roba non è mai troppa… questa è la prima legge della termodinamica. Per me il whisky non è mai troppo… Tu sei giovane: ne hai mai abbastanza, di donne? Ebbene, né la Standard Oil né la Royal Dutch Shell potranno mai avere abbastanza petrolio grezzo.» Dick arrossì e fece una risatella un po’ forzata. Quel Robbins non gli andava a genio. Il cameriere finalmente tornò con acqua bollente, e Robbins fece un toddy per entrambi. Per un po’ nessuno dei due proferì verbo. I giocatori di dama se n’erano andati. D’un tratto Robbins si rivolse a Dick e lo guardò in faccia con quegli occhi azzurri e annebbiati da ubriaco: «Be’, e voialtri ragazzi dell’esercito che cosa ne pensate? Che cosa ne pensano quelli delle trincee?». «Come sarebbe a dire?» «Niente in particolare, oh no… Ma se per caso pensano che la guerra è una porcheria, lascia un po’ che vedano la pace… Oh, ragazzo, lascia che vedano quello che sarà la pace.» «Giù a Tours non credo che si dessero gran pensiero di questo, in un senso qualsiasi… però non credo che chi l’ha vista da vicino consideri la guerra come la maniera più indicata di sistemare le controversie internazionali… Neanche Testa-di-legno Pershing, secondo me.» «Ma sentilo un po’!… ha sì e no venticinque anni, e parla come un libro di Woodrow Wilson… Io sono un figlio di puttana e lo so, ma quando ho bevuto dico tutto quello che mi passa per la testa.» «Non vedo che sugo ci possa essere nel continuare a parlare di queste cose importanti. È uno spettacolo magnifico e tragico… la nebbia parigina sente di fragole… gli dèi non ci amano, ma noi moriremo ugualmente giovani… Chi ha detto che io sia astemio?» Diedero fondo alla bottiglia. Dick insegnò a Robbins una poesiola francese: Les marionnettes font font font trois petits tours et puis s’en vont e quando il caffè chiuse, i due uscirono a braccetto, Robbins canticchiava:
Coraggio, Napoleone, presto sarai morto… Meglio viver poco e allegramente e si fermava a chiacchierare con tutte le petites femmes che incontravano nel Boul’ Mich’. Poi finalmente Dick lo lasciò che parlava con una donna dall’aspetto di mucca e dal cappello largo e floscio davanti alla fontana di place Saint-Michel, e s’incamminò verso il suo albergo, che si trovava lontano, di fronte alla Gare Saint-Lazare. Le larghe strade asfaltate erano deserte sotto i rosei lampioni ad arco voltaico, ma qua e là, sulle panchine dei lungofiume, sotto i nudi alberi gocciolanti lungo la riva della Senna, ad onta della notte gelida erano ancora sedute coppie avviticchiate nelle strette frenetiche dell’amour. All’angolo del boulevard de Sébastopol un giovane dal viso bianco, che andava nel senso opposto, gli lanciò una rapida occhiata in faccia e si fermò. Dick rallentò il passo per un momento, ma proseguì oltre la fila di carretti che rotolavano fragorosi per rue de Rivoli, respirando profondamente per schiarirsi la testa dai fumi del whisky. Il lungo corso illuminato che menava all’Opéra era vuoto. Davanti all’Opéra c’era poca gente e una ragazza dalla bella carnagione che stava appoggiata al braccio di un poilu gli lanciò un insistente sorriso. Quasi all’altezza del suo albergo incontrò a faccia a faccia una ragazza notevolmente carina, e senza nemmeno rendersi conto di quello che diceva le domandò che cosa stava facendo fuori a quell’ora. Lei rise, di un riso che gli parve incantevole, e rispose che faceva la stessa cosa che stava facendo lui. La portò a un alberghetto situato nella strada retrostante al suo. Furono introdotti in una fredda camera che odorava di cera per mobili. C’era un grosso letto, un bidè, e una quantità di pesanti tendaggi cremisi. La ragazza era più anziana di quanto gli era parso, e alquanto stanca, ma aveva una bella figura e un’epidermide molto pallida; gli fece piacere constatare che aveva la biancheria molto pulita, con graziose orlature di pizzo. Si misero a sedere per un po’ sulla sponda del letto, parlando a bassa voce. Quando lui le domandò come si chiamava, lei scosse il capo sorridendo: «Qu’estce que ça vous fait?». «L’homme sans nom et la femme sans nom vont faire l’amour à l’hôtel du néant» disse lui. «Oh qu’il est rigolo, celui-là» ridacchiò lei.
«Dis, tu n’est pas malade?» Lui scosse la testa. «Moi non plus» disse lei, e cominciò a soffregarglisi contro come una gattina. Quando uscirono dall’albergo gironzolarono per le vie buie sinché non trovarono un caffé di quelli mattinieri. Presero assieme caffè e croissants, in una quiete sonnolenta ed intima, stringendosi l’uno all’altra nell’appoggiarsi al banco. Lei lo lasciò per salire verso Montmartre. Lui le chiese se poteva vederla ancora qualche altra volta. Lei fece spallucce. Lui le diede trenta franchi, la baciò e le sussurrò all’orecchio una parodia della sua poesiola: Les petites marionnettes font font font un p’tit peu d’amour et puis s’en vont La donna rise e gli diede un pizzicotto sulla guancia, e l’ultima voce che di lei gli giunse fu quel suo risolino sprezzante e «Oh, qu’il est rigolo, celui-là». Tornò in camera sua soddisfatto e assonnato, dicendosi: che importa se non ho una donna mia. Ebbe appena il tempo di lavarsi, sbarbarsi e indossare una camicia pulita e correre al comando per poterci arrivare giusto prima del colonnello Edgecombe, che era maledettamente mattiniero. Trovò in ufficio l’ordine di partire per Roma quella sera stessa. Salendo in treno aveva gli occhi bruciati dal sonno. Lui e il sergente che lo accompagnava avevano uno scompartimento riservato all’estremità di una vettura di prima classe segnato Parigi-Brindisi. Fuori del loro scompartimento il treno era stipato; la gente stava in piedi nei corridoi. Dick si era tolto cappotto e cinturone e si stava slacciando i gambali, con l’intenzione di sdraiarsi sopra uno dei divani e addormentarsi prima che il treno partisse, quando vide una smunta faccia americana alla porta dello scompartimento. «Scusate, siete il cap… il capitano Savage?» Dick si rizzò a sedere e annuì sbadigliando. «Capitano Savage, io mi chiamo Barrow, G.H. Barrow, addetto alla delegazione americana… Devo andare a Roma stasera e non c’è un posto a sedere in tutto il treno. L’ufficiale addetto ai movimenti, alla stazione, mi ha detto molto gentilmente che… ehm… ehm… per quanto non sia proprio a norma di regolamento, 1 voi potevate chiudere un occhio e permetterci di viaggiare nel vostro
scompartimento… Ho con me una gentilissima signorina che fa parte del Near East Relief…» «Capitano Savage, è certamente molto cortese da parte vostra lasciarci viaggiare con voi» interloquì una cadenzata voce del Texas, e una fanciulla dalle guance rosee e in uniforme grigio scura sorpassò sfiorandolo l’uomo che diceva di chiamarsi Barrow e salì in carrozza. Barrow, che aveva la forma di un fagiolino e il pomo d’Adamo prominente, scosso da tremiti, e gli occhi sporgenti, cominciò a buttar su borse e valigie. Dick era scocciato e cominciò a dire con rigidezza: «Credo sappiate che è in completo contrasto coi miei ordini…», ma sentì la propria voce nell’atto stesso di dirlo e non trattenne un sorriso: «Va bene, vuol dire che il sergente Wilson e io saremo probabilmente fucilati all’alba, ma avanti pure!». In quel momento preciso il treno partì. Dick raccolse con riluttanza in un angolo le sue cose e ci si rincantucciò, chiudendo subito gli occhi. Aveva troppo sonno per fare lo sforzo di conversare col primo dannato organizzatore assistenziale che capitava. Il sergente sedette nell’altro angolo mentre Barrow e la ragazza occupavano l’altro sedile. Attraverso la sua sonnolenza Dick udiva la voce di Barrow sgranarsi sorda, sommersa di tanto in tanto dallo strepito dell’espresso. Aveva un modo di parlare balbuziente come un motore di motoscafo che funzionasse male. La ragazza non diceva gran che, solo di tanto in tanto «Oh guarda!» e «Ah sì!». Si trattava della situazione europea: il presidente Wilson dice… nuova diplomazia… nuova Europa… pace duratura senza annessioni o indennità. Il presidente Wilson dice… una intesa nuova tra capitale e lavoro… Il presidente Wilson si rivolge a… democrazia industriale… tutta la gente semplice e onesta del mondo è col presidente. Patto. Lega delle Nazioni… Dick dormiva e sognava di una ragazza che gli soffregava contro le mammelle facendo le fusa come una gattina, di un uomo dagli occhi sporgenti che faceva un discorso, di William Jennings Wilson che parlava al cospetto dell’incendio di Baltimora, e la democrazia industriale in uno stabilimento balneare sulla Marna, in calzoncini rigati, con un giovincello del Texas dalle guance rosate che voleva… come un fagiolino… col pomo di Adamo scosso da tremiti… Si svegliò sotto l’incubo di sentirsi strozzare. Il treno si era fermato.
Nello scompartimento si soffocava. La lampadina in alto era schermata d’azzurro. Egli urtò passando le gambe di tutti e uscì nel corridoio ad aprire un finestrino. Una fredda aria montana gli punse le nari. Le alture erano nevose nella luna. Accanto al binario una sentinella francese si appoggiava sonnacchiosa al suo fucile. Dick sbadigliò disperatamente. Gli stava accanto la ragazza del Near East Relief, e lo osservava sorridente. «Dove stiamo andando, capitano Savage?… È già l’Italia questa?» «Credo che sia il confine svizzero… ci sarà molto da aspettare, immagino… sono lunghi come la fame, a questi confini.» «Oh, jimminy,» esclamò la fanciulla saltellando «è la prima volta che passo una linea di confine in vita mia.» Dick rise e si rincantucciò daccapo al suo posto. Il treno infilò una stazioncina solitaria di campagna, fiocamente illuminata, e i passeggeri civili cominciarono a scendere coi bagagli. Dick mandò i suoi documenti al controllo militare per mezzo del sergente e si rimise a dormire. Dormì sodo e non si svegliò che al Moncenisio. Qui era la frontiera italiana. Ancora aria fredda, montagne nevose, e tutti che scendevano a una stazioncina vuota. Ricordando tra il sonno e la vena sentimentale l’altra volta che era venuto in Italia con Sheldrake sulla Fiat, si diresse tremando dal freddo al bar della stazione e si bevve una bottiglia di acqua minerale e un bicchier di vino. Tornò nello scompartimento con due bottiglie di acqua minerale e un fiasco di Chianti e, quando Barrow e la ragazza rivennero tutti imbronciati e sonnacchiosi dal controllo della dogana e della polizia, offrì loro da bere. La ragazza disse che non poteva bere vino perché entrando nel Near East Relief si era impegnata per iscritto a non bere e a non fumare, ma bevve un po’ di acqua minerale lamentandosi perché le solleticava il naso. Poi tornarono tutti a rannicchiarsi nei loro angoli per tentar di dormire un altro po’. Quando entrarono nella stazione di Termini a Roma si chiamavano già per nome. La fanciulla del Texas si chiamava Anne Elizabeth. Lei e Dick avevano passato la giornata in piedi nel corridoio a guardare le città dai tetti zafferano e le case di campagna, ciascuna con una mano
di blu sull’intonaco dietro la vite che sormontava la porta, e gli olivi e le forme contorte delle viti nei loro campi a terrazzature rosse; il pallido paesaggio collinoso italiano, nel quale i cipressi appuntiti si ergevano così neri da parer squarci in una tela. Essa gli raccontò tutto quello che aveva fatto per riuscir a venire oltre oceano, sin dall’inizio della guerra, e come suo fratello era rimasto ucciso mentre imparava a volare a San Antonio, e quanto gentile era stato Barrow in piroscafo e a Parigi, ma poi tentava sempre di fare all’amore, e si comportava così scioccamente, il che era proprio fuori di posto; e Dick rilevò che dopo tutto non era una cosa tanto fuori di posto. Vedeva benissimo che Anne Elizabeth toccava il cielo col dito per il solo fatto di andare a Roma in compagnia di un vero ufficiale dell’esercito che era stato al fronte e sapeva l’italiano eccetera. Dalla stazione dovette precipitarsi all’ambasciata con le sue borse di documenti, ma fece in tempo a combinare telefonicamente un appuntamento con la signorina Trent al Near East Relief. Anche Barrow gli strinse calorosamente le mani, dicendogli che sperava di rivederlo qualche volta; era ansioso di stabilire contatti con persone che fossero veramente al corrente della situazione. La sola cosa a cui pensò Dick per tutta quella sera fu di liberarsi dagli impegni d’ufficio e andare a letto una buona volta. Il mattino seguente telefonò a Ed Schuyler alla Croce Rossa. Consumarono assieme un bel pranzo innaffiato di buon vino a un costoso ristorante presso i giardini del Pincio. Ed si era abituato a fare la vita di Riley: aveva un appartamento alle scale spagnole e faceva un sacco di gite. Era diventato grasso. Ma ora era nei guai. Il marito di una donna italiana con la quale si era dato buon tempo minacciava di sfidarlo a duello, e lui temeva uno scandalo che gli avrebbe fatto perdere il posto alla Croce Rossa. «La guerra è andata benone, ma è la pace che ti frega» disse. In ogni modo era arcistufo dell’Italia e della Croce Rossa e voleva andarsene a casa. Solo che in Italia adesso stavano preparando una rivoluzione, e a lui sarebbe piaciuto stare a vederla. «Be’, Dick, come componente le Grenadine Guards pare che tu abbia saputo cavartela da signore.» «Tutta una serie di casi fortuiti» disse Dick arricciando il naso. «Il
mondo è pieno di strane combinazioni, non è vero forse?» «Altroché!… E chissà che ne è del povero Steve… Fred Summers si doveva arruolare nella legione polacca, poi non ho saputo più nulla di lui.» «Steve probabilmente è in prigione,» disse Dick «dove dovremmo trovarci anche noi.» «Ma non capita tutti i giorni l’occasione di assistere a uno spettacolo come questo.» Erano le quattro precise quando lasciarono il ristorante. Andarono in camera di Ed e sedettero vicino alla finestra a bere cognac e a guardare i tetti gialli e verderame e le cupole barocche scintillanti all’ultimo sole, a ricordare quanto intensamente avevano sentito Roma l’altra volta che ci erano stati assieme, e a parlare di quello che avrebbero fatto ora che la guerra era finita. Ed Schuyler disse che desiderava un posto di corrispondente estero per andare in Oriente; non poteva rassegnarsi all’idea di tornare in America, nell’Upside New York; doveva pur vedere la Persia e l’Afghanistan. Il parlare dei progetti per il futuro faceva star male Dick, lo abbatteva tremendamente. Si mise a camminare avanti e indietro sul pavimento a piastrelle. Sonò il campanello e Schuyler uscì nell’atrio. Dick sentì bisbigliare, e una sottile voce femminile da soprano che parlava italiano. Poco dopo Ed sospinse nella stanza una donnina dal naso lungo e dai grandi occhi neri. «Questa è Magda» disse. «La signora Sculpi, il capitano Savage.» Dopodiché dovettero mischiare, per intendersi, un po’ d’italiano e di francese. «Io non credo che finisca per piovere» disse Dick. «Che ne diresti se ti trovassi una ragazza e tutti insieme andassimo in carrozza a cenare al palazzo dei Cesari?… forse non farà questo gran freddo.» Dick si ricordò di Anne Elizabeth e telefonò al Near East Relief. La voce del Texas squillava di piacere, disse che gli impiegati assistenziali erano insopportabili e che lei aveva un appuntamento col signor Barrow ma avrebbe fatto in modo di liberarsene. Sì, tra mezz’ora sarebbe stata pronta se venivano a prenderla. Dopo interminabili contrattazioni tra la signora Sculpi e un fiaccheraio, noleggiarono un landò a due, molto elegante e decrepito. Anne Elizabeth li aspettava sull’uscio. «Quelle vecchie galline mi stancano
davvero» disse balzando in carrozza. «Ditegli di spicciarsi, altrimenti il signor Barrow ci raggiunge… A sentir quelle vecchie galline, dovrei rientrare per le nove. Vi garantisco che qui è peggio che alle scuole parrocchiali… Siete stato tanto gentile a invitarmi coi vostri amici, capitano Savage… Morivo dalla voglia di uscire e vedere un po’ la città… Non è meravigliosa?… A proposito, dove sta il papa?» Il sole era tramontato e cominciava a far freddo. Il palazzo dei Cesari era vuoto e freddo, dimodoché si limitarono a prendervi un vermut e tornarono in città a pranzare. Dopo pranzo andarono a vedere uno spettacolo all’Apollo. «È la volta che mi prendo una solenne lavata di capo e mi rovino la posizione» disse Elizabeth «ma non me ne importa un fico. Voglio vedere la città.» Nell’entrare in teatro prese Dick sottobraccio. «Sai, Dick… tutti questi stranieri mi danno un senso di solitudine… sono proprio contenta di avere con me un uomo di fegato… Quando andavo a scuola a New York ero abituata, per esempio, a recarmi a Jersey per assistere a uno sciopero dei tessili… Cose di questo genere mi interessavano sempre. Allora mi sentivo abitualmente come in questo momento. Ma non ne perdevo una. Forse è lo stato d’animo nel quale ci si trova quando si attraversa un’esperienza veramente interessante.» Dick si sentiva un po’ brillo e in vena di espansioni affettive. Le strinse vigorosamente il braccio e le si appoggiò. «Guai a chi si permetterà di torcere un capello alla ragazzina del Texas» cantilenò con fare dolce. «Mi par di capire che tu mi prenda per una sventatella» disse Anne Elizabeth mutando improvvisamente di tono. «Ma caro mio, come si fa a resistere con quella specie di commissione metodista per la temperanza e la morale pubblica che la sorte mi ha affibbiato! Non che disconosca il lavoro che fanno… Se si pensa ai poveri bambini affamati che languiscono per ogni dove, c’è da star male… Noi abbiamo vinto la guerra, ma adesso tocca a noi di dare una mano a mettere le cose a posto in Europa, proprio come dice il presidente.» Si alzava il sipario, e tutti gli italiani intorno a loro si misero a sibilare per zittirla. Anne Elizabeth tacque. Quando Dick tentò di impadronirsi della sua mano, ella la respinse e diede con le dita un colpo ammonitore a quella di lui. «Ehi, credevo che non fossi
più uno studentello» gli disse. Lo spettacolo non fu gran che, e Anne Elizabeth, che non capiva una parola, continuava ad appoggiare la testa alla spalla di Dick e a dormicchiare. Nell’intervallo, quando tutta la comitiva andò al bar a bere qualcosa, Anne Elizabeth prese una limonata, in ossequio al dovere. Mentre risalivano ai loro posti in galleria, si verificò un improvviso incidente. Un italiano piccolo di statura e con la testa calva si avventò contro Ed Schuyler gridando: «Traditore!». Lo aveva investito con tale irruenza che entrambi perdettero l’equilibrio e rotolarono giù per la gradinata coperta d’un tappeto rosso, mentre l’ometto italiano tirava calci e pugni e Ed si studiava di tenerlo a distanza meglio che poteva. Dick e Anne Elizabeth, che dimostrò di possedere una forza notevolissima, afferrarono l’ometto italiano, lo sollevarono di peso e gli immobilizzarono le braccia dietro la schiena, mentre la signora Sculpi gli cadeva sul collo singhiozzando. Era il marito. Ed frattanto si rialzò rosso come un peperone e con un’espressione tremendamente scema. Quando comparve la polizia italiana, tutto era calmo ormai, e il direttore del teatro stava nervosamente spazzolando la divisa di Ed. Anne Elizabeth trovò all’ometto italiano i suoi occhiali, che erano malamente contorti, e lui condusse via la moglie, che singhiozzava. Era così ridicolo, quando si fermò sulla porta, con gli occhiali contorti che gli ballavano in punta al naso, ad agitare un pugno minaccioso contro Ed, che Dick non poté trattenere le risa. Ed si stava profondendo in scuse col direttore, il quale a quanto pareva stava prendendo le sue parti, perché spiegava ai poliziotti adorni dei loro berretti luccicanti che il marito era pazzo. 2 Sonò il campanello e tutti si riavviarono ai loro posti. «Ma, Anne Elizabeth, tu sei una provetta lottatrice di jujutsu!» sussurrò Dick, sfiorandole le orecchie con le labbra. Furono presi da un tale accesso di risa che non poterono badare allo spettacolo e dovettero uscire tutti e recarsi in un caffè. «E adesso scommetto che tutti i wops mi giudicheranno un vile se non sfido a duello quel povero verme.» «Eh certo, adesso dovrete farla fuori con le pistole Flobert a trenta passi… o con le melanzane a cinque metri.» Dick rideva tanto che gli venivano le lacrime agli occhi.
Ed cominciò a prendersela. «Non c’è niente da ridere,» disse «è un bel guaio questo, e doveva capitare proprio a me… pare che non ci si possa mai divertire un po’ senza rendere infelice qualcun altro… povera Magda… per lei è un inferno… Signorina Trent, spero che mi perdonerete questo spettacolo poco dignitoso.» E così dicendo Ed si alzò e tornò a casa. «Be’, di che diavolo si trattava, Dick?» domandò Anne Elizabeth quando furono usciti per incamminarsi verso la pensione del NER. «Immagino che il signor marito fosse geloso per via del buon tempo che Ed si dà con Magda… oppure si tratta di un ricatto bello e buono… il povero Ed ne sembra sinceramente sconvolto.» «Certo, qui la gente si permette cose che in patria si guarderebbe bene di fare… Sostengo che è un fatto singolare.» «Oh, ma Ed si caccia sempre nei pasticci… Ci ha un bernoccolo speciale.» «Per me è colpa della guerra, dei princìpi continentali eccetera, tutti fattori che contribuiscono a corrompere la morale… Non sono mai stata una bacchettona, ma, sinceramente, son rimasta sorpresa quando il signor Barrow mi domandò di andare all’albergo con lui, il giorno dello sbarco… E in piroscafo ci eravamo parlati solo tre o quattro volte, tutto lì… Ma ti garantisco che in America non si sarebbe mai sognato di fare una cosa simile.» Dick scrutò attentamente il viso di Anne Elizabeth. «A Roma, fa’ quello che fanno i romani: paese che vai, usanza che trovi» disse con una smorfia buffa. Lei rise, fissandolo bene negli occhi come per cercar d’indovinare quello che voleva dire. «Eh, capisco benissimo, tutto rientra nella vita» disse. All’ombra del portone lui voleva sfogarsi a baciarla, ma lei lo bloccò fulminea con uno schiaffo sulla bocca e scrollò il capo. Poi gli afferrò la mano, la strinse forte forte e disse: «Perché non vogliamo essere buoni amici?». Dick s’avviò a casa inebriato dall’odore dei suoi capelli color sabbia. Dick aveva tre o quattro giorni da attendere a Roma. Il presidente doveva arrivare il 3 gennaio, e parecchi corrieri eran tenuti a sua disposizione. Nel frattempo a Dick non restava altro da fare che gironzolare per la città, ascoltare le bande musicali che si esercitavano a suonare The Star-Spangled Banner, e osservare l’allestimento dei
vessilli e dei padiglioni. Il 1° gennaio era festa; Dick, Ed e Barrow con Anne Elizabeth noleggiarono un’auto e andarono alla villa di Adriano e quindi a Tivoli a far colazione. Era una giornata piovosa, e le strade erano piene di fango. Anne Elizabeth trovò che l’ondulata campagna romana, gialla e bruna d’inverno, le rammentava i paesaggi nativi della zona lungo il Middlebuster. Mangiarono fritto misto e bevvero una quantità di ottimo Frascati dorato al ristorante sopra la cascata. Ed e Barrow si trovarono d’accordo sull’argomento dell’impero romano e sul fatto che gli antichi conoscevano effettivamente l’arte della vita. Parve a Dick che Anne Elizabeth flirtasse con Barrow. Lo fece soffrire la maniera in cui ella permise all’altro di accostarle la propria seggiola quando si misero a sedere nel terrazzo per sorbire il caffè, dopo pranzo, e intanto guardavano giù nel profondo burrone colmo di nebbia salente dalla cascata. Dick se ne stava seduto a prendersi il suo caffè senza aprir bocca. Vuotata la tazzina, Anne Elizabeth balzò in piedi e disse che voleva salire al tempietto rotondo che si ergeva sul versante dirimpetto come in una vecchia incisione. Ed obiettò che il sentiero era troppo ripido per farlo appena mangiato. Barrow disse senza entusiasmo che sì, lui ci sarebbe andato. Anne Elizabeth partì di corsa, superò il ponte e imboccò il sentiero con Dick alle calcagna che scivolava e incespicava nella ghiaietta e nelle pozzanghere. Quando furono in fondo, la nebbia era densa e fredda sui loro volti. Avevano la cascata proprio sopra la testa, e le orecchie piene del suo rombo. Dick si voltò a guardare se veniva Barrow. «Dev’essere tornato indietro» gridò per vincere il rumore della cascata. «Oh, io non posso soffrire le persone che non vogliono mai andare in nessun posto» strillò Anne Elizabeth; e gli afferrò la mano: «Corriamo su al tempio». Ci arrivarono senza fiato. Di là dal burrone videro Ed e Barrow ancora seduti sul terrazzo del ristorante. Anne Elizabeth fece marameo al loro indirizzo e poi agitò le mani in segno di saluto. «Non è meraviglioso qui?» ansò. «Oh, io vado matta per le rovine antiche e i begli scenari… Come mi piacerebbe girare tutta l’Italia e vedere ogni cosa… Dove possiamo andare oggi
pomeriggio?… Non vorrai mica tornar là ad ascoltare gli sproloqui che vanno facendo sull’impero romano, per caso?» «Si potrebbe andare a Nemi… sai, è il lago dove Caligola teneva le sue galee… ma credo che senza macchina non ci si possa arrivare.» «Ma allora si accodano anche loro… No, andiamoci a piedi, che è una bella passeggiata.» «E se ci prende la pioggia per strada?» «Be’, e se anche piove? Non ci metteremo certo a correre!» Si avviarono per un sentiero sulle colline sovrastanti la città, e ben presto si trovarono in mezzo a pascoli e querceti bagnati di pioggia, con la distesa bruno chiara della campagna romana sotto di loro e i tetti di Tivoli punteggiati di cipressi neri come punti esclamativi. Era un pomeriggio piovoso che sentiva di primavera. Si vedevano gli acquazzoni avanzare a masse scure, grigie e biancastre attraverso la campagna. Per terra fiorivano piccoli ciclamini purpurei. Anne Elizabeth non faceva che raccoglierne e ficcarli sotto il naso a lui per farglieli odorare. Aveva le guance rosse e i capelli arruffati, e le trapelava da tutti i pori la felicità di continuare a camminare, correre e saltellare. Li bagnò un pochettino una spruzzata di pioggia, che a lei appiccicò sulla fronte i capelli a ciocche. Poi ci fu uno squarcio di freddo sole. Si misero a sedere sulle radici di un grosso faggio e levarono lo sguardo ad osservare le lunghe gemme aguzze rossobrune che luccicavano contro il cielo. Avevano le nari piene del profumo dei piccoli ciclamini. Dick si sentiva tutto fumare per la scalata e le erbe bagnate in mezzo a cui eran passati e il vino che aveva bevuto e il profumo dei piccoli ciclamini. Si voltò a guardarla negli occhi. «Bene» disse. Lei lo prese per le orecchie e lo baciò ripetutamente. «Dimmi che mi ami» continuava a dirgli con voce soffocata. Egli sentiva il profumo dei suoi capelli color sabbia e del suo corpo caldo e dei piccoli ciclamini. La fece alzare in piedi e la tenne stretta a sé baciandola sulla bocca; le loro lingue si confusero. Passando per un’apertura nella siepe, la trascinò nel campo vicino. Il terreno era troppo bagnato. All’altra estremità del campo c’era una capannetta di arbusti. Ci si avviarono barcollando, cingendosi la vita, coscia contro coscia. La capanna era piena di foglie secche di granturco. Si buttarono sul fogliame crepitante e vi giacquero
contorcendosi assieme. Lei stava supina con gli occhi chiusi e le labbra arricciate e serrate. Lui le teneva una mano sotto il capo, e con l’altra cercava di svestirla; qualcosa gli si stracciò sotto la mano. Lei cominciò a respingerlo: «No, no, Dick, non qui… dobbiamo tornare». «Bimba mia cara… io devo… sei così meravigliosa.» Ella si svincolò a forza e si precipitò fuori dalla capanna. Lui si mise a sedere sul pavimento, odiandola, ripulendosi la divisa dalle foglie secche. Fuori pioveva che Dio la mandava. «Torniamo indietro, Dick, io sono pazza di te, ma non dovevi stracciarmi le mutandine… oh, sei proprio esasperante.» E scoppiò a ridere. «E tu non dovresti cominciare una cosa per poi pentirti a metà» disse Dick. «Oh, le donne sono davvero tremende… tranne le prostitute… con quelle almeno sai dove vai a finire.» Lei gli si avvicinò e lo baciò. «Povero ragazzino… lui è tanto arrabbiato, vero? Mi dispiace tanto… Verrò a letto con te, Dick… Te lo prometto. Ma, vedi, è così difficile!… A Roma troveremo bene una stanza in qualche posto.» «Sei vergine?» La sua voce era dura e impacciata. Ella annuì. «Strano, vero?… in tempo di guerra… Voialtri ragazzi avete rischiato la vita. Io allora posso bene rischiare questo.» «Credo che potrò farmi prestare l’appartamento da Ed. Domani mi sembra che lui debba andare a Napoli.» «Ma tu mi ami davvero, Dick?» «Ma certo… è solo questo che mi fa star così male… fare all’amore è una cosa magnifica.» «Lo immagino… Oh, vorrei essere morta.» S’incamminarono a passi pesanti giù per il pendio sotto il rovescio di pioggia che a poco a poco si ridusse a un’acquerugiola fredda. Dick era esausto e inzuppato fino alle ossa; la pioggia cominciava a scendergli per il collo. Anne Elizabeth aveva lasciato cadere il suo mazzo di ciclamini. All’arrivo, l’albergatore disse loro che gli altri erano andati a Villa d’Este ma sarebbero tornati presto. Intanto, loro bevvero rum e acqua bollente e si sforzarono di scaldarsi con un braciere in cucina. «Siamo due bei pulcini bagnati» disse argentina Anne Elizabeth. Dick bofonchiò: «Due begli idioti fatti e finiti!». Quando tornarono gli altri, loro erano riusciti ormai a scaldarsi ma
non ad asciugarsi. Fu un sollievo discutere con Barrow, il quale diceva che, se le classi dirigenti odierne avessero conosciuto l’arte di vivere come quegli italiani antichi, lui avrebbe fatto a meno del socialismo. «Ma io non ero affatto convinta che tu fossi ancora socialista» interloquì Anne Elizabeth. «Certo che non lo sono; guarda un po’ come si sono comportati in guerra i socialisti tedeschi, i quali adesso cercano di simulare il pianto degli innocenti e affermano di essersi sempre battuti per la pace.» «È possibilissimo… con… conciliare il socialismo con la fede nel nostro presidente e… ehm… nella democrazia» balbettò Barrow, accostandosi a lei. «Ne parleremo a lungo in altra sede, Anne Elizabeth.» Dick notò come gli venivan fuori gli occhi dalla testa quando la guardava. Scommetto che ha in mente di sedurla, disse a se stesso. Quando salirono in macchina, non si curò se Barrow si metteva a sedere vicino a lei o meno. Il viaggio di ritorno a Roma lo fecero tutto sotto la pioggia. I tre giorni seguenti furono tutti presi dalla visita a Roma del presidente Wilson. Dick fu invitato a varie cerimonie ufficiali, ascoltò un mucchio di discorsi in italiano, francese e inglese, vide una caterva di cappelli a cilindro e di onorificenze e si sbracciò a salutare a dritta e a manca, e gli venne persino il mal di schiena a furia di stare in una rigida posizione militare. Al Foro romano si trovava abbastanza vicino al gruppo del presidente da sentire l’ometto baffuto che additava le rovine del tempio di Romolo dire in un inglese imparaticcio: «Qui tutto ha rapporto con gli eventi della grande guerra». Ci fu uno zittio mentre coloro che si trovavano nei gruppi periferici delle autorità tendevano le orecchie per sentire quello che avrebbe detto il signor Wilson. «È verissimo» rispose Wilson con voce misurata. «E noi non dobbiamo considerare queste rovine come semplici pietre, ma come simboli immortali.» La comitiva emise un lieve mormorio di apprezzamento. Ora l’italiano parlò un poco più forte. Tutte le tube si inchinarono mentre le autorità aspettavano la risposta dell’italiano. «In America» disse questi, con un inchino «voi avete qualcosa di ancor
più grande, ed è celato nei vostri cuori.» La tuba del signor Wilson si drizzò netta e impettita sullo sfondo delle colonne rose dal tempo e delle interminabili susseguenze di pietra lavorata. «Sì,» rispose Wilson «il massimo orgoglio degli americani è quello di aver dimostrato l’immenso amore che portano in cuore per l’umanità.» Mentre il presidente parlava, Dick ne scorse la faccia dietro i piumetti di alcuni generali italiani. Era una faccia grigia, petrigna e fredda, scannellata come le colonne, lunga lunga sotto la tuba. Il sorrisetto che increspava gli angoli della bocca dava l’impressione di esserci stato dipinto sopra in un secondo tempo. Il gruppo proseguì per la sua strada e non fu più a portata d’orecchi. Quella sera alle cinque, quando Dick si incontrò con Anne Elizabeth nell’appartamento di Ed, non poté fare a meno di raccontarle tutto delle onoranze ufficiali. Tutto quello che aveva visto lui era una copia in oro della lupa allattante Romolo e Remo su al Campidoglio, dove il presidente era stato fatto cittadino romano, e la faccia di lui al Foro. «Una faccia terrificante, ti assicuro che è una faccia da rettile, da animale a sangue freddo, oppure la faccia di uno di quegli antichi uomini politici romani che si vede sopra una tomba della via Appia… Sai quello che siamo, Anne Elizabeth? Siamo i Romani del ventesimo secolo!» disse scoppiando a ridere «e io invece volevo essere soltanto un greco.» Anne Elizabeth, che era una grande ammiratrice di Wilson, a tutta prima si seccò di quello che diceva lui. Era nervoso ed eccitato e continuava a parlare e parlare. Per quella volta ella ruppe il suo voto e bevve con lui un po’ di rum caldo, perché la stanza era gelata. Alla luce dei lampioni situati all’angolo delle scale spagnole che si potevano vedere dalla finestra, si scorgeva la tumultuante tenebra di folla in perpetuo andirivieni. «Perdio, Anne Elizabeth, a pensarci è una cosa tremenda… Tu non sai che sentimento ci mette la gente; c’è chi prega per lui nelle capanne dei contadini… oh, noi ignoriamo tutto e li stiamo calpestando tutti come stracci… È il saccheggio di Corinto… credono che lui dia loro la pace, restituisca loro il bel mondo anteguerra. C’è da star male a sentire tutti i discorsi… Oh, Cristo, restiamo umani finché possiamo… Dio ci salvi dall’avere occhi
di rettile e faccia di pietra e inchiostro nelle vene al posto del sangue… Non sarò mai un romano, io!» «Capisco benissimo quello che vuoi dire» commentò Anne Elizabeth, arruffandogli i capelli. «Tu sei un artista, Dick, e io ti amo tanto… tu sei il mio poeta, Dick.» «Vadano tutti all’inferno!» esclamò Dick abbracciandola di colpo. Ad onta del rum caldo, Dick era molto nervoso quando si svestì. Ella tremava quando lui la raggiunse sul letto. Andò tutto bene, ma lei sanguinò molto, e così non fu per loro un gran divertimento. Dopo, a cena, non trovavano una parola da dirsi. Lei rincasò presto e Dick girovagò desolato per le vie tra folle eccitate, bandiere, illuminazioni e divise. Il corso era stipato di gente; Dick entrò in un caffè e vi fu accolto trionfalmente da un gruppo di ufficiali italiani che vollero a tutti i costi offrirgli da bere. Un giovanotto dalla pelle olivastra e dalle lunghissime ciglia nere, che si chiamava Carlo Ugobuoni, gli si improvvisò amico e compagno particolare, e gli fece fare il giro di tutti i tavoli presentandolo come il capitano Salvaggio Riccardo. Tutto a suon di spumante d’Asti e Viva gli americani e Italia irredenta e Mister Vilson che aveva salvato la civiltà e viva la pace, finirono per portare Dick a vedere le belle ragazze. Con suo grande sollievo, nella casa di tolleranza dove andarono non c’era una ragazza libera, e così Dick poté svignarsela, tornare all’albergo e mettersi a letto. Il mattino dopo, quando scese a prendere il caffè, c’era Carlo che lo aspettava nel vestibolo dell’albergo. Carlo aveva molto sonno; non era riuscito a trovarsi una ragazza sino alle cinque del mattino, ma ora era a completa disposizione del suo caro amico per fargli visitare la città. Tutto il santo giorno Dick l’ebbe alle costole, ad onta degli sforzi fatti per liberarsene senza urtarlo nella suscettibilità. L’altro stette ad aspettarlo mentre Dick andava a prendere ordini alla missione militare, fece colazione con lui e con Ed Schuyler: Ed non poteva far altro che levarlo di torno e permettere così a Dick di darsi convegno con Anne Elizabeth nel suo appartamento. Ed uscì a tale proposito in una battuta spiritosissima rilevando che, siccome personalmente aveva perduto Magda, per lui non c’era più niente di buono da fare lì, e quindi era ben felice che la stanza la usasse Dick a scopi venerei. Poi
prese fermamente sottobraccio Carlo e se lo portò via a un caffè. Dick ed Anne Elizabeth furono molto teneri e quieti. Era l’ultimo pomeriggio che passavano assieme. Dick partiva per Parigi quella sera stessa, e Anne Elizabeth attendeva da un giorno all’altro l’ordine di trasferimento a Costantinopoli. Dick promise che avrebbe fatto di tutto per venire a trovarla colà. La sera Anne Elizabeth lo accompagnò alla stazione. Quivi trovarono Carlo che aspettava, un grosso salame involtato in stagnola e una bottiglia di Chianti sotto il braccio. Il compagno di viaggio aveva pensato lui a portare le borse dei dispacci, dimodoché a Dick non rimase che salire in treno. Non gli venivano parole alle labbra; e quando il treno partì fu per lui un sollievo. Non appena presentatosi al colonnello Edgecombe, fu fatto ripartire per Varsavia. In Germania i treni erano tutti in ritardo, la gente aveva un pallore mortale e non si faceva che parlare di una insurrezione bolscevica. Durante una sosta interminabile in una stazione della Prussia orientale, Dick camminava su e giù per il marciapiede coperto di neve, pestando i piedi per tenerli caldi, quando si trovò a faccia a faccia con Fred Summers. Fred era di guardia a un carro di viveri della Croce Rossa, e invitò Dick a tenergli compagnia per un paio di stazioni. Dick andò a prendersi i suoi documenti e lo seguì. Fred si era sistemato nella vettura mettendoci una stufa a nafta, una branda e gran quantità di vino, cognac e cioccolata Baker. Passarono tutta la giornata a conversare mentre il treno percorreva lentamente, a furia di ritmici sobbalzi, una infinita landa grigia gelata. «Questa non è una pace,» diceva Fred Summers «è un massacro bello e buono! Cristo, dovresti vedere i pogrom.» Dick si sbellicava dalle risa. «Per Gerusalemme, sapessi come mi fa bene sentirti parlare, vecchio lazzarone di Fred!… Mi par di tornare ai bei tempi delle Grenadine Guards.» «Gesù, che baldoria era quella!» disse Fred. «Da queste parti invece è un vero inferno, non si può stare allegri… tutti morti di fame e ammattiti!» «Hai fatto un affare a non diventare ufficiale, tu… c’è da parlare sempre in punta di forchetta, e non ci si può mai divertire in santa pace.»
«Gesù, non me la sarei mai aspettata da te, che diventassi capitano!» «C’est la guerre» disse Dick. Tra bere e parlare ci si misero con tanto impegno, che poi Dick ce la fece a malapena a tornarsene al suo scompartimento con la borsa dei documenti. Quando furono alla stazione di Varsavia, Fred venne di corsa con un pacco di stecche di cioccolata: «Eccoti un po’ di generi di conforto, Dick. È quel che Dio fece per coucher avec. In tutta Varsavia non c’è una donna che non sia disposta a fare una nottata intera per una stecca di cioccolata.» Di ritorno a Parigi, Dick andò al tè della signorina Stoddard col colonnello Edgecombe. Il salotto era alto e imponente, con tutti quei pannelli italiani alle pareti e i tendaggi di damasco giallo e arancione; attraverso i fitti pizzi delle finestre si vedevano i rami purpurei degli alberi sul lungofiume, la Senna di giada e l’alta merlettatura di pietra dell’abside di Notre-Dame. «Che stupendo ambiente vi siete creata, signorina Stoddard!» disse il colonnello Edgecombe «e se mi permettete il complimento, la gemma è degna della sua incastonatura.» «Erano bei locali vecchi,» disse la signorina Stoddard «con queste case vecchie c’è una cosa sola da fare: sfruttarle nella maniera più indicata.» E si rivolse a Dick: «Giovanotto, e voi che cosa avete fatto a Robbins quella sera che pranzammo tutti assieme? Non fa che parlare di voi, dice che siete un tipo così brillante». Dick arrossì. «Dopo pranzo prendemmo assieme un bicchiere di Scotch sopraffino… Dev’essere stato quello.» «Be’, bisognerà che vi tenga d’occhio… Io non mi fido di questi giovanotti brillanti.» Bevvero il tè seduti attorno a una stufa antica di ferro battuto. Vennero un maggiore grasso e un tizio della Standard Oil, un certo Rasmussen, dalle mascelle lunghe e pendenti, e in seguito una certa signorina Hutchins a cui la divisa della Croce Rossa stava a pennello facendone risaltare la svelta figuretta. Parlarono di Chartres e delle regioni devastate e dell’entusiasmo popolare che accoglieva dovunque Wilson, e del motivo per cui il signor Clemenceau portava sempre guanti di Lisle grigio. La signorina Hutchins disse che era perché quell’uomo aveva effettivamente artigli al posto delle mani, ragion per
cui lo chiamavano il Tigre. La signorina Stoddard tirò Dick in disparte alla finestra: «Apprendo che siete appena tornato da Roma, capitano Savage… Io ho soggiornato parecchio a Roma, dall’inizio della guerra in poi… Ditemi quello che avete visto… ditemi tutto… Per me non c’è altra città al mondo.» «Vi piace Tivoli?» «Sì, piuttosto; ma è un po’ troppo una località da turisti, non vi pare?» Dick le raccontò il fatterello della rissa all’Apollo, senza fare il nome di Ed, e lei ne fu alquanto divertita. Filavano d’incanto lì alla finestra, osservando i lampioni fiorire verdastri lungo il fiume mentre loro due conversavano; e Dick intanto si chiedeva quanti anni poteva avere quella femme de trente ans. Uscendo, incontrarono nell’atrio Moorehouse. Egli diede a Dick una calda stretta di mano, si dichiarò felicissimo di rivederlo e lo invitò a venire da lui qualche pomeriggio sul tardi: lui stava al Crillon, e lì c’era spesso gente interessante. A Dick quel tè aveva stranamente rialzato il morale, quantunque prima avesse temuto di annoiarvisi a morte. Cominciò a pensare che era ora di congedarsi ormai, e strada facendo, mentre tornavano all’ufficio dove c’era un po’ di lavoro da sbrigare, domandò al colonnello quali passi bisognava fare per ottenere il congedo in Francia. Riteneva di potersi sistemare in qualche modo a Parigi. «Be’, se è questo che cercate, quel Moorehouse fa proprio al caso vostro… Credo che debba dirigere qualche attività pubblicitaria per la Standard Oil… Vi ci vedete come consulente per le relazioni col pubblico, Savage?» E il colonnello rise. «In fin dei conti devo pensare a mia madre» disse Dick serio serio. In ufficio Dick trovò due lettere. Una era del signor Wigglesworth e annunciava la morte di Blake, avvenuta per tubercolosi a Saranac la settimana prima, e l’altra era di Anne Elizabeth: Mio caro, sto lavorando a tavolino in questo miserabile buco che è semplicemente una collezione di vecchi gufi noiosi. Caro, ti amo tanto. Bisognerà che ci vediamo presto. Chissà che cosa direbbero papà e Buster se io mi portassi a casa, tornando da oltremare, un bel marito. A tutta prima farebbero il diavolo a quattro, ma poi credo che ci si adatterebbero. Dio santo, io non voglio saperne di lavorare a tavolino,
voglio viaggiare per l’Europa e vedere quello che c’è da vedere. L’unica cosa che mi vada a genio qui è un mazzetto di ciclamini sul tavolino. Ti ricordi quei bei ciclamini rosa? Ho un raffreddore potente e sono sola come un cane. Questi commissari metodisti per la temperanza e la morale pubblica sono la gente più insopportabile che abbia mai conosciuto. Non hai mai provato la nostalgia, Dick? Credo di no. Fatti rimandare subito a Roma. Oh, come vorrei non essere stata sciocca e sostenuta quella volta dei ciclamini! È difficile essere donna, Dick. Fa’ quello che ti pare ma non dimenticarmi. Ti amo tanto. Anne Elizabeth Quando Dick tornò alla sua camera d’albergo con le due lettere nella tasca interna della mantellina, si buttò lungo disteso sul letto e ci rimase un bel po’ a fissare il soffitto. Poco prima di mezzanotte Henry bussò alla porta. Era appena rientrato da Bruxelles. «Ma che hai, Dick? Guarda un po’, sei verde… uno straccio! Sei malato?» Dick si alzò e andò a sciacquarsi la faccia. «Non ho nulla» farfugliò attraverso l’acqua. «È che ne ho piene le scatole della vita militare.» «Hai addirittura l’aria di aver pianto.» «Sì, per il latte versato» replicò Dick, schiarendosi la gola con una risatina. «Ehi, Dick, ti avverto che sono nei guai, e bisogna che tu mi aiuti a cavarmi d’impiccio… Ti ricordi quella Olga, la ragazza che mi lanciò contro la teiera?» Dick annuì. «Bene, adesso dice che deve avere un bambino e che io sono il fortunato genitore… È semplicemente ridicolo.» «Che vuoi, cose di questo genere capitano più di quanto si creda» disse acidamente Dick. «Ma per Cristo, ragazzo mio, capisci che non voglio saperne di sposare quella cagna, e nemmeno di accollarmi la prole… è da stupido. Anche se è vero che deve avere un bambino, quel bambino con ogni probabilità non è mio… Lei dice che scriverà al generale Pershing. A qualcuno di quei poveri diavoli di fantaccini hanno appioppato vent’anni di galera per stupro… è la stessa storia.» «Un paio ne hanno addirittura fucilati… Grazie a Dio, non facevo parte della Corte marziale.»
«Ma pensa che dolore sarebbe per la mamma… Ora, vedi, tu sai parlar francese meglio di me… Io voglio che tu venga a parlare con lei.» «Va bene… ma sono stanco morto e ho addosso un malumore d’inferno…» Dick indossò la mantellina. «A proposito, Henry, e a quattrini come stai? Il franco sta calando continuamente. Si potrebbe darle un po’ di denaro, e poi tanto si rimpatria presto, e saremo fuori portata di qualunque ricatto.» Henry abbassò lo sguardo. «È dura da confessare al fratello minore… ma l’altra sera ho giocato a poker e mi hanno ripulito le tasche… Sono a terra su tutta la linea.» Si recarono a Montmartre, al posto dove Olga lavorava al guardaroba. Non c’era ancora nessuno, e così lei poté uscire e andare a bere qualcosa con loro al bar. A Dick non riuscì antipatica. Era una bionda ossigenata dal visetto piccolo e impudente e dai grandi occhi castani. Dick mise in opera le sue arti dialettiche per convincerla, dicendo che suo fratello non poteva sposare una straniera per via della famille, e poi non aveva una posizione, e presto avrebbe lasciato l’esercito per tornare a un tavolo di disegnatore… sapeva lei come pagavano male en Amérique un disegnatore in uno studio di architetto? Una miseria addirittura, e con la vie chère e la chute du franc e le dollar forse avrebbe seguito la stessa china, e sarebbe venuta la révolution mondiale, e la miglior cosa che lei potesse fare era di star buona, da brava bambina, e non far nascere il bimbo. Lei si mise a piangere… aveva tanto desiderio di sposarsi e avere bambini, e in quanto a un aborto… mais non, puis non. Pestò i piedi e tornò alla sua cabina di guardaroba. Dick le tenne dietro, e la consolò, e le diede buffetti sulla guancia e disse que voulez-vous, era la vie, e che ne diceva di un regalo di cinquecento franchi? Lei scosse il capo, ma quando lui parlò di mille cominciò a rischiararsi e ad ammettere che que voulez-vous, era la vie. Dick la lasciò di buon umore con Henry, dopo aver combinato un appuntamento per tornare a casa assieme dopo la chiusura della boîte. «Be’, avevo da parte un duecento dollari, vuol dire che sfumano… tu cerca di dilazionare finché non potremo avere un buon cambio… e la prossima volta che giochi a poker, Henry, per carità, sorvegliati.»
Alla vigilia della prima seduta plenaria della Conferenza della pace, Dick si stava precipitando al Crillon per andare a trovare Moorehouse, che aveva promesso di ottenere biglietti d’invito per lui e per il colonnello Edgecombe, quando scorse un volto noto in divisa francese. Era Ripley, appena licenziato dalla scuola francese di artiglieria di Fontainebleau. Disse che era lì per veder di pescare un vecchio amico di suo padre e farsi dare un posto in relazione con le delegazioni di pace. Era al verde, e Marianne la Terza Repubblica non voleva più saperne di lui ammenoché non si arruolasse nella Legione straniera: ma non gli passava neanche per l’anticamera del cervello. Quando Dick ebbe telefonato al colonnello Edgecombe che Moorehouse non era riuscito a procurare i biglietti e che bisognava quindi ritentare attraverso la via gerarchica, andarono a bere insieme qualcosa al Bar Ritz. «Aria di grande occasione» disse Ripley, dando uno sguardo in giro alle divise con decorazioni e ai gioielli delle donne. «“E come farete a tenerli legati al poderetto… Quando han visto Parigi?”» mugugnò Dick. «Mi piacerebbe proprio sapere che cosa farò quando avrò dato un calcio all’esercito.» «Chiedimi qualcosa di facile… oh, un posto purchessia lo troverò bene… e se viene proprio il peggio, mi toccherà tornare e terminare l’università alla Columbia… Cosa pagherei perché venisse la rivoluzione! Non ne voglio sapere di tornare negli Stari Uniti… diavolo, non so neppur io che cosa voglio fare.» Questi discorsi misero Dick sulle spine: «Méfiez-vouz» citò. «Les oreilles ennemies vous écoutent.» «È non è tutto.» «A proposito, hai notizie di Steve Warner?» domandò Dick a bassa voce. «Ho ricevuto una lettera da Boston… credo che gli abbiano dato un anno di carcere per essersi rifiutato di iscriversi nei registri di leva… È fortunato… Tanti di quei poveretti si son buscati vent’anni.» «Be’, son cose che capitano a chi scherza col fuoco» disse Dick ad alta voce. Ripley lo guardò duramente per un secondo ad occhi aggrottati; poi parlarono d’altro. Quel pomeriggio Dick condusse la signorina Stoddard a prendere il tè da Rumplemeyers, e dopo l’accompagnò al Crillon a far visita a Moorehouse. I corridoi del Crillon brulicavano come un formicaio di
movimentate uniformi kaki, marescialli di marina, fattorini civili; da ogni porta aperta prorompeva una raffica di strepito dattilografico. A ogni pianerottolo stavano gruppi di esperti civili parlando a bassa voce, scambiando occhiate con chi passava, scribacchiando annotazioni su taccuini tascabili. La signorina Stoddard afferrò Dick per un braccio con quelle sue dita bianche e affilate: «Ascoltate… è come una dinamo… che cosa può significare, secondo voi?». «Non certo la pace» disse Dick. Nel vestibolo dell’appartamento di Moorehouse essa lo presentò alla signorina Williams, la bionda dal viso affilato e dall’aria stracca che faceva da segretaria. «È un tesoro,» bisbigliò la signorina Stoddard nel passare in salotto «qui non c’è nessuno che lavori come lei.» C’erano molte persone lì, nella luce azzurra che filtrava dalle lunghe finestre. Un cameriere si destreggiava fra i gruppi con un vassoio di bicchieri, e una persona dall’aria di cameriere personale girava in punta di piedi con una bottiglia di porto. Alcuni avevano in mano tazze da tè, altri bicchieri, ma nessuno badava gran che ai nuovi venuti. Da come la signorina Stoddard entrò nella stanza e dal modo in cui Moorehouse le venne un poco incontro, Dick arguì subito che lei era abituata a far da padrona in quella stanza. Fu presentato a varie persone e se ne stette lì per un po’ a bocca chiusa e ad occhi aperti. Il signor Moorehouse gli rivolse la parola e ricordò il suo nome, ma in quel momento preciso annunciarono una telefonata del colonnello House, e Dick non ebbe più agio di parlargli. Mentre usciva, la segretaria, signorina Williams, lo fermò: «Capitano Savage, scusatemi un momento… Voi siete un amico del signor Robbins, vero?» Dick le sorrise. «Ecco, direi piuttosto una conoscenza. Lui mi sembra un uomo molto interessante.» «È un uomo brillantissimo» disse la signorina Williams «ma temo che stia perdendo il suo nerbo… per quanto posso vedere io, qui la situazione è molto demoralizzante… per un uomo. Come si fa a compiere il proprio lavoro in un posto dove ci vogliono tre ore a far colazione, e il resto della giornata poi lo si passa a bere in quei miserabili caffè?» «A voi dunque non piace Parigi, signorina Williams.» «Direi proprio di no.»
«A Robbins invece piace» disse Dick maliziosamente. «Fin troppo» soggiunse la signorina Williams. «Io pensavo che, se voi siete amico suo, potreste aiutarci a rimetterlo in carreggiata. Siamo molto preoccupati per lui. Non si è fatto vedere per due giorni in un momento importantissimo, con contatti importantissimi da stabilire. J.W. si sta ammazzando di lavoro. E temo che finisca per crollare sotto lo sforzo. E non c’è verso di trovare una buona stenografa o una dattilografa di rinforzo… Tutto il lavoro di battitura a macchina cade sulle mie spalle, senza contare che ho già le mie incombenze di segretaria.» «Eh sì, siamo tutti pieni di lavoro fino al collo» disse Dick. «Arrivederci, signorina Williams.» Ella gli sorrise nel ricambiargli il saluto. A febbraio inoltrato, tornando da una lunga e faticosa scappata a Vienna, trovò un’altra lettera di Anne Elizabeth: Dick mio caro, grazie delle belle cartoline. Ho sempre questo lavoro da tavolino e mi sento così sola. Cerca di venire a Roma se puoi. Sta succedendo qualcosa che apporterà un grande mutamento nella nostra vita. Ne sono assai turbata, ma ho tanta fiducia in te. So che sei leale, fanciullone mio, Dick. Oh, bisogna che ti veda a qualunque costo. Se non vieni fra un giorno o due, sono capacissima di buttare tutto all’aria e correre a Parigi. La tua Anne Elizabeth Dick si sentì serpeggiare il freddo per la schiena quando scorse quella lettera nella Brasserie Weber, dove era andato a prendere una birra con un sottotenente di artiglieria, un certo Staunton Wills, che studiava alla Sorbona. Poi ne lesse una di sua madre che si lamentava della solitudine e della tarda età, e un’altra del signor Cooper che gli offriva un posto. Wills parlava di una ragazza vista al Théâtre Caumartin; voleva conoscerla, e domandava a Dick, nella sua veste di esperto in materia, come doveva regolarsi. Dick si sforzò di sostenere la conversazione consigliandogli, quale mezzo sicuro per ottenere un abboccamento, di farle recapitare un biglietto da una maschera; si sforzò di continuare ad osservare la gente che andava e veniva con tanto di ombrelli per la rue Royale, e i tassì bagnati e le lucide auto
militari, ma la sua mente era sconvolta dal panico: lei doveva aver un bambino; e si aspettava che lui, Dick, la sposasse; stava fresca! Presa la birra, se ne andò a spasso con Wills per la riva sinistra della Senna, guardando libri e incisioni antiche nelle librerie di seconda mano, e finì per andare al tè di Eleanor Stoddard. «E perché sei così mesto, Richard?» chiese Eleanor. Si erano già appartati nel vano della finestra, con le rispettive tazzine da tè. Al tavolo, Wills conversava con Eveline Hutchins e un giornalista. Dick inghiottì una sorsata di tè. «Parlare con te è un grande piacere per me, Eleanor» disse poi. «Allora non sono io la causa di questo muso lungo due spanne, se Dio vuole!» «Sai… vi son giorni in cui ci si sente come ristagnare… forse è che non ne posso più della divisa… voglio fare il privato cittadino, tanto per cambiare.» «Non vorrai tornare a casa, immagino?» «Oh, no davvero, ma bisogna pure che ci vada per occuparmi della mamma, almeno se non ci va Henry… Il colonnello Edgecombe dice che mi può far congedare qui, purché io rinunci al diritto di essere riportato in patria a spese dello Stato. Sa Dio se sono disposto a farlo! Non vedo l’ora.» «Perché non ti stabilisci qui… Si potrebbe farti trovare una sistemazione da J.W. … Ti andrebbe a genio di essere uno dei suoi brillanti luogotenenti?» «Sarebbe meglio che la politica di provincia nel Jersey… Mi piacerebbe avere un lavoro per cui ci fosse da viaggiare… Ciò è ridicolo, perché col servizio attuale si può dire che passi la vita in treno, ma non ne sono ancora stufo.» Ella gli carezzò il dorso della mano: «Ecco quello che mi piace di te, Richard: l’appetito che hai per ogni cosa… J.W. mi ha parlato varie volte della vivacità che tu dimostri… e lui è fatto della stessa stoffa, non ha mai perso il suo appetito, ecco perché sta diventando una vera potenza… sai, il colonnello House si consulta sempre con lui… Vedi, io invece l’ho perso, il mio appetito». E tornarono al tavolo da tè. L’indomani venne l’ordine di mandare un uomo a Roma; Dick
colse la palla al balzo. Quando udì al telefono la voce di Anne Elizabeth, si sentì ripercorrere da una gelida ondata di panico, ma fece di tutto per addolcire la voce. «Oh, che caro sei stato a venire, Dick, bambinone mio!» diceva lei. Si incontrarono a un caffè all’angolo di piazza Venezia. Lo mise in imbarazzo la maniera irruenta con cui ella gli corse incontro gettandogli le braccia al collo e lo baciò. «Ma sì, che importa?» commentò lei ridendo. «Ci prenderanno giusto per due americani eccentrici… Oh, Dick, lasciati guardare un po’… Oh, Dick, ragazzo mio, come ero sola senza di te!» Dick aveva un nodo alla gola. «Possiamo cenare assieme, vero?» riuscì a dire. «Ho pensato che si potrebbe rintracciare Ed Schuyler.» Ella scovò un alberghetto in una via secondaria. Dick ci si lasciò portare; dopo tutto, era proprio carina, con quelle guance così rosse, e l’odore dei suoi capelli gli faceva venire in mente l’odore dei ciclamini sulla collina di Tivoli; ma per tutto il tempo che faceva all’amore con lei, sudando e faticando nelle sue braccia, gli martellava in testa questo ritornello: e adesso che faccio, che faccio? Tardarono tanto che Ed, a casa sua, ormai aveva rinunciato alla speranza di vederli. Aveva i bagagli fatti: l’indomani partiva per Parigi, diretto in America. «Ottima combinazione,» disse Dick «faremo il viaggio in treno assieme.» «Questa è l’ultima notte che passo a Roma, signore e signori,» disse Ed «andiamo a fare un cenone coi fiocchi, e al diavolo la Croce Rossa!» Cenarono come papi, con vini di prima qualità, in un posto situato davanti alla Colonna Traiana, ma Dick non riusciva a gustare nulla. Gli sonava falsa come latta negli orecchi la sua stessa voce. Si accorse che Ed faceva grandi sforzi per rianimare la compagnia, ordinando nuove bottiglie, celiando col cameriere, raccontando buffi aneddoti sulle sue disavventure con le signore di Roma. Anne Elizabeth bevve una quantità di vino, disse che le carabiniere del NER non erano poi cattive come le aveva dipinte lei, perché le avevano dato la chiave del portone quando avevano saputo che il suo fidanzato si trovava a Roma per una sera. Continuava intanto a dar di ginocchio nel ginocchio di Dick sotto la tavola, e ad esigere che cantassero Auld Lang Syne. Dopo pranzo fecero una passeggiata in carrozza e si fermarono a
gettar monete nella fontana di Trevi. Terminarono la serata da Ed, seduti su casse da imballaggio, vuotando fino all’ultima goccia una bottiglia di champagne che Ed ricordò improvvisamente di avere, e cantando Auprès de ma blonde. Frattanto Dick si sentiva interiormente lucido e freddo. Fu un sollievo quando Ed annunciò con voce da ubriaco che andava a trovare per l’ultima volta certe graziose signore romane di sua conoscenza, e che nel frattempo lasciava l’appartamento a disposizione dei promessi sposi per la notte. Quando se ne fu andato, Anne Elizabeth gettò le braccia al collo di Dick: «Dammi un bacio, Dick, bambinone mio, perché poi devi riportarmi alla commissione metodista per la temperanza e la morale pubblica… dopo tutto, quella che conta è la morale privata. Oh, come mi piace la nostra morale privata!». Dick la baciò, poi andò ad affacciarsi alla finestra. Aveva ricominciato a piovere. Fragili nastri di luce d’un lampione colpivano d’infilata i gradini dell’angolo delle scale spagnole che si potevano scorgere tra le case. Ella venne ad appoggiargli il capo sulla spalla: «A che pensi, Dick, ragazzone?» «Ecco, Anne Elizabeth, era un po’ che volevo parlartene… sei proprio sicura che?…» «Son già più di due mesi… Non potrebbe essere altro, e poi di tanto in tanto ho un po’ di nausea al mattino. Oggi mi sentivo malissimo, solo che, te lo garantisco, vederti e scordarmene completamente è stata una cosa sola.» «Ma devi renderti conto… che la cosa mi dà tremendamente fastidio. Ci dev’essere bene un rimedio.» «Ho provato l’olio di ricino e il chinino… altri non ne conosco… vedi, io sono una semplice ragazza di campagna.» «Ma qui si tratta di una cosa seria… devi pur fare qualcosa. Chissà quanti dottori se ne occuperebbero… il denaro posso procurarlo io, in un modo o nell’altro… È infernale, devo tornare domani… Ah questa dannata divisa, non me la posso più sentire addosso!» «Ma io ti garantisco che mi piacerebbe tanto avere un marito e un bambino… se il marito fossi tu e il bambino fosse tuo.» «Non posso farci nulla… non ho i mezzi… Nell’esercito non danno
il permesso di sposarsi.» «Non è vero, Dick» disse lei lentamente. Stettero a lungo a fianco a fianco, senza guardarsi, osservando la pioggia sui tetti neri e le fioche strisce fosforescenti delle strade. Ella parlò con voce tremula ed esile: «Dunque non mi ami più». «Ma certo che ti amo, io non so nemmeno che cosa sia l’amore… credo di amare tutte le ragazze graziose… e specialmente te, tesoro.» Dick udì la propria voce risonargli nelle orecchie come se fosse stata quella di qualcun altro: «Abbiamo passato assieme ore deliziose». Lei gli stava coprendo di baci tutto il collo sopra il rigido colletto della mantellina. «Ma, cara, devi renderti conto che io non posso mantenere un bambino finché non ho una carriera assicurata, e poi ho mia madre da mantenere; Henry è così irresponsabile che da lui non posso aspettarmi nulla. Ma ora bisognerà che ti riaccompagni a casa; si sta facendo tardi.» Quando scesero in strada, la pioggia era cessata nuovamente. Le grondaie gorgogliavano tutte, e l’acqua luccicava sotto i lampioni nei canaletti a lato dei marciapiedi. Tutt’a un tratto ella lo schiaffeggiò per gioco, gli gridò: «Ce l’hai!» e scappò di corsa per la strada. Gli toccò inseguirla, imprecando fra i denti. La perse di vista in una piazzetta, e stava già per abbandonare la caccia e tornarsene a casa, quando lei gli saltò addosso d’improvviso da dietro una fenice di pietra situata all’orlo di una fontana. Egli l’afferrò per un braccio. «Non fare la gattina in questo modo!» le disse irritato. «Non vedi che sono preoccupatissimo?» Lei scoppiò a piangere. Quando arrivarono al portone, lei gli si rivolse improvvisamente per dirgli seria seria: «Ascolta, Dick, forse la faccenda del bambino possiamo eliminarla… Proverò con l’andare a cavallo. Dicono tutti che ha efficacia. Ti scriverò… credimi, non sarò mai io a intralciarti la carriera… e so pure che devi avere un po’ di tempo libero per la tua poesia… Tu hai un grande avvenire, ragazzo, lo so… se ci sposassimo lavorerei anch’io». «Anne Elizabeth, sei una fanciulla meravigliosa, forse se non ci fosse di mezzo il bambino potremmo aggiustarci bene.» La prese per le spalle e la baciò sulla fronte. A un tratto lei si mise a saltare come un
grillo, cantando come una bambina: «Evviva, evviva, evviva! Ci sposeremo!». «Suvvia, sta’ un po’ seria, bimba!» «Ma lo sono… fino alla morte» disse lei scandendo le parole. «Senti, non venire a trovarmi domani… ho un mucchio di viveri da controllare. Ti scriverò a Parigi.» Di ritorno all’albergo, gli fece uno strano effetto indossare il pigiama e ficcarsi da solo in quel letto dove aveva passato il pomeriggio con Anne Elizabeth. V’erano le cimici e la stanza era maleodorante, e così passò una nottata infelice. In treno, per tutta la durata del tragitto fino a Parigi, Ed continuò a farlo bere e a parlargli della rivoluzione, affermando di sapere da buona fonte che in Italia per il 1° maggio i sindacati operai avrebbero occupato le fabbriche. Erano diventate rosse l’Ungheria e la Baviera, poi sarebbe stata la volta dell’Austria, poi dell’Italia, poi della Prussia e della Francia; le truppe americane mandate contro i russi ad Arcangelo si erano ammutinate: «È la rivoluzione mondiale, ed è maledettamente bello vivere in un’epoca simile; e saremo maledettamente fortunati se ne usciremo con la ghirba intatta». Dick obiettò immusonito che lui non era di questo parere: gli Alleati padroneggiavano la situazione. «Ma Dick, credevo che tu fossi anima e corpo per la rivoluzione; è la sola maniera di metter fine una volta per sempre a questa porca guerra!» «La guerra adesso è finita, e tutte queste rivoluzioni non sono altro che la guerra a rovescio… Non si può stroncare la guerra mettendo al muro tutti gli avversari. Questo non è che il modo di fare dell’altra guerra.» Si irritarono e discussero con acredine. Dick constatò con sollievo che erano soli nello scompartimento. «Ma Ed, io ti credevo un monarchico.» «Lo ero infatti… ma da quando ho visto il re d’Italia ho cambiato idea… Eh sì, sono per la dittatura, per un bel dittatore su di un cavallo bianco.» Si misero a dormire ai due lati dello scompartimento, inaspriti e ubriachi. Al mattino uscirono barcollando col mal di capo a ricevere l’aria frizzante di una stazione di frontiera, e bevvero cioccolata calda fumante che una francesina dal viso fresco versò loro in grosse tazze bianche. Tutto era coperto di brina. S’alzava il sole vermiglio chiaro.
Ed Schuyler parlò della belle, della douce France, e cominciarono a rappaciarsi. Quando raggiunsero la periferia di Parigi, parlavan già di andare a vedere Spinelli quella sera stessa in Plus ça change. Dopo il lavoro d’ufficio e i particolari da sbrigare e la necessità di mostrarsi rigido e militaresco davanti ai sergenti, era un sollievo incamminarsi per la riva sinistra della Senna, dove le gemme sugli alberi scoppiavano rosee e verdine pallidissime e i bouquinistes chiudevano bottega nel crepuscolo di lavanda via via più cupo, in direzione del quai de la Tournelle dove tutto aveva lo stesso aspetto di due secoli fa, per poi salire lentamente i freddi gradini di pietra della casa di Eleanor e trovarla seduta al tavolino da tè con un vestito avorio e grosse perle al collo, intenta a versare il tè e a rivendere, con quella sua vocina maliziosa, tutti gli ultimi pettegolezzi del Crillon e della Conferenza della pace. Fece a Dick uno strano effetto sentirsi dire, all’atto di salutarla, che per un paio di settimane non si sarebbero rivisti perché lei andava a Roma a svolgere un po’ di lavoro presso quell’ufficio della Croce Rossa. «Che peccato non esserci potuti andare assieme!» osservò Dick. «Sarebbe piaciuto anche a me» disse lei. «Arrivederci, Richard.» Marzo fu un gran brutto mese per Dick. Non aveva più amici vicino a sé, e tutti gli addetti al servizio dispacci lo annoiavano a morte. Quando non aveva da lavorare, la sua camera d’albergo era così fredda che gli toccava andare in un caffè a leggere. Sentiva la mancanza di Eleanor e delle visite pomeridiane a quel suo delizioso appartamento. Continuava a ricevere lettere preoccupanti da Anne Elizabeth; non riusciva a raccapezzarcisi; lei alludeva enigmaticamente alla recente conoscenza, fatta alla Croce Rossa, di un simpaticissimo amico suo che le era stato di grande conforto. E poi, Dick era al verde, perché doveva continuamente prestar denaro a Henry per tacitare Olga. Ai primi di aprile ritornò da uno dei suoi eterni viaggi a Coblenza e trovò all’albergo una lettera di Eleanor, mandata per posta pneumatica. Lo invitava a un picnic a Chantilly con lei e J.W. per la domenica prossima. Partirono alle undici dal Crillon nella Fiat nuova di J.W. C’era
Eleanor nel suo tailleur grigio, e una cospicua signora di una certa età, la signora Wilberforce, moglie di un vicepresidente della Standard Oil, e il signor Rasmussen dalla faccia lunga. Era una bella giornata, e tutti sentivano la primavera nell’aria. A Chantilly visitarono il castello e diedero da mangiare alla grossa carpa nel fosso. Fecero colazione nei boschi, seduti su cuscini di gomma. J.W. fece ridere tutti spiegando il suo profondo odio per i picnic e chiedendo a ciascuno per quale mai ghiribizzo anche le donne più intelligenti dovevano sempre cercar di adescare gli amici ai loro picnic. Dopo aver mangiato andarono in macchina a Senlis a vedere le case che gli ulani vi avevano distrutto nella battaglia della Marna. Nel camminare per il giardino del castello in rovina, Eleanor e Dick rimasero indietro. «Ne sai niente di quando firmeranno la pace, Eleanor?» chiese Dick. «Per adesso pare che nessuno abbia voglia di firmarla… meno che mai gli italiani: hai visto quello che ha detto d’Annunzio?» «Perché il giorno dopo la firma della pace io mi levo di dosso la livrea dello Zio Sam… La sola epoca della mia vita in cui il tempo mi è parso interminabile è quella del servizio militare.» «Ho incontrato una tua amica a Roma» disse Eleanor dandogli un’occhiata di traverso. Dick si sentì correre il freddo per la schiena. «Chi era?» domandò. La sua voce tradiva lo sforzo di mantenerla ferma. «Quella ragazzina del Texas… è una creatura intelligente. Ha detto che sei fidanzato!» La voce di Eleanor era fredda e penetrante come un trapano di dentista. «Ha esagerato un po’,» rispose lui con un risolino «come disse Mark Twain quando diedero la notizia della sua morte.» Dick si accorgeva di arrossire furiosamente. «Lo spero… Vedi, Richard… Io sono vecchia abbastanza da poterti essere zia. Lei è una creatura intelligente… ma tu non dovresti sposarti ancora; naturalmente non è affare che mi riguardi… molti giovani promettenti si sono rovinati con un matrimonio sbagliato… Questo non dovrei dirlo.» «Ma io sono contento che tu abbia tanto interesse per me, credimi, per me vuol dir molto… So benissimo che cosa significhi sposarsi in fretta e pentirsi con comodo. Infatti, a dire il vero, io non ci tengo poi
tanto al matrimonio… ma… non so… Oh, è tutto una cosa così complicata!» «Non complicar mai le cose… Non ne vale mai la pena» disse severamente Eleanor. Dick non rispose nulla. Ella affrettò il passo per raggiungere il resto della comitiva. Nel camminarle a fianco egli ne osservò il profilo freddamente cesellato, lievemente scosso dal contraccolpo dei sobbalzi che i tacchi facevano sul lastricato. D’un tratto ella gli si rivolse ridendo: «Adesso non ti sgriderò mai più, Richard, mai più». Si addensava un acquazzone. Fecero appena in tempo a entrare nell’auto, che cominciò a piovere. Nel viaggio di ritorno gli adorni sobborghi di Parigi apparvero grigi e cupi nella pioggia. Quando si salutarono nell’atrio del Crillon, J.W. fece capire a Dick che nel suo ufficio ci sarebbe stato un posto per lui non appena fosse congedato. Dick andò a casa e scrisse alla madre una lettera gongolante: … Non che qui a Parigi non sia tutto estremamente interessante, o che io non sia giunto a conoscere persone vicinissime agli ambienti dove si decidono e si sanno le cose d’importanza, ma il fatto di indossare una divisa e doversi preoccupare sempre di regolamenti militari, saluti e via dicendo, a quanto sembra impedisce alla mia mente di lavorare. Sarò giù di morale finché non mi potrò rimettere in borghese una volta per sempre. Mi è stato promesso un posto nell’ufficio di John Ward Moorehouse qui a Parigi; lui è un esperto dalle finanze non troppo brillanti, ma non appena sarà firmata la pace conta di avviare nuovamente la sua azienda. È consulente per le relazioni col pubblico e la pubblicità presso grandi imprese come la Standard Oil. Questo è proprio il genere di lavoro che mi permetterà di proseguire per mio conto la mia vera attività. Tutti mi dicono che è un’occasione di quelle che si presentano una volta sola nella vita… La prima volta che vide la signorina Williams, lei gli fece un largo sorriso e gli venne incontro a mano tesa: «Oh, come sono contenta, capitano Savage, J.W. dice che verrete a lavorare con noi… Sono certa che sarà un’esperienza simpatica e vantaggiosa per tutti gli interessati». «Personalmente credo che per me valga l’adagio: Non dir quattro
se non l’hai nel sacco» si schermì Dick. «Oh, ma ormai è cosa fatta» disse la signorina Williams dandogli uno sguardo raggiante. A metà maggio Dick ritornò da Colonia con un brutto regalo preso in una baldoria fatta con due aviatori e qualche ragazza tedesca. Andando con le tedesche si contravveniva a ordini tassativi del Gran Quartier generale, e lui era sui carboni ardenti perché temeva di essere stato visto comportarsi in maniera disdicevole a un ufficiale e a un gentiluomo. Aveva ancora in bocca il sapore del sekt con pesche quando smontò dal treno alla Gare du Nord. In ufficio, il colonnello Edgecombe notò il suo pallore e la sua prostrazione, e lo canzonò parlandogli dei brutti momenti che doveva aver passato in zona occupata. Poi lo rimandò a casa a riposarsi. In albergo trovò una lettera per posta pneumatica, di Anne Elizabeth: “Sono al Continental e devo vederti subito.” Fece un bagno caldo e dormì varie ore. Quando si svegliò era già buio. Ci volle un po’ di tempo perché si ricordasse della lettera di Anne Elizabeth. Stava seduto sulla sponda del letto, occupato ad affibbiarsi di malavoglia i gambali per andare a trovarla, quando sentì bussare all’uscio. Era l’addetto all’ascensore, venuto ad avvertirlo che c’era giù una signora ad attenderlo. Aveva appena finito di parlare, che già Anne Elizabeth accorreva precipitosa dall’atrio. Era pallida e aveva un lato del viso arrossato da una contusione. Un che di rabbioso in quel suo modo di correre diede immediatamente ai nervi a Dick. «Ho detto loro che sono tua sorella e ho fatto le scale di volata» gli disse baciandolo col fiato mozzo. Dick diede all’uomo dell’ascensore un paio di franchi e bisbigliò a lei: «Entra. Che c’è?». Lasciò la porta della camera socchiusa. «Sono nei guai… il Near East Relief mi rimanda a casa.» «E come mai?» «Credo che sia perché mi sono assentata una volta di troppo… Tanto meglio, del resto; mi annoiavano a morte.» «E com’è che ti sei fatta male?» «A Ostia, sono caduta insieme al cavallo… Mi sono divertita sfogandomi a fare equitazione con i cavalli dell’esercito italiano… sono eccellenti.»
Dick le aveva piantato gli occhi in faccia per cercar di scovare la verità. «Be’,» disse «è proprio come dici?… Devo pur saperlo… è una cosa che mi tormenta.» Lei si buttò sul letto a faccia in giù. Dick andò a chiudere delicatamente la porta, camminando in punta di piedi. Lei teneva la testa ficcata nel gomito e singhiozzava. Egli sedette sulla sponda del letto e cercò di far sì ch’ella lo guardasse in faccia. Lei d’un tratto si alzò e prese a camminare per la stanza: «Non c’è niente da fare… io sto per avere il bambino… Oh, sapessi come sono impensierita per il babbo. Temo che muoia se viene a sapere una cosa simile… Oh, tu sei così perfido… sei così perfido.» «Ma, Anne Elizabeth, sii ragionevole!… Non possiamo continuare ad essere amici? Mi è stato appena offerto un buon posto per quando mi sarò congedato, ma non posso accollarmi una moglie e un figlio proprio in questo momento delicatissimo della mia carriera, devi capirlo… e se vuoi sposarti, ebbene, ci son tanti uomini che pagherebbero chissà che cosa per averti come moglie… Sai bene che hai il dono di far colpo… Comunque non credo che il matrimonio abbia importanza.» Ella si accomodò sopra una seggiola, e si rialzò subito. Rideva: «Se ci fossero qui papà o Buster, si avrebbe un matrimonio in quattro e quattr’otto, per amore o per forza… ma non gioverebbe gran che». Il suo riso isterico gli diede ai nervi; egli tremava per lo sforzo di controllarsi e parlare ragionevolmente. «E perché non ti prendi G.H. Barrow? Ha una posizione cospicua e non gli manca il denaro… È pazzo di te, me lo ha detto lui stesso l’altro giorno quando lo incontrai al Crillon… Dopo tutto, le cose bisogna risolverle col buon senso… Non è solo colpa mia, è anche tua… se avessi preso le opportune precauzioni…» Lei si tolse il cappello e si ravviò i capelli allo specchio. Poi versò acqua nella bacinella, si lavò la faccia e si ravviò nuovamente i capelli. Dick non vedeva l’ora che se ne andasse, perché tutto quello che faceva gli dava il parossismo. Lei aveva le lacrime agli occhi quando gli si avvicinò: «Dammi un bacio, Dick… non darti pensiero di me… in un modo o nell’altro mi arrangerò.»
«Sono sicuro che non è troppo tardi per tentare un’operazione» disse Dick. «Domani penso io a trovarti un indirizzo e a mandarti un rigo al Continental… Anne Elizabeth… è veramente splendido da parte tua comportarti così in questa faccenda.» Lei crollò il capo, sussurrò un arrivederci e uscì dalla camera in gran fretta. «Già, così è» si disse Dick ad alta voce. Gli dispiaceva tanto per Anne Elizabeth. Caspita, che fortuna non essere una ragazza! continuava a pensare. Aveva un mal di testa da morire. Chiuse a chiave la porta, si svestì e spense la luce. Quando aprì la finestra, una ventata fredda di aria piovosa invase la stanza e lo fece sentir meglio. Era proprio come diceva Ed: non si poteva muovere un dito senza far degli infelici. Che mondo porco! Le vie prospicienti la Gare SaintLazare brillavano come canali al riflesso dei lampioni. C’era ancora gente in giro, un uomo che strillava InTRANsigeant, il clacson delle auto pubbliche, simile al grido dell’oca selvatica. Pensò ad Anne Elizabeth che se ne andava a casa in tassì per le vie bagnate. Desiderò aver molte vite, in modo da poterne spendere una con Anne Elizabeth. Poteva scriverci una poesia e mandargliela. E il profumo dei ciclamini. Nel caffè dirimpetto i camerieri stavano rovesciando le sedie per metterle sui tavolini. Desiderò avere molte vite, in modo da poter essere un cameriere di caffè occupato a rovesciar sedie. Le saracinesche di ferro strepitavano calando. Era il momento in cui uscivano le donne, camminando su e giù, fermandosi, indugiando, camminando su e giù, al pari di quei giovani ruffiani dalla pelle color fungo. Cominciò a rabbrividire. Si ficcò in letto; le lenzuola avevano una patina attaccaticcia. Eh sì, aveva un bel dire lui, ma Parigi non era il posto da andare a letto soli, non era posto da rincasare soli in un tassì gracidante, nel crepacuore dei tassì gracidanti. Povera Anne Elizabeth. Povero Dick. Giaceva brividendo fra le lenzuola attaccaticce, gli occhi tenuti aperti con spille di sicurezza. A poco a poco si riscaldò. Domani. Sette e mezza: sbarbarsi, affibbiare i gambali… café au lait, brioches, beurre. Chissà che fame avrebbe avuto, non avendo cenato… deux œufs sur le plat. Bonjour messieurs, mesdames. All’ufficio, speroni tintinnanti; sergente Ames,
riposo. Giornata monotona in kaki; al crepuscolo, tè da Eleanor, farla parlare con Moorehouse per assicurare il posto una volta firmata la pace, dirle del defunto generale Ellsworth, ne avrebbero riso assieme. Giornate monotone in kaki sin dopo la firma della pace. Monotonia, squallore, kaki. Povero Dick, bisognerà lavorare dopo la firma della pace. Il povero Tom ha freddo. Povero Dick, ragazzone… Richard… Rattrasse i piedi in modo da poterseli fregare. Poveri piedi di Richard. Dopo la Firma della Pace. Quando ebbe i piedi caldi, era già addormentato. 1. Vale la pena di notare l’espressione curiosa usata dal testo inglese, che dice «according to Hoyle», cioè “in accordo con Hoyle”: Hoyle era uno scrittore inglese del Settecento che si occupava di regole dei giochi delle carte. (NdT) 2. In italiano nel testo; così le espressioni in corsivo che seguono.
Cine-giornale XXXVII LE GUARDIE ROSSE ARRETRANO il comandante in capo americano rese omaggio ai morti e ai feriti, esortò i soldati a ringraziare Dio per la vittoria e dichiarò che si inaugurava per tutti un nuovo aspetto del dovere verso Dio e la Patria. Quando si fece il riscontro dei numeri si trovò mancante quello di Zimzizimi, del signor A. Aumont. Il puledro era stato preso da un accesso di tosse in mattinata, e in conseguenza era stato ritirato quasi all’ultimo momento I REPUBBLICANI SI APPRESTANO A RENDER LA VITA DIFFICILE A WILSON UN MOVIMENTO PER METTERE SOTTO PROCESSO L’EX KAISER A CHICAGO Johnny dàgli col fucile dàgli col fucile dàgli col fucile li abbiamo messi in fuga si annuncia un grande mutamento nella struttura sociale di questo paese, ha dichiarato il signor Schwab, e gli aristocratici dell’avvenire diverranno tali non per nascita o per censo ma perché avranno fatto qualcosa per il bene della nazione GUERRA SPIETATA PER SGOMINARE I ROSSI in fuga sì in fuga! contemporaneamente apparvero davanti al palazzo del cancelliere varie colonne di soldati e marinai. In Germania la situazione si va delineando sempre più nettamente come una lotta a coltello fra i vettovagliamenti americani e il bolscevismo. Lloyd George Prende le Parti di Entrambi nelle Discussioni per la Pace. Oh quella signora francese tatuata tatuata dalla testa ai piedi che meraviglia a vederla MACKAY, DELLE POSTE E TELEGRAFI, DÀ A BURLESON DEL BOLSCEVICO
dimostrazioni popolari contrassegneranno la visita del presidente e dei governanti inglesi e belgi che saranno ricevuti con una serie di festeggiamenti. L’ironia della situazione sta nel fatto che proprio quella libertà di linguaggio e di stampa per cui si batterono a gran voce i socialdemocratici si sta ora dimostrando la principale minaccia per il nuovo governo Di traverso sulla mascella aveva l’aviazione inglese sulla schiena la bandiera inglese che volete di più? il dipartimento della Guerra ha oggi deciso di emanare un circospetto comunicato sul quasi ammutinamento di parte delle truppe americane del settore di Arcangelo e sul loro rifiuto di obbedire all’ordine di andare al fronte, ad onta delle misure di polizia prevalse una certa calma, ma mentre il corteo percorreva le varie arterie, Malakoff, Henri Martin, Victor Hugo, e il Trocadero, e quella parte del quartiere aristocratico di Parigi in cui abitava Jaurès, si aveva la sensazione di camminare su strade minate, in cui il minimo incidente poteva provocare un’esplosione SI FANNO AFFLUIRE RINFORZI PER ABOLIRE I MOTIVI D’ANSIA Su e giù per la spina dorsale c’era la guardia del re in fila e tutto attorno alle anche navigava una flotta di corazzate i lavoratori della Baviera hanno superato le loro divisioni di partito per unirsi in un blocco poderoso contro ogni dominio e sfruttamento; coi Consigli dei lavoratori, soldati e operai essi si sono assunti ormai tutta l’autorità pubblica Proprio sopra i remi c’era una veduta di Sydney a volo d’uccello ma quello che mi piacque di più fu la mia casa del Tennessee tatuata sul suo petto AGLI ABITANTI DELL’EAST SIDE SI DEVE IN GRAN PARTE IL
BOLSCEVISMO, AFFERMA IL DOTT. SIMONS ORDINA CHE I LAVORATORI VENGANO ALLOGGIATI NEI PALAZZI GLI UCRAINI FANNO FUOCO SULLA MISSIONE ALLEATA ora le cose sono al punto che Landru si tende addirittura a ritenerlo responsabile della morte di tutte le donne scomparse in Francia non solo durante lo scorso decennio ma anche per molti altri precedenti
Occhio fotografico (40) percorsi tutta la città a piedi sciopero generale niente autobus niente tassì gli ingressi della metro chiusi place de Iéna vidi bandiere rosse Anatole France con la barba bianca manifesti MUTILÉS DE LA GUERRE e la faccia da schiaccianoci degli agents de sûreté Mort aux vaches in place de la Concorde le guardie repubblicane con elmetti tipo albero di Natale cavalcavano tra la folla dando piattonate ai parigini con le sciabole brani dell’Internationale soldati in elmetto dall’aria preoccupata con armi al piede lungo tutti i Grands Boulevards Vive les poilus alla République à bas la guerre MORT AUX VACHES à bas la Paix des Assassins hanno divelto le inferriate d’intorno agli alberi e stan gettando pietre e pezzi di ghisa contro le guardie repubblicane nelle loro divise fantasia fischiando sibilando dando di punta cogli ombrelli ai cavalli brani dell’Internationale alla Gare de l’Est cantano tutta quanta l’Internationale la gendarmeria nationale si sta aprendo lentamente un varco per rue Magenta fra sassate fischi pezzi di ferro l’Internationale Mort aux Vaches Barricate bisogna costruire barricate giovanetti stan cercando di abbattere le saracinesche di un’armeria la rivoltella spara una vecchia che stava alla finestra fu colpita (Di chi è quel sangue sul lastrico?) stiamo tutti correndo per una stradicciola secondaria svoltando nei cortili portinai che tentano di chiudere i portoni davanti alla cavalleria che carica in fila per dodici facce da prender con le molle spaventate e miserabili sotto quei baffoni sotto quegli elmetti da albero di Natale a un angolo mi imbatto in un amico che corre pure lui All’erta! Tirano ad ammazzare e s’è messo a piovere a dirotto così ci infiliamo giusto in tempo tutti e due in un caffeuccio prima che la saracinesca si abbassi dentro tutto scuro e calmo alcuni operai anziani bevono al bar mugugnando Ah les salops Non ci sono giornali Qualcheduno ha detto che la rivoluzione ha trionfato a Marsiglia e a Lille Ça va taper
dur Beviamo grog americano abbiamo i piedi bagnati al tavolo vicino due uomini di età giocano a scacchi tra un sorso e l’altro di una bottiglia di vino bianco più tardi facciamo capolino da sotto la saracinesca calata per dare un’occhiata alle strade deserte pioggia torrenziale solo un ombrello rotto e un vecchio berretto a quadretti l’uno vicino all’altro nel canaletto pulito e un foglio volante strappato L’UNION DES TRAVAILLEURS FERA
Cine-giornale XXXVIII C’est la lutte finale groupons-nous et demain l’Internationale sera le genre humain FUCILATE ALLA DIETA LAVORATORI DELL’YMCA ARRESTATI PER SOTTRAZIONE DI FONDI dichiara che solo la saggezza del popolo può guidare la nazione in una simile impresa DICE CHE GLI STATI UNITI DEBBONO AVERE LA FLOTTA PIÙ GRANDE DEL MONDO quand’ero in Italia uno zoppicante gruppetto di feriti di guerra italiani mi chiese un’intervista. Non riuscivo ad immaginare che cosa volessero dirmi, e con la massima semplicità, con una semplicità toccante essi mi presentarono una petizione in favore della Lega delle Nazioni. Ribellione di Soldati al Teatro d’Opera Tedesco HA ORDINATO DI LASCIAR MORIRE TUTTI I GRECI TUMULTI DEI CANADESI IN UN ACCAMPAMENTO BRITANNICO In piedi, prigionieri della fame, in piedi, derelitti di tutto il mondo, ché la Giustizia tuona la sua condanna! A qui la Faute si le Beurre est Cher? GRANDE ASCESA DEI GUADAGNI A WALL STREET MOLTI NUOVI PRIMATI NE SOYONS PAS LES DUPES DU TRAVESTI BOLCHEVISTE a Washington prevale l’opinione che, mentre potrebbe riuscire ostico al popolo americano l’invio di truppe in Asia Minore, si sarebbe in genere più favorevoli all’impiego di un contingente armato per ristabilire l’ordine a sud del Rio Grande. Gli scioperanti minacciano di paralizzare completamente la città di New York. L’ordine ristabilito a Lahore. Sciopero delle pompe funebri a Lille MINACCIA DI AMMUTINAMENTO DA PARTE DI TRUPPE AMERICANE LA GIURIA CALIFORNIANA EMETTE UN RAPIDO VERDETTO
CONTRO I LAVORATORI DI SACRAMENTO È la lotta finale, uniamoci, e domani l’Internazionale sarà tutto il genere umano IL CROLLO DEL BOLSCEVISMO È IMMINENTE, DICE UN GENERALE FUGGITO il censore francese non permetterà allo «Herald» di riferire quello che ha fatto la delegazione cinese, ma che ci sia uno stato di seria agitazione sarebbe ozioso negarlo. Non si può certo pretendere che uomini i quali sono stati privati della possibilità di guadagnarsi il pane, che vedono i propri figlioli reclamar cibo a gran voce, che si trovano davanti alla prospettiva di una chiusura delle industrie a tempo indefinito e un’eventuale cessazione del traffico ferroviario, con tutta la disorganizzazione nazionale connessa, considerino la situazione con calma ed equanimità GLI INGLESI FANNO DI TUTTO PER MANTENERE LA PROMESSA DI IMPICCARE IL KAISER si asserisce che i coreani confidano nella venuta per via aerea del presidente Wilson e nella sua benigna attenzione. Una bandiera bianca issata sulla collina di Seoul si presume indichi il luogo di atterraggio
Figlia Non soffrì neanche l’ombra del mal di mare e godette molta popolarità a bordo durante la traversata, che fu molto gaia a dispetto del mare alquanto agitato e del freddo pungente. Un certo signor Barrow, che era stato inviato in missione speciale dal presidente, le dedicò parecchia attenzione. Era un uomo molto interessante e informatissimo su tutto. Veniva dal socialismo ed era stato molto vicino ai lavoratori. Quand’ella gli narrò quello che aveva visto nello sciopero dei tessili a Jersey, lui dimostrò molto interesse. La sera facevano giri e giri di ponte a braccetto, e di tanto in tanto un rollio più forte faceva loro quasi perdere l’equilibrio. Essa ebbe il suo daffare a respingere le sue profferte d’amore, ma vi riuscì definitivamente col dirgli che quello che le serviva ora era un buon amico, che lei aveva appena preso una brutta scottatura in amore e a queste cose non ci poteva più nemmen pensare. Lui fu tanto gentile e comprensivo, e disse che capiva benissimo, perché a sua volta egli era stato sempre assai sfortunato con le donne. Disse che la gente dovrebbe esser libera nell’amore e nel matrimonio, e non legata da convenzioni o inibizioni. Disse che personalmente credeva solo nell’amicizia appassionata. Anche lei convenne in questo, ma quando lui poi le propose di venire nella sua camera d’albergo la prima notte dell’arrivo a Parigi, gli fece una tremenda lavata di capo. Però lui fu così gentile con lei durante il viaggio a Roma da indurla a pensare che, chissà, se l’avesse chiesta in sposa forse lei l’avrebbe anche accettato. Nel treno c’era un ufficiale americano, il capitano Savage, di così bella presenza e parlatore divertente, diretto a Roma con dispacci importanti. Dal momento in cui incontrò Dick, l’Europa fu per lei meravigliosa. Lui sapeva il francese e l’italiano, e parlava della bellezza delle vecchie città rose dal tempo, e arricciava la bocca in un modo così buffo nel raccontare episodi comici della guerra. Somigliava un po’ a Webb, ma molto più simpatico, fiducioso in se stesso e avvenente. Dall’istante in cui lo conobbe dimenticò completamente Joe, e in quanto a G.H. Barrow, non riusciva neanche a sopportarne il pensiero. Quando il capitano Savage la guardava, la
faceva rimescolare tutta dentro; giunti che furono a Roma, ella ammetteva in segreto di esserne già innamorata alla follia. Quando poi andarono a fare una passeggiata a tu per tu, il giorno della gita in comitiva alla villa di Adriano e alla cittadina dove c’era la cascata, ella fu contenta di aver bevuto. Per tutto quel tempo non pensava che a gettarglisi nelle braccia: nel paesaggio piovoso, nelle persone brune dagli occhi lascivi, nei nomi antichi delle città, nell’aglio e olio delle vivande e nelle voci sorridenti e nell’odore di quei fiorellini purpurei chiari che, diceva lui, si chiamavano ciclamini, c’era qualcosa che la induceva a non curarsi più di nulla. Per poco non svenne quando lui prese a farle i suoi approcci amorosi. Oh, lei avrebbe voluto, ma no, no, in quel momento non si sentiva; ma l’indomani poi avrebbe fatto una bella bevuta alla faccia dell’impegno sottoscritto col NER, e… alle stelle! La cosa poi non era sozza come aveva creduto, ma non era neanche straordinaria; ella ne fu tremendamente sgomentata, fredda e in preda al malessere, come quando gli aveva detto che era la prima volta. Ma il giorno dopo la cosa lui fu così gentile e forte, e lei d’un tratto si sentì tanto felice. Quand’egli dovette tornare a Parigi, e non le rimase altro che il lavoro d’ufficio e una schiera di zitelle noiose per compagnia, fu un disastro. Quando si accorse di essere incinta, si sgomentò, ma non eccessivamente: certo lui l’avrebbe sposata. Dapprima papà e Buster se la sarebbero presa, ma poi gli si sarebbero certamente affezionati. Lui scriveva poesie, e una volta congedato dall’esercito avrebbe fatto lo scrittore; lei era sicura che sarebbe diventato famoso. Non scriveva molto spesso, e quando lei lo chiamò a Roma non si dimostrò gentile com’ella aveva sperato; ma d’altra parte doveva essere stato un bel colpo per lui. Decisero che forse sarebbe stato meglio non aver bambini proprio in quel momento e nemmeno sposarsi fino a quando lui non fosse congedato; ma poi si vedeva bene che a lui non passava neanche per la mente di farlo. Allora lei provò vari rimedi e fece molta equitazione col tenente Grassi, che era stato educato ad Eton e parlava perfettamente l’inglese, era tanto cortese con lei e le diceva che era la miglior amazzone tra quante ne aveva conosciute. Fu per la frequenza di queste passeggiate ippiche col tenente Grassi e per la conseguente
abitudine di rincasar tardi la sera che i barbagianni del NER se la presero con lei e la rispedirono in America. Nel viaggio in treno a Parigi, Figlia provò veramente la paura. L’equitazione non era servita a niente, ed era tutta indolenzita per una caduta da cavallo. Era andata così: che uno dei cavalli militari del tenente Grassi era caduto con lei in sella saltando un muro di pietra, e si era rotto una zampa. Il cavallo lo si era dovuto abbattere, e il tenente se l’era presa a morte: questi stranieri, gratta gratta, finivano sempre per combinartene una. A lei dava seriamente da pensare il fatto che la gente notava ormai il suo stato: era già al terzo mese. Lei e Dick dovevano sposarsi in quattro e quattr’otto: ecco tutto. Anzi, sarebbe stato forse meglio dire alla gente che li aveva sposati a Roma un vecchio pretonzolo obeso. Nell’istante preciso in cui vide la faccia di Dick, correndogli incontro nel corridoio del suo albergo, capì che tutto era finito; egli non l’amava nemmen per sogno. Tornò al proprio albergo quasi senza vedere dove andava, per le strade di Parigi viscide di pioggia. Fu sorpresa di arrivarci, all’albergo, perché credeva proprio di aver smarrito la strada. Anzi, l’aveva quasi sperato. Salì in camera e si buttò a sedere in una poltrona senza togliersi cappello e soprabito, che grondavano acqua. Doveva pensare. Questa era la fine di tutto quanto. Il mattino dopo si presentò in ufficio: le diedero i documenti per il viaggio di rimpatrio, le dissero il nome del suo piroscafo e l’avvertirono che doveva partire fra quattro giorni. Dopodiché se ne tornò all’albergo, si rimise a sedere in una poltrona e cercò di pensare. Così non poteva ripresentarsi a Dallas. Arrivò un biglietto di Dick che le indicava l’indirizzo di un dottore. Perdonami! scriveva lui. Sei una ragazza meravigliosa, e sono sicuro che andrà tutto per il meglio. Strappò la sottile lettera azzurra in tanti pezzettini e la buttò dalla finestra. Poi si sdraiò sul letto e pianse fino a bruciarsi gli occhi. Le venne la solita nausea, e dovette uscire nell’atrio per andare al gabinetto. Quando si sdraiò di nuovo sul letto si addormentò per un poco, e si svegliò poi con la fame.
Il giorno si era messo al bello; la stanza era invasa di sole. Scese all’ufficio dell’albergo e telefonò a G.H. Barrow. Lui se ne mostrò contento come una pasqua, e disse che, se aveva la bontà di aspettarlo mezz’oretta, sarebbe venuto a prenderla per andare insieme a far colazione al Bois; avrebbero dimenticato tutto, tranne questo: che era primavera e che loro due erano dei bei pagani in fondo all’anima. Figlia fece la faccia scura, ma al telefono disse con sufficiente buona grazia che sì, lo aspettava. Lui arrivò, e indossava un abito sportivo di flanella grigia e un cappello fedora grigio. Accanto a lui ella si sentiva scialba quanto mai nell’uniforme grigioscura che non poteva soffrire. «Ma lo sai, mia cara bambina… che mi hai salvato la vita?» disse lui. «L-L-l-la primavera mi fa pensare al s-s-s-suicidio se non ho un amore… Mi sentivo… ehm… ehm… vecchiotto e senza amore. Adesso dobbiamo farla finita con questa situazione.» «Anch’io mi sentivo così.» «Ma che hai?» «Be’, forse te lo dirò e forse no.» Oggi quasi le piacevano quel suo naso lungo e quella sua mascella. «In ogni modo ho troppa fame per poter parlare.» «Ci penserò io a tener su la conversazione…» disse lui ridendo. «F-F-f-fa’ sempre c-c-c-come vuoi… e io ti offrirò il p-p-ppasto migliore che tu abbia mai fatto.» Per tutto il tragitto in carrozza egli non fece che parlare con enfasi della Conferenza della pace e della lotta terribile che il presidente aveva dovuto sostenere per salvaguardare i suoi princìpi. «Insidiato da ogni sorta di loschi intrighi, da tutti i velenosi spettri dei trattati segreti, con due avversari che erano fra i più abili e spregiudicati imbroglioni dello statismo europeo… Ha continuato a lottare… tutti noi stiamo proseguendo la lotta… È la più grande crociata della storia; se vinciamo, il mondo sarà migliore e più adattabile, se perdiamo cadrà nelle fauci del bolscevismo e della disperazione… tu non sai, Anne Elizabeth, che stupenda cosa è stata per me sentire la tua vocina graziosa stuzzicarmi improvvisamente l’orecchio al telefono e staccarmi di peso, seppure per poco, da tutto questo groviglio di ansie e responsabilità… ma pensa, si vocifera persino che abbiano tentato di avvelenare il presidente all’Hôtel de Murat… è soltanto il presidente con pochi sostenitori, simpatizzanti e seguaci devoti che si batte per la
causa della probità, della lealtà e del buon senso, non dimenticarlo…» E giù frasi e frasi di questo tono, come se stesse facendo la prova di un discorso. Figlia lo sentiva sì e no, come al telefono quando la linea non funziona bene. E poi la giornata stessa, le piccole pagode di fiori sugli ippocastani, la folla, i bambini ben vestiti, le bandiere contro il cielo azzurro, le vie fiancheggiate da case belle con alberi davanti e intagli in pietra, balconi di ferro e finestre lustrate splendenti al sole di maggio; Parigi era tutta piccola, luminosa e remota come una scena vista dal cannocchiale a rovescio. Quando venne servita la colazione, al grande ristorante all’aperto tutto luccichii, fu la stessa cosa, ella non poteva gustare ciò che mangiava. Lui le fece bere una quantità di vino, e dopo un po’ essa constatò che gli stava parlando. Non aveva mai parlato così a un uomo in vita sua. Lui pareva così comprensivo e gentile. Gli stava raccontando di papà, e com’era stato duro rinunciare a Joe Washburn, e come la traversata oceanica le avesse improvvisamente rinnovato la vita… «Mi è successo qualcosa di strano, te lo garantisco… Una volta andavo d’amore e d’accordo con tutti, e adesso non ci riesco più. All’ufficio NER di Roma non ero capace di andare d’accordo con nessuna di quelle vecchie civette del malaugurio, e feci amicizia con un ragazzo italiano; lui mi accompagnava a cavalcare, e non riuscivo ad andare d’accordo con lui, e il capitano Savage, sai, quello del treno che ci permise di salire nel suo scompartimento, andammo a Tivoli con lui» cominciarono a ronzarle le orecchie quando parlò di Dick. Stava per dire tutto a Barrow. «Filavamo così bene che giungemmo a fidanzarci, e adesso ho litigato con lui.» Vide la lunga faccia ossuta del signor Barrow avvicinarlesi dall’altro capo della tavola. Quand’egli sorrise, fra i suoi anteriori c’era molto spazio. «Annie bella, e credi che con me potresti andare d’accordo un po’?» Le accostò sulla tavola la mano scarna dalle vene rilevate. Ella rise reclinando il capo da una parte: «Mi pare che stiamo filando d’incanto sin d’ora!». «Sarebbe per me una grande felicità se tu potessi davvero… ma in ogni modo tu mi dai tanta felicità anche solo a guardarti… Erano anni che non mi sentivo così felice, tranne forse il m-m-m-m-momento in
cui fu firmato il patto della Lega delle Nazioni.» Essa rise ancora: «Be’, se devo dirtelo non mi sento proprio di essere addirittura un trattato di pace; il fatto è che sono in un guaio tremendo». E gli osservò il viso attentamente: aveva il labbro superiore assottigliato e non sorrideva più. «Be’, d-d-d-dimmi che hai… s-s-s-sse in qualche modo ti potessi… ehm… essere di aiuto… sarei l’uomo più felice del mondo.» «Oh, no… è che, se vuoi saperlo, non posso rassegnarmi a perdere l’impiego e dover tornare a casa in disgrazia… giacché si tratta di questo… ed è tutta colpa mia, non facevo che svolazzare di qua e di là come una sciocca.» A questo punto stava per crollare in una crisi di pianto, ma d’improvviso le tornò la nausea e dovette correre al gabinetto per signore che c’era nel ristorante. Ci arrivò appena in tempo per vomitare. La donna informe dal viso coriaceo che vi era addetta fu molto gentile e comprensiva; e Figlia si sgomentò al vedere con quanta prontezza dimostrasse di capire di che si trattava. Figlia non era una cima in francese, ma capì benissimo che la donna le chiedeva se era il primo figlio di Madame, e quanti mesi erano, e le faceva le congratulazioni. Allora decise tutt’a un tratto di uccidersi. Quando fu di ritorno, Barrow aveva già pagato il conto e camminava sul sentiero di ghiaietta davanti ai tavoli. «Povera bambina» le disse. «Che può mai essere? Ti è venuto un pallore mortale.» «Non è nulla… forse è meglio che rincasi e mi corichi… dev’essere stato tutto quell’aglio e tutti quegli spaghetti che ho mangiato in Italia… oppure chissà, il vino.» «Ma io potrei anche trovarti un posto qui a Parigi. Sei dattilografa o stenografa?» «Ci potrei provare» disse Figlia aspramente. Non poteva soffrire Barrow. Per tutto il viaggio di ritorno in tassì non le riuscì di spiccicar parola. Barrow parlava e parlava. Tornata all’albergo, si sdraiò sul letto e si diede interamente a pensare a Dick. Decise di andare a casa. Si trattenne sempre in camera, e benché Barrow insistesse a telefonarle per invitarla fuori e proporle eventuali impieghi, lei non ne volle sapere di vederlo. Addusse il pretesto di un
attacco biliare che la costringeva a stare a letto. La sera prima della partenza egli la invitò a pranzo in compagnia di amici, e lei accettò, non sapeva nemmeno perché. Egli venne a prenderla alle sei e la portò al Bar Ritz a prendere il cocktail. Lei era andata a comperarsi un abito da sera alle Galeries Lafayette, e si sentiva benone (diceva a se stessa mentre, seduta, beveva il cocktail allo champagne): se ora fosse entrato Dick, lei non avrebbe battuto ciglio. Barrow parlava della situazione di Fiume e delle difficoltà che il presidente incontrava al Congresso, e del suo timore che tutta quanta la grande opera della Società delle Nazioni fosse in pericolo, quando eccoti entrare Dick, elegantissimo nella sua divisa, con una donna pallida in grigio, più anziana di lui, e con un uomo alto e biondo, piuttosto corpulento, che Barrow indicò come J. Ward Moorehouse. Dick doveva averla vista, ma non la guardava. A lei non importava più niente di niente. Finirono i cocktail e uscirono. Nell’andare a Montmartre si lasciò dare da Barrow un lungo bacio sulla bocca che lo ringalluzzì tutto. A lei non importava niente: aveva deciso di uccidersi. Al tavolo che Barrow aveva prenotato all’Hermitage li attendevano un corrispondente di giornali di nome Burnham e una certa signorina Hutchins che lavorava nella Croce Rossa. Quei due erano agitatissimi per via di un certo Stevens che era stato arrestato dall’esercito di occupazione, probabilmente sotto l’imputazione di propaganda bolscevica, pensavano loro; era stato deferito alla Corte marziale, e loro temevano che finisse al muro. La signorina Hutchins era assai sconvolta, e diceva che Barrow avrebbe dovuto andare a parlarne al presidente non appena Wilson tornasse a Parigi. Nel frattempo, bisognava far dilazionare l’esecuzione. La Hutchins disse che Don Stevens era un giornalista e, quantunque radicale, estraneo a qualsiasi propaganda, e in ogni modo era orribile fucilare un uomo per il solo fatto che voleva un mondo migliore. Barrow ne fu imbarazzatissimo, prese a balbettare e a costellare le sue frasi di ehm! e uhm!, e disse che Stevens era un giovanotto molto sciocco che parlava troppo di cose che non capiva, però lui da parte sua avrebbe ritenuto suo dovere far di tutto per tentar di levarlo da quel po’ po’ di guaio, ma in fondo Stevens non aveva dato prova di spirito
patriottico… Allora la signorina Hutchins scattò: «Ma lo fucileranno!… e se fosse capitato a voi?» continuava a dire. «Non capite che dobbiamo a tutti i costi salvargli la vita?» Figlia non sapeva che dire, perché non era al corrente dell’argomento di quella conversazione; se ne stava semplicemente seduta lì nel ristorante a guardare i camerieri e le luci e la gente ai tavoli. Dirimpetto c’era una comitiva di avvenenti ufficialetti francesi. Uno di questi, un tipo alto dal naso grifagno, la stava osservando. I loro sguardi si incontrarono, e lei non poté trattenere un sorriso. Pareva che quei ragazzi si stessero divertendo un mondo. Una comitiva di americani agghindati come cavalli di stoppa traversò la sala passando tra lei e i francesi. Erano Dick, la donna pallida, J. Ward Moorehouse e una grossa donna di mezza età tutta sbuffi rosa e smeraldi. Sedettero al tavolo attiguo a quello di Figlia, dove infatti sin dall’inizio aveva campeggiato la scritta: “Réservée”. Si fecero le reciproche presentazioni, e lei e Dick si strinsero la mano con molta compassatezza come se fossero stati semplici conoscenti alla lontana. La signorina Stoddard, con la quale aveva avuto rapporti così amichevoli a Roma, le lanciò una fredda occhiata indagatrice che la fece star male. La signorina Hutchins passò immediatamente all’altro tavolo e cominciò a parlare di Don Stevens e a tentar di indurre Moorehouse a telefonare su due piedi al colonnello House per farlo intervenire di persona. Moorehouse dimostrò molta calma e ponderatezza, e le disse che poteva star tranquilla, ne era sicuro, perché Stevens probabilmente lo avevano arrestato soltanto per interrogarlo, e comunque secondo lui la Corte marziale dell’esercito di occupazione non avrebbe certo adottato misure estreme contro un civile che per di più era cittadino americano. La signorina Hutchins disse che a lei interessava semplicemente una dilazione, perché il padre dell’arrestato era amico di La Follette e avrebbe potuto far leva su molte aderenze a Washington. Al sentir ciò Moorehouse sorrise: «Se la sua vita dipendesse dall’influenza del senatore La Follette, allora sì che dovreste allarmarvi, Eveline, ma credetemi, non è così». La signorina Hutchins si mostrò molto indispettita a queste parole, e si
rimise tutta imbronciata a consumare la sua cena. La serata però era rovinata. Figlia non poteva capire il vero motivo di quel gelo che aveva preso tutti; forse lo immaginava per via di quello che c’era fra lei e Dick. Di tanto in tanto gli lanciava un’occhiata con la coda dell’occhio. Com’era diverso da quello che aveva conosciuto; seduto lì tutto damerino e in punta di forchetta, e ogni tanto rivolgeva la parola con un basso bisbiglio ostentato alla donna corpulenta in rosa. Le veniva voglia di tirargli un piatto sulla testa. Fu un sollievo quando l’orchestra attaccò a sonar musica da ballo. Barrow non era un ballerino molto in gamba, e a lei non andava quel suo modo di premerle la mano e darle buffetti sul collo. Finito che ebbero di ballare, andarono al bar a prendere un gin soda. Il soffitto era tutto addobbato in tricolore; c’erano i quattro ufficiali francesi; c’era gente che cantava La Madelon de la victoire, e tutte le ragazzine allegre ridevano e vociavano in francese. Intanto Barrow non faceva che sussurrarle all’orecchio: «Fanciulla mia cara, stanotte devi lasciarti accompagnare a casa da me… Non devi partire… Sono sicuro di poter aggiustare tutto con la Croce Rossa, o che altro è… Ho fatto sempre una vita così infelice, e adesso mi ammazzerei se dovessi rinunciare a te… non potresti amarmi almeno un po’… Ho dedicato la vita a ideali irraggiungibili, ed eccomi qua, condannato a invecchiare senza carpire la vera felicità nemmeno per un momento. Tu sei la sola ragazza che dimostri davvero di essere una bella pagana nel profondo del cuore, tra quante ne ho conosciute… apprezza l’arte della vita.» Poi le diede un bacio umido sull’orecchio. «Ma, George, io adesso non posso amare nessuno… Odio tutti.» «Lascia che te lo insegni… dammene almeno la possibilità.» «Se tu sapessi tutto di me, non mi vorresti» disse freddamente. E di nuovo colse una buffa espressione sgomenta sul suo volto e un assottigliarsi delle labbra sui suoi denti così staccati. Tornarono al tavolo. Quivi essa stette sulle spine mentre tutti gli altri parlavano attentamente e con lunghe pause del trattato di Pace, della sua probabile data di firma, e se i tedeschi avrebbero firmato. Poi non ci resistette più e andò nel gabinetto per signore a incipriarsi il naso. Tornando al tavolo si affacciò al bar per vedere che cosa vi stesse
succedendo. L’ufficiale francese dal naso di falco la scorse, balzò in piedi, batté insieme i tacchi, salutò, s’inchinò e disse in un inglese incerto: «Incantevole signora, non volete fermarvi un momento e bere una sola volta col vostro umile servo?». Figlia andò a sedersi al loro tavolo. «Mi pare che voialtri ragazzi vi steste divertendo un mondo» disse. «Io sono con quegli insopportabili cavalli di stoppa… Mi annoiano.» «Permettez, mademoiselle» disse lui presentandola ai suoi amici. Era un aviatore. Erano tutti ufficiali d’aviazione. Lui si chiamava Pierre. Quando ella disse che aveva avuto un fratello aviatore, morto in servizio, furono molto gentili con lei. Non poté fare a meno di lasciar credere che Bud fosse morto al fronte. «Mademoiselle,» disse solennemente Pierre «permettetemi, con tutto il rispetto possibile, di essere vostro fratello.» «Stringiamoci la mano» disse lei. Si strinsero tutti solennemente la mano; stavano bevendo bicchierini di cognac, ma dopo di ciò ordinarono champagne. Lei ballò con tutti. Era tanto contenta e non le importava nulla di quello che poteva succedere. Erano giovani dall’aspetto simpatico, sempre ridenti e compiti con lei. Si erano presi per mano e stavano ballando il girotondo in mezzo alla sala mentre tutti gli astanti intorno battevano ritmicamente le mani, quando lei vide sull’uscio la faccia rossa e indignata di Barrow. Non appena la porta, girando, le passò ancora davanti agli occhi, essa gridò voltandosi indietro: «Vengo fra un minuto, signor precettore». La faccia sparì. Le girava la testa, ma Pierre la prese e la tenne salda; era profumato, ma con tutto ciò a lei piaceva un mondo farsi tener così stretta da lui. Egli propose di andare in qualche altro posto: «Mademoiselle Sistèr,» sussurrò «permetteteci di mostrarvi i mystères de Paris… e dopo possiamo tornar qui dai vostri cavalli di stoppa. Probabilmente a quell’ora saranno già brilli… i cavalli di stoppa diventano sempre brilli». Risero tutti. Lui aveva gli occhi grigi e i capelli chiari, e disse di essere un normanno. Lei gli disse che era il più simpatico francese ch’essa avesse mai conosciuto. Le ci volle del bello e del buono a ricuperare il soprabito dal guardaroba, perché non aveva la marchetta di riscontro, ma entrò a pescarselo da sola mentre Pierre parlava in francese all’addetta. Montarono in un’auto lunga e grigia; Figlia non
aveva mai visto una macchina correre così. Ma Pierre era un bel guidatore: aveva un trucco speciale, di correre a tutta velocità contro un gendarme per poi schivarlo con una sterzata all’ultimo momento. Lei gli fece osservare che a quel modo poteva finire per investirne uno; lui si strinse nelle spalle e rispose: «Non importa… quelli sono… come dite voi?… sudice vacche». Andarono da Maxim, dove però c’era troppa quiete per loro, e poi in una saletta da ballo ordinaria dall’altra parte di Parigi. Figlia poté constatare che Pierre era conosciutissimo dovunque, e che era per di più un asso. Gli altri aviatori incontrarono ragazze in vari luoghi e un po’ alla volta si staccarono. E così un bel momento, senza neanche essersene accorti, lei e Pierre furono soli nella lunga automobile grigia. «Per prima cosa» spiegava lui «andremo alle Halles a mangiare soupe à l’oignon… e poi vi farò fare un giretto en avion.» «Oh sì, che bellezza! Non sono mai stata in aereo… Mi piacerebbe volare e fare il giro della morte… promettetemi che farete il giro della morte.» «Entendu» disse lui. Sedettero un po’ assonnati in un posticino libero a mangiare soupe à l’oignon e a bere dell’altro champagne. Lui era sempre gentilissimo e controllato, ma pareva avesse esaurito il suo inglese. Lei aveva in mente un vago pensiero di tornarsene all’albergo e prendere il treno che doveva portarla all’imbarco, ma invece tutto quello che le riuscì di dire fu: «Fa’ il giro della morte, promettimi che farai il giro della morte». A lui s’erano un po’ velati gli occhi: «Con Mademoiselle Sistèr non faccio all’amore… faccio il giro della morte». Il tragitto in macchina al campo di aviazione fu lungo. Cominciava a sfiorare tutte le cose un fioco grigiore d’alba. Pierre non riusciva più a guidar diritto, tanto che le toccò di afferrare il volante una o due volte per tenerlo in carreggiata. Quando si fermarono al campo con un sobbalzo, ella vide la fila di aviorimesse e tre aeroplani che spiccavano in blu cupo, e, sullo sfondo, filari di pioppi contro l’orlo argenteo della pianura. Sopra le loro teste il cielo pendeva floscio come una tenda bagnata. Figlia smontò dall’auto rabbrividendo. Pierre aveva l’andatura un po’ malferma. «Forse tu preferirai andare a letto… a letto si sta molto bene» disse sbadigliando. Ella lo cinse con le braccia: «Mi hai promesso che mi avresti presa a bordo e che avresti fatto il
giro della morte.» «Va bene» disse lui stizzito, e si diresse a uno degli apparecchi. Armeggiò un poco col motore, e intanto bestemmiava in francese. Poi andò nell’aviorimessa a svegliare un meccanico. Figlia rimase lì a tremar di freddo nella crescente luce argentata. Non voleva pensare a nulla. Voleva andare in aeroplano. Le doleva il capo, ma non sentiva nausea. Quando venne il meccanico con Pierre, ella capì che discuteva con lui per tentare di farlo desistere da quel volo. Lei si impuntò con rabbia: «Pierre, mi devi far volare» gridò ai due uomini che discutevano sonnacchiosi in francese. «D’accordo, Mademoiselle Sistèr.» La infagottarono per bene in un pesante cappotto militare e la legarono accuratamente con le apposite cinghie al seggiolino dell’osservatore. Pierre montò sul seggiolino del pilota. Era un monoplano Blériot, disse lui. Il meccanico diede l’avvio all’elica. Il motore rombò. Il suo fragore riempì lo spazio. D’improvviso la colse lo sgomento: in una pausa di lucidità, pensò a casa sua, a papà e Buster e al piroscafo che doveva prendere l’indomani, macché, oggi! Parve interminabile il tempo, con quel ruggito di motore. La luce era più chiara. Essa prese ad armeggiare con le cinghie per slacciarle. Era da pazzi andare in volo a questo modo. Bisognava prendere quella nave. L’aeroplano era partito. Stava rimbalzando sul campo, rimbalzava correndo sul terreno. Erano sempre a terra, e si rimbalzava. Chissà, forse non sarebbe salito. Sperò che non salisse. Un filare di pioppi passò sotto di loro come una ventata. Il rombo del motore si era fatto regolare, adesso, si stava guadagnando quota. Era giorno; le brillò in faccia un freddo sole d’argento. Sotto di loro c’era un pavimento di spesse nuvole bianche, come una spiaggia. Lei aveva un freddo tremendo, e l’assordava il rombo del motore. L’uomo dagli occhiali protettivi che le stava davanti si voltò e le gridò qualcosa. Lei non poté udire. Si era dimenticata di Pierre. Stese la mano verso di lui e descrisse con essa un semicerchio. L’apparecchio continuava a guadagnar quota. Ella cominciò a vedere colline che emergevano nella luce da ambo i lati della bianca spiaggia di nuvole, doveva essere la valle della Senna piena di nebbia; dov’era Parigi? Si stavano tuffando a capofitto nel sole, no, no, non farlo, è la fine. Le nuvole bianche erano un soffitto sopra di loro, il sole girò attorno all’apparecchio una
volta, prima rapidamente, poi adagio, poi l’aereo riprese a salire. Lei si sentiva malissimo, aveva una gran paura di svenire. Quando si moriva doveva essere così. Forse avrebbe abortito. Il corpo le pulsava rintronato dal rombo del motore. Le rimaneva appena appena la forza di stender la mano verso di lui e far lo stesso gesto. Ancora la stessa cosa di prima. Stavolta non si sentì tanto male. E ora stavano nuovamente salendo nel cielo azzurro, e si doveva essere alzato il vento, perché l’aereo andava un po’ a sbalzi, e una volta poi cadde bruscamente in un vuoto d’aria; era da morire. La faccia dagli occhiali protettivi si voltò oscillando lateralmente. A lei parve proprio che le labbra formassero le parole: «Non va»; ma ora poté vedere Parigi sotto di sé come un portaspilli ricamato, con tutti i campanili, la Tour Eiffel e le torri del Trocadero che bucavano una bruma lattiginosa. La chiesa del Sacré-Cœur a Montmartre era candidissima, e proiettava un’ombra netta sul giardino che pareva una carta topografica. Poi tutto ciò fu alle loro spalle, e si girava sull’aperta campagna. Il volo era instabile, e lei ricominciò col malessere. C’era un suono lacerante, di natura imprecisabile. Un esile filo metallico che oscillava libero e luccicava nell’azzurro prese a gemere. Lei tentò di gridarlo all’uomo dagli occhiali. Lui si voltò, vide il suo gesto e si tuffò un’altra volta in picchiata. Stavolta. No. Parigi, la Tour Eiffel, il Sacré-Cœur, i campi verdi turbinavano. Si stava riprendendo quota. Figlia vide il fulgore metallico di un’ala che se ne andava per conto suo, un po’ discosto dall’apparecchio. Il sole roteante la accecò durante la caduta.
Cine-giornale XXXIX lo spettacolo dei villaggi ridotti in macerie e della terra martoriata, “opera dei demoni”, strazia il cuore al signor Hugh C. Wallace durante la sua visita alle regioni devastate e crivellate dai bombardamenti I CARRI ARMATI WHIPPET NELLA QUINTA STRADA SUSCITANO ENTUSIASMO PER IL PRESTITO GLI STATI UNITI MOBILITANO IN ORIENTE CONTRO LA MINACCIA GIAPPONESE Britannia, impera, impera sulle onde i britanni non saran mai schiavi GIOVANE DONNA TROVATA STRANGOLATA A YONKERS i socialrivoluzionari sono gli agenti di Denikin, Kolcˇak e le Armate Imperiali Alleate. Io sono stato uno degli organizzatori del Soldiers, Sailors and Workmen’s Council a Seattle. In questa adunanza c’è lo stesso sentimento che si manifestò alla nostra prima adunanza di Seattle, a cui presenziarono 5000 uomini in divisa. L’EX KAISER PASSA ORE INTERE A SCRIVERE. A dirla schietta, essi debbono scegliere fra socialismo rivoluzionario e anarchia. L’Inghilterra si è già buttata a capofitto nel socialismo, la Francia esita, il Belgio se n’è andato, l’Italia se ne sta andando, mentre l’ombra di Lenin ingigantisce sempre più sulla conferenza. DIECI NAVI CALARONO UNA BARRIERA DI MORTE IMPROVVISA DALLE ORCADI ALLO SKAGERRAK NON C’È CARBONE? PROVATE LA TORBA Se volete trovare i generali lo so io dove sono se volete trovare i generali lo so io dove sono le masse ignorano tuttora come sia iniziata la guerra, come sia stata condotta e come sia terminata, ha dichiarato Maximilian Harden. Il ministero della Guerra è stato assalito da dimostranti che ne han trascinato fuori a forza Herr Neuring gettandolo poi nell’Elba, dove è
stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre tentava di guadagnare la riva a nuoto WILSON DICHIARA AL CONGRESSO CHE L’ALTO COSTO DELLA VITA È DOVUTO A SUBDOLE MANOVRE Io li ho visti li ho ben visti laggiù in fondo alla trincea
Occhio fotografico (41) non venite al picnic anarchico? ma certo, c’è un picnic anarchico devi venire al picnic anarchico oggi pomeriggio fu fuori città a Garches in una specie di parco ci volle molto tempo per arrivarci facemmo tardi c’erano giovincelli e giovanette con gli occhiali e vecchi coi favoriti e lunghe basette bianche e tutti portavano cravatte nere a farfalla qualcuno s’era levato scarpe e calze e girovagava così nell’erba alta un giovanotto con cravatta a farfalla leggeva una poesia Voilà disse una voce c’est plutôt le geste prolétaire era un bel pomeriggio ci sedemmo sull’erba e ci guardammo attorno per vedere le geste prolétaire Ma dannazione nel mondo hanno tutte le mitragliatrici tutte le rotative linotype nastro telegrafico ferri da ricci cavalli di stoppa Ritz e noi tu e io? mani nude qualche canzone non molto bella plutôt le geste prolétaire Les bourgeois à la lanterne nom de Dieu et l’humanité la futurité la lutte des classes l’inépuisable angoisse des foules la misère du travailleur tu sais mon vieux sans blague faceva freddo prima estate baluginante frammezzo agli alberi di foggia settecentesca quando prendemmo la via del ritorno io mi misi a sedere sull’imperiale della vettura di terza classe con la figlia del Libertaire (ma quello è il nostro Patrick Henry dopo tutto o questo o la morte) una ragazza in gamba suo padre diceva lei non la lasciava mai uscire sola non le lasciava mai vedere giovanotti era come stare in convento lei voleva libertà fraternità eguaglianza e un giovanotto per accompagnarla a spasso nelle gallerie l’acido carbonico ci faceva tossire e lei voleva l’Amérique la vie le théâtre le five o’clock le smoking le foxtrot era una bella ragazza sedevamo a fianco a fianco sul tetto della vettura e guardavamo la periferia di Parigi un deserto di casette in mattoni a pan di zucchero che si appiattivano sotto la vasta penombra della sera lei ed io tu sais mon ami ma che razza di mondo ladro è questo?
Cine-giornale XL UN DETENUTO IN PIGIAMA SEGA LE SBARRE; SCALA I MURI; PRENDE IL VOLO Italiani! contro tutto e tutti ricordate che a Fiume è acceso il faro e che tutte le arringhe sono contenute in queste parole: Fiume o Morte. Criez aux quatre vents que je n’accepte aucune transaction. Je reste ici contre tout le monde et je prépare de très mauvais jours. Criez cela je vous prie à tue-tête il bando di arruolamento menziona la possibilità di procacciarsi nastrini d’oro, di far caccia grossa ed emozionanti sport acquatici, senza contare il vantaggio di viaggiare all’estero Chi va piano va sano chi va forte va alla morte evviva la libertà 1 IN ITALIA IL TERREMOTO PRODUCE DEVASTAZIONI PARI A QUELLE DELLA GUERRA il solo modo in cui possono viaggiare le ragazze dell’YMCA è a bordo di navi adibite a trasporto truppe; parte della flotta andrà verso il mare aperto per aiutare Wilson DEMPSEY METTE FUORI COMBATTIMENTO WILLARD ALLA TERZA RIPRESA Ils sont sourds Je vous embrasse Le cœur de Fiume est à vous. 1. In italiano nel testo. (NdT)
Joe Hill Un giovane svedese di nome Hillstrom si diede alla vita di mare, si fece i calli a bordo dei velieri e dei cargo senza rotta fissa, imparò l’inglese nel castello di prua dei piroscafi che fanno la spola tra Stoccolma e Hull, sognò il sogno svedese dell’Occidente; quando andò in America gli diedero da pulire le sputacchiere in un locale di Bowery. Si trasferì a occidente, a Chicago, e si mise a lavorare in una fabbrica di macchine. Si trasferì ancora ad occidente e seguì il raccolto, bazzicò le agenzie di collocamento, sborsò vari dollari per ottener lavoro in un cantiere di costruzioni, se la filò via a parecchie miglia di distanza quando il mangiare era troppo cattivo o il principale troppo duro, quando c’erano troppe cimici nel dormitorio; lesse Marx e il preambolo all’Internazionale comunista e sognò di formare la struttura della nuova società entro il guscio di quella vecchia. Si trovò in California per lo sciopero della Southern Pacific (“Casey Jones, due locomotive, Casey Jones”), prese a sonare la concertina alle porte dei dormitori, dopo cena, di sera (“Ogni notte vengono predicatori dalla lunga capigliatura”), e dimostrò un raro estro per adattare parole ribelli a motivi preesistenti (“E l’unione fa la forza”). Lungo la costa, nelle cucine popolari, negli alberghi di basso rango, negli accampamenti di fortuna, gli iscritti all’Internazionale comunista, i lavoratori alla giornata, i vagabondi cominciarono a cantare le canzoni di Joe Hill. Le cantarono nelle prigioni di contea dello Stato di Washington, dell’Oregon, California, Nevada, Idaho, nelle carceri provvisorie del Montana e dell’Arizona, le cantarono a Walla Walla, San Quentin e Leavenworth, formando le strutture della nuova società dentro le carceri di quella vecchia. A Bingham, Utah, Joe Hill organizzò i lavoratori della Utah Construction Company nella One Big Union, strappò una nuova scala salariale, una riduzione di orario, miglioramenti nel vitto. (All’angelo
Moroni non andavano a genio gli organizzatori sindacali più che alla Southern Pacific.) L’angelo Moroni mosse i cuori dei mormoni a decidere che era stato Joe Hill a uccidere con arma da fuoco un droghiere di nome Morrison. Il console svedese e il presidente Wilson si adoperarono per ottenergli una revisione del processo, ma l’angelo Moroni mosse i cuori della Corte Suprema dello Stato dello Utah a confermare il verdetto di colpabilità. Joe stette in carcere un anno, e continuò a far canzoni. Nel novembre 1915 fu messo al muro nel cortile della prigione di Salt Lake City. «Non piangetemi, organizzate» fu l’ultima parola d’ordine che mandò agli operai dell’Internazionale comunista. Joe Hill stette là dritto contro il muro del cortile, guardò le bocche dei fucili e diede lui stesso l’ordine di fuoco. Gli misero addosso un vestito nero, un colletto rigido attorno al collo e una cravattina ad arco, lo mandarono a Chicago perché gli si facesse un funerale di prima classe e fotografarono la sua bella maschera impietrata che fissava il futuro. Il 1° maggio dispersero le sue ceneri al vento.
Ben Compton La storia di tutta la società sinora esistita è storia della lotta di classe… I suoi erano ebrei, ma a scuola Benny diceva sempre che no, lui non era un ebreo, era un americano, perché era nato a Brooklyn ed abitava al numero 2531 della Venticinquesima Avenue, quartiere Flatbush, e la casa che abitava era di proprietà della sua famiglia. L’insegnante della settima disse che era strabico e lo rimandò a casa con una nota accompagnatoria, così papà sottrasse un pomeriggio di lavoro alla gioielleria dove attendeva a riparar orologi con una lente all’occhio, per portare Benny da un oculista, il quale gli mise certe gocce negli occhi e gli fece leggere minuscoli caratteri stampati sopra un foglio bianco. Papà si mostrò compiaciuto quando l’oculista disse che Benny doveva portare occhiali: «Occhi da orologiaio… ha preso dal suo vecchio» disse dandogli un buffetto sulla guancia. Gli occhiali di acciaio gli pesavano sul naso, a Benny, e gli facevano male dietro le orecchie. Gli fece uno strano effetto sentir dire a papà, rivolto all’oculista, che un ragazzo con gli occhiali non avrebbe fatto il perdigiorno e il giocatore di baseball come Sam e Isidore, ma si sarebbe dedicato agli studi e sarebbe riuscito un bell’avvocato e un letterato, come gli uomini del buon tempo antico. «E, chissà, fors’anche un rabbino» disse l’oculista, ma papà disse che i rabbini erano dei fannulloni che succhiavano il sangue dei poveri; lui e la sua vecchia rispettavano ancora la legge mosaica in fatto di dieta ed osservavano il sabato come i padri, ma in quanto alla sinagoga e ai rabbini… e abbozzò con le labbra un sibilo di sputo. L’oculista rise e disse che personalmente lui era un libero pensatore, ma che la religione andava benone per il popolo. Tornati a casa, la mamma disse che con gli occhiali Benny invecchiava tremendamente. Sam e Izzy strillarono «Ehilà, quattr’occhi!» quando rientrarono dopo aver venduto giornali, ma l’indomani a scuola dissero agli altri ragazzi che sfottere uno perché portava gli occhiali era un delitto da galera. Una volta che ebbe gli occhiali, Benny fece molto profitto a scuola. Alla scuola media superiore primeggiò nelle discussioni. Quando fu al tredicesimo anno, papà ebbe una lunga malattia e dovette
abbandonare il lavoro per un anno. Perdettero la casa ormai quasi interamente pagata e andarono ad abitare in un appartamento in Myrtle Avenue. Benny andò a lavorare di sera in una farmacia. Sam e Izzy lasciarono la casa paterna, Sam per andare a lavorare da un pellicciaio a Newark, mentre Izzy si era messo a fare il perdigiorno nelle sale da bigliardo, e così papà lo cacciò di casa. Era sempre stato un buon atleta, e si diede a bighellonare con un irlandese di nome Pug Riley che voleva portarlo sul ring. Mammà pianse e papà proibì ai figlioli di fare il suo nome; però sapevano tutti che Gladys, la maggiore di tutti, che lavorava come stenografa a Manhattan, ogni tanto mandava a Izzy un biglietto da cinque dollari. Benny pareva molto più vecchio di quanto fosse, e non pensava ad altro che a far soldi per poter ridare ai suoi vecchi una casa loro. Adulto, avrebbe fatto l’avvocato e l’uomo d’affari e avrebbe guadagnato in fretta un mucchio di quattrini, in modo che Gladys potesse lasciare il lavoro e sposarsi, e i vecchi comprarsi una casa spaziosa e andare a vivere in campagna. Mammà gli raccontava sempre di quando era una giovinetta, in campagna, che c’era l’abitudine di andare nei boschi a coglier fragole e funghi e fermarsi nelle fattorie a bere latte caldo e spumoso, appena munto. Benny voleva arricchire per poterli portare tutti in campagna d’estate. Quando papà fu nuovamente in condizioni di poter lavorare, prese in affitto metà d’una casa per due famiglie, a Flatbush, dove almeno si era al sicuro dal fracasso della ferrovia sopraelevata. In quello stesso anno Benny prese il suo diploma e vinse un premio per un saggio sul governo americano. Si era fatto molto alto e mingherlino, e aveva emicranie tremende. I vecchi dissero che era cresciuto troppo in fretta e lo portarono dal dottor Cohen, che abitava nello stesso caseggiato ma aveva l’ufficio nel centro, presso Borough Hall. Il dottore disse che non doveva più lavorare di notte e studiare troppo; aveva bisogno di un’attività che gli facesse fare vita all’aperto sviluppandogli il corpo. «Chi troppo studia matto diventa» disse grattandosi la barba brizzolata sotto il mento. Benny disse che quell’estate lui voleva guadagnarsi un po’ di denaro perché in autunno intendeva andare all’università di New York. Il dottor Cohen disse che doveva
mangiare molte vivande a base di latte e uova fresche e andarsene in qualche posto dove si potesse godere il sole e l’aria libera e riposare tutta estate. Per la visita chiese due dollari di onorario. Nel tornare a casa il vecchio non faceva che battersi la fronte con la palma della mano e dire che quello era un bel disastro per lui: trent’anni di lavoro in America, e adesso eccolo lì, un vecchio esausto impotente a provvedere ai figli. Mammà pianse. Gladys disse loro di non fare gli sciocchi, perché Benny era un ragazzo in gamba, uno studente brillante, e a che serviva tutta la sua sapienza appresa sui libri se non sapeva trovare il modo di procurarsi lavoro in campagna. Benny se ne andò a letto senza aprir bocca. Qualche giorno dopo Izzy si ripresentò a casa. Sonò il campanello una mattina subito dopo che il vecchio era andato al lavoro. «Per poco non incontravi papà» gli disse Benny aprendogli. «Eh, ci vuol altro! Me ne sono stato ad aspettare dietro l’angolo finché non l’ho visto passare… Come state voialtri?» Izzy indossava un abito grigio chiaro con cravatta verde, e portava un cappello fedora per intonarsi all’abito. Disse che doveva andare a Lancaster, Pennsylvania, per sostenere sabato un incontro con un peso piuma filippino. «Prendimi con te» disse Benny. «Ma tu non sei abbastanza duro, figliolo… troppo figlio di mammà.» Finì che Benny andò con lui. Presero la L per andare al ponte di Brooklyn e poi traversarono New York a piedi fino al traghetto. Acquistarono due biglietti per Elizabeth. Quando il treno sostò in una stazione merci, ne approfittarono per andare ad appiattarsi nel bagagliaio. Alla stazione di West Philadelphia scesero, inseguiti dal sorvegliante. Si fecero prendere a bordo di un furgone di birreria che li portò a West Chester. Il resto della strada dovettero farlo a piedi. Un agricoltore mennonita li ospitò per la notte nel suo granaio, ma al mattino non diede loro la colazione che a patto di tagliargli legna per due ore filate. Quando arrivarono a Lancaster, Benny era sfinito. Si addormentò nel guardaroba dell’Athletic Club e non si svegliò che a incontro terminato. Izzy aveva messo fuori combattimento il peso piuma filippino alla terza ripresa, vincendo una borsa di venticinque dollari. Mandò Benny in una pensione col lustrascarpe che sorvegliava il guardaroba, e uscì coi ragazzi a far
baldoria. Il mattino dopo si presentò con la faccia verde e gli occhi iniettati di sangue; aveva speso tutti i soldi che aveva, ma intanto era riuscito a trovar lavoro a Benny come aiuto di un tizio che nei ritagli di tempo si occupava di organizzare incontri, e gestiva uno spaccio in un cantiere presso Mauch Chunk. Si lavorava in strada. Ben ci stette due mesi, guadagnandosi dieci dollari la settimana più il mantenimento. Imparò a guidare un tiro di cavalli e a tenere i registri. Il principale dello spaccio, Hiram Volle, truffava gli operai sui conti, ma Benny non ci badava perché erano per lo più degli italiani, finché poi fece amicizia con un giovanotto di nome Nick Gigli che lavorava nella squadra della cava di ghiaia. Nick si faceva vedere allo spaccio di sera, verso l’ora di chiusura, poi uscivano assieme a fumarsi una sigaretta e a far quattro chiacchiere. La domenica andavano a spasso in campagna col giornale della domenica e oziavano tutto il pomeriggio sdraiandosi a godere il sole e a parlare degli articoli di varietà. Nick era dell’Italia settentrionale, e tutti i suoi compagni di squadra erano siciliani, dimodoché lui si sentiva solo. Suo padre e i fratelli maggiori erano anarchici come lui; parlò a Benny di Bakunin e Malatesta e disse che Benny avrebbe dovuto vergognarsi di quel suo desiderio di diventare un ricco affarista; sì, doveva studiare e istruirsi, fors’anche diventare avvocato, ma soprattutto lavorare per la rivoluzione e per la classe operaia, perché essere un affarista significava essere un pescecane e un ladro come quel figlio di puttana d’un Volle. Insegnò a Benny ad arrotolarsi le sigarette e gli parlò delle ragazze che erano innamorate di lui: per esempio quella ragazza che lavorava nella biglietteria del cinema a Mauch; avrebbe potuto averla quando avesse voluto, ma un rivoluzionario doveva star molto in guardia con le donne, le donne distolgono dai suoi fini la mente di un lavoratore che ha coscienza di classe, sono la principale seduzione della società capitalista. Ben gli domandò se secondo lui egli doveva piantare in asso Volle, visto che Volle era un tal manigoldo, ma Nick gli rispose che qualunque altro capitalista sarebbe stato l’identica cosa; tutto quello che si poteva fare era attendere il Gran Giorno. Nick aveva diciotto anni, occhi castani amari e la pelle scura, quasi da mulatto. Ben lo giudicava un
grand’uomo per tutto quel che aveva fatto: il lustrino, il marinaio, il minatore, lo sguattero; aveva lavorato nell’industria tessile, nelle fabbriche di calzature e in quelle di cemento, aveva avuto ogni sorta di donne ed era stato in prigione tre settimane in occasione dello sciopero Paterson. Nel cantiere, se uno degli italiani scorgeva Dick da solo gli gridava: «Ehilà, ragazzo, dov’è Nick?». Venerdì sera ci fu una questione davanti alla finestra dove il capo del cantiere pagava gli uomini. Quella notte, mentre Ben si stava infilando nella sua cuccetta nel retro della baracca di cartone incatramato in cui era allogato lo spaccio, venne Nick a bisbigliargli all’orecchio che i principali avevano truffato gli uomini sul tempo, e che l’indomani c’era sciopero. Ben disse che se scioperavano loro scioperava anche lui. Nick lo chiamò bravo camerata in italiano e prima di andarsene lo baciò sulle guance. Il mattino dopo solo qualcuno degli spalatori e picconatori si presentò al fischio della sirena. Ben bighellonò presso la porta della cucina, senza saper che fare. Volle lo notò e gli disse di attaccare i cavalli per andare alla stazione a prendere una cassa di tabacco. Ben si guardò i piedi e disse che non poteva perché era in sciopero. Volle scoppiò a ridere e gli disse di piantarla con quelle ragazzate: questa sì che era da ridere!… un giudeo che faceva comunella con un branco di italiani. Ben si sentì venir freddo: «Giudeo sarai tu… io sono americano di nascita… e sostengo la mia classe, farabutto che non sei altro!». Volle diventò bianco come un cencio, gli si avvicinò e gli agitò il pugno massiccio sotto il naso, gli disse che era licenziato e che, se non era un fottuto sgorbietto d’un quattr’occhi ebreo, lui era pronto a tagliarsi la testa, comunque ci avrebbe pensato suo fratello a dargli una buona lezione quando l’avrebbe saputo. Ben se ne andò alla sua cuccetta, fece un fagotto delle sue cose e uscì a cercare Nick. Nick era un po’ più in là, nella strada dove c’erano i dormitori, al centro di un gruppo di italiani che schiamazzavano tutti agitando le braccia. Il sovrintendente e i capisquadra vennero tutti con rivoltelle alla cintola in foderi neri, e uno di loro fece un discorso in inglese e un altro in siciliano, per dire che quella era una ditta seria che aveva sempre trattato gli operai con giustizia, e se a loro non
garbava potevano andarsene fuori dai piedi. Non avevano mai avuto scioperi e non volevano cominciare proprio adesso. In quel lavoro c’era investito un mucchio di quattrini, e la compagnia non aveva nessuna intenzione di veder compromettere il suo lavoro per una cretineria qualsiasi. Chiunque non avesse ripreso il lavoro al prossimo fischio di sirena era licenziato e avrebbe dovuto fare fagotto e ricordarsi bene che lo Stato di Pennsylvania aveva fior di leggi contro il vagabondaggio. Quando la sirena fischiò un’altra volta, tutti tornarono al lavoro tranne Nick e Ben. Se ne andarono per la strada col fagotto in spalla. Nick aveva le lacrime agli occhi e diceva: «Troppo gentili, troppo pazienti… non conosciamo ancora la nostra forza». Quella sera trovarono una scuola in rovina, un po’ discosto dalla strada, sopra un’altura che dominava un fiume. Si erano comperati un po’ di pane e cioccolata in un negozio, e si misero a sedere davanti all’edificio mangiando e parlando sul da farsi. Quand’ebbero finito di mangiare era già buio. Ben non si era mai trovato in aperta campagna di notte. Il vento stormiva nei boschi tutt’intorno e l’impetuoso fiume ribolliva nella valle. Era una fredda notte di agosto, umida di guazza. Non avevano di che coprirsi, e così Nick insegnò a Ben a togliersi la giacca e a mettersela sopra la testa, e a dormire contro il muro per non farsi male sul nudo impiantito. Si era appena addormentato che si risvegliò intirizzito e tremante. C’era una finestra rotta; se ne vedevano bene l’inteleiatura e le schegge aguzze di vetro contro la nuvolosa notte lunare. Si coricò daccapo, doveva aver sognato. Qualcosa fece fracasso sul tetto e rotolò sull’assito sopra la sua testa per cadere a terra. «Ehi Ben, cos’è quello, perdio?» chiese la voce di Nick con un roco bisbiglio. Si alzarono entrambi a guardare dalla finestra rotta. «Quella era già rotta» disse Nick. Andò ad aprire la porta che dava sull’esterno. Li fece rabbrividire il freddo vento della valle che rumoreggiava sugli alberi come pioggia, e il fiume sotto mandava un cigolio di macina, come quello d’una fila di carri. Una pietra colpì il tetto sopra le loro teste e rotolò giù. La successiva passò tra le loro teste e andò a colpire lo screpolato
intonaco del muro alle loro spalle. Ben udì lo scatto del coltello tascabile a serramanico di Nick. Aguzzò gli occhi sino a farli piangere, ma non riuscì a scorgere altro che il fogliame mosso dal vento. «Vieni fuori… avvicinati un po’… parla!… figlio di puttana!» urlò Nick. Non ci fu risposta. «Tu che ne pensi?» bisbigliò Nick a Ben voltando il capo. Ben non disse nulla; stava sforzandosi di impedire ai denti di battere. Nick lo spinse nell’interno e richiuse la porta. Ammonticchiarono i polverosi banchi contro la porta e bloccarono la parte inferiore della finestra con assi tolte dal pavimento. «Adesso di’ che entrino se son capaci. In ogni modo ti garantisco che uno lo ammazzo» disse Nick. «Tu non credi agli spiriti?» «No, a queste cose non ci credo» disse Ben. Sedettero per terra a fianco a fianco, con la schiena rivolta all’intonaco screpolato, e ascoltarono. Nick aveva deposto il coltello fra sé e Ben. Prese le dita di Ben e gli fece sentire al tatto il bottoncino che teneva ferma la lama. «È un buon coltello… da marinaio» sussurrò. Ben tese le orecchie. Solo il fruscio crepitante del vento fra gli alberi e il continuo macinare del fiume. Non arrivarono altri sassi. Il mattino dopo lasciarono la scuola di buon’ora. Nessuno dei due aveva chiuso occhio. A Ben bruciavano gli occhi. Quando s’alzò il sole, trovarono un uomo che stava aggiustando una balestra rotta di un autocarro. Lo aiutarono ad accomodarla con un pezzo di legno, e lui diede loro un passaggio fino a Scranton, dove trovarono lavoro come sguatteri in una rosticceria gestita da un greco. … tutte le relazioni fisse e congelate, col loro strascico di antichi e venerabili pregiudizi ed opinioni, vengono spazzate via, tutte quelle di nuova formazione diventano antiquate prima che possano ossificarsi… La pesca delle perle non andava molto a genio a Ben, e così dopo un paio di settimane, quando si fu messo da parte i soldi del biglietto, disse che tornava a vedere i suoi vecchi. Nick si fermò perché c’era una ragazza che si era innamorata di lui. In seguito sarebbe andato ad Allentown, dove c’era un suo fratello che lavorava in un’acciaieria e stava facendo un sacco di soldi. L’ultima cosa che disse quando andò
ad accompagnare Ben al treno di New York fu: «Benny, tu pensa ad imparare e studiare… sii un campione della classe lavoratrice e ricordati che correre troppo appresso alle donne è un serio impiccio». Ben non sapeva rassegnarsi a lasciare Nick, ma doveva pur tornare a casa per trovarsi un impiego per l’inverno che gli desse modo e tempo di studiare. Fece gli esami di ammissione e si immatricolò al collegio universitario della città di New York. Il vecchio prelevò un prestito di cento dollari dal Morris Plan per dargli la possibilità di cominciare, e Sam gliene mandò venticinque da Newark per comprarci i libri. Poi si guadagnò lui qualcosetta lavorando di sera nella farmacia Kahn. La domenica pomeriggio andava in biblioteca a leggersi Il capitale di Marx. Si iscrisse al partito socialista e frequentò le conferenze della Rand School con assiduità, ogni volta che poteva. Si preparava ad essere uno strumento ben affilato. Quella primavera poi s’ammalò di scarlattina e stette dieci settimane in ospedale. Quando ne uscì, aveva gli occhi in tali condizioni che bastava un’ora di lettura a dargli il mal di testa. Il vecchio era debitore al Morris Plan di altri cento dollari oltre i primi cento, gl’interessi e i diritti d’indagine. In una conferenza a Cooper Union, Ben aveva conosciuto una ragazza che aveva lavorato in una filanda a Jersey. Era stata arrestata durante lo sciopero Paterson e messa sulla lista nera. Ora faceva la commessa da Wanamaker, ma i suoi lavoravano sempre nella fabbrica Botany a Passaic. Si chiamava Helen Mauer; aveva cinque anni più di Ben, era una biondina e aveva il viso segnato da rughe. Secondo lei il movimento socialista non valeva nulla; erano i sindacalisti che vedevano giusto. Dopo la conferenza lo portò al Cosmopolitan Café nella Seconda Avenue, per offrirgli un bicchiere di tè e presentargli certe persone che, a quanto disse, erano veri ribelli; quando poi Ben ne parlò a Gladys e ai suoi vecchi, il vecchio disse: «Pfuh!… ebrei radicali» e con le labbra abbozzò il sibilo d’uno sputo. Disse che Ben doveva troncarla con quegli sconclusionati e mettersi a lavorare. Lui stava invecchiando e ora aveva debiti, e se si ammalava sarebbe toccato a Benny di pensare a lui e alla vecchia. Ben disse che lavorava da mane a sera, ma non era la famiglia che contava, era la classe
lavoratrice, e ad essa egli dedicava la sua attività. Il vecchio si imporporò e disse che la famiglia era sacra, e dopo di quella veniva il suo popolo. Mammà e Gladys piansero. Il vecchio si alzò in piedi; soffocando tra colpi di tosse si alzò le mani sulla testa e maledisse Ben, e Ben lasciò la casa. Non aveva denaro con sé ed era ancora indebolito dalla scarlattina. Traversò Brooklyn e il ponte di Manhattan e s’inoltrò nell’East Side, tutto pieno di luci rossastre, folla e carretti di verdura che odorava di primavera, diretto alla casa di Helen, nella Sesta Strada Est. La padrona di casa gli disse che non poteva salire in camera. Helen disse che quello non era affare che la riguardasse, ma nel corso di questa disputa a lui cominciarono a ronzare le orecchie, e svenne sul divano dell’atrio. Quando rinvenne, a furia di acqua in faccia che gli correva giù per il collo, Helen lo aiutò a salire le quattro fughe di scalini e lo fece sdraiare sul suo letto. Alla padrona, che strillando minacciava di chiamare la polizia, gridò giù per le scale che tanto per cominciare se ne sarebbe andata solo al mattino dopo, e per nulla al mondo si sarebbe mossa prima. Fece a Ben un po’ di tè, e tutta notte stettero seduti sul suo letto a parlare. Decisero che avrebbero convissuto in libera unione, e il resto della notte lo passarono a preparar le valigie di lei. Più che altro, aveva libri e opuscoli. Il mattino seguente uscirono alle sei in punto, per cercarsi una stanza, perché lei doveva trovarsi da Wanamaker alle otto. Alla nuova padrona di casa non dissero precisamente che non erano sposati, ma quando quella disse: «Ah, siete sposini novelli?» annuirono sorridendo. Fortunatamente Helen aveva contanti bastevoli a pagare una settimana anticipata. Poi dovette correre al lavoro. Ben non aveva denaro e non poteva quindi comperar nulla da mangiare, così se ne stette lungo disteso sul letto tutta la giornata a leggersi Progresso e povertà. La sera, rientrando dal lavoro, lei portò qualcosa per la cena, comperata in una salumeria. Mangiarono pane di segale e salame, contenti come pasque. Piccola e snella com’era, lei aveva seni tanto vistosi. Lui dovette andare in una farmacia a comperare qualche preservativo, perché lei gli fece presente che non potevano avere un bambino proprio ora che bisognava consacrare tutte le energie al
movimento. C’erano cimici nel letto, ma loro si dissero che quella era tutta la felicità che si poteva avere sotto il sistema capitalista, e un bel giorno avrebbero avuto una società libera in cui i lavoratori non sarebbero stati costretti a intanarsi in sporchi alloggi pieni di cimici e a litigare con le padrone di casa, e gli amanti avrebbero potuto aver bambini quando volessero. Qualche giorno dopo Helen fu licenziata da Wanamaker perché stavano riducendo il personale in vista della stagione morta, l’estate. Si trasferirono a Jersey, dove lei andò dai suoi e Ben trovò lavoro nel reparto Spedizioni di una fabbrica di stoffe pettinate. Presero in affitto assieme una stanza a Passaic. Quando venne uno sciopero, lui e Helen facevano tutti e due parte del comitato organizzatore. Ben diventò un oratore fatto e finito. Fu arrestato varie volte ed ebbe il cranio quasi rotto dallo sfollagente d’un poliziotto; la conseguenza di questo incidente furono sei mesi di prigione. Ma intanto aveva potuto constatare che quando montava sopra una cassa di sapone per tenere un discorso sapeva farsi ascoltare, sapeva parlare e dire quello che pensava e strappare la risata o l’applauso alla massa di facce rivolte in su. Quando comparve in tribunale per assistere alla lettura della sentenza, si mise a parlare del plusvalore. Gli scioperanti che facevano parte del pubblico applaudirono, e il giudice fece sgomberar l’aula. Ben osservò che i giornalisti erano tutti occupati a prendere nota di quello che diceva lui: era lieto di essere un esempio vivente dell’ingiustizia capitalista. Il giudice lo mise a tacere dicendogli che se non stava zitto gli dava altri sei mesi per disprezzo di tribunale, e Ben fu portato alla prigione di contea in un’auto piena di guardie speciali armate di rivoltelle antisommossa. I giornali parlarono di lui come noto agitatore socialista. In carcere Ben fece amicizia con un membro dell’Internazionale, un certo Bram Hicks, un giovanotto alto di San Francisco, dagli occhi azzurri e dai capelli chiari; costui gli disse che se voleva conoscere il movimento dei lavoratori doveva procurarsi una tessera rossa e andare nella Costa Occidentale. Bram era di mestiere calderaio, ma tanto per cambiare si era imbarcato come marinaio ed era sbarcato a Perth Amboy senza un soldo in tasca. Aveva lavorato al turno
riparazioni di una fabbrica, e poi aveva abbandonato il lavoro con gli altri. Quando i poliziotti avevano rotto una linea di squadre anticrumiraggio, lui ne aveva preso uno a pugni in faccia, e si era buscato sei mesi per aggressione e maltrattamenti. Incontrarlo una volta al giorno nel cortile della prigione era la sola cosa che tenesse su il morale a Ben. Furono rimessi in libertà nello stesso giorno. Si incamminarono assieme per la strada. Lo sciopero era finito. Le fabbriche funzionavano. Le strade dove c’erano stati i picchetti, l’atrio dove Ben aveva tenuto i suoi discorsi avevano un aspetto calmo e normale. Egli portò Bram da Helen. Lei non c’era, ma dopo un po’ venne con un piccolo inglese dalla faccia rossa e dal naso di furetto che presentò come Billy, un compagno inglese. Ben capì al volo che dormivano assieme. Lasciò Bram nella stanza con l’inglese e fece segno a lei di uscire. Lo stretto atrio superiore della vecchia casa di legno odorava di aceto. «Di me non ne vuoi più sapere?» domandò con voce malferma. «Oh Ben, non comportarti in maniera così convenzionale!» «Avresti anche potuto aspettare che io fossi uscito di prigione.» «Ma non vedi che siamo tutti compagni? Tu sei un bravo lottatore e non dovresti essere così convenzionalista, Ben… Billy non è nulla per me. È come un intendente a bordo di un transatlantico. Se ne andrà via presto.» «Allora nemmeno io sono niente per te.» Afferrò il polso di Helen e glielo strinse più che poté. «Forse ho torto, ma sono pazzo di te… Credevo che tu…» «Oh, Ben… che sciocchezze dici, lo sai quanto ti amo.» Tornarono nella stanza e parlarono del movimento. Ben disse che se ne andava a occidente con Bram Hicks. … egli diventa un’appendice della macchina, ed è solo l’abilità più elementare, più monotona, più facile a ottenersi quella che gli si chiede… Bram conosceva tutti i trucchi. Camminando a piedi, infilandosi nei bagagliai dei treni o sui barconi vuoti, prendendosi passaggi su furgoni ed autocarri, arrivarono a Buffalo. Ivi, in un albergo di basso rango, Bram trovò un tizio di sua conoscenza che li fece assumere come marinai di coperta a bordo di un whaleback 1 che tornava a
Duluth senza carico. A Duluth si unirono a una squadra che andava a mieter frumento per conto di un’impresa nel Saskatchewan. Dapprima il lavoro fu molto pesante per Ben, e Bram temeva che crollasse, ma le quattordici ore giornaliere passate all’aria libera nel sole e nella polvere, il cibo abbondante, il sonno di piombo ai piani superiori dei grandi granai cominciarono a temprarlo. Sdraiato sulla paglia coi vestiti intrisi di sudore, ancora nel sonno sentiva la sferza del sole sulla faccia e sul collo, la tensione nei muscoli, il ronzio delle mietitrici e delle legatrici all’orizzonte, il ruggito della trebbiatrice, lo sferragliare degli autocarri che portavano il rosso frumento agli elevatori. Cominciò a usare il linguaggio dei mietitori. Finito il raccolto lavorarono in una fabbrica di conserve di frutta sul fiume Columbia, brutto posto, aria piena di vapore, impregnata dell’acido tanfo di resti di frutta in putrefazione. Lì appresero dai giornali la notizia dello sciopero dei tessitori di amianto e della lotta per la libertà di parola a Everett, e decisero di andar a vedere di persona come stavano le cose e portare il loro contributo. L’ultimo giorno che lavorarono nella fabbrica di conserve, Bram perdette l’indice della mano destra nel riparare il macchinario di affettatura e pelatura. Il dottore della compagnia disse che non gli spettava alcun indennizzo perché lui aveva già dato un’avvertenza al riguardo, e poi, non essendo canadese… Un avvocatucolo di basso conio si presentò alla pensione dove Bram stava sdraiato sul letto con tanto di febbre e con la mano sepolta nei bendaggi, e fece di tutto per indurlo a far causa, ma Bram gridò all’avvocato di andarsene fuori dai piedi. Ben lo disapprovò, perché la classe lavoratrice doveva avere anche i suoi legali. Quando la mano si fu avviata alla guarigione, se ne andarono via mare da Vancouver a Seattle. Lì il quartier generale dell’Internazionale operaia pareva un campo da picnic, gremito di giovani provenienti da ogni parte degli Stati Uniti e del Canada. Un giorno un buon manipolo andò in vapore a Everett per veder di tenere un comizio all’angolo di Wetmore e Hewitt Avenue. La banchina era piena di guardie armate di fucili e rivoltelle. «I ragazzi del Commercial Club ci aspettano» ridacchiò qualcuno nervosamente. Le
guardie portavano fazzoletti bianchi al collo. «Ecco lì lo sceriffo McRae» disse qualcuno. Bram si accostò a Ben: «È meglio che stiamo vicini… Se non mi sbaglio, ci son botte in vista». Gli internazionalisti furono arrestati man mano che scendevano dal battello e ammassati all’estremità della banchina. Le guardie erano quasi tutte ubriache; a quella che afferrò Ben per il braccio, tutta rossa in viso, puzzava il fiato di whisky lontano un miglio: «Muoviti, figlio di puttana!…». Ben ricevette un colpo di calcio di fucile in fondo alla schiena. Sentì rumor di legno che si spezzava sulle teste. A chiunque opponeva resistenza spiaccicavano la faccia a bastonate. Gli internazionalisti furono fatti salire in un autocarro. Col crepuscolo s’era messo a piovigginare, un’acquerugiola fredda. «Ragazzi, adesso bisogna far vedere a questa gente che abbiamo fegato» disse un giovane dai capelli rossi. Una guardia che si teneva aggrappata al retro dell’autocarro cercò di menargli una bastonata, ma perse l’equilibrio e cadde giù. Gli internazionalisti fecero una risata. La guardia rimontò, paonazza. «Riderà bene chi riderà l’ultimo, brutti musi!» gridò. In aperta campagna, nei boschi dove la strada provinciale tagliava la strada ferrata, li fecero scendere dagli autocarri. Le guardie li circondarono coi fucili spianati, mentre lo sceriffo, che barcollava per l’ubriachezza, discuteva sul da farsi con due uomini eleganti di mezza età. Ben sentì parlare di bastonatura a catena. «Sentite un po’, sceriffo,» disse qualcuno «noi non siamo venuti per far disordini. Tutto quello che vogliamo sono i nostri diritti costituzionali di libertà di parola.» Lo sceriffo si rivolse verso di loro agitando il calcio della rivoltella: «Ah sì, eh, ah sì, carogne? Bene, questa è la contea di Snohomish e ve la ricorderete per un pezzo… e se ci rimettete piede, qualcuno di voialtri ci lascia la pelle, questo è poco ma è sicuro… Forza ragazzi, spicciamoci!». Le guardie formarono due file in direzione della ferrovia. Afferrarono i compagni uno per uno e li caricarono di botte. Tre di loro acciuffarono Ben: «Tu, un compagno?!». «Certo che lo sono, sporco vigliacco…» cominciò lui. Sopraggiunse lo sceriffo, che fece per misurargli un cazzotto. «Bada che ha gli occhiali.» Una manaccia glieli levò. «Adesso regoliamo i conti.» E lo sceriffo lo colpì con un pugno
sul naso. «Di’ che non lo sei!» Ben aveva la bocca piena di sangue. Irrigidì la mascella. «È un ebreo, dagliene un altro anche per me.» «Avanti, di’ che non sei un compagno!» Qualcuno gli percosse gli stinchi con una canna di fucile, e Ben cadde in avanti. «Di corsa!» gli gridavano. Gli stavano maciullando le orecchie a bastonate e a colpi di calcio di fucile. Cercò di camminare senza correre. Inciampò in una rotaia e cadde, ferendosi il braccio su qualcosa di aguzzo. Aveva tanto sangue negli occhi che non ci vedeva più. Uno scarpone lo stava ripetutamente calciando nel fianco. Stava rendendo l’anima. In un modo o nell’altro avanzò, barcollando. Qualcuno lo reggeva per le ascelle e lo stava trascinando via di peso per liberarlo dal parabestiame 2 della strada ferrata. Un altro prese a pulirgli il viso con un fazzoletto. A una certa distanza udì la voce di Bram: «Abbiamo passato il confine della contea, ragazzi». Tra la perdita degli occhiali, la pioggia, l’oscurità della notte e il dolore lancinante che gli trafiggeva la schiena, Ben non ci vedeva più. Sentì degli spari alle spalle e urla provenienti da dove altri stavano correndo sotto le forche caudine della bastonatura a catena. Lui si trovava al centro di un gruppetto di internazionalisti che avanzava a passi lenti lungo la strada ferrata. «Compagni lavoratori,» diceva Bram con la sua voce profonda e calma «non dovremo mai scordare questa nottata.» Alla stazione tranviaria interurbana si fece una colletta nel gruppo lacero e insanguinato per acquistare biglietti per Seattle a beneficio dei peggio colpiti. Ben era così intontito e spossato che quasi non ce la faceva a tenere il biglietto, quando glielo ficcarono in mano. Bram e gli altri si avviarono a percorrere a piedi le trenta miglia di strada che li separavano da Seattle. Ben stette ricoverato in ospedale per tre settimane. I calci nella schiena gli avevano leso i reni, e soffrì quasi continuamente dolori atroci. La morfina che gli somministrarono lo stordì a tal punto da togliergli la coscienza di quanto accadeva, quando ricoverarono i ragazzi feriti nella sparatoria del molo Everett, del 5 novembre. Dimesso che fu, si reggeva a stento sulle gambe. Tutti quelli che conosceva erano in prigione. Fermo posta trovò una lettera di Gladys con cinquanta dollari; diceva che il padre lo rivoleva a casa.
Il comitato di Difesa lo incaricò di andarsene nell’Est a raccogliere fondi, perché era l’uomo più indicato per quella bisogna. Ci voleva una somma enorme di denaro per difendere i settantaquattro compagni detenuti al carcere di Everett sotto l’accusa di omicidio. Ben gironzolò per Seattle un paio di settimane sbrigando qualche lavoretto per il comitato di Difesa, e scervellandosi nel frattempo a trovare il modo di andare a casa. Un simpatizzante che lavorava in un’agenzia di spedizioni marittime gli procurò poi un posto come addetto al controllo del carico a bordo di un cargo che doveva andare a New York passando per il canale di Panama. Il viaggio per mare e l’accurato lavoro burocratico lo aiutarono a riprendersi. Pure, non c’era notte che un incubo non lo svegliasse di soprassalto con un urlo nella strozza: si rizzava a sedere in letto, sognando che le guardie venivano a prenderlo per farlo passare sotto la bastonatura a catena. Quando si riaddormentava, sognava di impigliarsi nel parabestiame, e i denti di ferro gli laceravano le braccia, e pesanti scarponi lo colpivano nella schiena. Finì che gli ci voleva uno sforzo inaudito per sdraiarsi in cuccetta e prender sonno. Gli uomini dell’equipaggio lo prendevano per un pazzoide e stavano alla larga. Fu un gran giorno, quello in cui vide gli alti edifici di New York brillare sulla bruma dorata del mattino. … quando nel corso dell’evoluzione le distinzioni di classe saranno sparite e tutta la produzione sarà concentrata nelle mani di una vasta associazione nazionale, il potere pubblico perderà il suo carattere politico… Quell’inverno Ben stette coi suoi perché economicamente conveniva di più. Quando annunciò a papà la sua intenzione di andare a studiare diritto nello studio di un avvocato radicale di nome Morris Stein, che aveva avuto modo di conoscere durante l’attività svolta per raccogliere denaro in favore dei ragazzi dell’Everett, il vecchio ne gioì. «Un avvocato in gamba trova il modo di proteggere i lavoratori e gli ebrei poveri, e contemporaneamente di far denaro» disse fregandosi le mani. «Benny, l’ho sempre detto, io, che sei un bravo ragazzo.» Mammà annuì sorridendo. «Sì, perché in questo paese non è come laggiù dove comandano i guerrafondai, qui anche un lazzarone di vagabondo ha i suoi diritti costituzionali, ed è
appunto per questo che hanno scritto la Costituzione.» Parlar con loro di queste cose era una vera sofferenza per Ben. Lavorava come impiegato nell’ufficio di Stein, in Lower Broadway, e di sera prendeva la parola nei comizi di protesta per il massacro del molo Everett. Fanya, la sorella di Stein, una ricca trentacinquenne esile e bruna, era pacifista ardente, e gli fece leggere Tolstoj e Kropotkin. Era convinta che Wilson avrebbe preservato la nazione dalla guerra e inviato denaro a tutte le organizzazioni pacifiste femminili. Possedeva un’automobile, e certe volte che lui aveva diversi comizi da tenere in una sera sola ci pensava lei a scarrozzarlo da un posto all’altro della città. Gli picchiava sempre il cuore quando entrava nel salone dove si teneva il comizio e cominciava a sentire il mormorio del pubblico che affluiva: lavoranti di sartoria dell’East Side, portuali di Brooklyn, operai delle officine metallurgiche di Newark, socialisti da salotto e “rosa” della Rand School o della bassa Quinta Avenue, la vasta massa anonima d’ogni classe, razza e mestiere di Madison Square Garden. Quando stringeva le mani al presidente e agli altri oratori sul podio, le sue erano sempre fredde. Quando veniva la sua volta, c’era un momento in cui tutte le facce fisse su di lui si confondevano in una massa rosa, il mormorio della sala lo assordava, e lo coglieva il terrore di aver dimenticato ciò che voleva dire. Poi tutt’a un tratto udiva la propria voce esprimersi chiara e ferma, la sentiva riverberarsi sui muri e sul soffitto, sentiva le orecchie tendersi, uomini e donne sporgersi in avanti dai rispettivi posti, vedeva chiaramente le file di volti, i gruppi di persone che non trovando posto si affollavano alle porte. Frasi come protesta, azione di massa, unione della classe lavoratrice di questo paese e del mondo, rivoluzione illuminavano sotto di lui occhi e facce come la vampa d’un falò. Dopo il discorso si sentiva tremebondo, gli occhiali li aveva talmente appannati che doveva strofinarli, e si avvedeva di tutta la goffaggine della sua alta figura dinoccolata. Fanya lo portava via al più presto, gli diceva con gli occhi lustri che aveva parlato magnificamente, e lo conduceva in centro, se il comizio si era svolto a Manhattan, a cenare al seminterrato Brevoort o al Cosmopolitan Café, prima ch’egli prendesse la metropolitana per Brooklyn per tornare a
casa sua. Sapeva benissimo, Ben, che era innamorata di lui, ma tra loro due non capitava quasi mai che parlassero di argomenti estranei al movimento. A febbraio, quando venne la rivoluzione russa, Ben e gli Stein seguitarono per settimane e settimane ad acquistare ogni edizione dei giornali, a leggere con disperata attenzione tutti i resoconti dei corrispondenti: era l’alba del Gran Giorno. C’era aria come di carnevale per tutto l’East Side e nei quartieri ebrei di Brooklyn. I vecchi piangevano solo a parlarne. «Adesso viene l’Austria, poi il Reich, poi l’Inghilterra… dappertutto popoli liberati» diceva papà. «E per ultimo, lo Zio Sam» aggiungeva Ben, irrigidendo torvo la mascella. Quel giorno di aprile che Woodrow Wilson dichiarò la guerra, Fanya si mise a letto con un accesso di pianto isterico. Ben andò a trovarla nell’appartamento che Morris Stein e sua moglie avevano in Riverside Drive. Era tornata da Washington il giorno prima. Ci era andata con una delegazione di donne pacifiste che volevano ottenere udienza dal presidente. Gli agenti investigativi le avevano allontanate bruscamente dai prati antistanti alla Casa Bianca, e parecchie ragazze erano state arrestate. «E che volevi mai aspettarti?… naturalmente i capitalisti vogliono la guerra. Cambieranno idea quando si accorgeranno che invece si stanno buscando fra capo e collo una rivoluzione.» Lo pregò di fermarsi da lei, ma lui si accomiatò dicendo che doveva andare da quelli di «The Call». Nell’uscire si accorse di far con le labbra un suono di sputo come suo padre. Si ripromise di non metter più piede in quella casa. Si iscrisse nei registri di leva dietro consiglio di Stein, però scrisse sul foglio: «Obiettore di coscienza». Di lì a poco ebbe una lite con Stein. Stein disse che l’unica cosa da fare era chinare il capo di fronte alla tempesta; Ben disse che intendeva reagirvi sino a tanto che non lo avessero messo in galera. E con ciò rimase senza lavoro e dovette troncare i suoi studi giuridici. Kahn non lo rivolle nella sua farmacia perché temeva una spedizione punitiva dei poliziotti qualora si risapesse che teneva alle sue dipendenze un radicale. Sam, il fratello di Ben, lavorava in una fabbrica di munizioni a Perth Amboy e faceva
denaro a palate; seguitava a scrivere a Ben di piantarla con tutte le sue ubbie e venirsene lì anche lui a trovar lavoro. Anche Gladys gli disse che era da sciocchi batter la testa contro il muro. A luglio lasciò i suoi e se ne tornò a convivere con Helen Mauer a Passaic. La sua classe non era stata ancora chiamata, e così gli fu facile trovar lavoro nel reparto Spedizioni di una fabbrica locale. Si seguitava a fare straordinari e a perdere operai per via della chiamata alle armi. La Rand School era stata chiusa, «The Call» sospeso, e ogni giorno altri amici accedevano alle vedute wilsoniane. I parenti di Helen e i loro amici guadagnavano bene, facendo straordinari; se si parlava di scioperi di protesta o movimenti rivoluzionari, scoppiavano a ridere o se la prendevano; la gente comperava macchine lavatrici, obbligazioni Liberty, aspirapolvere, pagava le prime rate di acquisti immobiliari. Le ragazze comperavano pellicce e calze di seta. Helen e Ben cominciarono a pensare di andarsene a Chicago, dove i compagni organizzavano una resistenza. Il 2 settembre venne la gran retata di dirigenti dell’Internazionale operaia, fatta dagli agenti governativi. Ben e Helen si aspettavano l’arresto da un momento all’altro, ma la tempesta li risparmiò. Passarono tutta una piovosa domenica accoccolati sul letto nella loro umida stanza a tentar di decidere il da farsi. Tutto ciò in cui avevano riposto fiducia crollava sotto i loro piedi. «Mi sento come un topo in trappola» continuava a dire Helen. Ogni tanto Ben saltava su e si metteva a misurare la stanza a gran passi, battendosi la fronte col palmo della mano: «Dobbiamo pur fare qualcosa qui; guarda un po’ che cosa fanno in Russia!». Un bel giorno si presentò al reparto Spedizioni un lavoratore dell’industria bellica a prenotare tutti quanti per un’obbligazione Liberty ciascuno. Era un giovanotto spavaldo in impermeabile giallo. Ben non era molto proclive a discussioni durante le ore di lavoro, e così si limitò a scuotere il capo in segno di diniego e tornò ad occuparsi della bolletta doganale che stava compilando. «Ma non vorrete per caso rovinare il primato raggiunto dal vostro reparto, vero? Finora è il cento per cento assoluto.» Ben tentò di sorridere: «È un vero peccato, ma dovrà proprio essere così». Sentì su di sé gli occhi dell’altro. Il giovanotto in impermeabile, in preda ad evidente disagio,
si bilanciava da un piede all’altro: «Immagino che non vorrete farvi prendere per un germanofilo o per un pacifista, vero?». «La gente può pensare di me tutto quello che vuole, per quel che me ne importa.» «Fuori il documento di iscrizione ai ruoli di leva: scommetto che siete un renitente.» «Ecco qua allora, e ascoltami bene;» disse Ben alzandosi in piedi «io non credo nella guerra capitalista, e per quanto sta in me non farò mai nulla per sostenerla.» Il giovanotto in impermeabile gli voltò le spalle: «Oh, ma se sei uno di quei vigliacchi bastardi non voglio neanche rivolgerti la parola». Ben tornò al suo lavoro. Quella sera stessa, mentre stava regolando l’orologio segnatempo, si vide comparir davanti un poliziotto. «Fuori il certificato di iscrizione alla leva, bello mio.» Ben trasse il documento dalla tasca interna. Il poliziotto lo esaminò attentamente: «Mi sembra proprio in regola» disse con riluttanza. A fine settimana Ben si trovò licenziato, senza che ne venisse indicato alcun motivo. Si recò alla sua camera in preda al panico. Quando tornò Helen, le disse che aveva intenzione di andarsene al Messico: «Con quello che ho detto a quel tizio sulla necessità di combattere il capitalismo, c’è da finir sotto processo ai sensi della legge sullo spionaggio». Helen cercò di calmarlo, ma lui disse che in quella camera non ci avrebbe dormito un’altra notte, e così fecero le valigie e presero il treno per New York. Fra tutti e due avevano circa cento dollari di risparmio. Affittarono una stanza nell’Ottava Strada Est sotto il nome di coniugi Gold. Fu il mattino dopo che lessero nel «Times» la notizia che i massimalisti avevano assunto il governo a Pietrogrado con questa parola d’ordine: Tutto il potere ai sovieti. Erano seduti in una piccola pasticceria della Seconda Avenue a sorbirsi il caffè del mattino, quando Ben, che era andato al chiosco a comperare il giornale, tornò con la notizia. Helen si mise a piangere: «Oh, caro, è troppo bello per essere vero. È la rivoluzione mondiale… Adesso i lavoratori si accorgeranno che li stava ingannando una falsa prosperità, che la guerra è veramente rivolta contro di loro. Adesso gli altri eserciti cominceranno ad ammutinarsi». Ben le prese la mano sotto il tavolo e gliela strinse forte: «Ora c’è da lavorare sul serio, cara… Piuttosto di scapparmene al Messico mi farò mettere in prigione. Se non fosse stato per te mi sarei
comportato da vigliacco bastardo, Helen… È inutile, da solo un uomo non sa far niente». Inghiottirono il caffè a grandi sorsate e andarono a casa dei Ferber, nella Diciassettesima Strada. Al Ferber era un dottore, un ometto basso e tarchiato con un notevole pancione; stava giusto uscendo per andare nel suo studio. Tornò nell’atrio con loro e gridò alla moglie di sopra: «Molly, scendi!… Kerenskij se l’è svignata da Pietrogrado col pungolo alle reni… travestito da donna, è scappato!». Poi disse in yiddish a Ben che, se i compagni volevano tenere un’adunanza per inviare un saluto al governo dei soldati e dei contadini, lui offriva cento dollari per le spese, ma il suo nome non doveva figurare, altrimenti ne andava dell’autorizzazione ad esercitare. Molly Ferber scese al pianterreno in vestaglia imbottita e si dichiarò disposta a vender qualcosa per aggiungerne altri cento. Passarono l’intera giornata a cercare i compagni dei quali possedevano gli indirizzi; del telefono non osavano servirsi per timore di un controllo. Il comizio fu tenuto all’Empire Casino nel Bronx, una settimana dopo. In prima fila presero posto due agenti federali dalla faccia gnocca, con uno stenografo che prendeva nota di tutto quel che si diceva. La polizia chiuse le porte dopo l’ingresso delle prime duecento persone. Gli oratori dal podio la sentivano operare con le motociclette, fuori, per rompere l’assembramento che si era evidentemente formato. Soldati e marinai in divisa si infilavano in galleria uno o due per volta e cercavano di fissare gli oratori in guisa tale da metterli in imbarazzo. Quando il vecchio canuto che presiedeva la riunione si portò sul proscenio e disse: «Compagni, signori del dipartimento della Giustizia e giovani simpatizzanti della galleria, noi ci siamo qui riuniti per inviare un messaggio di saluto da parte degli oppressi lavoratori d’America ai trionfanti lavoratori di Russia», tutti applaudirono. Applaudì anche la folla che si accalcava di fuori. Si sentì anche in un punto imprecisabile un gruppo che cantava L’internazionale. Si sentirono i fischietti della polizia e il gracidare di un’autovettura di pattuglia. Ben notò che nell’uditorio c’era Fanya Stein; era pallida e lo fissava con occhi febbrili. Quando venne il suo turno di parlare, esordì dicendo che a causa dei cortesi simpatizzanti di Washington presenti
nel pubblico egli non poteva dire quello che voleva, ma ogni uomo e donna dell’uditorio che non fosse un traditore o una traditrice della sua classe sapeva bene quello che lui voleva dire… «I governi capitalisti si stanno scavando la fossa con lo spingere i loro popoli al macello in una pazza guerra inutile, che può giovare soltanto ai banchieri e ai fabbricanti di munizioni… La classe lavoratrice americana, al pari delle altre classi lavoratrici del mondo, imparerà la lezione. I profittatori ci stanno insegnando come si adoperano i cannoni; e verrà giorno che metteremo in pratica l’insegnamento.» «Questo è troppo, ragazzi, facciamola finita!» gridò una voce dalla galleria. Dagli ingressi la polizia si diresse sugli oratori con manovra convergente. Ben fu arrestato insieme ad altri due. Gli uomini dell’uditorio che erano atti alle armi dovettero mostrare i certificati di iscrizione alla leva, prima di uscire. Prima ancora di poter parlare con Helen, Ben fu cacciato a urtoni in una limousine chiusa con gli scuri abbassati. Non aveva neanche potuto vedere chi lo avesse ammanettato. Lo tennero per tre giorni senza mangiare e senza bere in un ufficio vuoto del Federal Building in Park Row. A intervalli di poche ore entrava nel locale un nuovo gruppo di agenti investigativi per interrogarlo. Con la testa che gli pulsava, e prossimo a svenir di sete, egli affrontava allora il cerchio di facce lunghe e gialle, facce rosse paffute, facce tonde infossettate, facce di ubriaconi e di gaudenti, e si sentiva perforare da quegli occhi; a volte lo canzonavano e tentavano di persuaderlo a forza di lusinghe, altre invece minacciavano brutalmente; un gruppo portò con sé pezzi di tubi di gomma per batterlo. Lui balzò in piedi e li affrontò. Chissà perché, non lo batterono, anzi gli portarono un po’ d’acqua e un paio di panini imbottiti di prosciutto andato a male. Dopodiché gli riuscì finalmente di dormire un po’. Un agente lo tirò giù bruscamente dalla panca e lo condusse in un lindo ufficio, dove fu interrogato quasi cortesemente da un uomo anziano che stava dietro una scrivania di mogano con un mazzo di rose sull’angolo. L’odore delle rose lo faceva star male. L’uomo anziano gli disse che poteva conferire col suo avvocato, e Morris Stein
entrò nella sua stanza. «Benny,» disse questi «lascia fare a me… Il signor Watkins ha acconsentito a ritirare tutte le accuse pendenti a tuo carico qualora tu prometta di presentarti alle autorità militari per l’addestramento. Pare che la tua classe sia stata chiamata.» «Se mi mettete in libertà» disse Ben con voce bassa e tremante «io farò del mio meglio per oppormi alla guerra capitalista sinché non mi metterete dentro un’altra volta.» Morris Stein e Watkins si scambiarono un’occhiata e scossero il capo con aria indulgente. «Be’,» disse Watkins «io non posso fare altro che ammirare il vostro spirito e rammaricarmi che non sia a servizio di miglior causa.» Finì che lo lasciarono in libertà provvisoria contro cauzione di quindicimila dollari, dietro assicurazione di Morris Stein che non avrebbe fatto agitazioni sino al giorno del processo. Gli Stein non vollero dirgli chi avesse offerto la cauzione. Morris e Edna Stein gli diedero una stanza del loro appartamento; e Fanya era sempre lì. Lo nutrirono con vivande sostanziose e si adoperarono per fargli bere vino a pasto e un bicchiere di latte prima di andare a letto. Lui non si interessava a nulla, dormiva a più non posso, e leggeva tutti i libri che trovava. Quando Morris cercava di parlargli del suo caso, lui gli troncava il discorso: «Tu stai facendo questo, Morris… fa’ quello che vuoi… perché mai dovrei interessarmene? Per me è indifferente star qui o in prigione.» «Be’, bisogna proprio dire che questo è un complimento» disse ridendo Fanya. Helen Mauer si fece viva al telefono varie volte per informarlo dell’andamento delle cose. Gli diceva sempre che le novità che aveva da riferirgli non poteva dirle al telefono, ma lui dal canto suo non le diceva mai di venire a trovarlo. Dalla casa degli Stein si allontanava giusto per andare giornalmente a sedersi un poco su di una panchina del lungofiume e guardare dall’altra sponda del grigio Hudson le file di case di legno e le palizzate grigie che c’erano dalla parte di Jersey. Il giorno in cui si aprì il suo processo, la stampa era piena di accenni a vittorie tedesche. Primavera e sole fuori degli sporchi finestroni dell’aula. Ben sedeva assonnato nella penombra soffocante.
Tutto pareva molto semplice. Stein e il giudice si scambiarono frizzi, e il viceprocuratore distrettuale poi era addirittura brillante. La giuria emise verdetto di colpevolezza, e il giudice lo condannò a vent’anni di carcere. Morris Stein inoltrò domanda di appello, e il giudice lo lasciò in libertà condizionata, dietro cauzione. Il solo momento in cui Ben si rianimò fu quando gli consentirono di parlare alla Corte prima che si decidesse la condanna. Fece un discorso sul movimento rivoluzionario che da settimane andava preparando. Ma sin dall’inizio gli parve sciocco e debole. A metà quasi si fermò. Mentre si avvicinava alla fine, la sua voce aumentò di forza e riempì l’aula. Anche il giudice e i vecchi cancellieri sbuffanti si alzarono in piedi quando a mo’ di perorazione egli recitò le ultime parole del manifesto comunista: Al posto della vecchia società borghese con le sue classi e il suo antagonismo di classe, avremo un’associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno sarà la condizione del libero sviluppo di tutti. L’appello andava per le lunghe. Ben si rimise a studiar legge. Avrebbe voluto lavorare nell’ufficio di Stein per pagarsi il mantenimento, ma Stein obiettò che era una cosa rischiosa; la guerra presto sarebbe finita e il terrore del pericolo rosso si sarebbe smorzato, dimodoché lui, Stein, avrebbe potuto ottenergli una sentenza mite. Gli portò libri di diritto per farlo studiare, e gli promise di prenderlo come socio nel suo studio una volta che avesse preso la sua laurea e ricuperato la cittadinanza. Edna Stein era una donna grassa e sdegnosa e ben di rado gli rivolgeva la parola; Fanya gli prodigava certe attenzioni nervose che sapevano di moina e gli davano fastidio. Lui dormiva male e i reni lo tormentavano. Una notte si alzò e si vestì, e stava scendendo in punta di piedi le scale dell’atrio rivestite di un tappeto, dirigendosi alla porta con le scarpe in mano, quando si affacciò all’uscio della propria stanza Fanya, coi capelli neri sciolti lungo la schiena. Aveva una camicia da notte che metteva in evidenza la sua figura magra e i seni piatti. «Benny, dove vai?» «Io qui sto impazzendo… bisogna che me ne vada.» Gli battevano i denti. «Bisogna che ritorni nel movimento… Mi prenderanno e mi sbatteranno in prigione sui due piedi… sarà meglio così.» «Povero ragazzo, ma tu non sei in condizione di poterlo fare!» Così
dicendo gli buttò le braccia al collo e se lo tirò in camera sua. «Fanya, devi lasciarmi andare… Potrei riuscire a passare il confine del Messico… c’è chi l’ha già fatto.» «Sei pazzo… e la cauzione?» «E che m’importa?… non vedi che dobbiamo assolutamente fare qualcosa?» Lei lo aveva fatto adagiare sul suo letto e gli stava carezzando la fronte: «Povero ragazzo… Ti amo tanto, Benny, perché non pensi un poco anche a me?… appena un pochettino, sai… Ti potrei aiutare tanto nel movimento… Domani ne riparleremo… Voglio aiutarti, Benny.» Lui si lasciò sciogliere il nodo della cravatta. Venne l’armistizio, e poi le notizie della Conferenza della pace, moti rivoluzionari per tutta Europa, le armate di Trockij che stavano cacciando i russi bianchi dalla Russia. Fanya Stein diceva a tutti che lei e Ben erano moglie e marito, e lo portò ad abitare con sé nel suo appartamento studio dell’Ottava Avenue, dove lo curò sino alla guarigione dell’influenza e della polmonite doppia. Il primo giorno che il dottore disse che lui poteva uscire, ella guidò la sua Buick a quattro posti lungo lo Hudson. Tornarono nel primo crepuscolo estivo e trovarono un espresso di Morris. La Corte d’appello federale aveva respinto l’appello, ma ridotto la condanna a dieci anni. L’indomani a mezzogiorno egli doveva presentarsi coi suoi mallevadori per essere passato in custodia alla Corte distrettuale americana. Sarebbe andato probabilmente ad Atlanta. Poco dopo venne Morris in persona. Fanya era crollata e piangeva istericamente. Morris era pallido. «Ben,» disse «siamo battuti… Dovrai andare ad Atlanta per un po’… lì sarai in buona compagnia… ma non impressionarti. Sottoporremo il tuo caso al presidente. Adesso che la guerra è finita, non potranno più tener la stampa liberale alla museruola.» «Va benone» disse Ben. «È meglio conoscere subito il peggio.» Fanya balzò su dal divano sul quale si era accasciata a singhiozzare e inveì contro il fratello. Quando Ben uscì per fare il solito giro attorno al caseggiato, li lasciò che litigavano aspramente. Si sorprese a osservare attentamente le case, i tassì, i lampioni, le facce della gente, un curioso idrante che aveva come un torso di donna, certe bottiglie di olio minerale ammassate in una vetrina di farmacista:
Nujol. Risolse di andare a Brooklyn a salutare i suoi vecchi. Alla stazione della metropolitana si fermò. Non si sentiva la forza di farlo; era meglio che scrivesse. La mattina dopo alle nove si recò all’ufficio di Morris Stein con la valigia in mano. Si era fatto promettere da Fanya di non venire. Dovette ripetere parecchie volte a se stesso che stava andando in prigione, perché gli pareva di accingersi semplicemente a qualche viaggio d’affari. Indossava un abito nuovo di tweed, comperatogli da Fanya. Lower Broadway era tutta striata di rosso, bianco e blu per via delle bandiere; quando Ben uscì dalla metropolitana, i marciapiedi erano entrambi gremiti di folle d’impiegati e fattorini. Poliziotti in motocicletta tenevano sgombra la strada. Dalla parte del parco Battery veniva un suono di banda militare che eseguiva Keep the Home Fires Burning. Tutti avevano l’aria eccitata e contenta. Bisognava fare uno sforzo per non camminare a tempo sul ritmo della musica nel fresco mattino estivo che sentiva di porto e di navi. Egli doveva continuamente ripetere a se stesso: questa è la gente che ha mandato Debs in galera, questa è la gente che ha ucciso a fucilate Joe Hill, che ha assassinato Frank Little, questa è la gente che ci ha picchiati a sangue all’Everett, che mi vuol far marcire per dieci anni in galera. Il ragazzo negro addetto all’ascensore gli abbozzò un sorriso nel farlo salire: «Non hanno ancora cominciato a sfilare, signore?». Ben crollò il capo e corrugò la fronte. L’ufficio legale aveva un aspetto lindo e lustro. La telefonista aveva i capelli rossi e portava una stella d’oro. Sulla porta dell’ufficio privato di Stein c’era drappeggiata una bandiera americana. Stein era al tavolo e stava parlando con un giovanotto in tweed dall’aria benestante. «Ben,» disse Stein in tono cordiale «ti presento Stevens Warner… È appena uscito da Charlestown, dove ha scontato un anno di carcere per essersi rifiutato di iscriversi ai ruoli di leva.» «Non proprio un anno, veramente» disse il giovanotto alzandosi e stringendogli la mano. «Sono fuori per via della buona condotta.» A Ben non riuscì simpatico, con quel vestito di tweed e quella cravatta costosa; ma tutt’a un tratto gli venne in mente che anche lui
portava lo stesso tipo di abito. Questo pensiero lo irritò. «E com’è andata?» domandò freddamente. «Non tanto male, mi han fatto lavorare nella serra… Mi han trattato piuttosto bene quando son venuti a sapere che ero già stato al fronte.» «E come fu?» «Oh, col servizio ambulanze… Mi hanno preso giusto per un pazzo tranquillo… È stata un’esperienza tremendamente istruttiva.» «I lavoratori li trattano in un altro modo» disse irosamente Ben. «E adesso noi inizieremo una campagna nazionale per far liberare tutti gli altri ragazzi,» disse Stein, alzandosi in piedi e fregandosi le mani «a cominciare da Debs… vedrai, Ben, che non ci starai molto, là dentro… la gente sta già ritornando in sé.» Salì da Broadway una ventata di musica d’ottoni, col trepestio regolare di soldati in marcia. Si affacciarono tutti e tre alla finestra. Per tutta quella specie di lungo cañón grigio garrivano bandiere, nastri telegrafici srotolantisi e giornali brillavano al sole rossastro, si contorcevano nell’ombra; la gente gridava a squarciagola. «Fessi della malora!» disse Warner. «Come se tutto ciò potesse bastare a far dimenticare ai fanti la prigione di rigore!» Morris Stein rientrò nella stanza con una strana lucentezza negli occhi: «Mi par quasi di aver perso qualcosa». «Be’, è ora che me ne vada» disse Warner, stringendo la mano un’altra volta. «Voi certamente avete avuto una bella batosta, Compton… ma state sicuro che noi lavoreremo giorno e notte per tirarvi fuori di lì… Sono certo che l’opinione pubblica cambierà. Speriamo molto dal presidente Wilson… dopo tutto, prima della guerra la storia dei suoi rapporti coi lavoratori fu abbastanza buona.» «Io ritengo che, se uscirò di galera, saranno i lavoratori a farmi uscire» disse Ben. Gli occhi di Warner lo stavano scrutando. Ben non sorrise. Warner gli stette davanti un momento in preda a imbarazzo, e poi gli prese daccapo la mano. Ben non ricambiò lo stretta. «Buona fortuna» disse Warner, e uscì dall’ufficio. «E chi è quello, uno dei soliti ex universitari dalla mentalità
liberale?» chiese Ben a Stein. Stein annuì. Aveva nel frattempo rivolto la sua attenzione a certi documenti che stavano sulla scrivania. «Sì… è un gran bravo ragazzo, quello Steve Warner… troverai in biblioteca qualche libro o rivista… sarò da te a minuti.» Ben andò in biblioteca e prese dallo scaffale un’opera sui Torti. Lesse e lesse quei caratteri eleganti. Quando Stein venne a prenderlo, lui non sapeva né che cosa avesse letto sino allora né quanto tempo fosse trascorso. Per Broadway dovettero camminare a passo lento per via della folla, delle bande musicali e delle continue sfilate di soldati marcianti in kaki con copricapi di latta. Stein lo avvertì con una gomitata di togliersi il cappello mentre passava una bandiera reggimentale in mezzo a un corpo di pifferi e tamburi. Lui si tenne il cappello in mano per non doverselo ritogliere un’altra volta. Respirò a pieni polmoni la polverosa aria della strada intrisa di sole, di profumi femminili e benzina proveniente dal tubo di scappamento degli autocarri che trainavano i grossi calibri, piena di riso e grida e rimescolio e calpestio; poi lo scuro portone del Federal Building li inghiottì. Fu un sollievo aver concluso tutto e trovarsi solo con la guardia di scorta sul treno diretto ad Atlanta. La guardia era un tipo ingrugnato con borse bluastre sotto gli occhi. Siccome le manette stringevano troppo i polsi a Ben, la guardia le apriva, tranne quando il treno si fermava in qualche stazione. Ben si ricordò che era il suo compleanno; aveva ventitré anni. 1. Letteralmente, “dorso di balena”: si tratta di imbarcazioni dal ponte convesso che si unisce alle fiancate in curva continua; molto usate nei Grandi Laghi. (NdT) 2. Apparato di protezione disposto lungo i binari per impedire che gli animali ci vadano sopra e provochino danni gravi a sé e ai treni. (NdT)
Cine-giornale XLI negli ambienti del Colonial Office britannico si ritiene che l’irritazione australiana diminuirà non appena ci si renderà conto che la sostanza è più importante dell’ombra. Si può senz’altro asserire che i rappresentanti della stampa i quali si premurano di spedire i loro telegrammi di buon’ora soffrono perché i loro telegrammi vengono gettati in appositi cestini. I telegrammi che arrivano dopo vengono ammucchiati sui primi, e va a finire che si sbrigano prima quelli in cima al cestino. Ma questo non bisogna prenderlo per un insulto. Il conte von Brockdorff-Rantzau era molto debole, e sono state soltanto le sue condizioni fisiche ad impedirgli di alzarsi CONDUCENTE DI AUTO PUBBLICA RAPINATO DA SCONOSCIUTI Tenete duro perché noi veniamo gli uomini dell’Unione son forti; avanziamo lottando a fianco a fianco, la vittoria verrà. La Consulta Municipale di New York Dice che gli Abiti da Sera Femminili Stanno Corrompendo la Morale di Questa Gioventù I SOLDATI OLTREMARE TEMONO LA PERDITA DELLA V D’ORO LA COSCRIZIONE È UN BUSILLIS A Parigi c’è al lavoro propaganda avversaria? Noi ci aduneremo oggi per la causa della Libertà e alzeremo la voce ci daremo la mano in salda unione per combattere o per morire LA FRANCIA È PUR SEMPRE LA FRONTIERA DELLA LIBERTÀ si provvede esplicitamente a che il benessere e lo sviluppo delle regioni arretrate e coloniali siano contemplati nel quadro dei sacri doveri della civiltà, su cui la Lega delle Nazioni esercita la sua tutela e il suo controllo SECONDO WASHINGTON I ROSSI PERDONO TERRENO Tenete duro perché noi veniamo
gli uomini dell’Unione son forti il sindacato dei lavoratori marittimi che si riunì nelle prime ore della scorsa notte al n. 26 di Park Place ha deliberato di indire uno sciopero generale dalle ore 6 antimeridiane di domani BURLESON ORDINA LA SOPPRESSIONE DI TUTTE LE NOTIZIE TELEGRAFICHE POSTALI per tutta risposta egli ordinò ai suoi seguaci di impiccare sul posto quei due ragazzi. Essi furono collocati su sedie sotto gli alberi, vennero loro messe attorno al collo corregge fissate ai rami, e poi vennero maltrattati sinché non respinsero da sé le sedie a furia di calci per porre termine ai loro tormenti
Occhio fotografico (42) per quattro ore noi militari di passaggio ammucchiamo rottami di ferro nei carri merci scoperti e per quattro ore scarichiamo i rottami dai carri merci e li ammucchiamo a lato dei binari TENETE I RAGAZZI IN ALLENAMENTO PER IL RITORNO è la divisa dell’YMCA nel mattino le ombre dei pioppi additano l’Ovest e nel pomeriggio additano l’Est la direzione della Persia gli aguzzi ferrivecchi ci pungono le mani attraverso i guantoni di tela grezza una specie di grigia polvere di scoria ci tappa naso e orecchie ci punge gli occhi quattro ungheresi un paio di wops uno slavo spagnoli italiani due omuncoli bruni altezzosi con cui non c’è verso di scambiare una parola pezzi di ricambio che nessun reparto ha voluto parafanghi acciaccati molle rotte vecchie zappe e badili arnesi da zappatori brande d’ospedale contorte una montagna di bulloni con dadi d’ogni misura quattro milioni di miglia di filo spinato filo metallico per stie e conigliere acri di tetti di lamiera miglia di autocarri parcheggiati lunghe parate di locomotive in fila lungo le rotaie gialle dei binari morti TENETE I RAGAZZI IN ALLENAMENTO PER IL RITORNO SU in fureria i sergenti brontoloni che fanno tutto il lavoro delle scartoffie non sanno neanche dove sia la casa hanno perso l’indicazione dei nostri reparti il nostro stato di servizio le nostre piastrine di alluminio col numero di matricola no spika de Engliss no entiendo comprend pas non capisco nie panimàiu giorno dopo giorno le ombre dei pioppi additano l’Ovest il Nordovest il Nord il Nord-est l’Est Quando disertano puntano sempre a sud disse il caporale Abbastanza in gamba ma se non ha il suo stato di servizio come possiamo compilargli il congedo? TENETE I NOSTRI RAGAZZI IN ALLENAMENTO ma perché diavolo, la guerra è finita rottami
Cine-giornale XLII per Seattle fu un giorno di gala. Una folla enorme non solo riempiva le strade per tutto il percorso riservato alla parata dal molo in poi, ma finalmente in seguito di sera furono piazzate mitragliatrici, e gli uomini della guardia furono fatti segno a una pioggia di proiettili sinché la loro inazione li mise in tale pericolo da indurre gli ufficiali a dar l’ordine di aprire il fuoco. VOLEVANO TAGLIARE I FILI DELLA LUCE. Il Rettore Magnifico Lowell dell’università di Harvard ha esortato gli studenti a prestare la loro opera contro gli scioperi. «In armonia con la sua tradizione di servizio pubblico, l’università desidera in questo momento di crisi mantenere l’ordine e difendere le leggi della Federazione.» TRE ARMATE SI CONTENDONO KIEV Definisce la Situazione un Delitto contro la Civiltà PER RENDERLI INVULNERABILI durante il servizio funebre in onore di Horace Traubel, esecutore letterario e biografo di Walt Whitman, oggi pomeriggio, è scoppiato un incendio nella chiesa unitaria del Messia. Sono stati creati periodici, rimorchiatori e cantieri navali. 2000 passeggeri si fermarono a Le Havre, dove il sig. Wilson si imbarcò per passare in rivista la flotta del Pacifico, ma migliaia e migliaia di persone stavano ammassate da ambo i lati della strada, evidentemente soddisfatte di poter vedere il presidente anche per un attimo solo. Mentre la George Washington si dirigeva lentamente al suo ormeggio in Hoboken passando per la gremita parte inferiore della baia, tutti i navigli che si trovavano in mare salutarono re Alberto e la regina Elisabetta con rauchi ululi di sirena L’ACCIAIO DI LEGA FINA SEGUITA A TENERE IL PRIMO POSTO NEL MERCATO Il mio paese è tuo dolce terra della libertà di te io canto
Paul Bunyan Quando Wesley Everest tornò dall’Europa e si congedò dall’esercito, si rimise a fare il taglialegna come prima. I suoi appartenevano a quel vecchio ceppo di boscaioli e cacciatori di scoiattoli del Kentucky e del Tennessee che seguirono la pista aperta da Lewis e Clark nelle piovose foreste giganti del versante Pacifico. Nell’esercito Everest era tiratore scelto, e vinse una medaglia per un colpo eccezionale. (Sin dai giorni dello Homestead Act a Washington i promotori della colonizzazione nel West, i politicanti e i trafficanti di voti si erano dati un gran daffare per le piovose foreste giganti del versante Pacifico, col risultato che: dieci gruppi monopolistici comprendenti solo milleottocentodue azionisti monopolizzarono milleduecentootto miliardi ed ottocento milioni, [1.208.800.000.000] piedi cubi di legname vivo… tanto legname vivo… che [tenuto conto dello spreco di lavorazione] avrebbe potuto fornire assi sufficienti a costruire un ponte galleggiante fra New York e Liverpool e largo più di cinque miglia; legname per impalcature, legname per costruire a buon mercato quartieri di abitazione suburbani, cartelli indicatori, legname per capannoni, navi e città di baracche, cellulosa per i giornali illustrati, per i giornali a effetto sensazionale, pagine per articoli di fondo, copie di fogli pubblicitari, cataloghi postali, cartelle per schedari, scartoffie per la burocrazia militare, fogli volanti, carta vergatina.) Wesley Everest era un taglialegna come Paul Bunyan. 1 I boscaioli, i taglialegna, i fabbricatori di tavole da tetti, gli operai di segheria erano gli iloti dell’impero del legname; l’Internazionale proletaria mise in testa a Paul Bunyan l’idea della democrazia industriale; gli organizzatori radicali dicevano che le foreste avrebbero dovuto appartenere a tutto il popolo, dicevano che Paul Bunyan avrebbe dovuto essere pagato in denaro contante anziché con pezzi di carta della Compagnia, avrebbe dovuto avere un posto decente ove potersi asciugare i vestiti, impregnati del sudore di una giornata di lavoro a zero gradi e con la neve, una giornata lavorativa di otto ore,
dormitori puliti, cibo sano; quando Paul Bunyan tornò dall’Europa, dove aveva combattuto per accaparrare l’Europa alla democrazia dei quattro Grandi, aderì all’organizzazione sindacale dei boscaioli per contribuire ad accaparrare il versante Pacifico ai lavoratori. I sindacalisti dell’Internazionale erano rossi. In questo mondo non c’è niente che possa far paura a un Paul Bunyan. (Essere un rosso nell’estate 1919 era peggio che essere un unno o un pacifista nell’estate 1917.) I proprietari del legname, i re delle segherie e delle tavole da tetto erano patrioti; avevano vinto la guerra (nel corso della quale il prezzo del legname era salito da sedici dollari a centosedici dollari ogni mille piedi; in certi casi poi il governo pagava sino a milleduecento dollari l’abete); essi si accinsero a ripulire i campi alloggio dai rossi; le libere istituzioni americane debbono esser salvate a qualunque costo; e così formarono l’Employers Association e la Legion of Loyal Loggers, e diedero lauti compensi a gruppi di reduci che devastavano le sedi dell’Internazionale, linciavano e picchiavano a sangue gli organizzatori, bruciavano la letteratura sovversiva. Il giorno delle Rimembranze, 30 maggio del 1918, i ragazzi dell’American Legion di Centralia, guidati da un gruppo di appartenenti alla Camera di Commercio, devastarono la sede dell’Internazionale proletaria, picchiarono a sangue tutti coloro che vi trovarono, ne misero alcuni in prigione e gli altri li caricarono in un autocarro per poi scaricarli oltre il confine di contea, bruciarono gli opuscoli e i giornali e vendettero gli arredi a beneficio della Croce Rossa; la scrivania dell’Internazionale si trova tuttora alla Camera di Commercio. I taglialegna presero in affitto una nuova sede e il sindacato seguitò a svilupparsi. A questo mondo non c’è niente che faccia paura a un Paul Bunyan. Verso la ricorrenza dell’armistizio nel 1919 circolavano per tutta la città voci secondo le quali la sede sarebbe stata devastata a mo’ di commemorazione. Un giovanetto di buona famiglia e di modi garbati, Warren O. Grimm, aveva fatto l’ufficiale nel continente americano
della Siberia; ciò faceva di lui senz’altro un’autorità in materia di classe lavoratrice e bolscevismo, e così egli fu prescelto dagli uomini d’affari per capitanare le forze della Citizens’ Protective League, mobilitate al completo, per inculcare in Paul Bunyan il timor di Dio. La prima cosa che fecero i valorosi patrioti fu di acciuffare un giornalaio cieco, caricarlo di botte e buttarlo in una fossa di là dal confine di contea. I taglialegna si rivolsero alla loro consulta e deliberarono che avevano il sacrosanto diritto di difendere la loro sede e se stessi in caso di irruzione. Non c’è niente al mondo che possa far paura a un Paul Bunyan. Wesley Everest era un tiratore infallibile; l’anniversario dell’armistizio indossò la sua divisa e si riempì le tasche di cartucce. Wesley Everest non era quello che si dice un parlatore; a un’adunanza tenuta nella sede del sindacato la domenica prima dell’incursione si era parlato dell’evenienza di un linciaggio; Wesley Everest non aveva fatto altro che camminare su e giù per la sala con il cappotto militare verde oliva sopra una tuta, distribuendo libri ed opuscoli; quando i ragazzi dissero che non ne volevano sapere di un’altra incursione, lui si fermò con i giornali sotto il braccio, si arrotolò una sigaretta di carta scura e sorrise, con un suo strano sorriso calmo. L’anniversario dell’armistizio fu una giornata aspra e fredda; la nebbia avanzava rotolando da Puget Sound e gocciava dai neri rami degli abeti e dalle facciate della città, lucenti di negozi. Warren O. Grimm comandava la sezione di Centralia della parata commemorativa. I reduci erano in divisa. Quando la parata passò davanti alla sede del sindacato senza fermarsi, i taglialegna dentro tirarono il fiato, ma al ritorno la parata si fermò davanti alla sede. Qualcuno si mise le dita in bocca e fischiò. Qualcuno gridò: «Forza ragazzi… addosso!». Si precipitarono contro la sede dei radicali. Tre uomini abbatterono la porta a spallate. Un fucile parlò. Fucilate crepitarono sulle colline retrostanti alla città, ruggirono nel retro della sede. Grimm e un reduce furono colpiti. La parata si sciolse in disordine, ma quelli che erano armati di
fucile si rimisero in formazione e investirono la sede. Trovarono alcuni uomini inermi nascosti in una vecchia ghiacciaia, un ragazzo in divisa in cima alla scalinata con le mani in alto. Wesley Everest esaurì il caricatore del suo fucile, gettò via l’arma e fuggì verso i boschi. Nel correre si aprì un varco tra la folla addensata alle spalle della sede, tenne a bada gli avversari con una pistola automatica, scalò una palizzata, infilò un viale e poi la strada secondaria. La folla lo inseguì. Lasciò andare i rotoli di corda che aveva portati per linciare Britt Smith, il segretario dell’Internazionale. Fu la diversione di Wesley Everest che impedì a quella gente di linciare sul posto Britt Smith. Fermandosi una volta o due per tenere a bada la folla con qualche colpo sporadico, Wesley Everest puntò sul fiume, cominciò a guadarlo. Quand’ebbe l’acqua alla vita si fermò e si voltò. Wesley Everest si voltò ad affrontare la folla con uno strano sorriso calmo. Aveva perso il cappello e i capelli gli colavano acqua e sudore. Fecero per corrergli addosso. «Tiratevi indietro!» gridò lui. «Se ci sono poliziotti nella folla, mi sottopongo all’arresto.» La folla era su di lui. Lui sparò quattro colpi dall’altezza dell’anca, poi l’arma gli s’inceppò. Tirò ancora il grilletto, e mirando con determinazione freddò il primo dei suoi persecutori. Era Dale Hubbard, un altro reduce, nipote di uno dei grandi proprietari di legname di Centralia. Poi buttò via l’arma scarica e lottò coi pugni. La folla ebbe ragione di lui. Uno gli spaccò i denti con un calcio di schioppo. Qualcuno portò una corda e si accinsero a impiccarlo. Una donna si fece largo a gomitate tra la folla e gli tirò via la corda dal collo. «Non avete il coraggio di impiccare un uomo alla luce del sole» fu quello che disse Wesley Everest. Lo portarono in prigione e lo buttarono per terra in una cella. Intanto facevano subire agli altri taglialegna il terzo grado. Quella notte le luci della città furono spente. Una folla abbatté la porta d’ingresso del carcere. «Non sparate, ragazzi, ecco qui il vostro uomo» disse il guardiano. Wesley Everest li affrontò in piedi. «Dite ai
ragazzi che ho fatto del mio meglio» bisbigliò agli occupanti delle altre celle. Lo portarono in automobile chiusa al ponte del fiume Chehalis. Mentre Wesley Everest giaceva stordito sul fondo della macchina, un uomo d’affari di Centralia gli tagliò con un rasoio verga e testicoli. Qualcuno ha ricordato che dopo un po’ egli sussurrò: «Per grazia di Dio, uomini, sparatemi… non fatemi soffrire così». Poi lo impiccarono al ponte al bagliore dei fari. Nella sua inchiesta il coroner prese tutto ciò per uno scherzo colossale. Riferì che Wesley Everest era evaso e fuggito al fiume Chehalis, e poi si era legato una corda al collo ed era saltato nel vuoto, e trovando che la corda era troppo corta si era nuovamente inerpicato sul ponte legandosene una più lunga, ed era saltato giù un’altra volta, rompendosi il collo e crivellandosi di colpi. Ficcarono i suoi resti massacrati in una cassa da imballaggio e li seppellirono. Nessuno sa dove abbiano sepolto il corpo di Wesley Everest, ma i sei taglialegna che riuscirono a prendere li seppellirono nel penitenziario di Walla Walla. 1. Paul Bunyan è l’eroe leggendario e spaccone dei racconti dei boscaioli. (NdT)
Richard Ellsworth Savage I pinnacoli e i contrafforti dell’abside di Notre-Dame parevano sbriciolati come cenere di sigari nel sole del tardo pomeriggio. «Ma tu devi fermarti, Richard» diceva Eleanor nel girare per la stanza per raccogliere in un vassoio le tazzine del tè affinché la cameriera le portasse via. «Dovevo pur fare qualcosa per Eveline e suo marito prima che salpassero… dopo tutto, è una delle mie più vecchie amiche… ed ho invitato per il dopopranzo tutti i miei spasimanti.» Fuori rombò sul lungofiume una flotta di grossi carri ingombri di barili di vino. Dick guardava fuori nella cenere grigia del pomeriggio. «Su, chiudi quella finestra, Richard, sta entrando un sacco di polvere… Naturalmente mi rendo ben conto che tu dovrai andartene presto per poter presenziare alla conferenza stampa di J.W. … Se non fosse stato per questo avrebbe dovuto venire anche lui, poverino, ma tu sai bene com’è impegnato.» «Be’, a dire il vero neanch’io ho molto tempo libero… ma in ogni modo mi fermerò per salutare la coppia felice. A furia di star nell’esercito mi ero disabituato al lavoro.» Si alzò e tornò nella stanza ad accendersi una sigaretta. «Oh, ma adesso non farla così tragica, non è il caso.» «A quanto sembra, però, anche tu non balli di gioia.» «Secondo me Eveline ha commesso un grave sbaglio… Gli americani prendono il matrimonio tremendamente alla leggera.» Dick sentì un nodo serrargli la gola. Si accorse egli stesso con quanta rigidezza si metteva in bocca la sigaretta, inalava il fumo e lo espirava. Lo scrutavano in faccia freddi e indagatori gli occhi di Eleanor. Dick non diceva nulla, solo cercava di tener compassata l’espressione del viso. «Eri innamorato di quella povera ragazza, Richard?» Dick arrossì e scosse il capo. «Be’, allora è inutile che tu faccia mostra di prendertela tanto a cuore… è proprio da giovincelli mostrar di prendersela a quel modo.» «Abbandonata da un ufficiale dell’esercito, una bellezza del Texas trova la morte in un incidente aviatorio… ma quasi tutti i giornalisti mi conoscono e han fatto del loro meglio per coprire la faccenda… E
che avrei dovuto fare, saltar nella tomba come Amleto? L’onorevole signor Barrow ci ha pensato lui a tutto questo. È stato un colpo tremendo…» Si lasciò cadere in una poltrona. «Vorrei essere abbastanza insensibile da non curarmi di nulla al mondo. Quando la storia ci marcia sul viso non è il momento di indulgere ai sentimenti delicati.» Fece una faccia buffa e prese a parlare dall’angolo della bocca: «Tutto quello che chiedo, sorella, è vedere il mondo con zio Woodrow… le beau monde sans blague tu sais.» Eleanor rideva il suo risolino stridulo, quando udirono fuori sul pianerottolo le voci di Eveline e Paul Johnson. Eleanor aveva comprato loro un paio di cocorite blu in gabbia. Si bevve Montrachet e si mangiò anitra arrosto cotta con aranci. A metà cena Dick dovette andare al Crillon. Fu un sollievo trovarsi fuori all’aria libera, seduto in un tassì aperto, sorpassare così il Louvre reso enorme dal tardo crepuscolo sotto il quale le vie di Parigi sapevano di vuoto e di remota antichità come il Foro romano. Per tutto il tragitto che fece dopo le Tuileries egli giocò internamente con l’impulso di dire all’autista che lo portasse all’Opéra, al circo, alle fortificazioni, in un posto qualunque all’inferno e via. Riatteggiò il volto all’impassibilità del giocatore di poker non appena passò davanti al portiere del Crillon. Quando si presentò, la signorina Williams lo accolse con un sorriso di sollievo: «Oh, temevo proprio che faceste tardi, capitano Savage». Dick crollò il capo sorridendo: «Non è venuto nessuno?». «Oh, vengono a sciami. Ne parleranno le prime pagine dei giornali» sussurrò lei. Poi dovette rispondere al telefono. La vasta stanza si stava già riempiendo tutta di giornalisti. Nello stringergli le mani Jerry Burnham bisbigliò: «Sai, Dick, se si tratta di una dichiarazione dattiloscritta ti prometto che non escirai vivo di qui». «Non preoccuparti» disse Dick con una smorfia ilare. «A proposito, dov’è Robbins?» «Non è in programma» disse seccamente Dick. «Credo che sia a Nizza, occupato a finir di consumarsi il fegato dal gran bere.» J.W. era entrato dall’altra porta e stava girando per la stanza, stringendo le mani ai conoscenti e facendosi presentare agli altri. Un
giovanotto dai capelli arruffati e dalla cravatta storta mise in mano a Dick un foglio di carta: «Scusate, chiedetegli se è disposto a rispondere ad alcune di queste domande». «È vero che rimpatria per fare una campagna propagandistica per la Lega delle Nazioni?» mormorò qualcuno all’altro orecchio di Dick. Tutti quanti si accomodarono nelle sedie; J.W. si appoggiò alla spalliera della sua e disse che questa intendeva essere una chiacchierata alla buona; dopo tutto, era anche lui un vecchio giornalista. Ci fu una pausa. Dick spostò lo sguardo sulla pallida faccia lievemente paffuta di J.W. giusto in tempo per cogliere un lampo di quei suoi occhi azzurri che passavano in rassegna i volti dei corrispondenti. Un uomo anziano domandò con voce grave se a Moorehouse non spiaceva dir qualcosa sulle divergenze di vedute fra il presidente e il colonnello House. Dick si riaccomodò sulla sua sedia, rassegnato ad annoiarsi. J.W. rispose con un sorriso freddo che per tale questione era meglio rivolgersi direttamente al colonnello House. Non appena qualcuno pronunciò la parola petrolio, tutti drizzarono il busto. Sì, lui era in grado di affermare senz’altro che un accordo, un’intesa di massima era stata raggiunta fra certi produttori di petrolio americani e forse la Royal Dutch Shell, oh certo non per stabilizzare i prezzi, ma quale prova del sorgere di una nuova era di cooperazione internazionale, in cui le grandi aggregazioni di capitale avrebbero lavorato di conserva per la pace e la democrazia, contro i reazionari e i militaristi da una parte e contro le forze sanguinarie del bolscevismo dall’altra. E la Lega delle Nazioni? «Una nuova era» proseguì J.W. in tono fiducioso «sta albeggiando.» Le sedie grattarono il pavimento e cigolarono, le matite graffiarono i taccuini, tutti stettero molto attenti. Tutti quanti annotarono che J.W. salpava per New York a bordo del Rochambeau di lì a due settimane. Quando i giornalisti se ne furono andati a far la coda all’ufficio telegrafico, J.W. sbadigliò e pregò Dick di scusarlo presso Eleanor, dicendole che lui era effettivamente troppo stanco per poter andare a trovarla quella sera. Quando Dick tornò all’aria libera, il cielo aveva un po’ di viola crepuscolare. Chiamò un tassì; grazie a Dio, adesso poteva prendere un tassì quando ne aveva voglia.
Da Eleanor c’era aria di compassatezza, la gente sedeva in salotto e in una camera da letto che era stata adattata a boudoir con un alto specchio drappeggiato di pizzo, e la conversazione languiva nel disagio. Lo sposo poi pareva avesse le formiche sotto il colletto. Eveline ed Eleanor stavano alla finestra a conversare con un uomo dalla faccia asciutta: era quel Don Stevens che era stato arrestato in Germania dall’esercito d’occupazione e per il quale Eveline aveva fatto correre tutti quanti. «E ogni volta che casco in un guaio» diceva «trovo sempre un piccolo ebreo che mi aiuta a cavarmela… stavolta è stato un sarto.» «Be’, Eveline non è un piccolo ebreo e nemmeno un sarto,» disse gelida Eleanor «però ti assicuro che ha fatto molto.» Stevens traversò la stanza per avvicinarsi a Dick e gli chiese che tipo d’uomo era quel Moorehouse. Dick, colto alla sprovvista, arrossì. Se Stevens non avesse parlato così forte! «Ecco, è un uomo di abilità eccezionale» farfugliò. «Credevo che fosse un pupazzo impagliato… Non capisco che cosa sperassero di cavarci per i loro articoli quei fessi della stampa borghese… Io ero lì per il “Daily Herald”.» «Infatti vi ho visto» disse Dick. «Da quello che mi disse Steve Warner io mi ero fatto l’idea che voi doveste essere un tipo intimamente noioso.» «Forse noioso e annoiato, volete dire.» Stevens gli diede un’occhiata come se stesse per prenderlo a pugni. «Be’, presto giocheremo a carte scoperte. Dovremo tutti mostrare la faccia, come dicono in Russia, fra non molto.» Eleanor interruppe il diverbio con una bottiglia di champagne appena stappata. Stevens tornò a parlare con Eveline nel vano della finestra. «Santo Cielo, è come avere in casa un predicatore battista» ridacchiò Eleanor. «Accidenti, non posso soffrire le persone che ci provano gusto a mettere a disagio gli altri» brontolò Dick fra i denti. Eleanor abbozzò un rapido sorriso a V e gli diede sul braccio un colpetto con quella sua manina sottile che terminava in unghie lunghe appuntite e rosee, segnate con mezzelune: «Anch’io, Dick, anch’io».
Quando Dick bisbigliò che aveva il mal di testa e riteneva opportuno andarsene a casa e mettersi a letto, lei lo prese per il braccio e se lo tirò nell’atrio: «Non oserai andartene così e lasciarmi con questo gelo?!». Dick fece una faccia rassegnata e la seguì in sala. Ella gli versò un calice di champagne dalla bottiglia che aveva ancora in mano: «Cerca di rialzare il morale a Eveline» sussurrò stridula. «È la terza volta che sta per crollare.» Dick stette lì per ore intere a parlare con la signora Johnson di libri, drammi, opere liriche. Nessuno dei due, a quanto pareva, seguiva l’altro. Eveline non riusciva a staccare gli occhi dal marito. Lui aveva un’aria da cucciolo che a Dick non poteva a meno di riuscire simpatica; stava accanto alla credenza e si stava sborniando con Stevens, il quale seguitava a fare apprezzamenti ad alta voce sui parassiti e i figli di papà della borghesia. Andò avanti un pezzo a questo modo. Paul Johnson si sentì male e Dick dovette aiutarlo a trovare la stanza da bagno. Quando tornò in sala per poco non venne alle mani con Stevens, il quale, dopo una discussione sulla Conferenza della pace, improvvisamente si ritrasse coi pugni stretti e lo chiamò dannata signorina. I Johnson buttarono fuori Stevens. Eleanor si accostò a Dick, gli mise un braccio al collo e gli disse che si era comportato magnificamente. Paul Johnson tornò di sopra dopo che fu andato a prendere le cocorite. Era pallido come un cencio lavato. Uno degli uccelletti era morto e giaceva supino e rigido, con gli unghioli all’aria, sul fondo della gabbia. Alle tre circa Dick tornò al suo albergo in tassì.
Cine-giornale XLIII ai radicali furono strappati i cartelli che portavano, lacerati i vestiti e anneriti gli occhi a forza di percosse prima ancora che i soldati e gli ex combattenti avessero finito di picchiarli 34 Persone Muoiono per Ingestione di Alcool Metilico Forse Presto Fermi i Treni in Francia Gerard Butta il Cappello nel Ring LA CORTE SUPREMA SPEZZA L’ULTIMA SPERANZA DI BOCCA UMIDA UN’IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO CHIAMATA DA SEGNALI RAZZO CERCA INVANO PER SEDICI ORE America, ti amo, sei come una mia innamorata LES GENS SAGES FUIENT LES RÉUNIONS POLITIQUES CHIUSURA DEPRESSA A WALL STREET: I TIMORI BLOCCANO IL DENARO Da un oceano all’altro per te la mia devozione raggiunge ogni confine SI ATTENDE IL PICCOLO CARUSO sua madre, la signora W.D. Gillicudy, ha detto: «il mio primo marito morì sotto un treno nell’attraversare i binari, il mio secondo marito fece la stessa fine e ora è la volta di mio figlio Proprio come un bimbetto sulle ginocchia della mamma LE MITRAGLIATRICI MIETONO LA FOLLA A KNOXVILLE America ti amo Alcuni Aviatori Si Sono Nutriti per Sei Giorni di Molluschi la polizia obbligò i dimostranti ad abbassare questi vessilli e ordinò all’assemblea di non esibire altri emblemi rossi che il rosso contenuto nella bandiera nordamericana; comunque non sarà indiscreto accennare – e non potrà certo offuscare la sua gloria – che quando arrivò il messaggio il generale Pershing era chiuso nella sua
cabina in preda al mal di mare. Un Vecchio Camerata dell’Ottantanove Tesaurizza la Gomma da Masticare come Prezioso Ricordo Non Riusciva a Mantenere la Calma nel Concludere i Dibattiti della Lega E come me ve n’è altri cento milioni
Le spoglie mortali di un americano Laddoveil Congressodeglistatiuniti condeliberazioneunanimeadottatail quattromarzo scorsoautorizzavail segretarioallaguerra a far portare in Americale spogliemortali di un americanocheappartennealcorpodispedizioneamericanoineuropa cheperdettelavitanellaguerramondialeenonè statoidentificato per inumarle nell’anfiteatrodellerimembranzedelcimiteronazionalediarlingtonvirgi nia Nell’obitorio di cartone incatramato di Châlons-sur-Marne, fra il puzzo di cloruro di calcio e di cadavere, presero la cassa di pino che conteneva tutto quel che restava di N.N. una caterva di altre casse di pino ammonticchiate lì contenevano quanto si era potuto racimolare di Richard Roe e altra persona o persone sconosciute. Una soltanto può partire. Come han fatto a prendere proprio John Doe? Accertatevi che non sia un francese, ragazzi, accertatevi che non sia un italiano o un ebreo tedesco, come si fa a esser sicuri che si tratti di un americano al cento per cento quanto tutto quanto si riduce a un sacco di iuta pieno di ossa, bottoni di bronzo con impressa l’aquila che grida, e un paio di gambali? … e il cloruro soffocante e il lezzo vomitevole dei cadaveri vecchi d’un anno… In complesso la giornata è stata troppo tragica e significativa per consentire acclamazioni. Oggi il consenso nazionale si è espresso attraverso il silenzio, le lacrime, gli inni e la preghiera, i tamburi e la musica in sordina. John Doe nacque (pulsante diana del sangue in amore nello slancio brividente di un uomo e una donna soli veramente assieme che si trasfondono in e nove mesi di pena sonnecchiare svegliandosi a una sgomenta
agonia e il dolore e il sangue e il caos del parto). John Doe nacque e crebbe a Brooklyn a Memphis, presso la riva del lago a Cleveland, Ohio, nel tanfo degli allevamenti di bestiame di Chicago, a Beacon Hill, in una vecchia casa di mattoni ad Alexandria, Virginia, a Telegraph Hill, in una casetta stile Tudor costruita a metà in legno a Portland la città delle rose, nel Lying-In Hospital fondato dal vecchio Morgan in Stuyvesant Square, vicino ai binari della ferrovia, in campagna nei pressi del circolo, in una capanna cabina casa d’affitto appartamento signorile quartiere d’abitazione dei sobborghi; rampollo di una delle prime famiglie, vinsero il primo premio al concorso di bellezza per bambini di Coronado Beach, fu campione di biglie dei ginnasi di Little Rock, cestista scelto della scuola media superiore di Booneville, capitano della squadra di calcio al riformatorio di Stato, avendo salvato il figliolo dello sceriffo che stava per annegare nel Little Missouri fu invitato a Washington per essere fotografato nell’atto di stringere la mano al presidente sulla scalinata della Casa Bianca; sebbene questa sia una mesta occasione, un’adunanza simile non può non avere una nota di colore. Nelle tribune si vedono le tenute di gala dei diplomatici stranieri, gli alti gradi del nostro esercito e della nostra marina e di quelli stranieri, il nero dell’abito mattutino da cerimonia degli statisti americani, le variopinte pellicce e abiti da passeggio delle madri e sorelle venute a piangere i loro cari, il grigio oliva e il blu dei soldati e marinai, il luccichio degli strumenti musicali e il bianco e nero di un coro in tenuta solenne – bigliettario di autobus bracciante agricolo porcaio boy-scout contadino sfogliatore di pannocchie del Kansas occidentale cameriere dello United States Hotel di Saratoga Springs fattorino buttafuori fruttivendolo telefonista scaricatore di porto boscaiolo aiuto idraulico, lavoro come sicario per un’associazione a delinquere a Union City, riempì la pipa in una fumeria d’oppio di Trenton, N.J. Segretario dell’YMCA, spedizioniere, camionista, meccanico d’automobili, vendette libri a Denver, Colorado: Signora, vorreste
aiutare un giovane a compiere gli studi universitari? Il presidente Harding, con ossequio riverente tanto più significativo per la sua alta posizione sociale, concluse il suo discorso: Noi siamo qui riuniti oggi per rendere l’omaggio impersonale; il nome di colui le cui spoglie mortali giacciono davanti a noi se ne volò via con la sua anima immortale… da tipico soldato di questa democrazia rappresentativa combatté e morì credendo nell’incontestabile giustizia della causa della sua patria… alzando la mano destra e chiedendo alle migliaia di persone che lo ascoltavano di unirsi alla preghiera seguente: Padre nostro che sei nei Cieli, sia benedetto il nome Tuo… Nudo entrò nell’esercito; lì ti pesarono, ti misurarono, guardarono se avevi i piedi piatti, ti compressero la verga per vedere se avevi l’ernia, ti guardarono nell’ano per vedere se avevi le emorroidi, ti contarono i denti, ti fecero tossire, ti auscultarono cuore e polmoni, ti fecero leggere i caratteri sul cartello, ti studiarono l’orina e l’intelligenza, ti diedero la scheda personale dello stato di servizio per il futuro (anima immortale) e una piastrina di riconoscimento col numero di matricola stampato sopra da appenderti al collo, ti diedero il corredo regolamentare grigio oliva, una gavetta e una copia degli articoli del codice militare di guerra. Aaat-TENTI! pancia in dentro testa di c…o! Via quel sorriso dalla faccia occhi dritti che cosa credi che sia questa, una riunione da oratorio? Avanti-MARCH! John Doe e Richard Roe e altra persona o persone sconosciute si esercitò alla marcia, studiò le armi, mangiò la sbobba, imparò a salutare, a darsi malato, a fare il lavativo nei gabinetti, proibito fumare in coperta, servizio di guardia oltremare, ispezione alle armi portatili e lo scoppiettio dello shrapnel e gli striduli proiettili che pettinavano l’aria e il cecchino i picchi le mitragliatrici fango pidocchi maschere antigas e la scabbia. Ehi tu, dimmi come debbo fare per tornare al mio reparto.
John Doe aveva una testa per venti anni e rotti intensamente i nervi degli occhi degli orecchi del palato della lingua delle dita delle mani dei piedi delle ascelle, i nervi termosensibili sotto la pelle caricarono le circonvoluzioni cerebrali di dolore dolce caldo freddo mio devo non farlo frasi stampa titoli di giornale: Tu non dovrai la tabella della moltiplicazione lunga divisione, Questo è il momento per tutti i buoni bussa una sola volta alla porta di un giovane, C’è da ringraziare il Cielo se Accidenti, I primi cinque anni saranno La sicurezza prima di tutto, Immagina che un unno tentasse di violentare la tua la mia patria ha sempre ragione, Prendeteli da giovani, Macché egli non sa niente non li tratterà male, A loro non dir nulla, Ha avuto quel che si meritava e ben gli sta, Questa è una terra di bianchi, Un calcio al secchio, Partito per l’Occidente, Se non ti va puoi… tutto questo lo intronò. Ehi stella vuoi dirmi come debbo fare per tornare al mio reparto? Non posso fare a meno di saltare quando quegli affari scoppiano, mi danno il tremito convulso quegli affari. Ho perso il piastrino di riconoscimento nuotando nella Marna, scherzando con uno mentre aspettavamo il turno della disinfezione, a letto con una ragazza che si chiamava Jeanne (Amore cinema cartolina francese bagnata sogno cominciato con il nitrato di potassio nel caffè e terminato all’infermeria reparto profilattico); – Ehi militare, per grazia di Dio vuoi dirmi come posso fare per tornare al mio reparto? Il cuore di John Doe pompava sangue: vivo pulsante silenzio del sangue nelle orecchie laggiù nella radura nella foresta dell’Oregon dove c’erano i poponi color popone riversantisi nel sangue attraverso gli occhi e gli alberi color autunno e le cavallette di bronzo saltavano nell’erba secca, dove esili chiocciole striate pendevano dalla pagina inferiore di fili d’erba e le mosche ronzavano, le vespe brusivano, i calabroni sonavano il violoncello, e i boschi odoravano di vino e funghi e mele, odore familiare d’autunno che si riversava nel sangue,
e io deposi il cappello lucido e lo zaino impregnato di sudore e mi sdraiai col sole canicolare che mi leccava la gola e il pomo di Adamo e la pelle tesa sopra lo sterno. Il proiettile aveva il suo numero. Il sangue scorse penetrando nella terra. La scheda personale cadde dallo schedario quando il sergente che fungeva da quartiermastro fu polverizzato quella volta dovettero far bagaglio in fretta e furia e lasciar lì le scartoffie. Il piastrino di riconoscimento era in fondo alla Marna. Il sangue penetrò nella terra, il cervello colò dal cranio spaccato e fu leccato dai topi di trincea, il ventre si gonfiò e nutrì una generazione di mosche verdi, e l’incorruttibile scheletro, e i brandelli di visceri e pelle essiccati avvolti nella stoffa kaki li portarono a Châlons-sur-Marne e li misero come stavano in una bara di pino e li portarono in patria, nella Terra di Dio, a bordo di una corazzata e li seppellirono in un sarcofago nel Memorial Amphitheatre nel cimitero nazionale di Arlington e ci drappeggiarono sopra l’Old Glory e il trombettiere sonò il silenzio e gli ammiragli e i pezzi grossi e i politicanti e le signore eleganti della cronaca mondana del «Washington Post» stettero ritti e solenni e pensarono com’era bello triste Old Glory Terra di Dio avere il trombettiere che sonava il silenzio e le tre salve intronarono gli orecchi. Sul punto dove avrebbe dovuto esservi il suo petto appuntarono la medaglia del Congresso, la Distinguished Service Cross, la Médaille Militaire, la Croix de Guerre belga, la medaglia d’oro italiana, la Virtutea Militara˘ inviata dalla regina Maria di Romania, la croce di guerra cecoslovacca, la Virtuti Militari dei polacchi, una corona d’alloro inviata da Hamilton Fish junior di New York, e una piccola collana di conchiglie portata come omaggio da una delegazione di pellirosse dell’Arizona dipinti all’uso di guerra e con tanto di penne.
Tutti gli abitanti di Washington portarono fiori. Woodrow Wilson portò un mazzo di papaveri.
Un mucchio di quattrini Traduzione di Cesare Pavese
Charley Anderson Charley Anderson giaceva nella cuccetta in un abbagliante ronzio rosso. Oh, Titine, maledetta la canzone di ieri. Giaceva piatto con gli occhi scottanti; la lingua gli sapeva in bocca come di panno spesso tiepido disgustoso. Issò fuori i piedi da sotto la coperta e li spenzolò oltre l’orlo della cuccetta, grossi piedi bianchi dalle nocche rosee alle dita; li lasciò cadere sul rosso tappeto e si trascinò malfermo al finestrino. Cacciò fuori la testa. Invece della calata: nebbia e ondicelle verde-grigio sciaguattanti contro l’erto fianco del piroscafo. Ancorati. Un gabbiano gli strillò sopra, celato dalla nebbia. Lui rabbrividì e ritirò la testa. Alla vaschetta si buttò acqua fredda in faccia e sul collo. Dove l’acqua fredda lo toccò, la pelle arrossava. Cominciò a sentir freddo e nausee, e ritornò in cuccetta tirandosi sotto il mento le lenzuola ancor tiepide. Era in patria. Maledetta la canzone. Balzò su. Tempie e stomaco ora gli palpitavano insieme. Tirò fuori l’orinale e vi si piegò sopra. Sussultò; venne un po’ di bile verde. No, non ho da rigettare. Si mise maglia e mutande e i pantaloni di fustagno dell’uniforme, e s’insaponò per radersi. Radendosi si sentiva angosciato. Quel che mi occorre è… Suonò per chiamare il cameriere. «Bonjour, m’sieur.» «Di’, Billy, un doppio cognac, tuzuit.» Si abbottonò la camicia con cura e indossò la giubba; guardandosi nello specchio, aveva gli occhi cerchiati di rosso e le guance livide sotto l’abbronzatura. Di colpo gli tornò la nausea; un acido rigurgito gli saliva in gola dallo stomaco. Accidenti, puzzano queste navi francesi! Un busso, il sogghigno da rana 1 del cameriere e «Voilà, m’sieur», il piattino bianco lasciò cadere un po’ di fluida ambra traboccatavi dal bicchiere. «Quando attracchiamo?» Il cameriere alzò le spalle e borbottò: «La brume». Chiazze verdi gli ballavano ancora davanti agli occhi quando salì la scaletta odorante di linoleum. Una volta in coperta la nebbia gli stillò in faccia umidità. Si ficcò le mani in tasca e andò avanti, piegandosi. Nessuno in coperta; qualche baule, sedie a sdraio
ripiegate e accatastate. A sopravvento tutto era bagnato. Stillavano gocciole giù per i finestrini cerchiati d’ottone della sala fumatori. Nulla da nessuna parte, se non la nebbia. Al secondo giro incontrò Joe Askew. Joe era in gamba. I baffetti si spartivano eleganti sotto il naso fino. Gli occhi eran limpidi. «Ci mancava anche questa, Charley. La nebbia.» «Porcheria.» «Mal di testa?» «Tu stai bene, Joe.» «Certo, perché no? Ho il nervoso, sono in piedi dalle sei. Maledetta la nebbia, possiamo star qui tutto il giorno.» «È nebbia sul serio.» Fecero un paio di giri intorno alla coperta. «Senti come puzza la nave, Joe?» «È perché siamo alla fonda; e poi la nebbia ti stimola il fiuto, immagino. Se mangiassimo un boccone?» Charley non rispose nulla per un istante, poi tirò un respiro profondo e disse: «Ma sì, proviamo». La sala da pranzo sentiva di cipolle e di lucida metalli. I Johnson erano già al tavolo. La signora Johnson aveva un’aria pallida e fredda. Indossava un cappellino grigio che Charley non le aveva mai veduto, già pronta a sbarcare. Paul rispose al saluto di Charley con un sorriso disgustato. Charley s’accorse che la mano di Paul tremava sollevando la spremuta d’arancia. Le sue labbra eran bianche. «Qualcuno ha visto Ollie Taylor?» domandò Charley. «Si sentiva piuttosto male, il maggiore, scommetto» disse Paul ghignando. «E voi, Charley, come state?» modulò amabilmente la signora. «Oh io… io sono a cavallo.» «Bugiardo!» fece Joe Askew. «Io non riesco a capacitarmi» diceva la signora «che cosa vi abbia tenuto in piedi fino a così tardi, ieri sera.» «Abbiamo cantato un po’» disse Joe Askew. «Qualcuno di mia conoscenza» disse la signora Johnson «è andato
a letto vestito.» Il suo sguardo incontrò quello di Charley. Paul cambiò discorso. «Ebbene, rieccoci finalmente nella Terra Promessa.» «Non riesco a capacitarmi» esclamò la signora Johnson «di quel che sarà l’America.» Charley stava trangugiando i suoi wuffs avec du bakin 2 e il caffè che sapeva di fondaccio. «Quello che mi riprometto» diceva Joe Askew «è una vera colazione americana.» «Pompelmo» disse la signora Johnson. «Paste di meliga con panna» disse Joe. «Crostini caldi» disse la signora Johnson. «Uova fresche e vero prosciutto di Virginia» disse Joe. «Focaccia e salsiccia paesana» disse la signora Johnson. «Scrapple» 3 disse Joe. «Buon caffè e vera panna» disse la signora Johnson ridendo. «Hai colto nel segno» esclamò Paul con un ghigno sofferente mentre si alzava. Charley bevve un ultimo sorso di caffè. Poi disse che aveva pensato di salire in coperta a vedere se i funzionari dell’ufficio immigranti eran giunti. «Ma che cos’ha Charley?» Sentì Joe e la signora Johnson che se la ridevano insieme, mentre lui correva per la scaletta di cabina. Arrivato in coperta decise che non aveva da vomitare. La nebbia s’era un po’ diradata. A poppa del Niagara si vedevano le ombre di altri piroscafi ancorati e, oltre, un’ombra tondeggiante che poteva esser la terra. Alcuni gabbiani vorticavano e strillavano in alto. Da qualche parte attraverso l’acqua una sirena da nebbia rombava a intervalli. Charley si mise a camminare dritto avanti a sé e si piegava nella nebbia bagnata. Joe Askew lo raggiunse alle spalle fumando il sigaro e gli prese un braccio: «Meglio far quattro passi, Charley» disse. «Non è una porcheria, questa? Sembra che la cara vecchia New York si sia fatta silurare durante il sullodato conflitto… Non ci vedo neanche a morire, e tu?»
«Mi era parso di veder terra un minuto fa, ma adesso è scomparsa.» «Forse era Atlantic Highlands; siamo all’ancora al largo di Sandy Hook… Porco cane, io voglio sbarcare.» «Ci sarà tua moglie, vero, Joe?» «Dovrebbe esserci… Conosci nessuno, Charley, a New York?» Charley scosse il capo. «Ho ancora molta strada prima di giungere a casa… Non so quel che farò una volta arrivato.» «Porco cane, vedrai che stiamo qui tutto il giorno» disse Joe Askew. «Joe,» disse Charley «che ne dici di un sorso… il sorso dell’addio?» «Hanno chiuso quel maledetto bar.» Le valigie le avevan preparate la sera prima. Non restava più nulla da fare. Passarono la mattinata giocando a carte nella sala fumatori. Nessuno riusciva a stare attento al gioco. A Paul cadevano continuamente le carte. Nessuno sapeva mai chi aveva fatto l’ultima mano. Charley cercava di stogliere gli occhi dagli occhi della signora Johnson, dalla curvetta di quel collo là dove scompariva sotto la grigia guarnizione di pelliccia dell’abito. «Non riesco a capacitarmi» ricominciò quella «che cosa avevate da dirvi fino a così tardi, ieri sera… Credevo che avessimo parlato di tutto il possibile e l’immaginabile, quando sono andata a letto.» «Oh, abbiamo trovato argomenti, ma essenzialmente tutto ci è venuto sotto forma di canto» disse Joe Askew. «Lo so che io ci rimetto sempre quando vado a letto.» Charley s’accorse di Paul accanto a sé, che la fissava con due occhi smarriti e adoranti. «Ma» diceva la signora col suo sorriso canzonatorio «è davvero troppo noioso stare in piedi.» Paul arrossì, ebbe l’aria di mettersi a piangere; Charley si chiese se Paul aveva pensato alla stessa cosa che lui. «Dunque, vediamo; a chi tocca?» disse vivamente Joe Askew. Verso mezzogiorno il maggiore Taylor entrò nella sala fumatori. «Buon giorno a tutti… So che nessuno può sentirsi peggio di me. Il comandante dice che potremmo non attraccare fino a domani mattina.»
Tutti posarono le carte senza finire il giro. «Quest’è carina» disse Joe Askew. «Fa proprio lo stesso,» disse Ollie Taylor «io sono un rottame. L’ultimo dei gran bevitori, gran cavalcatori che furono i Taylor, è un rottame. Abbiamo saputo far fronte alla guerra, ma la pace ci ha liquidati.» Charley levò gli occhi alla faccia terrea di Ollie Taylor, floscia nel riverbero pallido della nebbia ai finestrini e gli vide strisce bianche nei capelli e nei baffi. Giuda, pensò tra sé, bisogna che io smetta di bere. Bene o male mandarono giù il pranzo, e si sparsero nelle varie cabine, a dormire. Nel corridoio della sua, Charley incontrò la signora Johnson. «Via, saranno i primi dieci giorni i più difficili, signora Johnson.» «Perché non mi chiamate Eveline, come tutti gli altri?» Charley avvampò. «Che serve? Non ci vedremo mai più.» «Perché no?» disse lei. Le guardò negli occhi color nocciola; le pupille si dilatarono finché tutto il bruno fu nero. «Dio mio, mi piacerebbe se fosse» balbettò. «Non crediate che io…» Ella era già sgusciata oltre frusciando, e scomparsa nel corridoio. Charley entrò in cabina sbattendo l’uscio. Le valigie erano fatte. Il cameriere aveva tolto le lenzuola. Charley si gettò bocconi sulla tela a strisce del materasso, che sapeva di rancido. «Donna maledetta» disse a voce alta. Il martellio di un molinello a vapore lo destò, e poi udì il frastuono delle campane, nella sala macchine. Guardò fuori del finestrino e vide un battello di dogana bianco e giallo e, al di là, un vago sole rosato sulle case di legno. La nebbia saliva; erano nello stretto. Nel tempo che si cacciò a spruzzi d’acqua il sonno dagli occhi indolenziti e corse in coperta, il Niagara aveva cominciato a farsi strada adagio traverso la verdegrigia baia luccicante. La nebbia rossastra era arrotolata come un tendaggio in alto. Una rossa chiatta li incrociò a prua. A destra c’era una fila di golette a quattro e cinque alberi ancorate, oltre queste un brigantino a vele quadre e un gruppo
di tozzi vapori della Shipping Board, qualcuno ancora listato e screziato dalla mascheratura. Poi, dritto in prora, l’andirivieni brillante, nella foschia degli alti edifici di New York. Joe Askew gli si avvicinò col cappotto indosso e il binocolo tedesco a spalla. I suoi occhi azzurri risplendevano. «Vedi già la statua della Libertà, Charley?» «No… sì, eccola. Me la ricordavo più grande.» «Là è Black Tom, dov’è stata l’esplosione.» «Tutto sembra tranquillo, Joe.» «È domenica, sfido.» «Dev’essere domenica.» Erano di fronte al Battery, ora. Le lunghe arcate dei ponti di Brooklyn s’allontanavano nell’ombra fumosa dietro i grattacieli pallidi. «Dunque, Charley, è là che ci sono i quattrini. Dovremo portarne via un poco anche noi» disse Joe Askew, tirandosi un baffo. «Vorrei sapere come si comincia, Joe.» Costeggiavano una lunga fila di calate con tettoia. Joe tese la mano. «E allora, Charley, scrivimi, vecchio, capito? È stata una gran guerra finché è durata.» «Sta’ certo, Joe.» Due rimorchiatori facevano virare il Niagara per attraccarlo alla banchina, vincendo la resistenza del riflusso. Bandiere americane e francesi sventolavano sul tetto dello scalo, sulle soglie oscure c’eran gruppi di gente che salutavano. «Ecco mia moglie» disse Joe Askew a un tratto. Serrò la mano di Charley. «Ciao, vecchio. Siamo arrivati.» Prima cosa di cui Charley s’accorse, troppo presto, fu che camminava giù per il ponte di sbarco. Il funzionario gli guardò appena le carte; il doganiere disse: «Dev’essere un gusto tornare a casa, tenente» e gli metteva i bolli sulla valigia. Passò innanzi a quello dell’YMCA e ai due giornalisti e al rappresentante del comitato municipale; la poca gente e i bauli sparsi apparivano sperduti e soli nella gran penombra gialla sotto il tetto dello scalo. Il maggiore Taylor e i Johnson si strinsero la mano come estranei. Poi s’accorse di camminare verso un tassì, dietro al suo bauletto
kaki. I Johnson erano già in macchina e aspettavano una valigia smarrita. Charley si avvicinò. Non trovò nulla da dire. Paul gli disse che senza fallo doveva venire a trovarli se si fermava in New York, ma non si toglieva dallo sportello del tassì, cosicché fu difficile a Charley parlare con Eveline. Vide i muscoli rilassarsi sulle mascelle di Paul quando il facchino arrivò con la valigia perduta. «Venite senza fallo a trovarci» disse Paul, e saltò dentro e sbatté lo sportello. Charley ritornò al suo tassì, portando con sé un’ultima immagine di lunghi occhi color nocciola e di un sorriso canzonatorio. «Sapete se per gli ufficiali fanno ancora tariffe speciali al McAlpin?» chiese all’autista. «Ma sì, vi trattano con tutti i riguardi se siete ufficiale… Se invece venite dalla truppa ci sono calci in culo» rispose l’autista parlando in un angolo delle labbra, e cacciò in marcia. Il tassì svoltò in un’ampia via deserta acciottolata. Si andava più molleggiati che sui tassì di Parigi. I grossi empori e gli edifici dei negozi erano tutti chiusi. «Giuda, tutto è tranquillo qui» disse Charley, curvandosi a parlare all’autista attraverso il vetro. «Tranquillo, sì… Aspettate di mettervi in giro a cercar lavoro» disse l’autista. «Ma, perdio, non ricordo di aver visto mai tutto così tranquillo.» «E be’, perché non dev’essere tranquillo…? È domenica, no?» «Ah già, dimenticavo ch’è domenica.» «Sicuro che è domenica.» «Ricordo adesso che è domenica.» 1. Le rane, the frogs, sono i francesi. (NdT) 2. Tartine al lardo. La frase è un misto di francese e inglese storpiato. (NdT) 3. Pasticcio di carne di porco tritata con spezie, ecc. (NdT)
Cine-giornale XLIV Yankee Doodle la canzone IL COLONNELLO HOUSE GIUNGE DALL’EUROPA IL SUO ASPETTO È MOLTO SOFFERENTE Yankee Doodle la canzone CONQUISTARE LO SPAZIO E VEDERE LE COSE LONTANE e non è dunque venuta l’ora che i proprietari dei giornali si uniscano in un movimento risanatore allo scopo di calmare l’agitazione dei cervelli, pubblicando bensì ogni notizia ma dando minor risalto alle probabili calamità LA STASI CONTINUA MENTRE LA BATTAGLIA S’ESTENDE permisero ai governatori dello Steel Trust di calpestare i diritti democratici, che tanto spesso erano stati proclamati il retaggio del popolo di questa terra GLI ARMATORI CHIEDONO PROTEZIONE Yankee Doodle la canzone Yankee Doodle la canzone mi fa sorgere e gridare gli unici sopravvissuti della goletta Onato vengono chiusi in carcere appena giunti a Filadelfia IL PRESIDENTE STRONGER LAVORA NELLA SUA STANZA DA LETTO Vengo, America Canterò POTREBBE FAR TACERE LA STAMPA non c’è terra… così bella Charles M. Schwab, che ritorna dall’Europa, è stato invitato a colazione nella Casa Bianca. Ha dichiarato che questo paese è prospero assai, ma non quanto dovrebbe, poiché ci sono in corso troppe inchieste preoccupanti … come quella che si stende fra gli oceani
Charley Anderson Il ragazzotto faccia di topo posò le valigie, provò i rubinetti del lavabo, schiuse la finestra, mise la chiave nella toppa interna e poi si piantò suppergiù sull’attenti e disse: «Nient’altro, tenente?». Così è la vita, pensò Charley, e pescò una moneta da venticinque cents nella tasca dei calzoni. «Grazie, signore, tenente.» Il ragazzo stropicciò i piedi e si schiarì la gola. «Dev’essere stata una cosa tremenda laggiù, tenente.» Charley rise. «Oh niente male.» «Vorrei esserci stato, tenente.» Il ragazzo mostrò ghignando un paio di denti da topo. «Dev’essere bello sentirsi un eroe» disse, e indietreggiò all’uscio. Charley guardava dalla finestra, sbottonandosi la giubba. Era ben in alto. Attraverso una via di tetri edifici quadrati poteva vedere certe colonne e i tetti della nuova stazione di Pennsylvania, e al di là, oltre i fasci e le baracche dei binari, un sole annebbiato calare dietro un terrapieno sulla riva opposta dello Hudson. Il cielo era rosa e purpureo. Un treno aereo strepitò stridente sopra le vie deserte nel crepuscolo domenicale. La ventata che spirava per la fessura della finestra sentiva di granuloso carbone bruciato. Charley abbassò il vetro e andò a lavarsi faccia e mani. L’asciugamano d’albergo era soffice e spesso, con una punta di cloruro. Andò allo specchio e si pettinò. E ora? Passeggiava avanti e indietro per la stanza tormentando la sigaretta, guardando il cielo abbuiarsi fuori della finestra, quando il trillo del telefono lo scosse. Era la voce cortese e malferma di Ollie Taylor. «Ho pensato che forse non sapevate dove bere un bicchiere. Volete venire da me al circolo?» «Grazie, siete ben gentile, Ollie. Stavo appunto chiedendomi che può fare un uomo da queste parti.» «Vedete, è una cosa spaventosa» continuò la voce di Ollie. «Col proibizionismo e tutto il resto, è peggio di quel che poteva immaginare la fantasia più lugubre. Verrò a prendervi con un tassì.» «Va benissimo, Ollie, sarò sotto.» Charley si mise la giubba, ricordò di lasciare il cinturone, riordinò un’altra volta i ciuffi rossi dei suoi capelli e scese nella sala d’aspetto.
Sedette in una profonda poltrona di fronte alla porta girevole. La sala era affollata. Si sentiva un’orchestra da qualche parte, in fondo. Charley sedeva ascoltando i ballabili, sbirciando le calze di seta e i tacchi alti e le pellicce e i visi delle belle ragazze un po’ ravvivati dal vento mentre entravano dalla via. Tutto aveva un tintinno e un sinuoso fruscio d’eleganza. Caspita, era bello. Le donne lasciavano lievi buffate di profumo e un tiepido odore di pelliccia passandogli accanto. Si mise a contare quanto denaro gli restava. Aveva una tratta di trecento dollari risparmiati sullo stipendio, quattro bigliettoni gialli da venti in portafogli nella tasca interna, guadagnati a poker durante il viaggio, un paio di biglietti da dieci e vediamo un po’ quanti spiccioli. Le monete gli tintinnarono leggere nei calzoni, mentre le passava tra le dita. Il viso rosso di Ollie Taylor ammiccava a Charley al disopra di uno spesso soprabito di cammello. «Ragazzo mio, New York è un disastro… Servono i gelati al selz al Knickerbocker.» Quando furono saliti insieme nel tassì, alitò in faccia a Charley un tanfo di whisky fortissimo. «Charley, ho promesso di portarvi a pranzo con me… Soltanto dal vecchio Nat Benton. Non avete niente in contrario… è un bel tipo. Le dame vogliono conoscere un vero pilota, con tanto di palme». 1 «Siete sicuro che non disturbo, Ollie?» «Ragazzo mio, non parliamone più.» Al circolo tutti, pareva, conoscevano Ollie Taylor. Lui e Charley stettero un bel po’ a bere Manhattan 2 a un banco di legno scuro fra un crocchio di vecchi signori canuti che avevano in faccia la concia della liquoreria. Maggiore di qua, maggiore di là, e tenente ogni volta che parlavano a Charley. Charley cominciava a impensierirsi se Ollie non si sarebbe empito troppo per portarlo ancora a cena in casa di qualcuno. Alla fine furono le sette e mezzo, e lasciando l’ultimo giro d’addio di cocktail si rimisero in tassì, masticando ciascuno un chiodo di garofano, e si diressero alla periferia. «Non so che dire a quella gente» fece Ollie. «Racconto che ho vissuto i due anni più deliziosi della mia esistenza e quelli mi fanno certe smorfie, ma non so che farci.» C’era una tremenda quantità di marmo, e portieri in verde, nella
casa dove andavano a cena, e l’ascensore era intarsiato di legni differenti. «Nat Benton» bisbigliò Ollie mentre aspettavano che la porta s’aprisse «è un agente di Borsa.» Tutti in abito da sera li aspettavano per la cena in un salotto roseo. Erano evidentemente vecchi amici di Ollie, perché gli fecero intorno un grande cancan e si mostrarono molto cordiali con Charley e subito vennero i cocktail, e Charley si sentiva come il galletto nel pollaio. C’era una ragazza a nome signorina Humphries, carina come un quadro. Appena le pose gli occhi addosso, Charley decise ch’era lei quella a cui avrebbe rivolto la parola. Quegli occhi e quel vaporoso abito verdepallido e la cipria nel piccolo cavo tra le spalle gli diedero un po’ di vertigine, in modo che non osava starle troppo vicino. Ollie li vide tutti e due insieme e s’accostò prendendole l’orecchio. «Doris, ti sei fatta una signorina di radiosa bellezza.» Si fermò geniale dondolandosi un poco sulle gambe corte. «Uhm… l’amore è il premio dei forti… Non capita tutti i giorni di tornare dalla guerra, vero, Charley, bamboccio?» «Non è un caro ragazzo?» disse lei, quando Ollie se ne fu andato. «Eravamo grandi innamorati quando io avevo sei anni e lui era uno studente.» Quando tutti furono pronti per la cena, Ollie, che aveva bevuto un altro paio di bicchierini, distese le braccia e fece un discorso. «Guardatele, le nostre adorabili, intelligenti e briose donne americane… Non c’era niente di simile, laggiù, vero, Charley? Tre cose vi sono, che non si trovano altrove nel mondo: un buon cocktail, una colazione decente, e una fanciulla americana, Dio le benedica.» «Com’è caro!» sussurrò la signorina Humphries nell’orecchio di Charley. C’era argenteria su argenteria, in tavola, e un vassoio cinese con rose nel centro e un gruppo di coppe dal piede dorato a ciascun posto. Charley si sentì meglio, quando trovò che l’avevano collocato vicino alla signorina Humphries. Questa gli sorrideva. «Perdinci,» disse lui, ridendo «non so quasi come comportarmi.» «Dev’essere una bella differenza… da laggiù. Ma siate naturale. Io faccio così.» «Oh, no, ci si mette sempre nei pasticci a essere naturali.» Quella rise. «Forse avete ragione… Oh, raccontatemi com’eran
davvero le cose laggiù… Nessuno me lo vuol mai dire.» Additò le palme sulla sua Croix de Guerre. «Oh, tenente Anderson, di queste dovete dirmi.» Ci fu vino bianco con il pesce e vino rosso con l’arrosto, e un dolce tutto spuma di crema. Charley si ripeteva continuamente che non doveva bere troppo per essere certo di comportarsi educatamente. Il nome della signorina Humphries era Doris. La signora Benton la chiamava così. Aveva passato un anno in un convento di Parigi prima della guerra e lo interrogava sui luoghi dov’era stata, la chiesa della Madeleine e Rumpelmayer e quella pasticceria di fronte alla ComédieFrançaise. Dopo la cena, lei e Charley portaron le loro tazzine di caffè nel vano di una finestra dietro una grossa begonia rosa in un vaso d’ottone e Doris gli chiese se non credeva che New York fosse un orrore. S’era seduta presso il davanzale e lui le stava accanto e guardava, sopra quella spalla candida, per la finestra, giù al movimento nella via sottostante. S’era messo a piovere e i fari delle automobili facevano lunghe strisce increspate sul lastricato nero di Park Avenue. Charley disse come pensava che trovarsi a casa gli avrebbe fatto comunque piacere. Si stava chiedendo se sarebbe stato educato dirle che aveva delle bellissime spalle. Ci si era appunto ormai deciso, quando udì Ollie Taylor raccogliere tutti per andare in qualche ritrovo. «So che è una corvè» stava dicendo «ma, figli miei, dovete ricordare che questa è la mia prima notte a New York e cedere alla mia debolezza.» Si fermarono in crocchio sotto il tendone mentre il portiere chiamava i tassì. Doris Humphries nel suo lungo mantello da sera, orlato di pelliccia in fondo, stava così vicina a Charley che con la spalla gli sfiorava il braccio. Nel fradicio vento sferzante della via si sentiva il suo profumo tiepido misto a quello delle pellicce e dei capelli. Rimasero indietro mentre i più anziani salivano nelle macchine. Per un secondo la mano di lei fu nella sua, minuscola e fresca, mentre l’aiutava a salire. Tese un mezzo dollaro al portiere che aveva mormorato all’autista «da Shanley» con una voce di servitore grave e cauta. Il tassì ronzava scivolando liscio verso il centro frammezzo gli alti
edifici quadrati. Charley aveva un po’ di capogiro. Non osava guardarla nemmeno per un attimo ma fissava fuori dal finestrino visi, macchine, agenti segnalatori, persone con l’impermeabile e i parapioggia che passavano contro le vetrine. «E adesso ditemi come avete guadagnato le palme.» «Oh, i francesi ne facevan distribuzione ogni tanto per tenerci in gamba.» «Quanti unni avete abbattuto?» «Perché parlarne?» Ella pestò il piede sul pavimento della macchina. «Oh, nessuno vuol mai dirmi nulla… Non credo nemmeno che siate mai stati al fronte, nemmeno uno di tutti voi.» Charley si mise a ridere. Aveva la gola un po’ secca. «Ebbene, ci sono stato e dall’altra parte anche, un paio di volte.» D’un tratto ella gli si rivolse. Aveva lampi di luce negli occhi nella penombra del tassì. «Oh vi capisco, tenente Anderson, e credo che voi piloti siate la gente migliore che esista.» «Signorina Humphries, io credo che voi siate un… tesoro. Spero che questa macchina non arrivi mai a quel posto… dovunque andiamo.» Ella piegò la spalla contro la sua per un istante. Charley s’accorse che le teneva la mano. «Dopo tutto, mi chiamo Doris» disse lei con una vocetta infantile. «Doris» fece lui. «E io Charley.» «Charley, vi piace ballare?» gli chiese con la stessa vocettina. «Certo» disse Charley, dandole una rapida premuta alla mano. E quella voce si liquefece come uno zuccherino. «Anche a me… Oh, tanto.» Quando entrarono, l’orchestra suonava Dardanella. Charley posò il cappotto e il berretto nel guardaroba. Le pesanti ciglia brizzolate del primo cameriere s’inchinarono su un candido sparato. Charley andava dietro alla schiena snella di Doris, a quel cavo tra le spalle dove la sua mano si sarebbe posata tanto volentieri, sopra un rosso tappeto, fra i tavolini candidi, i petti inamidati degli uomini, le spalle delle donne, attraverso un frizzante odore di champagne e di crostini al formaggio e fornelli caldi, lungo un angolo del palchetto fra le coppie dondolanti, verso la candida tavola rotonda dove tutti gli altri erano già disposti.
Coltelli e forchette risplendevano tra le pieghe rigide della tovaglia di bucato. La signora Benton si stava sfilavano i guanti di pelle bianca e fissava il viso purpureo di Ollie Taylor che raccontava una storia da ridere. «Balliamo» sussurrò Charley a Doris. «Balliamo tutta la sera.» Charley temeva di ballar troppo stretto e così la tenne un po’ discosto da sé. Doris aveva un suo modo di ballare con gli occhi chiusi. «Perbacco, Doris, siete una ballerina straordinaria.» Quando cessò la musica, tavolini fumo di sigari e persone continuarono a turbinare un poco nelle loro teste. Doris lo stava fissando con la coda degli occhi. «Scommetto che sentite la mancanza delle francesine, Charley. Vi piaceva come ballavano le francesine, Charley?» «Troppo.» Al tavolo bevevano champagne in tazzine da caffè. Ollie se n’era fatto portare dal circolo due bottiglie da un fattorino. Quando la musica riprese, Charley dovette ballare con la signora Benton, e poi con l’altra signora, quella dai diamanti e dal copertone di ricambio intorno alla vita. Con Doris non fecero più che due balli. Charley s’accorgeva che gli altri volevano andarsene perché Ollie cominciava a esser fradicio. Aveva una fiaschetta di whisky nei calzoni e due volte aveva fatto segno a Charley che uscisse a buttar giù un sorso anche lui, nel guardaroba. Charley finse soltanto di bere, ogni volta, perché sperava di avere l’occasione di accompagnare Doris a casa. Una volta fuori, scoprì che lei abitava nello stesso isolato dei Benton; e così costeggiò tutt’intorno il crocchio mentre le signore indossavano i mantelli prima di uscire e recarsi al tassì, ma non ebbe da lei un’occhiata. Fu semplicemente: «Buona notte, caro Ollie, buona notte, tenente Anderson» e il portiere sbatté lo sportello. Non seppe nemmeno quale delle mani che aveva stretto fosse stata la sua. 1. Decorazione militare. (NdT) 2. Varietà di cocktail. (NdT)
Cine-giornale XLV Senza cipria e la parrucca il mio bello non vivrebbe se si volesse cercare una semplice spiegazione della sua carriera, la si troverebbe senza dubbio in quella straordinaria decisione di abbandonare le mollezze di un impiego per le stremanti fatiche del terrazziere. Il giovane che così precocemente aveva tanta intelligenza e forza di volontà non poteva non sollevarsi sul comune livello. Divenne l’intimo amico di banchieri la donna di St. Louis coi diamanti se lo tira al guinzaglio come un cagnolino Stanco di camminare, di andare in bicicletta o in tram, si compera una Ford. AGGRESSIONE A MANO ARMATA IN PIENO GIORNO CHE DISPERDE LA FOLLA E appena la moglie scopre che tutte le Ford si somigliano e che tutti ce l’hanno, cerca di convincerlo a salire nel successivo gruppo sociale, di cui la Dodge è il più cospicuo esempio. SEGUE UNA DISPERATA LOTTA ALLA RIVOLTELLA Il passo successivo viene quando la figlia ritorna dal collegio e la famiglia cambia alloggio. Papà vuole che si faccia economia. Mamma è ansiosa di offrire opportunità ai figli, dei quali l’una desidera prestigio in società e l’altro viaggi, velocità, pronta carriera. UCCISO PRESSO L’ALBERGO MAJESTIC DA TRE BANDITI Tramonta il sole e piango tramonta il sole e piango perché il mio amore è morto simili imprese possono rivelare un pericoloso grado di temerarietà ma illustrano le qualità che fecero di un ragazzo adolescente il capo riconosciuto di una banda che fu una spina nei fianchi dello Stato di
Il piano americano Frederick Winslow Taylor (lo chiamavano Speedy Taylor, nel laboratorio) nacque a Germantown, Pennsylvania, l’anno che venne eletto Buchanan. Suo padre era avvocato, sua madre era figlia di un capitano baleniere di New Bedford; una grande lettrice di Emerson, iscritta alla chiesa unitaria e alla Browning Society. Era un’abolizionista fervente e credeva nelle buone maniere democratiche; in casa sua era una padrona vecchio stampo e teneva il personale in movimento dall’alba al tramonto. Stabilì le regole della condotta: rispetto di sé, fiducia di sé, dominio di sé e una mente sgombra e lucida per le cifre. Ma desiderava che i suoi figli apprezzassero le cose belle e li portò all’estero per tre anni, in Europa, mostrò loro cattedrali, la grand-opera, i frontoni romani, i maestri antichi sotto la loro patina bruna nelle grandi cornici d’oro annerito. In seguito Fred Taylor non poté più soffrire questi anni buttati, e usciva a bella posta dalla camera quando la gente discorreva di cose belle; era un giovanotto caparbio, pieno di burle di cattivo genere, ma una mano d’oro quando si trattava di montare trovate e congegni. Ad Exeter fu capoclasse e capitano della squadra di baseball, il primo che battesse a mano levata (quando gli arbitri si lagnavano che battere a mano levata non era nelle regole del gioco, lui rispondeva che però dava risultati). Da bimbo aveva incubi, andare a letto era per lui uno spavento; pensò che tutto questo nascesse dal fatto che dormiva sulla schiena. Si fece una bardatura di cuoio con cavicchi di legno che gli entravano nella pelle, quando si voltava. Da adulto dormiva in una poltrona o in letto, seduto, appoggiandosi a cuscini. Tutta la vita sofferse d’insonnia. Era un prodigioso tennista. Nel 1881, con il suo amico Clark, vinse il Campionato nazionale di doppio (adoperava una racchetta a foggia di cucchiaio, ch’egli stesso aveva disegnata). In scuola gli venne l’esaurimento per il lavoro eccessivo, gli fecero cilecca gli occhi. Il medico suggerì il lavoro manuale. E così, invece di
andare a Harvard, entrò nel laboratorio di una piccola azienda per la fabbricazione delle pompe, proprietà di un amico di famiglia, per impararvi il mestiere di disegnatore e meccanico. Imparò a maneggiare un tornio e a vestirsi e a imprecare come un operaio. Fred Taylor non assaggiò mai tabacco né liquore, e non bevve mai tè né caffè; non poteva comprendere perché i suoi colleghi meccanici amassero tanto le ribotte e sbronzarsi e fare il diavolo a quattro la sera del sabato. Lui viveva in casa, e quando non leggeva libri di tecnica recitava in spettacoli filodrammatici o si metteva al piano, la sera, e cantava con una buona voce tenorile A Warrior Bold o A Spanish Cavalier. Per un anno fu apprendista senza salario nel laboratorio; i due anni successivi guadagnò un dollaro e mezzo la settimana, l’ultimo anno due dollari. La Pennsylvania si stava arricchendo con il ferro e il carbone. A ventidue anni Fred Taylor andò a cercar lavoro nelle Iron Works di Midvale. Dapprima lo misero a un tavolino, ma egli odiava questo lavoro e si fece dare una pala. Finalmente ottenne che gli affidassero un tornio. Era un buon meccanico, lavorava dieci ore al giorno, e la sera seguiva un corso d’ingegneria allo Stevens. In sei anni avanzò da aiuto meccanico a guarda utensili, a capogruppo, a caporeparto, a meccanico scelto designato alle riparazioni, a capo disegnatore e direttore delle ricerche, a ingegnere capo di tutto il macchinario di Midvale. Nei primi anni che era meccanico con gli altri meccanici del laboratorio, imprecava e scherzava e lavorava con loro, batteva la fiacca quando la battevano loro. Non bisogna dare al padrone di là dalla paga. Ma quando si trovò caporeparto, fu con la direzione dall’altra parte del fosso, raccogliendo per conto di quelli della direzione tutta la grande massa di conoscenze tradizionali che nel passato sono state nel cervello dei lavoratori e nell’abilità e destrezza fisiche del lavoratore. Non poteva stare a vedere un tornio o un uomo oziosi. La produzione gli andò alla testa e fece fremere i suoi nervi insonni, come un liquore o le donne la sera del sabato. Non stava mai con le mani in mano e, che il diavolo lo portasse, nessun altro ci
doveva stare. La produzione gli faceva il prurito sotto la pelle. Perdette ogni amico nel laboratorio; lo chiamarono il negriero. Era un ometto di brusco umore e dalla parola acida. Ero giovane d’anni ma vi do la mia parola che mi sentivo assai più vecchio d’ora, per la preoccupazione e il disgusto e la bassezza di tutta la maledetta faccenda. È una vita orribile quando un uomo non può guardare in faccia nessun operaio senza vederci dell’ostilità e un senso che ciascuno intorno a lui è il suo virtuale nemico. Tale fu il principio del Taylor System of Scientific Management. Egli era insofferente di spiegazioni, non badava a chi strappasse la pelle imponendo le leggi che credeva inerenti al processo industriale. Quando cominciate un esperimento in qualsiasi campo, mettete in dubbio ogni cosa, mettete in dubbio anche le fondamenta su cui l’arte riposa, mettete in dubbio anche i fatti più semplici, più evidenti, più universalmente indiscussi; sperimentate ogni cosa, eccetto i dominanti principi quaccheri di condotta (i capitani di New Bedford erano i più tremendi negrieri della baleneria). Egli si vantava di non pretendere mai nulla da un operaio che quello non potesse fare. Inventò un martello a vapore, perfezionato; standardizzò utensili e corredi, riempì il laboratorio di studenti universitari, forniti di cronometri e diagrammi, traccianti specchietti, classificanti. C’è il modo giusto di fare una cosa e c’è il modo sbagliato; il modo giusto significa incremento della produzione, diminuzione dei costi, rialzo dei salari, aumento dei profitti: il piano americano. Spezzò il lavoro del caporeparto in funzioni separate, gli acceleratori, i sorveglianti, i tempisti della produzione e i distributori. I meccanici scelti eran troppo testardi per lui, gli occorreva un semplice individuo che facesse quanto gli si comandava. Se questi si rivelava un uomo di prima classe, Taylor intendeva dargli una paga di prima classe; e qui cominciò a non più andare d’accordo coi padroni. A trentaquattr’anni si sposò e lasciò Midvale e fece speculazioni in connessione con una carriera aperta nel Maine da certi ammiragli e amici politici di Grover Cleveland; il panico del ‘93 mandò in frantumi l’impresa,
e così Taylor s’inventò l’impiego di ingegnere consulente di direzione e cominciò a mettere insieme una sostanza per mezzo di guardinghi investimenti. La prima comunicazione che lesse davanti all’American Society of Mechanical Engineers fu tutt’altro che un successo; dicevano che era matto. Mi son dovuto rendere conto, scrisse nel 1909, che qualunque perfezionamento non solo è contrastato, ma contrastato aggressivamente e accanitamente dalla maggior parte degli uomini. Lo vennero a cercare dalla Bethlehem Steel. Fu in Bethlehem che fece i suoi famosi esperimenti sui pani di ferro; insegnò a un olandese di nome Schmidt come trasportare quarantasette tonnellate di ghisa al giorno invece di dodici e mezzo, e fece ammettere a Schmidt che alla fine della giornata non si sentiva peggio delle altre volte. Aveva la mania delle pale, ogni lavoro doveva avere una pala del peso e della forma giusti soltanto per quel lavoro; ogni lavoro doveva avere un uomo del peso e della forma giusti soltanto per quel lavoro; ma quando cominciò a pagare i suoi dipendenti in proporzione con l’aumentata efficienza del lavoro prestato, i padroni che erano un sacco di ingordi olandesi dagli occhi piccini cominciarono a fare il diavolo; quando Schwab comperò l’acciaieria nel 1901 Fred Taylor l’inventore dell’efficienza, che aveva raddoppiato la produttività del macchinario accelerando le principali cinghie di trasmissione da novantasei a duecentoventicinque giri al minuto, venne senza cerimonie licenziato. D’allora Fred Taylor disse sempre che non poteva prendersi il lusso di lavorare per vivere. Si mise a giocare a golf (adoperava mazze ch’egli stesso aveva disegnato), escogitò metodi per trapiantare grossi alberi di bosso nel giardino di casa sua. A Boxly in Germantown teneva casa aperta agli ingegneri, direttori di fabbriche, industriali; scriveva comunicazioni,
faceva conferenze ai collegi, apparve davanti a un comitato della Camera, dappertutto predicava la virtù della direzione scientifica e il sistema Barth, l’eliminazione dello spreco e dell’ozio, e la sostituzione dei meccanici scelti col semplice individuo (come Schmidt il portatore dei pani di ferro) che faceva quanto gli si comandava e lavorava a cottimo: la produzione; più rotaie d’acciaio più biciclette più bobine di filo più lastre corazzate per navi da guerra più scaldaletti più filo spinato più aghi più parafulmini più cuscinetti a sfere più dollari; (le antiche famiglie quacchere di Germantown arricchivano, i milionari della Pennsylvania generavano i miliardari per mezzo del ferro e del carbone) la produzione avrebbe arricchito ogni americano di buona qualità che avesse voglia di lavorare a cottimo e non bere o fare il diavolo a quattro o starsene al tornio con la testa nelle nuvole. L’economo Schmidt, il portatore di ghisa, può investire il suo denaro e diventare un padrone come Schwab e tutti gli altri ingordi olandesi dagli occhi piccini e coltivarsi il gusto di Bach e possedere bossi centenari nel suo giardino di Bethlehem o Germantown o Chestnut Hill, e stabilire regole di condotta; il piano americano. Ma Fred Taylor non poté mai vedere il funzionamento del piano americano; nel 1915 entrò nell’ospedale di Filadelfia malato d’esaurimento. Tutta la vita aveva avuto l’abitudine di caricare l’orologio il pomeriggio alle quattro e mezzo; nel pomeriggio del suo cinquantesimo compleanno, quando l’infermiera gli entrò nella camera alle quattro e mezzo per dargli un’occhiata, era là morto con l’orologio in mano.
Cine-giornale XLVI questi sono gli individui per cui gli indisciplinati elementi anarchici di questo paese han lavorato dal giorno della sentenza, e ultimamente si sono accresciuti di molti buoni cittadini disciplinati che gli speciosi argomenti di questi propagandisti hanno traviato Tempi cattivi tempi cattivi piantala in asso Johnny possiamo appena tenerci vivi piantala in asso Johnny BANCHIERI CHE SALUTANO L’ERA DELL’ESPANSIONE LA PROSPERITÀ PER TUTTI ASSICURATA Scoprono che l’amore tedesco per il caviale è un pericolo per la stabilità della moneta. REDUCI CHE CERCANO LAVORO Nessuno pensa nessuno bada a noi che siamo tornati qui tira ciascuno per la sua strada non si ricordano Château-Thierry SENTIAMO MOLTA SIMPATIA PER GLI UTENTI DI MACCHINE PER SCRIVERE IN NEW YORK I DISOCCUPATI TUMULTUANO A UN’AGENZIA Navi che affondano sono quel desso la bella bionda mi ha fatto fesso
Occhio fotografico (43) un nodo alla gola quando il piroscafo dalle rosse ciminiere dibattendo le fiacche ondate ardesia vira vibrando in una lunga verdelucida curva oltre la nave faro la spina si tende al ricordo del brivido dell’Atlantico aperto e il frastaglio delle baracche ad occidente sopra l’invisibile terra e la ragnatela delle giostre e le torri di gomma di Coney e le navi da carico con le ciminiere lontano in poppa e la foschia oltre Sandy Hook e il tanfo degli acquitrini tiepido dolce viscoso ricordi di baie insenature argentee sbarrate da chiudende il pot-pot innanzi giorno del battello a motore su per il torrente alberi obliqui di paranze contro alti pini ritti sulla spiaggia biancoconchiglia il fumo freddomota di un’imbarcazione d’ostriche l’inverno e cigolio di sedie a dondolo nel portico della villa dal cartiglio a voluta e le voci degli zii impassibili storie pronunciate per storto dalla grossa bocca (Missouri che non accettava i quattrini di latta) il pellerossa nell’abito di cuoio di bufalo che vendeva contravveleni nella vampa dell’oratorio fuoco rosso il fumo sulfureo soffocante e l’automobile con pompe e scala che strepita giù per la via in mattoni rossi mentre i pompieri penzolanti con le facce degli zii s’infilano le giacchette di gomma e il crocchiare dei crostini e del caffè con panna inghiottito in furia prima del treno e le mattinate nel caseggiato soffocanti di giornali e il liscio tocco di cipria dei dollari nuovi e lo schianto della mazza di un poliziotto che rompe il cranio a un cittadino e le facce di gente in guardina scancellate dall’inchiostro dei giornali il lamento e lo strido della sega circolare e il mostoso sentore del legname grezzo e vagabondare per i mucchi di rosticci per le erbacce da bruciare per desolate boscaglie le baraccopoli le baraccopoli a che serve aver sepolto quegli anni nell’antico cimitero accanto alla chiesa in rovina quel mattino di primavera quando i viottoli sabbiosi eran rigati di strisce azzurre e l’atmosfera sapeva di violette e aghi di pino
a che serve aver sepolto quegli anni odiati nel puzzo dei cessi a Brocourt sotto le stelle delle granate se oggi faccia disonesta l’ispettore di dogana dalla molle chiacchiera tenace la parola ronzante giocherellando come in un giornale umoristico con le spesse mani facendo scattare il pollice (E così portate a casa libri francesi, eh?) è mio zio
Cine-giornale XLVII giovane che cerca una posizione offriamo… ottimi posti per abili… OCCASIONE DI AVANZAMENTO… giovane che impari… fattorino… commissioniere CERCASI GIOVANOTTO Ditemi quanto debbo aspettare CERCASI in una banca che sceglie i suoi dirigenti tra i gregari, un ragioniere capace e ambizioso… disegnatore edile con esperienza di fabbriche e costruzioni industriali in mattoni, legno e cemento armato… bronzista… letterista… progettista… verniciatore di carri… decoratore di prima qualità… commesso per negozio di maglie, biancheria e gingilli… assistente in reparto… copista di prima classe accuratissimo nelle cifre… energico specialista a fissar matrici in stampi meccanici di pezzi a metallo piazzista… chimico profumiere… custode montacarichi… commesso… assicuratore… assicuratore… fatturista… gioielliere… manovale… meccanico… laminaturista… spedizioniere… spedizioniere… spedizioniere… commesso di calzoleria… pittore di insegne… acquirente spaccio pesci al minuto… insegnante… cronometrista… specialista in utensili e stampi, ricalcatore, capodeposito, traduttore, copista… finestraio… impacchettatore CERCASI Ditemi subito se c’è da fare giovanotto che non abbia paura della fatica giovanotto per ufficio giovanotto per magazzino giovanotto stenografo giovanotto che viaggi giovanotto che impari CERCASI Ditemi quanto
per dirigere gli impianti municipali della luce dell’acqua e del ghiaccio in una ridente, prospera e salubre cittadina sulle alture della Florida… per incaricarsi del reparto Biancheria in un grande emporio all’ingrosso… per assistere in una inchiesta ferroviaria… per sorvegliare circa venti operai impiegati a utensili, matrici, pettini e calibri… come contabile in un magazzino… per leggero lavoro di trasporto… ingegnere civile… collaudatore di macchine e di stampi… perito edile… ingegnere elettrotecnico
Occhio fotografico (44) l’innominato viaggiatore (che aveva appeso al pomo della sella del bianco stallone sferrato un sacco da viaggio pieno e abbandonando le braci morenti nel vallone delle desolate colline siriache dove avevan campeggiato gli Agail quando l’alba splendidotagliente spezzò la notte sul costoloso deserto aveva cavalcato verso i luridi villaggi e gli appezzamenti di sesamo e i giardini di albicocchi) si fece la barba a Damasco e sedette a bere caffè e latte caldo di fronte all’albergo di Beirut fissando il bianco ammasso del Libano rovistando lettere ammonticchiate sul tavolo e ritagli sventolanti di giornali indirizzati non all’ignorante di lingua araba quello che si arrampicava goffamente sul cammello col sedere tanto indolenzito dalla cavalcatura ma a qualcuno che (ma stasera nella tepida atmosfera notturna della costa del Levante i cortesi funzionari preparano ulteriori perfezionamenti a malapena preso un bagno costui si trova a dover recitare una parte provveduto di una cravatta bianca annodata con cura dal viceconsole inzeppato nella camicia inamidata un abito da sera troppo piccolo un paio di pantaloni troppo grandi che la moglie cortese di un cortese funzionario ghignando gli stringe alla schiena con spille di sicurezza che immediatamente cedono quando s’inchina alla signora dell’Alto commissario un difettoso abbigliamento rende impossibile sostenere la parte di eminente esploratore e gli scarpini di vernice che gli stritolano le dita dei piedi vanno smarriti sotto la mensa durante lo champagne e i discorsi) che arrivando a Manhattan trova un’altra volta in attesa l’abito da sera fatto per qualcun altro la posizione offriva la possibilità presentava il bottone del colletto che pungeva nel pomo d’Adamo mentre una figura legnosa gracchia da un tavolo a due file di signori stirati di fresco che indossano
elegantemente i loro vestiti ben tagliati inzeppati di camicie a intestare migliaia anni luce di ritagli sventolanti di giornale Signori chiedo scusa si è sbagliato campanello fu colpa di un equivoco se mi trovavo in scena quando s’è aperto il sipario la poesia che ho recitato in lingua straniera non era mia in verità era qualche altro che parlava non sono io con l’uniforme nella foto è uno spiacevole errore sbaglio d’identità lo stato di servizio si è smarrito il signore nella poltrona girevole che porta il garofano rosso è qualche altro e non chiunque fosse quello che munito di baffi finti stava fuori alla pioggia nella via e riuscì inosservato a battersela giù per un tombino il giovanotto dalla faccia floscia che indossa comprata fatta l’occasione commerciale di qualche altro non è sicuramente il detentore di qualcuna delle posizioni per le quali fece domanda all’agenzia di collocamento
Charley Anderson Il treno arrivava a St. Paul con tre ore di ritardo. Charley aveva infilato il soprabito e chiuso la valigia un’ora prima di giungere. Sedeva irrequieto al suo posto, togliendosi e rimettendosi il paio di guanti di cuoio nuovi. Faceva voti che non si trovassero tutti alla stazione a riceverlo. Forse sarebbe venuto solo Jim. Forse non avevano ricevuto il telegramma. Venne il facchino e lo urtò passando, poi si prese le valigie. Charley non vedeva gran che in mezzo ai vortici di vapore e di neve davanti al finestrino. Il treno rallentò, si fermò in un largo campo di binari spazzati, e riprese la marcia con uno strattone e una serie di sbuffi per lo sforzo del vapore nella caldaia. I respingenti rimbombarono lungo tutto il convoglio. Charley si sentiva le mani agghiacciate sotto i guanti. Il facchino mise dentro il capo e gridò «St. Paul». Non c’era altro che uscire. Eccoli là tutti. Il vecchio Vogel e zia Hartmann con le facce rosse e i lunghi nasi avevano sempre la stessa aria, ma Jim e Hedwig erano tutti e due ingrassati. Hedwig indossava una giacca di martora, e il soprabito di Jim mostrava, accidenti, parecchia prosperità. Jim strappò a Charley le valigie, e Hedwig con zia Hartmann lo baciarono mentre il vecchio Vogel gli picchiava sulla schiena. Parlavano tutti in una volta e gli fecero ogni sorta di domande. Quando chiese di Mamma, Jim s’accigliò e disse che era all’ospedale, sarebbero andati a trovarla nel pomeriggio. Ammucchiarono le valigie in una nuova sedan Ford e si ficcarono dentro dopo che zia Hartmann ebbe ridacchiato e squittito. «Come vedi ho l’agenzia Ford, adesso» disse Jim. «A dir la verità qui le cose sono andate piuttosto bene.» «Aspetta di vedere la casa, è stata tutta rintonacata» disse Hedwig. «Tunque, pampino mio, appiamo fatto scappare il Kaiser. A nome tella comunità tetesco-americana telle Città Cemelle, 1 sono superpa di te.» C’era pronto un grosso pranzo e Jim gli diede un sorso di whisky e il vecchio Vogel continuava a versargli birra dicendo: «E adesso
contaci tutto.» Charley era là seduto con la faccia rossa, rimpinzandosi di pollo stufato e bodino e bevendo birra finché fu per scoppiare. Non gli venne nulla da raccontare, e diceva freddure quando gli facevano domande. Dopo pranzo il vecchio Vogel gli diede uno dei suoi migliori Avana. Quel pomeriggio Charley e Jim andarono all’ospedale a trovar Mamma. Mentre guidava, Jim gli disse che era stata operata di tumore, però lui temeva fosse cancro, ma nemmeno questo aveva dato a Charley un’idea di quanto Mamma fosse giù. Aveva il viso scarno e ingiallito contro il guanciale bianco. Quando si piegò a baciarla, le sentì le labbra assottigliate e scottanti. Le puzzava molto il fiato. «Charley, sono contenta che sei venuto» disse con una voce tremolante. «Sarebbe stato meglio se fossi venuto prima… Non che qui mi manchi nulla… comunque sarò contenta di vedermi intorno i miei ragazzi quando starò bene. Dio ci ha protetti tutti, Charley, non dobbiamo dimenticarlo.» «Su, Mamma, non dobbiamo stancarci e agitarci» disse Jim. «Dobbiamo tenerci in forze per guarire.» «Oh ma Egli è stato tanto misericordioso.» Tirò fuori la manina, tanto sottile ch’era azzurra, da sotto la coperta e si toccò gli occhi con un fazzoletto. «Jim, dammi i miei occhiali, è un bravo ragazzo» disse con una voce più ferma. «Voglio veder bene il figliuol prodigo.» Charley non poté fare a meno di muovere inquieto i piedi mentre lei lo fissava. «Adesso sei ormai un uomo e ti sei fatto un gran nome laggiù. Tutti e due siete riusciti meglio che non sperassi… Charley, avevo paura che tu diventassi un vagabondo come il vecchio.» Risero tutti. Non sapevano che dire. Si tolse gli occhiali e cercò di arrivare a deporli sul tavolino da notte. Gli occhiali le sfuggirono di mano e si infransero sul pavimento di cemento. «Oh… povera… non importa, non li adopero molto qui.» Charley raccattò i frammenti e se li mise con cura nel taschino del panciotto. «Li farò riparare, Mamma.» L’infermiera era sull’uscio e accennava del capo. «Allora, ciao, torniamo domani» dissero. Una volta nel corridoio Charley si sentì scorrere le lacrime per le
guance. «Così stanno le cose,» disse Jim accigliato «la tengono quasi continuamente sotto morfina. Ho pensato che sarebbe stata meglio in una camera a pagamento, ma lo sanno levare il pelo, in questi maledetti ospedali.» «Pagherò la mia parte» disse Charley. «Ho avanzato qualche soldo.» «Be’, mi pare soltanto giusto da parte tua» disse Jim. Charley trasse una profonda boccata nell’aria fredda, mentre si fermavano sui gradini dell’ospedale, ma non riusciva a levarsi dal capo l’odor d’etere, di medicine e di malattia. S’era fatto sereno e tirava un vento gelido. La neve per le vie e sui tetti era d’un vivo rosa sotto il tramonto di fiamma. «Adesso andiamo alla rimessa a vedere un po’» disse Jim. «Ho detto al mio aiutante di telefonare a qualche giornalista. Mi pare che sarebbe tutta pubblicità gratis se venissero in negozio a intervistarti.» Jim gli batté sulla schiena. «Queste storie sul ritorno dell’eroe vanno molto. Dà un po’ di corda a quei ragazzi, eh.» Charley non rispose. «Santo Dio, Jim, non so quel che dirò» fece poi a voce bassa quando risalirono sull’auto. Jim stava premendo il piede sullo starter automatico. «Che ne pensi di metterti con me nel negozio, Charley? Ti posso assicurare che ha dell’avvenire.» «Sei molto gentile, Jim. Fa’ conto che ci penserò sopra.» Quando furono a casa, fecero un giro nella nuova bottega che Jim aveva cavato dall’autorimessa, dove un tempo c’era stata la selleria, dietro la casa del vecchio Vogel. La bottega aveva una grande vetrina a una lastra con la dicitura “Ford” scritta obliquamente in lettere turchine. Dentro c’era un nuovo furgone tutto lustro e fiammante. Poi c’erano un tappeto verde e una scrivania di mogano intarsiato e un telefono che usciva su di un supporto ribaltabile, e in un angolo una palma artificiale dentro un portafiori fantasia. «Riposati un poco le gambe, Charley» disse Jim, additando una poltrona girevole e tirando fuori una scatola di sigari. «Sediamo qui e facciamo quattro chiacchiere.» Charley sedette e si prese un sigaro. Jim rimase in piedi contro il
termosifone coi pollici nelle ascelle del panciotto. «Che te ne pare, birichino, a posto, no?» «A posto, Jim.» Accesero i sigari e mossero un poco i piedi attorno. Jim ricominciò: «Ma non serve più. Bisogna che mi trovi un nuovo locale spazioso, nel centro. Qui una volta c’era movimento. Adesso siamo fuori mano del tutto». Charley fece un grugnito e cacciò uno sbuffo di fumo. Jim passeggiò indietro e avanti, fissando sempre Charley. «Con le tue conoscenze nella Legione e nell’aviazione e in tutti questi posti, staremo da papi. Ogni altro agente di Ford nel distretto ha un nome tedesco.» «Jim, cambia disco. Io non voglio parlare coi giornalisti.» Jim avvampò e s’accigliò e sedette sull’orlo della scrivania. «Ma devi pur fare la tua parte… Per che cosa credi che io ti prenda con me? Non lo faccio mica per i begli occhi del mio caro fratellino.» Charley sorse in piedi. «Jim, io non mi metterò con te. Ho già firmato un contratto per un progetto d’aviazione col mio antico comandante.» «Fra venticinque anni mi potrai parlare di aviazione. Non è ancora una cosa pratica.» «Comunque, abbiamo qualche idea in testa… Rischiamo l’osso del collo.» «Questa è la verità.» Jim si mise in piedi. Le sue labbra eran tese. «Va bene, ma non devi credere di poterti sbattere per casa mia tutto l’inverno solo perché sei un eroe. Se è questo che hai in mente, guarda che sbagli.» Charley scoppiò in una risata. Jim gli si fece accanto e gli posò amichevolmente la mano sulla spalla. «Senti, quei tali saranno qui fra qualche minuto. Fai l’uomo come si deve, mettiti l’uniforme con tutte le decorazioni… Facci questo favore.» Charley fissò per un istante la cenere del suo sigaro. «Se tu facessi a me questo favore? Non sono cinque ore che arrivo e mi sei già addosso come quando lavoravo qui…» Jim perdeva il dominio di sé, cominciava a tremare. «Quanto a questo, sai come regolarti» disse, pronunciando seccamente le parole. Charley si sentì voglia di appioppargliene uno in quella dannata
mandibola. «Se non fosse per Mamma, non avresti da lamentarti neanche di questo» disse con calma. Per un istante Jim non rispose. Gli vennero le rughe sulla fronte. Scosse il capo e apparve preoccupato. «Hai ragione, Charley, è meglio che ti fermi. Se le dà conforto…» Charley gettò il sigaro, ancor mezzo, nella sputacchiera d’ottone, e se ne uscì dalla porta prima che Jim pensasse a fermarlo. Entrò in casa, si prese cappello e soprabito e uscì a fare una lunga camminata entro la nevaia fradicia del crepuscolo. Stavano appunto finendo di cenare, quando Charley rientrò. Gli avevan messo la cena in un piatto, al suo posto. Nessuno parlò tranne il vecchio Vogel. «Appiamo pensato che questi piloti vivessero anche t’aria» disse, e rise asmatico. Nessun altro rise. Jim s’alzò e uscì dalla stanza. Appena trangugiata la cena, Charley disse che aveva sonno e salì a letto. Charley restò mentre novembre trascorreva lento, verso il giorno di Grazie 2 e Natale. Sua madre non dava segni di miglioramento. Ogni pomeriggio andava a vederla per cinque minuti. Lei era sempre lieta. Gli faceva una pena terribile il modo che aveva di parlare intorno alla bontà divina e come presto sarebbe guarita. Cercava di farla parlare di Fargo e della vecchia Lizzie e dei tempi passati nella pensione, ma non pareva ricordarsi troppo, Mamma, di tutto questo, eccetto dei sermoni che aveva sentiti in chiesa. Charley usciva dall’ospedale con un senso di debolezza e d’intontimento. Il resto del tempo lo passava consultando in biblioteca libri sui motori a combustione interna, o attendeva a lavori casuali per Jim nell’autorimessa come aveva fatto da ragazzo. Una sera dopo Capodanno, Charley si recò al ballo degli Alci 3 a Minneapolis con due tali che conosceva. Il grande salone era pieno di rumore e di lanterne di carta. Charley navigava aprendosi un passaggio fra crocchi di gente in attesa del ballo successivo, quando si trovò a guardare in un visino sottile e in due occhi azzurri che conosceva. Era troppo tardi per fingere di non averla veduta. «Ciao, Emiscah» disse, facendo la voce più disinvolta che poté. «Charley… Dio mio.» Per un attimo ebbe paura che gli basisse
dinanzi. «Balliamo» propose. Emiscah gli stava abbandonata nelle braccia. Ballarono un po’ senza dir nulla. Lei aveva troppo belletto sulle guance e a Charley non gustava quel profumo. Finito il giro, sedettero in un angolo e parlarono. Non era ancora maritata. Lavorava in un grande emporio. No, non stava più in casa, stava in un appartamentino con un’amica. Doveva venire a trovarla. Sarebbe stato come ai bei tempi. Doveva darle il suo numero di telefono. Certo, dopo tutte quelle ragazze francesi, la vita doveva sembrargli ben noiosa. E pensare ch’era ufficiale; certo che lui e suo fratello si stavano facendo un posto nel mondo; scommetteva che avrebbero dimenticato le vecchie amicizie. La voce di Emiscah s’era fatta stridula e la sua mano aveva un modo di posarglisi sul ginocchio, che non gli piaceva niente. Appena poté, Charley disse che aveva mal di capo e doveva andare a casa. Non aspettò quei due che l’avevano condotto. La sua serata era comunque bell’e sfumata, pensava. Ritornò tutto solo sulla tranvia interurbana. Faceva un freddo che pelava. Era ben ora che uscisse da quel mortorio. Sentiva davvero un mal di capo che spaccava, accompagnato da brividi. La mattina dopo, ecco che aveva l’influenza e dovette stare a letto. Fu quasi un sollievo. Hedwig gli portò fasci di racconti polizieschi e zia Hartmann gli si agitò intorno e gli serviva toddies e birra calda zuccherata, e tutto quel che ebbe da fare fu di starsene tranquillo a leggere. Prima cosa, quando fu in piedi, andò all’ospedale. Mamma aveva subìto un’altra operazione e non ne era uscita troppo bene. La camera era in penombra e lei non ricordava quando l’avesse visto l’ultima volta. Pareva credesse di essere ancora in casa a Fargo e che lui tornasse allora dal suo viaggio nel Sud. Gli teneva serrata la mano e badava a ripetere: «Il mio figliolo che si era perduto mi è stato reso… Dio, ti ringrazio per il mio figliolo». A Charley questo tagliò le gambe, tanto che dovette sedersi un momento in una poltrona di vimini nel corridoio, quando se ne andò. Gli si fece accanto un’infermiera e restò lì in piedi, tormentando un foglio di carta e una matita. Charley levò gli occhi a guardarla: aveva
le guance rosa e belle ciglia scure. «Non dovete lasciarvi abbattere» gli disse. Charley sorrise con simpatia. «Oh, sto bene… Mi alzo adesso dal letto; ho fatto un po’ d’influenza; lascia fiacchi, però.» «Sento che eravate pilota» disse la ragazza. «Io avevo un fratello nei Royal Flying Corps. Siamo del Canada.» «Bravi compagni quei canadesi» disse Charley. Si chiese se doveva combinare un appuntamento, ma poi si ricordò di Mamma. «Ditemi sul serio quel che ve ne pare, su, vi prego.» «Veramente è contro le regole, ma giudicando dagli altri casi che ho veduto, non ci sono molte speranze.» «Lo pensavo.» Si alzò in piedi. «Siete un fiore, sapete?» Il viso di lei avvampò dal tocco inamidato al colletto candido dell’uniforme. Corrugò la fronte e con una voce tutta fredda disse: «In un caso come questo è meglio accada presto». Charley si sentì salire un nodo alla gola. «Oh, lo so.» «Buon giorno, tenente, ho da fare, adesso.» «Vi ringrazio mille volte» disse Charley. Quando uscì all’aria, aveva sempre in mente quel visino e quelle labbra graziose. Una mattina, che lo sgelo dimoiava – al principio di marzo –, Charley stava togliendo una bronzina bruciata da una Buick, quando l’aiutante venne a dirgli che lo volevano al telefono dall’ospedale. Una voce pacata disse che la signora Anderson peggiorava di minuto in minuto e si rendeva opportuno avvertire la famiglia. Charley si tolse la tuta e venne a cercare Hedwig. Jim era uscito, e così salirono su una macchina della rimessa. Charley s’era dimenticato di lavarsi le mani e le aveva nere di grasso e di carbone. Hedwig gli trovò un cencio da forbirsele. «Un giorno o l’altro, Hedwig,» le disse «mi troverò un impiego decente a un tavolo da disegno.» «C’era Jim che voleva farti suo socio» ritorse scontrosa Hedwig. «Non vedo dove potrai arrivare se continui così a rifiutare tutte le occasioni.» «Be’, può darsi ci siano delle occasioni che non rifiuterò.» «Vorrei sapere con chi le potrai avere se non con noi» disse lei. Charley non rispose. Nessuno dei due disse più nulla nella lunga corsa attraverso la città. Quando giunsero all’ospedale seppero che Mamma era entrata in coma. Due giorni dopo morì.
Al funerale, circa a metà della cerimonia, Charley si sentì salire le lacrime. Uscì allora e si chiuse nel gabinetto dell’autorimessa e sedette sull’asse e pianse come un bambino. Quando ritornarono dal cimitero era d’un umore impossibile e non tollerava che nessuno gli parlasse. Dopo cena, quando trovò Jim e Hedwig seduti al tavolo che calcolavano con carta e matita quanto era loro costato, non si tenne più e gridò che avrebbe pagato fin l’ultimo maledetto centesimo e loro non avrebbero più avuto da rodersi che si fermasse ancora in quella casa dannata. Uscì sbattendosi la porta dietro e corse disopra e si gettò sul letto. Stette là molto tempo in uniforme senza spogliarsi, sbarrando gli occhi al soffitto e udendo voci melliflue ripetere: defunta, trapasso, oltretomba. Il giorno dopo Emiscah telefonò. Disse che le spiaceva tanto della morte di sua madre e se non voleva venire una sera a trovarla. Prima di pensare a quel che faceva, le aveva già detto di sì. Si sentiva angosciato e solo e aveva bisogno di parlare con qualcuno che non fosse Jim o Hedwig. Quella sera andò in macchina a trovarla. Era sola in casa. Non gli piacque quella misera aria di salottino che il suo alloggio aveva. La portò al cinema e lei gli chiese se ricordava quella volta ch’erano andati a vedere insieme la Nascita di una nazione. Charley disse di no, benché se ne ricordasse benissimo. Capiva che lei voleva ricominciare tutto da capo. Mentre tornavano a casa e lui guidava, Emiscah gli posò la testa sulla spalla. Fermata l’auto davanti al portone di lei, Charley abbassò gli occhi e vide che piangeva. «Charley, non vuoi darmi un bacetto come ai bei tempi?» gli sussurrò. Charley la baciò. Quando gli chiese se non saliva, lui balbettò che doveva rientrare presto. Lei si mise a ripetere: «Oh, vieni dunque. Non ti mangerò mica, Charley» e alla fine salirono insieme sebbene fosse quella l’ultima cosa che Charley aveva avuto intenzione di fare. Emiscah scaldò una cioccolata per due sul fornello a gas e gli raccontò quanto lei fosse infelice, stancava talmente stare in piedi tutto il giorno dietro al banco e le donne che venivano a fare acquisti eran così maligne, e i commessi non facevano altro che pizzicarvi e pretendere di mettervi addosso le mani nei salottini di prova. Un
giorno o l’altro avrebbe aperto la chiavetta del gas. A sentirla parlare così Charley stava a disagio e dovette coccolarla un po’ per fermarle le lacrime. E allora si scaldò e finì per farci l’amore. Quando uscì le promise di telefonarle la settimana dopo. L’indomani mattina ricevette una lettera che Emiscah gli doveva aver scritto appena uscito e diceva che non aveva mai amato nessuno tranne lui. Quella sera dopo cena Charley si provò a scriverle che non intendeva di sposar nessuna donna e tanto meno lei; ma non gli venivano le parole giuste e finì per non scrivere affatto. Quando Emiscah gli telefonò il giorno dopo, lui disse di aver molto da fare e che avrebbe dovuto recarsi nel Nord Dakota per occuparsi di certi beni lasciati da sua madre. Non gli piacque affatto il modo in cui lei disse: «Certamente, capisco. Ti telefonerò quando ritorni, caro». Hedwig cominciò a chiedere chi fosse quella donna che gli telefonava di continuo, e Jim disse: «Sta’ attento alle donne, Charley. Se capiscono che hai qualche cosa in tasca, ti si attaccano addosso come sanguisughe». «Cossì è,» disse il vecchio Vogel «non sei più nell’esercito, atesso, ta tire stammi pene, mein Schatz, vado alla guerra: atesso sanno trovare tove stai.» «Non c’è da pigliarsela» borbottò Charley. «Non ci starò molto.» Il giorno che andarono allo studio del notaio per leggere il testamento di Mamma, Jim e Hedwig si vestirono da far colpo. Mise Charley di malumore vederli, Hedwig in un nuovo vestito nero fatto su misura, con un pezzo di merletto alla gola e Jim imbottito come un impresario di pompe funebri nell’abito acquistato per il funerale. Il notaio era un ebreo tedesco piccolotto e di età, coi capelli canuti tirati accuratamente sulla larga pelata del capo, e sul naso sottile aveva un pince-nez cerchiato d’oro. Li stava aspettando quando entrarono nello studio. Si alzò sorridendo con solennità dietro la scrivania ingombra di documenti in buste azzurre e s’inchinò lievemente. Poi sedette fissandoli radioso coi gomiti tra le carte, strofinando insieme leggere le punte delle dita. Nessuno parlò per un istante. Jim tossì dietro la mano come in chiesa. «Vediamo dunque» disse il signor Goldberg con una voce dolcecortese che aveva un lieve accento, come quella d’un attore. «Non dovreste essere di più?»
Jim prese la parola. «Esther e Ruth non potevan venire. Vivono tutte e due sulla costa… Ho la loro procura. Ruth fece firmare la sua anche dal marito, nel caso che vi fossero beni immobili.» Il signor Goldberg fece un leggero schiocco con la lingua. «Peccato. Preferirei fossero tutti qui presenti… Ma è un caso questo che non presenterà difficoltà, sono convinto. Il signor James A. Anderson è nominato esecutore testamentario. Capirete naturalmente che in un caso come questo lo scopo di tutti è di evitare l’omologazione del testamento. Ciò risparmia noie e spese. E non ce n’è alcun bisogno quando uno dei legatari è nominato esecutore… Passerò a leggere il testamento.» Il signor Goldberg evidentemente l’aveva redatto, poiché parve gustarlo assai durante la lettura. Tranne un lascito di mille dollari a Lizzie Green che aveva tirato avanti la pensione di Mamma a Fargo, tutto il patrimonio, immobili e fondi, i terreni a Fargo, le cartelle del prestito della Libertà, e il libretto di millecinquecento dollari, era lasciato indiviso ai figli. L’avrebbe amministrato James A. Anderson, esecutore unico; e nel caso di una spartizione, si sarebbero dovuti metter d’accordo tutti. «E adesso c’è qualche dubbio o proposta?» domandò genialmente il signor Goldberg. Charley non poté fare a meno di notare quanto Jim fosse soddisfatto. «Mi è stato suggerito» continuò il signor Goldberg con una voce piana che si liquefaceva mollemente fra quei documenti come il burro su un panino caldo «che il signor Charley Anderson, che sento partirà presto per l’Est, accetterebbe di firmare una procura simile a quella delle sorelle… Resta inteso che il denaro verrà investito sotto ipoteca nella Anderson Motor Sales Co.» Charley si sentì venir freddo. Jim e Hedwig lo fissavano ansiosi. «Non capisco i termini legali» disse «ma quel che mi occorre è riscuotere la mia parte al più presto… Ho un contratto nell’Est dove voglio mettere qualcosa.» Il sottile labbro inferiore di Jim si mise a tremare. «Non esser stupido a questo punto, Charley. M’intendo d’affari più di te, io.» «Dei tuoi affari, magari, ma non dei miei.» Hedwig che sinora aveva fissato Charley, come volesse strozzarlo,
s’intromise anch’essa: «Via, Charley, devi lasciar fare a Jim quel che gli pare meglio. Lui non cerca altro che di far bene per noi tutti». «Chiudi il becco, tu» disse Charley. Jim balzò in piedi. «Bada a te, birichino, non parlare in questo tono a mia moglie.» «Amici, amici cari» modulò il notaio strofinandosi insieme le dita finché parve dovessero far fumo «non dobbiamo perdere la calma, non dobbiamo, in un’occasione solenne com’è la presente… Quel che ci vuole è una tranquilla chiacchierata accanto al fuoco… l’atmosfera cordiale della famiglia…» Charley cacciò una sbruffante risata. «Ma è sempre stato così in casa mia» disse a mezza voce, e volse loro la schiena per guardar fuori della finestra su tetti candidi e scalette esterne inghiacciolate. La neve, squagliandosi sul tetto d’assi di una baracca a due passi, fumava nel fresco sole meridiano. Al di là, si vedevano appezzamenti nudi sepolti nel nevicaio, e un tratto di sgombra via asfaltata dove le macchine scattavano andando e venendo. «Bada, Charley, deciditi.» Alle sue spalle la voce di Jim prese una cadenza di pianto. «Tu sai la condizione che Ford ha imposto ai suoi negozianti… Per me si tratta di vita o di morte… Ma come investimento è l’occasione di tutta una vita… Le automobili ci sono… Tu non puoi rimetterci, nemmeno se la compagnia chiudesse gli sportelli.» Charley si volse. «Jim» disse benigno «non voglio discutere… Voglio ricevere la mia parte di ciò che Mamma ha lasciato in contanti, quanto più presto tu e il signor Goldberg potrete sbrigare la cosa… Ho qualche idea a proposito di motori d’aeroplano, che farà sembrare una baracca qualunque vecchia agenzia Ford.» «Ma io voglio che il denaro di Mamma sia investito in qualcosa di sicuro. La macchina Ford è il più solido investimento del mondo, nevvero, signor Goldberg?» «Certo che si vedono dappertutto. Ma forse questo giovanotto vuol aspettare e pensarci un poco sopra… Io posso fare i passi preliminari…» «Preliminari un corno. Voglio avere quel che si può, subito. E se
voi non vi decidete, andrò a cercare un altro avvocato che si deciderà.» Charley raccattò il cappello e il soprabito e uscì. L’indomani mattina Charley si presentò a colazione in tuta come al solito. Jim gli disse che non desiderava da lui nessuna prestazione per l’azienda, visto come la pensava. Charley ritornò su per le scale in camera sua e si distese sul letto. Quando entrò Hedwig per far pulizia gli disse: «Oh sei ancor qui?» e uscì sbattendosi la porta dietro. Charley la sentiva sbattere porte e buttare oggetti per casa, mentre con zia Hartmann attendeva alle faccende. Verso la metà della mattina, scese nell’ufficio dove Jim sedeva alla scrivania preoccupato sui suoi registri. «Jim, voglio parlarti.» Jim si tolse gli occhiali e alzò il capo a guardarlo. «Ebbene, che hai in testa?» chiese mangiando le parole in quel suo modo. Charley disse che avrebbe firmato la procura per Jim, se lui gli imprestava subito cinquecento dollari. E magari in seguito, se l’impresa aeronautica andava bene, vi avrebbe fatto entrare anche lui. A sentir ciò, Jim fece un viso arcigno. «Be’, allora» disse Charley. «Facciamo quattrocento. Bisogna che io esca da questo buco.» Jim sorse lento in piedi. Era talmente pallido che Charley lo credette malato. «Insomma, se non ti vuoi mettere in testa quel che io ho in vista… è inutile, e puoi andare all’inferno… Siamo intesi, fra me e te tutto è finito… Hedwig dovrà chiederli alla banca a nome suo… Io ho l’acqua alla gola.» «Veditela tu» disse Charley. «Io bisogna che esca di qui.» Fortuna che il telefono trillò proprio allora, altrimenti Charley e Jim se ne sarebbero misurato qualcuno. Charley staccò il ricevitore. Era Emiscah. Disse ch’era venuta a St. Paul e l’aveva veduto in strada solo ieri e che lui le aveva detto che sarebbe stato fuori proprio soltanto per darle il giro, e che stasera doveva venire da lei altrimenti non sapeva quel che avrebbe fatto, lui non voleva che si uccidesse, vero? Charley si smarrì, per via del litigio con Jim e tutto il resto, e finì col dirle che sarebbe venuto. Nel tempo che terminò la conversazione, Jim era passato in bottega e stava ora chiacchierando con un cliente, tutto sorrisi.
Viaggiando sulla tranvia, decise di contarle che aveva sposato una francesina durante la guerra, ma quando fu salito al suo appartamento non seppe che dirle, tanto affilata e pallida gli apparve. La portò a una sala da ballo. Si sentiva a disagio vedendo quanto si mostrava felice, come se tutto fosse di nuovo accomodato tra di loro. Quando se ne andò, le diede un appuntamento per la settimana ventura. Prima che venisse quel giorno era partito per Chi. 4 Non cominciò a sentirsi veramente tranquillo finché non ebbe attraversato la città e cambiato treno, stavolta per New York. Aveva in tasca una lettera di Joe Askew che gli diceva che Joe sarebbe stato in città per incontrarlo. Aveva quel che restava delle trecento svanziche sputate da Hedwig defalcandone vitto e alloggio per tutto l’inverno a dieci dollari la settimana. Ma sul treno di New York cessò di pensare a tutto questo e ad Emiscah e alla vita dannata di quei mesi e si sbrigliò invece intorno a New York e i motori d’aeroplano e Doris Humphries. Quando si destò la mattina nella cuccetta inferiore, sollevò la tendina e guardò fuori; il treno attraversava le colline della Pennsylvania, i campi eran di fresco arati, qualcuno degli alberi aveva intorno un po’ di verde vaporoso. In un’aia uno stormo di pulcini gialli andava becchettando sotto un pero in fiore. «Giuda» disse a voce alta «ne ho abbastanza di questi paesacci.» 1. Le Città Gemelle: Minneapolis e St. Paul. (NdT) 2. Festa americana, generalmente l’ultimo giovedì di novembre. (NdT) 3. Loggia americana. (NdT) 4. Chicago. (NdT)
Cine-giornale XLVIII davvero la Steel Corporation si aderge materialmente e finanziariamente come un colosso di associazione ora farà furore laggiù nella Georgia quel nuovo pizzicore quel ballo che si chiama Dimènati di più GRANAI IN FIAMME ZINGARO ARRESTATO PER AVER DETTO LA VERITÀ Frustate al cavallo che accelerano le nozze questa forza è da lungo tempo diventata quasi un luogo comune a misura che l’espansione dell’acciaio andava progredendo, eppure le sue proporzioni richiedono a volte di venire nuovamente misurate per esser intese nella giusta prospettiva STORDITI DAL MAINE I DEMOCRATICI CHIEDONO DENARO dimènati di più la donna del mistero tenta di uccidersi in Park Lane dimènati di più OLIVE THOMAS È MORTA DI VELENO UNA LETTERA DICE VIA DA WALL STREET LA TRACCIA DELLE BOMBE ARRIVA A JERSEY dimènati di più Arriva l’autore degli avvisi IL CORPO LEGATO ALLA BICICLETTA SCOPERTA DI UNA MACCHINA INFERNALE
Macinino “Il signor Ford l’automobiliere” scriveva il pubblicista nel 1900, “Il signor Ford l’automobiliere cominciò dando al suo corsiere tre o quattro secchi scossoni con la leva a destra del sedile; mi spiego, spinse seccamente su e giù la leva allo scopo, diceva, di mescolare aria e benzina e cacciare la miscela nella camera di scoppio… Il signor Ford toccò una maniglietta girevole ed ecco seguire un puff, puff, puff… Lo sbuffare della macchina divenne più rumoroso. Essa filava ormai a circa otto miglia all’ora. Le carraie nella strada eran profonde ma la macchina andava certamente molleggiando come in sogno. Nulla dello sbatacchiamento comune anche a un tranvai… A questo punto eravamo giunti sul viale e l’automobiliere, abbassando un attimo una leva, la lasciò scattare. Via. La macchina accelerò con indicibile slancio. E mentre correva, si sentiva dietro uno strepito, il nuovo rumore dell’automobile.” Per vent’anni o più, sin da quando sedicenne aveva lasciato la cascina del padre per cercar lavoro in un laboratorio di macchine a Detroit, Henry Ford aveva avuto il pallino della meccanica. Prima furono orologi, poi disegnò una trattrice a vapore, poi costruì un veicolo senza cavalli con un meccanismo adattato dalla macchina Otto a benzina, di cui aveva letto sul «World of Science», poi una vetturetta meccanica a quattro ruote con un motore da un cilindro, che non poteva però fare marcia indietro; alla fine, nel novantotto, si sentì abbastanza sicuro da rischiare l’abbandono del suo impiego nella Edison Company di Detroit, dove era salito da fuochista notturno a capomacchinista, per spendere tutto il suo tempo lavorando a una nuova macchina a benzina, (poco prima del Novanta aveva conosciuto Edison in una riunione di impiegati elettricisti ad Atlantic City. Si era avvicinato a Edison, dopo che questi aveva pronunciato un discorso, e gli aveva chiesto se credeva che la benzina fosse pratica come combustibile, Edison aveva detto di sì. Se Edison lo diceva, era vero. Edison fu la grande ammirazione della vita di Henry Ford); e guidando la sua vetturetta meccanica, seduto là alla leva
petulantemente vestito in una giubba abbottonata stretto e un colletto alto e la bombetta, avanti e indietro sulle piane e mal selciate vie di Detroit, spaventando, con le secche esplosioni del motore, i cavalloni di birreria e i magri trottatori e quelli solenni dai lucidi fianchi, cercando teste abbastanza bruciate da investir denaro in una fabbrica per automobili. Era il figlio maggiore di un immigrante irlandese che durante la guerra civile aveva sposato la figlia di un prosperoso contadino olandese della Pennsylvania e s’era stabilito a coltivare la terra presso Dearborn nel distretto di Wayne, Michigan; come infiniti altri americani, il giovane Henry crebbe odiando l’interminabile inzuppamento nella mota durante il lavoro, il trasportare e sparpagliare letame, la lucerna a petrolio e lo straccio, la pena e il sudore e la solitudine della campagna. Era un giovanotto sottile, attivo, un buon pattinatore abile di mano; a lui piaceva attendere al macchinario e che gli altri facessero il lavoro pesante. La mamma gli aveva detto di non bere né fumare né giocare né far debiti; e lui mai si permise. Poco dopo i vent’anni, suo padre cercò di farlo tornare da Detroit, dov’egli lavorava da meccanico e riparatore per la Drydock Engine Company che costruiva macchine per battelli a vapore, concedendogli quaranta acri di terra. Il giovane Henry si costruì una moderna residenza bianca e quadrata con un finto tetto a soffitte e si sposò e si stabilì nella campagna, ma lasciò coltivare i braccianti; lui si comperò una sega circolare e affittò una macchina stabile e tagliò il legname dei boschi. Era un giovane risparmiatore che non bevve mai né fumò né giocò né desiderò la moglie del prossimo, ma in una campagna non poteva resisterci. Si trasferì a Detroit e nel granaio in muratura dietro la casa pasticciò per anni nelle sue ore libere alla vetturetta meccanica che doveva esser tanto leggera da correre sulle argillose carrozzabili del
distretto di Wayne, Michigan. Nel 1900 aveva una macchina pratica da lanciare. Giunse a quarant’anni, avanti che la Ford Motor Company venisse fondata e sviluppasse la produzione. La velocità fu la prima cosa di cui i primi fabbricatori d’automobili s’occupassero. Gare di corsa facevano la pubblicità al modello delle vetture. Henry Ford stesso portò via molti primati sulla pista di Grosse Pointe e sul ghiaccio del lago St. Clair. Nella sua 999 corse il miglio in trentanove e quattro quinti. Ma era sempre stata sua abitudine stipendiare gli altri per i lavori pesanti. La velocità di cui s’occupava era la velocità di produzione; i primati, primati di rendimento efficiente. Stipendiò Barney Oldfield, un campione ciclista di Salt Lake City, che corresse per lui. Henry Ford aveva idee intorno ad altre cose che disegnar motori, carburatori, magneti, bielle e attacchi, punzoni e stampi; aveva idee sulle vendite, che i milioni stavano nella produzione economica di quantità, nella circolazione rapida, nel buon mercato dei pezzi standardizzati, commutabili, facilmente rimpiazzabili; non fu che nel 1909, dopo anni di discussioni coi suoi soci, che Ford produsse il primo Modello T. Henry Ford ebbe ragione. Quella volta vendette più di diecimila macinini, dieci anni dopo ne vendeva un milione all’anno. In questi anni il piano Taylor eccitava i direttori e gli industriali per tutto il paese. La parola d’ordine era l’efficienza. La stessa ingegnosità che migliorava il risultato di una macchina poteva migliorare il risultato degli operai che producevano la macchina. Nel 1913 si stabilì a Detroit la produzione a catena. Questa volta i profitti furono qualcosa come venticinque milioni di dollari, ma ci furono difficoltà a trattenere gli uomini sul lavoro, pare che a Detroit i meccanici non ci pigliassero gusto. Henry Ford aveva idee intorno ad altre cose che la produzione. Era il più grande costruttore di automobili del mondo; pagava alti
salari; forse se i solidi lavoratori avessero pensato di ottenere un tanto (un piccolo tanto) sui profitti, sarebbe stato per i disciplinati uno stimolo a perseverare di buona voglia, i lavoratori ben pagati potevano risparmiare abbastanza da comperarsi un macinino; la prima volta che Ford annunciò che i ben sbarbati e decentemente sposati lavoratori americani che cercassero un posto avevano la possibilità di far cinque dollari al giorno (naturalmente venne fuori che c’era qualche condizione; c’era sempre qualche condizione) una tal folla smisurata aspettò davanti all’officina di Highland Park per tutta quella notte sotto zero di gennaio che ci fu un tumulto quando s’aprirono i cancelli; poliziotti ruppero teste, postulanti tirarono mattoni, e la proprietà, la proprietà di Henry Ford, andò distrutta. Le guardie della compagnia dovettero aprire la pompa incendi per respingere la folla. Il piano americano; automovente prosperità che gocciola dall’alto; venne fuori che c’erano condizioni. Ma quei cinque dollari al giorno pagati a buoni, decenti lavoratori americani che non bevevano né fumavano né leggevano né pensavano né commettevano adulterio e le cui mogli non tenevano pensione, fecero ancora una volta dell’America uno Yukon per tutti gli stremati lavoratori del mondo; fecero tutti i macinini e l’era automovente, e di passaggio fecero di Henry Ford l’automobiliere, l’ammiratore di Edison, l’amante degli uccellini, il grande americano del suo tempo. Ma Henry Ford aveva ancora idee oltre la produzione a catena e il tenor di vita dei suoi dipendenti. Era pieno d’idee. Invece di andare in città per far fortuna, ecco un contadinotto che l’aveva fatta trasportando la città nella campagna. I precetti imparati nel Sillabario di McGuffey, i pregiudizi e i preconcetti di sua madre, lui se li era
conservati nuovi e intatti come biglietti fiammanti nella cassaforte di una banca. Voleva che tutti sapessero delle sue idee, per questo comprò il «Dearborn Independent» e iniziò una campagna contro i fumatori. Quando la guerra scoppiò in Europa, aveva idee anche su questo. (La diffidenza per gli eserciti e la vita militare era parte della tradizione rurale del Centro, come l’economia, la perseveranza, la temperanza e la perspicace capacità negli affari.) Qualsiasi meccanico americano con la testa sul collo poteva capire che se gli europei non fossero stati un mucchio d’ignoranti stranieri malpagati che bevevano, fumavano, fornicavano con le donne, prodighi nei loro metodi di produzione, la guerra non sarebbe mai avvenuta. Quando Rosika Schwimmer irruppe oltre la palizzata di segretari e dipendenti che circondava Henry Ford e gli suggerì che lui poteva troncare la guerra, lui disse che sicuro, avrebbero noleggiato una nave e passato l’oceano e sarebbero andati a cavar di trincea quei ragazzi per Natale. Noleggiò un piroscafo, l’Oscar II, e lo riempì di pacifisti e lavoratori sociali, per traversare l’oceano e spiegare ai principotti d’Europa che quant’essi facevano era sciocco e cattivo. Non era colpa sua se il buon senso del povero Riccardo non regge più il mondo e se la maggior parte dei pacifisti erano idioti, rincretiniti dagli articoli. Quando William Jennings Bryan andò a Hoboken per augurargli buon viaggio, qualcuno passò a William Jennings Bryan uno scoiattolo in gabbia; William Jennings Bryan fece un discorso con lo scoiattolo sotto il braccio. Henry Ford lanciava rose American Beauty alla folla. La banda suonava I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier. Cinici burloni liberarono tra la folla altri scoiattoli. Una coppia in fuga venne unita in matrimonio da una squadra di pastori nel salone, e il signor Zero, il filantropo d’asilo notturno, che giunse allo scalo troppo tardi per imbarcarsi, si tuffò nel North River e nuotò dietro al bastimento. L’Oscar II venne descritto come un’università popolare
galleggiante; Henry Ford disse che gli pareva un villaggetto del Centro, ma quando giunsero a Kristiansand, in Norvegia, i giornalisti l’avevan tanto preso in giro che s’era finalmente risentito e messo a letto. Il mondo era troppo ammattito fuori del distretto di Wayne, Michigan. La signora Ford e la direzione mandarono sulle sue tracce un decano episcopalista che lo riportò a casa ben imbacuccato, e i pacifisti dovettero far da soli i loro discorsi. Due anni dopo, la sua compagnia fabbricava munizioni, navi Eagle; Henry Ford progettava carri armati a un sol uomo e sommergibili a un sol uomo come quello sperimentato nella Guerra della Rivoluzione. Annunciò alla stampa che avrebbe destinato i suoi profitti di guerra al governo, ma non risulta che l’abbia fatto mai. Una cosa che riportò dal suo viaggio furono i Protocolli degli Anziani di Sion. Iniziò per illuminare il mondo una campagna sul «Dearborn Independent»; agli ebrei si doveva se il mondo non somigliava al distretto di Wayne, Michigan, ai bei giorni antichi del cavallo e del biroccino; gli ebrei avevano dato il via alla guerra, al bolscevismo, al darwinismo, al marxismo, a Nietzsche, alle sottane corte e al rossetto. Gli ebrei erano il retroscena di Wall Street e dei banchieri internazionali, e della tratta delle bianche e del cinema e della Corte Suprema e della musica sincopata e degli affari illeciti nei liquori. Henry Ford denunciò gli ebrei e si portò senatore e querelò il «Chicago Tribune» per diffamazione, e divenne la favola di tutta la stampa metropolitana prezzolata; ma quando i banchieri metropolitani tentarono di dir la loro sui suoi affari Henry Ford li fece fessi tutti quanti. Nel 1918 aveva preso a prestito su cambiali allo scopo di riscattare gli azionisti di minoranza, per la misera somma di settantacinque milioni di dollari. Nel febbraio 1920, gli occorrevano contanti per soddisfare alcune di queste cambiali che scadevano. Si vuole che andasse a trovarlo un
banchiere e gli offrisse ogni agevolazione se si poteva far membro del consiglio dei direttori il rappresentante delle banche. Henry Ford gli rese il cappello e si mise attorno a raccogliere il denaro a modo suo: spedì fin l’ultima macchina e pezzo che aveva in fabbrica ai venditori e chiese immediato pagamento in contanti. Che i debiti li faccia un altro, era sempre stato un principio fondamentale. Fermò la produzione e cancellò tutte le ordinazioni delle ditte fornitrici. Molti venditori andarono in bolletta, molte ditte fornitrici fallirono, ma quando lui riaprì la fabbrica, ne era il padrone assoluto, a quel modo che uno possiede una cascina senza ipoteche e con le tasse pagate. Nel 1922 cominciò la febbre per Ford presidente (salari alti, carbone bianco, sparpagliamento dell’industria nelle piccole città) che venne abilmente stimolata dietro le quinte da un altro organetto filosofo, Calvin Coolidge; ma nel 1922 Henry Ford vendette un milione trecentotrentaduemiladuecentonove macinini; era l’uomo più ricco del mondo. Belle strade eran subentrate alle strette carraie lasciate nel fango dal Modello T. La grande febbre automovente era in cammino. Da Ford la produzione si perfezionava continuamente; meno spreco, più occhi aperti, più sorveglianti, spauracchi e spie (quindici minuti per il pasto, tre minuti per il gabinetto, dappertutto la sveltezza di Taylor, fatevi sotto, tenete la ranella, girate la vite, ficcate la chiave, fatevisotto tenetelaranella, giratelavite, fatevisottotenetegiratefatevisottotenete, finché l’ultima goccia di vita era succhiata dalla produzione e alla notte gli operai ritornavano a casa, larve smorte tentennanti). Ford era il padrone di ogni particolare del processo, dal minerale nelle colline fino a che l’auto al termine della catena non sgusciava fuori in piena efficienza, gli impianti erano razionalizzati fino all’ultimo decimillesimo di pollice misurato alla scala Johansen; nel 1926 il ciclo di produzione venne ridotto a ottantun ore dal
minerale ancora in miniera all’auto finita e pronta alla vendita in piena efficienza, ma il Modello T era antiquato. La prosperità della Nuova Era e il piano americano (c’era qualche condizione, c’era sempre qualche condizione) avevano ucciso il Macinino. Quella di Ford non era che una delle tante fabbriche d’automobili. Quando il pallone della Borsa scoppiò, il signor Ford l’organetto filosofo dichiarò tutto giubilante, «Ve l’avevo detto. Vi sta bene per il vostro vizio di giocare e far debiti. Il paese è sano». Ma quando il paese in scarpe rotte, calzoni consunti e cinture tirate sulle pance vuote, mani oziose tagliuzzate e screpolate dal gelo di quel gelido giorno di marzo nel 1932, si mise in marcia da Detroit a Dearborn, richiedendo lavoro e il piano americano, tutto quello che seppero escogitare da Ford furono le mitragliatrici. Il paese era sano, ma i marciatori li falciarono. Ne ammazzarono quattro. Henry Ford nella sua vecchiaia è un appassionato antiquario, (vive assediato nel podere di suo padre rinchiuso in una tenuta di migliaia d’acri milionari, protetto da un esercito di servitori, segretari, agenti segreti, guardie agli ordini di un ex pugile inglese, sempre col terrore dei piedi in scarpe rotte per le strade, dei banditi che gli rapiscano i nipotini, che un mattoide gli spari, che la Novità e le braccia in ozio dei disoccupati irrompano per i cancelli e gli alti recinti; protetto da un esercito privato contro la nuova America dei bambini affamati e delle pance vuote e delle suole rotte che scalpicciano facendo la codaviveri, che ha inghiottito le vecchie campagne risparmiatrici
del distretto di Wayne, Michigan, come non fossero mai esistite). Henry Ford nella sua vecchiaia è un appassionato antiquario. Egli ricostruì la cascina di suo padre e la rimise esattamente nello stato in cui la ricordava da bambino. Costruì un villaggio di musei per biroccini, slitte, carrozze, vecchi aratri, ruote idrauliche, modelli antiquati di automobili. Perlustrò tutto il paese in cerca di suonatori che gli eseguissero quadriglie all’antica. Persino vecchie osterie comperò e le rimise nella forma originaria, allo stesso modo che i primitivi laboratori di Thomas Edison. Quando comprò il Wayside Inn presso Sudbury, Massachusetts, il recente stradone dove le macchine nuovo modello rombavano e scivolavano e schizzavano benzina (il nuovo rumore dell’automobile) lo fece spostare dall’entrata, rimise la vecchia e brutta strada al suo posto, cosicché tutto fosse come soleva un tempo, nei giorni dei cavalli e dei biroccini.
Cine-giornale XLIX Fante di quadri fante di quadri tu m’hai rubato l’argento e l’oro EMERGONO FATTI MISTERIOSI DALLE TESTIMONIANZE NELL’INCHIESTA DEL FONDO NERO un filadelfiano picchiato a morte in casa sua gli uomini di cui s’era detto ai lavoratori soltanto un anno prima che combattevano sugli insanguinati campi di Francia la loro stessa battaglia per la democrazia, e che s’era loro chiesto di appoggiare dando l’estremo del loro sforzo alla fatica della produzione – questi uomini ritornavano a insegnar loro la democrazia e con essi vennero i loro strumenti di morte, i fucili automatici, le mitragliatrici, i cannoni che sgombravano in pochi minuti una via di due miglia e gli elmetti che i lavoratori di Gary avevano fatto Sì non abbiam più banane oggi non abbiam più banane GARZONE UCCISO DA UN RIMORCHIO Truppe in sottana ubriache che ballano mentre le case bruciano LA GIOVANE SUICIDA ERA UN’AMICA DI OLIVE THOMAS Si uccide nonostante il folle dolore della moglie CERCA I DATI DELLA CACCIA AI CONTANTI NELL’EST l’attività della ditta consiste in buona parte nel finanziare industriali e commercianti acquistando prove di indebitamento nascente dalla vendita di una gran varietà di prodotti naturalmente commerciabili quali automobili, applicazioni elettriche, macchinario
Charley Anderson «’Gnor Andson, ’Gnor Andson, telegramma per ’Gnor Andson.» Charley tese la mano al telegramma e in piedi nel traballante corridoio lesse le liste di lettere incollate sul foglio: PRESO INFLUENZA TELEGRAFA INDIRIZZO VENGO SETTIMANA VENTURA JOE. «Non ci mancava che questa» si ripeté Charley serpeggiando per aprirsi una strada verso il suo sedile frammezzo a donne che chiudevano valigie, un individuo brizzolato che s’infilava il pastrano, il facchino carico di pesanti porta abiti. «Non ci mancava che questa.» Il treno stava già rallentando sul punto di entrare nella Grand Central. C’era quiete sulla grigia banchina sotterranea quand’egli discese dal chiuso vagone e tolse la valigia al facchino, con un’aria desolata. Camminò su per il pendio, dondolando la pesante valigia. Il treno gli aveva fatto venire il mal di capo. Tanto vasta era la stazione che non pareva affollata, come Charley invece ricordava New York. Per gli spessi vetri dei finestroni ad arco poteva vedere la pioggia che rigava i palazzi di fronte. Errando per la stazione, non sapendo dove andare, si trovò a guardare nella vetrina di una trattoria. Entrò e sedette. La cameriera era una piccola ragazza bruna e arcigna, con anelli di rughe sotto gli occhi. Era una giornata pesante d’umidità; gli odori di sapone della rigovernatura e di grasso caldo della cucina si spargevano immobili nell’aria. Quando la cameriera si piegò a mettergli il coperto, gli giunse un buffo di biancheria sudata e di ascelle e di borotalco. Levò gli occhi a guardarla e si provò a cavarne un sorriso. Quando la ragazza si volse per andargli a prendere della conserva, Charley le osservò il corpo pieno sussultante sotto il vestito nero. C’era qualcosa di opprimente e libidinoso in quella piovosa giornata cittadina. Si cacciò in bocca il brodo a cucchiaiate senza gustarlo. Non aveva ancora finito che si alzò e andò alla cabina telefonica. Non ebbe bisogno di cercare quel numero. Attendendo la risposta, era così nervoso che il sudore gli corse dietro le orecchie. Quando gli rispose una voce femminile, la sua gli si disseccò giù in fondo alla gola. Alla fine mise fuori: «Voglio parlare con la signorina Humphries, per
favore… Parla Charley Anderson… il tenente Anderson». Stava ancora raschiandosi la gola, quando la voce di lei gli giunse con un’intima carezzevole cadenza. Certo che si ricordava di lui, disse quella voce, com’era stato gentile a telefonarle, ma certo, dovevano tenersi compagnia tutti quei giorni, quale sogno, ne sarebbe stata incantata, ma ora andava fuori di città per il weekend, sì, un lungo weekend. Non poteva telefonarle la settimana ventura, no, verso la fine della settimana? Sarebbe stata una gioia per lei rivederlo. Quando tornò al suo tavolino, la cameriera vi si stava affaccendando. «Non vi è piaciuto il brodo?» gli domandò. «Perdiana… Dovevo telefonare.» «Oh, telefonare» fece l’altra con una voce di scherzo. Stavolta era la cameriera che si provava a cavargli un sorriso. «Prenderò un po’ di dolce e una tazza di caffè» disse lui gettando gli occhi sulla lista. «Ci sarebbe un bel dolce di meringa al limone» disse la cameriera con una sorta di sospiro che lo fece ridere. Alzò gli occhi a guardarla, ridendo e tornando a sentirsi pieno di forza e iniziativa. «E va bene, tesoro, vada per la meringa al limone.» Mangiato il dolce, pagò il conto e ritornò nella cabina. C’era stata qualche donna che vi aveva lasciato un forte effluvio di profumo. Chiamò il Century Club per sentire se Ollie Taylor era a New York. Risposero che si trovava in Europa: allora chiamò i Johnson di sua conoscenza; non restavano più che costoro. La voce di Eveline Johnson aveva un basso suono soffocato, al telefono. Quando le disse il nome, lei rise e rispose: «Ma certo, saremo felici di vedervi. Venite a cena stasera; vi presenteremo al nuovo marmocchio». Quando uscì dalla sotterranea in Astor Place, non era ancora l’ora di andare a cena. Domandò al giornalaio da che parte era la Quinta Avenue e passeggiò su e giù fra i tranquilli isolati rossi. Si sentiva intorpidito dal cinema in cui aveva ammazzato il pomeriggio. Quando guardò l’orologio erano soltanto le sei e mezzo. L’invito dei Johnson era per le sette. Già tre volte era passato davanti alla casa, quando decise di salire i gradini. I loro nomi erano scritti a mano: Paul Johnson – Eveline Hutchins, in un cartoncino sopra il campanello. Premè il bottone e restò a tormentarsi la cravatta, aspettando. Nessuno veniva. Si chiese allora se doveva suonar di nuovo, quando Paul
Johnson giunse svelto per la via dalla Quinta Avenue con il cappello gettato sulla nuca e fischiettando mentre camminava. «Oh Anderson, vi saluto, di dove venite?» gli chiese con una voce imbarazzata. Portava parecchi sacchetti di provviste, che dovette ammonticchiarsi sul braccio sinistro, prima di dargli la mano. «Sento che bisogna congratularsi con voi» disse Charley. Paul lo guardò un istante, smemorato; poi arrossì. «Oh sicuro… il figlio nonché erede… Ecco, è un ostaggio in mano al destino, 3 così si dice…» Paul lo introdusse in un vuoto stanzone all’antica, dai drappeggiati tendaggi purpurei alle finestre. «Sedetevi un momento. Vado a vedere che fa Eveline.» Gli indicò un divano di crine, e facendo scorrere i battenti di una porta scomparve nell’altra stanza. Ritornò quasi subito, richiudendosi dietro con cura la porta. «Ma bene. Eveline dice che vi fermate a cena. Dice che arrivate ora da casa. Come vi son parse le cose laggiù? Io non tornerei a casa nemmeno se mi pagassero, ora. Gran bella vita a New York, se uno non cede… Per di qui: vi mostrerò dove potrete ripulirvi… Eveline ha invitato tutta una baraonda di gente a cena. Bisogna che scappi dal macellaio… Volete rinfrescarvi?» La stanza da bagno era vaporosa e sentiva di sali. Qualcuno aveva fatto allora il bagno. Pannolini infantili spenzolavano ad asciugarsi sulla vasca. Una rossa borsa da doccia pendeva dietro la porta e sopra c’era una specie di vestaglia gialla merlettata. Dava a Charley un senso curioso esser là dentro. Quando si fu asciugate le mani le annusò, e il profumo della saponetta gli salì alla testa. Quando uscì da quella porta, trovò la signora Johnson poggiata al marmo bianco del caminetto, con un giallo romanzo francese tra le mani. Indossava un lungo abito di pizzo con maniche a sbuffo e, per leggere, occhiali di tartaruga. Si tolse gli occhiali, li cacciò nel libro e rimase là porgendo la mano. «Sono contenta che siate venuto. Non esco ancora che di rado e non vedo nessuno se non mi vengono a trovare.» «Ben gentile a invitarmi. Vengo dal paesello. Vi dico io che fa piacere veder gente di città… Da un pezzo non vedevo niente che ricordasse tanto Parì.»
Lei rise. Charley si ricordò come rideva sul piroscafo. La voglia che sentiva di baciarla lo rendeva nervoso. Accese una sigaretta. «Vi dispiace non fumare? Non so perché, il fumo del tabacco mi dà nausea da quando ho avuto il bambino, e non permetto a nessuno di fumare. Sono insopportabile, vero?» Charley diventò rosso e gettò la sigaretta nella griglia del camino. Si mise a passeggiare avanti e indietro nell’angusta stanza sotto l’alto soffitto. «Vogliamo sederci?» gli disse lei con quel lento, irritante sorriso. «Che cosa venite a fare a New York?» «Devo trovar lavoro. Ho dei progetti… E dite, come sta il bambino? Mi piacerebbe vederlo.» «Bene, quando si sveglierà, vi presento. Potrete essere un suo zio. Ora ho qualcosa da sbrigare per la cena. Non è strano che siamo tutti qui in New York?» «Son convinto che questa città è un osso duro da rodere.» Eveline entrò nell’altra stanza per la porta scorrevole e tosto cominciò a spandersi un odore di burro che friggeva. Charley si colse sul punto di accendere un’altra sigaretta, poi gironzolò per la stanza, guardando quei mobili vecchi, i tre gigli candidi in un vaso, le scansie di libri francesi, finché Paul, rosso in faccia e sudato, non passò con altri pacchetti e gli disse che avrebbe preparato un bicchierino. Charley sedette sul divano e distese le gambe. C’era una gran quiete sotto l’alto soffitto della stanza. Emanava qualcosa di intimo dal leggero fruscio e acciottolio che i Johnson facevano aggirandosi dietro quei battenti, l’odore francese della cucina. Paul rientrò con un vassoio ingombro di piattini e di bicchieri e un fiasco di vino. Posò una savoiarda sul tavolino di marmo e un piattino di tonno e una forma di cacio. «Mi dispiace che non ho trovato nulla per un cocktail… sono uscito dall’ufficio molto tardi… Non c’è che questo vino italiano.» «Perdiana… Tanto, me ne astengo in questi giorni… Ho la testa piena.» «Siete qui in cerca di lavoro?» «Un tale è con me in un’impresa. Ricordate Joe Askew del piroscafo? Gran tipo, no? Il seccante è che quello stupido si è messo a letto con l’influenza, e questo mi lascia in alto mare finché non viene.»
«Le cose van più fredde che non mi aspettassi, è un fatto… Il mio vecchio mi ha ficcato nell’ufficio di un agente di grani a Jersey City… tanto per tenermi a galla. Ma perbacco, non ho nessuna voglia di scaldare per tutta la vita una scrivania. Non avrei nemmeno accettato, se non fosse per il pargolo.» «Bene bene, noi abbiamo un’idea che vale tant’oro, basta che troviamo i quibus che ci vogliono a impiantarla.» Eveline spalancò i due battenti e portò una bacinella d’insalata. Paul s’era messo a parlare del mercato granario, ma chiuse il becco e lasciò parlar lei. «È curioso» disse Eveline. «Dopo la guerra, New York… Nessuno sa tenersene lontano.» Un esile strillo infantile la seguì dall’altra stanza. «È il suo grido di fame» disse Paul. «Se davvero avete voglia di vederlo» disse Eveline «venite adesso, ma io direi che è troppo scocciante guardare i bambini degli altri.» «Vorrei» disse Charley. «Non ne ho di miei da guardare.» «Così sicuro siete?» gli fece Eveline con un lento sorriso provocante. Charley diventò rosso e rise. Si raccolsero intorno al lettino rosa con i bicchieri in mano. Charley si trovò a guardare in basso una faccia rosea e sdentata e due manucce paffute che abbrancavano l’aria. «Suppongo che debbo dire quanto assomiglia a Papà.» «Tesoruccio somiglia di più al nostro darwiniano progenitore» disse fredda Eveline. «Quando lo vidi la prima volta, ho pianto tanto. Oh, spero ancora che gli nasca il mento.» Charley si colse a sbirciare con la coda dell’occhio il mento di Paul, che neanch’esso era troppo sporgente. «È un allegro bricconcello» disse. Dalla cucinetta accanto al bagno Eveline portò una bottiglia al bambino, poi ritornarono nell’altra stanza. «È un fatto che questo spettacolo mi mette invidia» stava dicendo Charley, quando incontrò lo sguardo di Eveline. Lei si strinse nelle spalle. «Voi due col bambino, tutto ben disposto con una casa e un bicchiere di vino e ogni cosa… Mi fa capire che la guerra è proprio finita… Quel che debbo fare adesso è metter testa a partito e buttarmi a lavorare.» «Non disperarti» disse Paul. «Verrà anche troppo presto la tua ora.»
«Be’, mi pare che potrebbero arrivare. La pentola aspetta» disse Eveline. «Verrà Charles Edward Holden… Sempre in ritardo, lui.» «Ha detto che forse veniva» disse Paul. «Ecco qui Al. È la sua maniera di bussare.» Un individuo smorto e sparuto entrò dalla porta esterna. Paul lo presentò a Charley come il fratello Al. Costui fissò Charley con uno scontroso e indagante occhio grigio, per un momento. «Tenente Anderson… Dite, ma noi ci siamo già visti.» «Siete stato laggiù?» L’uomo sparuto scosse il capo vigorosamente. «No… Dev’essere stato qui a New York… Io non dimentico mai una faccia.» Charley sentì la sua arrossire. Un tale alto e scarno di nome Stevens e una signorinella grassoccia entrarono. Charley non afferrò il nome della ragazza. Aveva i capelli neri e lisci, tagliati. Colui che si chiamava Stevens non badava a nessuno tranne Al Johnson. La signorinella non badava a nessuno tranne Stevens. «Dunque, Al,» disse questi minacciosamente «non vi hanno fatto cambiare un poco idea i recenti avvenimenti?» «Adagio dobbiamo andare, Don, adagio dobbiamo andare… non possiamo oltraggiare ogni umano istinto più lecito… Dobbiamo tenerci accosto alla classe lavoratrice.» «Oh, se avete intenzione di mettervi tutti a parlare della classe lavoratrice, credo faremo meglio a cenare senza aspettare Holden» disse Eveline, levandosi in piedi. «Don sarà troppo bisbetico se discute a stomaco vuoto.» «Chi è costui? Charley Edward Holden?» domandò Al Johnson con un tono di rispetto nella voce. «Non aspettatelo» disse Don Stevens. «Non è altro che uno scandalista borghese.» Charley e Paul aiutarono Eveline a trasportare un’altra tavola che era già imbandita nella camera da letto. Charley riuscì a sedersi accanto ad Eveline. «Caspita, che pranzo coi fiocchi. Mi ricorda tutto la vecchia Parì» badava a dire. «Mio fratello voleva che mi mettessi in un’agenzia Ford con lui, laggiù nelle Città Gemelle. Ma com’è possibile trattenere la gente al paesello quando ha visto Parì?»
«Ma ora la capitale è New York.» Era provocante il modo come lei gli si piegava incontro parlando, il modo come quei lunghi occhi parevano continuamente fargli addosso congetture. «Spero che mi permetterete di venirvi a trovare di tanto in tanto» le disse. «Sarà duro tirare avanti in New York finché non avrò i piedi sul solido.» «Oh, io sono sempre in casa» disse Eveline «e sempre ci starò finché non potremo pagarci una bambinaia fidata per Jeremy. Quel povero Paul metà delle volte deve trattenersi in ufficio… Oh, come vorrei che tutti riuscissero a guadagnare tanti tanti denari al più presto, subito.» Charley fece un truce sorriso. «Date fiato a questi ragazzi. Non ci siamo ancora del tutto levati il kaki di dosso.» Charley non ce la faceva troppo a tener dietro alla conversazione e allora si abbandonò sul divano contemplando Eveline Johnson. Nemmeno Paul parlava troppo. Dopo ch’ebbe portato il caffè scomparve del tutto. Eveline e la signorinella a capotavola parevano tutte e due fare un conto straordinario di Stevens, e Al Johnson che sedeva sul divano accanto a Charley continuamente gli si piegava innanzi per scambiare una battuta con Eveline e agitava il lungo indice. In certi momenti pareva che Al Johnson e Stevens fossero sul punto di menarsene qualcuna. E così, tra che non seguiva il discorso – dopo tutto non era ancora ambientato nella città – e il pasto eccellente e quel vino, Charley cominciò a sentir sonno. Alla fine dovette alzarsi per sgranchirsi le gambe. Nessuno gli badava, e così gironzolando entrò nella cucinetta dove trovò Paul che lavava i piatti. «Su, che vi aiuto» disse. «No, io ho un sistema» disse Paul. «Avrete veduto che Eveline fa tutta la cucina e così è pura giustizia che io lavi i piatti.» «Dite, ma quei tali non avran delle noie a parlar come parlano?» Charley cacciò il pollice in direzione della stanza d’entrata. «Don Stevens è un rosso e comunque è già un uomo segnato.» «Badate, non dico che abbiano torto, ma, cribbio, dobbiamo pur vivere.» «Al scrive sul “World”. Là sono gran liberali.»
«Dalle mie parti un cristiano non può dire quello che pensa senza provocare un vespaio» osservò Charley ridendo. «Lì non sanno che la guerra è finita.» Lavati i piatti ritornarono nella stanza d’entrata. Don Stevens venne alla volta di Charley. «Eveline dice che siete un aviatore» fece con cipiglio. «Diteci quel che pensano gli aviatori. Sono per gli sfruttatori o per la classe lavoratrice?» «Questo sì che è un quesito» disse adagio Charley. «Quasi tutti quelli che conosco io fanno del loro meglio per entrare nella classe lavoratrice.» Suonò il campanello. Eveline alzò gli occhi sorridendo. «Sarà Charles Edward Holden» disse Al. Paul aprì la porta. «Ciao, Dick» esclamò Eveline. «Credevamo tutti che fossi Charles Edward Holden.» «Potrebbe anche darsi» disse un giovanotto distintamente vestito, dagli occhi azzurri alquanto sporgenti, che apparve sulla soglia. «È tutto il giorno che mi sento strano.» Eveline presentò il nuovo arrivato con la sua etichetta militare: «Capitano Savage, tenente Anderson». «Uhm» disse Stevens in fondo alla stanza. Charley notò che Stevens e il giovanotto entrato allora si fissavano senza parlare. Cominciava a diventare un imbarazzo. Eveline e la signorina dai capelli corti si misero a farsi cortesi osservazioni con voce tagliente. Charley indovinò ch’era ormai tempo di levare il disturbo. «Debbo battermela, signora Johnson» disse. «Ehi, Anderson, attendetemi un momento. Scenderò in strada con voi» gli gridò Al Johnson attraverso la stanza. Charley si trovò a un tratto con gli occhi fissi negli occhi di Eveline. «Mi son proprio divertito» disse. «Venite a prendere il tè, qualche giorno» gli disse lei. «Certamente, verrò.» Le strinse la mano, forte. Mentre diceva arrivederci agli altri, sentì il capitano Savage ed Eveline che se la ridevano insieme. «Sono soltanto venuto a vedere come se la passa l’altra metà» diceva quello. «Eveline, sei davvero troppo bella stasera.» Charley si sentì bene, sotto il portico della casa nella sera primaverile. L’aria cittadina aveva un fresco sentore risciacquato dalla pioggia. Si chiedeva se davvero… Be’, non si può mai sapere finché
non si tenta. Al Johnson gli uscì alle spalle e gli prese il braccio. «Dite, Paul mi dice che venite da casa.» «Certo» rispose Charley. «Non mi si vedono i fili di fieno sulle orecchie?» «Accidenti, quando Eveline riceve in una volta la visita di due o più sue antiche fiamme, non si sa più come uscirne… E lei poi che gela il sangue a quella povera ragazza di Don… Dite, che ne pensate di andare insieme a bere un whisky per levarci di bocca il gusto di quel lurido inchiostro rosso?» «Grande idea» disse Charley. Camminarono per la Quinta Avenue e poi per la via finché giunsero a una porticina nera. Al Johnson suonò il campanello e un uomo in maniche di camicia li fece entrare per una strettoia che sapeva di gabinetti. Attraverso questa arrivarono in uno spaccio. «Ecco. Questo sì» disse Al Johnson. «Dopo tutto non ho libera che una sera alla settimana.» «È come ai bei tempi che non furon mai» disse Charley. Sedettero a un tavolino rotondo di fronte al banco, e ordinarono del rye. 1 Al Johnson agitò improvvisamente il lungo indice sopra il tavolino. «Ricordo dov’è che vi ho conosciuto. Nel giorno che han dichiarato la guerra. Eravamo tutti sbronzi come oche al Little Hungary.» Charley disse «già»; quella notte aveva visto tanta gente. «Sicuro, è proprio allora» disse Al Johnson. «Io non dimentico mai una faccia» e gridò al cameriere di portar sopra due boccali di birra. Bevvero parecchi altri ryes a boccali, in forza dei bei tempi. «Ma guarda, New York è proprio un buco come gli altri,» diceva Charley «un villaggio.» «Il villaggio di Greenwich» 2 disse Al Johnson. Bevvero tutta una serie di whisky in forza dei bei tempi trascorsi al Little Hungary. Dopo un po’ non si trovarono più bene al tavolino, e allora vennero in piedi al banco. Qui c’erano due giovanotti smorti e una ragazza grassottella dai capelli fibrosi in un giubbettino bulgaro ricamato. Vecchi amici di Al Johnson. «Un vecchio giornalista» diceva Al Johnson «non dimentica mai le facce… né i nomi.» Si volse a Charley. «Colonnello, vi presento i miei cari amici… Colonnello… uh…» Charley aveva teso la mano e stava per dire Anderson, quando
Al Johnson venne fuori con «Charles Edward Holden, vi presento i miei amici artisti…» A Charley non fu più possibile dire una parola. I due giovanotti partirono a spiegare la commedia cui avevano assistito al Washington Square Players. La ragazza aveva il naso all’insù e occhi azzurri con borse nere sotto. Gli occhi lo guardarono espansivi mentre lei gli dava la mano. «Ma no!… Oh, desideravo tanto conoscervi, signor Holden. Leggo tutti i vostri articoli.» «Ma non sono proprio…» cominciò Charley. «Non proprio colonnello» disse la ragazza. «Colonnello per una notte» intromise Al con un cerchio della mano, e ordinò altri whisky. «Oh, signor Holden,» disse la ragazza, che tracannò il suo come un granatiere «non è straordinario conoscerci in questo modo?… Vi credevo molto più vecchio e non così simpatico. E ora, signor Holden, dovete dirmi ogni cosa.» «Chiamatemi Charley.» «Io mi chiamo Bobbie… chiamatemi Bobbie, volete?» «Perbacco» disse Charley. La ragazza lo tirò un po’ in disparte lungo il banco. «Mi scocciavo terribilmente… Sono cari ragazzi, ma non sanno parlare d’altro che di come Philip ha preso l’iodio perché Edward non lo amava più. Odio le personalità, voi no? Mi piace discorrere, e voi? Oh, come odio la gente che non fa qualcosa! Voglio dire libri e politica mondiale e cose simili, voi no?» «Sicuro» disse Charley. Si trovarono all’estremità del banco. Al Johnson pareva aver scoperto una quantità di altri amici carissimi con cui celebrare i bei tempi. La ragazza tirò la manica a Charley. «Che ne direste di andare in qualche posto tranquillo a discorrere? Non ce la faccio a pensare, qui dentro.» «Conoscete qualche posto dove si possa ballare?» chiese Charley. La ragazza annuì. Nella via gli prese il braccio. Il vento s’era messo al nord, freddo e polveroso. «Andiamo a piedi» disse la ragazza «oppure ne soffre la vostra dignità, signor Holden?» «Chiamatemi Charley.» Camminarono verso l’est giù per una via piena di case d’affitto e di affollate bottegucce italiane. La ragazza suonò a una porta a pianterreno. Mentre attendevano, gli posò la mano sul braccio. «Ho
con me qualche soldo… lasciate pagare a me.» «Ma non posso tollerare.» «Va bene, allora faremo a metà. Io credo nell’uguaglianza dei sessi, voi no?» Charley si piegò e le diede un bacio. «Oh, questa per me è una grande serata… Siete la più simpatica celebrità che abbia mai conosciuto… La maggior parte sono così muffiti, non pare anche a voi? Non hanno joie de vivre.» «Ma» balbettò Charley «io non sono…» Mentre parlava, l’uscio si aperse. «Ciao, Jimmy» disse la ragazza al lucente giovanotto in abito marrone, che aveva aperto. «Vi presento il mio amico… signor Grady… il signor Holden.» Gli occhi del giovane avvamparono. «Non Charles Edward…» La ragazza dimenò il capo eccitata, tanto che un grosso ciuffo di capelli le sventolò sugli occhi. «Oh, signore, sono felice di conoscervi… Sono un vostro costante lettore.» Inchinandosi e arrossendo Jimmy li guidò a un tavolino vicino al palchetto nel soffocante locale, surriscaldato dai riflettori, dal fumo delle sigarette e dal pigia pigia dei ballerini. Ordinarono altro whisky e crostini al formaggio. Poi la ragazza afferrò la mano di Charley e lo trasse in piedi. Ballarono. La ragazza gli si strofinava stretto tanto che Charley poteva sentirne i piccoli seni tondi sotto il giubbetto bulgaro. «Oh Dio… come balla quest’uomo» gli sussurrò. «Dimentichiamo tutto, chi siamo, che giorno è…» «Quanto a me… è da due ore che l’ho dimenticato» disse Charley dandole una strizzata. «Voi siete un semplice contadinotto e io una ragazza scalza.» «C’è in questo più verità che poesia» disse Charley tra i denti. «Poesia… Oh, io l’amo la poesia, voi no?» Ballarono finché non si chiuse. Non stavano più in piedi quando uscirono per le nere vie deserte. Incespicavano nelle pattumiere di latta. Di tra le loro gambe scappavano gatti. Si fermarono a ragionare del libero amore con una guardia. In tutti gli angoli si fermavano e si baciavano. Mentre lei cercava nella borsetta la chiave di casa, disse meditabonda: «Quelli che fanno veramente qualcosa sono anche i più perfetti amanti, non credi?». Charley si svegliò il primo. Il sole inondava la stanza per una finestra senza tendine. La ragazza dormiva, col viso schiacciato nel
guanciale. Teneva la bocca aperta e appariva discretamente più vecchia che non fosse la sera prima. Aveva una pelle flaccida e verde, e i capelli come fibra. Charley si rivestì tutto cheto. Su un grande tavolo dalla polvere spessa un dito, e ingombro di disegni di nudi bizzarri, trovò un pezzo di carboncino. Sul retro di un foglio di carta gialla dov’era scritta una mezza poesia, Charley scrisse. Divertito un mondo… Addio… Auguri. Charley. Non s’infilò le scarpe finché non giunse al fondo della scala cigolante. Fuori in strada, nel freddo e alitante mattino di primavera, si sentì a meraviglia. Non la smetteva di scoppiare in risate. Una gran cara vecchia città. Entrò in una trattoria all’angolo dell’Ottava Avenue e si ordinò una colazione di uova strapazzate col lardo, tartine calde e caffè. Mentre mangiava, se la rideva tutto solo. Poi uscì dal centro verso la Quarantaduesima, sull’aerea. Tetti sudici, lastre alle finestre, sudice lampadine di insegne luminose, scale esterne, cisterne d’acqua, tutto appariva stupendo al ventoso splendore del sole. Alla Grand Central l’orologio segnava le undici e mezzo. Facchini gridavano il nome di treni che partivan per l’Ovest. Ritirò la valigia dal deposito e prese un tassì per recarsi a Chatterton House. Qui Joe Askew gli aveva scritto di scendere, un miglior indirizzo che non l’YMCA. La valigia gli tagliava la mano, tanto pesavano le cianografie e i volumi di disegno meccanico di cui era piena; e così saltò in un tassì. Quando l’impiegato al banco gli chiese qualche referenza, tirò fuori il suo foglio di congedo. Il locale aveva un ascensore e bagni e docce in fondo a corridoi poco illuminati, e una serqua di regolamenti sull’interno della porta della cameretta dove lo condussero. Si buttò sul letto, vestito. Aveva sonno. Stette là, ridendosela e fissando il soffitto. Una gran cara vecchia città. Come poi andò, Charley visse a lungo in quella soffocante stanzetta verde dal rachitico mobilio tipo missione. I primi giorni girò a visitare tutte le ditte aeronautiche che trovò elencate nella guida telefonica, a vedere se gli riusciva di pescare qualche impiego temporaneo. S’imbatté in un paio di individui conosciuti oltremare,
ma nessuno seppe promettergli lavoro; se soltanto si fosse presentato due mesi prima… Tutti dicevano che le cose andavano fiacche. I politicanti avevano in pugno l’aviazione commerciale e tutto si fermava qui, ecco. Comunque, c’erano in giro troppi piloti in cerca di lavoro. Alla fine della prima settimana, tornava da una scappata in un’impresa di motori a Long Island City, dove gli avevano mezzo promesso un posto di disegnatore per l’estate, beninteso se ottenevano il contratto di cui s’occupava il loro agente di Washington, quando trovò una lettera della signora Askew: Joe era grave, polmonite doppia. Ci sarebbe voluto un paio di mesi prima che potesse venire in città. Joe aveva insistito perché scrivesse, sebbene lei non lo trovasse tanto in forze da potersi preoccupare di affari: comunque, l’aveva fatto per levargli quel pensiero. Joe gli mandava a dire di star bene attento che non facesse vedere a nessun altro i suoi progetti, finché non avessero ottenuto il brevetto; meglio era cercarsi un impiego per stare a galla, finché non potessero cominciar la cosa in tutta regola. Stare a galla un corno; Charley sedette sul letto infossato, contando i soldi. Quattro da dieci, un biglietto da due, un dollaro e cinquantatré cents di spiccioli. Con la camera a otto dollari la settimana, le sue prospettive per l’estate non erano poi pazzesche. Alla fine un giorno pescò al telefono Doris Humphries, che lo invitò ad andar da lei l’indomani. In casa Humphries le cose stavano esattamente come in casa Benton, quella notte che c’era andato con Ollie Taylor, eccetto che stavolta c’era una cameriera invece del maggiordomo. Charley si sentì molto a disagio, poiché non si vedevano che donne. La madre di Doris era una signora sparuta e truccata, e gli diede uno sguardo indagatore che Charley si sentì passare da parte a parte fino al portafogli nella tasca dei calzoni. Ci fu tè con tartine, e Charley non era ben sicuro se doveva o no fumare. Dissero che Ollie Taylor era di nuovo all’estero, nel sud della Francia, e siccome Ollie Taylor era il solo argomento che aveva in comune con loro, la conversazione s’incantava qui. Vestito in borghese non era più tanto facile parlare con donne ricche, com’era stato in uniforme. Pure, Doris gli sorrideva graziosamente e parlava, in un
amichevole tono di confidenza, di quanto nauseata lei si sentiva di questo turbine mondano e di tutto, e che sarebbe uscita di casa e si sarebbe impiegata. Non è poi tanto facile, pensò Charley. Doris si lagnò di non incontrare mai uomini interessanti. Disse che Charley e Ollie Taylor – naturalmente che Ollie era un vecchio caro – erano i soli uomini di sua conoscenza con cui sopportasse di parlare. «Credo sia la guerra e il fatto che siete stati oltreoceano, che vi ha dato un qualcosa» disse, levando gli occhi a guardarlo. «Quando si son vedute cose come quelle, non si può più prendersi tanto sul serio come questi poveri fannulloni che mi tocca frequentare. Non sono altro che attaccapanni.» Quando Charley uscì dal grande palazzo, gli girava la testa tanto che traversando la strada fu quasi investito da un tassì. Scese per il grande corso brulicante di traffico nell’imbrunire. Doris aveva promesso di venire al teatro con lui, qualcuna di queste sere. Quando andò a prender Doris per condurla a cena una sera dei primi di maggio, dopo che l’appuntamento venne rinviato di settimana in settimana – era così terribilmente occupata, si lagnava ogni volta al telefono, sarebbe stata una gioia venire ma era così terribilmente occupata – a Charley non restavano nel portafogli che venti svanziche. L’attese un po’, solo, nel salotto di casa Humphries. Fodere bianche eran state infilate sul piano, sulle poltrone e sulle tende, e la gran sala candida sapeva di naftalina. Tutto ciò gli dava un senso d’esser giunto troppo tardi. Doris entrò finalmente con un’aria così pallida e serica e dorata in un vestito da sera scollato, che gli tagliò il respiro. «Come va, Charley? spero non siate morto di fame» disse in quel modo intimo che sempre gli faceva pensare di conoscerla da tanto. «Lo sapete che io non mi accorgo che il tempo passi.» «Perbacco, Doris, siete meravigliosa.» S’accorse che gli guardava l’abito grigio da passeggio. «Oh, scusatemi» disse Doris. «Corro a cambiarmi d’abito.» Qualcosa di gelido le passò nella voce e dileguò subito. «Non ci vorrà più di un minuto.» Charley si sentiva arrossire. «Credo che avrei dovuto mettermi in abito da sera» disse. «Ma ho avuto tanto da fare. Non mi è ancora arrivato il baule dal Minnesota.» «Ma certo. E poi è quasi estate. Non so che cosa mi sia passato in mente. Sempre la testa nelle nuvole.»
«Perché non venite così? state molto bene.» «Ma è buffo a vedersi una donna abbigliata come un cavallo di lusso accanto a un uomo in abito comune. Sarà divertente comunque… meno l’imbarazzo di società, no?… Davvero non starò che cinque minuti d’orologio.» Doris uscì e mezz’ora dopo fece ritorno in un vestito da passeggio grigioperla. Entrò con lei una cameriera che portava un vassoio con uno shaker e i bicchieri. «Ho pensato che potevamo rinfrescarci prima di uscire. Così siamo sicuri di quel che prendiamo» disse. Charley la portò a cena al McAlpin; non sapeva altri posti. Erano già le otto. I biglietti del teatro gli scottavano in tasca, ma Doris non pareva avesse fretta. Erano le nove e mezzo quando la cacciò in un tassì per andare al teatro. La macchina si empì della nuvola folle e leggera del suo profumo e dei suoi capelli. «Doris, lasciatemi dire per un minuto quel che ho bisogno di dire» balbettò a un tratto malcerto. «Non so se vi piaccia troppo qualche altro. Ho idea di no, da quanto mi avete detto su quei tali di vostra conoscenza.» «Oh, vi supplico, dichiarazioni no» gli disse. «Se sapeste come odio le dichiarazioni, specialmente fatte dentro un tassì fermo a un incrocio!» «No, non voglio dir questo. Voi non mi sposereste, del resto, nello stato in cui sono ora… no, di certo. Bisogna prima che mi rimetta in piedi. Ma ci arriverò ben presto… L’aviazione, sapete, è l’industria dell’avvenire… Fra dieci anni… Ebbene, noi piloti abbiamo una probabilità di entrare dal pianterreno… Vorrei che mi deste respiro, Doris, tener lontani gli altri per un po’…» «Aspettarvi dieci anni, mamma mia, quest’è romantica!… la nonna forse, l’avrebbe trovato carino.» «Avrei dovuto saperlo che vi sareste burlata di me. Eccoci arrivati.» Charley tentò di non fare l’aria indispettita mentre le porgeva la mano. Doris gliela strinse, per un secondo appena, piegandovisi sopra. Gli venne il batticuore. Mentre seguivano la maschera nel buio teatro pieno di ballerine e di musica, Doris gli posò la mano lievemente sul braccio. Sulle loro teste passava il lungo fascio
pulverulento del riflettore che andava a spiegarsi in uno scintillio di lustrini dove una ragazza labbra rosse in organdi danzava. Charley si premé contro le costole la mano di Doris. «Così. Mi avete compreso» bisbigliò. «Pensateci… Nessun’altra ragazza mi ha infatuato a questo modo, Doris.» Sedettero ai loro posti. La gente dietro cominciò a zittire, e Charley dovette tacere. Non riuscì a fare nessuna attenzione allo spettacolo. «Charley, non aspettatevi nulla, ma vi dico che siete proprio simpatico» gli fece quando, intontiti dal caldo e dalle luci e dalla folla, salirono in un tassì all’uscita. Si lasciò baciare, ma il tassì giunse al suo portone terribilmente presto. Charley le augurò buona notte presso l’ascensore. Doris scosse il capo con un sorriso quando le chiese se poteva salire anche lui. Camminò verso casa con le ginocchia molli fendendo il trambusto del dopoteatro in Park Avenue e nella Quarantaduesima Strada. Continuava a sentirsi la bocca di lei sulla sua, il profumo dei pallidi capelli ricciuti, la piccolezza di quelle mani sul suo petto quando gli respingeva il viso per scostarlo dal proprio. L’indomani mattina si svegliò tardi con un senso di smarrimento come fosse ubriaco da tre giorni. Comperò i giornali e prese una tazza di caffè e una ciambella in uno spaccio che puzzava di lavatura rancida. Stavolta non cercò nella colonna delle offerte commerciali, ma sotto meccanici e macchinisti. Nel pomeriggio trovò lavoro in un’autorimessa in First Avenue. Gli fece sangue cattivo ritornare alla tuta, all’untume sotto le unghie e picchiare sull’orologio di controllo a quel modo, ma non c’era altra via. Quando ritornò nella sua camera trovò una lettera di Emiscah che gli rimescolò ancor più il sangue. Appena scorsa la lettera, la strappò. Niente da farci, gli seccava abbastanza esser ricascato a smerigliare valvole, per ricominciare ancora quella faccenda. Sedette sul letto, gli occhi pieni di lacrime rabbiose. Era troppo, fottutamente troppo, vedersi tutto chiuso a quel modo, dopo ch’era arrivato alla nomina e al servizio di sanità e alla Escadrille Lafayette e a un meccanico per il suo apparecchio, incaricato dei lavori più sudici. Carogna lurida d’un destino. Quando si fu un po’ calmato si alzò e scrisse a Joe di guarire al più presto,
perdio, che lui aveva rifiutato un’offerta di lavoro da parte della Triangle Motors di Long Island City e per mantenersi a galla lavorava da meccanico e ne aveva fin sopra i capelli e non vedeva l’ora di incamminare quell’impresa. Lavorava già all’autorimessa da due settimane, quando scoperse che il caporeparto organizzava un pokerino tutte le sere di paga, in un locale smesso, dietro il caseggiato. Entrò anche lui e giocò con gran cautela. Le prime due settimane perse mezzo salario, ma poi cominciò a capire di non essere tutto sommato un cattivo giocatore. Non perdeva mai la calma e riusciva discretamente a indovinare in mano a chi fossero le carte. Si guardò bene, anche, dallo strombazzare le sue vincite, e in questo modo se ne andava avendo in tasca più denaro altrui che quelli non supponessero. Il caporeparto era un grosso lestofante dal gran vocione e non fu per nulla soddisfatto di vedere intromettersi nei suoi guadagni Charley; era stata sua costante abitudine portarlo via lui, il denaro, a quei ragazzi. Charley si mise a insaponarlo con un bicchiere di tanto in tanto, e d’altra parte, una volta che si fece la mano, sbrigava più lavoro lui che chiunque altro là dentro. E prima di uscire rimetteva sempre i suoi abiti belli. Non riuscì più a veder Doris prima che lei partisse per York Harbor in villeggiatura. I soli che conosceva erano i Johnson. Li andava a trovare un paio di volte la settimana. Faceva loro delle scansie e una domenica li aiutò a dar la vernice al pavimento della sala. Un’altra domenica telefonò di buon’ora per sentire se i Johnson avevan voglia di scendere a Long Beach per bagnarsi. Paul era a letto col mal di gola, ma Eveline disse che sarebbe venuta. Ebbene, se è questo che vuole, l’avrà, si diceva Charley venendo verso il centro, per la deserta lordura delle vie calde nella mattinata festiva. Eveline gli venne ad aprire in una discinta vestaglia gialla di seta e merletto, che mostrava la radice dei seni morbidi. Senza lasciarle il tempo di parlare, Charley se l’era tirata addosso e baciata. Lei chiuse gli occhi e gli si abbandonò molle fra le braccia. Poi lo respinse e portò il dito alle labbra. Charley arrossì e accese una sigaretta. «Permettete?» chiese con la
voce malferma. «Bisogna bene che torni ad abituarmici una volta o l’altra, immagino» disse piano Eveline. Charley andò alla finestra per rimettersi. Lei lo seguì e gli prese la sigaretta e tirò un paio di boccate. Poi disse forte con la voce pacata: «Ritorniamo a salutare Paul». Paul era disteso appoggiato ai cuscini con un’aria smorta e sudaticcia. Su un tavolino accanto al letto c’era una caffettiera, una tazza a fiorami, un piattello e un boccale di latte caldo. «Ohi, Paul, sembra che facciate la vita di Michelaccio» Charley s’accorse di dire con voce cordiale. «Oh, bisogna viziarli un tantino quando sono malati» tubò Eveline. Charley si sentì ridere un po’ troppo forte. «Speriamo non sia nulla, vecchio.» «Macché, solo questa porca gola. Passatevela bene alla spiaggia, fanciulli. Vorrei poter venire anch’io.» «Magari sarà una cosa insopportabile» disse Eveline. «Ma se non ci andrà, potremo sempre tornare indietro.» «Non abbiate fretta» disse Paul. «Ce n’ho d’avanzo da leggere. Starò come un papa qui.» «Bene, tu e Jeremy farete insieme gli scapoli.» Eveline aveva preso un cestino con qualche sandwich e un termos pieno di cocktail. Camminandole accanto per la strada polverosa e assolata, col cestino e il giornale festivo, Charley pensava che lei aveva un aspetto ben elegante con quel cappellino bianco alla marinara e l’abito estivo color giallino. «Oh, divertiamoci» gli disse. «Da tanto tempo non so più che cosa voglia dire!» Quando scesero dal treno a Long Beach, un grande vento azzurro spirava al largo, velato da fresche nebbioline di vapore. C’era una gran folla sul tavolato della passerella. Tutti e due camminarono a lungo su per la spiaggia. «Non credete che sarebbe bello se andassimo in un punto deserto?» gli diceva Eveline. Camminavano, i piedi affondavano nella sabbia, le voci sparivano nei rimbombi e nei sibili della risacca. «Gran bella cosa» ripeteva Charley. Camminavano sempre. Charley portava sotto gli abiti il costume da bagno; e cominciò a sentirlo caldo e pruriginoso, prima che giungessero a un punto di loro gradimento. Deposero il cestino dietro una duna bassa ed Eveline si spogliò sotto un largo asciugamano che
s’era portata. Charley ebbe un po’ vergogna a togliersi la camicia e i calzoni proprio davanti a lei, ma la cosa pareva permessa. «Dio, avete un corpo magnifico» disse Eveline. Charley stiracchiò imbarazzato l’estremità del suo costume. «Ho una perfetta salute» rispose. Si guardò le mani che sporgevano rosse e macchiate dalla pelle candida degli avambracci un poco lentigginosi sotto la pelurie leggera. «Vorrei sì, trovare un lavoro che non mi sporcasse le mani.» «Le mani di una persona debbono mostrare il suo lavoro… È tutta la bellezza delle mani» disse Eveline. Divincolandosi era entrata nel costume e lasciò cadere l’asciugatoio. Era un costume a un sol pezzo, celeste, molto aderente. «Perdio, come siete ben fatta. È la prima cosa che ho notato di voi sul piroscafo.» Eveline si avvicinò e gli prese il braccio. «Andiamo in acqua» disse. «La risacca mi fa paura, ma è di una bellezza terrificante… Oh, questo sì è divertente, no?» Il braccio di lei toccò serico il suo. Charley ne sentiva la coscia nuda contro la coscia nuda. I loro piedi si toccarono, mentre uscivano dalla molle sabbia scottante sulla fresca sabbia indurita. Un’ampia lingua schiumosa d’acqua spazzò la spiaggia verso di loro e li investì alle gambe, bagnandoli fino alle ginocchia. Eveline abbandonò il braccio e gli prese la mano. Charley non aveva troppa confidenza con la risacca e senz’altro un’ondata lo buttò a gambe all’aria. Si risollevò sbruffando, con la bocca e le orecchie piene d’acqua. Eveline era in piedi, rideva di lui e gli tendeva la mano per aiutarlo a stare in piedi. «Venite al largo» gli gridò. Si tuffarono attraverso l’ondata successiva e nuotarono fuori. Appena fuori del punto dove le ondate si frangevano, si misero in piedi a mezz’acqua ballonzolando su e giù. «Non troppo al largo, c’è pericolo.» «Di che?» «Le correnti» gridò Eveline, accostandogli la bocca all’orecchio. Venne sommerso da un altro cavallone e risalì sputacchiando e boccheggiando. Eveline nuotava sulla schiena con gli occhi chiusi e le labbra imbronciate. Charley in due bracciate le fu accanto e le baciò il volto freddo e bagnato. Cercò di afferrarla alla vita ma un’ondata s’infranse sul loro capo. Eveline lo respinse mentre risalivano sbruffando. «Mi avete fatto perdere la cuffia da bagno. Ecco.» «È là.
Ve la prendo.» Dibattendosi ritornò verso la risacca e abbrancò la cuffia proprio mentre il risucchio stava per tirarla sotto. «Quest’è risacca» urlò. Lo raggiunse Eveline e stette ritta accanto a lui nel basso ribollimento, coi capelli corti bagnati sugli occhi. Li ricacciò indietro con una mano. «Eccoci qui» disse. Charley guardò ai due lati lungo la spiaggia. Non c’era anima viva nel fulgore del primo meriggio. Fece per cingerla col braccio. Eveline sfuggì saltellando alla sua presa. «Charley… non morite di fame?» «Per voi, Eveline.» «Io invece voglio mangiare.» Quand’ebbero finito il pasto e bevuti i cocktail, si sentirono assonnati e un po’ brilli. Giacquero a fianco a fianco nel sole sopra il largo asciugatoio. Eveline gli fece tenere le mani a posto. Charley chiuse gli occhi, ma era troppo eccitato per dormire. Senza volere parlava come un mulino. «Capite, Joe si è occupato del brevetto, lui sa come si trattano i legali e i pezzi grossi che hanno i soldoni. Ho paura che, se mi ci mettessi da solo, qualche tale cercherebbe di rubarmi l’invenzione. È così che succede di solito quando uno inventa qualche cosa.» «Non ve lo dicono mai le donne che siete simpatico, Charley?» «Oltremare non avevo da disturbarmi… Sapete, Aviatèr, Lieutnàn, Cruà de gher, cuscè, uì uì. Andava bene allora, ma in questo caro paese nessuna ragazza che vi piaccia vi guarda in faccia se non siete pieno di soldi… Vi menano per il naso e vi fan mezzo ammattire.» Sentiva di fare una sciocchezza, ma ci si mise e le contò di Doris. «Ma non sono tutte a questo modo» disse Eveline, carezzandogli il dorso della mano. «C’è qualche donna leale.» Non gli lasciò far null’altro che abbracciarsi un po’ con lei sotto l’asciugatoio. Il sole cominciava ad abbassarsi. Si misero in piedi intirizziti e insabbiati, con le scottature che cominciavano a prudere. Mentre camminavano di ritorno lungo la spiaggia, Charley si sentiva scontroso e triste. Eveline parlava della sera e delle ondate e dei gabbiani e gli premeva il braccio appoggiandovisi. Entrarono in una trattoria sulla passerella a mangiare una cenetta, e così gli partirono gli ultimi quattrini.
Non sapeva troppo che dire ritornando a casa sul treno. La lasciò all’angolo della sua via, poi s’incamminò verso l’aerea della Terza Avenue e salì su un treno per la periferia. Le vetture eran piene di giovanotti e di ragazze che ritornavano dalle gite domenicali. Aprì l’occhio se intravvedeva una conquista, ma nulla da fare. Quando salì nella sua soffocante stanzetta verde, non ci poté restare. Tornò a uscire e bighellonò su e giù per la Seconda e la Terza Avenue. Una donna lo abbordò, ma era troppo grassa e vecchia. Trovò una ragazzetta soda e carina e le camminò al fianco per un bel tratto, ma quella minacciò di chiamare una guardia, quando le rivolse la parola, e allora ritornò in camera sua, prese una doccia calda e una fredda, e si buttò nel letto. Ma non chiuse occhio tutta la notte. Eveline gli telefonò tante volte nelle settimane che seguirono e gli lasciò tante commissioni che l’impiegato al banco lo prese in disparte e lo ammonì che quella casa non intendeva ospitare che giovani di irreprensibile vita cristiana. Prese l’abitudine di lasciar presto il lavoro per uscire con lei, e verso la fine di luglio il caporeparto lo buttò fuori. Tanto, ce l’aveva con lui perché continuava a guadagnar troppo a poker. Charley lasciò Chatterton House e prese una stanza ammobiliata nell’est sulla Quindicesima Strada, spiegando alla padrona che sua moglie lavorava fuori città e non poteva venire a trovarlo che di tanto in tanto. La padrona gli chiese altri due dollari d’affitto e la lasciò lì. Finì che non fece più nulla tutto il giorno se non aspettare Eveline e bere un fetido gin che acquistava in una trattoria italiana. Gli dispiaceva per Paul, ma dopo tutto Paul non era un suo particolare amico, e faceva conto che se non lui sarebbe stato un altro. Eveline parlava tanto da fargli girar la testa, ma certo era un tocco elegante e in letto poi straordinaria. Fu solamente quando lei parlò di divorziare da Paul e sposar lui, che Charley cominciò a raffreddarsi. Era una buona compagna trattandosi di pagare le cene e gli spuntini, quando i denari risparmiati lavorando furon finiti, ma non poteva decentemente lasciare che gli pagasse l’affitto. E così un mattino di settembre all’alba tagliò la corda dalla stanza e portò la valigia alla Grand Central. Quello stesso giorno passò da Chatterton House a ritirare la posta e
trovò una lettera di Emiscah. Sedette su una panca del parco dietro la biblioteca pubblica insieme con gli altri scioperati e lesse: Mio caro Charley, so che tu hai sempre avuto un cuore d’oro, e se sapessi come son stata disgraziata faresti qualcosa per aiutarmi. Prima di tutto ho perduto il mio posto e c’è stata una tale crisi qui tutta l’estate che non sono riuscita a trovarne un altro; poi, sono stata malata e il dottore mi è costato cinquanta dollari e da allora non sono più stata quel che si dice bene e così ho dovuto riscuotere il libretto e adesso non ho più un soldo. I miei non ne vogliono sapere perché hanno sentito qualche orribile calunnia sul mio conto, troppo assurda per smentirla. Ma adesso mi occorrono dieci dollari entro la settimana altrimenti la padrona mi sfratta e non so quel che sarà di me. So soltanto di non aver mai fatto nulla da dover soffrire tanto. Come vorrei che tu fossi qui e mi potessi tenere nelle tue grosse braccia muscolose come facevi una volta. Una volta amavi la tua povera Emiscah. In nome della tua povera mamma morta mandami dieci dollari subito per espresso altrimenti è troppo tardi. Qualche volta penso che sarebbe meglio aprire il rubinetto del gas. Mi vengono le lacrime agli occhi e non riesco più a vedere il foglio. In nome di Dio Emiscah Anche la mia amica è al verde. Per te che guadagni i quattrini a palate, dieci dollari non sono nulla e ti prometto che non te ne chiederò altri. Charley, se non puoi dieci, mandane cinque. Charley fece gli occhi torvi e strappò la lettera e se ne mise i pezzi in tasca. Quella lettera gli faceva cattivo sangue, ma a che giovava? Ritornò a passo a passo all’albergo Astor e scese nella sala uomini per lavarsi. Si guardò in uno degli specchi. L’abito grigio aveva ancora un aspetto decente, la paglietta era nuova e la camicia pulita. La cravatta era lisa in un punto, ma con la giacca abbottonata non si vedeva. Tutto bene se non si metteva a piovere; l’altro abito e il cappotto e gli stivali dell’uniforme erano già impegnati. Gli restava ancora un paio di dollari spiccioli, e si fece lucidare le scarpe. Poi salì nella sala di scrittura e scrisse a Joe, che si trovava ormai a terra e per favore gli
mandasse venticinque dollari a volta di corriere e santodio venisse a New York. Impostò e scese nel centro, camminando adagio per Broadway. Il solo posto di sua conoscenza dove scroccare un pasto era dai Johnson e s’infilò in quella via, svoltando dalla Quinta Avenue. Paul venne ad aprirgli e gli tese la mano. «Salute, Charley» disse. «Da secoli non ti vedo.» «Ho traslocato» balbettò Charley, che si sentiva come un verme. «Troppe cimici c’erano in quell’ultimo buco… Ma sentite, passavo soltanto a salutarvi.» «Venite su, vi faccio un cocktail. Eveline ritorna subito.» Charley scuoteva il capo. «No, passavo soltanto a salutarvi. Come sta il piccolo? I miei omaggi a Eveline. Ho un appuntamento.» Andò all’edicola sull’angolo dell’Ottava e comperò i vari giornali. Poi entrò in uno spaccio clandestino di sua conoscenza e interrogò gli avvisi del “Cercasi” tra un bicchiere di birra e l’altro. Beveva adagio e annotava gli indirizzi su un pezzo di carta grattato all’Astor. Uno era l’indirizzo di una rivendita di macchine usate, dove un amico di Jim era direttore. Charley l’aveva conosciuto a St. Paul. Si accesero le luci e oscurarono le finestre nella soffocante sera settembrina. Pagata la birra, non gli restarono che venticinque cents in tasca. «Giuda, è l’ultima volta che mi metto in un pasticcio simile» badava a borbottare gironzolando per le vie del centro. Stette a lungo seduto in Washington Square, meditando quale imbonimento avrebbe fatto al direttore di quella baracca. Cominciò a piovigginare. Ormai le strade eran vuote. Charley si rivoltò in su il colletto e si mise a camminare. Aveva fori nelle scarpe e ad ogni passo sentiva l’acqua fredda schizzargli tra le dita dei piedi. Sotto un lampione si tolse la paglietta e la esaminò. Era già appiccicaticcia, e la tesa appariva gonfia e molle. «E adesso, porco mondo, come faccio a presentarmi per un posto, domani?» Fece dietrofront e andò difilato verso la casa dei Johnson. A ogni istante pioveva più forte. Suonò sotto il cartoncino Paul Johnson – Eveline Hutchins, finché Paul non venne ad aprire in pigiama e cascante dal sonno.
«Sentite, Paul, mi lasciate dormire sul vostro divano?» «È un po’ duretto… Entrate… Non so se abbiamo lenzuola pulite.» «Non fa nulla solo per stanotte… Capite che mi han pelato ai dadi. Domani mi arrivano soldi. Credevo di farcela sulle panche ma questo fottuto d’un tempo si è messo a piovermi addosso. Domani ho da fare e bisogna che mi conservi il vestito, mi spiego?» «Capito… Siete piuttosto bagnato… Vi impresterò un pigiama e un accappatoio. Meglio levarvi questa roba di dosso.» Si stava asciutti e comodi sul divano dei Johnson. Dopo che Paul fu ritornato a letto, Charley giacque nel suo accappatoio fissando il soffitto. Per l’alta finestra si scorgeva la pioggia tremolare davanti ai lampioni nella via, e se ne sentiva l’incessante picchiettio sul lastricato. Il marmocchio si svegliò e pianse, nell’altra camera si accese una luce. Charley sentì le voci assonnate di Paul e di Eveline e il fruscio dei loro passi in giro. Poi il marmocchio si chetò, la luce si spense. Di nuovo tutto fu quiete nel tamburellare della pioggia. S’addormentò. Alzarsi e far colazione con loro non fu un piacere e nemmeno chiedere a Paul venticinque dollari, benché Charley fosse sicuro di poterli restituire dopo un paio di giorni. Se ne andò quando se ne andò Paul per recarsi all’ufficio, e non fece alcuna attenzione agli obliqui sguardi canzonatori di Eveline. Mai più mettersi in un simile pasticcio, badava a ripetersi. Prima cosa andò da un sarto e stette seduto dietro una tenda leggendo l’«American» mentre gli stiravano l’abito. Poi si comperò una nuova paglietta, andò dal parrucchiere, dove si fece radere, tagliare i capelli, massaggiare il viso e ripulire le unghie, e passò da un calzolaio a farsi lucidare e risuolare le scarpe. Finì ch’era quasi mezzogiorno. Uscì dal centro con la sotterranea, e tanto disse che lo assunsero come piazzista in quel negozio d’auto di seconda mano sopra il Columbus Circle, dove il direttore era amico di Jim. Quando costui s’informò di come i parenti di Minneapolis se la passassero, Charley dovette inventare grosso. Quella sera stessa ritirò la sua biancheria dal cinese, disimpegnò la sua roba e riprese una camera, dalla tappezzeria marrone stavolta, a Chatterton House. Si mangiò un’ottima cena e andò a letto presto, stanco morto.
Qualche giorno dopo venne una lettera di Joe Askew con le venticinque svanziche e la notizia che andava ristabilendosi e si sarebbe presto messo a lavorare. Intanto Charley guadagnava qualche poco in percentuali, ma vinceva o perdeva fino a un bigliettone per notte nella Sessantaquattresima Strada a un gioco di poker dove l’aveva portato uno dei piazzisti. C’erano al tavolo specialmente piazzisti d’auto e agenti di pubblicità, gente che spendeva senza riguardo. Charley spedì per posta a Paul i venticinque che gli doveva, e quando Eveline lo cercava al telefono rispondeva sempre ch’era terribilmente occupato e avrebbe telefonato lui al più presto. Basta con quelle storie, poco ma sicuro. Quando faceva vincite, ne metteva la metà in un conto di banca che s’era aperto allora. Portava questo libretto nella tasca interna. Quando se lo vedeva, gli pareva sempre di essere un uomo di giudizio. Si teneva lontano da Eveline. Era una corvè per lui scendere tanto nel centro e comunque non ne aveva bisogno, perché uno di quei piazzisti gli diede il recapito telefonico di un appartamento in una specie di albergo del West Side, dove una certa signora Darling combinava appuntamenti con graziose signorine, purché avvertita a tempo durante la giornata. Costava venticinque svanziche alla volta, ma le ragazze erano pulite e giovani e non c’era seguito di sorta. Il fatto di potersi permettere di buttar giù venticinque svanziche a quel modo dava a Charley un certo senso di sé, ma gli scalzava le vincite del poker. Dopo una seduta con uno dei numeri telefonici della signora Darling, ritornava nella sua stanza a Chatterton House triste e disgustato. Niente da dire su quelle ragazze, ma non era più bello come con Eveline o persino con Emiscah. Gli veniva in mente Doris e diceva a se stesso porco mondo, doveva farsi una donna sua. Cominciò a vendere meno automobili e a giocar più partite via via che le settimane passavano, e proprio quando ricevette un telegramma da Joe Askew come qualmente questi veniva a New York l’indomani, il posto era pressoché perduto. Poteva ben dire che non l’avevano ancora licenziato soltanto perché il direttore era un amico di Jim. Perse la sua vena di fortuna e dovette ritirare tutto il suo denaro dalla banca. Quando si recò alla stazione per incontrare Joe, aveva una
testa che scoppiava e dieci cents in tasca. La notte avanti l’avevano pelato a cane rosso. Joe aveva sempre lo stesso aspetto, soltanto era più magro e portava i baffetti più lunghi. «Ebbè, come va?» Charley prese l’altra valigia di Joe, mentre s’incamminavano per la banchina. «Il mio malanno è la ristrettezza, e faccio acqua da tutte le parti.» «Si vede. Di’, hai l’aria di aver corso la cavallina, Charley. Spero sarai disposto a metterti al lavoro.» «Ma certo. Tutto dipende dalla giusta preparazione… Non sono stato tutte queste notti a scuola serale?» «Si vede.» «E adesso come ti senti, Joe?» «Oh, adesso va bene. Ho mangiato tanta rabbia, da venir matto. Che estate del boia ho passato… E tu che cos’hai fatto, lestofante?» «Io? Ho raccolto informazioni sulla teoria della mano servita. E poi donne… quel che si dice donne. Ehi, come stanno la moglie e i figli?» «Bene… Ti presenterò. Voglio affittare un alloggio qui per l’inverno… Dunque, ragazzo mio, è il caso di dire: sotto. Ci mettiamo con Andy Merritt. Lo conoscerai oggi. Dove trovo una camera?» «Io sto in quella specie di YMCA all’ottava potenza che è nella Trentottesima Strada.» «E va bene.» Quando furono nel tassì, Joe gli batté il ginocchio e si piegò dicendo con un ghigno: «Quando sei pronto a cominciare la lavorazione?». «Domani mattina alle otto. È giusto andato in bolletta il vecchio Bigelow a Long Island City. Ho veduto la baracca. Non costerebbe troppo a rimetterla in ordine.» «Ci andremo quest’oggi. Potrebbe accettare dei titoli.» Charley crollò il capo. «Questi titoli diventeranno preziosi, Joe… dategli contanti, cambiali, quel che volete. Tanto è un mezzo scemo. L’ultima volta che ci sono stato, era per tentare di lavorar da meccanico… Giuda, spero sian finiti quei tempi… Quel che ho bisogno, Joe, è di sposarmi, e per sposarmi come voglio io ci vuol grano… Che tu lo creda o no, io sono innamorato.» «Di tutto il corpo di ballo delle “Follie”, lo credo… Quest’è carina… Charley che vuole sposarsi.» Joe rise da tenersi i fianchi. Poi,
mentre Joe saliva in camera sua a ripulirsi, Charley andò allo spaccio d’angolo e prese un bromo-seltzer. Pranzarono con Merritt, che era un giovanotto smorto dalla mascella quadra, allo Yale Club. Charley, col continuo spasimo del mal di capo, s’accorgeva, nell’intontimento, di non fare molta impressione. Teneva chiuso il becco e lasciava che Joe parlasse. Joe e Merritt parlavano di Washington, del ministero della Guerra, del ministero della Marina e di cifre che mettevano a Charley la velleità di pizzicarsi per sentirsi sveglio. Dopo pranzo Merritt li portò a Long Island City in una PierceArrow da viaggio aperta. Quando poi furono nell’officina, attraverso gli stanzoni ingombri, esaminando torni, motori elettrici, magli e stampatrici, Charley s’accorse di saper meglio di loro come si faceva. Tirò fuori un pezzo di carta e cominciò a prendere appunti. E siccome la cosa pareva far colpo su Merritt, continuò a prendere appunti. Allora anche Joe si mise a prendere appunti. Quando Merritt trasse di tasca un libriccino e cominciò in persona a prendere appunti, Charley capì di aver fatto la cosa che ci voleva. Cenarono con Merritt e passarono con lui la sera. Era navigazione difficile, poiché Merritt apparteneva a quel tipo d’uomini che con un’occhiata misurano un uomo, e cercava di misurare Charley. Mangiarono in un costoso locale clandestino francese e vi rimasero a lungo seduti bevendo cognac con selz. Merritt era grande per scrivere su pezzi di carta elenchi di funzionari e stipendi, e parole come capitalizzazione, deprezzamento, ammortamento, il tutto seguito da cifre enormi con abbondanza di zeri. Il risultato della cosa parve questo: Charley Anderson avrebbe guadagnato duecentocinquanta dollari settimanali (pagabili in titoli privilegiati) a decorrere dal lunedì scorso, come ingegnere capo, e la questione del percento di capitale azionario che sarebbe toccato a lui e a Joe per i loro brevetti si sarebbe decisa a una riunione del consiglio di direzione l’indomani. Charley aveva la testa a passeggio. La lingua gli sentiva un po’ di pasta per via del cognac. Tutto quel che gli venne fatto di dire, e lo disse e ridisse sovente, fu: «Ragazzi, non dobbiamo uscircene sbronzi». Sia lui che Joe, quando ebbero rimandato Merritt con la sua Pierce-
Arrow allo Yale Club, trassero un profondo respiro. «Di’ un po’, Joe, chi è costui? un mago della finanza o un pazzoide? Parla come se i bigliettoni nascessero sugli alberi.» «Li fa nascere sugli alberi. Sul serio, Charley…» Joe Askew gli prese il braccio e la sua voce divenne un bisbiglio, «quell’uomo sarà il Durant dell’aviazione.» «Non credo conosca che differenza passi tra un motore Liberty e il deretano di un caccia.» «Conosce il segretario dell’Interno, cosa ben più importante.» Charley cominciò a ridere e non si fermò più. Per tutta la strada di ritorno continuò a urtarsi nei passanti. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Rideva, rideva. Quando furono a Chatterton House e chiesero al banco la posta, vedendo il lungo muso pallido dell’impiegato, Charley toccò Joe col gomito. «Ebbene, è l’ultima notte che passiamo in questa camera mortuaria.» Il corridoio delle loro camere sapeva di vecchie pantofole e docce e ripostigli. Charley si rimise a ridere. Stette a lungo seduto sul letto ridacchiandosela. «Giuda, a questo modo sì che va; è meglio che a Parì.» Quando Joe uscì per andarsene a letto, Charley cacciò la testa nella porta sempre ridendo. «Fammi la frizione, Joe» gridò. «Ho troppa fortuna.» L’indomani andarono a far colazione al Belmont. Poi Joe fece entrare Charley da Knox, che si comprasse una bombetta, prima di scendere al centro. Charley aveva i capelli un po’ troppo ruvidi per portar bene la bombetta, ma il nastro aveva un costoso odore di cuoio inglese. Charley non smetteva di cavarsela e annusarla, nella sotterranea che li portava al centro. «Di’, Joe, al primo assegno voglio che tu mi porti in società e mi fai mettere la pancia di gesso… A quella ragazza piace che un uomo vesta bene.» «Non avrai il tempo di levarti di dosso la tuta, caro ragazzo,» brontolò Joe Askew «notte e giorno, per sei mesi, finché ci sarò io. Dovremo viverci in quell’officina, se vogliamo che la produzione sia almeno decente, non farti mica idee storte.» «Ma certo, Joe, certo, scherzavo soltanto.» S’incontrarono nello studio di un legale, certo Lilienthal. Dall’istante che dissero i loro nomi all’elegantissima bionda della scrivania, Charley sentì nell’aria l’eccitazione di un contratto. La
bionda sorrise e si piegò al ricevitore. «Ma certo… i signori Anderson e Askew.» Uno scarno fattorino li introdusse nella biblioteca, una lunga stanza semibuia piena di opere legali rilegate in cuoio. Non ebbero il tempo di sedersi che il signor Lilienthal in persona apparve per una porta dal vetro smerigliato. Era un viso ovale scuro, senza collo, dai modi lepidi. «Ecco qua il nostro paio d’assi giunto in tempo.» Presentandogli Joe, quello tenne per un istante la mano di Charley nella palma liscia e grassa della sua manuccia. «Andy Merritt ha cantato sinora il vostro elogio, giovanotto, dice che siete l’impresario dell’avvenire.» «Ed io gli stavo appunto dicendo che l’avrei tenuto chiuso in fabbrica per sei mesi. Capisce i motori al tocco, lui.» «Be’, forse intendeva le vostre imprese» disse il signor Lilienthal, sollevando un sottile sopracciglio nero. Il legale li introdusse in un grande ufficio dall’enorme scrivania di mogano sgombra, nel mezzo, e un azzurro tappeto cinese sul pavimento. Merritt e due altri eran già là. A Charley parvero un cartellone Kuppenheimer, tutti e tre in piedi fra le azzurre spire delle sigarette nei ben tagliati abiti scuri e con la grigia luce splendente che entrava dalla finestra alle loro spalle. George Hollis era un giovane pallido, dalla scriminatura nel mezzo, e l’altro uno sparuto avvocato irlandese faccia fosca, di nome Burke, antico amico di Joe Askew e che avrebbe fatto passare i loro brevetti a Washington, spiegò Joe. Tutti sembravano convinti che Charley fosse un uomo in gamba, ma lui si ripeteva continuamente di tener chiuso il becco e lasciar parlare Joe. Stettero seduti alla scrivania in mogano di quell’ufficio tutta la mattinata e fumarono sigari e sigarette e buttarono una valanga di fogli d’appunti, tanto che la scrivania venne a somigliare al pavimento di una gabbia insudiciata e le Lucky Strike sentivan acido sulla lingua di Charley. Il signor Lilienthal non faceva altro che chiamare la sua stenografa, una ragazzina faccia di topo dagli occhioni grigi, che prendesse appunti, e poi rimandarla. Ogni tanto trillava il telefono e ogni volta lui rispondeva con la voce seccata: «Cara signorina, non vi viene proprio in mente ch’io possa avere una seduta?». L’azienda si sarebbe chiamata la Askew-Merritt Company. Ci furon grandi parole a proposito dello Stato che avrebbero scelto per
associarsi e come si sarebbe venduto il capitale azionario, come sarebbe stato quotato, come sarebbe stato ripartito. Quando finalmente si alzarono per andare a pranzo, erano già le due e a Charley girava la testa. Parecchi di loro passarono al gabinetto andando all’ascensore, e a Charley riuscì di entrare nell’orinatoio accanto a Joe e di bisbigliargli: «Di’ un po’, Joe, siamo noi che li facciamo fessi o loro fanno fessi noi?». Joe non rispose. Tutto quel che fece fu di torcere un viso impassibile e stringersi nelle spalle. 1. Hostages to fortune: in inglese è proverbiale. (NdT) 2. Whisky di segala. (NdT) 3. Greenwich Village è il famoso quartiere di New York che durante e dopo la guerra divenne ritrovo di artisti, spiantati, guitti, bohémiens, che volevano – pare – ripetervi le esperienze di Montmartre. (NdT)
Cine-giornale L No la colpa non è della mia Broadway con poche eccezioni il potere del nostro governo è stato ed è in mani oneste competenti, che le finanze sono sane e ben amministrate, e che gli interessi commerciali della nazione, inclusi i proprietari, i direttori e i dipendenti, rappresentano onorevoli e patriottici motivi e che l’attuale condizione economica garantisce una continuazione di fiducia e prosperità Quando la colpa è tua non maledire questa vecchia Broadway LA GRANDE GIURIA INTERROGHERÀ I GIOCATORI SISTEMA PERFEZIONATO DI LUBRIFICAZIONE CHE GARANTISCE UN EFFETTIVO E COSTANTE AFFLUSSO SULL’INTERA SUPERFICIE DI RESISTENZA Mi sta una pena giù giù in fondo al cuore per quei compagni che si son perduti la Dooling Shipbuilding Corporation non ha pagato né accettato di pagare né pagherà direttamente o indirettamente nessun regalo di nessun genere o colore a impiegati o rappresentanti della U.S. Shipping Board, alla Emergency Fleet Corporation o a qualunque altra agenzia governativa IL CADAVERE DI UN RICCONE SEPOLTO IN CANTINA Non posso scordare quel caro quartetto che cantava Sweet Adeline addio per sempre compagni e compagne addio per sempre amore NUOVI MODELLI DI CAMBIO CHE PRESENTANO NON SOLO MAGGIOR RESISTENZA E DURATA MA ACCRESCIUTA SCORREVOLEZZA NUOVA FRIZIONE – UNA CONQUISTA DELLA MECCANICA CHE AGGIUNGE PRODIGIOSA EFFICACIA ALLA TRASMISSIONE CHE RENDE IL CAMBIO DI VELOCITÀ FACILE E SILENZIOSO
NUOVE E PIÙ GROSSE LAMPADINE A GRIGLIA CHE DANNO LA PIÙ PERFETTA ILLUMINAZIONE MAI OTTENUTA PER LE AUTOMOBILI GARY CHIAMA RESPONSABILE DELLA GIORNATA DI OTTO ORE IL ROMANTICISMO DEL PUBBLICO i prezzi ottenuti per i prodotti d’imballaggio erano il risultato delle pure leggi economiche. Le cifre ufficiali provano che se i prezzi del grano debbono rispondere alla legge di domanda e offerta LA PRODUZIONE DELLA GHISA NETTAMENTE ABBASSATA Se ceni con la bella c’è pur sempre un lampione che avverte del pericolo e canta la canzone no la colpa non è della mia Broadway
L’amaro calice Veblen, faccia smorta, goffo, abbandonato sdegnosamente sulla scrivania con la gota sulla mano, con un sommesso sarcastico borbottio di frasi intricate, sottilmente filando il logico inevitabile canapo delle cose reali, perché una società vi si impicchi, sezionando il secolo con uno scalpello tanto penetrante, tanto ironico, tanto esatto che professori e studenti nove volte su dieci non se ne accorgevano, e i magnati e i rispettati palloni gonfi e gli applauditi vociferatori non se ne accorsero mai. Veblen faceva troppe domande, soffriva di un’incapacità costituzionale a dir di sì. Socrate faceva domande e tracannò l’amaro calice una notte quando cantò il primo gallo, ma Veblen lo trangugiò a piccoli sorsi per tutta una lunga esistenza nella mefite delle aule scolastiche, nella polvere delle biblioteche, nell’odor rancido degli appartamenti economici quali può permettersi un insegnante povero. Combatté il pantano fino in fondo, la pedanteria, l’andazzo, gli opportunisti seduti alle scrivanie, gli amministratori, i rettori, i lacchè grassottelli dei bottegai dominanti, tutti i posti migliori affidati a coloro che dicevano di sì, mai denaro a sufficienza, ogni speranza di respiro contrastata. Veblen trangugiò l’amaro calice fino in fondo. I Veblen erano una famiglia di contadini proprietari. Quei proprietari delle anguste vallate norvegesi erano una razza caparbia e indefessa, contadini, lattivendoli, pescatori, radicati nei campi sassosi dei padri, nelle loro antiche fattorie di travi con le facciate intagliate, da cui prendevano i nomi, nei pascoli montani dove pascevano il gregge durante l’estate. Al principio del diciannovesimo secolo le città crebbero; la Norvegia si empì di gente senza terra, di negozianti, sceriffi, usurai, uscieri, notai in nero con colletti rigidi e borse piene di sentenze sotto
il braccio. Si formavano le industrie. I cittadini cominciarono a cavar profitti dalle campagne e strozzare i contadini nelle libertà dei loro angusti poderi. I deboli di fegato chinarono il capo e furono affittavoli, braccianti; ma i forti se ne andarono dal paese come i loro padri se ne erano andati secoli prima quando Harald il Biondo e sant’Olaf frantumarono le franchigie degli uomini del Nord, che erano stati ciascuno un signore sul suo ruscello, per farne dei cristiani e degli schiavi; solamente, nei tempi antichi gli uomini del Nord avevan fatto vela verso l’Islanda, la Groenlandia, la Vinelandia, adesso andavano in America. Tanto i genitori del padre di Thorstein Veblen quanto quelli della madre avevano perduto le loro fattorie e con esse i nomi che li designavano gente libera. Thomas Anderson per un po’ cercò di vivere facendo il falegname e lo stipettaio ambulante, ma nel 1847 lui e la moglie, Kari Thorsteinsdatter, partirono da Brema in una baleniera e andarono a raggiungere gli amici nelle colonie scandinave intorno a Milwaukee. L’anno dopo lo raggiunse suo fratello Haldor. Erano indefessi lavoratori; in un anno avevano risparmiato abbastanza da assicurarsi la concessione di 160 acri di terreno incolto nel distretto di Sheboygan, Wisconsin; quando ebbero dissodato quella porzione di terra, la vendettero e si trasferirono in una colonia tutta di norvegesi nel distretto di Manitowoc, presso Cato in un punto chiamato Valders dal nome della valle da cui tutti erano usciti; là, nella casa che Thomas Anderson costruì coi suoi arnesi, il sesto di dodici figli, Thorstein Veblen, venne al mondo. Quando Thorstein ebbe otto anni, Thomas Anderson si trasferì di nuovo ad occidente nelle terre nere delle praterie del Minnesota, donde i Sioux e i bufali erano stati cacciati da pochi anni. Nell’atto di acquisto della nuova terra Thomas Anderson riprese l’antico nome libero di Veblen. Era un solido agricoltore e costruttore, un capace falegname, il primo a importare pecore merino e una macchina per mietere e legare
i covoni; era un uomo d’importanza nel gruppo di quei norvegesi che coltivavano l’orlo della prateria, mantenevano i loro dialetti, i modi di vita delle anguste vallate della patria, i loro pastori luterani, gli abiti, il formaggio e il pane fatti in casa, la loro diffidenza e la caparbia antipatia verso i modi della gente di città. Quelli di città erano in maggioranza yankees, abili a far crescere due dollari dove prima ne cresceva uno solo, negozianti, sensali, speculatori, usurai, con teste fine per la politica e per le ipoteche; e disprezzavano i contadinacci scandinavi sui quali vivevano, le figlie dei quali lavavano i piatti alle loro mogli. I norvegesi credevano, come i loro padri avevano creduto, che non ci siano che due occupazioni per un uomo onesto, o la terra o il pulpito. Thorstein crebbe un giovanottone con fama di pigrizia e bello spirito. Odiava il fastidio delle eterne faccende rurali fatte per rompere la schiena. Quando leggeva era beato. Lavorar da falegname gli piaceva, oppure manovrare le macchine agricole. I pastori luterani che venivano in casa s’accorsero che la sua mente agile girava facilmente gli angoli della loro teologia. Era difficile cavarne lavoro di campagna, aveva una lingua che levava il pezzo e divenne famoso per i buffi soprannomi che dava alla gente; suo padre decise di farne un predicatore. Quand’ebbe diciassette anni, lo mandarono a cercare nel campo dove lavorava. La sua sacca era già pronta, i cavalli attaccati. Lo mandavano alla Carleton Academy di Northfield, a prepararsi per il Carleton College. Siccome ce n’eran parecchi, di giovani Veblen da educare, il padre costruì loro una casa su un appezzamento presso il campo di ricreazione. Pasti e vestiti glieli mandavano da casa. Denaro spicciolo non ne videro mai. Thorstein parlava l’inglese con accento non inglese. Aveva un’incapacità costituzionale a dir di sì. Si era formato la mente sulle saghe nordiche e sulla realtà del lavoro rurale paterno e sugli esatti bisogni della falegnameria e delle trebbiatrici. Non riuscì mai a interessarsi molto della teologia, sociologia ed
economia politica del Carleton College, dove s’affaccendavano a smussare le asperità nei dogmi degli antichi biblici mercanti del New England per farne cartigli da appendere alle pareti degli uffici dei rappresentanti. Gli anni di studio di Veblen furono gli anni che le asserzioni darwiniane dello sviluppo e adattamento infrangevano gli stampi chiusi del mondo dell’Arca, che le donne di Ibsen tiravan giù a strappi le portières dei salotti vittoriani, e la macchina poderosa di Marx attrezzava la logica stessa dell’ufficio di contabilità per distruggere la contabilità. Quando Veblen tornò a casa nel podere parlò di queste cose con suo padre, seguendolo su e giù mentre arava, cominciando una discussione mentre attendevano un nuovo carico per la trebbiatura. Thomas Anderson aveva visto la Norvegia e l’America; aveva la mente quadrata di un falegname e costruttore, e un’esperienza di strumenti e quel sapere tesoreggiato, elaborato, messo insieme a stagioni, del contadino riflessivo, una dura cote per l’acciaio filato della sagacia del giovane Thorstein. Al Carleton College il giovane Veblen era considerato un brillante eccentrico senza serietà; nessuno riusciva a comprendere come mai un ragazzo di simile ingegno non si mettesse di proposito alla faccenda del giorno, vale a dire a puntellare la proprietà e i profitti con tutto quel che di usabile ci fosse ancora nei frantumi della morale cristiana e dell’economia diciottesimo secolo che ingombrava i cervelli dei professori, e a rafforzare il sacro, ma già barcollante edificio con la nuova potente travatura della scienza che Herbert Spencer drizzava in beneficio dei padroni. Si lagnavano di non capire mai se Veblen scherzava o faceva sul serio. Nel 1880 Thorstein Veblen cominciò a tentare di guadagnarsi da vivere facendo l’insegnante. Un anno in un’accademia di Madison, Wisconsin, non riuscì un gran successo. L’anno dopo, lui e il fratello Andrew iniziarono una libera docenza al John Hopkins. Il John
Hopkins non andò; ma lo stare a pensione in un’antica casa di Baltimora con certe dame rovinate gli aprì uno sdegnoso spiraglio su un cerimoniale tarlato ora, ma tramandato, attraverso la prodiga comodità delle residenze dei piantatori proprietari di schiavi, direttamente dalla gaia Inghilterra dei gentiluomini feudali. (I contadini delle valli eran sempre stati sprezzanti dei modi dei forestieri.) Si sentì più a suo agio a Yale dove in Noah Porter trovò un granito puritano contro il quale il suo granito norvegese squillò in limpido dissenso. Si laureò là in filosofia. Ma c’era ancora qualche dubbio in quale facoltà del mondo accademico si sarebbe meglio guadagnato da vivere. Leggeva Kant e scriveva saggi di concorso. Ma non riusciva a trovare un impiego. Per provare che facesse, non poteva indurre la sua bocca agli essenziali sì. Ritornò nel Minnesota con una certa intollerante esperienza delle amenità dell’alta cultura universitaria. Al leggero accento nordico aveva aggiunto l’a larga. A casa bighellonava per il podere e pasticciava nuove invenzioni meccaniche e leggeva e parlava di teologia e filosofia col padre. Nelle colonie scandinave il prezzo del grano e la fede in Dio e sant’Olaf calavano insieme. Gli agricoltori del Nord-ovest cominciavano allora la lunga battaglia perduta contro gli affaristi parassiti che li rosicchiavano all’osso. C’era un’ipoteca sul podere, interessi di debiti da pagare, sempre nuovo concime e nuove macchine da comprare per accelerare la produzione e succhiare in mezzo secolo a quel suolo la ricchezza che milioni di anni di buffalo grass vi avevan deposto. I suoi fratelli borbottavano su questo sarcastico fannullone che non voleva saperne di mantenersi. Tornato a casa ritrovò la sua innamorata degli anni universitari, Ellen Rolfe, la nipote del rettore di Carleton, una ragazza che aveva in famiglia quattrini e magnati delle ferrovie. Tutti a Northfield storsero il naso quando si seppe che costei avrebbe sposato quel languido, difficile, letterato, malvestito buonannulla d’un norvegese. La famiglia di lei preparò un piano per dargli un posto di
economista nella ferrovia di Santa Fe ma, proprio quando non ci voleva, lo zio di Ellen Rolfe perse il controllo della linea. La coppia dei due giovani andò a stare a Stacyville, dove fecero di tutto tranne guadagnarsi il pane. Leggevano i latini e i greci, erborizzavano nei boschi e lungo gli steccati e nella macchia lungo le strade. Andavano in barca sul fiume e Veblen cominciò la sua traduzione della Laxdaela Saga. Lessero Guardando indietro e gli articoli di Henry George. Guardavano il loro mondo dall’esterno. Nel ‘91 Veblen mise insieme qualche soldo per recarsi al Cornell e lavorare a una libera docenza. Comparve nell’ufficio di direzione della facoltà d’Economia con un berretto di tasso e calzoni bigi di fustagno e disse nella sua sommessa cadenza sarcastica «Sono Thorstein Veblen», ma non fu che diversi anni più tardi, dopo che fu stabilito nella nuova università di Chicago cresciuta in seguito alla Fiera mondiale ed ebbe pubblicato La teoria della classe agiata, messa di moda dalla famosa recensione di Howells, che il mondo dell’alta cultura seppe chi era Thorstein Veblen. Anche a Chicago, dove faceva il giovane economista brillante, visse da uomo dei boschi (i contadini delle valli eran sempre stati sprezzanti dei modi dei forestieri). Teneva i libri in valigie drizzate contro le pareti. Le sue sole stravaganze eran le sigarette russe che fumava e la fascia rossa in cui talvolta si drappeggiava. Era un uomo senza chiacchiere. Quando faceva lezione si posava la gota sulla mano e mormorava le sue lunghe frasi a spirale, piene di ripetizioni come l’Edda. La sua lingua era un misto di termini di meccanica, latino scientifico, gergo e Thesaurus di Roget. Gli altri professori non sapevano spiegarsi come mai le ragazze se ne innamorassero tutte. Le ragazze se ne innamoravano tanto che Ellen Rolfe cominciò a piantarlo. D’estate faceva gite all’estero senza la moglie. Ci fu uno scandalo con una ragazza su un transatlantico. Le male lingue tanto fecero (Veblen era un uomo che non dava mai spiegazioni, che non poté mai indurre la bocca agli essenziali sì, i contadini delle valli eran sempre stati sprezzanti dei modi dei forestieri, e delle loro opinioni) che la moglie lo piantò e scappò a viversene sola in una concessione di boschi nell’Idaho e il rettore gli
chiese le dimissioni. Veblen andò nell’Idaho a convincere Ellen Rolfe di venirsene con lui in California dove riuscì a trovare e a migliori condizioni un posto al Leland Stanford, ma anche a Palo Alto fu la stessa storia di Chicago. Soffriva il mal di donna e una incapacità costituzionale a dir di sì e una innaturale tendenza a mettersi dalla parte dei lavoratori invece che con la classe profittatrice. Ci furono le solite lagnanze che i suoi corsi non riuscivano costruttivi o lusinghieri ai grossi lasciti e non aiutavano gli studenti a imburrarsi la pagnotta, a intrufolarsi nella confraternita, a raccoglier i frutti su per le gerarchie del boschetto accademico. La moglie lo piantò per davvero. Egli scrisse a un amico: “Il rettore non approva le mie vicende domestiche; neanch’io”. Parlando della faccenda una volta disse: «Che deve fare uno se le donne lo vengono a cercare?». Se ne tornò nella baracca dell’Idaho. Qualche amico gli cercò un incarico per fare studi in Creta, una cattedra all’università di Pechino, ma sempre il pantano, l’andazzo, in ogni ufficio universitario i lacchè dei bottegai… l’amaro calice per chi faceva troppe domande. Il suo amico Davenport gli trovò un posto all’università del Missouri. A Columbia visse come un eremita al pianterreno di casa Davenport, aiutava nei lavori manuali, si fabbricò da sé un tavolo e le sedie. Era già un uomo amareggiato, vecchio, dalla faccia smorta e coperta di un velo di piccole rughe e una barbetta alla Van Dyke e i denti gialli. Pochi studenti riuscivano a seguire i suoi corsi. I dirigenti dell’istituto eran sovente sorpresi e qualche poco irritati che quando dall’Europa venivano visitatori era sempre Veblen che volevano vedere. Furono gli anni che scrisse tutte le sue opere, sperimentando le sue idee sugli studenti, scrivendo adagio di notte in inchiostro violetto con una penna disegnata da lui. Ogni volta che pubblicava un libro doveva darne garanzia agli editori. Nella Teoria dell’impresa, nell’Instinct of Workmanship, nei Vested Interests and the Common Man stabilì il nuovo diagramma di una società dominata dai capitali del monopolio,
mostrò inciso nell’ironia il sabotaggio della produzione da parte degli affaristi, il sabotaggio della vita da parte della cieca necessità dei profitti, additò le alternative: o una società violenta strozzata dalle burocrazie dei monopoli costretti dalla legge dei guadagni decrescenti a schiacciare sempre più, per cavarne profitto, l’uomo della strada, o una nuova realistica società del buon senso dominata dai bisogni degli uomini e delle donne che hanno prodotto il lavoro, e le possibilità incredibilmente vaste di pace e abbondanza offerte dai progressi della tecnologia. Furono gli anni dei discorsi di Debs, delle crescenti associazioni sindacali, dei progetti internazionalisti di una democrazia industriale: in questi anni Veblen sperava ancora che i lavoratori avrebbero rilevato la macchina della produzione prima che il monopolio spingesse un’altra volta nelle tenebre le nazioni d’occidente. La guerra tagliò a mezzo tutto ciò: sotto la bandiera riparo delle frasi di Woodrow Wilson i monopoli s’imposero. La democrazia americana era schiacciata. La guerra almeno offrì a Veblen una possibilità di uscir fuori dalla serra soffocante della vita accademica. Gli offrirono un posto alla Food Administration, mandò al ministero della Marina un’invenzione per catturare i sommergibili stendendo gomene di solido cavo. (Intanto il governo trovava i suoi libri alquanto imbarazzanti. La direzione delle Poste vietava il transito a Imperial Germany and the Industrial Revolution, mentre le agenzie di propaganda lo spedivano in giro per attizzare l’odio contro gli unni. Gli educatori attaccavano The Nature of Peace, mentre gli esperti di Washington ne ritagliavano frasi per aggiungerle alle cortine di fumo wilsoniane.) Per la Food Administration Thorstein Veblen scrisse due relazioni: in una sostenne che bisognava cedere alle richieste dell’IWW 1 come provvedimento straordinario di guerra e conciliarsi la classe del lavoro invece di bastonare e ficcar dentro tutti i dirigenti onesti; nell’altra fece osservare che la Food Administration era una trappola degli speculatori e non mirava affatto all’organizzazione efficiente del paese come macchina di produzione. Suggeriva che, nell’interesse
dell’efficiente prosecuzione della guerra, il governo prendesse il posto degli intermediari e fornisse il necessario agli agricoltori in cambio delle materie prime; ma troncare le speculazioni non era affatto il modo in cui all’Administration intendevano di far libero il mondo per la democrazia, e così Veblen dovette dar le dimissioni. Firmò le proteste contro il processo di cento e uno sovversivi di Chicago. Dopo l’armistizio andò a New York. Nonostante tutta l’oppressione degli anni di guerra, l’aria si andava rinfrescando. Era scoppiata in Russia la grande tempesta della rivolta e dava segno di travolgere l’Occidente; alle vigorose ventate del nuovo mondo costituitosi ad oriente le moltitudini macerate dalla guerra riaprirono gli occhi. A Versailles alleati e nemici, magnati, generali, lacchè della politica si sbracciavano a serrar le imposte contro la tempesta, contro il nuovo, contro la speranza. Per un attimo nella vampa tonante si svelò con improvvisa chiarezza il retroscena della guerra, il retroscena della pace. In America, in Europa, vinsero quelli del vecchio ordine. I banchieri tirarono il fiato negli uffici, le vecchie signore ingioiellate della classe comoda tornarono a staccare le loro cedole nella quiete raffinata delle camere di sicurezza, gli ultimi buffi di ozono della rivolta smorirono nel bisbiglio delle conversazioni clandestine. Veblen scrisse sul «Dial», fece conferenze alla New School of Social Research. Nutriva ancora una speranza che gli ingegneri, i tecnici, i non profittatori che avevano le mani sulle leve di comando riprendessero la lotta là dove la classe operaia era fallita. Contribuì a fondare la Technical Alliance. La sua ultima speranza fu lo sciopero generale britannico. Possibile che non ci fosse nessun gruppo di uomini abbastanza coraggiosi da assumersi il controllo della magnifica macchina prima che gli speculatori dagli occhi porcini e i burocrati servili la
rovinassero irreparabilmente e con essa le speranze di quattro secoli? Nessuno andava alle conferenze di Veblen alla New School. Ad ogni articolo che faceva sul «Dial» la vendita diminuiva. La normalità di Harding, l’era nuova cominciavano; persino Veblen fece un piccolo colpo in Borsa. Era un vecchio solitario. La sua seconda moglie era finita in una clinica, afflitta dalla mania di persecuzione. Non c’era posto per un vecchio senza padroni. Veblen ritornò a Palo Alto a viversene nella capanna sulle colline fulve e osservare dall’esterno le ultime rapaci convulsioni del sistema dei profitti rivelante, diceva lui, le sistematiche illusioni della demenza precoce. Qui terminò la traduzione della Laxdaela Saga. Era un vecchio. Era assai solo. Lasciava che i topi di bosco prendessero quel che volevano dalla dispensa. Una puzzola che girava intorno alla capanna era così domestica che veniva a strofinarglisi contro una gamba come un gatto. Disse a un amico, che talvolta udiva nel silenzio intorno a sé le voci della sua infanzia che parlavan norvegese, limpide come nel podere del Minnesota dove era stato allevato. Gli amici lo trovavano sempre più restio a parlare, sempre più restio a interessarsi di qualsiasi cosa. Andava in collasso. Gli ultimi sorsi dell’amaro calice. Morì il 3 agosto 1929. Tra le sue carte si trovò un biglietto a matita: È pure mio desiderio, quando muoia, di venir cremato se si può farlo convenientemente, con la minor complicazione o spesa possibile, senza esequie né cerimonie di nessun genere; che le mie ceneri siano sparse nel mare o in qualche largo fiume che si getti nel mare; che nessuna lapide, o lastra o epitaffio o effigie o tavoletta o iscrizione o monumento di qualunque nome o natura si dedichi alla mia memoria o al mio nome in nessun luogo e in nessuna occasione; che nessun necrologio, commemorazione, ritratto o biografia di me, né alcuna lettera da me scritta o ricevuta, sia data alle stampe o pubblicata, o in qualunque modo riprodotta, copiata o fatta circolare;
ma il suo ricordo dura inchiodato nel linguaggio: il limpido acuto prisma della sua mente. 1. Industrial Workers of the World: Lavoratori industriali del mondo. (NdT)
Cine-giornale LI La mia casa è senza sole CERCASI: FAR STRADA posizioni che offrono a pronte, accurate, sperimentate ben raccomandate giovinette e signorine… buone opportunità di far strada Sin dal triste giorno che Sally non fece più ritorno SIGNORINE SIGNORINE SIGNORINE viaggiatrici di commercio… custodi… cassiere… domestiche… cameriere… spazzatrici… schedatrici… segretarie private… contometriste… corrispondenti… cuoche… operatrici di dictafono… dame… operatrici di multigrafo… operatrici Elliott Fisher… segretarie di registrazione… gommatrici… guantaie… governanti… pettinatrici… indossatrici… bella occasione per signore eleganti… signorine intelligenti Sono andato al St. James Infirmary 1 e ho veduto la mia vita stesa, il capo sul guanciale bella, smorta e irrigidita Son salito dal dottore ABBIAMO CENTINAIA DI POSTI APERTI siamo impazienti di riempire i vuoti, offriamo buoni stipendi, provvigioni, interessenze, premi, possibilità d’affari, addestramento, avanzamento, possibilità educative, servizio metodico… sala di riposo e sala dei pasti dove viene servita sotto costo una colazione eccellente Dell’addio le parole la raggiungano dovunque ma in nessun luogo sotto il sole nessuno più l’amerà tanto 1. È il celebre “blues” di Louis Armstrong. (NdT)
Mary French Mai il povero Papà poteva mettersi in letto, subito dopo cena, a quel modo che a lui piaceva, con la lampada a sinistra, gli occhiali inforcati, il giornale in mano e un sigaro intero in bocca, che il telefono non squillasse, oppure bussavano alla porta di servizio e Mamma diceva a Mary di aprire e compariva un minatore bianco in faccia con le ciglia e le palpebre annerite dal carbone e diceva: «Il dottor French, prego… venisse subito», e il povero Papà scendeva dal letto sbadigliando in pigiama e accappatoio e si ricacciava dalla fronte i capelli grigi disordinati e diceva a Mary di andargli a prendere nello studio la valigetta e partiva annodandosi intanto la cravatta, e metà delle volte stava fuori tutta la notte. A tavola era ancor peggio. Non riuscivano a sedersi una volta, loro tre, per il pasto, senza che squillasse quell’orribile telefono. Papà usciva, e Mary con Mamma restavan sedute a finir sole il pasto, sedute là in silenzio: Mary con le gambe attorte a quelle della sedia fissava il quadro delle due anatre selvatiche morte, in mezzo alla tappezzeria color zenzero sopra l’elegante pettinatura nera di Mamma. Poi Mamma sparecchiava e ciabattava per casa mormorando tra sé che se il povero Papà si fosse mai preso, coi clienti che pagavano, metà della pena che si prendeva per quegli straccioni di forestieri e minatori, sarebbe ormai stato un uomo ricco e lei non sarebbe ridotta a uccidersi di fatica. Mary detestava di udire Mamma parlare a quel modo contro Papà. Mamma e il povero Papà non andavano d’accordo. Confusamente Mary si ricordava di un tempo, quando lei era piccina piccina, che le cose eran state diverse e abitavano a Denver in una casa piena di sole coi cespugli in fiore nel cortile. Fu prima che mancasse Fratellino e Papà perdesse quei denari che aveva investiti. Sempre, se qualcuno diceva Denver, le tornava in mente il sole. Ora vivevano in Trinidad, dove tutto era nero come il carbone, le scarne colline, dritte, che oscuravano la vallata piena di baracche fuligginose in fila, i depositi, i minatori, messicani e ungheresi la maggior parte, e le orribili osterie, il fumo soffocante dei forni e i trenini neri. A Denver c’era il bel sole, e ci
viveva gente civile, decenti bimbi, americani autentici, come Fratellino ch’era mancato e Mamma disse che se il povero Papà si fosse curato del suo sangue come si curava di quegli straccioni di forestieri e minatori, la vita di Fratellino forse si sarebbe potuta salvare. Mamma l’aveva fatta entrare nella cappella, lei aveva tanta paura, ma Mamma le stringeva la mano così forte che le faceva un male intollerabile ma nessuno ci badava, tutti credevano che piangesse per via di Fratellino e Mamma glielo fece guardare nella bara sotto il vetro. Dopo il funerale Mamma fu molto malata e vennero un’infermiera per il giorno e una per la notte; a Mary non era più permesso vederla e doveva giocare da sola nel cortile. Quando Mamma guarì, non andava più d’accordo col povero Papà e dormirono in camere separate e Mary dormiva in un piccolo vano frammezzo. Il povero Papà divenne grigio e preoccupato e da quel tempo non rise mai più per casa e poi venne la faccenda dell’investimento e traslocarono a Trinidad, dove Mamma non la lasciava giocare coi figli dei minatori e quando tornava da scuola Mary aveva lendini nei capelli. Mary doveva portar gli occhiali e riusciva bene nello studio e a dodici anni sarebbe entrata nella scuola media. Quando non studiava, leggeva: lesse tutti i libri che c’erano in casa. «La bimba si guasterà la vista» diceva Mamma attraverso il tavolo al povero Papà durante la colazione, quando lui scendeva con gli occhi gonfi dal sonno e doveva buttar giù la colazione per esser fuori in tempo a far le visite. La primavera che Mary finì l’ottava e prese il premio di francese, di storia patria e d’inglese, la signorina Parson venne apposta per far visita alla signora French e dirle quale brava scolara fosse Mary French e quale consolazione per le insegnanti, dopo tutti quegli straccioni ignoranti di forestieri che le toccava di sopportare. «Cara signorina» disse Mamma «non crediate che io non lo sappia.» Poi aggiunse a un tratto: «Signorina Parson, non ne parlate con nessuno: quest’ottobre che viene andremo a stabilirci a Colorado Springs». La signorina Parson trasse un sospiro. «Certo, signora French, ci dispiacerà molto perdervi, ma senza dubbio per la bambina è meglio. Laggiù vi è un miglior elemento nelle scuole.» La signorina Parson sollevò la tazza del tè scostando il dito mignolo e tornò a posarla nel
piattino con un secco colpo. Mary sedeva guardandole tutte e due, su uno sgabellino ricamato, presso il camino. «Non dovrei dirlo» continuò la signorina Parson «visto che son nata e cresciuta qui, ma Trinidad non è posto per educarvi una brava e vera bimba americana.» Nonno Wilkins era morto quella primavera a Denver e Mamma era beneficiaria della sua assicurazione, cosicché essa decise la cosa con molta arroganza. Il povero Papà non voleva saperne di lasciare Trinidad e non si parlavano quasi mai senza mandar prima Mary a leggere in biblioteca mentr’essi litigavano fra i piatti sporchi in cucina. Mary si sedeva con un vecchio Ivanhoe rosso, in cuoio sbalzato, fra le mani e ascoltava le amare voci altercare di là dalla tramezza di legno. «Hai rovinato la mia esistenza e ora non ti permetterò di rovinare quella della bimba» strillava Mamma con quella voce odiosa che faceva a Mary tanto senso, e Mary stava là seduta piangendo sul libro, finché non riprendeva il filo della lettura e due pagine dopo tutto era dimenticato tranne i messeri in verde lincoln e i cavalieri in arcione e i castelli. Quell’estate invece di andare a campeggiare al Yellowstone come Papà aveva progettato traslocarono a Colorado Springs. A Colorado Springs alloggiarono prima in una pensione e poi, quando giunse il mobilio, si trasferirono in un bungalow dal tetto verde, che sarebbe stato la loro casa, un po’ discosto dal rosso stradone inghiaiato, in un prato stento fra grandi pioppi. Nell’erba alta Mary trovò i resti scagliosi di un gioco di croquet. Mentre Papà e Mamma erano in grande agitazione per il mobilio che i facchini trasportavano dal carro, lei saltellava menando colpi con la mazzetta rotta alle vecchie palle screpolate, cui non restava pressoché nulla delle loro bande di vernice rossa, verde, gialla e azzurra. Quando Papà uscì dalla casa con un’aria spossata e grigia e i capelli scomposti sulla fronte, lei gli corse incontro agitando la mazzetta e voleva che giocasse al croquet. «Non è tempo di giochi, ora» disse Papà. Mary scoppiò in lacrime e lui se la alzò sulla spalla e la fece girare dietro la casa, davanti al portico, e le mostrò come, arrampicandosi sul tetto del piccolo ripostiglio dietro la porta della cucina, si vedeva
l’altipiano e al di là, dietro una frangia sbrindellata di galoppanti nubi di garza, le azzurre catene dentellate accumulantisi fino alla liscia massa imponente dei massicci dov’era Pikes Peak. «Qualche volta andremo lassù sulla funicolare» le disse presso l’orecchio con la sua voce intima e calda. I monti parevan così lontani e la rapidità delle nubi le dava le vertigini. «Solo tu ed io» diceva Papà «ma non devi mai piangere… riderebbero di te a scuola i ragazzi, Mary.» A settembre dovette andare alla scuola media. Fu terribile entrare in una nuova scuola dove non aveva amiche. Le ragazze parevan così benvestite e superbe nella prima classe. In giro nei corridoi sentendo le altre parlare di riunioni e del circolo campestre e di partite a tennis e stazioni di villeggiatura e automobili e amiche nelle scuole superiori dell’Est, Mary, con i suoi occhiali e l’apparecchio di protesi che Mamma le aveva fatto mettere dal dentista e la faceva sibilare un poco, e le sue lentiggini, e i capelli che non erano né rossi né biondi ma color della sabbia, si sentiva una stracciona di forestiera come quei puzzolenti e schiamazzanti marmocchi dei minatori, laggiù a Trinidad. Le piacevano di più i ragazzi. Ce n’era uno dalla testa rossa che le faceva qualche volta un sogghignetto. Comunque, la lasciavano in pace. Riusciva bene nello studio e le insegnanti le parevano amabili. Nell’ora d’inglese leggevano Ramona e un giorno Mary, sola e mezza morta di paura, andò al cimitero a visitare la tomba di Helen Hunt Jackson. 1 Era di una tristezza affascinante quel tramonto di primavera nell’Evergreen Cemetery. Quando sarebbe stata grande, Mary decise, avrebbe fatto come Helen Hunt Jackson. C’era una ragazza svedese di nome Anna che attendeva alle faccende, e Mamma e Papà non erano quasi mai in casa quando Mary ritornava da scuola. Papà aveva uno studio nel quartiere del centro in un palazzo nuovo e Mamma era sempre in attività religiose o nella biblioteca intenta a leggere per le conferenze che teneva nei circoli femminili. La metà delle volte Mary cenava tutta sola leggendo un libro o preparando le sue lezioni. Poi passava in cucina e aiutava Anna a mettere in ordine e cercava di non lasciarla andare a casa abbandonando lei sola. Quando udiva aprirsi la porta di entrata, si
precipitava incontro perdutamente. Di solito era soltanto Mamma, ma qualche volta era Papà col suo sigaro e l’aria stanca e i vestiti esalanti tabacco e iodoformio ed etere, e qualche volta riusciva a farselo sedere sul letto, prima di addormentarsi, che le raccontasse storie dei tempi passati: minatori e cercatori di giacimenti e la guerra tra i pastori e i rancheri. In scuola la miglior amica di Mary era Ada Cohn, figlia di un distinto avvocato di Chicago che aveva dovuto venir là per motivi di salute. Mamma faceva del suo meglio per impedire a Mary di frequentare i Cohn e sosteneva odiose discussioni con Papà come qualmente era colpa della sua inettitudine se l’unica figlia che lei aveva era ridotta a uscire con degli ebrei e con Tizio e con Caio; e perché non entrava nel circolo campestre e a che serviva dunque che lei faticasse tanto nelle attività religiose, nei circoli femminili e nell’opera dei fondi sociali, per fargli una posizione nel miglior ambiente, se lui continuava a non esser altro che un dottore dei poveri e si mostrava a zonzo con la plebaglia nelle sale da biliardo e magari in luoghi peggiori, invece di farsi una clientela distinta, in una città come quella, dove c’era tanta gente ricca malata: non era per uscire da quello stato di cose che avevano lasciato Trinidad? «Ma, Hilda,» diceva Papà «sii ragionevole. I Cohn sono diventati miei clienti proprio perché Mary è una loro amica. Sono una simpatica e distinta famiglia.» Mamma gli piantava gli occhi addosso e sibilava tra i denti: «Oh se tu avessi tanto così d’ambizione». Mary allora si alzava da tavola e scappava via piangendo e si gettava sul letto con un libro e stava là distesa in ascolto delle voci eccitate e poi il passo pesante di Papà e lo sbatter della porta e il frastuono della manovella quando incamminava l’auto per riprendere le visite. Sovente stava là distesa stringendo i denti pensando se Mamma morisse una buona volta e lasciasse lei con Papà, soli insieme, a vivere tranquilli. La percorreva un freddo brivido al pensiero di quanto orribile fosse pensare di queste cose, e si metteva a leggere, dapprima distinguendo appena la pagina di stampa attraverso le lacrime ma a poco a poco obliando se stessa nella storia del libro. Una cosa su cui Mamma e Papà si trovaron d’accordo fu il comune
desiderio che Mary frequentasse una scuola superiore dell’Est veramente seria. L’anno prima di diplomarsi alla scuola media, Mary era stata promossa in tutti gli esami di commissione esterna eccettuato in geometria solida. E smaniava d’andarci. Tolto qualche giorno di campeggio ogni estate con Papà e un mese intero trascorso a rispondere al telefono, compilare le tabelle dei pazienti, tenere i conti di Papà e spedire le note dal suo studio, Mary detestava Colorado Springs. L’unico ragazzo che frequentasse era un giovinetto zoppicante a nome Joe Denny, figlio di un liquorista di Colorado City, che si manteneva al Colorado College col suo lavoro. Era un amaro e taciturno ragazzo dai capelli di stoppa e dalle mascelle aguzze: un portento in matematica. Odiava i liquori e John D. Rockefeller più d’ogni cosa al mondo. Con Joe e Ada andavano alla domenica a far gite nel Giardino degli dei e ad Austin Bluffs o in qualche canyon e leggevano versi insieme. I pezzi favoriti erano Il celeste segugio e La città della notte terribile. Joe entusiasmò un giorno le ragazze mettendosi in piedi sopra una rupe piatta che dominava il focherello dove friggeva il prosciutto e recitando The Man with the Hoe. Dapprima credettero l’avesse scritta lui. Quando rientravano cotti dal sole e beati dopo una giornata trascorsa all’aperto, Mary desiderava tanto di poter invitare in casa gli amici come faceva Ada. I Cohn erano affabili e gioviali e sempre invitavano tutti a pranzo, sebbene il povero signor Cohn fosse molto malato. Ma Mary non osava di portarsi in casa nessuno, per paura che Mamma li trattasse male o scoppiasse una di quelle gare di strilli ch’eran sempre nell’aria fra Mamma e Papà. L’estate prima che lei andasse a Vassar, Mamma e Papà non si parlarono più affatto dopo la tremenda discussione di quando Papà aveva detto una volta a cena che a novembre avrebbe votato per Eugene V. Debs. A Vassar le ragazze di sua conoscenza eran meglio vestite di lei e avevano ricercati modi universitari, ma per la prima volta nella sua vita Mary fu popolare. Piaceva alle istitutrici perché era accurata, seria e schietta in tutto, e le compagne dicevano di lei che era ordinaria come una scarpa, ma tanto cara. Andò tutto guastato l’anno dopo, quando a Vassar venne Ada.
Ada era la sua più antica amica e Mary l’amava assai; per questo si fece orrore sorprendendosi a desiderare che Ada non fosse venuta, Ada s’era fatta così prosperosa, così ebrea e fracassona, e i suoi abiti eran talmente dispendiosi e mal intonati all’ambiente. Occupavano la stessa camera e Ada le provvedeva la massima parte degli abiti e dei libri, perché i fondi di Mary eran piuttosto esigui. Dopo l’arrivo di Ada, Mary non fu più popolare come prima e le compagne più in vista si misero a evitarla. Mary e Ada nel secondo biennio presero sociologia e dichiararono che sarebbero diventate lavoratrici sociali. Mary era ancora nel primo biennio, quando Mamma andò a Reno e ottenne il divorzio da Papà, portando i moventi dell’ubriachezza e della crudeltà mentale. Non era mai passato in testa a Mary che il povero Papà bevesse. Pianse a lungo quando ne lesse la notizia in un ritaglio di giornale segnato in rosso, che qualche anonima anima buona le mandò da Colorado Springs. Bruciò il ritaglio nel camino in modo che Ada non potesse vederlo, e, quando Ada le chiedeva perché avesse gli occhi tanto rossi, diceva che l’avevano fatta piangere le notizie di tutti quei poveri soldati che morivano nella guerra d’Europa. La fece stare orribilmente la coscienza di aver mentito a Ada e per tutta la notte non chiuse occhio, disperata. L’estate seguente tutte e due trovaron posti nella comunità di Hull House a Chicago. Chicago metteva paura e la povera Ada Cohn non ce la fece a continuare e andò nel Michigan a farsi venire un esaurimento nervoso; era spaventoso come quei poveri vivevano, le nocche rosse e screpolate delle donne che facevano le lavandaie in casa, e le teste crostose dei bimbi e lo strepito e il vento polveroso in South Halstead Street e il fetore degli ammazzatoi; ma a Mary diede il senso d’esser tornata a Trinidad quand’era una bimba, quel senso provato l’estate che aveva lavorato nello studio di Papà. Quando ritornò a passare due settimane in Colorado Springs prima che si riaprisse Vassar, trovò Mamma insediata lussuosamente in un appartamentino del Broadmoor. Mamma aveva ereditato un pacco di azioni dell’American Smelting and Refining, alla morte di zio Henry in quell’accidente tranviario di Denver, e godeva una rendita di ventimila annui. S’era fatta grande giocatrice di bridge e girava la
regione parlando nei circoli femminili contro il voto alle donne. Parlò di Papà con una vocetta fredda ed agra come di «quel tuo povero e caro padre» e disse a Mary che doveva vestirsi meglio e smetterla di portare quegli orribili occhiali. Mary non voleva accettare denaro di sorta da sua madre, perché diceva che nessuno ha diritto al denaro che non ha guadagnato, ma si lasciò equipaggiare di un nuovo vestito di lana leggera, fatto su misura, e d’un modesto abito da pomeriggio coi polsini e il colletto di pizzo. Andava ora meglio d’accordo con la mamma, ma tra loro c’era sempre un freddo senso di sforzo. Mamma diceva di non sapere dove abitasse Papà, e così Mary dovette recarsi nello studio per trovarlo. Lo studio era più sudicio che lei non ricordasse, e pieno di pazienti, gente miserabile la maggior parte, e ci volle un’ora prima che Papà potesse andarsene e portarla a colazione. Mangiarono appollaiati su sgabelli al banco, nella piccola trattoria a due passi. I capelli di Papà erano quasi bianchi ora e la faccia terribilmente solcata e aveva grosse borse grigie sotto gli occhi. Mary si sentiva un nodo alla gola ogni volta che lo guardava. «Oh Papà, dovresti riposarti.» «So, so… Dovrei scendere per qualche tempo da questa altitudine. La vecchia pompa non funziona più come una volta.» «Papà, perché non vieni nell’Est a Natale?» «Forse sì, se troverò i soldi e qualcun altro che mi rilevi la clientela per un mese.» A Mary piaceva tanto quella sommessa voce sonora. «Ti farebbe così bene… Da quanto tempo non facciamo più un viaggetto insieme!» Era tardi. Non c’era nessuno nella sala tranne la faccia scontrosa della cameriera che mangiava il suo pasto a un tavolino, dietro. Il grosso pendolo dall’aria stanca sopra l’urna del caffè ticchettava rumoroso nelle pause del discorso lento di Papà. «Non avrei mai creduto di abbandonare la mia bambina… tu sai com’è andata… è questo che ho fatto… Come sta tua madre?» «Oh, Mamma tocca il cielo col dito» disse Mary con una risata che le suonò falsa alle orecchie. Manovrava per mettere Papà a suo agio, come in un caso di beneficenza. «E va bene, adesso è tutto finito… Io non ero il marito per lei» disse Papà. Mary sentì gli occhi empirsi di lacrime. «Papà, quando avrò la
laurea, lascerai che m’occupi io del tuo studio? Quella brutta signorina Hylan è così trascurata…» «Oh avrai di meglio da fare, tu. Tanto per me è ancor adesso sorprendente, quanta gente c’è che paga il conto… I miei non li pago.» «Papà, bisognerà che m’incarichi io di te.» «Lo vedo bene, figliola… quel tuo lavoro di comunità serve dunque da tirocinio per emendare il vecchio?» Mary si sentì arrossire. Si era appena bendisposta per stargli un po’ insieme che Papà dovette scappare in furia a visitare una donna che da cinque giorni era in doglie e non partoriva ancora. Mary detestava di tornare al Broadmoor fra gli inservienti in giacchetta e le lussuose vecchie galline in sala. Quella sera Joe Denny telefonò per sentire se poteva portarla a spasso in macchina. Mamma era occupatissima al bridge e così Mary sgusciò fuori senza dirle nulla e trovò Joe sotto il porticato d’entrata. Lei indossava il suo nuovo abito e s’era tolti gli occhiali e li portava in una borsetta. Joe le apparve in una nebbia, ma riuscì a distinguere che aveva un’aria di prosperità e guidava una vetturetta Ford nuova. «Ma insomma, Mary French,» disse Joe «insomma, se questo non si chiama darsi all’eleganza… Vedo che ormai non c’è più speranza per un tipo come me.» Guidò adagio un po’ di tempo per il parco e poi fermò in una chiazza di luna sopra un passaggio coperto. Giù per la piccola ripa oltre i pioppi tremanti si scorgevano le piane fosche e lucenti, distese lontano fino all’orizzonte lunare. «Che incanto!» disse Mary. Joe le rivolse il viso serio dal mento aguzzo e disse balbettando un poco: «Mary, debbo spuntarla… vorrei che mi accettassi… Andrò a Cornell a seguire un corso di meccanica… una borsa di studio… Quando uscirò dovrei essere in grado di guadagnare discretamente in un paio d’anni, e di mantenere una moglie… Sarebbe per me la felicità… se mi dessi speranza… se una volta allora… non ci fosse nessun altro…». La voce dileguò in un bisbiglio. Mary ebbe un lampo dei tratti recisi e seri di quel volto nella luce lunare. Non poteva fissarlo. «Joe, ho sempre creduto che fossimo amici come con Ada. Guasta tutto parlare in questo modo… Quando uscirò dal collegio io ho
intenzione di far lavoro sociale e poi debbo occuparmi di Papà… Ti prego dunque… tutte queste cose mi fanno disperare.» Joe tese la sua mano quadrata e se la strinsero solennemente al disopra del cruscotto. «D’accordo, sorella, quanto dici è vangelo» disse, e la ricondusse all’albergo senza una parola. Mary restò a lungo seduta sotto il portico fissando la notte lunare, disperata. Qualche giorno dopo, quando partì per ritornare agli studi, fu Joe che la portò in macchina alla stazione a prendere il treno per l’Est, perché Mamma aveva un’importante seduta di comitato e Papà doveva essere all’ospedale. Quando si dissero addio stringendosi la mano, Joe le batté nervosamente sulla spalla due o tre volte e pareva che avesse la gola disseccata, ma di fidanzamento non parlò più. Fu un grande sollievo per Mary. Sul treno lesse The Harbor di Ernest Poole e rilesse The Jungle e giacque quella notte nella sua cuccetta troppo agitata per dormire, tendendo l’orecchio al rombo delle ruote sulle rotaie, allo sbatacchio degli incroci, ai lontani sibili spettrali della locomotiva, ricordando le dame lussuose che si erano date arie, nel gabinetto per signore, passandole davanti allo specchio, e gli uomini d’affari dai tratti grossolani, che russavano nelle cuccette; pensando al lavoro da compiere per rendere il paese quel che doveva essere, e le condizioni di vita, i quartieri della miseria, le baracche dalle luride e vacillanti tettoie, i bambini dei minatori dai sudici indumenti troppo grandi per loro, le donne spossate ricurve sulle stufe, i giovani che si arrabattavano per un diploma nelle scuole serali, la fame, la disoccupazione e l’alcool, la polizia, gli avvocati, i giudici, sempre pronti a pigliarsela coi deboli; se soltanto fosse stato possibile far comprendere queste cose alla gente dei vagoni di lusso, se lei avesse sacrificato la sua vita, come Papà, che assisteva i suoi pazienti notte e giorno, forse anche lei, come la signorina Addams… Non poteva sopportare l’attesa. Non poteva restare nella cuccetta. Si alzò e andò a sedersi fremente nella saletta vuota tentando di leggere The Promise of American Life. Lesse qualche pagina, ma non le riusciva di afferrare il senso delle parole; i pensieri le tumultuavano in capo come i brandelli di nuvolaglia traboccanti per il colle e traverso
la massa nera delle montagne laggiù a casa. La presero freddo e brividi e ritornò in cuccetta. Attraversando Chicago disse a un tratto all’autista di portarla alla Hull House. Sentiva il bisogno di sfogarsi con la signorina Addams. Ma quando il tassì rallentò al marciapiede nel mezzo del noto squallore di South Halstead Street e Mary vide due ragazze che conosceva, in piedi sotto il portico di pietra, a parlare, le cadde a un tratto ogni coraggio e disse all’autista di proseguire per la stazione. A Vassar quell’inverno ogni cosa le parve insopportabile. Ada s’era data alla musica e studiava il violino e non aveva altro in mente che andarsene a New York per i concerti. Le disse che era innamorata del dottor Muck della Sinfonica di Boston, e che non voleva saperne di guerra né di pacifismo né di lavoro sociale né di qualsiasi discorso di questo genere. Il mondo all’esterno – la campagna dei sommergibili, la guerra, l’elezione – era talmente vivido che Mary non riusciva più a prestare attenzione ai suoi corsi o al cicaleccio di Ada intorno alle celebrità della musica. Andava a tutte le conferenze sugli avvenimenti d’attualità e sulle condizioni di vita. La conferenza che l’eccitò maggiormente quell’inverno fu quella di G.H. Barrow sulla “Promessa della Pace”. Costui era alto, con folti capelli grigi e il viso rosso e un pomo d’Adamo sporgente e gli occhi luminosi che tendevano un poco a uscirgli dalla fronte. Aveva un po’ di balbuzie e un fare caldo e confidenziale nella parlata. Appariva, in qualche modo, così simpatico che Mary era certa ch’era stato un lavoratore. Aveva rosse mani nocchiute dalle lunghe dita e passeggiava avanti e indietro per la sala con un passo scattante, togliendosi e rimettendo un paio di occhiali di tartaruga. Dopo la conferenza si recò in casa del signor Hardwick, dove la signora Hardwick servì limonata, cioccolata e panini, e tutte le ragazze gli si misero attorno e gli fecero domande. Era più timido che sul palco, ma parlava in bel modo della fede che il Lavoro aveva nel signor Wilson e come il Lavoro avrebbe chiesto la pace e come la rivoluzione messicana (veniva allora dal Messico e vi aveva passato ogni sorta di avventure) fosse soltanto un principio. Il Lavoro stava per drizzarsi in piedi in tutto il mondo e porsi a sgombrare le macerie che l’ordine
vecchio aveva fatto, non con la violenza ma con metodi di pace, metodi wilsoniani. Quella notte Mary si mise in letto continuando a sentire il teso e affascinante tremito nervoso che a volte s’impadroniva della voce del signor Barrow. Tutto ciò la rendeva follemente ansiosa di sprigionarsi da quella soffocante vita di collegio e uscire nel mondo. Il trascorrer del tempo non le era mai parso più lento che in quell’inverno. A febbraio, in una dimoiante giornata di sgelo, era rientrata in un intervallo nella sua camera per cambiarsi le soprascapre fradice, quando trovò un giallo telegramma sotto la porta: CONSIGLIO TORNARE QUALCHE GIORNO MAMMA POCO BENE. Firmato PAPÀ. Mary provò una terribile agitazione, ma fu un sollievo avere una scusa per andarsene dal collegio. Prese con sé una quantità di libri ma non riuscì a leggere in treno. Sedeva là troppo accaldata sulla felpa verde, un libro sulle ginocchia, fissando i monotoni campi coperti di neve e orlati da grovigli di brulli alberi viola e i cartelloni pubblicitari e le baracche e i negozi dalla falsa facciata in mattoni rossi lungo i nuovi stradali in cemento e cittadine caotiche in legno, fuligginose del fumo di fabbriche, e le baracche e i granai e le casipole lentamente roteanti, mentre il treno si precipitava attraverso il Middle West; sedeva e non pensava a nulla. Papà era alla stazione. I suoi panni parevano anche più spiegazzati del solito e gli mancava un bottone al soprabito. Aveva il viso, quando sorrideva, pieno di nuove e sottili rughette; e gli occhi cerchiati di rosso, come se da notti non dormisse. «Niente di grave, Mary» disse. «Non avrei dovuto telegrafarti di venire… sono vizi che mi do… mi sento solo, invecchiando.» Prese la valigia di lei al facchino e continuò a parlare, mentre uscivano dalla stazione. «Tua madre se la cava bene… L’ho messa in salvo… Fortuna che ho saputo ch’era malata. Quel maledetto dottore dell’albergo, ancora un giorno e l’avrebbe ammazzata. Questa spagnola fa certi scherzi.» «Ce n’è molta qui, Papà?» «Molta… E tu dovrai stare attenta al contagio… Salta su, ti porto io là.» Accese il motore del rugginoso macinino e le fece segno di sedersi
davanti. «Sai quel che pensa tua madre dei liquori?… Ebbene, l’ho tenuta ubriaca quattro giorni.» Salì accanto a lei e partì, senza smettere di chiacchierare. Il rigido freddo le ridiede vita dopo il soffocante odor di felpa nella vettura. «È stata simpatica come non l’avevo mai conosciuta. Perbacco, quasi quasi tornavo a innamorarmene… Dovrai stare molto attenta che non si affatichi troppo quando si alzerà… sai com’è lei… Sono le ricadute che spacciano in questi casi.» D’improvviso Mary si sentì felice. I rametti brulli degli alberi rosei, gialli e purpurei, si tendevano contro l’azzurro sopra le larghe vie tranquille. C’eran chiazze di neve agghiacciata sulle zolle. Il cielo era enormemente alto e pieno di giallo fulgore. Il freddo le faceva increspare i peluzzi delle narici. Al Broadmoor Mamma era a letto nella sua linda camera assolata con una giubbetta rosa sulla camicia da notte e una cuffia di merletto sulla ben pettinata testa nera. Appariva pallida ma talmente giovane e carina e come sventata, che per un attimo sembrò a Mary che lei e Papà fossero i grandi e Mamma la loro figliola. Senz’altro Mamma cominciò gioiosamente a discorrere della guerra e degli unni e della campagna dei sommergibili e cosa mai pensava il signor Wilson che non dava una lezione a quei messicani. Lei era certa che le cose sarebbero andate altrimenti se avessero eletto il signor Hughes; di fatto era certa che legalmente era stato eletto lui e che i democratici avevan carpito l’elezione con qualche loro imbroglio. E quell’odioso Bryan che copriva di ridicolo il paese. «Mia cara, Bryan è un traditore e bisognerebbe fucilarlo.» Papà ghignò volto a Mary, si strinse nelle spalle e se ne andò dicendo: «Be’, Hilda, adesso sta’ a letto e, ti prego, niente eccessi alcoolici». Partito Papà, Mamma si mise a un tratto a piangere. Quando Mary le chiese che avesse, non voleva rispondere. «Credo sia quest’influenza che mi indebolisce il cervello» disse. «Mia cara, lo debbo alla misericordia di Dio, se sono scampata.» Mary non poteva sedere là tutto il giorno ascoltando sua madre che continuava sul “teniamoci pronti”, l’avviliva troppo; e allora passò l’indomani mattina allo studio di Papà, caso mai lo vedesse un
momento. La stanza d’aspetto era piena. Quando fece capolino nello studio s’accorse al primo sguardo che Papà quella notte non aveva dormito. Venne fuori che la signorina Hylan era andata a casa il giorno prima malata. Mary disse che avrebbe preso il suo posto, ma Papà non voleva saperne. «Sciocchezze» disse Mary. «So rispondere al telefono “studio del dottore” tanto quanto quella brutta signorina Hylan.» Alla fine le diede una maschera di garza e le permise di restare. Quand’ebbero finito con l’ultimo paziente, passarono nella trattoria a mangiare un boccone. Erano le tre. «Faresti bene a passare da tua madre» le disse Papà. «Io debbo cominciare le visite. Muoiono come le mosche con questo malanno. Non ho mai veduto niente di simile.» «Prima ritorno a riordinare la scrivania» disse Mary fermamente. «Se qualcuno telefona, rispondi che, se sospettano influenza, il paziente va messo subito a letto, i piedi caldi con una bottiglia d’acqua, e stimolanti in quantità. Inutile cercare di portarlo all’ospedale perché non c’è più un letto nel giro di cento miglia.» Mary ritornò allo studio e sedette alla scrivania. A quanto pareva c’era un numero spaventoso di nuovi pazienti; il giorno avanti la signorina Hylan era rimasta senza schedine e aveva scritto i nomi su un brogliaccio. Erano tutti casi d’influenza. Finché stette là seduta, il telefono non smise di trillare. Provava freddo alle dita e abbrividiva in tutto il corpo, quando le giungevano le voci ansiose di uomini, donne, che chiedevano del dottor French. Vennero le cinque prima che lasciasse lo studio. Prese il tram per tornare al Broadmoor. Fu un brusco mutamento sentire l’orchestra che suonava nel salone per il ballo delle cinque e vedere i lampioncini colorati e trovare il tranquillo tepore delle sale e l’ambiente di fasto elegante nella camera di sua madre. Mamma fu piuttosto stizzita e le disse a che serviva dunque il ritorno di sua figlia, se la trascurava a quel modo. «Ho avuto da fare per Papà» fu tutta la risposta di Mary. Mamma cominciò una filastrocca intorno alla sua campagna diretta a escludere le donne tedesche dal circolo femminile del martedì. Continuò durante tutta la cena. Dopo cena giocarono a carte, finché
Mamma non cominciò a sonnecchiare. L’indomani Mamma disse che si sentiva assai bene e voleva mettersi a sedere su una poltrona. Mary cercò di Papà al telefono per sentire se doveva permetterlo, ma dallo studio non ci fu risposta. Poi si ricordò di aver detto che sarebbe stata là alle nove e si precipitò in città. Vennero le undici e la stanza d’aspetto era piena, prima che entrasse Papà. Era evidente che veniva allora dal barbiere dove s’era fatto radere, ma appariva stracco morto. «Oh Papà, scommetto che non sei stato a letto.» «Ma certo, ho dormito un paio d’ore all’ospedale in una delle camere degli infermieri. Stanotte ci son morti due casi.» Tutta quella settimana Mary stette alla scrivania nella stanza d’aspetto dello studio di Papà, rispondendo al telefono attraverso la maschera di garza, ripetendo a uomini e donne atterriti e scottanti, che stavan seduti sentendosi i primi dolori nella schiena, sentendosi la febbre crescente avvampare le gote, di non temere, il dottor French sarebbe tornato subito. Alle cinque smetteva e tornava all’albergo a cenare ascoltando i discorsi di Mamma, ma il lavoro di Papà cominciava soltanto allora. Mary fece il possibile perché si prendesse il riposo del sonno almeno una notte su due. «Ma com’è possibile? McGuthrie è in letto e ho tutti i suoi da curare oltre i miei… Questa porca epidemia non può durare all’infinito… Appena smette un pochino, andremo sulla costa un paio di settimane. Sei contenta?» Aveva una secca tosse e un colore terreo sotto le occhiaie, ma insisteva che era in gamba e stava bene. La domenica mattina Mary arrivò in centro tardi perché aveva dovuto accompagnare Mamma in chiesa e trovò Papà appisolato aggobbito su una sedia. Quando lei entrò nello studio, saltò in piedi con un’aria colpevole e Mary s’accorse che aveva una faccia avvampata. «In chiesa, eh, siete state, tu e la mamma?» disse con una bizzarra voce raschiante. «Su, bisogna che mi metta al lavoro.» Mentre lui oltrepassava la porta col cappello floscio tirato giù sugli occhi, in mente a Mary passò come un lampo che forse Papà aveva bevuto. Non pareva ci fossero troppe visite quella domenica e allora Mary ritornò all’albergo in tempo per fare una passeggiata in macchina con la mamma nel pomeriggio. La signora French si sentiva assai bene e
parlava di come Mary avrebbe dovuto fare il suo début quell’autunno. «Dopo tutto, è un dovere che hai verso i tuoi genitori di tener alta la loro posizione, mia cara.» Discorsi simili davano a Mary un senso d’angoscia alla bocca dello stomaco. Quando furono di ritorno, disse ch’era stanca e si mise nel letto e lesse La teoria della classe agiata. Prima di uscire l’indomani mattina, scrisse una lettera alla signorina Addams dicendole dell’epidemia d’influenza e spiegandole che assolutamente non si sentiva di ritornare al collegio, con tanta miseria che c’era nel mondo; non potevano trovarle qualcosa da fare alla Hull House? Aveva bisogno di sentire che faceva qualcosa di reale. Sul tram che la portava al centro, si sentì pacata e felice di aver preso una decisione; in fondo alle vie poteva scorgere la catena delle montagne bianche come pezzi di zucchero nello splendido sole invernale. Desiderò di partire per una escursione con Joe Denny. Quando mise la chiave nella porta dello studio, il tanfo di etere, iodoformio e alcool di quel luogo la serrò alla gola. Cappello e soprabito di Papà erano appesi all’attaccapanni. Strano che non avesse notato la sua auto in strada. La vetrata smerigliata dello studio era chiusa. Mary vi bussò. «Papà» chiamò. Nessuno rispose. Spalancò la porta. Oh, dormiva. Era steso sul lettino con la coperta dell’automobile sulle ginocchia. Le traversò la mente il pensiero, che orrore se fosse ubriaco fradicio. In punta di piedi attraversò la stanza. La testa di Papà era ficcata tra il guanciale e la parete. La bocca gli si era aperta. Il viso, scabro di stoppia grigia, era contratto e strozzato, gli occhi aperti. Era morto. Mary si trovò che andava cheta al telefono e chiamava il pronto soccorso per avvertire che il dottor French aveva avuto un collasso. Era ancora seduta al telefono quando sentì fuori il campanello dell’ambulanza. Un infermiere in bianco entrò. Mary doveva essere svenuta, perché il suo ricordo successivo era che la portavano in una grossa auto al Broadmoor. Salì direttamente in camera sua e vi si chiuse a chiave. Si gettò sul letto e cominciò a piangere. A un certo momento nella notte chiamò al telefono la camera della madre. «Ti prego, Mamma, non voglio veder nessuno. Non voglio andare al funerale. Voglio ritornare subito al collegio.»
Mamma fece una tremenda scenata, ma Mary non ascoltò quel che diceva e alla fine l’indomani mattina Mamma le diede cento dollari e la lasciò partire. Mary non ricordava se aveva baciato o no sua madre lasciandola. Andò sola alla stazione e stette due ore seduta nella sala d’aspetto perché il treno per l’Est era in ritardo. Non provava nessun sentimento. Le pareva di vedere le cose insolitamente vivide, la splendente giornata invernale, le facce nette della gente seduta nella sala, i colori delle riviste nell’edicola. Venne il facchino a prenderla per il treno. Lei sedette nella carrozza pullman guardando fuori la neve, l’erba gialla, le sodaglie rosse, le siepi di fil di ferro, i recinti del bestiame lungo la via ferrata che sorgevano grigi e giallicci sulla neve, le cisterne dell’acqua, le stazioncine, i serbatoi del grano, gli inservienti rossi in faccia coi loro paraorecchi e guantoni. Di buon’ora al mattino attraversando il distretto industriale prima di Chicago, guardò fuori gli uomini, giovanotti, vecchi con i loro secchielli del pranzo, facce rubiconde e rattratte dal freddo mattutino, che affollavano le banchine in attesa di andare al lavoro. Mary li guardava in faccia attentamente, studiava quelle facce; era gente che si riprometteva di imparare a conoscere, perché andava a stare a Chicago e non sarebbe tornata in collegio. 1. L’autrice di Ramona. (NdT)
Occhio fotografico (45) la stretta camera gialla pullula di chiacchierio sotto il soffitto basso e serpeggianti spirali di sigaretta si attorcono azzurre e vaniscono sopra nasi dietro orecchie sotto gli orli dei cappellini di donne dall’aria saputa che ritoccano le labbra la spiovenza di una frangia quelle esperte rughette me-ne-intendo intorno agli occhi tutto sfregato lisciato rasato raschiato con l’aiuto del rossetto crema da barba lame di rasoio ridotto a un insieme che implica questa donna dalla voce calda che si muove innanzi e indietro con un riso di gola la testa gettata un po’ indietro a distribuire con sguardi provocanti le parti nel dramma delle cinque ciascuno la sua casella le caratteristiche devono accuratamente essere sovrapposte al viso per facilitare il riconoscimento appunta su ciascuno un distintivo oggi impegna domani Grazie ma perché io? Un impegno? Proprio buon giorno il vecchio cappello scuro afflosciato fedelmente sulla sedia accanto all’uscio afferrato con successo all’esterno svaniscono le tintinnanti voci alticce Greenwich Village le scale salgono e scendono portano a un corridoio disseminato di tabelle con nomi evocanti esistenze grovigli ignorati nella via a due marciapiedi piovosa dove carrozze sgusciano sfangando passi risuonano luci oblique rilucono sulla curva di una gota bagnata un paio di labbra fresche un collo segnato sudicio una lurida mano nodosa l’occhio sanguigno d’un vecchio via a due marciapiedi fino all’angolo del viale muggente dove nel saltellio della pioggia e il frastuono i quattro punti cardinali (il salso che è dentro di noi oceano il protoplasma pulsante entro cellule che crescono si sdoppiano germinano in miriadi differenti non ancor catalogate senza nome sempre sfuggono tra le dita le mutevoli le pullulanti esistenze)
girano vertiginosamente
Mary French Per diverse settimane, quando Mary French passava correndo accanto al quadro degli avvisi della Hull House, l’annuncio d’una conferenza le aveva fermato lo sguardo: 15 maggio G.H. Barrow, Europa: “I problemi della ricostruzione postbellica”. Quel nome le stuzzicava la memoria, ma fu soltanto quando lo vide in carne ed ossa entrare nella sala, che riconobbe il simpatico e sparuto conferenziere rosso in viso che quel lontano inverno, a Vassar, aveva spiegato come il paese non sarebbe entrato in guerra grazie alla classe lavoratrice. Era la stessa voce esitante e sincera con un po’ di balbuzie di tanto in tanto all’inizio delle frasi, lo stesso modo alla buona di misurare a grandi passi la sala e sedersi al tavolino presso il boccale dell’acqua con le gambe incrociate. Al ricevimento che seguì, Mary non lasciò trapelare di averlo già conosciuto prima. Quando furon presentati, lei fu felice di essere in grado di fornirgli certe informazioni che gli occorrevano sulla possibilità che i congedati avevano di trovar lavoro sulla piazza di Chicago. L’indomani mattina Mary French fu tutta in agitazione quando domandarono di lei al telefono e sentì la voce del signor Barrow che le chiedeva di sprecare un’ora per lui quel pomeriggio dato che l’avevano richiesto da Washington di fornire informazioni confidenziali per un certo dicastero. «Voi capite, ho pensato che sareste stata in grado di dirmi le cose come stanno, visto che siete in contatto quotidiano col vero popolo.» Mary disse che non chiedeva di meglio e fu pregata di trovarsi nel salone dell’Auditorium alle cinque. Alle quattro era in camera sua che si arricciava i capelli, chiedendosi che abito avrebbe indossato, cercando di decidere se doveva andare con gli occhiali o senza. Il signor Barrow era così simpatico. Ebbero una conversazione assai interessante sulla situazione degli impieghi, che non riuscì affatto un quadro troppo luminoso, e quando il signor Barrow la invitò a cena con lui in un piccolo locale italiano che conosceva nel centro, Mary si trovò a dir di sì, senza un tremito, sebbene non fosse stata a cena con un uomo da quando era partita da Colorado Springs dopo la morte di suo padre, tre anni prima. Le
pareva in qualche modo di conoscere il signor Barrow da anni. Pure fu un tantino sorpresa all’aspetto equivoco, con segatura sul pavimento, del luogo dove la condusse, e che spacciassero liquori e che il signor Barrow paresse convinto che lei avrebbe preso un cocktail. Lui ne buttò giù parecchi e ordinò vino rosso. Mary rifiutò i cocktail, ma sorseggiò un po’ di vino per non aver l’aria troppo all’antica. «Ammetto» disse lui «di aver raggiunto l’età in cui mi occorre un bicchiere per sgombrarmi il capo dalla fatica e rilassarmi un po’… Questo era il grande dell’altra sponda… bere vino a pasto… Davvero comprendono l’arte di vivere, laggiù.» Mangiati gli spumoni, il signor Barrow ordinò per sé acquavite e Mary bevve l’amaro caffè nero e rimasero a sedere nella mal ventilata e strepitante trattoria piena d’odori d’aglio e di vino acido e di salsa di pomodoro e di segatura; si dimenticarono dell’ora e chiacchierarono. Mary disse d’essersi data al lavoro sociale per tenersi a contatto con qualcosa di reale, ma che ora cominciava a sentirsi ingabbiata e così istituzionale che sovente si domandava se non avrebbe fatto meglio ad arruolarsi nella Croce Rossa oltreoceano o nella Friends Reconstruction Unit come tante altre ragazze, solo che odiava talmente la guerra che non voleva far nulla che vi contribuisse nemmeno nel modo più pacifico. Se fosse stata un uomo sarebbe stata un C.O., 1 ne era sicura. Il signor Barrow s’accigliò e si schiarì la gola: «Va da sé ch’era gente in buona fede, ma hanno fatto un grande sbaglio e probabilmente si meritavano quel che loro toccò». «E ancora lo credete?» «Sì, cara signorina, io… Ora tutto possiamo domandare; nessuno ci può rispondere di no: salari, chiusura di esercizio, le otto ore. Ma è stato duro dissentire dai vecchi amici… il mio atteggiamento è stato molto malcompreso in certi ambienti…» «Ma non potete credere che fosse giusto condannarli a tutti quegli anni.» «È soltanto per spaventare gli altri… Vedrete che usciranno appena l’agitazione si sarà chetata… Di giorno in giorno, si attende il condono per Debs.» «Voglio sperare» disse Mary.
«Povero Debs,» disse il signor Barrow «un solo sbaglio ha distrutto l’opera di tutta una vita, ma è un grande cuore, il più grande cuore vivente.» E allora passò a raccontarle come era stato anche lui ferroviere, ai bei tempi, inserviente merci nella South Chicago; l’avevano fatto segretario amministrativo della sua sezione e aveva lavorato per la confraternita, aveva dovuto sudare a farsi un’educazione e d’un tratto s’era accorto – aveva più di trent’anni e si trovava a New York scrivendo una serie di articoli per l’«Evening Globe» – che nella sua vita non c’era nemmeno una donna e lui non sapeva nulla dell’arte di vivere e di quelle cose che parevano venir naturali alla gente oltreoceano e adesso anche ai messicani. Si era sposato poco giudiziosamente e messo nei pasticci con una ballerina, e una donna gli aveva reso la vita un inferno per cinque anni, ma ora che di tutto ciò s’era liberato si trovava solo a invecchiare e desiderava qualcosa di più sostanziale che non fossero le piccole conquiste di un uomo che viaggia in missione nel Messico, in Italia, in Francia, in Inghilterra, piccoli incidenti internazionali – diceva con un sorriso a labbra tese –, avventure gradite certo, finché duravano, ma polvere e cenere in conclusione. Andava da sé che non credeva nella morale borghese, ma gli occorreva la comprensione e l’amicizia appassionata di una donna. Mentre parlava, mostrava ogni tanto la punta della lingua per il largo vuoto al centro della gengiva superiore. Mary gli leggeva negli occhi quanto aveva sofferto. «Certo, neanch’io credo nel matrimonio convenzionale» disse Mary. E allora il signor Barrow intonò che lei era così fresca così giovane così fervida così adorabile così quel che ci voleva per lui e le sue parole cominciarono a imbrogliarsi e Mary azzardò ch’era tempo di ritornare alla Hull House poiché doveva alzarsi tanto presto. Quando la ricondusse in tassì, lei sedette nell’angolo più discosto ma il signor Barrow fu molto educato, benché paresse vacillare un poco quando si salutarono. Dopo quella cena il lavoro nella Hull House divenne sempre più una corvè, specialmente considerando che George Barrow, occupato a un giro di conferenze in tutto il paese in difesa della politica presidenziale, le scriveva diverse volte alla settimana. Mary gli
rispondeva con lettere facete, dove scherzava sulle vecchie zitelle della Hull House e diceva di sentirsi nelle ossa che ben presto si sarebbe laureata là dentro, a quel modo che s’era laureata da Vassar. Le sue amiche della Hull House cominciavano a osservare come diventava graziosa ora che si arricciava i capelli. Per le ferie a giugno Mary French aveva pensato di andare nel Michigan con i Cohn, ma quando venne l’ora decise che doveva rompere una buona volta; e così andò a Cleveland sul Northland e si trovò un posto di cassiera nella Cafeteria Eureka in Lakeside Avenue vicino alla stazione. Era un lavoro duro. Il principale era un grasso greco che pizzicava le ragazze, passando dietro il banco. Le ragazze usavano belletto e rossetto e trattavano male Mary, ridendosela negli angoli sui loro appuntamenti o scambiando scherzi osceni con gli autisti. La notte, sentiva fitte lancinanti al collo del piede per essere stata tanto tempo ritta e le girava la testa per tutte le facce le bocche spalancate gli occhi indaganti che le turbinavano innanzi nelle ore di piena, come grani su un filo. Di ritorno sul cigolante letto d’ottone nella gran pensione gialla, dove l’aveva indirizzata una ragazza a cui s’era rivolta sul battello, non riusciva a prender sonno o cavarsi dal naso il sentore di sugna fredda e di rigovernatura; stava stesa, sgomenta e solitaria, in ascolto degli altri pensionanti che si agitavano dietro le sottili pareti, scalpitavano alla volta del bagno, sbattevano gli usci nel corridoio. Dopo due settimane di lavoro in quel locale, Mary decise che non poteva resistere un minuto di più, e così lasciò il posto e andò a cercarsi una camera all’YWCA in periferia, dove la trattarono molto gentilmente quando sentirono che veniva dalla Hull House e le mostrarono un elenco di attività sociali in cui poteva provare a occuparsi, ma lei disse «No»; voleva una volta tanto fare un vero lavoro nell’industria, e prese il treno per Pittsburgh, dove conosceva una ragazza aiuto bibliotecaria nell’istituto Carnegie. Giunse a Pittsburgh verso la fine di un pomeriggio d’estate. Traversando il ponte vide come in un lampo il sole orizzontale accendere fiamme rosee e arancione su un groviglio di fumacchi grigio ferro che esalavano da una desolazione di comignoli disposti
intorno alle enormi opere di lamiera ondulata e travature sulla riva del fiume. Poi ecco che usciva dal carrozzone nella fosca bruna penombra della stazione con la valigia che le tagliava la palma della mano. Telefonò all’amica da una sudicia cabina che sapeva di fumo di sigaro. «Mary French, che sorpresa!» rispose la comica voce gorgogliante di Lois Speyer. «Vi fisserò una camera qui dalla signora Gansemeyer, veniteci a pranzo. È una pensione. Aspettate di averla veduta… Ma proprio non mi capacito che una venga a Pittsburgh a passar le ferie.» Mary si accorse di arrossire e innervosirsi là nella cabina. «Volevo vedere il mondo diversamente che dall’angolo del servizio sociale.» «Bene, è così piacevole la prospettiva di aver qualcuno con cui parlare che spero ciò non significhi che avete perduto la testa… sapete bene che non usa d’impiegare laureate di Vassar negli altiforni.» «Non sono una laureata di Vassar» strillò Mary French nel ricevitore, sentendosi quasi le lacrime bruciare negli occhi. «Sono una lavoratrice come le altre… Avreste dovuto vedermi lavorare in quella cafeteria di Cleveland.» «Bene, venite, cara Mary, vi metterò da parte un po’ di cena.» Fu lunga la corsa nel tranvai. Pittsburgh era ben tetra. L’indomani girò per gli uffici personale di parecchie compagnie dell’acciaio. Quando diceva che aveva fatto lavoro sociale, la guardavano in un modo assai curioso. Niente da fare; non si assumevano per il momento scritturali o segretari. Passò giornate fra le gazzette rispondendo agli avvisi di “Cercasi”. Certo Lois Speyer rise, con quella sua faccia lunga e sarcastica, quando Mary dovette accettare un posto di cronista che Lois le aveva trovato perché conosceva l’incaricata della colonna mondana sul «Times-Sentinel». Mentre l’estate di Pittsburgh s’avvicinava lenta al mese d’agosto, calda e irrespirabile per il gas di carbone e le fumate soffocanti dei forni a riverbero, fonderie e laminatoi, che stagnavano sulla fumosa Y in cui s’univano le strette convalli del fiume, all’ufficio si cominciò a parlare di come nelle fabbriche s’erano introdotti agitatori rossi. Un certo signor Gorman, che si diceva fosse uno dei dirigenti dello
Sherman Service, si fece spesso vedere a fumare un sigaro nell’ufficio del direttore. Il giornale cominciò a empirsi delle notizie di tumulti fra stranieri, e i bolscevichi russi e la nazionalizzazione delle donne e la disfatta di Lenin e Trockij. Poi un pomeriggio ai primi di settembre il signor Healy chiamò Mary French nel suo ufficio privato e la invitò a sedere. Si alzò in piedi e andò a chiuder bene la porta e Mary pensò per un attimo che stesse per farle proposte oscene, ma quello disse invece nel suo tono più straccamente paterno: «Dunque, signorina French, ho un incarico per voi che vi prego di non assumervi a meno che proprio vogliate. Ho anch’io una figlia e spero, quando sia cresciuta, che sarà anche lei una ragazza distinta, semplice e beneducata, come voi siete. Sul serio, quindi, se la stimassi una cosa disonorevole non vi proporrei di farla… sapete questo… Il nostro è strettamente il giornale delle famiglie… le cose sgradevoli le lasciamo agli altri… Sapete che un articolo non mi passa mai sulla scrivania senza ch’io pensi a mia moglie e alle mie figlie, se potrei tollerare che lo leggessero anch’esse.» Ted Healy era un individuo grosso, rotondo, capelli neri e bigi occhi roteanti, come quelli d’un merluzzo. «Spiegatevi, signor Healy» disse Mary vivamente; si era cacciata in testa che fosse qualcosa sulla tratta delle bianche. «Ecco, quei maledetti agitatori, sapete che cercano di metter su uno sciopero… Ebbene, hanno aperto un ufficio di pubblicità nel centro. Ho paura a mandarci qualcuno degli uomini… potrebbero nascere dei guai con quei gorilla… Non mi occorre “la morte di un cronista” in prima pagina… Invece mandando voi… ecco che voi non lavorate per un giornale, ma siete una lavoratrice sociale, volete sentire le due campane… una ragazza carina come voi, dall’aria innocente, non può capitar male… Insomma, mi occorrono rivelazioni sulla gente che opera laggiù… in che regione della Russia sono nati, come son riusciti a ficcarsi in questo paese prima di tutto… di dove vengono i soldi… le fedine penali, sapete… Raccogliete tutto il materiale che potete. Farò una stupenda edizione festiva.» «M’interessano molto le relazioni industriali… è un incarico magnifico… Ma, signor Healy, non vi pare che le condizioni di vita siano piuttosto cattive, alle fabbriche?»
Il signor Healy balzò in piedi e camminò a grandi passi avanti e indietro per l’ufficio. «Su questo ho tutto il materiale… Quei luridi emigrati guadagnano come non han mai guadagnato in tutta la vita, comprano azioni, comprano macchine da lavare e calze di seta per le loro donne e mandavano denari a casa ai vecchi. Mentre i nostri ragazzi esponevano la pelle nelle trincee, loro occupavano tutti gli impieghi migliori e la maggior parte poi sono anche stranieri nostri nemici. Questi emigrati stanno bene, non dimenticatevelo. La sola cosa che non possono comprare è un po’ di sale in zucca. È così che questi agitatori li accalappiano. Parlano il loro linguaggio e li rimpinzano di un sacco d’idee come qualmente tutto quanto loro occorre è di smettere di lavorare e poi potranno prendere possesso di questo paese che, grazie a noi, è diventato il più grande del mondo… Non ce l’ho con quei poveretti di emigrati, io: non sono che ignoranti, ma quei rossi che accettano l’ospitalità del nostro paese e poi vanno in giro diffondendo la loro diabolica propaganda… Santo Cielo, se fossero in buona fede, li potrei anche scusare, ma no, quelli lo fanno per i soldi, come tutti. Abbiamo prove irrefutabili che sono pagati dai rossi di Russia coi quattrini e i gioielli rubati lassù; e non sono ancora contenti, vanno in giro spogliando questi poveri ignoranti di emigrati… Ecco, dico che fucilarli sarebbe troppo poco.» Ted Healy era rosso in faccia. Un ragazzo dalla visiera verde irruppe nella stanza con un grosso mazzo di copie. Mary French si alzò. «Mi metto subito all’opera, signor Healy» disse. Scese dalla macchina sbagliando l’incrocio e camminò inciampando per lo scabro acciottolato di una ripida e larga via di negozietti di giocattoli, sale biliardo, barbieri e spacci di spaghetti. Un vento impetuoso mulinava polvere, trucioli d’imballaggio e vecchi giornali. Davanti a una porta senza vernice uomini dall’aria straniera parlottavano a voce bassa, in crocchi di tre o quattro. Prima di prendere il coraggio a due mani e salire la scala lunga, erta, stretta e sudicia, Mary guardò per un momento la vetrina del fotografo sottostante, i ritinti ingrandimenti di bambini dalle guance troppo rosee e i gruppi di famiglia e le coppie nuziali piantate come scope. Fatta la scala, si arrestò nel corridoio ingombro di rifiuti. Dagli uffici ai
due lati veniva un frastuono di macchine da scrivere e di voci in discussione. Nel buio si scontrò con un giovanotto. «Salute,» quello disse con una voce brusca che le piacque «siete voi la signora di New York?» «Non proprio. Io sono del Colorado.» «C’era una signora di New York che doveva venirci ad aiutare con un po’ di pubblicità. Credevo foste voi.» «Anch’io sono venuta per questo.» «Entrate, io mi chiamo Gus Moscowski. Sono come chi dicesse il fattorino.» Le aprì una delle porte chiuse che portava in un piccolo ufficio polveroso, ingombro di giornali accatastati e riempito di un tavolone ricoperto di ritagli, a cui sedevano in maniche di camicia due giovanotti dagli occhiali. «Ecco i giornalisti in persona.» Per tutto il tempo che parlò con gli altri, Mary non riusciva a staccargli gli occhi di dosso. Aveva capelli biondi e rasi, occhi azzurrissimi e un’aria di grosso orsacchiotto con quel comune abito di sergia lustro ai gomiti e alle ginocchia. I giovanotti rispondevano alle sue domande con tanta cortesia che Mary non poté tenersi dal dir loro che cercava di mettere insieme un articolo festivo per il «Times-Sentinel». Quelli risero da staccarsi le mascelle. «Ma il signor Healy diceva che gli occorreva un quadro imparziale. Crede appunto che questa gente sia fuorviata.» Anche lei si mise a ridere. «Gus,» disse il più anziano dei due «conducete questa signorina un po’ attorno e fatele vedere qualcosa… Dopo tutto può darsi che Ted Healy abbia perduto la testa. Anzitutto ecco qui ciò che gli amici di Ted Healy hanno fatto a Fanny Sellers.» Mary non riuscì a guardare la fotografia che il giovanotto le tese sotto il naso. «Ma che cosa aveva fatto?» «Tentato di organizzare la classe lavoratrice, il peggior delitto che possiate commettere in questo paese.» Fu un sollievo ritrovarsi nella via, camminando in fretta, mentre Gus Moscowski ghignando le veniva pesantemente a fianco. «Dunque, credo sarà meglio che cominci a mostrarvi come la gente vive a quarantadue cents l’ora. Peccato non parliate polacco. Io sono polacco.» «Siete nato in America, però.» «Certo. Diploma di scuola media. Se troverò i soldi, prenderò ingegneria al tecnico Carnegie…
Non lo so perché perda il tempo con questi maledetti polacchi.» La guardò dritto in viso e rise dicendo l’ultima frase. Mary gli rispose con un sorriso. «Io capisco perché» disse. Gus Moscowski fece un gesto col gomito mentre giravano un angolo accanto a un gruppo di monelli cenciosi che pasticciavano nel fango; erano ragazzetti smorti, flosci, sudici, con le borse sotto gli occhi. Mary torse gli occhi da un’altra parte, ma li aveva veduti, come aveva veduto la fotografia della donna morta con la testa bucata. «Dare un’occhiata al quartiere dei cessi, terra dell’avvenire» disse Gus in fondo alla gola. Quella sera, quando scese dal tram sull’angolo più vicino alla pensione, le tremavano le gambe e le doleva il fondo della schiena. Salì difilato nella sua camera e si cacciò in letto. Era troppo stanca per mangiare qualcosa o trattenersi ad ascoltare le lunghe ciarle sarcastiche di Lois Speyer. Non poté dormire. Giacque sul letto incavato tendendo l’orecchio alle voci dei pensionanti seduti a dondolarsi sotto il porticato e al sibilo delle vaporiere e allo schianto dei carri merci smistati giù nella valle, rivedendo ancora le scarpe rotte e informi, le mani consunte ripiegate sui grembiuli sudici, e il luccichio pronto e ansioso negli occhi delle donne, risentendo sotto i piedi il barcollio delle decrepite scale serpeggianti su e giù per le colline nere e brulle come rosticci, dove i siderurgici vivevano in un catafascio di baracche e grosse file nere di case assicellate rose dal fumo: pieno il naso del puzzo delle traballanti tettoie e cucine dove cuocevano cavoli e bolliva il bucato e asciugavano pezze e pullulavano i bimbi sporchi. Dormiva a scatti e sussulti e si svegliava risentendo la brusca e tiepida voce di Gus Moscowski; e tutto il corpo le fremeva al senso d’un solido contatto con la pelurie di un orsacchiotto quando quel braccio sfiorava il suo o Gus tendeva la manona per tenerla ritta in un punto dove s’era rotto il tavolato e lei scivolava sul facile sdrucciolo schistoso sottostante. Quando s’addormentò del tutto continuò a sognare di lui. Si svegliò di buon mattino, felice poiché l’avrebbe riveduto subito dopo colazione. Quel pomeriggio ritornò all’ufficio per scrivere l’articolo. A quel modo che Ted Healy le aveva detto, vi mise dentro tutto quanto le venne fatto di sapere su quei ragazzi dell’ufficio di pubblicità. Il più
russo di tutti non veniva da più lontano di Canarsie, Long Island. Mary cercò di far sentire le due campane, li chiamò persino «illusi forse». Circa un minuto dopo che l’ebbe mandato al redattore festivo, la chiamarono al tavolo della cronaca. Ted Healy aveva la visiera verde e stava curvo su un vortice di bozze. Mary poté vedere il suo scritto in cima a un mucchio di carte che gli stavano sotto il gomito. Qualcuno vi aveva scarabocchiato sopra a matita rossa: E perché proprio a me? «Dunque, cara signorina,» disse Ted Healy senza levare gli occhi «avete scritto un articolo di propaganda coi fiocchi per la “Nation” o quale altro giornaletto salottiero di New York vogliate, ma che accidenti credete che noi ne possiamo fare? Siamo a Pittsburgh qui.» Si alzò in piedi e tese la mano. «State bene, signorina French, vorrei aver modo di adoperarvi, perché siete una ragazza niente stupida… e le croniste niente stupide sono rare… Ho mandato il vostro conto giù alla cassa…» E prima che avesse ripreso il fiato, si trovò sul marciapiede con l’indennità di una settimana in tasca, ciò che, tutto sommato, era assai generoso da parte del vecchio Ted Healy. Quella sera Lois Speyer fu sbigottita quando Mary le disse del suo licenziamento, ma quando le aggiunse che aveva accettato un posto di agente di pubblicità per l’«Amalgamated» Lois scoppiò in lacrime. «Lo dicevo che avevi perduto la testa; è proprio vero… Una di noi due deve cambiare pensione… e non potrò più uscire con te come ho fatto sinora.» «Ma è una cosa ridicola, Lois.» «Cara, tu non conosci Pittsburgh. Io me ne infischio di questi straccioni di scioperanti, ma bisogna assolutamente che conservi il mio posto… Sai anche tu che debbo mandarne a casa… Oh, proprio adesso che si cominciava a divertirsi, tu dovevi guastare ogni cosa.» «Se avessi veduto tu quel che ho visto io, non parleresti così» disse Mary French freddamente. Da quella volta non furono mai più buone amiche. Gus Moscowski le trovò una stanza dalle pesanti tendine di pizzo in casa di un bottegaio polacco cugino di suo padre. Qui si mise a scortarla solennemente la sera dall’ufficio quando facevan tardi, e facevan tardi sempre.
Mary French non aveva mai lavorato tanto in vita sua. Scriveva resoconti, compilava statistiche sulla tubercolosi, sulla denutrizione infantile, sulle condizioni sanitarie, sulla criminalità, fece corse in tranvie interurbane o locali lentissime a Rankin, Braddock, Homestead e Bessemer e giunse fino a Youngstown, Steubenville e Gary, prese appunti ai discorsi di Foster e Fitzpatrick, vide comizi sciolti con la forza e i poliziotti a cavallo nelle uniformi grigioscure muoversi in fila giù per i vicoli disselciati dei terreni delle compagnie, picchiando uomini e donne con le mazze, togliendosi d’innanzi a calci i bambini, scacciando i vecchi dai pianerottoli delle case. «E pensare» diceva dei poliziotti Gus «che quei porci sono quasi tutti sporchi polacchi anche loro. Non è una cosa da polacchi, questa?» Mary intervistò giornalisti metropolitani, impiegò ore a cercar di convincere impiegati dell’A.P. e soci dell’U.P. 2 a mandare i resoconti che ci volevano, ripulì la grammatica nei manifestini scritti in inglese. L’autunno volò prima che lei se ne accorgesse. L’«Amalgamated» non poteva pagarle che le spese più necessarie: aveva gli abiti in uno stato orribile, nei capelli non più un ricciolo, di notte non dormiva per il ricordo di ciò che aveva veduto, gl’incarceramenti, le teste sporche di sangue, la distruzione di un salottino familiare, il divano sventrato, le sedie sfracellate, la credenza frantumata a colpi d’accetta, dopo una visita dei poliziotti in cerca di “letteratura”. Mary appena più si riconosceva guardandosi il viso nello specchio verdastro dalla cornice dorata sopra la catinella, mentre al mattino si vestiva in fretta e furia. Aveva un’aria selvaggia e disperata. Cominciava a parere anche lei una scioperante. Appena più si riconosceva, inoltre, quando la voce di Gus le dava brividi freddi o, secondo il numero di volte che lui le sorrideva parlando, si sentiva quel giorno più o meno bene; né era da lei quel modo di mettersi, ogni volta che per un istante non aveva niente da pensare, a immaginare che Gus le venisse vicino e le gettasse addosso le braccia, le labbra, le mani grosse e dure. Quando la prendeva questo stato, bisognava che chiudesse gli occhi e le pareva di barcollare dal capogiro. Allora con uno sforzo apriva gli occhi e si buttava alla macchina da scrivere e dopo un po’ tornava a sentirsi calma e
sgombra. Il giorno che Mary French ammise a se stessa per la prima volta che i lavoratori dall’alto salario non avrebbero lasciato il lavoro e quelli dal salario basso avrebbero così perduto lo sciopero, osò appena di guardare Gus in faccia quando lui passò a prenderla per ricondurla. Era un’insolitamente pesante e piovigginosa notte di novembre. Mentre camminavano per la via senza parlare, la foschia a un tratto avvampò rossa in direzione delle fabbriche. «Eccoli che vanno» disse Gus. La vampa cresceva sempre più, dapprima rosea poi arancione. Mary annuì e non disse nulla. «Che volete farci, se i lavoratori non si stringono insieme. Ogni porco straniero pensa che l’altro è uno straccione e gli americani poi pensano che tutti sono straccioni eccetto te e me. Non è molto tempo che eravamo tutti stranieri in questo paesaccio. Perdio, non so perché perda il tempo con loro.» «Gus, se perdessimo lo sciopero che fareste? Voglio dire, voi come voi.» «Sarò senz’altro sul libro nero. Ciò vuol dire che non troverò più lavoro nelle metallurgiche neanche se fossi l’unico uomo al mondo… Non so proprio. Prenderò un falso nome e forse entrerò in marina. Dicono che ci si può fare un’eccellente cultura in marina.» «Non dovremmo parlare di queste cose… Io non so quel che farò.» «Voi potrete andare dove vorrete e trovare un posto in qualche giornale come prima… Vorrei averlo io il vostro studio… Chi sa come sarete contenta di liberarvi da questa banda di straccioni.» «Sono i lavoratori, Gus.» «Sì, solo che ci facessimo più furbi, testoni che siamo… Sapete che ho un fratello che fin oggi ha fatto il crumiro.» «Forse avrà da pensare alla moglie e alla famiglia.» «Gli darò io da pensare se gli metterò mai le mani addosso. Un lavoratore non ha il diritto di farsi moglie e famiglia.» «Può darsi abbia una ragazza…» La voce le venne meno. Si sentì il cuore pulsare talmente, mentre gli camminava accanto sul lastrico scabro, che ebbe paura lui lo udisse. «Di ragazze ce n’è un fottio.» Gus rise. «Libere e facili, sono ragazze polacche. Quest’è ancora una consolazione.»
«Vorrei…» Mary sentì dire alla propria voce. «Buona notte, allora. Riposatevi, sembrate morta.» Le aveva dato una pacca sulla spalla e s’era girato incamminandosi pesantemente col suo lungo passo. Mary era sull’uscio di casa. Quando fu nella sua stanza, si buttò sul letto e pianse. Fu parecchie settimane più tardi che Gus Moscowski venne arrestato mentre distribuiva manifestini a Braddock. Mary lo vide portare davanti al magistrato, nella sudicia aula ammassata delle grigie uniformi dei poliziotti, e condannare a cinque anni. Aveva il braccio al collo e gli si vedeva una crosta di sangue raggrumato sul pelo stopposo della nuca. Gli occhi azzurri incontrarono i suoi nella folla: sorrise e le mandò un geniale cenno con la grossa mano. «Ah è così che stan le cose, eh?» una voce accanto ringhiò. «Be’, adesso l’hai finita con quel marmocchio.» Si vide un massiccio poliziotto grigio per fianco. La spinsero a gomitate fuori dell’aula e marciarono con lei fino alla fermata dell’interurbana. Mary non diceva nulla, ma non poteva trattenere le lacrime. Non aveva mai immaginato che gli uomini potessero parlare così a una donna. «Senti qua, molla, io e Steve ne facciamo due di… Fatti più furba invece di metterti in piazza 3 per quel lavativo.» Finalmente il tram di Pittsburgh giunse e i due la spinsero su, avvertendola che se mai la ripescavano da quelle parti l’avrebbero arrestata per cattivi costumi. Mentre il tram ripartiva, li vide muoversi per andarsene, picchiandosi a vicenda sulla schiena e ridendo. Sedette tutta raggomitolata nel posto in fondo alla vettura, con lo stomaco sconvolto e il viso fisso. Tornata all’ufficio, tutto quanto disse fu che i cosacchi l’avevano scacciata dall’aula del tribunale. Quando sentì che George Barrow era in città con la commissione senatoriale d’inchiesta, andò subito da lui. Lo attese nel salone dello Schenley. La tranquilla sera invernale era un solo ammasso di rigido freddo nerastro. Mary batteva i denti nel suo leggero soprabito. Era stanca morta. Le parevano settimane che non dormiva. Faceva caldo nel gran salone tranquillo dell’albergo, e attraverso le sottili suole avvertiva il pelo spesso del tappeto. Ci doveva essere una riunione di bridge in qualche parte dell’albergo, perché continuavano a passare
nel salone gruppi di eleganti signore anziane che le ricordavano sua madre. Mary si lasciò cadere in una profonda poltrona presso il termosifone e subito cominciò ad assopirsi. «Povera piccola, vedo che avete lavorato molto… E non più nel servizio sociale, scommetto.» Mary aprì gli occhi. George indossava un soprabito foderato di pelliccia con un colletto di pelliccia, dal quale il collo sottile e la lunga faccia nocchiuta sporgevano comicamente come la testa di un marabù. Si alzò in piedi. «Oh, signor Barrow… voglio dire, George.» Lui le prese nella sinistra la mano e vi batté sopra lieve con la destra. «Adesso so cosa sono le trincee della prima linea» disse Mary, ridendo al suo comico aspetto di cortesia. «Ridete della mia pelliccia… Non mi aiuterebbe per nulla l’“Amalgamated” se mi prendessi la polmonite, no?… E perché voi non avete un soprabito caldo?… Cara piccola Mary French… Esattamente colei che contavo di vedere… Vi dispiace salire in camera mia? Non mi piace discorrere qui, ci sono troppe orecchie.» Disopra, nella calda camera quadrata, dalle tappezzerie e lampade rosee, George l’aiutò a levarsi il soprabito. Rimase dritto, accigliandosi e pesando l’indumento con la mano. «Bisogna che mettiate un soprabito caldo» disse. Una volta ordinato per lei il tè al cameriere, lasciò piuttosto ostentatamente aperta la porta del corridoio. Si accomodarono ai due lati di un tavolino, ai piedi del letto, tutto ingombro di giornali e di dattiloscritti. «Bene, bene, bene» disse. «È davvero una grande gioia per un vecchio brontolone come me. Che direste di pranzare col senatore?… Tanto per vedere come vive l’altra metà.» Chiacchierarono a lungo. Di tanto in tanto lui le vuotava di soppiatto un po’ di whisky nel tè. Fu molto cortese, le disse di esser certo che tutti quei ragazzi sarebbero usciti di prigione appena lo sciopero fosse sistemato e che virtualmente era già sistemato. Veniva allora da Youngstown dove aveva parlato con Fitzpatrick. Pensava di averlo ormai quasi convinto che la sola cosa a farsi era di indurre gli uomini a ritornare al lavoro. Aveva l’assicurazione personale del giudice Gary che non si sarebbero fatti torti a nessuno e che gli esperti stavan già lavorando al problema della giornata di otto ore. Appena si
fossero superate le difficoltà tecniche, l’intero quadro della vita dei siderurgici sarebbe radicalmente mutato in meglio. A questo punto offrì uno stipendio a Mary French come sua segretaria. Disse che l’attuale esperienza di lei, Mary, sulle condizioni dei lavoratori sarebbe stata preziosissima per influire sulla legislazione. Se il grande sforzo dei siderurgici sinora sfruttati non doveva andare perduto, bisognava incorporarlo nella legislazione. Il teatro della lotta si spostava a Washington. Sentiva che i tempi in Senato erano maturi. Mary rispose che il suo più immediato dovere era verso il comitato di sciopero. «Ma mia cara, cara bambina,» disse George Barrow, battendole lieve sul dorso della mano «fra qualche giorno non ci sarà più nessun comitato di sciopero.» Il senatore era un meridionale dai capelli grigioferro e ghette bianche, che fissò Mary French entrando nella stanza, come se le attribuisse in cuor suo l’intenzione di ficcargli una bomba sotto la vasta rotondità del panciotto color crema, ma le sue paterne, rispettose, delicate e cavalleresche maniere furono blande. Ordinarono di apparecchiare il pranzo nella stanza di George. Il senatore canzonava George in un florido e pesante linguaggio sulle sue pericolose amicizie bolsceviche. Avevano mandato giù una certa quantità di rye e l’atmosfera fumosa della stanza era ricca di whisky. Quando Mary li lasciò per tornare all’ufficio, quelli stavano parlando di regalarsi una seduta di burlesque. 4 Quelli dell’ufficio avevano un’aria truce e amareggiata. Quando riferì loro dell’offerta di G.H. Barrow, le dissero di accettarla al volo; sarebbe stata certo una magnifica occasione averci lei che lavorava a Washington e d’altra parte non erano più in grado di pagarle nemmeno le spese. Mary terminò il suo resoconto e di pessimo umore augurò a tutti la buona notte. Quella notte dormì meglio che non le riuscisse da settimane, benché l’avessero ossessionata per tutta la strada gli occhi azzuri di Gus Moscowski e i suoi capelli biondi con quel sangue raggrumato sopra e il geniale sorriso di quando aveva incontrato i suoi occhi nell’aula. Aveva deciso che il modo migliore di far uscire di prigione i compagni era di andare a Washington con George.
L’indomani mattina per prima cosa George le telefonò all’ufficio e le chiese se dunque accettava il posto. Mary disse di sì. Lui chiese se andavano bene cinquanta settimanali; forse in seguito avrebbe potuto arrivare a settantacinque. Mary disse che non aveva mai guadagnato tanto in vita sua. Lui le disse che la voleva subito allo Schenley; aveva qualcosa di importante da farle fare. Quando Mary giunse, le venne incontro nel salone con un biglietto da cento in mano. «La prima cosa che vi chiedo, cara ragazza, è che andiate a comprarvi un soprabito pesante. Ecco l’anticipo di due settimane… Non mi servireste a gran cosa come segretaria, se vi lasciaste morire di polmonite il primo giorno.» Nella vettura salotto del treno per Washington le porse due valigione nere piene di documentazioni. «Non crediate nemmeno un istante che il vostro posto sia una sinecura» disse pescando le buste di manilla, l’una dopo l’altra, piene di appunti stenografici, o dattilografati fittamente su carta velina. «Quell’altra occupazione era più romantica» disse temperando una matita «ma questa, considerata alla lunga, è più utile.» «Chi sa» disse Mary. «Cara Mary, voi siete molto giovane… e molto cara.» S’appoggiò all’indietro nella sua poltrona di felpa verde, guardandola a lungo con i suoi occhi prominenti, mentre fuori sfilavano i colli nevosi screziati di verdi rupi lichenose e ricamati in nero dai rami brulli delle piante. Poi disse in fretta se non sarebbe stato divertente sposarsi giungendo a Washington. Mary scosse il capo e ritornò al problema della difesa degli scioperanti, ma non poté fare a meno di sorridergli quando gli disse che per il momento non aveva ancora idea di sposarsi; l’aveva trattata con tanta bontà. Sentiva ch’era un vero amico. A Washington si aggiustò un alloggetto sito a H Street, che le era subaffittato a buon prezzo da certi funzionari democratici che traslocavano. Sovente vi preparò la cena per George. Prima d’allora non aveva mai fatto cucina se non di campeggio, ma George era un intenditore e sapeva preparare gli spaghetti italiani e il chiliconcarne e la salsa d’ostriche e vera bouillabaisse francese. Aveva il vino dall’ambasciata romena e facevano insieme cenette molto intime,
dopo il lungo lavoro quotidiano dell’ufficio. George non smetteva mai di parlare dell’amore e dell’importanza di una sana vita sessuale per uomini e donne, tanto che alla fine Mary si diede. Fu così tenero e gentile che per poco credette di amarlo davvero. Dormire con un uomo non fece quella gran differenza di vita che si era immaginata. Il giorno dopo l’inaugurazione di Harding, due individui male in arnese, dagli informi berretti grigi, vennero strisciando le suole a cercarla nel vestibolo del piccolo edificio di G Street dov’era l’ufficio di George. Uno dei due era Gus Moscowski. Aveva le guance scarne e un’aria stanca e sporca. «Salute, signorina French» le disse. «Vi presento il fratellino… non quello che ci tradiva, quello fa fortuna… Voi state bene.» «Oh Gus, vi hanno rilasciato.» Gus accennò del capo. «Revisione del processo, assoluzione… Ma vi posso dire che non c’è da stare allegri in quel frigorifero.» Mary li fece salire nell’ufficio di George. «Sono certa che il signor Barrow sarà lieto di aver notizie dirette dei siderurgici.» Gus fece il gesto di scacciare qualcosa con la mano. «Non siamo siderurgici, siamo vagabondi… I vostri amici senatori ci hanno bellamente venduti. Qualunque disgraziato abbia traversato una volta la via con uno scioperante è sulla lista nera… I vecchi hanno riavuto il posto a mezzo dollaro invece che un dollaro e dieci, dopo che il prete gli ha fatto baciare la Bibbia e promettere di non iscriversi all’Unione… Un mucchio di gente ritorna a casa sua. Io e lui ce la siamo battuta, abbiamo provato a passare da Baltimora cercando lavoro su qualche nave, ma i marinai sono ammucchiati in dieci file sulle banchine… E allora ci viene in mente che si poteva anche assistere alla cerimonia di insediamento del presidente e vedere un po’ che faccia hanno quelli che mangiano.» Mary cercò di fargli accettare un po’ di denaro, ma quelli scossero il capo e dissero: «Non ci occorre una sovvenzione, possiamo lavorare». Stavano per andarsene, quando entrò George. Non parve affatto gran che rallegrato di vederli e cominciò a far una predica sulla violenza; se gli scioperanti non avessero minacciato violenze e lasciato che un mucchio di agitatori bolscevichi li fuorviassero, coloro che realmente stavano negoziando un accordo dall’interno avrebbero
potuto ottener loro condizioni assai migliori. «Non voglio discutere, signor Barrow. Immagino pensiate che padre Kazinski era un rosso e che è stata Fanny Sellers a sfondare la testa di un poliziotto a cavallo. E poi dite che siete dalla parte del lavoratore.» «Sì, George, persino la commissione del Senato ha ammesso che la violenza è stata da parte delle guardie e della polizia a cavallo… L’ho veduto coi miei occhi, del resto» intromise Mary. «Certamente, giovanotti… So quel che avete in mente… E io non difendo lo Steel Trust… Però, Mary, quanto vorrei fare intendere a questi giovanotti è che sovente il lavoratore è il peggior nemico di se stesso in queste cose.» «Il lavoratore viene sempre fregato, pigliatela come volete» disse Gus «e non so se la peggiore fregatura gliela danno gli amici o i nemici… Ora dobbiamo andarcene.» «Giovanotti, mi rincresce di avere tante cose urgenti da sbrigare. Mi piacerebbe sentire delle vostre esperienze. Magari un’altra volta» disse George, assestandosi alla sua scrivania. Mentre quelli partivano Mary French li seguì alla porta e bisbigliò a Gus: «E il tecnico Carnegie dunque?». Quegli occhi non apparivano più azzurri come eran stati prima che andasse in carcere. «Dunque sì» disse Gus senza guardarla, e si tirò piano alle spalle il vetro smerigliato. Quella sera, durante la cena, Mary a un tratto si alzò e disse: «George, noi siamo responsabili come chiunque altro per aver venduto i siderurgici». «Sciocchezze, Mary, è colpa dei dirigenti che hanno sbagliato il momento dello sciopero e poi hanno lasciato che gli industriali li coprissero con un mucchio di calunnie rivoluzionarie idiote. Il lavoro organizzato se le prende, ogni volta che s’imbroglia di politica. Gompers lo sa bene. Noi abbiamo fatto del nostro meglio.» Mary French si mise a camminare su e giù per la stanza. Divenne a un tratto amaramente, irrefrenabilmente rabbiosa. «È così che usavano ribattere a Colorado Springs. Farei meglio a tornarmene a stare con Mamma e occuparmi di beneficenza. Sarebbe meglio che vivere alle spalle dei lavoratori.» Camminava su e giù. George rimase là al tavolo che lei aveva
apparecchiato tanto accuratamente con fiori e una tovaglia bianca, e beveva sorsellini di vino e metteva prima un po’ di burro sull’angolo di un biscotto e poi un pezzetto di formaggio Rochefort e mordeva, e poi un altro poco di burro e un altro pezzo di formaggio, e masticava adagio tutto il tempo. Mary sentiva quegli occhi prominenti viaggiarle per il corpo. «Non siamo che sfruttatori» gli urlò in faccia, e corse nella sua camera. George si piegava su di lei, sempre masticando formaggio e biscotti, e le batteva nervosamente sulla spalla. «Che parole dispettose… Bambina mia, non devi essere così isterica… Non è il primo sciopero, questo, che sia finito male… Ma anche stavolta c’è qualcosa di guadagnato. Le persone oneste di tutto il paese hanno avuto orrore della spietata violenza dei baroni dell’acciaio. Ciò avrà un influsso sulla legislazione… Siediti e bevi un bicchiere… Su, Mary, perché non ci sposiamo? È troppo sciocco vivere a questo modo. Io possiedo qualche piccolo investimento. Ho veduto una bella casetta in vendita a Georgetown solo l’altro giorno. Questo è appunto il momento di comprare una casa, ora che i prezzi van giù… riducono il personale in tutti i dicasteri… Dopo tutto sono giunto a un’età che ho il diritto di mettermi a posto e avere una moglie e dei bambini… Non voglio aspettare che sia troppo tardi.» Mary sedette piagnucolando. «Oh, George, hai ancora tanto tempo… Non so, ma mi fa tanto orrore l’idea di sposarmi… Tutto mi fa orrore stanotte.» «Povera piccola, certo è il periodo che si avvicina» disse George e la baciò in fronte. Dopo che se ne fu partito per l’albergo, Mary decise di tornarsene a Colorado Springs dalla Mamma per qualche tempo. E poi avrebbe cercato qualche impiego in un giornale. Prima che fosse pronta a partire per l’Ovest, s’accorse che un mese era già passato. Il terrore di avere un bambino cominciò a ossessionarla. Non era affatto disposta a parlarne con George, perché sapeva che lui avrebbe insistito di sposarla. Non poteva aspettare. Non conosceva nessun dottore a cui ricorrere. A tarda ora una notte entrò nella cucinetta per ficcare la testa nella stufa e aprire il rubinetto del gas, ma in qualche modo la cosa le parve tanto incomoda e sentì
tanto freddo ai piedi, nudi sul linoleum, che ritornò nel letto. L’indomani ricevé una lettera da Ada Cohn tutta piena di come splendidamente lei se la passava a New York dove aveva il più incantevole degli alloggi e come lavorava accanitamente al violino e sperava di dare un concerto alla Carnegie Hall la stagione ventura. Senza terminare di legger la lettera, Mary French cominciò a fare i bagagli. Giunse alla stazione in tempo per il treno delle dieci. Dalla stazione telegrafò a George: CHIAMATAMI NEW YORK AMICA MALATA SCRIVERÒ. Aveva telegrafato a Ada e Ada la venne a prendere a New York nella stazione di Pennsylvania, elegantissima e tutta sfarzo. Nel tassì Mary le disse che voleva da lei una somma in prestito per fare un aborto. Ada ebbe una crisi di lacrime e disse che certo le avrebbe imprestato la somma, ma da chi voleva andare in nome del cielo? Sul serio, lei non avrebbe osato parlarne al dottor Kirstein, perché era tanto amico dei suoi che ne sarebbe stato troppo preoccupato. «Non voglio avere un bambino. Non voglio avere un bambino» continuava a ripetere Mary. Ada aveva un bell’alloggetto a tre vani nel retro di un palazzo in Madison Avenue con un chiaro tappeto marrone e un enorme piano a coda e una quantità di piante e di fiori in vasi. Mangiaron là la cena e camminarono a grandi passi su e giù per la camera tutta la sera cercando di raccoglier le idee. Ada si mise al piano e suonò preludi di Bach per calmarle i nervi, diceva, ma Mary era così sconvolta che non tenne dietro alla musica. Alla fine Mary scrisse a George una raccomandata dove gli chiedeva che fare. La sera seguente ebbe la risposta. George si sentiva il cuore spezzato, ma accludeva l’indirizzo di un dottore. Mary fece leggere la lettera a Ada. «Che bella lettera. Non so dargli torto. Pare un uomo di fine e delicato sentire.» «Lo odio» disse Mary cacciandosi le unghie nelle palme delle mani. «Lo odio.» L’indomani si recò tutta sola dal dottore e subì l’operazione. Dopo, ritornò a casa in tassì e Ada la mise a letto. Ada le diede spaventosamente ai nervi, entrando e uscendo in punta di piedi dalla camera con il viso tutto corrugato. Circa una settimana dopo Mary
French si alzò. Aveva l’aria completamente ristabilita, e si mise a girare New York in cerca di un impiego. 1. Conscientious Objectors: obiettori di coscienza, cittadini inglesi che ottennero dal governo, durante la guerra mondiale, la dispensa dal servizio militare, pretestando che la coscienza vietava loro di uccidere il proprio simile. Uguale nome fu dato ai pacifisti americani, che però finirono in prigione. (NdT) 2. Associated Press e United Press, agenzie di stampa degli Stati Uniti. (NdT) 3. Il testo inglese usa un’espressione molto più volgare: “aprire le gambe a”. (NdT) 4. Varietà americano che consiste in numeri di stripping: vale a dire, una o più belle ragazze entrano in scena con aria assorta e cominciano a spogliarsi con sapiente lentezza. (NdT)
Occhio fotografico (46) cammina e cammina per le vie cercando fra insegne Coca-Cola cartelloni Lucky Strike cartellini prezzi in vetrina brani di chiacchiere colte a volo sperduti brandelli di giornale e grossi titoli di ieri sporgenti dall’immondezzaio una tavola di cifre una formola d’azione un indirizzo non ricordi bene hai dimenticato il numero della via forse è a Brooklyn un treno parte per qualche luogo il sibilo di un piroscafo lacera i timpani un impiego scritto a gesso davanti a un’agenzia agire fare ci sono altre esistenze che camminare disperati per le vie presto schiavo agisci fa’ un discorso stimolante l’azione nella sala zeppa dopo il battimano le pacche e i sorrisi degli altri sul palco il raschio delle sedie il silenzio d’attesa qualche colpo di tosse durante i primi balbettanti tentativi di parlar netto saldo filato dar di piglio al grido di guerra sono tutti in ascolto e poi la facile ascesa da grido di guerra a grido di guerra fino all’applauso (se qualcuno dentro il capo non ti dicesse bugiardo e in Union Square quella volta che dritto su una cassa di sapone piegandoti su volti avidi giovani testardi vecchi quelli di mezza età rintontiti dal lavoro gli occhi pesti dalla lettura dei giornali tentativi di dire la parola giusta farli ridere dire quello che voglion sentire sventolare una bandiera bisbiglia l’agitatore intimo ansioso di riuscire) d’improvviso ti manca la voce per l’onta arrossisci ti metti a sudare perché non dire a questa gente nutrita di vento che stiamo sopra delle sabbie mobili? che il dubbio è la cote dell’intelligenza è troppo duro ferisce invece di stimolare sorvegliare John D. Rockefeller e se i poliziotti vi rompon la testa è tutto per il progresso del genere umano mentre ritorno a casa dopo un bicchierino e un boccone caldo e leggo (con qualche difficoltà nello stile della biblioteca Loeb) gli epigrammi di Marziale e medito il corso della storia e quali leve occorrono per sbalzare i proprietari dal potere e restaurare (anch’io Walt Whitman) la nostra scolastica democrazia e sempre in tasca quella lettera di uno studente che mi chiede di
spiegargli come mai avendo ragione cosa ch’egli ammette i radicali siano poi nella vita privata carogne simili mettiti a letto schiavo (e pela la cipolla del dubbio) col libro aperto in mano e dondola sull’altalena forse dopo tutto forse padrone guadagna quattrini hai capito quel che diceva il vecchiardo dalla barba bianca accanto al calamaio di cristallo sulla lucida scrivania di vernice nell’ufficio tutto in legno di noce nella sua voce rimbombavano tutti i pastori della fanciullezza e squillavano gli osanna degli stonati cori femminili Tutto quello che dite è assai vero ma c’è qualcosa che si chiama vendere e io ho delle figlie Sono certo che anche voi finirete per pensar differente guadagnare quattrini in New York (togliere a baci il rossetto dalle labbra di una profumata ragazza vestita alla moda alle cinque in un tassì che sobbalza giù per Park Avenue quando in fondo ad ogni via traversa il tramonto fiammeggia d’oro e di bianchi cirri usciti dai fumaioli dei piroscafi che salpano e tutto il cielo è foderato di verdi dollari i bullonatori stanno tranquilli i furgoni delle ditte sono relegati ai viali laterali e i guadagni cantano su tutti gli angoli delle vie scoppiettano nelle accensioni delle auto frusciano levigati nei cuscinetti a sfere scintillano nelle luci accese delle vetrine crocidano nei clacson tubano nelle trombe delle lucenti automobili milionarie d’importazione dollari fanno come seta nei suoi molli capelli nel suo abito germogliano negli ingegnosamente elaborati petali di rosa che stai baciando si fanno pungenti e croccanti nella cena alla trattoria mordono acuti nei bicchieri rendono fragoroso lo spettacolo di musica e gambe danno spicco alla sbornia ridente oscillano nell’ondeggiante orchestra schioccano secchi nel buona notte della guardarobiera) e se no perché no? camminare per le vie rivoltarti nel letto gli occhi bruciano a pelare la speculativa cipolla del dubbio se qualcuno dentro il capo schiavo? padrone? non ti dicesse (e così in Union Square) bugiardo
Cine-giornale LII riuniti al servizio divino per i cari defunti, l’ultima mezz’ora di pietà e rimembranza delle imprese compiute e del lavoro non finito; la rimembranza dell’amicizia e dell’amore; di ciò che era e avrebbe potuto essere. Perché non usar bene di quell’ultima mezz’ora, perché non fare quell’estremo servizio tanto elevato quanto lo può rendere Frank E. Campbell alla cappella funeraria (non affiliata ad alcuna setta religiosa) CADAVERE LEGATO IN UN SACCO CHE GALLEGGIA O quartiere cinese o quartiere cinese dove le luci sono fioche molti cuori conoscono questo solo paese cuori erranti SORPRESO DA UN COLPO APOPLETTICO MENTRE LA MOGLIE GLI FA LETTURA La signora Harding gli faceva lettura a voce sommessa e carezzevole. Si era sperato che avrebbe preso sonno sotto l’influsso. L’INCARICO A DAUGHERTY Tutto solo al telefono in attesa di un trillo Due cadaveri femminili nel baule dell’assassino I LAVORATORI MARCIANO SUL REICHSTAG NEL BUIO CORSA IN TASSÌ PER PREVENIRE UN SUICIDIO AL BELMONT FALLITA Pershing balla il tango in Argentina IL FUNERALE DI HARDING PERCORRE CINQUANTA MIGLIA ATTRAVERSO GLI AMMASSAMENTI DI FOLLA A CHICAGO Ragazza disoccupata che s’avvelena MOLTI VEDONO COOLIDGE MA POCHI LO ODONO Se conosceste Susie com’io conosco Susie direste oh che ragazza
L’arte e Isadora A San Francisco nel milleottocentosettantotto la signora Isadora O’Gorman Duncan, donna di carattere, che aveva un gusto per il pianoforte, si disponeva a divorziare dal marito, il distinto signor Duncan, che siamo spinti a credere si fosse grossolanamente malcomportato; tutta questa faccenda la rendeva talmente nervosa che ella dichiarò ai suoi bimbi di non poter sopportar altro nello stomaco che un po’ di champagne ed ostriche; e in mezzo ai ripicchi e alle recriminazioni della baraonda familiare, in un mondo di pensioni rischiarate a gas, tenute da decadute bellezze del Sud, e di magnati delle ferrovie e di porte a molla e di uomini baffuti mordicchianti chiodi di garofano per coprire il sentore del whisky e di sputacchiere d’ottone e di vetture a quattro ruote e di baschette e d’imbottiture e di scompigliate sottane a lunga coda (ove la sala delle conferenze e quella dei concerti, sotto l’impero delle signore colte, erano i centri d’aspirazione nella vita) ella diede alla luce una figliola cui pose il suo nome, Isadora. La rottura col signor Duncan e la scoperta della sua doppiezza fecero della signora Duncan una bigotta femminista ed atea, un’appassionata seguace delle conferenze e delle opere di Bob Ingersoll; dov’è Dio leggi natura; dov’è dovere, bellezza, e soltanto l’uomo è depravato. La signora Duncan dovette duramente lottare per tirare su i figli nell’amore del bello e nell’odio dei busti, delle convenzioni e delle leggi fatte dagli uomini. Dava lezioni di pianoforte, ricamava e lavorava sciarpe e mezziguanti. I Duncan erano sempre in debito. La pigione sempre da pagare. I primi ricordi di Isadora parlano dell’ammansamento di droghieri, macellai e padroni di casa e della vendita, di porta in porta, di oggettini fatti dalla mamma, di valigie fatte passare per le finestre posteriori quando occorreva saldare il conto, da una meschina pensione distinta all’altra, nei sobborghi di Oakland e San Francisco.
I piccoli Duncan e la loro madre formavano un clan; erano i Duncan in lotta con un rude e sordido mondo. I Duncan non erano più cattolici né presbiteriani né quaccheri né battisti; erano artisti. Quando i ragazzi eran bimbi, s’ingegnavano a suscitare attenzione fra i vicini dando spettacoli teatrali in una baracca; la ragazza maggiore Elizabeth dava lezioni di danze di società; erano tutti occidentali; il mondo era una sola febbre d’oro; non si vergognavano di esporsi al pubblico. Isadora aveva gli occhi verdi e i capelli rossicci, e un bel collo e due belle braccia. Non poteva pagarsi lezioni di danze convenzionali, ne inventò di testa sua. Si trasferirono a Chicago. Isadora trovò un posto di ballerina nel «Washington Post» al Masonic Temple Roof Garden. Ballò nei circoli. Andò a vedere Augustin Daly e gli disse che aveva scoperto la Danza e andò a New York scritturata come fata alla garza in un’edizione del Sogno d’una notte di mezza estate con Ada Rehan. La famiglia la seguì a New York. Affittarono una grande camera nella Carnegie Hall, gettarono materassi negli angoli, appesero drappi alle pareti e inventarono il primo studio al Greenwich Village. Erano sempre a due dita dal codice, passavano il tempo ad ammansire i fornitori, a rimandare la padrona di casa per l’affitto, a impetrare sovvenzioni dai ricchi filistei. Isadora combinò rappresentazioni con Ethelbert Nevin danzò a letture di ’Omar Khayya¯m dinanzi alle signore dell’alta società di Newport. Quando s’incendiò il Windsor Hotel, persero tutti i bagagli e il chilometrico conto che pendeva e s’imbarcarono alla volta dell’Europa per scampare al materialismo della natia America. A Londra nel British Museum scoprirono i greci; la Danza era greca. Sotto le fumose cappe del camino, tra le fuligginose piazze di Londra, danzarono in tuniche di mussolina, copiarono pose dai vasi greci, frequentarono conferenze, mostre d’arte, concerti, spettacoli, assorbirono in un inverno cinquant’anni di cultura vittoriana.
Ritorno alla Grecia. Ogni volta che li scacciavano per il mancato pagamento dell’affitto, Isadora li conduceva tutti nel miglior albergo e fissava un appartamento e spediva i camerieri in cerca d’aragoste e di champagne e di frutta fuori stagione; nulla era troppo buono per loro artisti, Duncan, greci; e alla Londra del ‘90 piacque quel fegato. A Kensington e persino in Mayfair ella danzò in ricevimenti di case private, tutti i britanni, a cominciare dal principe Edoardo, vennero rapiti dalla sua bellezza preraffaelita dalla sua sana innocenza americana, dal suo accento della California. Dopo Londra, Parigi durante la grande esposizione del Novecento. Isadora danzò con Loïe Fuller. Era ancora una vergine troppo timida per ricambiare le attenzioni di Rodin il grande maestro, del tutto costernata dal contegno straordinario di Loïe Fuller col suo circolo di pazzoidi bellezze invertite. I Duncan erano vegetariani, sospettosi d’ogni volgarità e degli uomini e del materialismo. Raymond fece a tutti dei sandali. Isadora, la madre e il fratello Raymond girarono per l’Europa in sandali e bende e tunica greca scendendo ai migliori alberghi facendo la vita greca secondo natura in uno svolazzio di note mai pagate. Il primo a solo di Isadora fu l’esibizione in un teatro di Budapest; dopo d’allora fu la diva, ebbe un intrigo con un primo attore; a Monaco di Baviera gli studenti le staccarono i cavalli. Dappertutto eran fiori, ovazioni e cene con champagne. A Berlino fu un furore. Coi quattrini che guadagnò nel suo giro in Germania portò tutti i Duncan in Grecia. Giunsero da Itaca su un battello peschereccio. Posarono in fotografie nel Partenone e danzarono nel Teatro di Dionisio e istruirono una banda di monelli a cantare il coro antico delle Supplici e costruirono per abitarci un tempio su una collina che dominava i ruderi dell’antica Atene, ma non c’era acqua là sopra e finirono i soldi prima che il tempio fosse a termine
così andarono all’Hôtel d’Angleterre e vi aprirono un conto. Finito il credito condussero il coro a Berlino e vi allestirono le Supplici in greco antico. Incontrando Isadora vestita del peplo che passava per il Tiergarten alla testa dei suoi piccoli greci tutti in fila con la tunica, il cavallo della Kaiserin s’adombrò e sua altezza andò per terra. Isadora era la moda. Giunse a Pietroburgo in tempo per assistere alle esequie notturne dei dimostranti mitragliati dinanzi al palazzo d’Inverno nel 1905. Ciò la ferì. Lei era un’americana come Walt Whitman; i criminosi potenti della terra non erano dei suoi; i dimostranti erano dei suoi; gli artisti non stavano dalla parte delle mitragliatrici; lei era un’americana in tunica greca; era per il popolo. A Pietroburgo, affascinata ancora dal settecentesco balletto di corte del Re Sole, la sua danza venne considerata pericolosa dalle autorità. In Germania fondò una scuola con l’aiuto della sorella Elizabeth che s’occupò dell’organizzazione. E Isadora andò in America in trionfo come aveva sempre avuto in mente e tormentò i filistei patrii con un giro di danze; continuamente le impacchettavano qualcuna del seguito per porto di tunica greca; non trovò la libertà dell’Arte, in America. Di ritorno a Parigi fu una vertigine; l’Arte significava Isadora. A un funerale del gran mondo conobbe un milionario e gli fuggì insieme sul panfilo (tutto quel che Isadora facesse era Arte) a danzare nel tempio di Pestum per lui solo, ma si mise a piovere e i suonatori la presero tutta. Allora decisero di ubriacarsi. L’Arte era la vita da milionari. L’Arte era tutto quel che Isadora facesse. Portava con sé il bimbo del milionario con grande scandalo delle vecchie signore dei circoli e delle nubili amatrici d’arte quando danzò nel suo secondo giro d’America; si mise a bere senza freno e s’avanzava alla ribalta e scacciava vociferando la gente dai palchi.
Isadora era all’apice della gloria e dello scandalo e della potenza e della ricchezza, la sua scuola lavorava, il suo milionario voleva costruirle un teatro a Parigi, i Duncan erano i sacerdoti di un culto (l’Arte era tutto quel che Isadora facesse) quando la macchina che riportava a casa i suoi due bimbi dall’altra parte di Parigi s’incantò su un ponte della Senna. Dimenticando che lasciava la macchina in marcia, l’autista discese per riavviare il motore. La macchina partì, buttò a terra l’autista e si tuffò nella Senna. I bimbi annegarono con la bambinaia. Il restante della sua vita continuò disperato nello strepito delle lingue scandalizzate, tra le facce canzonatrici dei giornalisti, le minacce della questura, le rimostranze dei direttori d’albergo che tendevano conti scaduti. Isadora beveva troppo, non sapeva tener a posto le mani davanti ai giovanotti simpatici, si tingeva i capelli in varie sfumature di rosso ardente, non si prese mai la pena di truccarsi la faccia ammodo, incurante dell’abito, non s’impacciava a mantenersi la figura in ordine, non tenne mai conto di un soldo ma un grande senso di salute riempiva la sala quando l’oblungo cerchio delle belle grandi braccia s’avanzava lentamente dal fondo della scena. Non aveva paura di nulla; era una grande danzatrice. In San Francisco sua patria i politicanti non le permisero di danzare nel teatro greco che avevano fatto costruire sotto il suo influsso. Dovunque ella andasse, era un’offesa ai filistei. Quando scoppiò la guerra, ella danzò La marsigliese, ma non parve una cosa rispettabile e poi offese tutti rifiutando di smettere Wagner o di mostrare i corretti rispettabili sentimenti di compiacimento davanti al massacro. Nel suo giro al Sud America dappertutto raccolse uomini, un pittore spagnolo, un paio di pugilatori, un fuochista di piroscafo, un poeta brasiliano, schiamazzò in sale di tango, vociferò agli argentini dalla ribalta
ch’eran negri, golosamente trionfò a Montevideo e nel Brasile; ma se aveva quattrini non sapeva non spenderli con scandalo in ballerini di tango, regalie, cene di mezzanotte, il gesto generoso, no, pago tutto io. I direttori la borseggiavano. Ella non aveva paura di nulla, mai si vergognava agli occhi del pubblico dello strepito delle lingue scandalizzate, dei grossi titoli dei giornali della sera. Quando ottobre spaccò il guscio del vecchio mondo, Isadora rammentò Pietroburgo, le bare barcollanti lungo le vie silenziose, i visi bianchi, i pugni convulsi quella notte a Pietroburgo e danzò la Marche slave e sventolò garza rossa sotto il naso delle vecchie dame di Boston nella Symphony Hall, ma quando andò in Russia piena della speranza di una scuola e del lavoro e di una nuova libera vita, trovò una cosa troppo enorme, troppo difficile: il freddo, la vodka, i pidocchi, nessun servizio negli alberghi, il vecchio e il nuovo ammonticchiati alla rinfusa, semenzaio e immondezzaio, ella non ebbe la pazienza, la sua vita era stata troppo facile; raccolse un poeta dai capelli gialli e lo portò con sé nell’Europa e nei grandi alberghi. Esenin fece in pezzi un piano intero del palazzo dell’Adlon a Berlino in una sera di sbornia, rovinò un appartamento al Continental di Parigi. E quando tornò in Russia si ammazzò. Era una cosa troppo enorme, troppo difficile. Quando divenne impossibile trovare altri quattrini per l’Arte, per i séguiti che mangiavano e bevevano in appartamenti d’albergo, per l’affitto delle Rolls-Royce e gli alimenti delle allieve e discepoli, Isadora se ne andò giù in Riviera a scrivere le sue memorie e raggranellare qualche soldo dal pubblico americano che si era desto dopo la guerra alla crassezza del materialismo e alla Grecia e allo scandalo e all’Arte, e ancora aveva dollari da spendere. Affittò uno studio a Nizza, ma non riuscì mai a pagar la pigione. Aveva litigato col suo milionario. I gioielli d’Isadora, il famoso smeraldo, il mantello d’ermellino, le opere d’arte offerte dagli artisti,
tutto era finito al monte o sequestrato dagli alberghieri. Non le restavano che gli antichi drappi azzurri testimoni dei suoi grandi trionfi, una borsetta di cuoio rosso e un vecchio abito di pelliccia spaccato nella schiena. Non sapeva smetter di bere né di gettar le braccia al collo del primo giovanotto, se aveva soldi in mano dava una festa e li buttava via. Tentò di annegarsi ma un ufficiale inglese di marina la trasse fuori al chiaro di luna dal Mediterraneo. Un giorno in una piccola trattoria di Golfe Juan trovò un bel giovanotto che aveva un’autorimessa e guidava una piccola Bugatti da corsa. Dicendo che poteva aver bisogno di comprare una macchina, lo invitò nel suo studio per portarla a fare una corsa; gli amici non volevano, dicevano che era solo un meccanico. Isadora insisté, aveva bevuto qualche bicchierino (non c’era più nulla al mondo che le importasse tranne qualche bicchierino e un bel giovanotto); salì accanto a lui e si gettò la sciarpa dalla frangia pesante intorno al collo con un gran gesto tutto suo e si volse e disse, col forte accento di California che il suo francese non aveva mai perduto: Adieu, mes amis, je vais à la gloire. Il meccanico accese il motore e partì. La pesante sciarpa svolazzante s’impigliò in una ruota, e s’attorcigliò stretta. La testa d’Isadora fu sbattuta contro il bordo della macchina. La macchina s’arrestò; l’osso del collo era spezzato, il naso rotto, Isadora era morta.
Cine-giornale LIII Addio bel merlo SIETE VOI LA PIÙ BELLA STENOGRAFA DI NEW YORK? Nessuno mi ama né mi vuol comprendere oh che storie pietose mi raccontano L’INGHILTERRA DECIDE DI FARE DA SOLA anche voi potete in breve imparare a ballare in casa vostra senza musica e senza maestro… dà gli stessi risultati di un abile massaggiatore, soltanto più presto, più agevolmente e con meno spesa. Ricordate che solo uomini in grado di sposarsi e nel pieno possesso di un’eccezionale forza fisica saranno accettati come i Campioni di Apollo Fammi il letto e accendi il lume stanotte vengo tardi UNA DONNA SCAMBIATA IN CASA PER UNA LADRA E UCCISA Un granduca viene a divertirsi L’ECLISSE RITARDA DI QUATTRO SECONDI Varie persone in centro ne osservano la corona altri sono più eleganti, fatti di ottomano, di raso pesante, di crespo o di cavallino con guarnizioni di struzzo magari UN CANE ARRABBIATO SPARGE IL TERRORE NELLA STAZIONE DI PENNSYLVANIA UNA MOGLIE INFELICE CHE TENTA DI MORIRE la ricca armonia della perfezione, interiore ed esteriore, può venire soltanto dalla mano dell’artista che persegue un ideale. Sostituisce solidi e normali tessuti a quest’adipe sfigurante. Tocca ogni esigenza nella vasta cerchia dei bisogni umani. Così per scritto può sembrare una cosa poco seria ma egli sa come svilupparvi l’intelligenza. Se siete vittima del malessere fisico egli può liberarvi dal dolore. Vi può aiutare a eliminare i problemi maritali e coniugali. È un esperto in materia di sesso Bel merlo addio GRATTACIELI CHE CONTEMPLANO LE VIE DESERTE
era una languida, una bianca e rosa Peggy Joyce nel salottino bianco e rosa, che tendeva una bianca manina
Margo Dowling Quando Margie fu abbastanza grande soleva recarsi alla stazione incontro a Fred con una lanterna, le notti scure d’inverno, quando lo aspettavano di ritorno dalla città sul treno delle nove e quattordici. Margie era piccolina per la sua età, soleva dire Agnes, ma il vestito di panno rosso dal colletto di pelliccia pungente sotto le orecchie era ugualmente troppo stretto e lasciava scoperti i polsi screpolati nelle notti che il nevischio turbinoso sferzava intorno all’angolo della stazione e il fil di ferro della pesante lanterna le tagliava gelido la mano. Ogni volta Margie partiva con un brivido giù per la spina e alle mani e ai piedi, per timore che Fred non fosse in se stesso e barcollasse e incespicasse come talvolta faceva e fosse così rosso in faccia e dicesse parolacce. Il signor Bemis, l’impiegato dalle spalle curve, soleva scherzarci su col grosso Joe Hines, il guardiano di linea che sovente bighellonava nella stazione all’ora dei treni, e Margie restava fuori per non ascoltarli quando dicevano: «Avanti, scommetto che Fred Dowling stanotte rientra pieno». Era quando Fred si trovava in questo stato che gli occorrevano Margie e la lanterna, perché le tavole del marciapiede verso casa erano così strette e sdrucciolevoli. Quand’era ancora una bambinella soleva pensare che fosse per la stanchezza del tremendo lavoro di città che Fred camminava così buffamente scendendo dal treno, ma quando ebbe otto o nove anni Agnes le aveva spiegato tutto, come ubriacarsi era una cosa che gli uomini facevano e non avrebbero dovuto fare. Così ogni notte Margie provava quell’orribile sensazione vedendo i fari del treno che le veniva incontro sopra il lungo viadotto da Ozone Park. Qualche volta Fred non arrivava neppure e lei tornava a casa piangendo; ma eran belle le volte che lui saltava agilmente giù dal treno, solido nel grosso pastrano che sapeva di pipa, e le piombava addosso e la tirava su, lanterna e tutto, e le diceva: «Come sta la piccolina di papà?». Poi la baciava e Margie si sentiva così felice e orgogliosa, issata lassù, e guardava di là il cattivo vecchio signor Bemis, e la voce di Fred profonda nel grosso torace usciva rimbombando dal cappuccio: «Buona notte, capo» e i finestrini
giallolucenti del treno si muovevano e i rossi occhi da bruco, in coda, impicciolivano e si fondevano, mentre il treno spariva alla vista sopra il viadotto di Hammels. Margie ballonzolava su e giù sulla sua spalla e sentiva i muscoli del braccio, duri come remi, tendersi contro il suo corpo quando Fred si metteva a correre con lei su per il tavolato gridando ad Agnes: «È avanzato qualcosa, bella?» ed Agnes veniva alla porta, ridendo e asciugandosi le mani nel grembiale e il padellone di brodo bollente fumava sulla stufa, e tutto era così bello caldo e pulito nella cucina, e lei la lasciavano alzata finché non le cadeva il capo e le bruciavano gli occhi ed entrava anche la fata del sonno ad ascoltare Fred che parlava di biliardi tascabili e totalizzatori e corse e risse spaventevoli nella città. Poi Agnes la portava a letto nella camera fredda e Fred si metteva accanto al letto fumando la pipa e le raccontava dei naufragi a Fire Island quando lui era guardacoste, finché le fessure di luce che venivano dall’uscio della cucina non si confondevano sempre più, e sebbene Margie cercasse per tutto il tempo di star sveglia, perché era così felice di ascoltare il ronzio della voce di Fred, la fata del sonno che lei aveva finto avesse perduto il treno entrava alle spalle di Fred, ed ecco che cadeva addormentata. Via via che cresceva e avanzava nelle elementari di Rockaway Park, tutto questo si fece sempre più raro. Sempre più sovente Fred era ubriaco scendendo dal treno oppure non arrivava nemmeno. Allora era Agnes che le raccontava le storie dei tempi passati e come erano stati allegri, e qualche volta si fermava a metà di una storia per piangere, e quanto amiche erano state Agnes e la mamma di Margie e tutte e due erano signorine commesse nell’emporio Siegel Cooper al banco dei fiori artificiali e solevano andare a Manhattan Beach, tanto più distinto di Coney, la domenica, non all’Oriental Hotel, si capisce, era troppo caro, ma in un piccolo stabilimento vicino, e qui Fred era bagnino. «Avresti dovuto vederlo a quei tempi, con il suo corpo robusto e abbronzato era l’uomo più bello…» «Ma anche ora è bello, no, Agnes?» s’intrometteva ansiosa Margie. «Ma certo, tesoro, ma avresti dovuto vederlo a quei tempi.» E Agnes continuava, com’era fortunato Fred alle corse e quante persone aveva salvato dal mare e come tutti i proprietari di concessioni ogni anno mettevano un tanto a
testa per regalargli una gratifica e quanto denaro aveva sempre in tasca e che bella risata e tanto gioviale era. «Questa fu la sua rovina» diceva Agnes. «Non ha mai saputo dir di no.» E Agnes raccontava delle nozze e i fiori d’arancio e il dolce, e come Margery mamma di lei Margie era morta mentre lei nasceva. «Ha dato la sua vita per te, non scordartene mai»; e Margie si sentiva a disagio, come se non fosse più lei, quando Agnes diceva questo. E poi un giorno mentre Agnes usciva dal lavoro, ecco Fred dritto sul marciapiede con la bombetta, tutto vestito in nero, che le chiedeva se voleva sposarlo, essendo lei stata la migliore amica di Margery Ryan, e fu così che si sposarono, ma Fred non si consolò più e non sapeva dir no, ed ecco perché si mise a bere e perse il posto all’Holland e più nessuno lo voleva prendere in nessuno stabilimento per via delle risse e dell’ubriachezza e allora erano andati a stare sul Broad Channel, ma non si guadagnava abbastanza con le esche, l’affitto delle barche e i pranzetti occasionali dei gitanti, e allora Fred aveva cercato un posto a Jamaica in una taverna al banco, visto che aveva una così simpatica risata e andava così a genio a tutti. Però quella fu la sua rovina, peggio che mai. «Ma non c’è un uomo simpatico come Fred Dowling in tutto il mondo, quando è in sé… Non scordartene mai, Margie.» E tutte e due allora si mettevano a piangere e Agnes domandava a Margie se le voleva altrettanto bene come se lei fosse stata sua madre e Margie piangeva e rispondeva: «Sì, Agnes cara». «Devi sempre volermi bene» diceva Agnes «perché credo che il Signore non voglia che io abbia dei piccoli bambini miei.» Margie doveva prendere tutti i giorni il treno per recarsi a scuola a Rockaway Park. Se la cavava bene nello studio e le piacevano le insegnanti e i libri e il canto, ma i ragazzi la burlavano perché i suoi vestiti eran tutti fatti in casa e buffi e perché lei era un tombolino e cattolica e stava in una casa costruita su palafitte. Ma dopo che un Natale in una recita scolastica fece Ranuncolo, tutto cambiò e cominciò a divertirsi più a scuola che non a casa. A casa c’erano sempre tante faccende da sbrigare; Agnes non cessava mai di fare il bucato e stirare e strofinare, perché Fred non portava quasi più denaro. Entrava barellando, sporco e puzzolente di
birra rancida e whisky e bestemmiava e borbottava sopra i piatti e perché mai Agnes non gli faceva più trovare una bella bistecca come un tempo quando lui era di ritorno dalla città e Agnes aveva lo schianto e singhiozzava: «Ma che debbo adoperare per denaro?». Allora Fred le dava nomacci e Margie correva nella sua cameretta e sbatteva la porta e qualche volta perfino vi trascinava contro lo stipo e si metteva a letto e vi restava rabbrividendo. Qualche volta, mentre Agnes apparecchiava la colazione, sempre in furia per timore che Margie perdesse il treno, le si vedeva un occhio annerito e un viso enfiato e molle dove Fred l’aveva battuta, e si dava una mansueta aria di compunzione che a Margie faceva dispetto. E tutto il tempo brontolava osservando la cioccolata e il latte condensato scaldarsi sulla stufa. «Lo sa il Signore che ho fatto quanto ho potuto e mi sono logorate le dita all’osso per lui… Santa pazienza di Dio, non si può continuare così.» Tutti i sogni di Margie erano di fuggire. D’estate qualche volta si sarebbero potuti divertire, non fosse stata l’eterna preoccupazione che Fred trasmodasse subito. Fred tirava fuori dal ripostiglio le barchette la prima bella giornata di sole e lavorava come un demonio a calafatarle e verniciarle di un bel verde vivo e fischiettava sul lavoro, oppure si levava avanti giorno a dissotterrare telline o acchiappare con la rete pesciolini per esca, ed ecco che c’erano di nuovo soldi e gran padelle di pesce stufato tipo Long Island e tipo New England gorgoglianti sulla stufa, e Agnes era felice e piena di canti e sempre affaccendata a preparare pranzi e panini per pescatori, e Margie si univa qualche volta a comitive di pesca, e Fred le insegnò a nuotare nel limpido braccio di mare sotto il ponte ferroviario e la portava con sé scalza sui banchi fangosi per telline e granchiolini, e gitanti pescatori dai panciotti fantasia che scendevano a noleggiare una barca, sovente le regalavano un quarter. 1 Quando Fred era in un lucido intervallo, era così bello d’estate, l’odore tepido dell’erba di palude, la freschezza della marea che saliva nella baia, il pizzicore di salso e dell’abbronzatura, ma poi appena metteva insieme un po’ di denaro Fred si buttava a bere e gli occhi di Agnes ritornavano rossi tutto il tempo e il lavoro andava a rotoli. Margie aborriva il modo
come la faccia di Agnes si faceva brutta e arrossata quando piangeva, e diceva a se stessa che non avrebbe mai pianto qualunque cosa le accadesse, quando fosse grande. Una volta ogni tanto, quando le cose andavano bene, Fred annunciava che avrebbe portato la famiglia a divertirsi e si vestivano a festa e lasciavano che facesse la guardia il vecchio Hines, padre di Joe Hines, che aveva una gamba di legno e folti favoriti bianchi, e si recavano alla spiaggia in treno, e fino al parco dei divertimenti Holland camminando sul tavolato. Qui c’era troppa calca e Margie aveva paura che capitasse qualcosa al suo bell’abito e la luce abbacinava e uomini e donne con braccia e gambe abbronzate e i capelli in disordine giacevano nel sole strapiombante, ricoperti di sabbia, e Fred ed Agnes ruzzavano in giro come gli altri in costume da bagno. Margie aveva paura delle enormi ondate spumeggianti che s’infrangevano sulla sua testa, anche quando Fred la teneva fra le braccia aveva paura, e le faceva spavento quanto lontano lui si spingesse a nuoto. Dopo, ritornavano col pizzicore degli abiti indosso e camminavano sul tavolato fra gli strilli dei venditori di noccioline e le esalazioni della meliga tostata, degli zuccherini dei salsicciotti, della mostarda e della birra, tutto mescolato con la risacca e il fragore rintronante degli automobilini e delle sirene della giostra, e tanta gente odiosa che spingeva e urtava, e pestava i piedi. Margie era troppo piccina per vedere oltre costoro. Era meglio quando Fred se la issava sulla spalla, quantunque fosse ormai troppo vecchia per salire a cavalluccio del babbo nonostante la sua piccola statura, e lei badava a tirare il bel vestitino celeste perché non le lasciasse scoperte le ginocchia. Quel che le piaceva alla spiaggia era partecipare a quel gioco dove si faceva rotolare una pallina sulle lisce e strette tavole verniciate entro buche numerate e c’era un giapponesino con un liscio abito candido inamidato, e scaffali su scaffali dei più graziosi oggettini per premi: teiere, ometti di porcellana che dondolavano il capo, vasi di fiori, file su file delle più carine bambole giapponesi, qualcuna con vere sopracciglia, e giare e brocche e caraffe. Una volta Margie vinse una piccola teiera a foggia di elefante e la conservò per anni. Fred ed
Agnes non parevano far gran caso del giapponesino che dava i premi, ma Margie pensava ch’era davvero bellino, col viso così glabro, e aveva una vocetta così buffa, e labbra e palpebre così nettamente segnate proprio come quelle delle bambole e persino lunghe sopracciglia nere. Margie soleva pensare che le sarebbe piaciuto averlo per portarselo a letto come una bambola. Lo disse una volta e Agnes e Fred risero talmente di lei, che la fecero terribilmente vergognare. Ma quel che le piaceva più di tutto a Holland’s Beach era il teatro di varietà. Entravano e la calca, le risate, il baccano morivano alle loro spalle, dietro i grandi battenti imbottiti. C’era qualche volta uno spettacolo di cinema quando entravano. Ciò non le andava molto, ma quel che le piaceva più d’ogni cosa al mondo erano le canzoni figurate che venivano in seguito, i quadri di belle dame e signori a colori come fiori dipinti, e così bei costumi e grandi cappelli e le scritte con le viole del pensiero e i nontiscordardimé intorno, e la dama o il signore che cantavano rivolti al teatro buio. Sempre c’erano barche su correnti increspate e dame in bei costumi che il cavaliere aiutava a discendere, ma non come a Broad Channel dove la luce abbacinava e non c’erano che banchi di fango e i pali puzzoviscidi e l’approdo poggiato nella melma quando calava la marea, ma bei fiumi azzurri increspati con belle sponde verdi e penduli salici piangenti. Poi veniva il varietà. C’erano acrobati e foche ammaestrate e uomini dalla paglietta che dicevano buffe freddure e dame che danzavano. The Merry Widow Girls, ci fu una volta, coi loro grandi cappelli neri inclinati così straordinariamente da un lato e l’abito a guaina e lo strascico azzurro, verde, purpureo, giallo, arancione, rosso, e un seducente giovanotto dalla giacchetta sfuggente che volteggiava con ciascuna a turno. Il brutto di quelle gite a Holland’s Beach era che Fred vi incontrava degli amici e cominciava a entrare per le porte a molla e uscirne con gli occhi lustri e nel fiato un sentore di whisky e cipolline sott’aceto, e a metà del divertimento Margie vedeva diffondersi sul viso di Agnes quella mansueta aria sofferente, e allora sapeva che per quel giorno non si sarebbe divertita più. L’ultima volta ch’erano andati tutti insieme alla spiaggia smarrirono Fred, quantunque lo cercassero
dappertutto, e bisognò tornare a casa senza. Agnes singhiozzava così forte che tutti la guardavano fisso in treno e il controllore Ed Otis, amico di Fred, si avvicinò e cercò di convincerla che non se la prendesse così, ma ciò non fece che aumentare i singhiozzi di Agnes. Margie ne ebbe una tale vergogna che decise di fuggire oppure uccidersi appena fossero giunti a casa, perché non voleva trovarsi mai più di fronte ai passeggeri di quel treno. Quella volta Fred non si mostrò l’indomani come solitamente faceva. Joe Hines venne a dire che un tale gli aveva detto che aveva veduto Fred spassarsela a Brooklyn e che non credeva sarebbe tornato tanto presto a casa. Agnes mandò Margie a letto e si sentirono la voce di Agnes e quella di Joe Hines parlottare in cucina per ore. Margie si risvegliò di soprassalto e vide Agnes che in camicia da notte le entrava nel letto. Aveva le guance scottanti e non smetteva di ripetere: «Pensa un po’ che faccia tosta, e non è che un guardalinea… Margie… Non possiamo più resistere a questa vita, vero, piccola?». «Scommetto che veniva qui a dar noia, quel vecchio odioso.» «Qualcosa di simile… Oh è troppo ormai, non posso più resistere. Lo sa il Signore se non mi sono logorata le dita fino all’osso.» D’un tratto Margie uscì con: «Ebbene, quando non c’è il gatto i topi ballano» e fu sorpresa vedendo Agnes rider tanto sebbene nello stesso tempo piangesse. A settembre, proprio mentre Agnes preparava gli abiti di Margie per l’apertura della scuola, il collettore dell’affitto venne per la rata trimestrale. Da Fred non avevano ricevuto altro che una lettera con dentro un biglietto da cinque dollari. Diceva che s’era trovato in una rissa, era stato arrestato e aveva passato due settimane in prigione, ma che adesso aveva lavoro e sarebbe tornato a casa appena le cose fossero andate un po’ meglio. Margie però sapeva che i cinque dollari li dovevano, con altri dodici, al droghiere. Quando Agnes ritornò in cucina, dopo l’incontro col collettore, il viso rigato e imbruttito dalle lacrime, disse a Margie che sarebbero andate a stare in città. «L’ho sempre detto a Fred Dowling che sarebbe venuto il giorno che non avrei più resistito. E adesso se la faccia da solo la casa, dopo questo.» Fu un orribile giorno quando portarono le due valigie e l’odioso
vecchio baule ammuffito alla stazione con l’aiuto di Joe Hines, che faceva sempre mille piccoli servizi ad Agnes quando non c’era Fred, e salirono sul treno che le portò a Brooklyn. Andarono dai genitori di Agnes, che stavano nel retro di una botteguccia da tappezziere in Fulton Street sotto l’aerea. Il vecchio signor Fisher era tappezziere e modellatore e tutto l’alloggio sapeva di colla, di pasta, di trementina e di gesso. Era un omettino grigio e la signora Fisher gli somigliava in tutto, salvo che lui aveva grigi baffi spioventi e lei no. Per Margie prepararono un lettino nel salotto, ma lei si accorse che la giudicavano un’intrusa. Neanche loro le piacevano, e detestava quella vita di Brooklyn. Fu un sollievo quando Agnes disse una sera, rientrando prima di cena assai elegante – parve a Margie – nel suo abito cittadino, che aveva trovato una sistemazione come cuoca presso una famiglia di Brooklyn Heigths e che nell’inverno avrebbe mandato Margie dalle suore. Margie fu un po’ sgomenta per tutto il tempo che stette nel convento, dall’istante che varcò la soglia del vestibolo di sasso grigio con la bianca figura di marmo ritta nel mezzo. Margie non era mai stata molto religiosa e le suore le facevano sgomento sotto le loro falde nere, con i visi e le mani così pallidi sempre chiusi nel candore inamidato, e la grande chiesa tenebrosa piena di ceri e la lezione di catechismo e la confessione e il tintinnio del campanellino durante la messa perché ciascuna chiudesse gli occhi mentre il Redentore scendeva tra gli angeli e le colombe in un fulgore di luce ambrata, verso l’altare. Era buffo, dopo che Agnes l’aveva lasciata scorrazzare per casa senza l’ombra di un vestito, che quando faceva il bagno una volta la settimana la suora le facesse tenere una camicia proprio nella vasca e voleva persino che si insaponasse sotto la camicia. L’inverno non fu che un lento e interminabile avvicinarsi al Natale, e dopo che tutte le sue compagne ebbero tanto parlato di quanto avrebbero fatto a Natale, quello di Margie fu orribile, una tarda e malinconica cena con Agnes e i vecchi, e solamente uno o due regali. Agnes era pallida, stanca morta per la fatica del pranzo per i suoi padroni. Portò una calza a rete piena di dolci e una bella bambola
capellidoro con gli occhi che s’aprivano e chiudevano; Margie aveva voglia di piangere. Nemmeno l’albero. Ma già sedendo a tavola era occupata ad inventare le cose che avrebbe raccontate alle compagne. Agnes stava appunto dandole la buona notte con un bacio e preparandosi a buttarsi addosso la logora pelliccetta per ritornare a Brooklyn Heights quando entrò Fred nello stato consueto e voleva portarle tutte e due a divertirsi. Naturalmente non andarono e Fred uscì, fuori di sé, e Agnes uscì piangendo e Margie stette sveglia metà della notte nel lettino preparatole nel salotto dei vecchi, pensando com’era orribile esser povera e avere un simile padre. Fu assai tetro, anche, restare in casa coi vecchi finché duraron le vacanze. Non c’era luogo da giocare e per il minimo gesto la rimproveravano. Fu una gran cosa ritornare al convento dove c’era una palestra e si poteva giocare a pallacanestro e ridere negli angolini con le altre ragazze. Il trimestre invernale fuggiva avvicinandosi Pasqua. Poco prima, Margie fece la prima comunione. Agnes le preparò lei il vestito bianco e tutte le suore levaron gli occhi al cielo e dissero com’era cara e innocente coi riccioli d’oro e gli occhi azzurri come un angelo, e Minette Hardy, una più anziana dal naso schiacciato, prese una cotta per lei e si mise a passarle nel cortile di ricreazione cioccolatini alla menta avvolti in bigliettini con su scritti certi brevi messaggi come: A Ranuncolo con l’amore della sua cara Minette, e altri. Ci fu da disperarsi quando venne la premiazione e lei non aveva nessun progetto per l’estate da raccontare alle compagne. In quell’estate si sviluppò assai e si fece goffa e cominciavano a spuntarle i seni. La stagione soffocante polverulenta torrida trascorreva adagio e interminabile in quella casa dei Fisher. Lei stava orribilmente, ingabbiata a quel modo coi vecchi. La signora Fisher aveva cura di non lasciarle mai dimenticare che lei non era la bambina di Agnes e la sua idea che fosse sciocco da parte di sua figlia mantenere la prole di un buonannulla come Fred. Cercavano di farle pagare in lavori di casa quel che costava, e tutti i giorni eran rimproveri e lacrime e angosce. Margie fu ben felice il giorno che venne Agnes e annunciò che aveva un nuovo posto e sarebbero andate lei e Margie a stare a New
York. Saltava su e giù strillando: «Bello bello… Oh Agnes, saremo ricche». «È probabile,» disse Agnes «comunque è sempre meglio che far la serva.» Lasciarono bauli e valigie da un corriere e si recarono a New York con l’aerea e poi alla periferia nella sotterranea. Le vie del West Side parvero a Margie straordinariamente grandi e spaziose e assolate. Avrebbero abitato coi Francini in un piccolo alloggio sull’angolo del medesimo isolato dov’era la panetteria che quelli esercivano in Amsterdam Avenue, dove avrebbe lavorato Agnes. Ebbero una stanzetta in tutto, ma c’erano un canarino in gabbia e molte piante sulla finestra e i Francini erano tutti e due grassi e faceti e si mangiavano a ogni pasto focacce con sopra zucchero filato. La signora Francini era la sorella di nonna Fisher. Non permettevano a Margie di giocare con gli altri bimbi del caseggiato; i Francini dicevano che non era un caseggiato sicuro per le bambine. Usciva solamente una volta la settimana e ciò avveniva la sera della domenica; bisognava sempre andare tutti al passeggio e arrivare fino alla tomba di Grant e poi tornare. A Margie s’indolorivano le gambe camminando così adagio sulla via affollata, come facevano i Francini. Tutta quell’estate desiderò un paio di pattini a rotelle, ma i discorsi dei Francini e i discorsi delle monache intorno ai pericoli la sgomentavano togliendole la voglia di uscir sola. Di che cosa avesse tanto sgomento, non sapeva bene. Le piaceva però aiutare Agnes e i Francini nella panetteria. Nell’autunno ritornò al convento. Un pomeriggio che da poco era ritornata dopo le feste natalizie, venne Agnes a trovarla; l’istante stesso che Margie passò la porta del parlatorio, vide subito che Agnes aveva gli occhi rossi e le chiese che c’era. Tutto era spaventosamente mutato alla panetteria. Il povero signor Francini era caduto morto, mentre infornava, di un colpo apoplettico, e la signora sarebbe andata in campagna a stare con lo zio Joe Fisher. «E poi c’è ancora una cosa» disse Agnes, sorridendo e arrossendo. «Ma ora non posso parlartene. Non devi credere che la povera Agnes sia cattiva e faccia del male, ma potevo resistere sempre così sola?» Margie saltò su e giù. «Oh bello, Fred è tornato.» «No, tesoro, non è questo» disse Agnes, e la baciò e
partì. A Pasqua Margie dovette restare al convento per tutti i giorni di vacanza. Agnes le scrisse che per il momento non aveva un posto dove portarla. Eran restate anche altre ragazze e fu una cosa divertente. Poi un bel giorno arrivò Agnes per prenderla e portarla fuori, recando in una scatola direttamente dal negozio un nuovo abito azzurro scuro e un cappellino di paglia ornato di fiori rosa: com’era dolce il fruscio della carta velina quando li sviluppò! Margie corse nel dormitorio e indossò l’abito, col cuore che palpitava; era l’abito più bello e più da grande che avesse mai avuto. Non aveva che dodici anni ma, da quel poco che poteva cogliere di sé nei piccoli specchi tollerati nel convento, le dava l’aspetto di una grande. Si precipitò giù per le vuote scale di sasso grigio, saltò e cadde nelle braccia di suor Elizabeth. «Perché tanta fretta?» «La mamma è venuta a prendermi per uscire col babbo e questo è l’abito nuovo.» «Com’è bello» disse suor Elizabeth «ma non bisogna…» Margie era già lontano per il corridoio, nel parlatorio, e saltava su e giù dinanzi ad Agnes stringendola e baciandola. «È il più bel vestito che ho mai avuto.» Mentre andavano a New York sull’aerea, Margie non seppe parlar d’altro che del suo vestito. Agnes disse che andavano a colazione in un ristorante frequentato da gente di teatro. «Magnifico. Non ho mai mangiato in un vero ristorante… Chi sa quanto ha guadagnato, è diventato ricco.» «Guadagna quello che vuole» disse Agnes con un bizzarro balbettio mentre proseguivano dalla stazione dell’aerea lungo la Trentottesima Strada. Invece di Fred fu un uomo alto e fosco dal fare distinto e un lungo naso regolare, che si alzò dal tavolino a incontrarle. «Margie,» disse Agnes «ecco Frank Mandeville.» Margie non lasciò mai trapelare che non avesse creduto fin da principio che così stavano le cose. L’attore le strinse la mano e s’inchinò come lei fosse una signorina grande. «Aggie, 2 non mi hai mai detto che la bimba era così bella… quali occhi… quali capelli…» pronunciò con la sua voce solenne. Fecero una meravigliosa colazione e poi andarono al Keith e sedettero in poltrona. Margie era senza fiato per l’eccitazione di trovarsi con un
vero attore. Questi aveva detto che l’indomani partiva per un giro di tre mesi in un numero di canto e piano e che Agnes l’avrebbe accompagnato. «E una volta finito ritorneremo e prepareremo una casetta per la mia bimba» disse Agnes. Margie ne fu tanto eccitata che soltanto quando si ritrovò a letto, nel dormitorio vuoto del convento, vide chiaro che per lei la cosa voleva dire che sarebbe rimasta con le suore tutta l’estate. Quando venne l’autunno lasciò il convento definitivamente e andò a stare col signore e la signora Mandeville, come loro si chiamavano, in due camere che davan sulla strada, prese in subaffitto da un chiroterapeuta. Era una vecchia casona di pietra scura dall’alto portico a scalini verso occidente sulla Settantanovesima Strada. Margie era contenta di starci e si faceva buona compagnia con la gente di teatro, tutta così elegantemente abbigliata e d’aspetto cittadino, che occupava gli alloggi di quella scala. Agnes le disse di stare attenta a non guastarsi, visto che tutti facevano notare i suoi occhi azzurri e i suoi riccioli che parevano quelli di Mary Pickford, e la sveglia impassibilità con cui diceva buffe ragioni. Frank Mandeville dormiva sempre fino a mezzogiorno, e Agnes e Margie facevano colazione sole di buon mattino, parlando a bisbigli per non svegliarlo e guardando dalla finestra i carri, le vetture e i furgoni che passavano fuori per la via, e Agnes spiegava a Margie i locali di varietà e gli spettacoli unici e tutto quel che provava nella sua nuova felicità e come fosse facile e libera quella vita e tanto diversa dalla corvè quotidiana di Broad Channel e come lei aveva conosciuto Frank Mandeville in un momento che era in bolletta e disperato e quasi sul punto di aprire il rubinetto del gas. Veniva ogni giorno a pranzare nella panetteria alle due del pomeriggio, giusto quando uscivano gli altri avventori. Stava, girato l’angolo, nella Centesimaquarta Strada. Una volta completamente all’asciutto, Agnes l’aveva tenuto a credito e le era tanto dispiaciuto per lui, visto quanto distintamente si comportava, disoccupato com’era; poi fece la pleurite e corse pericolo di diventar tisico, e lei era così sola e angosciata che non s’era preoccupata di quel che la gente avrebbe detto, ma era andata a coabitare con lui per curarlo e d’allora non se n’era più
staccata, e attualmente erano per tutti il signore e la signora Mandeville e Frank guadagnava quattrini a palate con il suo atto unico, “Il Trio Mandeville”. E Margie chiedeva dei colleghi di Frank Mandeville, di Florida Schwartz, una grossa donna dal vocione, i capelli oro caldo («È un fatto che si tinge» diceva Agnes «con l’henné») e di suo figlio, un odioso giovincello dal vitino di vespa, diciottenne, che non faceva nessun caso di Margie. Il chiroterapeuta del pianterreno, che tutti chiamavano Indian, era l’anima gemella di Florida, e questo era il motivo ch’eran tutti venuti a stare in casa sua. «La gente di teatro è originale, ma io credo che abbia un cuore d’oro» diceva Agnes. Il Trio Mandeville soleva esercitarsi durante il pomeriggio nella stanza d’entrata dove c’era un pianoforte. Suonavano ogni sorta di strumenti e cantavano canzoni, e Mannie, che sui cartelloni si chiamava Eddy Keller, faceva una danza eccentrica e un’imitazione di Hazel Dawn. Tutto ciò pareva meraviglioso a Margie, e fu talmente trasportata che credette di morire quando il signor Mandeville disse a un tratto, una sera ch’eran tutti intorno alla cena mandata a prendere in rosticceria, che la bimba doveva prendere lezioni di canto e di ballo. «Sarà denaro buttato, Frank» disse Mannie sopra un osso di pollo che stava rosicchiando. «Mannie, parli fuori tempo» ribatté Florida. «Suo padre era in gamba a cantare e ballare ai bei tempi» rilevò Agnes con la sua timida voce trafelata. Una carriera era qualcosa che tutti a New York avevano, e Margie decise che avrebbe avuto la sua. Scendeva per Broadway ogni giorno a prender lezione in un istituto ch’era nello stesso isolato del Lincoln Square Theater. Nell’ottobre il Trio Mandeville vi recitò per due settimane. Quasi tutti i giorni Agnes veniva a prenderla, finita la lezione, e si fermavano a mangiare un panino con un bicchiere di latte in una latteria, poi andavano allo spettacolo. Agnes non poteva mai capacitarsi di quanto carina e giovane apparisse la signora Schwartz dietro i lumi della ribalta e di come malinconico e distinto apparisse Frank quando entrava col suo pipistrello. Durante l’inverno anche Agnes trovò lavoro, a dirigere un tea-
room artistico, appena svoltando da Broadway nella Settantaduesima Strada, con una certa signorina Franklin, una dama dai capelli rossi che era teosofa e metteva il capitale. Lavoravano tutti così accanitamente che si vedevano soltanto la sera quando Frank e Florida e Mannie mangiavano un boccone in fretta prima di scappare al teatro. Il Trio Mandeville faceva Newark la prima volta che Margie calcò la scena. Doveva entrare a metà del numero Everybody’s Doing It, spingendo il cerchio, vestita di un abito di mussola azzurra che non le piaceva affatto perché le dava un’aria di sei anni e lei pensava che occorresse un’aria adulta per entrare in scena; doveva fare pochi passi di un ballo di ragtime e poi inchinarsi come le avevano insegnato al convento e scappar via col cerchio. Sovente durante le prove scoppiava in lacrime, avvilita dalle maligne osservazioni che faceva Mannie. Aveva una tremenda paura e il cuore le picchiava, mentre attendeva la battuta, ma tutto fu finito prima che lei sapesse quel che era stato. Era entrata di corsa dalle quinte sudice nel caldo fulgore scintillante del palcoscenico. Le avevano detto di non guardare verso il pubblico. Soltanto un attimo sbirciò la confusa caverna lucepolverosa di pallide facce in fila. Dimenticò un pezzo della sua arietta e tagliò la parte e si mise a piangere nel camerino, una volta finito l’atto, ma Agnes ritornò a cercarla dicendo che se l’era cavata con molta grazia, e Frank sorrideva, e persino Mannie non pareva trovar nulla di maligno da dire; cosicché, la volta dopo, il cuore non le batteva più tanto forte. Ogni minimo gesto che faceva aveva risposta dalla vaga caverna delle facce. Verso la fine della settimana si distingueva talmente che Frank decise di spostare il numero Everybody’s Doing It avanti al finale. Florida Schwartz aveva detto che Margery era un nome di nascita troppo volgare per la scena e allora scrissero sui cartelloni “La piccola Margo”. Tutto l’inverno e l’estate seguente recitarono nell’organizzazione Keith, dormendo in treno e in ogni sorta di alberghi e scendendo a Chicago, a Milwaukee, a Kansas City, a tante città, che Margie non ne
ricordava più il nome. Agnes venne con loro come guardarobiera e si occupava dei trasporti e correva a destra e a sinistra per tutti. Era sempre occupata a lavare e stirare e scaldare estratto in scatola su una stufetta a spirito. Margie finì per provar onta dell’aria meschina che Agnes aveva in strada accanto a Florida Schwartz. Quando si trovava con altri figli della scena e le chiedevano chi fosse secondo lei il miglior attore di varietà, rispondeva Frank Mandeville. Quando scoppiò la guerra, il Trio Mandeville era di ritorno a New York in cerca di nuove scritture. Una sera Frank stava spiegando il suo progetto di fare dell’atto unico un vero successo trasformandolo in una piccola operetta, quando lui e gli Schwartz caddero a bisticciare sulla guerra. Frank diceva che i Mandeville discendevano da una lunga trafila di nobiltà francese e che i tedeschi erano porci e barbari e l’arte non sapevano che fosse. Gli Schwartz non si tennero e risposero che i francesi erano degenerati e gente infida in fatto d’interessi e che Frank doveva loro qualcosa. Fecero un tale baccano che gli altri inquilini picchiarono sulle pareti e una signora a muso di cammello salì dal pianterreno in una veste da camera chiazzata di papaveri rossi e azzurri e coi capelli pieni di diavoletti per dir loro di starsene tranquilli. Agnes piangeva e Frank con una voce sonante ingiunse agli Schwartz di lasciare la stanza e non gettare mai più la loro ombra sulla sua porta, e a Margie venne uno spaventevole accesso di risa. Più Agnes le dava sulla voce più lei rideva. Solamente quando Frank la prese fra le braccia nel suo screziato costume dal taglio eccentrico e le lisciò i capelli e la fronte, Margie poté calmarsi. Quella notte andò a letto con un senso strano, e ansiosa nel suo intimo per il sentore di lozione aromatica, di energina e di sigarette egiziane, che le aveva irritato le narici quando si era appoggiata al suo petto. Quell’autunno tornarono i tempi difficili, a fatica si trovavano scritture di varietà e Frank non aveva una compagna per il suo atto unico. Agnes ritornò al locale della signorina Franklin e Margie dovette smettere le lezioni di canto e di ballo. Si ridussero in una sola stanza, con un’alcova a tendine dove dormiva Margie. Ottobre fu molto caldo quell’anno. Margie si sentiva disperata a bighellonare tutto il giorno per casa, il calorifero non si poteva
chiudere completamente e faceva troppo caldo anche con la finestra spalancata. Si sentiva sempre stanca. Il caseggiato sapeva di arricciatura di capelli, di pomate di bellezza e sapone da barba. Tutte le camere erano affittate a gente di teatro e non c’era istante della giornata che si potesse salire alla stanza da bagno senza incontrare per le scale gente dagli occhi gonfi, in accappatoio o in chimono. C’era, nel modo in cui gli uomini la guardavano quando li sfiorava passando nel corridoio, qualcosa di scottante e appiccicaticcio, che le dava un curioso imbarazzo. Amava Frank più di ogni altro. Agnes era sempre irritabile, frettolosa di recarsi al lavoro o stanca morta ritornandone allora, ma Frank parlava sempre con serietà a Margie, come fosse una signorina grande. I rari pomeriggi che restava in casa le dava lezioni di dizione e le raccontava storie di quando aveva recitato con Richard Mansfield. Le assegnava brani di una parte da imparare e lei doveva recitarglieli al suo ritorno. Quando non li sapeva, Frank si faceva gelido e camminava innanzi e indietro a grandi passi dicendo: «Fai pure, dipende da te, mia cara, se vuoi riuscire devi lavorare… I doni di fortuna li hai… ma senza un lavoro accanito non servono a nulla… Vedo che vuoi lavorare in un tea-room come la povera Agnes per tutta la vita». E allora Margie gli correva addosso, gli gettava le braccia al collo, lo baciava e diceva: «Davvero, Frank, lavorerò a più non posso». Frank restava tutto agitato quando Margie lo trattava così o gli scompigliava i capelli, e diceva: «Su bimba, niente confidenze» e proponeva di andare insieme a passeggiare in Broadway. Ogni tanto, quando aveva qualche soldo, andavano a pattinare al campo St. Nicholas. Parlando di Agnes, la chiamavano sempre la povera Agnes come se fosse un poco scema. C’era qualcosa di provinciale in Agnes. Ma il più del tempo Margie non faceva che stare in ozio o legger riviste nella stanza, oppure si buttava sul letto e ascoltava le ore sgocciolare così tremendamente adagio. Fantasticava di bei giovani che la portassero a teatro e a cena, e in che sorta di casa avrebbe abitato quando sarebbe stata una grande attrice e i gioielli che avrebbe portato, oppure le tornava in mente come Indian il chiroterapeuta le
aveva manipolato la schiena quella volta che si era sentita quella brutta emicrania. Era robusto e fosco e muscoloso in maniche di camicia mentre le lavorava sulla schiena con le mani dalle grosse nocche. Erano solamente gli occhi di quell’uomo che le davano un senso strano; occhi come quelli, ecco che la fissavano d’improvviso mentre scendeva passeggiando per Broadway e allora lei correva e non osava voltarsi per sapere se ancora la fissassero e giungeva a casa tutta trafelata e sgomenta. Un caldo pomeriggio della tarda stagione, Margie era gettata sul letto intenta a leggere un numero dello «Smart Set» acquistato da Frank, che Agnes le aveva fatto promettere di non leggere. Udì scricchiolare una scarpa e saltò a terra ficcando la rivista sotto il guanciale. Frank stava sulla porta fissandola. Non ebbe bisogno di guardarlo due volte per accorgersi che aveva bevuto. Negli occhi aveva quel tale sguardo e sul suo volto solitamente pallido appariva una vampa. «Ahah, ti ho presa stavolta, piccola Margo» le disse. «Scommetto che tu credi che io non sappia la parte» fece Margie. «Vorrei non sapere io la mia» disse lui. «Ho firmato poco fa il più lurido contratto di tutta la mia vita… Presto il mondo vedrà Frank Mandeville sulle sporche tavole di un burlesque.» Sedette sul letto col cappello floscio sempre in capo e si portò una mano sugli occhi. «Dio mio, sono stanco…» Poi levò a guardarla quegli occhi rossi e sbarrati. «Piccola Margo, tu non sai ancora che sia far fronte al mondo.» Margie disse, con un risolino, che sapeva benissimo, e gli sedette accanto sul letto e gli tolse il cappello e gli lisciò all’indietro i capelli sudaticci. Ciò facendo qualcosa dentro di lei l’atterriva, ma non poteva tenersi. «Andiamo a pattinare, Frank, è così orribile stare in casa tutto il giorno.» «Tutto è orribile» disse Frank. D’un tratto la tirò a sé e la baciò sulle labbra. Lei si sentì girare il capo all’odore di lozione aromatica e sigarette e whisky e garofano e ascelle che esalava da lui. Si divincolò per allontanarlo. «No, Frank, no.» Ma la teneva forte. Margie ne sentiva le mani tremare, il cuore picchiare sotto il panciotto. L’aveva afferrata a sé con un braccio e con l’altro le tirava via i vestiti. La sua
voce non era più la voce di Frank. «Non ti faccio male. Non ti faccio male, bambina. Dimentica. È nulla. Non posso più resistere.» La voce parlava, parlava supplichevole al suo orecchio. «Lascia. Lascia.» Margie non osava urlare per paura che i vicini venissero. Serrò i denti e picchiava e graffiava la grossa faccia dalle labbra umide che le premeva sopra. Si sentiva fiacca come in un sogno. Quando fu finito, lei non piangeva. Che le importava? Lui camminava su e giù per la camera sussultando. Margie si sollevò e ricompose il vestito. Le venne sopra e la scosse per le spalle. «Se mai dici qualcosa ti ammazzo, brutta marmocchia…» Andò poi alla catinella e si lavò la faccia. «Come potevo tenermi? non sono un santo… La tensione è stata troppa.» Margie sentì Agnes venire, lo scalpiccio dei suoi passi per le scale. Agnes sbuffava brancicando la maniglia della porta. «Ma che cosa c’è, in nome del cielo?» esclamò entrando trafelata. «Agnes, sono stato costretto a rimproverare la tua bambina» diceva Frank con la sua voce più teatrale. «Arrivo morto di stanchezza e ti trovo la bambina che legge quella sconcia rivista… Non posso tollerare… Almeno, finché sarete sotto la mia protezione.» «Oh Margie, avevi promesso di non farlo… Ma che ti sei fatto in faccia?» Frank avanzò al centro della camera, picchiettandosi per tutta la faccia con l’asciugamano. «Agnes, ho una confessione da farti… Ho avuto un alterco in Broadway. È stata per me una giornata assai penosa oggi. I miei nervi son tutti scossi. Che penserai di me, quando dovrò dirti che ho firmato un contratto con un burlesque?» «Ma è una fortuna» disse Agnes. «Davvero abbiam bisogno di denaro… Quanto guadagnerai ora?» «È una vergogna… venti la settimana.» «Oh sono così contenta… Credevo fosse accaduto qualcosa di terribile. Forse Margie potrà riprendere le sue lezioni.» «Se sarà buona e non butterà più via il tempo leggendo quella robaccia.»
Margie era tutta un brivido, come di gelatina, dentro di sé. Si sentiva spicciare un freddo sudore. Corse su per le scale, nel bagno, e chiuse a doppio giro e, incespicando alla volta della vaschetta, vi rigettò. Poi stette a lungo seduta sul bordo della vasca. Tutto quello che poté pensare fu di fuggirsene. Ma non pareva decidersi a fuggire. A Natale alcune amicizie di Frank le trovarono una parte in una recita di bambini. Guadagnò venticinque dollari per spettacolo e fu il tesoro di tutte le dame di società. Ciò le diede una gran boria. Quasi si fece cogliere con il ragazzo che impersonava il cavaliere, mentre lo faceva un’altra volta dietro certe vecchie scene e il teatro era buio durante una prova. Era insopportabile vivere nella stessa camera con Frank e Agnes. Li detestava ora. Nottetempo stava sveglia con gli occhi brucianti nell’alcova soffocante e ascoltava. Sapeva che cercavano di fare in silenzio, che non volevano che sentisse, ma lei non poteva fare a meno di tender le orecchie e tenere il fiato quando il lieve cigolio delle molle di quel vecchio sgangherato letto di ferro dove dormivano cominciava. Dormiva fino a tardi dopo quelle notti, d’un orribile sonno pesante dal quale non si sarebbe voluta svegliare più. Con Agnes cominciò a mostrarsi insolente e dispettosa e non voleva mai fare quel che le diceva. Non era difficile far piangere Agnes. «Accidenti di ragazza» diceva asciugandosi gli occhi. «Non posso più cavarne niente. È quello straccio di successo che le ha dato alla testa.» Quell’inverno cominciò a incontrare Indian sulla porta della sua sala di consultazione, le volte che passava, ritto là fosco e muscoloso nella giacchetta candida, sempre voglioso di discorrere o mostrarle un quadro o altro. Giungeva persino a offrirle le sue cure gratis, ma Margie guardava ardita in quegli strani occhi nerazzurri e se ne liberava scherzando. Poi un giorno gli entrò nello studio mentre non c’erano pazienti e gli sedette sulle ginocchia senza dire una parola. Ma il giovane che preferiva in tutto il caseggiato era un cubano di nome Tony Garrido, che suonava la chitarra per due sudamericani ballerini di maxixe in un locale di Broadway. Lo incontrava sempre sulle scale e seppe ogni cosa di lui e decise che ne era cotta, molto tempo prima che scambiassero una sola parola. Aveva un’aria così
giovane con quei grossi occhi marrone e il liscio volto ovale, d’una leggera tinta caffè, un po’ rosato sulle gote sotto i lunghi zigomi sporgenti. Margie si chiedeva stupita se avesse dappertutto lo stesso colore. Quello aveva modi cortesi e timidi e una voce sommessa da adulto. La prima volta che le rivolse la parola, una sera di primavera che lei indugiava sotto il portico, chiedendosi disperata che fare per non risalire nella stanza, Margie capì che si sarebbe innamorato di lei. Lo canzonò e gli chiese che cosa si dava alle sopracciglia per averle così nere. Lui disse ch’era la stessa cosa che rendeva i suoi capelli così belli e dorati e la invitò a prendere un gelato al selz. In seguito passeggiarono sul corso. Lui parlava bene l’inglese con un po’ d’accento che a Margie parve assai distinto. Senz’altro avevano smesso gli scherzi e lui le diceva della sua nostalgia per l’Avana e come smaniava di andarsene da New York e lei gli diceva che vita odiosa facesse e come tutti gli uomini del caseggiato eran sempre a darle pizzicotti e spintoni su per le scale, e come si sarebbe gettata nel fiume se avesse dovuto continuare a stare in un’unica stanza con Agnes e Frank Mandeville. Quanto poi a quell’Indian, non ne avrebbe tollerato il contatto, nemmeno se fosse stato il solo uomo al mondo. Non tornò a casa finché non fu l’ora che Tony doveva recarsi al centro, nel suo locale. Invece di cena, mangiarono qualche altro gelato al selz. Margie ritornò contenta come una pasqua. Mentre uscivano dallo spaccio aveva sentito una donna dire all’amica: «Guarda che bella coppia fanno». Naturalmente Frank e Agnes fecero il diavolo a quattro. Agnes pianse e Frank si montò a una passione superba e disse che rompeva la testa a quello sporco bisunto 3 se soltanto metteva un dito addosso a una bella innocente ragazza americana. Margie strillò che avrebbe fatto quel porco cane che le piaceva e disse le cose più indegne che le vennero in mente. Aveva deciso che la cosa da farsi era sposare Tony e scappare con lui a Cuba. A Tony l’idea di sposarsi non parve garbasse molto, ma Margie gli saliva nella cameretta sul corridoio, appena Frank usciva a mezzodì, e lo svegliava e lo stuzzicava e lo coccolava. Tony voleva far l’amore, ma lei non glielo permetteva. La prima volta che glielo vietò, Tony
ebbe uno schianto e si mise a piangere e disse che era un insulto e che a Cuba gli uomini non lasciavano le donne comportarsi a quel modo. «È la prima volta nella mia vita che una donna rifiuta il mio amore.» Margie disse che non c’era disposta, non prima almeno che fossero sposati e usciti da quel posto odioso. Finalmente un pomeriggio lo stuzzicò tanto che lui disse di sì. Margie si tirò i capelli sul cocuzzolo e indossò il vestito più da grande che avesse e andarono insieme con la sotterranea all’ufficio matrimoni. Tutti e due furono per morire di spavento quando si trattò di salire dall’impiegato. Tony aveva ventun anni e Margie disse di averne diciannove e a questo modo fu fatta. Margie aveva rubato il denaro nel portamonete di Agnes per pagare la licenza. Fu sul punto d’impazzire in quelle settimane che bisognò attendere perché Tony finisse la sua scrittura. Poi, un giorno di maggio, quando Margie bussò alla porta della sua camera, Tony le mostrò duecento dollari in biglietti, risparmiati da lui, e disse: «Ci sposiamo oggi… Partiamo domani per l’Avana. C’è da guadagnar molto laggiù. Tu ballerai, e io canterò e sonerò la chitarra». E fece il gesto di suonare con le dita affusolate di una delle sue manucce. Il cuore di Margie cominciò a dare grandi colpi. Corse giù dalle scale. Frank era già uscito. Buttò giù in fretta un biglietto per Agnes su un pezzo di cartone ritornato dalla lavanderia in una delle camicie inamidate di Frank: Agnes cara, non volermene. Tony ed io ci siamo sposati oggi e andiamo a stare all’Avana, Cuba. Dà la notizia a Papà se si fa vedere. Ti scriverò molto. Tenerezze a Frank. La tua riconoscente figliola Margery Poi gettò i suoi indumenti in una valigia inglese di porco, proprietà di Frank, ritirata allora dal monte, e fece le scale a tre gradini alla volta. Tony l’attendeva sotto il portico, pallido e tremante, con l’astuccio della chitarra e la valigia accanto. «Non badiamo alla spesa. Prendiamo un tassì» disse. Nel tassì Margie gli abbrancò la mano, era diaccia. Al municipio
era così sconvolto che dimenticò tutto il suo inglese e toccò a Margie far tutto. Presero a prestito l’anello dal giudice di pace. In un minuto era finito e si ritrovarono nel tassì che s’allontanava dal centro verso un albergo. Margie non riuscì mai a ricordare in seguito quale albergo fosse, soltanto avevan l’aria così sconvolta che l’impiegato non volle credere che fossero marito e moglie finché lei non gli mostrò la licenza di matrimonio, un gran foglio di carta tutto contornato di nontiscordardimé. Appena saliti in camera si baciarono frettolosi e si lavarono per uscire e andare a teatro. Prima passarono al Shanley a pranzare. Tony ordinò champagne costoso e ci fecero sopra molti risolini. Tony badava a ripeterle che razza di città ricca fosse l’Avana e come gli artisti laggiù erano veramente apprezzati, e che certi ricconi avrebbero pagato cinquanta, cento dollari per sera per sentirli suonare alle loro feste. «E con te, Margo, tesoro, guadagneremo due tre sei volte tanto… E prenderemo una splendida casa nel Vedado, un quartiere molto riservato, e la servitù là costa niente e tu sarai come una regina. Vedrai che ho molti amici laggiù, molti ricconi mi voglion bene.» Margie s’abbandonava appoggiata alla sedia, guardando il ristorante e le dame e i signori eleganti e i camerieri tanto deferenti e i piatti d’argento con cui tutto era servito e le lunghe ciglia di Tony che le sfioravano la gota rosa mentre parlava di che bel tepore facesse laggiù e la fresca brezza di mare, e le palme e le rose, e i pappagalli e gli uccelli canori nelle gabbie e come tutti spendessero all’Avana. Le pareva quella la sola giornata felice che avesse mai vissuto. Quando presero il piroscafo l’indomani, a Tony non restavano più che i denari per pagare i biglietti di seconda classe. Andarono a Brooklyn con l’aerea per risparmiare il tassì. Margie dovette portare le due valigie su per i gradini, visto che Tony diceva di aver mal di capo e temeva che gli sfuggisse di mano la custodia della chitarra. 1. Quarta parte di dollaro. (NdT) 2. Diminutivo di Agnes. (NdT) 3. Nel testo: greaser, (grassoso) messicano. (NdT)
Cine-giornale LIV non ci fu nulla di significativo nelle contrattazioni del mattino. La prima ora trascorse in compre e vendite generali allo scopo di pareggiare i conti, ma subito dopo le undici i prezzi furono meno oscillanti e a poco a poco si fissarono CLIENTI DI TIMES SQUARE CHE SI VEDON RIMANDARE CON MEZZA BARBA FATTA Lascerà marcire i raccolti nelle mani dei produttori se i prezzi non scendono IL SUICIDIO DI UNA BARONESSA RUSSA A MIAMI … quel tipo di ragazza che non va pupattola di un’ora Coolidge dipinge la prosperità della nazione in seguito alla sua politica CACCIA GROSSA NEI BOSCHI DEL JERSEY SULLE TRACCE DI UN LEOPARDO UNA MACELLAIA HA VEDUTO IL DELITTO Bisognava farlo e io lo feci, dice la signorina Ederle QUARANTADUE IMPUTATI NEGLI SCANDALI DELLA FLORIDA Ho veduto una donna che somigliava alla signora Hall strapazzare una coppia presso il luogo del delitto, dice il nuovo teste parecchie centinaia di tende e altri leggeri ripari drizzati da campeggiatori su di un colle a sud di Front Street, che domina Hempstead Harbor, erano disposti in fila davanti al ciclone come l’erba si presenta alla falce E quando suoneranno Vien la sposa tu sarai fuori 3000 AMERICANI SENZA UN SOLDO A PARIGI Sono una poveretta per me non c’è piacere mi ama per mia disdetta il figlio del droghiere
NOVE VITTIME NELLE INONDAZIONI DEL NORD LO SCEICCO MUORE Rudolph Valentino, il famoso astro dello schermo, ebbe un collasso improvviso ieri nel suo appartamento dell’Ambassador Hotel. Qualche ora dopo venne sottoposto
Tango lento Il figlio diciannovenne di un veterinario di Castellaneta nell’Italia meridionale venne imbarcato per l’America come un mucchio di altri giovani italiani indocili, quando i suoi rinunciarono alla speranza di dominarlo; che andasse a fondo o stesse a galla e magari spedisse a casa qualche lira per vaglia internazionale. Ne avevano ormai abbastanza. Ma Rodolfo Guglielmi voleva riuscire. Trovò un posto d’aiuto giardiniere in Central Park, ma quello non era un lavoro che gli andasse a genio; voleva riuscire alla luce dei riflettori; il denaro gli scottava la tasca. Bazzicò per i ritrovi facendo lavori occasionali, scopando per i camerieri, lavando automobili; era indolente, bello, ben fatto, snello, di carattere cordiale e vanitoso; era un ballerino di tango nato. Donne fameliche d’amore lo trovarono carino. Cominciò a occuparsi come cavaliere di tango in sale da ballo e ritrovi; fece coppia con una ragazza di nome Jean Acker in un giro di varietà e prese il nome di Rudolph Valentino. Finito sulla costa, fece capo a Hollywood, lavorò per molto tempo da comparsa a cinque dollari al giorno; i direttori cominciarono ad accorgersi ch’era assai fotogenico. Ebbe la sua occasione nei Quattro cavalieri e divenne il gigolo nei sogni di tutte le donne. Valentino trascorse la vita nell’incolore riverbero delle lampade klieg, in ville di stucco ingombre di ninnoli, tappeti orientali, pelli di tigre, negli appartamenti nuziali degli alberghi, in accappatoi di seta, in macchine private. Non faceva altro che salire in lussuose automobili o scendere da lussuose automobili, o carezzare il collo di bei cavalli. Dovunque andasse le sirene dei poliziotti in motocicletta lo precedevano stridendo divampavano i lampi del magnesio, le vie erano ingombre di visi isterici, mani dimenanti, occhi folli; gli tendevano gli album di autografi, gli strappavano i bottoni, gli
tagliarono una coda dal suo ammirevole abito da sera; gli rubavano il cappello e davano strattoni alla cravatta; i suoi domestici gli scacciavano le donne da sotto il letto; tutta la notte nei circoli e nei ritrovi notturni attrici in libidine di prime parti gli facevano gli occhi languidi sotto le ciglia truccate. Lui voleva riuscire sotto il riverbero dei riflettori milionari di El Dorado; lo Sceicco, il Figlio dello Sceicco; esibizioni personali. Sposò la sua antica collega di scena, divorziò, sposò la figlia adottiva di un milionario, si cacciò in processi coi produttori che avvilivano l’arte dello schermo, spese un milione di dollari in un solo viaggio in Europa; voleva riuscire alla luce dei riflettori. Quando il «Tribune» di Chicago lo chiamò un piumino rosa da cipria e tutti cominciarono a scuotere il capo a un braccialetto da schiavo, che portava dicendolo un regalo di sua moglie, e al suo gusto per i versi rancidamente sentimentali di cui pubblicò un volumetto intitolato Sogni ad occhi aperti, e i bisbigli si moltiplicarono intorno alla testimonianza del suo processo di divorzio, che lui e la prima moglie non avevano mai dormito insieme, ebbe il cuore spezzato. Tentò di sfidare a duello il «Tribune» di Chicago; voleva riuscire riuscire in quest’America di grossi maschi pugni-sodi donnacavalli gioca-poker truffa-Borsa (era un bravo pugilatore e stava bene in sella, amava il deserto come lo sceicco e s’era fatto abbronzare la pelle dal sole di Palm Springs). Ebbe un collasso nel suo appartamento dell’Ambassador Hotel a New York: ulcera gastrica. Quando i dottori operarono in quel suo bel corpo elegante vi trovarono un principio di peritonite; la cavità addominale conteneva liquame e frustoli alimentari in quantità, i visceri eran rivestiti di una stratificazione grigio-verdastra; una perforazione rotonda d’un centimetro di diametro appariva nella parete anteriore dello stomaco;
il tessuto dello stomaco tutt’intorno all’ulcerazione per un centimetro e mezzo era necrotico. L’appendice era infiammata e ritorta contro il tenue. Quand’egli rinvenne dall’etere la prima cosa che disse fu: «Ebbene, mi sono comportato come un piumino rosa da cipria?» Quel suo costosamente massaggiato corpo d’attore lottò contro la peritonite per sei giorni. Il centralino dell’ospedale era bloccato dalle telefonate, tutti i corridoi ammonticchiati di fiori, la folla riempiva ogni via all’esterno, stelle del cine che pretendevano d’esser sue fidanzate prendevano il treno per New York. A tarda ora nel pomeriggio una macchina s’arrestò al portone dell’ospedale (dove giornalisti e fotografi dalle dita sudice facevan crocchio, seccati, stremati, occhi accesi, fumando troppe sigarette, facendo corse al più vicino spaccio, scambiandosi freddure e rivelazioni, sperando che morisse in tempo per i giornali della sera) e una donna, che disse d’essere una cameriera al servizio di una ballerina che era stata la prima moglie di Valentino, discese. Consegnò a un inserviente una busta indirizzata all’astro dello schermo e sottoscritta Da parte di Jean, e un pacco. Il pacco conteneva una trapuntina con orli di pizzi e la parola Rudy ricamata nei quattro angoli. L’accompagnava una federa intonata a un profumato cuscino di seta azzurra. Rudolph Valentino non aveva che trentun anni quando morì. I suoi direttori progettarono di fare una grande cosa del suo ben reclamizzato funerale ma la gente nelle vie era troppo impazzita. Mentre egli giaceva solennemente in una bara coperto di un drappo d’oro, decine di migliaia di uomini, di donne e di bambini gremivano le vie all’esterno. A centinaia vi furono calpestati, ebbero i piedi schiacciati dai cavalli della polizia. Nella pioggia e nel sudore i poliziotti persero la testa. Masse pigiate si gettarono sotto gli sfollagente e gli zoccoli levati dei cavalli. La cappella funeraria venne denudata, uomini e donne lottarono per un fiore, un brano di tappezzeria, un frammento del vetro rotto della finestra. Si sfondarono vetrine. Macchine ferme vennero rovesciate e frantumate. Quando finalmente la polizia a cavallo dopo ripetute cariche respinse
la folla di Broadway, dove il traffico rimase fermo per due ore, si trovarono ventotto scarpe scompagnate, una furgonata di paracqua, giornali, cappelli, maniche strappate. Tutte le ambulanze di quel settore della città ebbero da fare a portar via donne svenute, ragazze calpestate. Alcuni epilettici ebbero accessi. I poliziotti raccolsero gruppi di bambini perduti. I fascisti mandarono una guardia d’onore e gli antifascisti la cacciarono via. Altri tumulti, teste rotte, piedi pesti. Quando il pubblico ebbe vietato l’accesso alle sale delle pompe funebri centinaia di donne ubriacate dai giornali si presentarono per visitare il povero corpo, pretendendo d’essere ex colleghe di coppia, antiche compagne di giochi, parenti venuti da casa, stelle del cine; di minuto in minuto una ragazza sveniva di fronte alla bara e la rianimavano i giornalisti prendendo nota del suo nome, indirizzo e diritto alla notorietà nella pubblica stampa. I necrofori e i portacordoni di Frank E. Campbell, dignitosi reggitori di panno nero e portatori di crespo, andarono a un pelo dall’esaurimento nervoso. Perfino il caporione quella volta ebbe la sua satolla di pubblicità. Passarono due giorni prima che i poliziotti arrivassero a sgomberare le vie tanto da far passare tutti i fiori spediti da Hollywood e i giornali della sera descriverli. La funzione alla chiesa ebbe miglior successo. Il commissario di polizia relegò il pubblico a quattro isolati di distanza. Parteciparono molte autorità. La Fidanzata di tutta l’America 1 singhiozzando amaramente in cappellino di paglia nero con nastro nero e fiocco nero dietro, in velo nero di georgette su nero e colletto e polsini bianchi di pizzo, seguiva il feretro ch’era ricoperto d’un letto di rose carnicine mandate da una stella che apparve al funerale fittamente velata e svenne e dovettero riportarla al suo appartamento dell’Ambassador Hotel dopo che ebbe mostrato ai cronisti un telegramma, preteso inviato da uno dei dottori, affermante che Rudolph Valentino aveva parlato di lei sul suo letto di morte come della sua sposa futura.
Una giovane si tolse la vita a Londra. I parenti che giungevano dall’Europa vennero ricevuti dal corpo di riserva della polizia e da bandiere drappeggiate di crespo. L’ex campione Jim Jeffries disse: «Ebbene, riusciva». Il campione stesso permise citassero di lui che il ragazzo amava il pugilato ed era un grande ammiratore del campione. Il treno funebre partì per Hollywood. A Chicago ancora altra gente venne malmenata per vedere la bara, ma comparve soltanto nelle pagine interne. Il treno funebre giunse a Hollywood a pagina 23 del «Times» di New York. 1. Mary Pickford. (NdT)
Cine-giornale LV FOLLA NELLE VIE PAZZO CHE FA SCOPPIARE UNA BOMBA NELLA BANCA DI PITTSBURGH Krishnamurti ci dice che il suo messaggio è la felicità universale Chiudi l’uscio ecco che vengono dai vetri I MARINAI AMERICANI SBARCANO NEL NICARAGUA PER PROTEGGERE GLI STRANIERI LA CATTURA DI PANGALOS; PRIGIONIERO AD ATENE Chiudi i vetri ecco che vengono dall’uscio Dice che ha veduto la macellaia ma non può identificare l’accusato S’ACCUMULANO I FONDI IN NEW YORK il desiderio di far profitti su profitti andò crescendo e la ricerca del facile guadagno divenne pressoché universale. Tutto ciò significava un tentativo di appropriarsi la proprietà altrui senza rendere un servizio corrispondente Il “medico” che ebbe così gran parte nelle esequie di Valentino viene smascherato come ex detenuto MAI VISTO, DICE IL DIRETTORE Chiudi l’uscio ecco che vengono dai vetri come spettri ecco che vengono dai muri
Occhio fotografico (47) sirene scoppiarono nella nebbia sul porto trombe di tutti i paesi fischietti d’ogni forma salgono dal fiume e sbattimento d’eliche e pulsar di macchine campane l’uniforme fruscio intermittente delle onde tagliate da prore nell’invisibile agitati a tastoni per la finestra tentacoli si tendono sibilanti a scattare la molla stanotte partire imbarcarsi in qualche luogo entrare firmare dove sono i puntini arruolarsi diventare uno dei manda al monte il vecchio impermeabile dell’incertezza (in cui ti aggobbi solitario dalla rovesciata immagine sulla retina laboriosamente con i colori le forme le parole il ricordo di luce e di scuro sforzandoti di ricostruire l’ieri di ritagliare figure di carta a simulare uno sviluppo fare un ordito di notizie che sian visi spianati o aggrinziti nelle diverse noncurate velocità del tempo) stanotte adesso la stanza è piena del sussulto e del tumulto della partenza l’esploratore butta insieme l’indispensabile bagaglio si prepara l’inizio meglio le vie prima due passi su e giù per la città lungo gli scali sotto l’aerea scrutando le facce nei tassì i conduttori di furgoni i vecchi che masticano nelle osterie i pezzenti ubriachi che sbavano vomito nei viottoli che cosa legge il giornalaio? che cos’ha bisbigliato quel vecchio che vende castagne alla grassona dietro i sottaceti? ma dove va quella povera ragazza dal cappello rosso che corre su per gli scalini della sotterranea e la guardia che canzona quell’altra guardia attraverso la via? e lo schiocco di un bacio da quelle due ombre sotto il portico della casa scura e le facce imbronciate all’angolo d’improvviso spalancate da un urlo al tonfo di un colpo una fischiata calpestio che fugge il fattaccio? stanotte adesso ma invece trovi te stesso (se te stesso è lo stesso piagnucoloso
fannullone che ti fa compagnia nelle camminate senza scopo) dimenticata la caccia al lavoro negletto il bollettino dove i destini son scribacchiati a calce tra piluccanti cinesi al Thalia gli orecchi storditi dallo schianto dei gong esotici il chioccolare delle raganelle lo zufolo di flauti incomprensibili la cadenza e il guaito dei discorsi inintelligibili musica lazzi atteggiamenti costumi d’un altro mondo un forestiero non bene identificato destinazione sconosciuta il cappello tirato sulla ce l’ha? faccia
Charley Anderson Era una luminosa, metallica giornata di gennaio quando Charley scese nel centro a far colazione con Nat Benton. Giunse all’ufficio dell’agente di Borsa un po’ in anticipo, e sedette ad attendere in una stanza vuota, guardando fuori dagli ampi finestroni intelaiati d’acciaio il North River e la statua della Libertà e la baia, al di là, tutta luccicante, increspata, verde sotto il vento di nord-ovest, picchiettata dagli schizzi candidi di fumo dei rimorchiatori, striata da bave di brezza e dalle scie ribollenti di navi da carico rivolte al vento, variegata di battelli e chiatte e traghetti veicoli e barconi e i rossi smozzicati traghetti passeggeri. Una goletta a vele grigie filava innanzi al vento. Charley sedeva alla scrivania di Nat Benton fumando una sigaretta, attento a gettare tutta la cenere nel lucido recipiente d’ottone che stava accanto alla scrivania. Trillò il telefono. Era l’impiegata del centralino. «Signor Anderson… il signor Benton mi ha detto di pregarvi di scusarlo ancora per qualche istante. È giù al pianterreno. Sarà subito qui.» Un poco dopo Benton sporse dalla fessura della porta il suo sottile viso pallido dal lungo collo che pareva quello di un pulcino. «Salve, Charley… torno subito.» Charley ebbe il tempo di fumare un’altra sigaretta prima che Benton fosse di ritorno. «Gioco che morite di fame.» «Niente di male, Nat, mi son goduto il panorama.» «Panorama?… Già… Ecco, io non credo di guardar fuori da quella finestra una volta sola in tutta la settimana… Però è stato da uno di quei maledetti traghetti rossi che il vecchio Vanderbilt ha preso lo slancio… Credo che se levassi il naso dal segnalatore una volta ogni tanto, non mi farebbe male… Venite, andiamo a mangiare qualcosa.» Scendendo nell’ascensore, Nat Benton continuava a parlare. «È un fatto che è difficile avere il bene di vedervi.» «È la prima volta, da un anno, che depongo la tuta» disse Charley ridendo. Il freddo pelava quando uscirono dalla porta girevole. «Sapete, Charley, si è fatta una gran conversazione proprio su voialtri giù in
strada… Le Askew-Merritt son salite di cinque punti ieri. L’altro giorno c’era un tale di Detroit, un tipo in gamba… conoscete gli impianti Tern… che vi cercava dappertutto. Mangeremo insieme un boccone la prossima volta che sarà in città.» Quando furono all’angolo sotto l’aerea una raffica gelida li sferzò in faccia e riempì i loro occhi di lacrime. La via era affollata; uomini, fattorini, belle stenografe, tutti avevano lo stesso sguardo preoccupato e le labbra increspate come Nat Benton. «Un bel freddo, oggi.» Benton ansava, stringendosi il bavero del soprabito. «Questi termosifoni ci rammolliscono.» Si cacciarono in un edificio e discesero nel caldo profumo di salsiccia d’un ristorante sotterraneo. I loro visi formicolavano ancora per il gelo, quando si furon seduti e studiarono la lista. «Sapete,» diceva Benton «ho in mente che voialtri siate incamminati a guadagnar qualcosetta laggiù.» «È stato un lavoro metter su la faccenda» disse Charley cacciando il cucchiaio in un piatto di brodo di piselli. Aveva fame. «Tutte le volte che si gira la schiena, qualcosa si rompe e tutto va al diavolo. Ma adesso ho trovato un diavolo d’un tipo per caporeparto. Un tedesco che lavorava negli impianti Fokker.» Nat Benton mangiava panini di arrosto crudo e latte scremato. «Non ho più stomaco che…» «Che John D. Rockefeller» finì Charley. Tutti e due risero. Benton si rimise e discorrere. «Ma, come dicevo, non m’intendo di produzione, eppure ho sempre avuto in mente che il segreto per far denari in questo campo fosse di scoprire gente adatta a lavorare per voi. O lavorano per voi o voi lavorate per loro. Così stanno le cose. Dopo tutto, voialtri mettete fuori i prodotti laggiù a Long Island City, ma se volete fare i soldi bisogna che veniate qui a prenderli… Non è forse vero?» Charley levò la testa dal succulento filetto che stava per tagliare. Scoppiò in una risata. «Lo credo bene» disse. «Uno sarebbe un bell’idiota se per tutta la vita tenesse il naso sui tavolini da disegno.» Parlarono qualche tempo di golf e poi, mentre prendevano il caffè, Nat Benton disse: «Charley, io volevo soltanto passarvi la parola,
considerato che siete un amico del vecchio Ollie, degli Humphries e tutto il resto… voi ragazzi non dovete vendere le vostre azioni. Se fossi in voi io raggranellerei tutto il contante possibile, come margine, e tante ne compaiono tante ne acquisterei. Presto avrete la vostra occasione». «Credete che continueranno a salire?» «Questo che vi dico, tenetelo sotto il cappello… Merritt e quegli altri sono preoccupati. Stanno vendendo; aspettatevi quindi una caduta. È questo che quelli del Tern di Detroit aspettano per intrufolarvisi con poca spesa, capite: la vostra impresuccia non dispiace a quella gente… Sono convinti che il vostro motore è un portento… Se voi siete d’accordo, volentieri mi occuperei dei vostri titoli, non per altro che in memoria dei bei tempi, voi mi capite.» Charley rise. «Giuda, non mi ero mai immaginato in possesso di un conto in Borsa… ma perdio, forse avete ragione.» «Non vorrei vedervi svegliare un bel mattino trovandovi buttato su una strada, mi capite, Charley.» Dopo ch’ebbero mangiato, Nat Benton chiese a Charley se aveva mai veduto le operazioni in Borsa. «È interessante a vedersi per chi non c’è mai stato» disse; e condusse Charley attraverso Broadway, dove il vento sferzante tagliava la faccia, giù per una via angusta sovrastata da edifici altissimi, in un vestibolo affollato. «Accidenti, questo freddo pela le orecchie» disse. «Dovreste vedere laggiù di dove vengo io» disse Charley. Salirono su un ascensore e uscirono in una stanzuccia dove certi personaggi anziani in uniforme salutarono il signor Benton con notevole rispetto. Nat mise la firma in un registro e vennero introdotti per una porticina nella loggia del pubblico, dove rimasero un minuto guardando giù in un immenso salone verdastro, che pareva una stazione ferroviaria, sopra le teste di una folla di gente, qualcuno in uniforme, altri con distintivi bianchi, che ribolliva adagio intorno ai luoghi di mercato. Ora la folla s’aggruppava e addensava a uno sportello e ora a un altro. L’ambiente era pieno di scalpiccio e d’un sommesso ticchettio di macchine, in cui le voci si perdevano. «Non ne ha troppo l’aria,» diceva Nat «eppure è qui che tutto muta tasca.» Nat additò agli sportelli dove si contrattavano le varie voci di
titoli. «Immagino che non facciano gran caso delle azioni aeronautiche» disse Charley. «No, adesso tutto è acciaio, petrolio, e industrie automobilistiche» rispose Nat. «Lasciamogli ancora qualche anno… che ne dite, Nat?» fece Charley reboante. Charley si diresse alla periferia sull’aerea della Seconda Avenue e proseguì sul Queensboro Bridge. Alla Queens Plaza scese e mosse i piedi verso l’autorimessa dove teneva la sua macchina, un macinino Stutz acquistato di seconda mano. Il traffico era opprimente e Charley si sentì stanco e irritato prima di giungere alla fabbrica. Il cielo s’era ricoperto e una neve asciutta cadeva sul vento. Entrò nel cortile e diede uno schianto ai freni sulla cenere cricchiante di fronte all’ufficio, poi si tolse il caschetto imbottito da aviatore e stette un momento seduto nella macchina, dopo aver spento il motore, tendendo l’orecchio al ronzio, al turbinio e allo strepito della fabbrica. «Quei lavativi mollano» borbottò sottovoce. Fece un attimo capolino nell’ufficio di Joe, ma Joe era occupato a parlare con un tale in giacchetta di pelle di tasso che aveva l’aria di un agente di cartelle. Allora si precipitò per il corridoio verso il suo ufficio, disse: «Salute, Ella, mandatemi il signor Stauch» e sedette alla scrivania coperta di appunti in fogli azzurri e gialli. “Roba da matti” pensava “stare incollato a un tavolo tutta la vita.” Il viso serio, quadrato e pallido di Stauch, sovrastato da un ciuffo di capelli incolori sporgenti da un paraocchi verde, gli si piegava sopra. «Sedete, Julius» gli disse. «Come va?… Tutto è in ordine alla lucidatura?» «Ach, certo, ma abbiamo avuto due guasti ai magli in un giorno.» «Porco cane. Andiamo a vedere.» Quando Charley ritornò all’ufficio aveva una striscia di unto in faccia. Teneva ancora in mano un micrometro olioso. Erano le sei. Chiamò Joe al telefono. «Ciao, Joe, vai via?» «E già, ti aspettavo; che cos’è successo?» «Al solito: strisciavo a terra con la pancia nell’untume.» Charley si lavò mani e viso al lavatoio e corse giù per i gradini coperti di gomma. Joe lo aspettava all’ingresso. «Mia moglie ha la mia auto, Charley, prendiamo la tua» disse Joe. «Ci sarà un bel ventaccio, Joe.» «Possiamo sopportarlo.» «Buona sera, signor Askew, buona sera,
signor Anderson» disse il vecchio guardiano in berretto turchino e paraocchi, che chiudeva alle loro spalle. «Senti, Charley» disse Joe quando si furono infilati nella corrente del traffico in fondo alla viuzza. «Perché non lasci che Stauch si occupi lui del lavoro minuto? Mi sembra abbastanza all’altezza.» «Se ne intende maledettamente più di me» disse Charley aguzzando gli occhi attraverso il parabrezza agghiacciato. I fanali che venivano in direzione inversa facevano grandi sbocci di luce scintillante nella neve fitta. Sul ponte le travature eran già tutte segnate di nette strisce candide. Tutto quel che si poteva vedere del fiume e della città era un turbinio d’ombre, ora buio ora splendido. Charley ebbe tutto il suo daffare a evitare che l’auto slittasse sui punti gelati della passerella. «Evviva, Charley» disse Joe mentre scivolavano giù per la rampa nella via di transito piena di luce dorata. Traversando la Cinquantanovesima dovettero rallentare a passo di lumaca. Erano irrigiditi dal freddo e furon le sette e mezzo prima che fermassero al portone dell’edificio in Riverside Drive dove Charley aveva abitato tutto l’inverno con gli Askew. La signora Askew e due bimbette dai capelli gialli vennero all’uscio. Grace Askew era una donna dall’aria sbiancata e dai capelli pallidi, con leggere zampe d’oca dietro gli occhi e ai lati del collo che le davano un tenero aspetto gualcito e lamentoso. «Ero preoccupata» disse «perché non avevate la macchina, in questa tormenta.» Jean, la bimba più alta, saltava su e giù vociando: «Nevica, nevica, nevica, ci sarà la neve». «Voi, Charley,» disse Grace con una voce canzonatrice, mentre entravano nel salotto, che odorava tiepido della cena imminente, a tender le mani davanti ai ceppi a gas «ha telefonato più di venti volte. Quella donna deve credere che io cerchi di allontanarvi da lei.» «Chi… Doris?» Grace strinse le labbra e annuì. «Ma, Charles, fareste bene a restare con noi a cena. C’è una coscia d’agnello con patatine dolci, che è una meraviglia. Sapete bene che vi piaccion di più i nostri pranzi che non quei pasticci di fantasia che vi danno là…» Charley era già al telefono. «Oh Charley» gli rispose il dolce
bisbiglio di Doris «ti temevo bloccato dalla neve a Long Island. Ti ho chiamato là al telefono, ma nessuno rispondeva… Ho un posto libero… Viene a cena certa gente che ti piacerebbe conoscere… Era ingegnere sotto lo zar. Siamo tutti in attesa di te.» «Ma ti assicuro, Doris, non sto più in piedi.» «Sarà uno svago. La mamma è andata nel Sud e tutta la casa è per noi. Ti aspettiamo…» «Sempre questi sporchi russi» borbottò Charley mentre correva in camera sua e si ficcava nell’abito da sera. «Guarda, guarda, il pelandrone» canzonò Joe dalla poltrona dove stava leggendo il giornale della sera con le gambe distese contro i ceppi a gas. «Papà, che vuol dire pelandrone?» intonò Jean. «Grace, volete essere tanto gentile?» e Charley si accostò arrossendo alla signora Askew, con le due estremità della cravatta nera penzolanti dal colletto. «Certo questa si chiama devozione» disse Grace alzandosi dalla sedia – per annodargli la cravatta sporse la punta della lingua nell’angolo della bocca – «in una notte simile.» «Io la chiamerei demenza, se chiedete a me» disse Joe. «Papà, che vuol dire demenza?» gli fece eco Jean, ma Charley si stava già infilando il soprabito mentre aspettava l’ascensore nel corridoio finto marmo pieno d’un campionario di odori di tutte le cene da tutti gli alloggi di quel piano. S’infilò i guanti di lana mentre saliva in auto. Nel giardino la neve gli sibilò sotto le ruote. Svoltando dal passaggio nella Cinquantanovesima Strada, gli capitò di slittare, si riprese, slittò un’altra volta. Le ruote morsero il marciapiede proprio a due passi da una guardia civica che stava all’angolo picchiandosi le braccia sul petto. La guardia civica aprì gli occhiacci. Charley scattò la mano alla fronte in un secco saluto. La guardia civica rise. «Birichino, birichino» disse, e continuò a menare le braccia. Quando la porta di casa Humphries gli si aprì davanti, i piedi di Charley affondarono d’un tratto nella folta lanugine di un tappeto del Belucistan. Doris venne a incontrarlo. «Oh, sei stato un tesoro a venire con questo tempaccio» tubò. Charley le diede un bacio. Desiderò che non avesse sulle labbra tanto rossetto appiccicaticcio. La strinse a sé, tanto flessuosa in quell’abito da sera verde pallido. «Il tesoro sei tu» sussurrò.
In sala si sentivano voci, accenti stranieri, e il tintinnio del ghiaccio in uno shaker. «Vorrei che potessimo star soli» disse rocamente. «Oh capisco, Charley, ma erano gente che dovevo proprio ricevere. Può darsi che vadano via presto.» Gli aggiustò la cravatta, gli lisciò i capelli e se lo spinse innanzi nella sala. Quando l’ultimo degli invitati di Doris se ne fu andato, rimasero loro due nel vestibolo, a fronte. Charley trasse un profondo respiro. Aveva bevuto una filza di cocktail e champagne. Non ne poteva più dal desiderio. «Perbacco, Doris, era difficile mandarli giù.» «Sei stato ben gentile, Charley, a venire.» Charley sentì una furia amara, ribollente, nascergli dentro. «Senti, Doris, ti debbo parlare…» «Oh oh, facciamo sul serio.» Gli fece una boccaccia, mentre si lasciava cadere sul sofà. «Ascoltami, Doris… son pazzo di te, lo sai…» «Oh, ma Charley, ci siamo tanto divertiti insieme… non vorrai guastar tutto così presto… Lo sai, il matrimonio non è sempre quel gran sollazzo… Quasi tutte le mie amiche che si sono sposate hanno fatto una vita d’inferno.» «Se è questione di soldi, non preoccuparti. L’impresa si mette a gonfie vele… Con te non direi mai una bugia. Chiedilo a Nat Benton. Proprio oggi mi ha spiegato come potevo cominciare subito a incassare.» Doris si alzò, gli venne accanto e lo baciò. «Ma sicuro, era uno sciocchino lui… Devi credere che io sia un’indegna, avida donnetta. Non capisco perché mi volevi sposare se eri convinto che io fossi così. Sul serio, Charley, quel che davvero mi farebbe felice sarebbe di andarmene di qui e guadagnarmi la vita. Detesto questa vita di parata.» Charley l’afferrò. Lei lo respinse. «È l’abito, caro, vedi, che costa denaro, non io… E adesso andrai a casa e ti metterai a letto da ragazzo ubbidiente. Hai l’aria esausta.» Quando Charley fu in strada, s’accorse che la neve era penetrata anche sul sedile della macchina. Il motore appena si moveva. Non c’era modo di accenderlo. Telefonò all’autorimessa che gli mandassero qualcuno per metterlo in marcia. Poi, visto che era in cabina, poteva anche telefonare alla signora Darling. «Ma che notte, che notte, piccolo. Be’, visto ch’è il signor Charley, può darsi che ci riesca di
combinare qualcosa, ma così di punto in bianco… e poi è la fine della settimana. Basta… fra un’oretta.» Charley passeggiò su e giù nella neve, di fronte all’edificio, aspettando che venisse qualcuno dall’autorimessa. La cieca bile furibonda gli ribolliva ancor dentro. Quando vennero finalmente dall’autorimessa e accesero il motore, lasciò che il meccanico la riconducesse. Poi girò l’angolo e andò in uno spaccio che sapeva. Le vie eran deserte. Fitta neve gli frustava il viso mentre scendeva i gradini dell’ingresso a pianterreno. La sala era piena di uomini e ragazze semisbronzi che vociavano e squittivano. Charley si sentì voglia di tirare il collo a tutti quei fottuti. Tracannò quattro whisky l’uno dopo l’altro e si diresse dalla signora Darling. Salendo nell’ascensore cominciò a sentirsi brillo. Diede al ragazzo un dollaro e colse con la coda dell’occhio il riso felice e sorpreso del moretto che si ficcava il biglietto in tasca. Una volta entrato cacciò un urrà. «Scusate, signor Charley,» disse la cameriera negra in cuffia e grembiale inamidato, che gli aveva aperto «sapete già che la signora non vuole baccano… e voi siete un signore così distinto.» «Ciao, piccola.» Non guardò quasi la ragazza. «Spegni la luce» disse. «Ricorda che ti chiami Doris. Va’ nella stanza da bagno e spogliati e non scordare di empirti le labbra di rossetto, rossetto in abbondanza.» Spense la luce e si strappò di dosso gli abiti. Nell’oscurità era difficile sfilare i bottoni della camicia inamidata. Abbrancò con le due mani il petto rigido e squarciò tutti gli occhielli. «E adesso vieni, Doris, porco mondo. Ti amo, sai, vigliacca.» La ragazza tremava. Quando lui l’afferrò scoppiò in lacrime. Charley dovette far portare del liquore per consolarla un poco e ciò lo rimontò. L’indomani si svegliò tardi e si sentiva troppo giù per andare in fabbrica; non aveva voglia di uscire, tutto quello di cui aveva voglia era bere, e così si trattenne tutto il giorno bevendo gin e amari nel salottino, accecato di tendaggi, della signora Darling. Nel pomeriggio la signora venne a trovarlo e giocò con lui alle carte e gli raccontò come a lei un cantante d’opera avesse rovinato l’esistenza, e si provò a ridurlo a sola birra. La sera Charley le fece di nuovo telefonare alla stessa ragazza. Quando questa giunse, cercò di
spiegarle che non era un matto. Si risvegliò solo nel letto, smaltito tutto e disgustato. Gli Askew stavano facendo colazione quando, il mattino della domenica, giunse a casa. Le bimbe eran distese sul pavimento che leggevano la pagina umoristica. Su tutte le sedie erano sparsi giornali festivi. Joe stava seduto in accappatoio fumando il sigaro, sull’ultima tazza di caffè. «Proprio a tempo per una bella tazza di caffè espresso» disse. «Dev’esser stata proprio una gran serata» fece Grace, ridendosela. «Ho preso parte a un pokerino» brontolò Charley. Quando sedette, gli si aprì il soprabito e tutti videro il petto della camicia strappato. «Volevo ben dire che era un pokerino coi fiocchi» fece Joe. «Non parlarmene» disse Charley. «Vado a lavarmi la faccia.» Quando fu di ritorno in accappatoio e pantofole cominciò a sentirsi meglio. Grace gli mise avanti salsiccia paesana e pane di meliga caldo. «Ho sentito anch’io di queste serate in Park Avenue, ma di nessuna che durasse due giorni.» «Oh smettetela, Grace.» «Di’, Charley, hai letto l’articolo nella sezione finanziaria dell’“Evening Post” di ieri sera che accennava a un rialzo nei titoli aeronautici?» «No… ma ho parlato con Nat Benton, sai, quell’agente che ti ho detto, un amico di Ollie Taylor… Ebbene… diceva….» Grace sorse in piedi. «Avanti, sapete, cari ragazzi, che se alla domenica parlate della baracca io vi pianto.» Joe prese la moglie per il braccio e dolcemente la fece risedere nella sedia. «Dico solo una cosa e poi basta… Spero che ci terremo fuori dalle mani degli speculatori per almeno cinque anni. Son seccato che questa roba sia quotata. Vorrei potermi fidare di Merritt e di quegli altri come di te e me.» «Ne parleremo, va’» disse Charley. Joe gli porse un sigaro. «Dunque, Grace» disse. «Ti va un po’ di grammofono?» Charley aveva progettato per tutto l’inverno di portarsi Doris insieme a Washington, quando avrebbe pilotato uno degli apparecchi tipo per far un po’ vedere qualcuno dei suoi brevetti agli esperti del ministero della Guerra, ma lei e la madre s’imbarcarono per l’Europa la settimana prima. Così restò con nulla da fare, un certo primaverile sabato sera, e telefonò ai Johnson. Aveva incontrato Paul sulla
sotterranea nell’inverno e Paul gli aveva domandato con aria offesa perché non si faceva più vedere. Charley aveva risposto che sul serio da mesi non metteva più il naso fuori della fabbrica. E adesso gli dava un senso strano telefonare, ascoltare il trillo del telefono e poi la voce provocante di Eveline, che sempre pareva contenere un che di beffardo: che ridere, subito doveva venire e fermarsi a cena, c’era quella sera un mucchio di gente divertente, diceva. Paul gli aprì la porta. Il viso di Paul aveva un’aria cerea che Charley prima non aveva notato. «Salute, straniero» disse in forzato tono reboante, e gli diede due pacche sulla schiena entrando nella camera affollata. C’erano diverse ragazze assai carine e giovanotti di forme e dimensioni diverse, bicchieri di cocktail, vassoi di cosucce da mangiare coi biscotti, spire di fumo. Tutti parlavano e strillavano come un mucchio di torni in un opificio. In fondo alla camera Eveline, alta, pallida e bella, sedeva su un tavolino di marmo vicino a un ometto dal lungo naso giallo e dalle borse sotto gli occhi. «Oh Charley, che aria a mezzi… Vi presento Charles Edward Holden… Holdy, ecco Charley Anderson; si occupa di aeroplani… Dico, Charley, mi avete preso un’aria indecentemente danarosa.» «Non ancora» fece Charley. Tentava di tenersi dal ridere. «Dunque, cos’è che vi rallegra tanto? Proprio oggi tutto è così funebre qui.» «Io non sono funebre» disse Holden. «Su, non ditemi che sono funebre.» «Ma sicuro, Holdy, voi non siete mai funebre, però quanto dite rivela sempre una tendenza all’assassinio e al suicidio.» Tutti ridevano assai. Charley si trovò ricacciato via dal tavolo dove sedeva Eveline, da persone che tentavano di cogliere quanto diceva Charles Edward Holden. Si trovò a parlare con una semplice signorina dal cappellino grigio lucido, che aveva sopra un gran fermaglio come un faro. «Ditemi che fate» gli diceva. «Come, che faccio?» «Voglio dire, quasi tutti qui fan qualcosa, chi scrive, chi dipinge, chi altro.» «Io? No, io non faccio niente di simile… Sono nei motori d’aeroplano.» «Un pilota, oh, Dio mio, che emozione… Mi piace proprio venire alle riunioni di Eveline, non sapete mai chi vi capiterà di trovarci… Pensate, l’ultima volta che venni, era uscito allora
Houdini. È straordinaria in fatto di celebrità. Ma credo che sia una cosa un po’ dura per Paul, voi non credete?… È un così caro giovane, Paul. E lei col signor Holden… una cosa tanto pubblica. Non scrive che di lei sulla sua colonna… Certo, ho idee un poco antiquate io. Il più della gente sembra non vi faccia caso… Certo, è bello essere persone oneste… Ma certo che il signor Holden è anche un nome… Io penso che le persone dovrebbero essere oneste in quel che riguarda la loro vita sessuale, voi no? Così si evitano tutti quei terribili complessi e le altre cose… Ma mi dispiace assai per Paul, un così distinto e schietto giovane…» Quando gli ospiti si furono un po’ diradati, una cameriera negra che parlava francese servì una cena di curry e riso con una quantità di contorni. Il signor Holden ed Eveline tennero soli la conversazione. Si aggirava tutta intorno a gente di cui Charley non aveva mai sentito parlare. Tentò di rompere il cerchio, raccontando come quella volta era stato preso in quello spaccio per Charles Edward Holden, ma nessuno gli porse orecchio, e rifletté che, tutto sommato, non era forse un danno. Erano giunti all’insalata quando Holden si alzò e disse: «Mia cara, il mio solo principio morale è di non arrivare mai in ritardo a teatro, dobbiamo correre». Uscirono lui ed Eveline in fretta, piantando Charley e Paul a discorrere con un litigioso signore di mezz’età e sua moglie, cui Charley non era stato mai presentato. Ma non servì a molto, cercar di discorrere con quei tali, perché l’uomo era troppo sbronzo per ascoltare ancora qualcosa da chiunque e la donna era impegnata con lui in qualche sorta di bisticcio privato e non si poteva staccarli di lì. Quando costoro uscirono barcollando, Charley e Paul restaron soli. Andarono allora a sedersi in un cine, ma il film era schifoso e Charley ritornò a casa di pessimo umore e si cacciò nel letto. L’indomani Charley andò a cercare di buon’ora Andy Merritt e gli sedette davanti nel gran salone da pranzo color antisettico dello Yale Club, mentre lui faceva colazione. «Ci sarà da ballare?» gli chiese, prima cosa. «Il bollettino meteorologico era bello ieri.» «Che dice Joe?» «Ha detto di tener chiuso il becco, noi, e lasciar parlare gli altri.» Merritt sorseggiava l’ultima tazza di caffè. «Vedete, Joe è un po’ troppo cauteloso a volte… Per lui, un’azienda è una pompa a mano
che lui possa dirigere e lasciare poi ai nipotini. Ora tutto questo stava benissimo nella provinciale New York dei bei tempi… ma al giorno d’oggi un’impresa che non si espande è servita.» «Oh, state tranquillo che noi ci espanderemo» disse Charley, saltando in piedi per tener dietro alle ampie spalle in tweed di Merritt verso la porta del salone. «Se non ci espandessimo, non potremmo esistere.» Mentre si lavavano le mani al lavandino, Meritt chiese a Charley che abiti portasse con sé. Charley rise e disse che credeva di avere da qualche parte una camicia pulita e uno spazzolino da denti. Merritt si volse con una faccia ferma e grave: «Ma potremmo aver da uscire… Ho fissato un appartamentino al Waldman Park. Sapete bene, queste cose a Washington contano molto». «Be’, per male che vada, posso sempre affittare un abito nero.» Mentre il facchino deponeva la gran valigia di porco e la cappelliera di Merritt nel sedile posteriore della macchina, Merritt domandò con un cipiglio preoccupato a Charley se credeva che quel bagaglio pesasse troppo. «Diavolo, nient’affatto, ne potremmo portare dodici volte tanto» disse Charley, premendo il piede sullo starter. Filarono per le vie deserte e uscirono dal ponte e costeggiarono gli ampi viali orlati di basse casettine, alla volta di Jamaica. Bill Cermak aveva fatto uscire l’apparecchio dal capannone e l’aveva messo in ordine. Charley posò la mano sulla schiena della bisunta giacchetta in cuoio di Bill. «Sempre in gamba, Bill» disse. «Ti presento il signor Merritt… Dite, Andy… Viene Bill con noi, se non avete niente in contrario… sarebbe capace di ricostruire tutto il motore con forcine e chewing gum, se qualcosa si guastasse.» Bill stava già issando la valigia di Merritt nella fusoliera. Merritt s’infilava una grossa giacca di cuoio e occhialoni, come quelli che Charley aveva veduti nelle vetrine di Abercrombie e Fitch. «Credete che ci sarà da ballare?» tornava a chiedere Merritt. Charley gli diede un’issata. «Forse qualche sberla volando sulla Pennsylvania… ma dobbiamo fare a tempo per un bel pranzo… Cari signori, quest’è la prima volta che sarò stato nella capitale della nazione.» «Io anche» disse Bill. «Bill non ha mai messo il naso fuori di Brooklyn» disse
Charley ridendo. Si sentiva a meraviglia scalando il montatoio. S’infilò gli occhialoni e strillò a Merritt, alle spalle: «Siete nel posto dell’osservatore, Andy». Lo starter Askew-Merritt funzionò come un sogno. Il motore ronzò liscio e tranquillo come una macchina da cucire. «Che te ne pare, Bill?» continuava a gridare Charley al meccanico, seduto alle sue spalle. L’apparecchio corse molleggiando lungo il campo soffice nel mattutino sole primaverile, rimbalzò un paio di volte, e prese quota mentre virava sopra i riquadri ardesia di Brooklyn. Il vento leggero di nord-ovest scavava milioni di solchi nella baia verde opaca. Poi ecco che traversavano gli sconvolti distretti industriali di Bayonne ed Elizabeth. Di là dalle rossicce marcite, il Jersey si allargava in grandi riquadri piatti, quali gialli, quali rossi, quali velati dal verde dei nuovi raccolti. C’erano schiere di grosse nubi a cumulo che intercettavano il sole di là dal Delaware. L’aria si fece elastica e Charley salì a settemila piedi, dove era freddo e limpido, con un vento di nord-ovest di cinquanta miglia. Quando si riabbassò, era mezzogiorno e il Susquehanna scintillava azzurro fiammante per uno squarcio delle nubi. Persino da duemila piedi Charley sentiva la tepida esalazione della primavera dal suolo arato. Volando basso sui poderi, poteva scorgere la bianca lanugine dei frutteti in fiore. Deviò troppo a sud, per evitare un forte groppo di vento sulla foce del Chesapeake, e dovette risalire a nord il corso del Potomac verso la smagliante cupola candida del Campidoglio e la striscia risplendente del monumento a Washington. Non c’era fumo al disopra di Washington. Spiralò per mezz’ora prima di trovare il campo d’atterraggio. C’era tanto verde che dappertutto pareva un campo d’atterraggio. «Ebbene, Andy,» disse Charley mentre si sgranchivano le gambe sul prato «quando questi esperti vedranno il nostro starter, si sentiranno schizzar gli occhi dalla testa.» Merritt era smorto in faccia e traballava un poco, passeggiando. «Non sento» gridò. «Ho bisogno di orinare.» Charley lo seguì al capannone, lasciando a Bill di ripassare il motore. Merritt telefonava per un tassì. «Dio onnipotente, che fame»
muggì Charley. Merritt trasalì. «Mi occorre un bicchierino per lo stomaco, prima.» Quando furono nel tassì con i piedi sull’enorme valigia in porco, «Voglio dirvi questo, Charley,» fece Merritt «dovremmo creare una corporazione separata per quello starter… potrebbe occorrere una differenziazione d’impianto e tutto. Aeroricambi Standard non suonerebbe male in Borsa.» Ebbero due camere e un ampio salotto con poltroncine rosa nell’enorme albergo nuovo. Dalle finestre si poteva contemplare la fresca verzura del Rock Creek Park. Merritt si guardò attorno con notevole soddisfazione. «È di mio gusto arrivare in un luogo la domenica» disse. «Uno ha tempo di mettersi a posto prima di cominciare il lavoro.» Aggiunse che secondo lui non ci sarebbe stato in salone da pranzo nessuno di sua conoscenza, almeno, visto ch’era domenica, ma andò invece che ci volle un bel po’ di tempo per arrivare al tavolino. Per la via Charley si vide presentare a un senatore, a un avvocato di corporazione, al più giovane membro della Camera dei rappresentanti e a un nipote del ministro della Marina. «Dovete sapere» spiegò Merritt «che mio padre era senatore.» Dopo pranzo Charley ritornò nel campo per dare un’occhiata all’apparecchio. Bill Cermak aveva lucidato tutto come la vetrina di un gioielliere. Charley se lo riportò all’albergo per fargli bere un bicchiere. C’erano camerieri nel corridoio fuori dell’appartamento e fumo di sigari e un gran chiacchierio di voci distinte che usciva dalla porta spalancata. Bill si accostò un grosso dito al naso storto e disse che forse era meglio se lui filava. «Giuda, sembra l’almanacco mondano. Senti, ti faccio entrare nella mia stanza e ti porto da bere, se non ti secca aspettare un minuto.» «Ma va benissimo per me, padrone.» Charley si lavò le mani, si aggiustò la cravatta e uscì nel salotto in gran furia come chi si tuffa nell’acqua fredda. Andy Merritt dava un cocktail-party con Martini secco, insalata di pollo, panini, un piatto di caviale, fette di pesce affumicato, due vecchi signori dal capo canuto, tre roche bellezze meridionali truccate all’eccesso, un senatore obeso e un senatore sottilissimo dall’alto colletto, una migliarola di pallidi giovani dall’accento di Harvard e un
signore giallo con un dente d’oro redattore di una colonna ufficiosa intitolata “Chiacchiere capitoline”. C’era pure un giovane agente pubblicitario di nome Savage che Charley aveva conosciuto in casa di Eveline. Charley fece il giro delle presentazioni e rimase ritto prima su un piede poi sull’altro, finché non gli venne fatto di sgattaiolare nella stanza da letto con due mezzi boccali di rye e un vassoio di panini imbotti. «Giuda, è un’ira di Dio là dentro. Non avevo il coraggio di aprire la bocca, per paura di metterci dentro i piedi.» Charley e Bill sedettero sul letto mangiando i panini e tendendo l’orecchio al cicaleccio rumoroso che veniva dall’altra stanza. Quand’ebbe bevuto il suo whisky, Bill si mise in piedi, si forbì la bocca con il dorso della mano e chiese a che ora doveva presentarsi l’indomani. «Le nove basteranno. Ma sei sicuro di non aver voglia di fermarti?… Io non so cosa dire a quei tali… Potremmo accoppiarti con qualche bellezza del Sud.» Bill rispose che lui era un tranquillo padre di famiglia e si sarebbe cercato un buco per mettersi a dormire. Quando se ne fu andato, a Charley non restava altro che ritornare alla riunione. Quando Charley rientrò nella camera di Merritt, trovò che gli occhi neri del senatore obeso lo fissavano di fra i graziosi cappellini sussultanti di due belle ragazze. Charley si trovò che le salutava. Gli occhi bruni erano della bionda e gli occhi azzurri di quella nera. Un lieve sentore di profumo e di guanti di capretto rimase dopo che se ne furono andate. «Ebbene, secondo voi, giovanotto, qual era la più carina?» Il senatore obeso gli stava accanto, levando gli occhi a guardarlo con un sorriso esageratamente confidenziale. Charley si sentì la gola secca, senza sapere perché. «Sono un paio di bei tocchi» disse. «Vi lasciano come l’asino tra i due fasci di fieno» disse il senatore obeso con un molle risolino che gli scorse agevolmente sopra e sotto le pieghe del mento. «L’asino di Buridano è morto dalla voglia, senatore» disse il senatore sottile rimettendosi in tasca la busta, sulla quale lui e Andy Merritt avevano messe insieme certe cifre. «E io pure, senatore» disse l’obeso, lisciandosi all’indietro il ciuffo di capelli neri in fronte, tremolando nelle guance flaccide. «Muoio di giorno in giorno…
Senatore, volete cenare con me e con questi giovanotti? Credo che il vecchio Horace ci stia preparando una bella testuggine.» Posò una piccola mano grassoccia sulla spalla del senatore sottile, e l’altra su quella di Charley. «Spiacente, senatore, mia moglie riceve qualche amico al Chevy Chase.» «Allora temo che questi giovincelli dovranno rassegnarsi a far cena con un paio di vecchi rimbambiti. Contavo su di voi per riempire il salto tra le generazioni… Verrà il generale Hicks.» Charley scorse una lieve ombra di compiacenza passare sul viso serio e ben educato di Andy Merritt. Il senatore obeso continuò con la sua fluida e pesante voce da tribunale. «Forse faremmo bene a incamminarci… Viene alle sette e questi vecchi guerrieri tendono alla puntualità.» Una grande Lincoln nera stava appunto silenziosamente fermandosi all’ingresso dell’albergo, quando loro quattro, Charley, Andy Merritt, quel Savage e il senatore obeso, uscirono nella notte washingtoniana che sentiva di benzina e d’asfalto, di scappamenti aperti, di foglie novelle e dei fiori di wisteria. La casa del senatore era una continuazione della sua automobile, grande, tenebrosa, con fiochi barlumi e non un rumore. Si abbandonarono in grandi poltrone di cuoio nero, e un vecchio mulatto canuto fece girare i Manhattan sopra un vassoio d’argento inciso. Il senatore prese ciascuno degli uomini a parte per mostrar loro dove lavarsi le mani. A Charley non piacevano troppo le pacchettine che gli dava sulla schiena il senatore con le piccole mani grassocce, mentre lo introduceva in una gran sala da bagno all’antica, dalla vasca incastrata. Quando ritornò, lavatesi le mani, i due battenti della sala da pranzo erano spalancati e un vecchio signore dall’aria vegeta, baffi bianchi e leggera azzoppatura, camminava innanzi e indietro avanti a loro impaziente. «Si sente l’odore di quella testuggine, Bowie» diceva. «Il vecchio Horace sa ancora il fatto suo.» Al brodo e al vino di Xeres il generale cominciò a parlare dal fondo della tavola. «È un fatto che tutta quest’attività aeronautica presenta un enorme interesse per l’avvenire della scienza… Vi dico, Bowie, siete uno dei pochi che restano in questa città, capaci di imbandire una tavola… può darsi che apra grandi possibilità nel remoto futuro… Ma
parlando da militare, signori, voi sapete, non tutti siamo convinti che gli aeroplani abbiano fatto una gran prova… Questa testuggine è squisita, Bowie… Voglio dire che noi non abbiamo negli aeroplani la fiducia che sembrano avere al ministero della Marina… Un buon bicchiere di borgogna, Bowie, non c’è nulla d’uguale… La prova dei fatti è una gran cosa, signori, e non nego che magari nel remoto futuro…» «Nel remoto futuro» fece eco Savage, ridendo, mentre usciva dietro Merritt e Charley da sotto il porticato di pietra della casa del senatore Planet. Un tassì lo attendeva. «Dove posso deporvi, signori?… Il male è che noi ci siamo già, nel remoto futuro, e non lo sappiamo.» «È un fatto che a Washington non lo sanno» disse Merritt mentre salivano nell’auto. Savage ridacchiò. «Il senatore e il generale sono stati d’una antichità squisita… come gli oggetti di uno scavo… Ma non preoccupatevi per il generale… una volta che sa di avere a che fare con… m’intendete… gente presentabile, diventa buono come Babbo Natale… Lui crede in un governo di gentiluomini, per gentiluomini e da parte di gentiluomini.» «E noi no, forse?» disse seccamente Merritt. Savage sbottò in una risata fragorosa. «I gentiluomini dei boschi… è da anni che ne cerco almeno uno.» Poi rivolse i suoi rigonfi occhi alcoolizzati, e la faccia camusa che rideva, a Charley. «Il senatore pensa di voi che siate una perla… Mi ha chiesto di portarvi a trovarlo… il senatore è molto suscettibile, sapete.» Sbottò in un’altra risata. Costui dev’essere ben sbronzo, pensò Charley. Lui stesso si sentiva un poco cotto per via dell’acquavite Napoleon bevuta in quei bicchierini a boccia con cui avevan finito la cena. Savage li depose al Waldman Park e il tassì tirò innanzi. «Dite, chi è quel tizio, Andy?» «È una testa bruciata» rispose Merritt. «È uno dei giovani d’ingegno di Moorehouse. L’ingegno ce l’ha, ma non mi piacciono quelle storie che sento sul suo conto. Caldeggia il contratto Askew-Merritt, ma non siamo ancora a questo punto. Questi tipi dei pubblici rapporti vi mangiano anche la camicia.»
Mentre salivano nell’ascensore Charley disse, sbadigliando: «Cristo, speravo che quelle brave ragazze venissero a cena». «Il senatore Planet non invita mai donne… Ha una fama curiosa… C’è della gente curiosa in questa città.» «Altroché» disse Charley. Era esausto, non fece quasi a tempo a spogliarsi che già dormiva. Alla fine della settimana Charley e Bill rivolarono a New York, lasciando Andy Merritt a negoziar contratti con gli esperti del governo. Quand’ebbero ficcato l’apparecchio nel capannone, Charley disse che voleva portare Bill a casa in Jamaica con la macchina. Si fermarono in una specie di Hofbräu a bere una birra. Avevano appetito e Bill giudicò che sua moglie avesse già finito cena, perciò mangiarono vermicelli in brodo e Schnitzel. Charley scoprì che avevano un certo vino del Reno pasticciato e ne ordinò. Bevettero il vino e chiesero un’altra porzione di Schnitzel. Charley spiegava a Bill come Andy Merritt avesse detto che i contratti governativi andavano avanti bene e Andy Merritt non si sbagliava mai e aveva detto ch’era un dovere patriottico capitalizzare su larga base la produzione. «Bill, porco mondo, avremo tutti quattrini. Un’altra bottiglia?… Caro Bill, il pilota ha bisogno del meccanico, il finanziatore della produzione… Noi due, Bill, siamo nella produzione e, porco giuda, sta’ a vedere che ci voglio rimettere. Se cercano di fregarci, picchieremo; ho già avuto delle offerte, grosse offerte da Detroit… fra cinque anni avremo quattrini e sta’ tranquillo che avrai anche tu quattrini, quattrini a palate.» Mangiarono torta di mele e allora il padrone tirò fuori una bottiglia di kümmel. Charley comprò la bottiglia. «Viene meno che pagandola un bicchierino per volta, non pare anche a te, Bill?» Bill cominciò a protestare che era un padre di famiglia e avrebbe fatto meglio a tornare a casa. «Io,» disse Charley, versando un po’ di kümmel in un bicchierone «io non ce l’ho una casa da tornare… Se Doris volesse, l’avrebbe una casa. Le farei una casa meravigliosa.» Charley scoprì che Bill Cermak se n’era andato e che tutto ciò stava raccontandolo a una atticciata signora bionda di età incerta dal ricco accento tedesco. La chiamava zia Hartmann e le diceva che se mai avesse avuto una casa lei sarebbe stata la sua massaia. Finirono il
kümmel e presero a bere birra. La donna gli lisciava i capelli e lo chiamava il suo ciovane errante. C’era un’orchestrina in costume bavarese e un uomo, collo di toro, che cantava. Charley voleva fare uno jodel per la compagnia, ma la donna lo tirò indietro sulla sedia. Era assai robusta e lo respinse con i braccioni rossi quando lui si prese qualche familiarità, ma quando la pizzicò, abbassò gli occhi sulla sua birra, e le scappò da ridere. Era tutto come in casa ai bei tempi, continuava a ripeterle Charley, solamente più baccano e più allegria. Fu un’allegria pazza per tutto il tempo che stettero seduti nell’auto e lei gli tenne il capo sulla spalla e lo chiamava Schatz e le sue lunghe trecce di capelli s’eran disfatte e s’imbrogliavano sul volante. Comunque, riuscì a guidare. Si risvegliò l’indomani mattina in un traballante alberghetto di Coney Island. Erano le nove, la testa gli si spaccava ed ecco zia Hartmann, seduta nel letto, grassa e rosea e bovina che gli chiedeva Kaffee e Schlagsahne. La portò a colazione in una pasticceria viennese. Lei mangiò abbondantemente e pianse altrettanto e disse che non doveva crederla una donna disonesta, perché era soltanto una povera ragazza senza lavoro e le aveva fatto tanta pena che lui fosse un povero ragazzo senza casa. Charley le disse che sarebbe stato sul serio un povero ragazzo senza casa, se non ritornava all’ufficio. Le diede tutti gli spiccioli che si trovò in tasca, un indirizzo falso, e la lasciò in lacrime alla terza tazza di caffè nella pasticceria viennese, dirigendosi verso Long Island City. Circa a Ozone Park dovette fermare per vomitare sulla banchina dello stradale. Ce la fece appena a raggiungere il cortile della fabbrica con l’ultima goccia che aveva di benzina. Sgattaiolò nell’ufficio. Mancavano dieci minuti a mezzogiorno. La sua scrivania era piena di appunti e lettere, tenuti insieme da fermagli, e carte azzurre segnate VEDER SUBITO. Aveva paura che la signorina Robinson o Joe Askew scoprissero ch’era di ritorno. Poi ricordò che c’era una fiaschetta d’argento di vecchio bourbon nel cassetto della scrivania, che Doris gli aveva data la sera prima d’imbarcarsi, perché si dimenticasse di lei, gli aveva detto scherzando. Aveva appena rovesciato il capo per buttar giù un sorso, che si vide
Joe Askew ritto innanzi alla scrivania. Joe stava piantato a gambe larghe con un cipiglio spossato in viso. «Dio degli dei, di dove vieni? Siamo stati in un’ansia tale per te… Grace ha rimandato di un’ora la cena.» «Perché non telefonare al capannone?» «Eravamo andati tutti via… Stauch sta male. Tutto è fermo.» «Non avete notizie di Merritt?» «Certamente… ma ciò vuol dire che dobbiamo riorganizzare la produzione… E francamente, Charley, è un pessimo esempio questo, per i dipendenti… sbevazzare anche all’ufficio. L’ultima volta non ho detto niente, ma Dio mio…» Charley andò verso il refrigeratore e si tirò un paio di cartocciate d’acqua. «Dovevo ben celebrare il viaggio a Washington, ieri sera… Dopo tutto, Joe, questi contratti ci daranno la spinta… Un sorso?» Joe s’accigliò. «Hai l’aria di non essere al primo… e se ti radessi un poco, prima di entrare all’ufficio? Pretendiamo che lo facciano i dipendenti, dovremmo farlo anche noi… Dio del Cielo, Charley, ricordati che la guerra è finita.» Joe si voltò e ritornò nel suo ufficio. Charley diede un’altra lunga sorsata alla fiaschetta. Era fuori di sé. «Non lo sopporterò» brontolava «né da lui né dagli altri.» Trillò il telefono. Il caporeparto della camera di montaggio era sulla porta. «Per favore, signor Anderson» disse. Ciò fu il principio. Da quel momento tutto parve andare a rovescio. Alle otto di sera Charley non si era ancor fatta la barba. Stava mangiando un panino imbottito e bevendo caffè nel bicchierino di cartone coi meccanici della squadra riparazioni, seduto su una macchina fuori uso. Fu mezzanotte e non stava più dritto, prima che potesse tornare a casa. Era tutto montato per dirne quattro a Joe, ma nemmeno un Askew comparve all’orizzonte. L’indomani a colazione le sopracciglia di Grace s’inarcarono, mentre versava il caffè. «Be’, se non son queste le ultime ore del condannato a morte» disse. Joe Askew si raschiò in gola. «Charley» disse nervosamente «non toccava a me darti sulla voce a quel modo… Credo che divento bisbetico, invecchiando. La fabbrica è andata avanti come Dio ha
voluto, questa settimana.» Le due bimbe cominciarono a ridersela. «Va’, non è il caso» disse Charley. «Perdindirindina, Joe» disse Grace, battendo sul tavolo per richiamare l’ordine. «Mi pare che abbiamo tutti bisogno di riposo. Quest’estate, Joe, ti prenderai una vacanza. Anche a me occorre d’urgenza una vacanza, specialmente ora che ho intrattenuto le pittime di Joe. Non aveva nessuno con cui discorrere mancando voi, Charley, e la casa è stata piena di pittime.» «È soltanto un paio di tali che ho cercato di impiegare. Grace ne dice male, perché non sono tipi di gran conversazione.» «Non lo dico, lo so che son pittime» ribatté Grace. Le bimbe se la risero un altro poco. Charley si alzò e spinse indietro la sedia. «Vieni, Joe?» disse. «Io debbo ritornare alla mia squadraccia.» Ci volle un paio di settimane prima che Charley potesse uscire dalla fabbrica altro che per dormire. Passato questo tempo, fu di ritorno Stauch coi suoi tranquilli modi compunti, simili a quelli di un dottore assistente nella sala d’operazioni di un ospedale, e tutto cominciò a ricomporsi. Il giorno che Stauch venne finalmente alla porta dell’ufficio di Charley dicendo: «La produzione è di nuovo in carreggiata, signor Anderson», Charley decise di andarsene a mezzogiorno. Telefonò a Nat Benton di aspettarlo prima di andare a pranzo e sgattaiolò per l’ingresso del personale in modo da non incontrare Joe nell’entrata. All’ufficio di Nat, bevvero due bicchierini prima di uscire a pranzo. Al ristorante, dopo ordinato, Charley disse: «Dunque, Nat, come va il servizio segreto?». «Quante azioni avete?» «Cinquecento.» «E nessun altro titolo, nulla che possiate adoperare da margine?» «Qualcosa… Un paio di bigliettoni in contanti.» «Contanti» disse Nat disgustato. «Per qualunque occorrenza… tutte sciocchezze… Perché non metterli a frutto?» «Parliamo appunto di questo.» «Che ne direste di un colpetto nelle Auburn tanto per cominciare?»
«E Merritt allora?» «Una alla volta… Quel che io cerco è di farvi guadagnare un capitaluccio perché possiate lottare ad armi uguali… Se no, vi sbatteranno fuori del gioco, sicuro come il destino.» «Joe non lo farebbe» disse Charley. «Non conosco quest’uomo personalmente, ma gli uomini li conosco e ce ne sono ben pochi che per prima cosa non pensino a sé.» «Credo che tutti tirino a fartela, se possono.» «Non m’esprimerei esattamente con queste parole, Charley. Ci sono degli splendidi esemplari della virilità americana nel mondo degli affari.» Quella notte Charley si sbronzò tutto solo in uno spaccio della Cinquantesima. Quando Doris sbarcò dall’Europa nell’autunno, Charley aveva fatto due bei colpi nelle Auburn e andava comprando tutte le AskewMerritt che gli venivano sotto mano. Intanto aveva scoperto che godeva credito e poté pagarsi una nuova macchina, vestiti dai Brooks Brothers, spuntini negli spacci di contrabbando. La macchina era una Packard tipo sport a carrozzeria bassa slanciata, imbottita di cuoio rosso. La guidò allo scalo, quando andò incontro a Doris e alla signora Humphries che arrivavano sul Leviathan. Il transatlantico aveva già attraccato, quando Charley giunse a Hoboken. Lasciò al posteggio la macchina e si precipitò fra i malvestiti crocchi della terza classe verso l’ampio turbine dei passeggeri eleganti che, al centro dello scalo, stavano a ciarlare intorno a cataste di valigie di pelle, cappelliere di cuoio verniciato, bauli armadio segnati coi cartellini degli alberghi Ritz. Alla lettera H i suoi sguardi si posarono sulla vecchia signora Humphries. Sopra il largo colletto di pelliccia quel viso appariva come un’edizione scolorita di quello di Doris, Charley non s’era mai accorto prima quanto. Quella lì per lì non lo riconobbe. «Oh, Charley Anderson, che bell’incontro.» Gli porse la mano senza sorridere. «Che cosa seccante. Al solito Doris ha dovuto dimenticare l’astuccio dei gioielli in cabina… Venite a prendere qualcuno, immagino.» Charley arrossì. «Ho pensato di offrirvi la macchina… Ne ho una grande, ora. Ho pensato che sarebbe stata più comoda per i bagagli che non un tassì.»
La signora Humphries non gli prestava troppa attenzione. «Eccola là…» Agitò una mano guantata che reggeva la borsetta di coccodrillo. «Son qui.» Doris arrivò correndo in mezzo alla folla. Le avvampava il viso e le labbra erano assai rosse. Il cappellino e la pelliccia avevano appunto il colore dei capelli. «L’ho trovato, mamma… che sciocca.» «Tutte le volte che ne esco viva» gemette la signora Humphries «giuro che non tornerò mai più a imbarcarmi.» Doris si curvò innanzi a ficcare un pezzo d’un qualcosa di giallo in una valigia che era aperta. «C’è il signor Anderson, Doris» disse la signora Humphries. Doris si volse d’un balzo e gli corse incontro e gli gettò le braccia al collo e lo baciò sulla guancia. «Che tesoro, venir qui.» Poi lo presentò a un rubicondo giovanotto inglese, vestito d’un soprabito inglese di plaid, che reggeva un grande astuccio di mazze da golf. «Son sicura che andrete d’accordo.» «È la prima volta che venite in America?» chiese Charley. «Al contrario» disse l’inglese, scoprendo i denti gialli in un sorriso. «Sono del Wyoming.» Faceva frescolino nello scalo. La signora Humphries andò a sedersi nella sala d’aspetto riscaldata. Quando il giovanotto dalle mazzette se ne fu andato per attendere ai suoi bagagli, Doris disse: «Dunque, vi piace George Duquesne? È nato qui, è cresciuto in Inghilterra. Sua madre discende da gente nominata nel “Doomsday Book”. Ho abitato con loro nella più incantevole antica abbazia… Sono stata felice come non mai in Inghilterra. George è proprio una perla. I Duquesne hanno capitali nelle miniere di rame. Sono quasi come i Guggenheim, salvo naturalmente che non sono ebrei… Ma, Charley, mi sembri geloso… Sciocchino… Io e George siamo proprio come fratello e sorella, ecco. Non è come tra te e me, ma George è tanto divertente». Ci volle per la famiglia Humphries un paio d’ore prima che si liberassero della dogana. Avevano infiniti bagagli e Doris doveva pagare dazio per certi abiti. Quando la signora Humphries s’accorse che le toccava attraversare la città in una macchina aperta, col mantice abbassato, divenne davvero nera; il fatto che si trattasse di una
slanciata Packard non parve farle alcun effetto. «Ma è proprio un torpedone torcicollo» disse Doris. «Mamma, che divertimento… Charley ci griderà tutti i palazzi più alti.» La signora Humphries brontolava mentre, circondata di bagaglio leggero, si accomodò nel sedile posteriore. «Al tuo povero padre, Doris, non è mai piaciuto vedere una signora passare in carrozze aperte, figurati in macchina aperta.» Dopo che le ebbe portate a casa, Charley non ritornò alla fabbrica. Passò il resto della giornata fino alla chiusura della Borsa in casa degli Askew, parlando al telefono con l’ufficio di Benton. Una volta quotate le Standard Airparts, c’era stata una grande caduta nelle AskewMerritt. Charley impegnava ogni suo avere e aspettava che toccassero fondo per iniziare la compra. Di tanto in tanto telefonava a Benton e diceva: «Che ve ne pare, Nat?». A quell’ora del pomeriggio Nat non aveva ancora suggerimenti da dare, e allora Charley gettò in aria un soldo, per decidersi; venne testa. Telefonò all’ufficio e lasciò detto di comprare l’indomani alla cifra d’apertura. Poi si mutò d’abito e tagliò la corda, prima che Grace riconducesse le bimbe da scuola; non scambiava quasi più parola in quei giorni con gli Askew. Ne aveva le scatole piene in fabbrica e sapeva che Joe lo considerava un fannullone. Mutando di giacca il portafogli, lo aprì e contò i denari. C’erano quattro biglietti da cento e rotti. I biglietti cantavano, eran nuovi fiammanti dalla banca. Se li portò al naso per sentire l’odore dolce e pungente dell’inchiostro fresco. E prima di sapere quel che facesse, li aveva baciati. Rise forte e rimise i biglietti nel portafogli. Giuda, come si sentiva bene. Il nuovo abito turchino non gli faceva una piega. Le scarpe eran lucide. S’era cambiato le calze. Sotto la cinghia si sentiva il ventre sodo. E attendendo l’ascensore si mise a fischiettare. In casa di Doris c’era George Duquesne che descriveva quale spettacoloso colpo d’occhio facessero i nuovi palazzi sulla Quinta Avenue. «Oh, Charley, aspettate che assaggiamo uno dei cocktail di George, quelli sono spettacolosi» disse Doris. «Ha imparato a farli a Costantinopoli dopo la guerra… Sai, era nell’esercito inglese… Charley è stato un asso della nostra aviazione, George.»
Charley portò George e Doris a cena al Plaza e poi al teatro e poi a un ritrovo notturno. Per tutto il tempo continuò a riempire George dei liquori più poderosi, sperando di stenderlo, ma George non faceva altro che diventar sempre più rubicondo in viso, e sempre più cheto. Nemmeno al principio aveva avuto molte parole da dire. Erano le tre del mattino e Charley cascava anche lui dalla sbornia e dal sonno, quando riuscì a consegnare George al St. Regis dove aveva preso alloggio. «E adesso che facciamo?» «Ma tesoro, io debbo tornare a casa.» «Non ho ancora avuto un momento per parlarti… Perdio, non ho ancora avuto un momento per darti un abbraccio come si deve, da quando sei sbarcata.» Finirono per entrare al Columbus Circle Childs e mangiarono uova strapazzate con lardo. Doris diceva che avrebbero dovuto esserci bei siti dove gli innamorati potessero andare in solitudine e trovarci letti e tutto intorno cose belle. Charley disse che ne sapeva un mucchio di quei posti, ma non erano tanto belli. «Verrei, Charley, sul serio verrei, se non avessi paura che fosse una cosa troppo sordida, e tutto si guastasse.» Charley le premette con slancio la mano. «Non ho il diritto di chiederti questo, piccola, almeno finché non saremo sposati.» Mentre a piedi traversavano la strada alla volta dell’auto, Doris gli abbandonò la testa sulla spalla. «Mi desideri, Charley?» gli chiese con la vocetta piccina. «Anch’io ti desidero… ma bisogna che torni a casa, altrimenti Mamma mi farà una scena domani.» Charley passò il pomeriggio del sabato successivo in cerca di un alloggio ammobiliato, senz’ascensore. Affittò una cucinetta economica e una stanza da bagno, tutta verniciata in grigio, da un’artista all’henné, svolazzante di batista, che diceva di andare a Capri per passare sei mesi di pura bellezza, e telefonò a un’agenzia chiedendo un domestico giapponese per le faccende. L’indomani a colazione annunciò agli Askew che traslocava. Joe lì per lì non disse nulla, ma sorbito il fondo della sua tazza di caffè si alzò accigliato e traversò avanti e indietro la stanza. Poi andò alla finestra, dicendo calmo: «Vieni qua, Charley, ho qualcosa da spiegarti». Posò una mano sul braccio di Charley. «Stammi a sentire, ragazzo, è per via che io sono sempre così brusco? Lo sai anche tu che
tutta questa dannata faccenda mi preoccupa… ho l’impressione che siamo in acque pericolose… ma sai che Grace ed io ti stimiamo assai… Mi è parso semplicemente che tu dessi troppo del tuo tempo alle speculazioni… Ma insomma noi, i bravi della vecchia guardia, dobbiamo aiutarci a vicenda.» «Ma certo, Joe, certo… Ti assicuro che il motivo per cui mi occorre questo dannato alloggio non ha nulla a che fare con ciò… Tu sei un uomo sposato con figli e non hai di questi grattacapi… ma io, io ho un pasticcio con una donna.» Joe scoppiò in una risata. «Il vecchio lavativo d’Europa! ma per dirla che tutti sentano, perché non te la sposi?» «Porco giuda, è ben questo che cerco» disse Charley. Rise e con lui Joe. «Be’, cosa c’è da ridere?» chiese Grace da dietro il vaso del caffè. Charley accennò del capo verso le sue bimbe. «Storie per soli uomini» disse. «Siete un porcaccione» disse Grace. Un nevoso pomeriggio prima di Natale, due o tre settimane dopo che s’era trasferito nel nuovo alloggio, Charley ritornò presto in città e si trovò con Doris al Biltmore. Doris disse: «Dove si va a bere una bibita?», e Charley rispose che le bibite le aveva pronte e lei sarebbe dovuta salire a vedere che buffi panini imbottiti Taki preparava, tutti in colori differenti. Doris chiese se il giapponese era allora in casa. Charley sorrise e scosse il capo. Non ci vollero più di due o tre minuti di tassì per arrivare alla nuova casa di arenaria scura. «Domando e dico se non è delizioso» ansimò Doris, un po’ trafelata della salita, aprendosi il soprabito di pelliccia. «Adesso sì che mi sento un demonio.» «Ma è una cosa diversa che se io fossi uno sconosciuto» disse Charley «o uno qualunque.» Doris si lasciò baciare. Poi si tolse il soprabito e il cappello e si lasciò cadere accanto a lui sul divano della finestra, tiepido per via del termosifone. «Nessuno sa l’indirizzo, nessuno sa il numero del telefono» disse Charley. Quando le circondò col braccio le spalle esili e la strinse a sé, Doris cedette con un piccolo brivido bizzarro e si lasciò tirare sulle sue ginocchia. Si baciarono a lungo, poi Doris si liberò divincolandosi e
disse: «Charley, mi hai invitato a prendere una bibita». C’era ogni cosa preparata per i cicchetti nella cucinetta, e un vassoio di panini. Charley dispose ogni cosa sul rotondo tavolino di vimini. Doris addentò parecchi panini prima di pronunciarsi sul migliore. «Ma davvero quel tuo giapponese dev’essere un artista, Charley» disse poi. «Sono una razza d’uomini in gamba» disse Charley. «Tutto è così bello qui, Charley, eccetto questa luce che mi fa male agli occhi.» Una volta spento, la finestra fu azzurro limpido. Le luci e le ombre dei tassì che andavano e venivano per la via nevosa e il riverbero dei negozi di fronte gettavano mobili rettangoli arancione sul soffitto. «Che amore qui» disse Doris. «Guarda come la strada sembra una scena del passato con tutti i solchi nella neve.» Charley non smetteva di riempire i bicchierini di whisky. La indusse a levarsi il vestito. «Visto che mi hai detto che il tuo abito costa denaro.» «Oh, sciocchino, Charley, mi vuoi un pochino di bene?» «Serve a qualcosa parlare?… Sono più che matto di te… ti ripeto che voglio che stiamo sempre insieme. Voglio che ci spo…» «Non guastare ogni cosa, è tutto così bello, non ho mai creduto che potesse esserci qualcosa di simile… Charley, fai attenzione, vero?» «Sta’ tranquilla» le rispose fra i denti serrati. Alle sette Doris si vestì in fretta e furia, disse che aveva un impegno a cena e avrebbe fatto orribilmente tardi. Charley l’accompagnò abbasso e la mise in un tassì. «E ora, tesoro,» disse «non parleremo più di quel che ho detto. Lo faremo senz’altro.» Ritornando su per le ripide scale scricchiolanti risentiva il sapore della sua bocca, dei suoi capelli; la testa gli scoppiava al profumo di lei. Un amaro senso di gelo lo invase a poco a poco, come l’avvicinarsi del mal di mare. «Dio santo» esclamò e si buttò bocconi sul divano della finestra. L’alloggio e Taki e il liquore di contrabbando e le rate dell’automobile e i fiori che ogni giorno mandava a Doris, tutto insieme faceva una spesa mensile superiore ai suoi calcoli. Aveva appena fatto un versamento alla banca, che doveva ritirarlo. Teneva in mano un mazzo di titoli che non gli davan dividendi. A Natale
dovette farsi prestare cinquecento dollari da Joe Askew, per comprare il regalo di Doris. Lei gli aveva detto che non voleva gioielli e Charley s’informò da Taki quale fosse, secondo lui, un regalo adatto per una signorina molto ricca e incantevole e Taki aveva detto che un chimono di seta sarebbe stato assai adatto. Fu così che Charley si mise in campagna e le comperò una casacca da mandarino. Doris fece una buffa faccia quando la vide, ma gli diede un bacio come una rapida beccatina nell’angolo della bocca, perché erano in casa della mamma, e disse con un tono viziato: «Oh che caro ragazzo». La signora Humphries l’aveva invitato al pranzo di Natale. La casa odorava di lustrini e verzura; c’era in quantità cartavelina e rifiuti sulle sedie. I cocktail furon molli e tutti stavano in piedi, Nat e Sally Benton, e certi nipoti, maschi e femmine, della signora Humphries e la sorella Eliza ch’era sorda come una talpa e George Duquesne, che non sapeva parlar d’altro che di sport invernali, in attesa che venisse annunciato il pranzo delle cinque. Tutti avevano un’aria scontrosa e imbarazzata, tranne Ollie Taylor che tornava allora dall’Italia pieno dello spirito natalizio. Stette quasi tutto il tempo in dispensa, in maniche di camicia, a manipolare quel che lui chiamava un buon ponce natalizio di quelli d’una volta. Ci si affaccendava talmente, che non fu facile trascinarlo a tavola per il pranzo. Charley dovette impiegare tutto il suo tempo a badargli e non scambiò in tutta la giornata una sola parola con Doris. Dopo il pranzo e il ponce natalizio, dovette ricondurre Ollie al suo circolo. Ollie era assolutamente fradicio, e si raggomitolò grasso e sbiancato nel tassì, e non la smetteva di gorgogliare: «Bel Natale, porco mondo». Quand’ebbe affidato Ollie alle mani del portiere, Charley non seppe decidersi se tornare dagli Humphries dove era sicuro che avrebbe trovato Doris e George con le teste accostate su qualche maledetto gioco, o salire dagli Askew come aveva promesso. Bill Cermak lo aveva invitato a venire a dare un’occhiata agli straccioni di Jamaica, ma sapeva che non sarebbe stato per lui un gran divertimento, aveva poi concluso. Charley aveva detto che certo sarebbe venuto, sarebbe andato in capo al mondo pur di uscire di fra i pagliacci. Dalla stazione di Pennsylvania mandò un telegramma agli
Askew augurante Buon Natale. Certo gli Askew avrebbero capito che doveva trascorrere il Natale con Doris. Sul treno deserto che andava a Jamaica, cominciò a tormentarsi per Doris: forse avrebbe fatto meglio a non lasciarla con quel bischero. A Jamaica Bill Cermak e la moglie e i parenti vecchiotti e gli amici furon tutti lusingati e anche un po’ sconvolti dall’arrivo di Charley. Stavano in una casetta in legno dal tetto d’eternit verde, in un quartiere di casette tutte identiche, dai tetti uno rosso e uno verde alternati. La signora Cermak era una tozza biondona, un poco brilla per via del gran pranzo e del vino che le aveva dipinto chiazze rossolucide sulle guance. Fece mangiare a Charley un po’ di tacchino e del panettone, che avevano tolto allora di tavola. Poi prepararono vino caldo con chiodi di garofano e Bill suonò ariette sull’armonica, mentre tutti ballavano e i marmocchi strillavano e picchiavano sui tamburi e si ficcavano tra i piedi. Quando Charley disse che doveva andare, Bill lo accompagnò fino alla stazione. «Padrone, non so come ringraziarvi che siate venuto» cominciò Bill. «Diavolo, non sono il padrone io» disse Charley. «Io sono coi meccanici… no, Bill? Tu ed io, Bill, i meccanici contro tutto il mondo… e quando mi sposo, voglio che tu venga a suonare quella tua dannata armonica alle nozze… capito, Bill?… può darsi che non ci voglia molto» Bill raggrinzò la faccia e si sfregò il lungo naso storto. «Bella cosa le donne una volta che uno le ha in mano, padrone, ma finché non si tengono in mano sono l’ira di Dio.» «Ce l’ho in mano, Bill, ce l’ho in mano in un modo che mi deve sposare, se vuole far di me un uomo onesto.» «Allora sì» disse Bill Cermak. Rimasero a ridere e stringersi la mano sulla banchina battuta dal vento, finché il treno di Manhattan non giunse. Durante la mostra automobilistica Nat telefonò un giorno per dire che Farrell, l’uomo che dirigeva gli impianti Tern, era in città e voleva veder Charley, e Charley disse a Nat di portarlo a prendere un cocktail nel pomeriggio. Questa volta fece fermare Taki. James Yardly Farrell era un uomo tondo in faccia, coi capelli d’un grigio sabbia e una pelata rotonda. Quando entrò nella porta cominciò a vociare: «Dov’è? dov’è?». «Eccolo qui» disse Nat Benton ridendo.
Farrell strinse la mano di Charley. «E così questo è l’uomo dal bernoccolo, vero? È da mesi che vado cercando di pescarvi… chiedete a Nat se non gli ho reso la vita impossibile… Ecco qua: che ne direste di venire a Detroit?… Long Island City non è posto per voi. Il vostro bernoccolo ci fa comodo laggiù… e quanto ci fa comodo, noi siamo pronti a pagarlo.» Charley divenne rosso. «Non posso lamentarmi di come sto qui, signor Farrell.» «Quanto guadagnate?» «Oh, anche troppo per un giovanotto.» «Parleremo di ciò… Ma non dimenticate che in una nuova industria qual è la nostra i requisiti cambiano in fretta… Bisogna aprire l’occhio, altrimenti si resta… Be’, lasciamo stare per il momento… Ma una cosa vi posso dire, Anderson, ed è questa: che io non so stare con le mani in mano a vedere quest’industria rovinarsi in una caterva di piccole azienducole tutte dedite a strozzarsi a vicenda. Non pare anche a voi che sia meglio fatto sedersi tutti intorno al tavolo e tagliare la torta in spirito d’amicizia e di reciproco servizio? e ve lo dico io, giovanotto, questa promette di essere una torta eccezionale.» La voce gli si ridusse a un bisbiglio. Taki, col viso giallo contratto in un fine sorriso diplomatico, venne tra loro con un vassoio di cocktail. «Grazie tante, non bevo» disse Farrell. «Siete scapolo, signor Anderson?» «Sì, più o meno… Ma non credo che durerà molto.» «Sono certo che vi troverete bene a Detroit, senza scherzi… Benton mi ha detto che siete del Minnesota.» «Ecco, vengo dal North Dakota.» Charley disse sopra la spalla, rivolto al giapponese: «Taki, un altro bicchierino al signor Benton». «Abbiamo un simpatico ambiente di società, laggiù» disse Farrell. Dopo che se ne furono andati, Charley telefonò a Doris e le chiese di punto in bianco se le piaceva abitare a Detroit quando fossero sposati. Quella fece uno strillo all’altra estremità della linea. «Ma che idea infame… e chi ha mai parlato di quest’infame… stato… non voglio neppure pronunciare quella parola orribile… Non credi anche tu che ci siamo tanto divertiti quest’inverno a New York?» «Ma certo»
rispose Charley. «E so che starei benissimo qui se… le cose cambiassero… Credevo che magari ti sarebbe piaciuto un mutamento, ecco tutto… Mi è stata fatta una proposta da una impresa di laggiù, vedi.» «Stavolta, Charley, mi devi promettere che non mi dirai mai più una simile sciocchezza.» «Sì… se verrai a cena con me domani sera.» «Tesoro, domani non posso.» «Facciamo sabato allora?» «E va bene, romperò un impegno. Forse potrai venire tu stesso a prendermi alla Carnegie Hall dopo il concerto.» «Vengo anche a quel dannato concerto se vuoi.» «Oh no, Mamma ha invitato una quantità di vecchie signore.» Doris parlava in fretta, la voce vibrava nel ricevitore. «Non ci sarà più posto nel palco. Vammi ad aspettare in quel piccolo tearoom, quel locale russo dove mi hai atteso e ti sei tanto stizzito la volta scorsa.» «Va bene, qualunque posto… Doris, tu non sai come mi manchi quando sei lontana da me.» «Proprio? Davvero? Oh Charley, sei un tesoro.» Chiuso il telefono. Charley posò il ricevitore e si lasciò piombare sulla sedia. Non riusciva a impedirsi di tremare dalla testa ai piedi tutte le volte che le parlava al telefono. «Ohi, Taki, portami quella bottiglia di scotch… Senti, dimmi un po’, Taki,» continuò versandosi un robusto bicchierino «al tuo paese è anche una dannazione simile riuscire a prender moglie?» Il giapponese sorrise e fece un lieve inchino. «Al mio paese tutto molto più difficile.» L’indomani ritornando alla fabbrica trovò un telegramma da parte di Doris che diceva: sabato assolutamente impossibile. «Vacca del boia» esclamò. Per tutta la sera non fece altro che cercarla al telefono e lasciarle commissioni, ma non la trovava mai. Venne che detestava anche il contatto di quel maledetto cornetto contro le labbra. Nemmeno al sabato riuscì a dirle una parola. La mattina della domenica venne la signora Humphries al telefono. La voce fredda e cigolante della vecchia strillò che Doris era andata d’improvviso in gita a Southampton per la fine della settimana. «Sono sicura che tornerà con un raffreddore coi fiocchi» aggiunse la signora. «Gite con questo tempo.» «I miei rispetti, allora, signora Humphries» disse Charley e chiuse il telefono. Il lunedì mattina, quando Taki gli portò una lettera dalla calligrafia di Doris, una grande busta azzurra che
emanava il suo profumo, nell’istante stesso che l’aprì, prima ancora di leggerla, sapeva quel che avrebbe detto. Caro Charley, tu sei così caro e io ti voglio tanto bene e sarei così contenta se mi fossi amico [sottolineato]. Sai quale insulsa vita io conduco; proprio ora mi trovo nella più assurda delle scampagnate e ho detto a tutti che ho un tremendo mal di capo e mi son messa a letto soltanto per scriverti. Ma, Charley, te ne prego, dimentica ogni cosa, matrimonio e compagnia bella. Soltanto a pensarci provo una ripugnanza quasi fisica e d’altra parte ho promesso a George che lo avrei sposato a giugno e i Duquesne hanno un legale per i pubblici rapporti – di’ tu se non è una sciocchezza – ma è pagato per conservarli popolari presso il pubblico e costui ha dato tutta la storia in mano ai giornali, come George mi ha fatto la corte fra le lande della Scozia e nell’antica abbazia medioevale e tutto il resto. Per questo ti scrivo così in fretta e furia, mio caro Charley, perché tu sei il miglior amico [sottolineato due volte] che io abbia e il solo di tutti che viva nel mondo reale degli affari, della produzione, del lavoro e di tutte queste cose, ch’io sarei tanto felice fosse anche il mio e volevo che lo sapessi tu prima di tutti. Oh, caro Charley, ti supplico non pensare brutte cose di me. La tua amica [sottolineato tre volte] affezionata D. Sarai buono e questa lettera la brucerai, vero? Strepitava il campanello. Era il ragazzo dell’autorimessa con la macchina. Charley si mise cappello e soprabito e scese le scale. Salì e guidò verso Long Island City, montò i gradini coperti di gomma verso l’ufficio, sedette alla scrivania, parlò con Stauch al telefono, fece colazione nella sala degli impiegati insieme a Joe Askew, dettò lettere alla nuova stenografa dai capelli di stoppa e d’un tratto furon le sei e s’accorse che stava dibattendosi in mezzo al traffico per tornare a casa. Attraversando il ponte ebbe la tentazione di dare uno strappo al volante e schiacciare l’acceleratore, ma quell’auto maledetta non avrebbe lo stesso abbattuto la ringhiera, non avrebbe fatto che una lurida catasta di traffico e autocarri imbottigliati. Non aveva voglia di tornare a casa o nello spaccio dove lui e Doris
avevano cenato diverse volte la settimana per tutto l’inverno, e così s’infilò per la Terza Avenue. Poteva darsi che s’imbattesse in qualcuno al Julius. Si mise al banco, in piedi. Non aveva nessuna voglia di bere, come non aveva voglia di far nessun’altra cosa. Tre o quattro sorsi di rye pretti lo fecero star meglio. Al diavolo colei. Niente come un bicchierino. Era solo, aveva soldi in tasca, poteva fare quel porco diavolo che gli piaceva. Accanto a Charley, al banco, stavano un paio di donne grassottelle e infagottate. Erano in compagnia di un tale dalla faccia rossa, discretamente sbronzo. Le donne parlavan d’abiti e l’uomo raccontava del Bosco Belleau. Senz’altro lui e Charley furono vecchi camerati dell’AEF 1 «Nome De Vries… Professione… bonvivant» disse l’uomo che diede strattoni alle due donne, finché queste non si volsero a Charley. Gettò le braccia sulle loro spalle con un gran gesto e gridò: «Questa è la moglie». Bevvero al Bosco Belleau, alle Argonne, allo sperone Saint-Mihiel, e alla battaglia di Parì. Le donne dicevano: «Misericordia, che voglia di andare a Hoboken all’Hofbräu». Charley disse che ve li avrebbe portati tutti con la sua auto. Si rimisero un tantino e stettero cheti quando furono sulla chiatta. Nella trattoria di quella gelida e buia strada di Hoboken non trovarono altro che birra. Una volta finito di cenare, De Vries disse che lui sapeva un posto dove si poteva bere vero liquore. Girarono intorno a un isolato dopo l’altro e finirono in una tampa di Union City. Quand’ebbero bevuto abbastanza da mettersi a ballare in quadriglia, le donne dissero se non sarebbe stato magnifico andare a Harlem. Questa volta nella traversata in chiatta non furon più così cheti, visto che avevano con sé una bottiglia di scotch. A Harlem vennero buttati fuori da una sala da ballo e alla fine capitarono in un circolo notturno. Il bonvivant capitombolò giù per i tappeti rossi delle scale e Charley ebbe il suo spasso a soffocare la faccenda a risate con la direzione. Mangiarono pollo arrosto e bevvero una sorta di terribile gin che il cameriere negro mandò a cercare fuori, e ballarono. Charley non smetteva di compiacersi quanto bene lui ballasse. Non riusciva a capire perché non avesse fortuna nell’abbordare qualche mulatta.
L’indomani si svegliò in una camera d’albergo. Si guardò intorno. No, non c’erano donne nel letto. Salvo che gli doleva la testa e gli bruciavano le orecchie, si sentiva bene. Lo stomaco a posto. Per un istante pensò che sbarcava allora dalla Francia. Poi si ricordò della Packard: dove diavolo l’aveva lasciata? Allungò la mano al telefono. «Dite, in che albergo mi trovo?» Era il McAlpin, buon giorno. Rammentò il numero di Joe Turbino e gli telefonò per chiedergli quale fosse il miglior rimedio per una sbornia. Quand’ebbe finito di telefonare, non si sentiva più tanto bene. La bocca gli sapeva come il fondo di una stia di polli. Si rimise a dormire. Il telefono lo risvegliò. «Un signore cerca di voi.» Allora si ricordò ogni cosa di Doris. L’uomo da parte di Turbino gli portò una bottiglia di scotch. Charley ne bevve senz’altro un sorso, tracannò in abbondanza acqua ghiacciata, prese un bagno, ordinò qualcosa da colazione. Ma era già l’ora di andare a pranzo. Si mise la bottiglia di scotch nella tasca del soprabito e si diresse alla volta del Frank and Joe a prendere un cocktail. La sera si fece portare in tassì a Harlem. Girò di locale in locale ballando con le mulatte. Ebbe una rissa in un circolo. Era giorno, quando si trovò in un altro tassì diretto al centro, dalla signora Darling. Non aveva più denaro per pagare l’autista e costui insistette per accompagnarlo nell’ascensore, quando salì a prendere dei soldi. Non c’era nessuno nell’appartamento tranne la cameriera negra e questa sparò cinque dollari. Cercò di indurre Charley a mettersi a letto, ma lui voleva firmarle un assegno. Sapeva benissimo fare la sua firma, ma non riusciva a farla sull’assegno. La cameriera cercò d’indurlo a prendere un bagno e coricarsi. Disse che aveva tutto lo sparato della camicia sporco di sangue. Si sentiva a posto ed era tutto ripulito, aveva fatto un sonno nella poltrona d’un barbiere, mentre il barbiere lo radeva e gli metteva una compressa di ghiaccio sull’occhio annerito, e se n’era tornato al Frank and Joe a bere un corroborante, quand’ecco Nat Benton. Bravo il vecchio Nat che gli chiese allarmato dell’occhio nero, e Charley faceva vedere a Nat dove si era spellate le nocche contro quel tale, ma Nat s’era messo a parlare di affari e di Askew-Merritt e di Standard Airparts e diceva che Charley, non fosse stato per lui, si sarebbe
trovato sul lastrico. Bevvero qualche bicchierino ma Nat parlava di latte scremato e voleva che Charley venisse all’albergo a vedere Farrell. Farrell aveva in mente che Charley fosse il più gran tipo del mondo, e Farrell era nell’industria l’uomo dell’avvenire, si poteva puntare anche l’ultimo dollaro su Farrell. E senz’altro ecco Farrell, e Charley gli mostrava le nocche e gli spiegava che aveva suonato quel tale in quella lurida partita e come li avrebbe pelati tutti se qualcuno non lo picchiava dietro l’orecchio con una calza piena di sabbia. Detroit, certo. Era pronto a venire a Detroit quando volesse. O Detroit o dovunque. Porco mondo, non fa piacere restare in una città dove vi hanno ripulito. E quella porca mulatta aveva il suo portafogli con dentro tutti gli indirizzi. Documenti? Certo. Firmo tutto quel che volete, tutto quel che Nat dice. Titoli, certo. Convertite fin l’ultima azione. A che diavolo servono i titoli in una fabbrica, in una città dove vi hanno ripulito le tasche in una trappola? Detroit, certo, senz’altro. Nat, chiama un tassì, andiamo a Detroit. E poi furono di nuovo nell’alloggio e Taki cicalava e Nat fece lui tutto e Farrell diceva: «Non vorrei vedere in faccia quell’altro» e Charley riuscì benissimo a far la sua firma stavolta. La prima volta la fece sul tavolo, ma poi la mise nel contratto, e Nat pensò tutto lui per la conversione delle Askew-Merritt in titoli Tern e poi lui e Farrell dissero che Charley doveva aver sonno e Taki non la smetteva di guaire che avrebbe dovuto prendere subito un bagno caldo. Charley si svegliò l’indomani mattina con la testa a posto, duro e stecchito come una carcassa pronta per i becchini. Taki gli portò una spremuta d’arancia, ma lui la rigettò senz’altro. Ricadde sul guanciale. Aveva detto a Taki di non far entrare nessuno, ma ecco là Joe Askew in piedi in fondo al letto. Joe era più pallido del solito e mostrava un cipiglio preoccupato come all’ufficio, e si tirava i baffetti biondi sottili. Non sorrideva affatto. «Come stai dunque?» disse. «Così così» rispose Charley. «E così siamo agli impianti Tern, vero?» «Joe, non posso più resistere a New York. Sono stufo di questo buco.» «Sei stufo di molte altre cose, mi sembra.»
«Joe, sul serio non l’avrei fatto, se non avessi dovuto andarmene di qui… e poi ho contribuito all’impresa tanto quanto te, qualcuno dice anche di più.» Le labbra sottili di Joe erano strettamente incollate insieme. Fece per dir qualcosa, si arrestò e uscì rigido dalla stanza. «Taki,» chiamò Charley «prova a farmi una spremuta di pompelmo, via.» 1. American Expeditionary Forces, le truppe americane del ‘17 inviate in Europa. (NdT)
Cine-giornale LVI il suo primo passo fu di salire su un treno rapido diretto a Miami per vedere se gli impresari impegnati alle costruzioni e finanziati dalla sua corporazione stimolavano il lavoro quanto era in loro potere e per dare un’occhiata generale Fresco e presto al mattino LUTERANI CHE ABBANDONANO L’INFERNO PER L’ADE Gioia mia quella barca che dondola allegria quei moretti che cantano e che sa cosa dice il fischietto tutto solo, tu, tu UNA FUGA D’ARIA È LA CAUSA DEL DISASTRO DELLA CORAZZATA Sei proprio nel Kentucky com’è vero che sei nato PIROSCAFO IN FIAMME UNA PATTUGLIA È ALLE CALCAGNA DEI DELINQUENTI DELL’AEROPOSTALE Dove il mare si distende sulla spiaggia di Miami c’è qualcuno che mi attende sulla spiaggia di Miami SINO A IERI QUASI DUEMILA SI SONO CONVERTITI ALLE CHESTERFIELD LE BELLE PRESERO IL VOLO CON POCHI VESTITI Ho veduto una rosa novella vado in cerca d’un’altra più bella stammi bene i tre bianchi che ha con sé pare siano di primitiva razza nordica. Fisicamente sono splendide creature. Hanno ciuffi biondofino, occhi glauchi e pelle candida. I maschi sono ricoperti di una peluria Lasciatemi dormire in Carolina laggiù
con un molle cuscino sotto il capo disteso per un povero errante non occorre di più dentro il cuore che stretta a sentir cantar la civetta in Carolina
Occhio fotografico (48) alla volta dell’Occidente via Avana Puerto México Galveston da Santander (l’estuario vitreo il senso delle colline all’orlo dell’umida notte ogni tanto una stella gocciola fredda giù dal cielo piovoso una fila di luci trabocca dalla spiaggia imbacuccata) le doppie eliche strepitano finalmente verso occidente via dalle zitelle pensionate che s’intendono di acquerelli dagli uomini vecchi occhi di coccodrillo che nascondono artigli sanguinosi sotto eleganti guanti di filato dai paesaggi corrosi di letteratura a occidente perché i vecchi son vecchi i vecchi son grigi ma il cuor del giovane è pieno d’amore vattene vecchio a tavola (verso occidente) nel salone tutto luce la bella cubana 1 largo seno occhi raggianti in abito giallo scollato maliziosissima con l’acuta unghia rosa del piccolo mignolo addita i ricciuti bei giovani di Bilbao (rumorosi e spiritosi) in completi attillati color gelato camicie di seta cravatte a strisce (vanno a occidente all’Avana per il rialzo dello zucchero) quello ricco ha un anello di diamanti occhi troppo lucenti guardano come il mignolo di lei si atteggia ma il cuor del giovane è pieno d’amore la bella mormora Lui usciva dalla cabina di lei mentr’io andavo al bagno Perché ridacchiava la passeggera del sessantasei? il riccone di Bilbao ordina champagne per fare eco ai tappi che scoppiano a salve dalla lunga tavola dove il generale messicano alto faccia solenne baffi neri e cinque figlioli dalle gote azzurre alti facce solenni un majordomo grasso e una spruzzaglia di vuote dame simili a galline che sfrusciano fuori in fretta vestite di seta nera coi fazzoletti alla bocca appena doppiamo il promontorio dov’è il faro alla volta dell’Occidente (dall’antico nel nuovo mai ordinato nuovo mai decifrato nuovo) una meridionale traversata estiva (verso la
realtà) il fragore nelle orecchie l’azzurro profondo che rovescia il sole ardente sopra il dorso della mano il senso umido di salsedine sui mancorrenti l’odore del lucido e il vapore d’alta pressione l’infinito balenante barbaglio della luce e ogni giorno a mezzodì ci rimpinziamo d’antipasti beviamo troppo vino mentre ridacchiante rotando gli occhi la bella a indicare con chi ha dormito il tale o la tale prontamente addita la juerga 2 ahimè il bel giovane di Bilbao quello dell’anello dei diamanti ha una falla a mezza nave (alla volta dell’Occidente le antiche furie incombono sulla scia) un calcio dal piede crudele di Venere si ritira a letto prendiamo il caffè nella sua cabina invece che nel fumatoio le signore s’interessano del suo caso due gallegos bocche scucite colli di rana girovaghi sono invitati su dalla terza a cantare con la chitarra (acqua di Vichy e canto appassionato argirolo rima con usignolo) si quieres qu’el carro cante mójele y déjele en río que después de buen moja’o canta com’un silbío 3 e storie allegre le mille e una notte dell’Avana la danza dei milioni le belle cubanas a ellas les gustan los negros ma salendo sul ponte a prendere una boccata di meriggio marino c’è altro da vedere che quella rugginosa mercantile dondolante nell’indaco el rubio 4 il bel giovane di Bilbao quello che non ha anelli di diamanti cinto da cubani vociferanti la bella in testa col seno prorompente un ometto con basette grigie viene cacciato innanzi contro el rubio lo spingono alle spalle escándalo alternamente i contendenti si accapigliano con gli amici che li trattengono irrompono si balzano addosso dibattendo le braccia sono riafferrati tirati da parte intervengono gli ufficiali della nave tremanti e pallidi i campioni sono portati via quello dalle basette nella sala delle signore el rubio a poppa nel fumatoio
qui ruminiamo gli insulti ma com’è stato? no señor no el rubio dà di piglio a un foglio intestato della Compagnie Générale Transatlantique ma le dita rifiutano di stringere la penna mentre se le attorceva nei lunghi capelli ricci uno spettatore non autorizzato che s’era immischiato nella baruffa scarabocchiò speditamente sotto sua dettatura una sfida e la portò gelido agli avversari nella sala delle signore coño 5 poi passeggiamo el rubio innanzi e indietro attraverso la poppa palpitante discutiamo pugnali pistole assalti di scherma ora soltanto lo spettatore non autorizzato appare ai pasti el rubio ozia accigliato in fondo alla cuccetta del suo zoppicante amico e si prepara all’ora fatale la nave è in subbuglio non si parla che di duelli finché mon commandant un bretone rosso in faccia visita le due parti e spiega che codesto tipo di scioccherie è categoricamente proibito nei regolamenti della Compagnie Générale Transatlantique e che i gallegos musicanti debbono ritornare in terza classe donde sono sbucati costernazione entra con passo marziale mi general esperto dice in affari d’onore un militare coño vamos può provarsi a riconciliare le parti? tutti al fumatoio dove sono già allineate quattro bottiglie di champagne confortevolmente ghiacciate nei loro secchielli bianchi coño vengon serviti panini mi general chiarisce l’equivoco qualcosa su los negros e las cabanas udito a caso nella cabina dei giovani di Bilbao ascoltando vamos giù dal boccaporto molte cose ch’è meglio tacere ma in ogni caso l’onore isolato dal boccaporto era intatto malsicuri i campioni si toccano la mano coño palmas sombreros música mi general dice due parole in terza i gallegos cantano e strimpellano el rubio al banco mi confida è da la bella dal mignolo rosa puntato e dall’orecchio schizzinoso ai boccaporti che l’amico dall’anello di diamanti si è preso anche lui teme coño una puta indecente arrivo all’Avana un marito sfarzosamente vestito e col panama riceve la bella i bei giovani di Bilbao vanno al Sevilla Biltmore e io danza dei milioni o no la bolletta ha rialzato la solita testa
inevitabile come i visti di controllo nel turbine dei prezzi dello zucchero nel divorante sole d’agosto il sottoscritto vagabonda la città e le notti zuccherate con venti dollari quindici otto e cinquanta che diminuiscono nelle tasche in cerca di redditizio e come andare al Messico o in qualunque altro posto 1. In italiano nel testo. 2. Baldoria. (NdT) 3. Se vuoi che il carro canti bagnalo e lascialo nel fiume ché dopo un buon bagno canta come un merlo. (NdT) 4. Biondo. (NdT) 5. Interiezione: “suvvia, perbacco”. (NdT)
Margo Dowling Margo Dowling aveva sedici anni quando sposò Tony. Le piacque il viaggio sul piroscafo alla volta dell’Avana. Il mare fu assai mosso, ma lei non ne soffrì affatto; Tony sì. Diventò giallo giallo e rimase in cuccetta tutto il tempo e non sapeva che gemere, quando Margo tentava di farlo salire sul ponte a respirare un po’ d’aria. Erano ormai in vista dell’isola e non le riusciva di farlo rivestire. Era così debole che dovette lei aiutarlo, come un bimbo. Tony stava disteso in cuccetta con gli occhi chiusi e le guance incavate, mentre gli abbottonava le scarpe. Poi lei si precipitò sul ponte per vedere l’Avana di Cuba. Il mare era ancor mosso. Le ondate sprizzavano colonne di schiuma su per le grandi rupi sotto il faro. Il giovane ufficiale in terza dal viso sottile, che le aveva usato tante gentilezze per tutta la traversata, le mostrò Morro Castle dietro il faro e le barchette da pesca con le minuscole figurine nere o brune sopra, che ballonzolavano su e giù sui grossi cavalloni al largo del faro. Dall’altra parte le pallide case color caramella pareva sorgessero proprio sui frangenti. Margo gli chiese dov’era il Vedado e quello tese il dito più oltre nella nebbiolina sopra la spuma. «Quello è il bel quartiere dei residenti» le disse. Faceva un gran sole e il cielo era pieno di grosse nuvole candide. Ormai erano già nell’acqua tranquilla del porto e passavano davanti a una fila di grandi golette ancorate contro l’erta collina sotto i forti e i castelli assolati, e lei dovette scendere nello stivato soffoco della cabina per far alzar Tony e chiudere le valigie. Tony era ancor debole e non smetteva di ripetere che gli girava la testa. Dovette sostenerlo, scendendo la passerella. La baracca dello scalo era piena di gente dagli occhi lucidi e piccini, in abiti bianchi e marrone, tumultuanti e cicalanti. Pareva che tutti fossero venuti a ricevere Tony. C’erano vecchie signore in scialle e giovanotti pustolosi in paglietta e un vecchio signore dai folti favoriti bianchi che portava un panama. Marmocchi dai cerchi scuri sotto gli occhi si cacciavano fra i piedi di tutti. Tutti erano o gialli o color del caffè e avevano occhi neri, e c’era una vecchia negra dai capelli grigiastri vestita di rosa. Tutti piangevano e levavano al cielo le
braccia e stringevano e baciavano Tony e passò molto tempo prima che qualcuno anche solo si accorgesse di Margo. Poi tutte le vecchie le si accalcarono intorno baciandola e spalancando gli occhi e gettavano esclamazioni in spagnolo sui suoi capelli e sui suoi occhi e lei si sentiva terribilmente sciocca non comprendendo una parola e badava a interrogare Tony quale fosse sua madre, ma Tony aveva dimenticato il suo inglese. Quando finalmente le additò una corpulenta vecchia signora in scialle e disse la mamá, Margo provò un grande sollievo che non fosse la negra. Se questo è il bel quartiere dei residenti, si disse Margo, quando si versaron tutti fuori dal tranvai, dopo una lunga corsa per lamentose vie di case in pietra piene di polvere e odori viscidi e carretti e tiri di muli, nel divorante sole di un vicolo acciottolato, io sono un’ereditiera milionaria. Passarono per un alto portone, aperto nello scrostato stucco rosa di un muro rognoso tagliato da anguste finestre inferriate che giungevano fino al suolo, entrando in un fresco vestibolo odor agro, ammobiliato di poltrone in vimini e piante. Un pappagallo in gabbia strillò e un cagnolino bianco grasso come un porcellino latrò contro di lei e la vecchia signora che Tony aveva detto essere la mamá s’avanzò e le circondò le spalle con un braccio e disse una quantità di cose in spagnolo. Margo se ne stette dritta prima su un piede poi sull’altro. Il portone era accalcato di vicini che le sbarravano addosso i loro occhi di scimmia. «Ma, Tony, potresti almeno spiegarmi che cosa mi sta dicendo» piagnucolò Margo stizzita. «Mamma dice che quest’è casa tua e che tu sei la benvenuta, cose simili. Ora devi rispondere muchas gracias, mamá.» Margo non riuscì a rispondere nulla. Le salì un nodo in gola e scoppiò in lacrime. Pianse ancora quando vide la loro camera, una enorme alcova semibuia, tappezzata di cortine di pizzo lacere e quasi riempita da un enorme letto di ferro con sopra una coltre gialla, ch’era tutta macchiata di una chiazza scura. Lasciò di piangere e le scappò un sogghignetto quando vide l’enorme orinale sbreccato, dipinto a rose, far capolino da sotto il letto.
Tony se la prese. «Ricordati che devi comportarti meglio» disse. «I miei dicono che sei molto carina ma niente beneducata.» «Ah, non mi rompere le scatole.» Per tutto il tempo che visse all’Avana restò in quell’alcova con un semplice paravento davanti alla porta a vetri che dava nel cortile. Tony e i ragazzi eran sempre fuori. Non la conducevano mai in nessun posto. Il peggio di tutto fu quando s’accorse che doveva avere un bambino. Giorno per giorno giacque là tutta sola, fissando l’intonaco bianco screpolato del soffitto, ascoltando lo stridulo cicaleccio delle donne nel cortile e nel vestibolo e il pappagallo e il guaiolare del cagnolino bianco che si chiamava Kiki. Scarafaggi correvano su e giù per le pareti e facevano buchi in tutti gli abiti che non venivano chiusi nei cassettoni. Ogni pomeriggio un riquadro cocente di sole si infilava attraverso il tetto di vetro del cortile e correva lungo la sponda del letto e sopra le mattonelle del pavimento gettando nell’alcova un riverbero soffocante. La famiglia di Tony non le permetteva mai d’uscire, a meno che l’accompagnasse una delle vecchie, e non s’andava di solito che fino al mercato o in chiesa. Lei detestava di andare al mercato che era così sporco e puzzolente di rancido e zeppo di negri sudati e pigianti e di cinesi che strillavano sopra stie di polli o lubrichi banchi di pesce. La mamá e Tia Feliciana e Carná, la vecchia negra, ne parevano incantate. In chiesa era meglio, là almeno la gente era meglio vestita e gli altari luccicanti eran spesso pieni di fiori, per cui Margo andava a confessarsi regolarmente, benché il prete non comprendesse le scarse parole spagnole che lei cominciava a mettere insieme e lei non potesse comprendere le sue risposte. Comunque, la chiesa era meglio che star seduta tutto il giorno nel soffoco e negli odori rancidi del vestibolo, a compiere tentativi per parlare con le vecchie le quali non facevano mai altro che sventagliarsi e cicalare, mentre il cagnolino dormiva su di un sudicio cuscino sopra una sedia rotta e di tanto in tanto avventava una dentata a una mosca. Tony non le prestava più la minima attenzione; e poteva volergliene Margo, visto il suo viso sempre così arrossato e gonfio
dalle lacrime? Tony era sempre in compagnia di un grassone anziano dalla faccia infantile vestito di bianco, dall’enorme doppia catena d’oro dell’orologio intrecciata attraverso la pancia, e di costui tutti parlavano con assai rispetto come del señor Manfredo. Era un sensale di zuccheri e doveva mandar Tony a studiar musica a Parigi. Certe volte arrivava e sedeva nel vestibolo su una poltrona di vimini, con la sua mazza dal pomo d’oro fra le ginocchia grasse. Margo aveva sempre la sensazione d’un qualcosa di curioso nel señor Manfredo, ma fu con lui quanto più gentile poté. Neanche lui le fece la minima attenzione. Non staccava mai gli occhi dalle lunghe ciglia nere di Tony. Una volta la prese la disperazione e corse sola al Park Central in una farmacia americana che aveva osservato una sera che le vecchie l’avevano portata a sentir la banda militare. Tutti gli uomini che incontrò le sbarravano gli occhi addosso. Arrivò alla farmacia dopo una corsa pazza e comperò tutto l’olio di ricino e il chinino che poté coi soldi che aveva. Al ritorno non poteva fare un isolato senza che qualche uomo la seguisse e cercasse di prenderle il braccio. «Va all’inferno» rispondeva in inglese, e tirava via ancor più svelta. Smarrì la strada, per poco non la investì una macchina e finalmente giunse a casa, senza più fiato. Le vecchie eran già tornate e fecero il diavolo a quattro. Quando arrivò Tony, glielo dissero e Tony fece una scenataccia e cercò di batterla, ma lei era la più forte e gli ridusse un occhio nero. Allora Tony si buttò sul letto singhiozzando e Margo gli mise compresse fredde sull’occhio per calmargli l’enfiagione e lo coccolò e furono insieme felici e contenti per la prima volta da quando erano giunti all’Avana. Il brutto fu che le vecchie scoprirono che l’occhio gliel’aveva annerito lei e tutti si misero a burlare Tony per questo. Pareva che tutta la via lo sapesse e tutti dicevano che Tony era una donnetta. La mamá non perdonò mai a Margo e fu in seguito con lei maligna e dispettosa. Se soltanto non avesse dovuto avere quel bambino, Margo sarebbe fuggita. Tutti i risultati dell’olio di ricino furono una colica tremenda, e il chinino le faceva soltanto sibilare le orecchie. Rubò un coltello
aguzzo in cucina e decise che si sarebbe uccisa con quello, ma non ebbe il coraggio di piantarlo. Decise di impiccarsi col lenzuolo, ma nemmeno a questo pareva risolversi. Tenne il coltello sotto il materasso e stette in letto tutto il giorno fantasticando di quel che avrebbe fatto se mai rimetteva i piedi negli Stati e pensando ad Agnes e Frank e agli spettacoli di varietà e all’organizzazione Keith e al pattinatoio di St. Nicholas. Certe volte s’induceva a credere che tutto ciò fosse soltanto un incubo e che si sarebbe destata nel suo letto a casa, da Indian. Scriveva ad Agnes tutte le settimane e Agnes talvolta le mandava in una lettera un paio di dollari. Aveva messo da parte quindici dollari in una borsetta di coccodrillo che Tony le aveva regalato appena giunti all’Avana quando un giorno Tony vi gettò per caso un’occhiata e intascò il denaro e se ne andò a far baldoria. Margo era tanto abbattuta che non strillò nemmeno per questo, quando lui tornò coi cerchi neri sotto gli occhi, dopo aver passato la notte in una sala di rumba. Stava troppo male in quei giorni per strillare ancora contro qualcuno. Quando la presero le doglie, a nessuno veniva in mente di portarla all’ospedale. Le vecchie dicevano che sapevan bene che fare, e due suore di carità con grandi cuffie candide a farfalla cominciarono ad affaccendarsi dentro e fuori reggendo catini e brocche d’acqua calda. Durò tutto il giorno e tutta la notte e parte dell’indomani. Margo era certa che sarebbe morta. Alla fine urlò così forte chiamando il dottore che quelle uscirono e ricondussero un vecchio dalle mani gialle tutte nocchiute dai reumatismi e una barba maculata di tabacco, e dissero che era il dottore. Portava occhiali cerchiati d’oro col nastro, che continuavano a cadergli dal lungo naso storto. Costui l’esaminò e annunciò che tutto andava a meraviglia, e le vecchie ghignanti e accennanti del capo gli stavano dietro. Poi le doglie la riafferrarono; non sentiva più altro che le doglie. Quando fu tutto finito, si distese così debole che credeva d’esser morta. Glielo portarono da vedere, ma lei non guardò. L’indomani, destandosi, udì un lieve vagito accanto e non capiva che fosse. Si sentiva troppo male, per volgere il capo a guardare. Le vecchie per
qualche ragione scuotevano il capo, ma lei non ci badava. Quando le dissero che lei non era abbastanza in salute per allattarlo e che si sarebbe dovuto allevarlo con la bottiglia, nemmeno ci badò. Passarono due o tre giorni di un vacuo sfinimento. Poi fu in grado di bere un po’ di spremuta di arancia e latte caldo, e poté alzare la testa sul gomito e guardare il piccino quando glielo portarono. Appariva tanto piccolo da far spavento. Era una bambina. Il povero faccino era rugoso e vecchio come quello di una scimmia. Agli occhi aveva qualcosa. Margo ottenne che mandassero per il vecchio dottore e questi sedette sulla sponda del letto con un’aria assai solenne e non smetteva di strofinarsi gli occhiali col grande e pulito fazzoletto di seta. Badava a chiamarla una povera piccola niña e finalmente le fece capire che la piccina era cieca e che suo marito aveva un malattia venerea e che appena lei si fosse rimessa doveva andare in una clinica a curarsi. Margo non si mise a piangere né a dir nulla, ma soltanto stette là distesa fissandolo con gli occhi brucianti e le mani e i piedi agghiacciati. Non voleva che andasse via, altro non pensò. Si fece spiegare ogni cosa della malattia e delle cure e finse di comprendere meno lo spagnolo che non in realtà, soltanto perché non andasse via. Qualche giorno dopo, le vecchie indossarono i loro migliori scialli neri di seta e portarono la piccina in chiesa per il battesimo. La sua faccina era spaventosamente violacea in mezzo a tutto il pizzo in cui l’acconciarono. La notte, si fece quasi nera. L’indomani mattina era morta. Tony si mise a piangere e le vecchie tutte fecero coro; e spesero un mucchio di denari in una piccola bara candida coi manichi d’argento e il carro e il prete per il funerale. Più tardi vennero le suore di carità e pregarono accanto al letto e venne il prete e parlò con le vecchie in una maestosa voce di tragedia, come quella di Frank quando indossava l’abito da cerimonia, ma Margo non fece che restarsene là in letto sperando di morire anche lei, con gli occhi chiusi e le labbra strettamente serrate. Qualunque cosa le dicessero, non voleva saperne di rispondere o aprir gli occhi. Quando si fu abbastanza rimessa da sedersi nel letto, non volle saperne di andare alla clinica, come faceva Tony. Non volle parlare
con lui né con le vecchie. Fingeva di non capire quel che dicevano. La mamá le guardava in faccia in quel suo modo dispettoso e crollava il capo e diceva «Loca». Che voleva dir pazza. Margo scrisse ad Agnes lettere disperate: per amore di Dio, vendesse qualche cosa e le mandasse cinquanta dollari per tornare a casa. Anche solo arrivare in Florida bastava. Avrebbe trovato lavoro. Non le importava quel che avrebbe fatto, purché potesse tornare al paese di Dio. 1 Disse soltanto che Tony era un fannullone e che l’Avana non le piaceva. Non fece mai parola della piccina né della malattia. Poi un bel giorno le venne un’idea. Non era una cittadina americana, lei? Sarebbe andata dal console a chiedere se non la potevano rimpatriare. Ci vollero settimane prima che potesse uscire senza una delle vecchie. La prima volta che arrivò al consolato, tutta elegante nel suo unico vestito bello, fu solamente per trovarlo chiuso. La seconda volta andò al mattino mentre le vecchie giravano per il mercato e le riuscì di trovare un impiegato dai capelli di stoppa che era un ex studente americano. Dio, come faceva piacere parlare ancora americano. S’accorse che quello la trovava una splendida ragazza. Anche a lei era simpatico il giovanotto, ma non glielo lasciò capire. Gli disse che era malata e doveva ritornare negli Stati e che l’avevano infinocchiata, facendola venire fin là con falsi pretesti di una scrittura all’Alhambra. «L’Alhambra» disse l’impiegato. «Caspita, ma voi non avete l’aria di una ragazza di questo genere.» «Non lo sono» rispose Margo. Si chiamava George. Le disse che, se aveva sposato un cubano, lui non poteva far nulla, dato che sposando uno straniero si perde la cittadinanza. Margo chiese: e se non fossero proprio sposati? Quello le rispose che gli pareva che avesse detto di non essere una ragazza di questo genere. Margo cominciò a piagnucolare e disse che non le importava che genere di ragazza lei fosse, ma a casa doveva andare. Lui disse che ritornasse l’indomani e avrebbe intanto veduto quel che il consolato poteva fare; ad ogni modo non voleva accettare un tè con lui nel pomeriggio al Miami?
Margo rispose che eran d’accordo e corse a casa, sentendosi meglio che non si fosse sentita da gran tempo. Appena si trovò sola nell’alcova tirò fuori dalla valigia la licenza di matrimonio e la strappò in tanti pezzetti minuscoli e la gettò nel lurido bacino giallo della vecchia latrina in fondo al cortile. Una volta tanto la catena funzionò e fin l’ultimo pezzetto della carta al nontiscordar scomparve nel tubo di scarico. Nel pomeriggio ricevé una lettera di Agnes con dentro un vaglia di cinquanta dollari sulla National City Bank. Ne fu così eccitata che il cuore quasi le cessò di battere. Tony era uscito e si dava bel tempo chi sa dove col sensale di zuccheri. Margo gli scrisse un biglietto dicendo ch’era inutile cercarla, ritornava in patria, e lo appuntava con uno spillo dietro il guanciale sul letto. Poi attese finché le vecchie non s’appisolarono per la siesta, e si precipitò fuori. Non sarebbe più ritornata. Non aveva che gli abiti che indossava, e qualche gioiello di poco prezzo, che Tony le aveva regalato al tempo delle nozze, chiusi nella valigia. Andò al Miami e ordinò un gelato al selz, in inglese perché tutti capissero che era un’americana, e attese George. Di minuto in minuto le cresceva la paura tanto che credeva di non farcela più. E se George non veniva? Ma George venne e fu certo ben contento quando vide il vaglia, perché disse che il consolato non aveva fondi per un caso come il suo. Disse che le avrebbe riscosso lui la somma l’indomani, e l’avrebbe aiutata a prendere il biglietto e tutto. Margo gli rispose ch’era tanto caro e poi di botto si piegò innanzi e gli posò sul braccio la mano inguantata candida e lo fissò negli occhi ch’eran azzurri come i suoi e sussurrò: «George, bisogna che mi aiutiate ancora un poco. Bisogna che m’aiutiate a nascondermi… Ho tanta paura di quel cubano. Sapete come sono tremendi quando s’ingelosiscono». George arrossì e cominciò a dar colpetti di tosse, ma Margie gli raccontò quel ch’era accaduto nella sua via proprio il giorno avanti, come un tale, un ufficiale, era tornato a casa e aveva trovato, insomma, la sua ragazza, con un altro uomo, insomma, poteva ben raccontargli la cosa com’era avvenuta – era certa comunque che
George non si sarebbe spaventato per così poco –, erano a letto insieme e l’ufficiale vuotò tutto il tamburo della rivoltella nel corpo dell’altro e poi rincorse la donna per la via con un trinciante e le diede cinque pugnalate sulla pubblica piazza. E arrivata a questo punto le scappava da ghignare e George cominciò a ridere. «So che vi sembrerà buffa… ma non è stato buffo per quella donna. È morta là in piazza senza uno straccio addosso, esposta agli sguardi di tutti.» «Allora, bisognerà che pensiamo quel che si può fare» disse George «per guardarvi da questo trinciante.» Quel che fecero fu di andarsene a Matanzas sul tram elettrico Hershey e prendere una camera all’albergo. Qui cenarono e bevvero una quantità di liquori al selz e George, che le aveva detto che se ne sarebbe andato per ritornare l’indomani in tempo per portarla al piroscafo, divenne romantico sui bicchierini e la luna e i cani che abbaiavano e i galli che cantavano. Andarono a passeggio, cingendosi col braccio, giù per le tranquille vie lunari color del gesso, e George perse l’ultimo tram per tornare all’Avana. Margo non pensò ad altro che a non restar sola in quell’albergo dalle mura bianche, deserto, che le dava la pelle d’oca, e quella luna così lucente e tutto. E poi, George le era simpatico. L’indomani a colazione lui le disse che avrebbe dovuto permettergli d’imprestarle altri cinquanta dollari, in modo che potesse prendere la prima classe, e Margo rispose che davvero glieli avrebbe restituiti non appena trovato lavoro a New York e che doveva scriverle tutti i giorni. George ritornò all’Avana col primo tram perché doveva trovarsi all’ufficio e lei ritornò più tardi, sola, attraverso la verde abbagliante campagna strepitosa d’insetti, e si recò in carrozza difilato dalla stazione al piroscafo. George l’aspettava là allo scalo col biglietto per lei e un mazzetto d’orchidee, le prime che Margo avesse mai avuto, e un rotolo di denari che lei ficcò nella borsetta senza contarli. I camerieri parvero sommamente stupiti che non avesse bagaglio, e allora fece dir loro da George che aveva dovuto correr da casa in cinque minuti, poiché suo padre, ricca persona, s’era ammalato a New York. Lei e George scesero senz’altro in cabina, e George era assai
sconsolato per la sua partenza e disse di non aver mai conosciuto una ragazza più adorabile e che le avrebbe scritto tutti i giorni, ma lei non riusciva a seguire quel che diceva, aveva tanta paura che Tony venisse al piroscafo a cercarla. Finalmente squillò il gong e George la baciò disperatamente stretto e scese a terra. Margo non osò salire sul ponte, finché non udì le campane delle macchine e sentì la vibrazione del bastimento che cominciava a indietreggiare staccandosi dalla gettata. Guardando dal finestrino, mentre il piroscafo s’incamminava, intravide un uomo svelto e fosco, vestito di bianco, che avrebbe potuto esser Tony, precipitarsi di fra le guardie e correre strillando e agitando le braccia fino all’estremità dello scalo. Fossero le orchidee o la sua figura o la storia della malattia paterna, fatto sta che il capitano la invitò al suo tavolo e tutti gli ufficiali le furono addosso e lei si divertì come non mai in quel viaggio. La sola seccatura era che poteva soltanto salire in coperta nel pomeriggio, perché non aveva che quell’unico abito. Aveva affidato a George un cablogramma da spedire e così, giungendo a New York, Agnes era a prenderla allo scalo. Era tardo autunno e Margo non aveva indosso altro che un leggero abito d’estate e perciò disse che voleva pagare ad Agnes il tassì per tornare a casa. Soltanto quando furono entrate nell’auto, s’accorse che Agnes era in lutto. Quando le chiese il perché, Agnes disse che Fred era morto a Bellevue due settimane prima. Era stato raccolto nella Ventitreesima Strada ubriaco fradicio e c’era morto, senza riprendere coscienza. «Oh, Agnes, mi pareva di saperlo… Ho avuto un presentimento sul piroscafo» singhiozzò Margo. Quando si fu asciugato gli occhi, si volse e osservò Agnes. «Ma, mia cara, tu stai bene» disse. «Che bell’abito. Frank lavora?» «Oh no» disse Agnes. «Devi sapere: le sale da tè della signorina Franklyn vanno a gonfie vele. Si sta ingrandendo e mi ha fatto direttrice della nuova filiale nella Trentaquattresima Strada a settantacinque dollari la settimana. Aspetta di vedere il nostro nuovo alloggio a un giro d’angolo dal corso… Oh, Margie, devi averne passate di belle.» «Certo» disse Margo «non è stato un piacere. I suoi stanno molto
bene e sono gente in vista e tutto, ma è duro mettersi al passo con le loro abitudini. Tony è un fannullone e lo detesto più di ogni cosa al mondo. Ma, tutto sommato, è stata un’esperienza che ho fatto… Non mi dispiace che sia andata così.» Frank le venne a incontrare sull’uscio di casa. Appariva più grasso dell’ultima volta che Margo l’aveva veduto e aveva chiazze di capelli argentei ai due lati della fronte che gli davano un aspetto distinto come un ecclesiastico o un ambasciatore. «Piccola Margo… Benvenuta a casa, bimba mia… Che bella signorina ti sei fatta.» Quando la prese tra le braccia e la baciò in fronte, Margo risentì quell’odore di lozione aromatica e di energina che di lui ricordava. «Te l’ha detto Agnes, che faccio un giro con la signora Fiske?… La cara Minnie Maddern ed io trascorremmo insieme l’infanzia.» L’alloggio era un po’ buio, ma aveva un salotto, una sala da pranzo e due camere da letto e una grande stanza da bagno e cucina. «Prima cosa che faccio» disse Margo «prenderò un bagno caldo… Non credo d’avere più fatto un bagno caldo da quando ho lasciato New York.» Mentre Agnes, che per quel pomeriggio s’era messa in libertà, usciva a fare qualche acquisto per la cena, Margo entrò nella sua linda cameretta dalle tendine di chintz alle pareti e si tolse lo spiegazzato abito estivo troppo leggero e indossò una delle vesti da camera trapuntate di Agnes. Poi si abbandonò seduta nella poltrona del salotto e tenne a bada Frank che le faceva domande sulla sua vita all’Avana. A poco a poco Frank s’accostò fiancheggiando al bracciolo della poltrona, mentre le descriveva quanto affascinante lei fosse diventata. Poi d’un tratto fece per afferrarla. Margo se l’era andato aspettando e gli menò un sonoro schiaffo sulla faccia, balzando in piedi. Si sentì prendere da un accesso d’isterismo quando Frank ansimante avanzò incontro a lei. «Non mettermi le mani addosso, vecchio barbagianni,» strillò «non mettermi le mani addosso o racconto tutto ad Agnes, e allora io e Agnes ti buttiamo fuori di casa.» Voleva fermarsi, ma non poteva cessare gli strilli. «Non mettermi le mani addosso. Laggiù mi son
presa una peste, e se mi tocchi la prendi anche tu.» Frank fu talmente sconvolto che cominciò a tremare in tutte le membra. Si lasciò cadere nella poltrona e si passò le lunghe dita in mezzo ai lucidi capelli neri e argento. Margo gli sbatté in faccia l’uscio della stanza da letto e chiuse a chiave. E seduta là sola, sul letto, cominciò a pensare come non avrebbe mai più riveduto Fred, e se fosse davvero stato un presentimento quando aveva detto a quelli del piroscafo che suo padre era malato. Le vennero le lacrime agli occhi. Certo era stato un presentimento. Il termosifone sibilò con un suono intimo. Margo si distese nel letto che era tanto comodo coi suoi guanciali di bucato e il copripiedi di seta e, ancora in lacrime, s’addormentò. 1. God’s Country, nomignolo affettuoso dato dagli americani alla patria. (NdT)
Cine-giornale LVII il medium si spogliò di ogni indumento prima delle sedute di Harvard. Torce elettriche, campanelli, grandi megafoni, cestelli, ogni cosa rischiarata di vernice fosforescente, eran questi gli ingredienti del medium Viene con gli ananassi mio fratello comincia lo spettacolo DISPOSTO AD AFFRONTARE L’INTERROGATORIO i piedi del medium non eran vicini a quelli del professore quando questi si sentì tirare una gamba dei calzoni. Una lampadina elettrica del soffitto s’accese e si spense. I campanelli suonarono. Un braccio teleplasmico afferrò oggetti sul tavolino e tirò i capelli al dott. B. Il dott. B. cacciò il naso nella ciambella e incoraggiò Walter a tirare il più forte possibile. E si sentì tirare il naso. Ci siam lasciati senza alcun rancore pure una penna mi sta in fondo al cuore MOGLIE INFELICE CHE TENTA DI MORIRE IL BEL DENTISTA SI RICONCILIA L’unico problema: il finanziamento Credevo di riuscire a tirare avanti e mi sento morire Donne di Società che cercano invano lavoro rifiutate come Dame della Regina UNA MONACA CHE SPOSA UN MARINAIO ho il cuore infranto LA REGINA RENDE OMAGGIO AL MILITE IGNOTO La polizia protegge la regina tra la folla Sotto una luna dell’antica Cina dove l’amore è sogno e melodia PROFESSORE CHE TORTURA UN RIVALE LA REGINA DORME E IL SUO SEGUITO SI RITIRA Lotta sociale che fermenta
COOLIDGE RACCOMANDA LA PUBBLICITÀ E l’ho trovata sotto il sol calante moriva il giorno Un poliziotto nutre un canarino con 500 dollari lasciati dalla ricca sposa e mentre l’orizzonte s’oscurava a me d’intorno le confessai tutto l’amore nell’antiiica Maaanila L’APOLLO ABBANDONATO SPERA ANCORA NEL RITORNO DELLA RICCA SPOSA
Margo Dowling Agnes fu un tesoro. Riuscì a trovar denaro col Morris Plan per l’operazione di Margo, quando il dottor Dennison disse che era assolutamente necessaria se non voleva pregiudicarsi in modo gravissimo la salute, e la curò come l’aveva curata quando da bambina aveva fatto la rosolia. Allorché le dissero che non avrebbe mai più potuto avere un figlio, Margo non se la prese troppo ma Agnes non smetteva di piangere. Quando ricominciò a star bene e a pensare di cercar lavoro, aveva l’impressione che lei e Agnes fossero sempre state insieme. L’“Antica casa delle cialde” andava a gonfie vele ed Agnes guadagnava settantacinque dollari la settimana; ed era una fortuna questa, perché Frank Mandeville non pareva più capace di trovare una scrittura: «Non c’è più amore per un buon spettacolo da quando c’è stata la guerra» diceva. S’era fatto molto mesto e rispettabile da quando con Agnes s’erano sposati nella Little Church Around The Corner, e passava il più del tempo giocando a bridge al Lambs Club e raccontando dei bei tempi quand’era stato in compagnia con Richard Mansfield. Quando fu di nuovo in piedi, Margo passò un intero tristissimo inverno a bighellonare per le agenzie e gli uffici personale dei teatri di riviste, prima che Flo Ziegfeld la vedesse per caso un pomeriggio seduta nella stanza d’aspetto di un ufficio in una fila di altre ragazze. Casualmente Margo lo guardò negli occhi, e accennò labilmente una smorfia buffa, mentre lui passava; Ziegfeld si fermò e le diede una squadrata; l’indomani il signor Herman la scelse per la prima fila nella prossima rivista. Le prove furono il più duro lavoro che avesse mai fatto nella sua vita. Fin dall’inizio Agnes disse che avrebbe pensato lei a che Margo non si rovinasse con la folla banale delle altre ballerine; e così, benché Agnes dovesse trovarsi al lavoro tutte le mattine alle nove precise, sempre passava al teatro tutte le sere dopo le tarde prove o rappresentazioni serali per ricondurre Margo. Fu soltanto dopo che Margo conobbe Tad Whittlesea, un terzino dell’università di Yale che una volta finita la stagione di gioco passava la fine di settimana a New
York, che Agnes mancò una prima volta. Le sere che veniva Tad a prender Margo, Agnes restava in casa. Aveva osservato Tad attentamente e l’aveva avuto a pranzo in casa una domenica e decise che per un figlio di milionario era abbastanza posato e che gli avrebbe fatto bene sentirsi qualche responsabilità verso Margo. In quelle sere Margo aveva una gran fretta di dare l’ultimo colpetto ai riccioli biondi sotto il caschetto di velluto azzurro e di sgusciare nella mantella di pelliccia, che non era volpe argentata ma a distanza poteva parere, e di lasciare la polverosa, soffocante camerata e i sentori di ferri per ricci e burro di cacao e ascelle femminili e scenari, e precipitarsi giù per la branca, piena di spifferi, degli scalini di cemento, passando innanzi al vecchio smorto Luke che dentro il suo sgabuzzino di vetro s’infilava il soprabito, sul punto di andarsene a casa anche lui. Tirava un’ampia boccata quando sbucava fuori, nel vento freddo della via. Non permetteva a Tad di venirla a prendere al teatro insieme con gli altri spasimanti della scena. Le piaceva vederlo piantato sulle sue lucide scarpe marrone ben divaricate e il soprabito di tasso aperto in modo da mostrare la cravatta a strisce e la camicia comune spiegazzata, fra la gente in abito da sera nel vestibolo dell’Astor. Tad era un semplice giovanotto rosso in faccia, che non aveva mai troppe cose da dire. Margo faceva lei tutta la conversazione, fin dal primo istante che Tad le dava la mano per aiutarla a salire nel tassì diretto al circolo notturno. Lo teneva allegro con storielle sulle altre ragazze e le guardarobiere e i ballerini. Certe volte Tad le chiedeva di ripetergli una storia per potersela ricordare e raccontarla ai suoi amici dell’università. La storia di come i ballerini, che erano la maggior parte fairies, 1 avevano gettato la maledizione della cagna su un giovanotto ch’era l’amico di Maisie De Mar, sicché anche lui era diventato un fairy, levò il fiato per il terrore a Tad. «Certo che capitano una quantità di cose che la gente non sospetta nemmeno» disse. Margo arricciò il naso. «Sei tu che non ne sospetti neanche la metà, caro.» «Ma dev’essere soltanto una storia.» «No, seriamente, Tad, è andata così… li sentivamo strillare e muggire, come fan sempre loro, nella camerata. Gli stavano tutti intorno in cerchio e gli gettarono
addosso la maledizione della cagna. Ti dico io che faceva paura.» Quella sera andarono al Columbus Circle Childs a mangiare un po’ di uova al prosciutto. «Senti, Margo» disse Tad a bocca piena mentre finiva la seconda portata di pani di burro. «Questa vita non mi pare che vada bene per te… Sei la ragazza più sveglia che ho conosciuta, e la più fine, accidenti.» «Non pensarci, Tad, la piccola Margo non resterà certo tutta la vita nel corpo di ballo.» Sulla via del ritorno nel tassì Tad cominciò a ficcarle addosso le mani. Fu stupefatta Margo, perché certo Tad non era un tipo intraprendente. E nemmeno era ubriaco, non aveva bevuto che una bottiglia di birra canadese. «Perdiana, Margo, sei straordinaria… Tu non bevi, tu non vuoi che ti abbraccino.» Margo gli scoccò un bacetto sulla guancia. «Dovresti capirlo, Tad,» disse «debbo pensare al mio lavoro.» «Mi crederai uno zuccone e nient’altro.» «Tu sei un caro ragazzo, Tad, ma mi piaci di più quando tieni le mani in tasca.» «Oh, sei meravigliosa tu» gemette Tad, fissandola con gli occhi tondi dal suo angolo d’auto dentro il morbido colletto rialzato. «Una donna che gli uomini dimenticano» disse lei. L’invito di Tad a pranzo, la domenica, divenne una cosa abituale. Tad giungeva di buon’ora per aiutare Agnes ad apparecchiare, e in seguito si levava la giacca e rimboccava le maniche per aiutar a lavare i piatti. Poi, tutt’e quattro giocavano alle carte e ciascuno beveva un bicchiere di elisir brodoferroconvino comprato in farmacia. Margo detestava questi pomeriggi festivi, ma Frank e Agnes parevano goderli assai e Tad rimaneva fino all’ultimo istante quando doveva scappar via a prendere suo padre al Metropolitan Club, dicendo che non s’era mai divertito tanto in vita sua. Una nevosa domenica che Margo se l’era sgattaiolata dal tavolino da gioco accusando un’emicrania e se n’era restata sul letto tutto il pomeriggio ascoltando il sibilo del termosifone e quasi piangendo per l’insofferenza e il tedio, Agnes disse con gli occhi accesi, quando entrò in vestaglia, una volta partito Tad: «Margo, bisogna che tu lo sposi. È un ragazzo d’oro. Ci stava raccontando che qui da noi, per la prima
volta nella sua vita, ha avuto il sentimento della casa. È stato allevato da servitori e maestri d’equitazione, tutta gente così… Non avevo mai creduto che un milionario potesse essere così caro. Mi sembra proprio un tesoro». «Non è mica un milionario» disse Margo imbronciandosi. «Il suo vecchio ha un posto in Borsa» esclamò Frank dall’altra stanza. «Non si comprano certo coi tagliandi dei tabacchi, cara mia.» «Va bene,» disse Margo, stirandosi e sbadigliando «con lui non avrei certo un marito spendaccione…» Poi sedette e scosse il dito verso Agnes. «Vuoi proprio sapere perché gli piace tanto venir qui alla domenica? Qui trova un pasto gratis, e non gli costa un centesimo.» Jerry Herman, il piccolo direttore calvo, raggrinzito, faccia gialla, era un uomo di cui tutte le ballerine avevano un terrore folle. Quando Regina Riggs disse che aveva veduto Margo un sabato far uno spuntino con lui alla Keene’s Chophouse nell’intervallo fra le recite, le ragazze non smettevano più di parlarne. Seccava molto a Margo e le dava un senso di nausea alla bocca dello stomaco, sentirle ridacchiare e bisbigliare alle sue spalle nella camerata. Regina Riggs, una ragazza dell’Oklahoma, larga di viso, il cui vero nome di battesimo era Queenie e che ballava nei corpi di Ziegfeld dal tempo che in Broadway passava il tranvai a cavalli, le prese il braccio mentre scendevano le scale a fianco a fianco dopo una prova mattutina. «Senti, marmocchia,» le disse «voglio soltanto dirti una parolina su quel tale. Tu sai chi sono, io le ho passate tutte ormai e non m’importa più un fico che è un fico, di nessuno… ma stammi a sentire. Nessuna ragazza ha mai cavato un ragno dal buco dando ascolto a quel falsone. E molte hanno provato. Fa’ conto che abbia provato anch’io. Non si può dirla con quel tale; e un bel corpo ben fatto è forse l’articolo più comune che c’è in tutta la città… Tu hai un’aria sveglia d’innocentina e ho pensato di metterti al corrente.» Margo spalancò gli occhioni azzurri. «Ma che idea… Che cosa ti ha messo in testa…?» Fece un ghigno da scolaretta. «Intese, ragazza, lasciamo andare… Vuol dire che ti conservi per i fiori d’arancio.» Risero tutte e due… Da allora furono sempre buone amiche. Ma nemmeno Queenie ne seppe nulla, quando la sera d’un sabato,
dopo la lunga e fiaccante prova di un nuovo numero per il lunedì successivo, Margo si trovò a salire nella vetturetta di Jerry Herman. Diceva che l’avrebbe condotta a casa, ma quando furono all’altezza del Columbus Circle le chiese se non voleva venire nelle sue terre del Connecticut e rifarsi davvero dalla stanchezza laggiù. Margo entrò in una farmacia e telefonò ad Agnes che ci sarebbero state prove per tutta la giornata di domenica e lei si sarebbe fermata nell’alloggio di Queenie Riggs che era più vicino al teatro. Mentre s’allontanavano, Jerry badava a far parlare di sé Margo. «C’è qualcosa di singolare in voi, ragazza mia» disse Jerry. «Gioco che voi non dite tutto quanto sapete… C’è del mistero in voi.» Per tutta la strada Margo gli andò raccontando della sua vita precedente in una piantagione di zucchero in Cuba e della grande casa cittadina di suo padre nel Vedado e di musica e danze cubane e come suo padre era andato in rovina per colpa del trust dello zucchero e lei aveva mantenuto la famiglia in Inghilterra recitando ancor bambina in pantomime natalizie, e del suo precoce disgraziato matrimonio con un nobile spagnolo e come tutta questa vita fosse ormai sepolta e d’altro lei non si curasse che del suo lavoro. «Perbacco, questa storia farebbe una magnifica pubblicità» fu quanto ne disse Jerry Herman. Quando fermarono a una cascina illuminata sotto un gruppo d’alti alberi, stettero un istante seduti nell’auto, rabbrividendo un poco nella nebbia fredda che saliva da qualche corso d’acqua. Jerry si volse a lei nel buio e parve cercare di guardarla in faccia. «Sapete la storia delle tre scimmie, cara?» «Certo» disse Margo. «Non veder male, non sentir male, non parlar male.» «Esatto» disse lui. Poi Margo si lasciò baciare. All’interno era la più simpatica delle case rustiche con un focolare divampante e due individui con camicie da legnaiuoli quadrettate, e un paio di curiose donne in abiti parigini e voce da Park Avenue, che si chiarirono poi per decoratrici. I due uomini erano scenografi. Jerry preparò per tutti nella cucina uova con prosciutto e bevvero sidro aspro e si divertirono assai, benché Margo non sapesse bene che contegno tenere. Per fare qualcosa diede di piglio a una chitarra che pendeva alla parete e ripescò Siboney e qualche altra canzone cubana imparata da Tony.
Quando una delle donne disse qualcosa su come lei avrebbe dovuto fare un numero cubano, il cuore cessò quasi di batterle. La luce azzurra del giorno filtrò per le finestre, attraverso la nebbia, prima che si mettessero a letto. Fecero poi una bella colazione campagnola ridendosela e canzonandosi tutti insieme in veste da camera e la domenica pomeriggio Jerry la riportò in città e la mise a terra sul passeggio presso la Settantanovesima Strada. Frank ed Agnes erano disperati quando giunse a casa. Tad non aveva smesso di telefonare tutto il giorno. Era andato al teatro e aveva scoperto che non c’erano prove in programma. Margo disse sprezzante ch’era stata a provare un numero individuale e se il primo venuto di studente credeva di potersi intromettere nella sua carriera gli avrebbe fatto cambiare idea. La settimana successiva, quando Tad telefonò, non accettò di trovarsi con lui. Ma una settimana più tardi, mentre usciva di camera sua circa alle due, giusto in tempo per il pranzo festivo di Agnes, ecco là Tad seduto a capo penzoloni, con le mani ciondolanti tra le ginocchia. Sulla sedia accanto c’era una scatola verde di fioraia che Margo, appena la guardò, seppe piena di rose American Beauty. Tad balzò in piedi. «Oh, Margo… non essere offesa… ma è che io non riesco più a divertirmi quando esco senza di te.» «Non sono offesa, Tad» disse Margo. «Ma voglio che tutti capiscano che non lascerò intralciare il mio lavoro dalla mia vita privata.» «Sicuro, ti capisco» disse Tad. Agnes s’avanzò tutta sorrisi e mise le rose nell’acqua. «Perdiana, dimenticavo» disse Tad e tirò fuori di tasca un astuccio di pelle rossa. Balbettava. «Senti, Pa-pa-papà mi ha da-dato certe azioni da giocarmi; la settimana scorsa mi è riuscito un colpo e ho comprato questo, solamente non le porteremo che quando usciamo insieme, no?» Era una collana di perle, piccole e non molto bene assortite, ma insomma perle. «Chi altro vuoi che mi conduca in qualche posto dove io possa metterle, zuccone?» disse Margo. Si sentiva arrossire. «E non sono poi Tecla?» Tad scosse il capo. Allora gli gettò le braccia al collo e lo baciò. «Perdiana, tienile care» disse Tad, parlando in fretta. «Ed ecco c’è
un’altra cosa… Papà mi permette di prendere l’Antoinette, è il suo battello, sai, per fare quindici giorni di crociera quest’estate coi miei amici. Voglio che veniate tu e la signora Mandeville. Inviterei anche il signor Mandeville, ma…» «Sciocchezze» disse Agnes. «Sono certa che la gita sarà lo stesso come si deve anche senza di me… Patirei il mal di mare… Lo soffrivo da morire, quando il povero Fred mi portava al largo a pescare.» «Era mio padre» disse Margo. «Amava tanto vivere sull’acqua… in panfilo… questa sorta di cose… Credo sia per questo che amo tanto il mare.» «Stupendo» disse Tad. In quell’istante Frank Mandeville rientrava dalla sua passeggiata domenicale, vestito dell’abito da cerimonia, reggendo una mazza dal pomo d’argento, e Agnes si precipitò ad apparecchiare l’arrosto di vitello ripieno, la verdura e la torta di fragole nella cucinetta, donde tiepide esalazioni drogate andavan filtrando da qualche minuto nell’aria del ristretto alloggio. «Perdiana, come mi piace questo posto» disse Tad, abbandonandosi all’indietro sulla sedia, dopo che tutti furon seduti a tavola. Per il resto di quella primavera Margo ebbe il suo daffare a impedire che Tad e Jerry si scontrassero. Con Jerry non si trovavano mai in teatro; fin dai primi giorni Margo gli aveva detto che lei non intendeva di lasciarsi intralciare il lavoro dalla vita privata e Jerry le aveva dato uno sguardo penetrante con quei suoi occhi sagaci, che parevan bolliti, e le aveva detto: «Uhm… Vorrei che molte delle nostre signorine la pensassero come te… Passo il mio tempo a staccarmele di dosso». «Brutta cosa» disse Margo. «Il Valentino dell’ufficio personale.» Le era discretamente simpatico Jerry Herman. Aveva molta esperienza nelle cose di teatro. La sola seccatura fu che, quando vennero in confidenza, cominciò a far pagare a Margo la sua parte di conto al ristorante e le mostrava ritratti della moglie e dei bambini che stavano a New Rochelle. Margo lavorò assai per quelle canzoni cubane, ma del numero individuale non si fece mai nulla.
A maggio la compagnia si metteva in giro. Per molto tempo Margo non seppe decidere se andare o no. Queenie Riggs diceva assolutamente di no. Andava tanto bene per lei che non aveva più ambizioni salvo quella di pescare un viaggiatore in qualche derelitto paesello e sposarselo prima che smaltisse la sbornia, ma per Margo Dowling che aveva una carriera innanzi a sé, niente affatto. Meglio restare in libertà tutta l’estate che ballerina in giro di spettacoli. Jerry Herman s’arrabbiò come un cane, quando lei non volle firmare il contratto di stagione. Perse le staffe di fronte al personale e a tutte le ragazze che aspettavano in fila. «E va bene, lo sentivo arrivare… si è montata la testa e si crede Peggy Joyce… E va bene, con me è finita.» Margo lo fissò dritto negli occhi. «Guardate che mi prendete per un’altra, signor Herman. Sono certa di non aver mai cominciato nulla che debba adesso esser finito con voi.» Tutte le ragazze scoppiavano, mentre lei se ne usciva e Jerry le guardò dietro come sul punto di strozzarla. Ma voleva dire non trovar più un posto in nessuna compagnia dove lui assumesse. Margo trascorse l’estate nella città torrida, ingabbiata nell’alloggio di Agnes, con nulla da fare. E c’era Frank sempre in agguato per metterle addosso le mani, di modo che doveva chiudere a chiave la porta, quando si metteva a letto. Stava buttata in giro tutto il giorno, nell’orribile soffocante cameretta dalla tappezzeria verde polverosa e dalla finestra sudicia che dava su cortiletti seminati di brace spenta, su un paio di alberi d’ailanto e il sempiterno bucato steso ad asciugare. Tad era andato al Canada appena finiti i corsi. Margo passava le giornate leggendo le riviste e pasticciandosi i capelli e curandosi le unghie e sognando come, come avrebbe potuto cavarsi da quella sordida, miserabile esistenza. Sordido era una parola che aveva sentito allora. L’aveva in mente tutto il giorno, sordido, sordido, sordido. Alla fine decise che era innamorata pazzamente di Tad Whittlesea. Quando venne agosto, Tad scrisse da Newport che sua madre stava male e la gita in panfilo era rimandata all’inverno venturo. Agnes pianse quando Margo le mostrò la lettera. «Va’ là, che ci sono
altri pesci nel mare» disse Margo. Con Queenie, che si era licenziata dal giro dopo un incidente col direttore scenico, ricominciò a battere gli uffici personale. Fecero quattro settimane di prove per una rivista che fu fischiata la prima sera. Poi trovarono lavoro al Greenwich Village Follies. Il direttore diede a Margo la possibilità di fare il suo numero cubano e Margo s’era fatta allestire un costume speciale, e tutto per vedersi scartare prima della prova generale data la lunghezza dello spettacolo. Margo si sarebbe davvero disperata, se non fosse comparso Tad dopo il giorno di Grazie e non l’avesse fatta uscire alla sera ogni sabato. Tad parlava assai della gita in panfilo che avrebbero fatto durante le vacanze invernali. Tutto dipendeva da quando cadevano i suoi esami. Dopo Natale fu di nuovo senza posto. Frank era in letto col mal di reni e Margo smaniava di andarsene da quelle stanze soffocanti, dove le toccava curare Frank e attendere alle faccende per Agnes che sovente non ritornava dal lavoro che alle dieci o alle undici di notte. Frank giaceva nel letto, il viso stirato giallo e bisbetico, e occorreva una sorveglianza continua. Agnes non si lagnò mai, ma Margo era talmente stufa di non far nulla in New York che firmò una scrittura come danzatrice in un locale di Miami, benché Queenie ed Agnes protestassero da far spavento e dicessero che si rovinava la carriera. Margo non aveva ancora regolato la contesa con il rappresentante, che le avrebbe pagato il trasferimento nel Sud, quando una mattina di febbraio Agnes entrò a svegliarla. Margo vide che qualcosa c’era, poiché Agnes era addirittura raggiante. Era Tad che la cercava al telefono. Disse che aveva la bronchite e avrebbe trascorso un mese di vacanza con un istitutore sul battello del padre nelle Indie Occidentali. Il battello era a Jacksonville. Prima che vi giungesse l’istitutore, avrebbe potuto portare a fare un po’ di crociera chi gli piacesse. Non voleva venire, conducendo un’amica? Qualcuna non troppo leggera. Si augurava che potesse venire Agnes, disse, e se ciò era impossibile per la malattia del signor Mandeville, chi altri poteva portare? Margo ne fu così eccitata che appena più respirava. «Tad, ma è prodigioso» disse. «Proprio questa
settimana facevo conto di andare nel Sud. Leggi nel pensiero, tu?» Queenie Riggs combinò di venirle insieme benché dicesse che non era mai stata prima su un panfilo e temesse di non comportarsi a modo. «Senti, io ho passato tanto tempo in barchetta, da piccola… È la medesima cosa» disse Margo. Quando smontarono dal tassì alla stazione di Pennsylvania, ecco là Tad con uno sparuto giovinottino dai capelli lustri, che le aspettava. Tutti si sentivano assai eccitati e il fiato dei due sapeva discretamente di gin. «Ragazze, prendete voi il vostro biglietto» disse Tad, stringendo il braccio a Margo e ficcandole i soldi nella tasca della pelliccia. «I posti riservati sono a vostro nome, voi avrete un salotto e noi anche.» «Questi la sanno lunga» bisbigliò Queenie al suo orecchio mentre facevan coda allo sportello dei biglietti. Il nome di quell’altro era Dick Rogers. Margo s’accorse subito che Queenie gli parve troppo vecchia e non abbastanza fine. Si tormentò anche per via del bagaglio. Le loro valigiotte avevano un’aria ben misera accanto a quelle di porco dei due. Margo si sentiva tutta abbacchiata quando il convoglio uscì dalla stazione. Qui è un dado che ho gettato, pensò. E Queenie rigettava già indietro il capo e mostrava il dente d’oro e gridava e strillava come fosse in scampagnata con carrettieri. Tutti e quattro si disposero nello scompartimento delle ragazze con il tavolino frammezzo per berci una boccata di gin e cominciarono a sentirsi sollevare. Quando il treno uscì dalla galleria e lumi cominciarono a lampeggiare via nell’oscurità esterna, Queenie tirò giù la tendina. «Dio, come si sta al calduccio, qui» disse. «E ora la prima cosa che mi dà da pensare è come imbarcarvi sul battello. Papà non direbbe nulla se sapesse che vi abbiamo conosciute a Jacksonville, ma se sapesse che venite con noi fino da New York farebbe un finimondo.» «Credo che una governante bell’e pronta ci aspetti a Jacksonville» disse il giovane Rogers. «È un prodigio di natura. Sorda, cieca, e non parla l’inglese.» «Vorrei che fosse con noi Agnes» disse Tad. «È la matrigna di
Margo. Lei sì, che è di buona compagnia.» «Dunque, ragazze» disse il giovane Rogers, dando una tracannata strepitosa alla bottiglia del gin. «Quando cominciano i bacetti?» Dopo che ebbero pranzato nella vettura ristorante, ritornarono traballando allo scompartimento e bevvero altro gin e il giovane Rogers voleva giocare al poker americano, 2 ma Margo disse di no. «Va’ là, guastafeste» ghignò Queenie. Queenie era già parecchio brilla. Margo s’infilò la pelliccia. «Voglio che Tad vada a letto presto» disse. «È ancora in convalescenza.» Prese la mano di Tad e lo trasse fuori nel corridoio. «Vieni, lasciamo in libertà i ragazzi… Il brutto con voi studenti è che, appena una ragazza si mostra non convenzionale, voi la credete una facile conquista.» «Oh Margo…» Tad la strinse attraverso la pelliccia del soprabito mentre uscivano nella gelida rimbombante aria della piattaforma panoramica. «Sei straordinaria.» La notte, dopo che si furono spogliate, il giovane Rogers entrò in accappatoio nel loro scompartimento e disse che c’era qualcuno che chiedeva di Margo nell’altro scompartimento. Margo dormì nello stesso scompartimento di Tad, ma non gli permise di salire nella sua cuccetta. «Credimi, Tad, mi piaci davvero» disse, sbirciando di tra le coperte della cuccetta superiore «ma lo sai… Se non si protegge da sé, una ragazza che si guadagna la vita, Dio non la protegge… E nella nostra famiglia ci sposiamo tutte prima di far l’amore, non dopo.» Tad sospirò e si voltolò col viso alla parete nella cuccetta sottostante. «Diavolo… ci ho già pensato a questo.» Margo spense la luce. «Ma, Tad, non mi darai nemmeno un bacio per la buona notte?» A metà della notte ci fu un busso alla porta. Il giovane Rogers piombò con un’aria piuttosto scompigliata. «Ora di smettere» disse. «Ho paura che il controllore ci becchi.» «Il controllore ficcherà il naso negli affari suoi» sbottò Tad brusco, ma Margo era già scivolata via e tornata nel suo scompartimento. L’indomani mattina facendo colazione in vettura ristorante Margo non la smetteva di canzonare i cerchi neri sotto gli occhi degli altri due. Il giovane Rogers ordinò un piatto di ostriche e credettero che le risate non si sarebbero fermate più. Avanti, poi, che giungessero a
Jacksonville, Tad aveva ricondotto Margo alla piattaforma panoramica e chiestole perché diavolo non si sposavano subito allora: era un libero bianco e maggiorenne, no? Margo cominciò a piangere e gli fece una smorfia tra le lacrime e diceva che sapeva ben lei quanti motivi c’erano per non sposarsi. «Perdiana,» disse Tad quando scesero dal convoglio nel gran sole della stazione «a buon conto ci compreremo un anello di fidanzamento.» Prima cosa, in tassì sulla strada di un albergo, passarono da un gioielliere e Tad le comprò un diamante solitario montato in platino e lo pagò con un assegno. «Misericordia, il vecchio dev’essere ben milionario» sussurrò Queenie all’orecchio di Margo con una voce come in chiesa. Dopo passato dal gioielliere, i due le condussero al Mayflower Hotel. Fissarono una camera e salirono a riordinarsi un pochino. Le ragazze si lavarono la biancheria e presero un bagno caldo e distesero l’abito sui letti. «Se vuoi il mio parere» diceva Queenie, mentre aiutava Margo a lavarsi i capelli «quei due accidenti han voglia di andarsene… È tutta la vita che desidero fare una crociera in panfilo e adesso son certa che non ci andremo proprio… Oh Margo, spero di non aver guastato io la partita.» «Tad farà tutto quanto vorrò io» rispose Margo scontrosa. «Aspetta di vedere prima» disse Queenie. «Intanto eccoci qui a bisticciare quando dovremmo invece essere a divertirci… Non è la più signorile camera del più signorile albergo di Jacksonville, Florida?» Margo non poté tenersi dal ridere. «Ebbene, di chi è la colpa?» «Giusto» disse Queenie, dimenandosi mentre usciva dalla stanza da bagno vaporosa di sapone per capelli, dove si lavavan la testa, e sbatté la porta in faccia a Margo. «Hai l’ultima parola.» All’una vennero i due giovanotti a prenderle, e fecero loro chiudere i bagagli e abbandonare l’albergo. Scesero allo scalo in una macchina Lincoln noleggiata da Tad. Era una bella giornata di sole. L’Antoinette era ancora al largo nel St. John River, e così dovettero prendere una lancia a motore. Il marinaio era un giovanotto simpatico tutto in bianco; si toccò il
berretto e tese la mano per far scendere le ragazze. Quando Margo gli poggiò la mano sul braccio mettendo il piede nella lancia, sentì i muscoli sodi sotto la manica di tela bianca e osservò come il sole scintillasse sui peli dorati della sua mano scura. Seduta sul morbido cuscino azzurroscuro sollevò gli occhi a guardare Tad, che porgeva le valigie al marinaio. Tad era ancor pallido di convalescenza, ma era anche lui un solido giovanotto ben piantato. Di botto Margo desiderò abbracciarlo. Tad timonava e la lancia filava talmente sull’acqua che alle ragazze toglieva il fiato e le riempiva di paura che gli spruzzi rovinassero i nuovi abiti sportivi che indossavano per la prima volta. «Oh che bellezza» fecero tutte e due con un sospiro quando videro l’Antoinette così grossa e candida con un casottino di mogano e un largo fumaiolo giallo. «Oh, non sapevo che era un panfilo a vapore» piagnucolò Queenie. «Ma ragazzi, così potreste traversare anche l’oceano.» «È un Diesel» disse Tad. «Tutti insieme» disse Margo. Tad filava talmente che cozzarono dritto nella scaletta di mogano che stava pronta per farli salire e per un attimo questa scricchiolò e cigolò come stesse per staccarsi, ma i marinai in qualche modo ce la fecero a tenerla. «Forza, Newt» gridò il giovane Rogers, scoppiando a ridere. «Maledetto» fece Tad e pareva ben seccato mentre salivano a bordo. Le ragazze furon beate di trovarsi sullo splendido panfilo e fuori dalla lancia ballonzolante dove tremavano di vedersi spruzzati gli abiti. Il panfilo aveva un simpatico equipaggio in uniformi bianche e un tavolino era già pronto per far colazione sotto una tenda in coperta. Un dispensiere delle Filippine era là dritto con un vassoio di cocktail e ogni sorta di panini imbottiti, tagliati a figure bizzarre. Si disposero in fretta per quello spuntino, perché i giovanotti dissero che morivano di fame. Mangiarono aragosta di Florida abbrustolita in una salsa color rosa e pollo freddo e insalata e bevettero champagne. Margo non era mai stata più felice in vita sua. Mentre mangiavano, il panfilo cominciò a muoversi lento giù per il fiume, allontanandosi dagli scali decrepiti e dai vecchi vapori sudici verso le vaste distese del fiume scuro, chiazzato dalle verdi macchie
fluttuanti dei giacinti d’acqua. Un bizzarro odore acquitrinoso veniva sul vento dall’intrico degli alberi che nascondevano le rive. A un certo punto videro una dozzina di grandi uccelli candidi dai lunghi colli involarsi nel cielo; Tad disse che erano aironi. «Chi sa quanto costano» disse Queenie. «Sono protetti dal governo federale» disse il giovane Rogers. Sorseggiarono bicchierini di brandy insieme al caffè. Quando finalmente si alzarono da tavola erano tutti discretamente allegri. Margo aveva deciso che Tad era il più simpatico giovane che avesse mai conosciuto e che non gli avrebbe più fatto resistenza, accadesse quel che voleva. Dopo lo spuntino Tad fece loro visitare tutto il panfilo. Il salone da pranzo era meraviglioso, tutto specchi incorniciati in bianco e oro, e le cabine erano cose graziosissime. La cabina delle ragazze aveva tutta l’aria di un salotto all’antica. I loro abiti eran già stati tutti appesi nell’armadio, mentre mangiavano. Durante la visita al panfilo, il giovane Rogers e Queenie scomparvero da qualche parte, e d’un tratto Margo s’accorse che lei e Tad eran soli in una cabina a guardare la fotografia di un battello a vela col quale il padre di Tad aveva vinto la regata delle Bermude. Guardando il quadro Margo sentì contro la sua la guancia di Tad ed ecco che si baciavano. «Perdiana, come sei in gamba, tu» disse Tad. «Io sono goffo in queste cose… non ho esperienza, vedi.» Margo si strinse a lui. «Chi sa quanta ne hai, scommetto.» Con la mano libera Tad tirava il chiavistello. «Farai come diceva l’anello, Tad?» Quando poi risalirono sul ponte, Tad si comportava in modo bizzarro; non voleva saperne di incontrare i suoi occhi e non smetteva di parlare col giovane Rogers. Queenie era tutta avvampata e scompigliata come uscisse allora da una macchina per torcere il bucato e camminava barcollando. Margo la fece riordinarsi e aggiustarsi i capelli. Come rimpiangeva di aver preso Queenie con sé! Lei, Margo, era fresca come una rosa, pensò quando si fu guardata nel grande specchio del salone disopra.
Il panfilo era fermo. Tad fece una faccia da temporale quando ritornò da un colloquio col capitano. «Ci tocca ritornare a Jacksonville, è bruciato il supporto di una pompa d’olio» disse. «Non mi mancava che questa.» «Splendido» disse il giovane Rogers. «Daremo una occhiata alla vita notturna di quaggiù.» «Quel che vorrei sapere» disse Queenie «è dove si trova quella governante che dicevate.» «Perdiana,» fece Tad «ci siamo dimenticati della signora Vinton… Scommetto che è tutto il giorno che ci aspetta allo scalo.» Era buio quando giunsero a Jacksonville. Avevano dovuto rifare le valigie e s’erano mutate d’abito. Mentre si rivestivano, Queenie aveva detto delle stupidaggini. «Ascoltami bene, Margo, quel ragazzo vuole sposarti.» «Non parliamone» disse Margo parecchie volte. «Tu lo tratti come uno straccio.» Margo si colse a dire piagnucolosa e cattiva: «Sono affari tuoi?». Queenie avvampò e attese alle sue valigie. Si vedeva bene che era offesa. Cenarono di cattivo umore all’albergo. Dopo cena il giovane Rogers li fece venire con sé in uno spaccio clandestino da lui scoperto. Margo non voleva andare e accusò un’emicrania, ma tutti dicevano non fare la guastafeste e allora si decise. Era un locale equivoco con la tela cerata sui tavoli e la segatura in terra. C’eran certi stranieri, portoghesi o cubani o che altro, appoggiati al banco in un’altra stanza. Queenie disse che quello non era certo il locale dove poteva entrare la figlia di mamma. «E chi diavolo volete che ci veda?» disse Tad ancora torvo. «Non vogliamo vedere la vita?» chiese Rogers, nel tentativo di tirarli un po’ su, tutti. Margo aveva perso il filo di quanto dicevano. Fissava gli occhi sbarrati attraverso la porta nell’altra stanza. Uno degli stranieri dritti al banco era Tony. Pareva invecchiato e aveva una faccia piuttosto rigonfia, ma non c’era dubbio: era Tony. In uno stato pietoso. Portava un abito bianco spiegazzato, liso al risvolto dei calzoni e dimenava le anche, mentre discorreva, come una donna. Prima cosa che Margo pensò fu come diavolo lei aveva potuto trovare attraente quel fantoccio. Con la coda dell’occhio vedeva la faccia tetra di Tad, i bei
capelli chiari in disordine e l’elegante modo studentesco di portare il vestito. Doveva far presto. Stava appunto per aprir bocca e annunciare che davvero doveva tornare all’albergo quando intravvide i grandi occhi neri di Tony e le sue ciglia scure. Eccolo che veniva al loro tavolo col suo passo affettato, tendendo le due mani. «Querida mía… che fai qui?» Lo presentò come Antonio de Garrido, suo cavaliere in un numero di danze cubane nell’organizzazione Keith, ma lui tagliò subito la testa al toro chiamandola moglie mia. Margo sentì il sussulto ch’ebbe Tad a udir questo. Poi d’un tratto Tad cominciò a dedicare tutta la sua attenzione a Tony e ordinargli bicchierini. Lui e Rogers si misero a bisbigliare e ridere insieme di qualcosa. Poi ecco che Tad invitava Tony a venir con loro in crociera. Margo vedeva che Tad faceva l’ubriaco più che non fosse in realtà. Se l’aspettava, quando i due si levarono per andarsene. Tad era rosso in faccia come un pomodoro. «Bisogna che passiamo dal capitano per quel guasto alle macchine» disse. «Forse il señor de Garrido vorrà ricondurvi all’albergo… Via, via, non fate una cosa ch’io non farei.» «Ci vediamo domattina, bimbe» echeggiò il giovane Rogers. Dopo che se ne furono andati, Margo si alzò in piedi. «Be’, che serve ora aspettare in questo buco… Ci hai proprio servite a dovere, Tony.» Tony aveva le lacrime agli occhi. «Tutto mi va così male» disse. «Credevo che forse la mia piccola Margo avrebbe ricordato… lo sai, ci volevamo tanto bene. Don Manfredo… ricordi, il mio protettore, Margo?… ha dovuto partire dall’Avana improvvisamente. Speravo mi conducesse a Parigi, invece mi ha portato a Miami. Ora non siamo più amici. Abbiamo avuto sfortuna alla roulette… Non gli restano più che i quattrini per sé.» «E perché non ti cerchi un lavoro?» «Con quest’abito… Ho vergogna a farmi vedere… forse i tuoi amici…» «Quelli li lasci stare, capito?» sbottò Margo. Queenie piagnucolava: «Avresti dovuto prendere i biglietti di ritorno per New York. Un’altra volta ricordatene. Mai lasciare il fornello di casa senza il biglietto di ritorno».
Tony le ricondusse all’albergo in tassì e volle assolutamente pagare. Fece una grande scena, alla buona notte. «Piccola Margo se non mi rivedrai più, ricordati che ti ho amata… mi ucciderò.» Mentre salivano coll’ascensore, lo poterono vedere sempre dritto sul marciapiede dove l’avevano lasciato. L’indomani mattina le svegliò un inserviente che portava una busta su un vassoio d’argento. Era una lettera per Margo da parte di Tad. La calligrafia era uno scarabocchio orribile. Tutto quel che diceva era che la gita cessava perché l’istitutore era arrivato e loro avrebbero dovuto andare a prendere papà a Palm Beach. Acclusi vi eran cinque biglietti da venti. «Oh belli, belli» esclamò Queenie sedendosi nel letto, quando li vide. «Sarebbe stato lungo fino a casa a piedi… Davvero quel ragazzo è un principe.» «Un villanzone è» disse Margo. «Cinquanta a testa facciamo… Fortuna che ho un contratto già fissato a Miami.» Fu per lei un sollievo, quando Queenie disse che sarebbe tornata col primo treno nella cara vecchia New York. Di quelle facce Margo non aveva più voglia di vederne nessuna. Non avevano finito di chiuder le valigie, quando eccoti Tony alla porta. Aveva un’aria ben malandata. Margo era tanto nervosa che gli strillò: «Chi diavolo ti ha fatto entrare?». Tony si abbandonò su una sedia e gettò indietro il capo, occhi chiusi. Queenie finì di chiudere la valigetta, poi s’accostò e gli diede un’occhiata. «Di’, costui è mezzo morto di fame… Lascia che gli ordini un po’ di caffè, qualcosa… È stato davvero tuo marito, come diceva?» Margo annuì. «Allora, devi fare qualcosa per lui. Poveretto, sembra piuttosto giù di corda.» «Credo che hai ragione» disse Margo, fissandoli tutti e due con gli occhi secchi e scottanti. Quel giorno non partì per Miami. Tony stette male e rigettava tutto quel che inghiottiva. Venne fuori che da una settimana non aveva mangiato nulla, bevendo forte tutto il tempo. «Scommetto che questo ragazzo prende la cocaina» sussurrò Queenie all’orecchio di Margo. Piansero tutte e due quando venne l’ora che Queenie doveva partire. «Bisogna che ti ringrazi per la bellissima gita, finché è durata»
le disse. Margo mise Tony a letto, dopo che Queenie se ne fu andata al treno. Quando giù al banco protestarono, disse ch’era suo marito. Dovettero di nuovo firmarsi. Le fece un senso orribile dover scrivere nel libro signore e signora Antonio de Garrido. Una volta scritto però, non faceva più quel brutto effetto. Ci vollero tre giorni prima che Tony si reggesse in piedi. Dovette chiamargli un dottore. Il dottore gli diede bromuro e latte caldo. La camera veniva sette e cinquanta al giorno, e i pasti portati in camera, il dottore, le medicine e tutto, facevano una somma che cresceva a vista d’occhio. Cominciava a parer probabile che avrebbe dovuto impegnare l’anello regalatole da Tad. Le dava l’impressione di recitare in una commedia, trovarsi a vivere di nuovo con Tony. Una certa tenerezza per lui dopo tutto la provava, ma certo ciò non era quel che aveva progettato. Quando cominciò a sentirsi meglio, Tony prese a parlare fiduciosamente del numero meraviglioso che avrebbero messo insieme loro due. Chi sa se non lo avrebbero potuto presentare nel locale dove lei s’era scritturata a Miami. Tutto sommato Tony era un docile e bravo ragazzo. Il brutto era che, ogni volta che lei usciva a farsi arricciare i capelli o che altro, trovava sempre al ritorno uno degli inservienti, un giovanotto testa nera, aria unta, sorta di meridionale anche lui, insieme con Tony nella camera. Quando chiedeva a Tony che cosa ciò volesse dire, lui rideva e rispondeva: «Niente. Parliamo insieme spagnolo. Ecco tutto. È stato molto gentile». «Sì, assai» diceva Margo. Ne aveva talmente fino alla gola di tutto, che non le importava più un fico, comunque fosse. Un mattino, quando si svegliò, Tony se n’era andato. Se n’erano andati pure il rotolo di biglietti dal suo portamonete e tutti i suoi gioielli, eccetto il diamante solitario che portava nel dito. Quando telefonò sotto per chiedere se aveva pagato il conto, risposero che aveva lasciato detto che la svegliassero a mezzogiorno e nulla più. Nessuno l’aveva visto uscire. Se n’era pure andato l’inserviente meridionale. Tutto ciò che restava a Margo era il soprabito di pelliccia e quindici cents. Non chiese il conto, ma sapeva che doveva aggirarsi sui
cinquanta o sessanta dollari. Si vestì meditabonda con gran cura e decise di andare in qualche posto a prendere un caffè. Non aveva denaro per altra colazione. Fuori era una tiepida giornata di primavera. Il sole scintillava sulle file di automobili ai posteggi. Le vie e i negozi e le edicole avevano un aspetto fresco, soleggiato, arioso. Margo passeggiò su e giù per l’arteria principale di Jacksonville con un orribile senso di vuoto alla bocca dello stomaco. Guardò nelle vetrine dei rigattieri, nelle vetrine dei piccoli gioiellieri e nelle botteghe di pegni e lesse e rilesse accuratamente tutte le imminenti attrazioni elencate davanti ai cinematografi. Si trovò di fronte a una stazione di autobus. Lesse le tariffe e l’orario degli autobus in partenza per Miami, New Orleans, Tallahassee, Orlando, Tampa, Atlanta di Georgia, Houston di Texas e Los Angeles di California. Nella stazione c’era un banco di caffè. Vi entrò per spendervi i suoi quindici cents. Avrebbe impegnato a miglior prezzo l’anello, se non ci si metteva a stomaco vuoto, pensava sedendosi al banco e ordinando una tazza di caffè e un panino. 1. Il pepe della cosa sta nel doppio significato di fairy, in inglese: “fata” (o mago, creatura soprannaturale insomma) e “uomo effeminato, donzello”. (NdT) 2. Da noi si chiama così lo strip poker: il p. spogliante, che consiste nel levarsi un capo di vestiario ad ogni mano perduta. (NdT)
Cine-giornale LVIII Dolce terra che ci afferra con le mille seduzion Valencia! A sentir come profumano i tuoi fiori in riva al mar che caratterizza in sé il grande dramma della Miami moderna. A quel tempo – vent’anni fa – quando il sito della Bay of Biscayne Bank era un’aia dove un contadino attaccava i cavalli e quello della First National Bank un pubblico arrostitoio, il terreno dove sorgono quest’albergo e questo circolo ultramoderni era foresta vergine isolata. Mio padre ed io vi sboscavamo intorno piccoli appezzamenti da coltivare a ortaglia e io vendevo la verdura al Royal Palm Hotel, a quel tempo un magnifico albergo di frontiera. Otto anni fa coltivavo ancora pomodori Valencia! ALLA RICERCA DEL BOTTINO SCOMPARSO UNA DONNA DIRIGE UNA RAPINA IN PIENA STRADA Fiume pigro che scendi nel Sud dove vorrei andare SPAZZOLINI IN BOCCA ALLE VITTIME DEL RADIO questa penisola è sempre stata un posto incantevole benché ci siano stati mesi che la Florida occidentale veniva rappresentata come la sola bella RAGAZZE EVANGELISTE CHE ATTENDONO CRISTO A NEW YORK quando cingue cinguettando saltellando giungerà Vogliamo che Usiate il Nostro Sistema di Credito nel Vostro Stesso Interesse. Un Piccolo Acconto Soltanto e il Soldato a Piccole Rate Secondo il Comodo Vostro Più nessuno piangerà cingue cinguettando attaccherà
CHIEDE CHE LO SCIOPERO SIA DICHIARATO UN REATO Quando cingue cinguettando attaccherà la cara canzone quando il petti petti rosso mattiniero e vivace non mostrava segno alcuno di fatica o le solite tracce di un così lungo viaggio finito appena. Non c’era una piega sul suo elegante completo di seta, di cui trama, tessuto e colore erano tanto intonati a una giornata estiva sui tropici. La cravatta con la spilla ingioiellata e l’anello al dito eran particolari in perfetto accordo con l’immacolato abbigliamento. Benché basso di statura e modesto di modi, alienò un valore di 20.000.000 di dollari di lavori edilizi con altrettanto poco scalpore quanto ne accompagna solitamente l’atto di un passeggero che sul tram porge un nichel al bigliettaio.
I campeggiatori di Kitty Hawk Il diciassette dicembre millenovecento e tre, il vescovo Wright dei Fratelli Uniti, un tempo redattore del «Religious Telescope», ricevette nella sua casetta di legno di Hawthorn Street a Dayton, Ohio, un telegramma dei suoi ragazzi Wilbur e Orville che si erano cacciati in capo di passare le vacanze in un piccolo campeggio fra le dune sulla spiaggia del North Carolina pasticciando a un modesto apparecchio che loro stessi avevan messo insieme. Il telegramma diceva: SUCCESSO QUATTRO VOLI GIOVEDÌ MATTINA TUTTI CONTRO VENTO DI VENTUN MIGLIA PARTITO DAL PIANO SOLO MOTORE VELOCITÀ MEDIA TRENTUN MIGLIA IL PIÙ LUNGO CINQUANTASETTE SECONDI INFORMA STAMPA TORNIAMO NATALE Le cifre non erano esatte perché il telegrafista non lesse giusto il frettoloso scarabocchio a matita di Orville ma il fatto resta che un paio di giovani meccanici di Dayton, Ohio, avevano disegnato costruito e guidato per la prima volta al mondo un aeroplano pratico. Aperto il motore per qualche minuto per scaldarlo, mollai il cavo che tratteneva la macchina alla rotaia e la macchina balzò innanzi nel vento. Wilbur corse accanto alla macchina reggendo l’ala per bilanciarla sulla rotaia. Invece di partire al 14° secondo come aveva fatto in calma la macchina fronteggiando un vento di 27 miglia avanzò molto adagio… Wilbur riuscì a starle accanto finché non si sollevò dalla rotaia dopo una corsa di quaranta piedi. Uno degli aiutanti fece scattare l’obiettivo prendendoci una fotografia proprio quando giungevamo in fondo alla rotaia e la macchina s’era sollevata a un’altezza di circa due piedi… La direzione del volo in su e in giù fu estremamente erratica, in parte per le irregolarità del vento, in parte per la mancanza d’esperienza a manovrare questa macchina. Un improvviso scossone appena raggiunti i centoventi piedi dal luogo in cui s’era levata nell’aria terminò il volo… Questo volo durò soltanto 12 secondi ma nondimeno fu il primo nella storia di tutto il mondo in cui una macchina contenente un uomo si sia sollevata a pieno volo nell’aria con i suoi soli
mezzi, abbia volato innanzi a sé senza riduzione di velocità e atterrato finalmente a un punto altrettanto elevato di quello da cui era partita. Qualche ora più tardi la macchina presa in un vortice di vento si rovesciò e fracassò, quasi ammazzando il guardacostiere che cercava di trattenerla; fu un brutto caso ma i fratelli Wright erano troppo felici per badarci avevan dimostrato che quel dannato apparecchio volava. Quando questi punti furono definitivamente stabiliti facemmo subito i bagagli e ritornammo a casa con la certezza che l’età del volo era finalmente venuta. Furono a casa per Natale a Dayton, Ohio, dove eran nati intorno al Settanta da una famiglia che s’era stabilita di là dagli Allegani fin dall’ottocento e quattordici; a Dayton, Ohio, dove avevano frequentato le elementari e le medie e praticata la chiesa del loro padre e giocato a baseball e a hockey e meditato sulle parallele e sull’altalena e venduto giornali e costruito da soli un torchio da stampa con cianfrusaglie tolte dai rifiuti, e gettato aquiloni e pasticciato ordigni e girato in città da bravi giovani occupati in lavori occasionali a guadagnarsi onestamente quattro soldi. I parenti pretendevano che fosse stata la trovata del vescovo quando portò a casa un elicottero, un giocattolo meccanico da mezzo dollaro fatto di due ali azionate da un elastico e che avrebbe dovuto librarsi nell’aria, a risvegliare nei due più giovani questa mania del volo cosicché non s’eran mossi invece di sposarsi come facevano gli altri, e bighellonavano tutto il giorno per la casa, guadagnandosi la vita con lavorucci di tipografia, e riparazioni di biciclette, vegliando la notte a legger libri d’aerodinamica. Pure erano fedeli sinceri, quel negozio delle biciclette prosperava, e si poteva contare sulla loro parola. Godevano una certa popolarità a Dayton. In quei giorni le macchine volanti erano la gran risata di tutti i filosofi da strapazzo. Gli esperimenti sfortunati di Langley e Chanute
eran stati canzonati con un ve-l’avevo-detto che echeggiò da costa a costa. Il grande problema dei Wright era di trovare un posto abbastanza appartato per eseguire i loro esperimenti senza diventare la favola della regione. E poi non avevano denaro da spendere; erano meccanici manuali; quando occorreva qualche pezzo se lo costruivano da sé. Capitarono a Kitty Hawk, sulle grandi dune e rive sabbiose che si distendono a sud verso Hatteras, di là dallo stretto di Albemarle, una vasta distesa di spiagge, deserta tranne la caserma guardacoste, poche baracche di pescatori e gli sciami delle zanzare e le zecche e le larve vescicanti nell’erbaccia dietro le dune e sul capo i gabbiani e le rondini marine calanti, nella sera le ossifraghe e le gru svolazzanti traverso le marcite, qualche volta un’aquila che i fratelli Wright seguivano in alto con lo sguardo come Leonardo le aveva osservate secoli prima sforzando gli occhi acuti ad afferrare le leggi del volo. A quattro miglia dalle baracche sparse nella sabbia molle, i fratelli Wright si drizzarono un campeggio e una tettoia per i loro apparecchi. Era lontana per portarci le provviste, gli utensili, ogni cosa che potesse occorrere; d’estate faceva più caldo d’un forno, le zanzare erano un inferno: ma là eran soli e avevano calcolato che nulla si poteva trovare di più morbido per caderci che la sabbia molle. Là con un apparecchio senza motore fatto di due tavole e una fusoliera in cui giacevano distesi sul ventre e comandavano la guida delle ali ancheggiando come ballerini, buttandosi giù senza posa infinite volte da una grossa duna chiamata il Kill Devil Hill, impararono a volare. Una volta che giunsero a librarsi per qualche secondo e avanzare anche di poco su una corrente montante
decisero ch’era venuto il momento di adattare un motore al loro biplano. Ritornati nel laboratorio di Dayton, Ohio, costruirono un tunnel aerodinamico che fu il loro primo grande contributo alla scienza del volo, e vi sperimentarono modelli. Non riuscirono a interessare nessun costruttore di macchine a benzina e così dovettero costruirsi i motori da sé. La cosa andava; dopo quel Natale del novecento e tre i fratelli Wright non fecero più per scherzo; tralasciarono le biciclette, ottennero per i voli di prova l’uso di un vecchio pascolo spazioso proprietà del banchiere locale e passarono tutto il tempo che non lavoravano alla macchina, in organizzare, farsi cattivo sangue per i brevetti, per le violazioni, per le spie, in tentativi d’interessare funzionari del governo, di cavare un senso dalle blande, involute disperanti insinuazioni degli avvocati. In due anni ebbero un apparecchio che percorreva ventiquattro miglia continue girando intorno al pascolo. La gente nel tranvai interurbano soleva sporgere il collo dai finestrini quando passava lungo il margine del campo, allarmata dallo strepitoso pop-pop del vecchio motore Wright e dallo spettacolo del bianco biplano che come un paio di assi da stiro posti l’uno sull’altro balzellava e avanzava a una cinquantina di piedi d’altezza. Le mucche ben presto ci si abituarono. Come i voli s’allungavano i fratelli Wright trovarono sostenitori, si cacciarono in processi, giacquero in letto nottetempo insonni al gemito dei fantastici milioni, peggiore delle zanzare di Kitty Hawk. Nel novecento e sette andarono a Parigi, si lasciarono infagottare negli abiti da sera e nei cilindri, impararono a dar la mancia ai camerieri parlarono con esperti del governo, si abituarono ai cordoni dorati e ai rinvii e alle barbette alla Van Dyke e alle palme distese dei politicanti. Per divertirsi giocavano al diabolo nei giardini delle Tuileries.
Fecero voli con gran coro di pubblicità a Fort Myers, dove ebbero il loro primo fatale disastro, a Pietroburgo, a Parigi, a Berlino; a Pau fecero un tale furore, un tale richiamo che l’albergatore non volle nulla per la loro camera. Alfonso di Spagna toccò loro la mano e si fece fotografare seduto nella macchina, re Edoardo assisté a un volo, il principe ereditario insisté per essere lasciato salire, la pioggia delle medaglie cominciò. Si congratularono con loro lo zar e il re d’Italia e i dilettanti di sport, e gli arrivisti di mondo e i titolati pontifici, e li decorò una società per la pace universale. L’aeronautica divenne lo sport del giorno. I Wright non sembra che fossero molto colpiti dai panneggiamenti e dai cordoni e dalle medaglie d’oro e dalle parate dei cavalli da mostra, restarono meccanici pratici e vollero sempre far tutto con le loro mani, persino riempire il serbatoio della benzina. Nel novecentoundici furono di ritorno sulle dune a Kitty Hawk con un nuovo apparecchio senza motore; Orville si mantenne in aria per nove minuti e mezzo, che restò a lungo il primato del volo senza motore. Lo stesso anno Wilbur morì di tifo a Dayton. Nella foga dei nuovi nomi: Farman, Blériot, Curtiss, Ferber, Esnault-Pelterie, Delagrange; nello starnuto violento delle bombe e nel gemito e frastuono degli shrapnel e lo strepito improvviso delle mitragliatrici, spento il motore in alto, (e noi ci buttiamo nel fango e ci facciamo piccini rannicchiati negli angoli dei muri sfondati), i fratelli Wright scomparvero dai giornali ma nemmeno i giornali o l’imbratto amaro dell’inchiostro o il
soffoco delle cortine di fumo e di gas o la ciarla degli agenti in Borsa o la canea dei fantastici milioni o l’eloquenza degli elmetti che posavano corone sui monumenti nuovi può cancellare il ricordo di quel freddo dicembre quando due intirizziti meccanici di Dayton, Ohio, la prima volta sentirono il loro ordigno fatto a mano tagliato in rami di hickory, incollato con pasta da biciclette Arnstein, rivestito di mussolina cucita alla macchina della sorella nel loro cortile di Hawthorn Street a Dayton, Ohio, librarsi nell’aria sopra le dune e la spiaggia bianca di Kitty Hawk.
Cine-giornale LIX lo straniero che viene la prima volta a Detroit se s’interessa del dinamico lato economico della vita moderna troverà un meraviglioso alveare industriale; se è innamorato della natura noterà un luogo reso per sempre memorabile dalle acque di quel famoso stretto che dà il nome alla città; se è uno studioso del passato e di storia scoprirà leggende e memorie tra le più affascinanti e istruttive dell’intero continente Desidero tornare anch’io laggiù nella mia Omaha e non lasciarla più DETROIT È ALLA TESTA DEL MONDO NELLA FABBRICAZIONE DELLE AUTOMOBILI Vo’ riveder il babbo vo’ riveder la mamma vo’ rivedere la mia vecchia Omaha DETROIT È LA PRIMA NEI PRODOTTI FARMACEUTICI STUFE CUCINE ECONOMICHE CALORIFERI MACCHINE CALCOLATRICI COLORI E VERNICI MOTORI NAVALI TUTE PRODOTTI DI SODIO CALZATURE DA SPORT SUCCHIELLI BACHECHE BUSTI LANTERNE A BENZINA FURGONI Radio ti prego di dirglielo tu perch’io son solo fagli sapere che torni quaggiù dal suo figliolo DETROIT LA DINAMICA SI SCHIERA TRA LE PRIME
NEI PRODOTTI DI FONDERIA E DI LABORATORIO NELL’OTTONE E PRODOTTI D’OTTONE NEL TABACCO E SIGARI NEGLI UTENSILI D’ALLUMINIO NEL FERRO E NELL’ACCIAIO NEGLI APPARECCHI DI LUBRIFICAZIONE NEL FERRO MALLEABILE NEI LETTI DI FERRO Ma ritorno alla terra dove un dì son nato il più bello dei luoghi che il Signore ha creato California! il mio posto è laggiù «DETROIT È LA CITTÀ DOVE VALE LA PENA DI VIVERE»
Charley Anderson Prima cosa che Charley udì scalando dai montatoi fu la voce di Farrell che urlava: «Charles Anderson, il giovane che sa il fatto suo. Ben arrivato nella cara vecchia Detroit» e poi scorse la faccia tonda di Farrell che attraversava l’erba verde del campo, e la sua grande bocca spalancata. «Avete ballato?» «Un freddo boia» disse Charley. «E questo qui sarebbe un campo?» «Per questo stiamo rompendo le scatole alla Camera di Commercio. Magari voi stesso potrete farle un’intemerata.» «Accidenti che pantano. Giuda, son partito così in fretta che non ho con me nemmeno uno spazzolino.» Charley si sfilò i guanti, che sgocciolavano d’olio per via di una falla che gli aveva dato da fare nella combattuta trasvolata delle alture. Gli doleva la schiena. Era un bel sollievo che fosse là Bill Cermak a portare l’apparecchio nel capannone. «Bene allora, andiamo» disse. «Evviva» muggì Farrell e calò la mano sulla spalla di Charley. «Passeremo da casa a vedere se vi sta bene qualche mio abito.» In quel momento un tassì sbucò verso il campo e ne discese Taki, che venne alla loro volta correndo, con la valigia di Charley. Giunse all’auto, trafelato. «Avete fatto buon viaggio, signore?» «Perbacco» disse Charley. «Mi hai trovato il posticino?» «Graziosissimo appartamento, modica spesa, con ascensore, di fronte al Museum of MunicipalArt» ansimò Taki con la sua voce guaiolante. «Questo si chiama servizio» disse Farrell; e mise il piede sullo starter della sua Lincoln da città, color biacca. Il motore ronzò come seta frusciante. Taki issò la valigia dietro e Charley saltò dentro accanto a Farrell. «Taki crede che manchiamo di cultura» disse Charley ridendo. Farrell strizzò l’occhio. Era piacevole abbandonarsi seduto nell’angolo, accanto alla persona ben vestita di Farrell, dietro il grosso motore dolceronzante, lasciandosi invadere da una sonnolenza leggera, mentre correvano per larghi viali diritti, costeggiati qua e là da un’impalcatura di
costruzioni, che gettava loro passando un sentore di mattoni freschi e tavole d’abete grezze e cemento recente. Una buffata di primavera precoce veniva dai campi e dai lotti di terreno, su un vento crudo che serbava in sé come strisce di un tepore di palude. «Ecco la nostra baracca» disse Farrell, e svoltò su una pista ricurva in salita e pigiò i freni, una volta in fondo a una lunga casa di pietra grigia con strette finestre a punta e torrette gotiche come una cattedrale. Scesero a terra e Charley lo seguì attraverso una terrazza, infilando un vialetto di bossi in vasi, e attraverso la porta di un balcone entrarono in una sala da biliardo dal soffitto pesantemente scolpito. «Qui è la stanza dei miei giochi» disse Farrell. «Dopo tutto un uomo bisogna bene che abbia dove giocare… Ecco una stanza da bagno per cambiarvi. Torno a cercarvi fra dieci minuti.» Era un’ampia stanza da bagno, tutta in verdegiada con un divano, una poltrona, una lampada sul pavimento, e una partita di manubri e di clavette nell’angolo. Charley si spogliò, prese una doccia calda e si mutò d’abito. Stava giusto annodandosi la sua più vistosa cravatta a strisce, quando Farrell gridò attraverso la porta. «Tutto bene?» «Perbacco» rispose Charley uscendo fuori. «Sto come un milione di dollari.» Farrell lo guardò negli occhi in un modo bizzarro e rise. «Perché no?» disse. L’ufficio era in un palazzo d’uffici non ancora finito in mezzo a una covata d’altri palazzi d’uffici non finiti intorno al Grand Circus Park. «Vi dispiace se prima cosa vi faccio passare dal reparto Pubblicità, Charley?» disse Farrell. «Eddy Sawyer è un gran giovane. Poi ci riuniremo tutti nel mio ufficio e mangeremo un boccone.» «Perbacco» disse Charley. «Di’, Eddy, eccolo qui l’uomo volante» urlo Farrell spingendo Charley in un grande ufficio luminoso dai tendaggi arancione. «Signor Sawyer, ecco il signor Anderson… Il Charley Anderson, nostro nuovo ingegnere consulente… Dateci una scampanellata quando avrete finito.» Farrell se ne andò in fretta, lasciando Charley solo con un ometto dal viso giallo e una gran testa stopposa, il quale aveva i modi e la parlata di uno studentello di scuola media dedito al fumo. Eddy
Sawyer diede alla mano di Charley una stretta tremenda, gli chiese se gli piacevano i nuovi uffici, spiegò che l’arancione significava ottimismo, gli chiese se non pativa il mal di volo, spiegò che lui sì lo pativa assai: non era un fottuto destino, considerato il mestiere che faceva? Tirò fuori da sotto la scrivania una bottiglia di whisky. «Scommette che J.Y. non vi ha dato da bere… Quell’uomo vive d’aria, è una vera salamandra.» Charley disse che un sorsetto lo prendeva e Eddy Sawyer tirò fuori due bicchieri con già dentro il ghiaccio, e un sifone. «Dite basta.» Charley bevve un sorso; Eddy si piegò indietro sulla sedia a perno, avendo scolato tutto il suo bicchiere, e disse: «Ora, signor Anderson, se non vi dispiace, fuori la vostra biografia, o quelle parti della vostra biografia che stiano bene stampate… Capite, lì per lì non ne facciamo nulla, ma ci piace averla in mano in modo da poterla servire al pubblico via via che l’occasione lo richieda.» Charley arrossì. «Ma» disse «non c’è mica molto da raccontare.» «Così va bene» disse Eddy Sawyer, mescendo altri due bicchierini e mettendo via la bottiglia. «È così che cominciano le storie migliori.» Premé un bottone, e una stenografa, capelli ricciuti, visetto rosa da bambola, entrò e sedette col taccuino all’altra estremità della scrivania. Mentre andava cercando a tastoni la sua storia, Charley non smetteva di ripetersi in fondo al cranio: “Sta’ attento, non farti prendere per stupido, fino dal primo giorno”. Prima che avessero finito, Farrell fece capolino dalla porta e disse di sbrigarsi, tutti aspettavano. «Dunque, vi siete messi d’accordo?… Charley, voglio presentarvi il nostro direttore alle vendite… Joe Stone, Charley Anderson. E il signor Frank e il signor O’Brien, la nostra batteria d’ingegno legale, e il signor Bledsoe, ha l’incarico della produzione… è il vostro reparto.» Charley strinse una quantità di mani; c’era una testa nera lucida, coi capelli scriminati nel mezzo, un paio di teste pelate e una testa grigiacciaio dai capelli irti come una spazzola, occhiali a pinzetta, occhiali di tartaruga, un paio di baffetti. «Sissignore» borbottava nervoso Eddy Sawyer. «Ne so tanto sul suo conto da bastare a qualunque ricatto, se sarà necessario.» «Quello starter è una gran cosa, giovanotto» diceva Cyrus Bledsoe,
la testa grigia, burbero. «Spero che avrete qualche altra idea di riserva in testa.» «Perbacco» disse Charley. Tutti, tranne Bledsoe che grugnì che lui non faceva mai colazione, si recarono con Charley all’Athletic Club dove li attendeva una saletta da pranzo riservata e un servizio di cocktail. Mentre salivano nell’ascensore una voce dietro a lui disse: «Come sta questo giovanotto, Charley?» e Charley fece un mezzo giro per trovarsi a faccia a faccia con Andy Merritt. L’abito grigioscuro pareva stare a Merritt anche meglio del solito. Il suo acido sorriso era insolitamente sottile. «Come, che fate qui?» balbettò Charley. «Detroit» disse Andy Merritt «è una cittadina che mi ha sempre interessato assai.» «E dite un po’, come se la passa Joe?» Andy Merritt prese un’aria afflitta e Charley capì che avrebbe dovuto tenere il becco chiuso. «Di salute stava benissimo, l’ultima volta che l’ho veduto» rispose Andy. Si chiarì poi che anche Andy faceva colazione con loro. Mentre eran tutti occupati al filet mignon, Farrell si alzò e fece un discorso come qualmente quella colazione era l’inizio di un nuovo spirito nel ramo dell’industria dei motori e accessori aeronautici e ch’era venuto il momento che l’aeroplano doveva staccarsi dalla tutela dell’industria automobilistica poiché gli aeroplani avrebbero fatto di tutti costoro, in quattro e quattr’otto, altrettanti costruttori di biciclette. Un’industria milionaria bisognava praticarla in un modo milionario. Qui tutti gridarono e applaudirono e Farrell levò la mano e descrisse la carriera di Charley Anderson, asso di guerra e inventore, e disse che era un grande giorno quello, un giorno da lui atteso per tanto tempo, in cui poteva dargli il benvenuto nel gruppo Tern. Qui Eddy Sawyer gridò un evviva per Anderson, e Charley dovette alzarsi e dire come si sentiva lieto di trovarsi con loro ed essere ritornato nei grandi spazi aperti e nel vero centro industriale di questo paese, e quando si dice il centro industriale di questo paese, perdio s’intende il centro industriale di tutto il mondo. Eddy Sawyer gridò un altro evviva e tutti si riassettarono a mangiare il gelato alla pesca.
Mentre ritiravano i cappelli dal guardaroba, sotto, Andy Merritt batté Charley sulla spalla e disse: «Bel discorso… Ricordate che da qualche tempo ero convinto che bisognava dare un taglio… Non si può praticare un’industria da grandi tempi con le idee del villaggio. Quest’è il difetto di quel povero vecchio Joe, che è un ottimo… però… idee di villaggio…». Charley andò a vedere il nuovo alloggio. Taki aveva fatto preparare ogni cosa in gran forma; fiori nei vasi e tutto il resto. «Ma che bellezza» disse Charley. «Ti piace Detroit?» «Assai interessante» disse Taki. «Il signor Ford permette che si visiti Highland Park.» «Giuda, non perdi tempo tu… C’è qualcosa di simile alla produzione a catena nel tuo paese?» Taki sorrise e abbassò il capo. «Assai interessante» ripeté con maggior enfasi. Charley si levò la giacca e le scarpe e si distese sul divano nella sala per schiacciare un sonnellino, ma gli pareva di avere appena chiuso gli occhi, quand’ecco Taki sorridente e tutto inchini alla porta. «Mi dispiace, signore, il signor Benton, interurbana.» «Perbacco!» fece Charley. Taki aveva già pronte le pantofole perché vi infilasse i piedi e aveva deposto discretamente l’accappatoio su una sedia accanto al divano. Al telefono Charley osservò ch’era già il crepuscolo e i lampioni delle vie stavano accendendosi. «Salute, Nat.» «Ehilà, Charley, come ve la passate?» «Stupendo» disse Charley. «Sentite, vi ho semplicemente telefonato per farvi sapere che voi e Andy Merritt sarete eletti vicepresidenti alla prossima assemblea di azionisti della Tern.» «Come lo sapete?» Nat rise nel telefono. «Un vostro servizio segreto?» disse Charley. «Appunto, siamo tutti qui per il servizio» disse Nat. «E poi, Charley, c’è una combinazioncella lì da voi… Io stesso provo a darci un colpetto e ho pensato che vi sarebbe piaciuto entrare… Non posso spiegarvi i particolari a telefono, ma vi ho scritto quest’oggi.» «Non ho contanti.» «Potreste offrire un diecimila di azioni per far fronte. I titoli non staranno troppo tempo impegnati.» «Perbacco» disse Charley. «Colpo in centro… quest’è l’anno della fortuna.» Lo stabilimento era stupendo. Charley vi si recò l’indomani
mattina in una nuova Buick sedan comprata allora e condotta da lui stesso via dal negozio. Il venditore pareva sapere ogni cosa di lui e non voleva nemmeno una caparra. «Sarà per me un piacere aprirvi un conto, signor Anderson» disse. Il vecchio Bledsoe pareva fosse in vedetta per il suo arrivo e gli fece visitare i locali. Tutto era illuminato da lucernari. Non c’era una sola cinghia di trasmissione. Ogni macchina aveva il suo motore. «Farrell mi crede un vecchio passatista, perché non parlo continuamente di alta finanza, ma porco cane, se c’è in tutto il mondo un altro stabilimento più moderno di questo, io voglio mangiare una dinamo.» «Cristo, ma pareva che fossimo ben attrezzati a Long Island City… Ma qui passa la facezia.» «È questo esattamente lo scopo» borbottò Bledsoe. Infine Bledsoe presentò Charley al personale meccanico e poi lo fece entrare nell’ufficio, dal gabinetto di disegno che lui doveva occupare. Chiusero la porta in vetro smerigliato e sedettero guardandosi in faccia nella luce argentea del finestrone. Bledsoe tirò fuori un sigaro e ne offrì uno a Charley. «Mai fumato di questi?… Schiariscono le idee.» Charley disse che provava di tutto almeno una volta. Accesero i sigari e Bledsoe cominciò a parlare in mezzo a fiere sbuffate d’un pungente fumo azzurro. «E adesso sentitemi bene, Anderson, spero che siate venuto qui per lavorare con noi e non per fare i giochi con quelle maledette azioni… So che siete un eroe della guerra e tutto, e vi vogliono un po’ mettere in vetrina, ma è sempre possibile che nella testa abbiate qualcosa… Ve lo dico una volta e non ve lo dirò più la seconda… Se lavorate con noi, lavorate con noi, diversamente farete meglio a restare nell’ufficio del vostro agente, di dove venite.» «Ma, signor Bledsoe, questa è l’occasione che io ho tanto cercato» balbettò Charley. «Cristo, sono un meccanico, io, dopo tutto. Questo me lo ricordo.» «Bene allora, lo spero… Se siete un meccanico, e non un dannato negoziante d’azioni, saprete che il nostro motore non vale una cicca e gli apparecchi dove lo ficcano non valgono una cicca. Siamo in ritardo di dieci anni in aviazione, sul resto del mondo, e dobbiamo
raggiungerli. Una volta che avremo i disegni, abbiamo l’impianto di produzione che ci vuole per metter seduto tutto il mondo. E adesso, vi prego, tornate a casa e sbronzatevi o andate a donne o che altro fate, quando vi girano le scatole pensando a questo lurido lavoro.» «Ho messo testa a partito a questo riguardo» disse Charley. «Ne ho avuto abbastanza a New York.» Bledsoe scattò in piedi, facendosi cadere la cenere del sigaro sul panciotto d’alpaga. «E allora fareste bene a sposarvi.» «Ci ho pensato a questo… Ma non riesco a trovare l’altro nome da scrivere sulla licenza» rispose Charley, ridendo. Bledsoe sorrise. «Disegnatemi un buon motore a sedici cilindri, leggero, fidato, con raffreddamento ad aria, e io vi faccio presentare dalla mia bambina a tutte le più belle ragazze di Detroit. Lei le conosce tutte… E se sono i quattrini che cercate, quelle li sudano i quattrini.» Il telefono trillò. Bledsoe rispose, borbottò a fior di labbro, e uscì a grandi passi. A mezzodì venne Farrell a prenderlo per portarlo a colazione. «Vi ha dato la sua strigliata il bravo Bledsoe?» chiese. Charley annuì. «Bene, non fateci troppo caso. Abbaia ma non morde. Non sarebbe nell’impresa se non fosse il direttore più in gamba di tutto il paese.» Fu al ballo del Country Club, dove Farrell e sua moglie, una sottile bionda già vecchiotta, sparuta e arcigna sotto un festone di diamanti, lo portarono, che Charley conobbe la figlia del vecchio Bledsoe, Anne. Era una ragazza spalle quadre, in rosa, dalla larga bocca dolcesorridente e dalla solida stretta di mano. Senz’altro Charley s’attaccò a lei. Ballarono Just a Girl That Men Forget e lei raccontò come fosse maniaca del volo e non le mancassero che cinque ore per la patente di pilota. Charley disse che l’avrebbe portata in volo quando voleva, se non era troppo orgogliosa per salire su un Curtiss-Robin. Lei disse che era meglio non promettesse nulla, se non intendeva mantenere, perché lei faceva sempre quello che diceva. Poi gli parlò di golf e Charley non le lasciò capire che nella sua vita non aveva mai preso in mano una mazza da golf. A cena quando tornò da cercare un paio di piatti d’insalata di pollo, la trovò seduta a un tavolino rotondo sotto una lanterna giapponese con un tale pallido, che si scoprì per suo fratello Harry, e
una ragazza dai bei capelli biondo cenere e un accento dell’Alabama nella voce, che si chiamava Gladys Wheatley. Pareva fidanzata o che altro con Harry Bledsoe che aveva una fiaschetta d’argento e badava a versare gin nella macedonia e le teneva la mano e la chiamava Glad. Erano tutti più giovani di Charley, ma fecero di lui il centro dell’attenzione e non smettevano di ripetere quale tremenda città fosse Detroit. Quando Charley ebbe dentro un po’ di gin, si mise a raccontare aneddoti di guerra per la prima volta in vita sua. Ricondusse Anne in macchina e il vecchio Bledsoe uscì con una copia dell’«Engineering Journal» tra le mani e disse: «Così avete fatto conoscenza, eh?». «Oh, sì, siamo vecchi amici, papà» disse Anne. «Charley mi insegnerà a pilotare.» «Uhm» fece il vecchio Bledsoe, e chiuse l’uscio in faccia a Charley con un grugnito. «Andate a casa e occupatevi di quel motore.» Per tutta l’estate tutti credettero che Charley e Anne fossero promessi. Charley usciva dallo stabilimento per un’ora o due nei pomeriggi senza vento e innalzava un apparecchio sul campo per darle modo di accumulare ore di volo, e alla domenica giocavano a golf. Charley si alzava di buon’ora la mattina della domenica e pigliava una lezione dal maestro di golf al Sunnyside Club dove nessuno lo conosceva. Il sabato sera spesso cenava in casa Bledsoe e andava al Country Club a ballare. Gladys Wheatley e Harry di solito erano della partita e tutti i giovani li consideravano un quartetto. Il vecchio Bledsoe parve soddisfatto che si fosse messo coi ragazzi e cominciò a trattarlo come un membro della famiglia. Charley era felice, gli piaceva quel lavoro; dopo gli anni passati a New York, vivere a Detroit era come vivere a casa. Con Nat fece qualche bel colpo in Borsa. Come vicepresidente e ingegnere consulente della Tern Company guadagnava 25.000 dollari all’anno. Il vecchio Bledsoe borbottava ch’eran troppi quei quattrini, perdio, per un ingegnere giovane come lui, ma gli fece piacere che Charley ne spendesse la massima parte in un piccolo laboratorio sperimentale, dove lui e Bill Cermak costruivano per loro conto un nuovo motore. Bill Cermak aveva trasferito la famiglia da Long Island a Detroit ed era pieno di buone idee di perfezionamenti meccanici. Charley era
tanto occupato che non aveva tempo di pensare a donne o di bere nulla, se non un occasionale sorso quand’era in società. Anne gli pareva un portento e ne godeva la compagnia, ma non ci pensò mai come alla ragazza con la quale potesse un giorno o l’altro andare a letto. Per la fine settimana della festa del Lavoro 1 i Farrell invitarono a fare una crociera i giovani Bledsoe e Gladys Wheatley. Quando lo dissero anche a lui, Charley pensò che questa era la gran vita finalmente e si offrì di portare Taki per sbattere i liquori e servire da cameriere. Condusse i Bledsoe al circolo nautico con la sua Buick. Anne non si capacitava come mai Charley avesse un’aria tanto felice. «Niente da fare per tre giorni che star distesi in una vecchia barca puzzolente e sentirsi mangiare dalle zanzare» brontolava col tono scontroso di suo padre. «Ha ragione papà, quando dice che lavorare al suo lavoro non gli dispiace, ma che lo possono ammazzare se lavorerà mai per divertirsi.» «Ma guardate la compagnia a cui siamo condannati, Anne,» Charley le posò per un attimo il braccio intorno alle spalle, mentre lei gli si sedeva accanto nel sedile anteriore. Harry, che era solo in quello posteriore, lasciò andare una risatina. «Là, non c’è bisogno che fai tanto il furbo, caro» disse Anne, senza voltarsi. «Tu e Gladys vi sbaciucchiate in pubblico abbastanza da stomacare un gatto.» «Il rude aviatore capitola» disse Harry. Charley arrossì. «Perbacco» disse. Erano già al circolo nautico e due giovanotti in abito da marinaio toglievano le valigie dal fondo dell’auto. Il battello di Farrell era un panfilo veloce lungo cinquanta piedi, con una sala da pranzo in coperta e poltrone di vimini, e mogano riverniciato di fresco e ottone lustro in abbondanza. Farrell aveva un berretto di marina, e passeggiava su e giù per lo stretto ponte con un’aria preoccupata, mentre il battello puntava al largo nell’umida brezzolina afosa. Il fiume nel tardo pomeriggio aveva un odore di scali e di pantani erbosi. «Mi rimette in vita uscire sull’acqua, a voi no, Charley?… È l’unico posto dove la gente mi lascia tranquillo.» Intanto la signora Farrell andava scusandosi con le signore per l’allogamento ristretto. «Ho cercato di convincere Yardly a prendere
un battello che avesse spazio, ma mi sembra che ogni volta lui lo prenda più ristretto.» Charley tendeva l’orecchio a un lieve tintinnio che veniva dalla dispensa. Quando Taki apparve con un vassoio di Manhattan, tutti si rianimarono. Osservando Taki che ciondolava col vassoio di fronte a Gladys, Charley pensò com’era stupenda, così tutta in bianco, coi pallidi capelli abbondanti stretti in un fazzoletto bianco di seta. Sorridendogli accanto, stava Anne coi capelli bruni cacciati negli occhi dal vento della velocità. La macchina faceva tanto rumore e le doppie eliche sbattevano talmente l’acqua, che Charley poté parlarle senza che gli altri udissero. «Anne» disse improvvisamente. «Stavo pensando che sarebbe ormai tempo che mi sposassi.» «Ma Charley, un ragazzetto come voi.» Charley si sentì invadere di calore. Tutto a un tratto provò il bisogno di una donna, terribilmente. Fu difficile dominare la voce. «Ecco, immagino che abbiamo tutti e due un’età da non fare sciocchezze, ma che ne direste della proposta? Sono stato assai fortunato quest’anno, per quel che riguarda i quattrini.» Anne sorbiva il cocktail guardandolo e ridendo coi capelli cacciati sul viso. «E che cosa volete che faccia, che chieda un rapporto alla banca, sui vostri depositi?» «Ma io dico voi.» «Perbacco» rispose Anne. Farrell strillava rivolto a loro: «Non venite a fare una partitina alle carte prima di cena?… Si leva il vento qui. Si starebbe meglio in sala.» «Sì, sì, capitano» rispose Anne. Prima di cena giocarono alle carte e bevvero Manhattan e dopo cena i Farrell e i Bledsoe si misero a giocare all’asta pubblica. Gladys disse che aveva l’emicrania e Charley, dopo aver osservato un po’ il gioco, uscì sul ponte per levarsi dai polmoni il sentore del sigaro fumato allora. Il battello era ancorato in una piccola insenatura, presso una gettata illuminata che sporgeva da terra. La mezzaluna andava tramontando dietro una punta di roccia, dove un alto pino si slanciava da un groviglio fosco di rami al disopra di una folla di tremolanti
betulle bianche. All’estremità della gettata c’era un circolo di qualche sorta, che versava increspamenti di luce dai finestroni; una musica da ballo palpitava perdendosi lontano sull’acqua. Charley sedette a prua. I giovanotti, che manovravano il battello, s’erano ritirati. Ne udiva le voci sommesse e coglieva un odore di sigaretta dal minuscolo boccaporto dinanzi al casotto del timone. Si piegò innanzi a guardare le ondicelle grigie che sciaguattavano contro la prua. “Ragazzo, queste sono le grandi occasioni” andava ripetendosi. Quando si volse, ecco Gladys al suo fianco. «Credevo foste a letto, signorina» le disse. «Credevate di esservi liberato di me, per una notte?» Non sorrideva, Gladys. «Non è una bella notte, Glad?» Le prese la mano; tremava ed era diaccia. «Non dovete prender freddo, Glad» disse. Lei gli piantò le lunghe unghie nella mano. «Sposate Anne, allora?» «Può darsi… Perché? Voi sposereste Harry, no?» «Nessuna cosa al mondo potrebbe indurmi a sposarlo.» Charley la cinse con le braccia. «Povera piccola, avete freddo. Dovreste essere a letto.» Gladys gli abbandonò il capo sul petto e cominciò a singhiozzare. Charley si sentì il tepore delle lacrime attraverso la camicia. Non sapeva che dire. Restava là, abbracciato, con l’odore di quei capelli vertiginoso, come era l’odore dei capelli di Doris, nelle narici. «Vorrei fossimo fuori di questa barca maledetta» sussurrò Charley. Il viso di lei era alzato al suo, assai rotondo e bianco. Quando Charley le baciò le labbra, anche lei lo baciò. Se la strinse forte al corpo. Ora, erano i piccoli seni che Charley si sentiva contro il petto. Per un attimo solo Gladys si lasciò ancora baciare, poi lo respinse. «Charley, non dobbiamo far questo; mi son sentita a un tratto così sola.» La voce gli suonò brusca nella gola. «Non ti lascerò mai più così sola… Mai più, davvero… mai più…» «Oh, caro Charley.» Gladys tornò a baciarlo svelta, deliberatamente, e poi fuggì via per il ponte. Charley camminò avanti e indietro solo. Non sapeva che fare. Era
pazzo per Gladys, ora. Non poteva rientrare e mettersi a discorrere con gli altri. Non poteva mettersi a letto. Sgusciò giù per il boccaporto prodiero e attraversò la cucina, dove Taki, tranquillo come un papa, sedeva nell’abito bianco leggendo chi sa che librone; entrò nella cabina dov’era la sua cuccetta, si mise in costume da bagno, corse in coperta e si tuffò da bordo. L’acqua non era fredda come si era aspettato. Girò un poco nuotando nella luce lunare. Issandosi su per la scaletta di poppa si sentì freddo e la pelle d’oca. Farrell con un sigaro tra i denti si sporse, gli afferrò la mano e lo tirò in coperta. «Ah, ah, l’uomo di ferro» esclamò. «Le ragazze ci han suonato due partite e sono andate a letto con le vincite. Che ne direste di infilarvi l’accappatoio e concedervi un bicchiere e una mezz’ora di cane rosso o qualche altro gioco più stupido, prima di andare a letto?» «Perbacco» disse Charley, che stava saltellando su e giù per il ponte per scrollarsi l’acqua di dosso. Mentre, sotto, andava strofinandosi con un asciugamano, Charley sentiva le ragazze cicalare e scoppiare a ridere nella loro cabina di lusso. Era talmente imbarazzato, quando sedette vicino a Harry un po’ brillo, e talmente istupidito, che bevette un mezzo boccale di rye e perse ottanta dollari. Fu contento di vedere che Harry vinceva. “Fortunato alle carte, sfortunato in amore” continuava a ripetersi, dopo che si fu messo a letto. Una settimana dopo Gladys portò Charley a conoscere i suoi genitori, dopo ch’ebbero preso insieme il tè nel suo alloggio, sorvegliati dal sorriso di Taki e dalla sua ciondolante testa nera. Horton B. Wheatley era una potenza, diceva Farrell, nella Security Trust Company, un individuo rubicondo dai capelli brizzolati e baffetti d’argento. La signora Wheatley era una donna cascante, dall’amabile accento dell’Alabama e dal volto sfiorito e rigonfio e aggrinzilo come un palloncino bell’e andato. Il signor Wheatley si mise a parlare prima che Gladys avesse finito le presentazioni. «Già, signore, ce l’aspettavamo qualcosa di simile. Ora come ora, certo, è troppo presto per prendere una decisione, ma non vedo perché non dovrei dirvi, giovanotto, che preferisco vedere mia figlia sposata a un giovane come voi che si è fatto la sua strada nel mondo, anche se di
voi non sappiamo ancora troppe cose, piuttosto che a un giovane come Harry, che a suo modo è un ragazzo abbastanza come si deve, ma non ha mai fatto nella vita un briciolo più che ricevere l’educazione che suo padre gli ha fornita. Giovanotto, noi siamo ben fieri, mia moglie ed io, di fare la vostra conoscenza e che voi e la nostra bambina… non abbiamo altro che lei al mondo e per questo ci è molto preziosa…» «I vostri genitori sono… sento che sono mancati, signor Anderson» intromise la signora Wheatley. Charley annuì. «Oh quanto mi dispiace… Erano di St. Paul, vero, dice Gladys…» Di nuovo parlava il signor Wheatley. «Il signor Anderson, mamma, è stato uno dei nostri più distinti assi di guerra, si è guadagnato gli speroni combattendo per la bandiera, mamma, e tutta la sua carriera a me pare un esempio… adesso vi farò arrossire, giovanotto… un esempio di come la democrazia americana operi nelle migliori condizioni spingendo avanti, al successo, i meglio adatti e intelligenti e stroncando i deboli… Signor Anderson, c’è una cosa che vi voglio pregare di concedermi subito. Vi voglio pregare di venire alla chiesa con noi domenica e parlare alla mia classe festiva. Sono certo che non vi dispiacerà di dir due parole d’ispirazione e di guida a quei ragazzi.» Charley arrossì e acconsentì. «Oh papà» gorgheggiò Gladys, gettando le braccia intorno al collo di tutti e due «non fargli far questo. La domenica è l’unica giornata che il povero ragazzo fa un po’ di golf… Sai che ho sempre detto che non avrei mai sposato un maestro festivo.» Il signor Wheatley si mise a ridere e la signora Wheatley abbassò gli occhi e diede un sospiro. «Una volta tanto non morirà, no?» «Certamente» Charley sentì dire a se stesso. «Potrebbe essere un’ispirazione.» L’indomani Charley e il signor Wheatley fecero colazione soli all’University Club. «Be’, figlio mio, il dado è gettato» disse il signor Wheatley incontrandolo nel vestibolo. «Le donne hanno preso la decisione, non c’è altro da fare per noi che piegarci alla loro volontà. Da parte mia, ragazzi, vi auguro ogni felicità…» Mentre mangiavano,
il signor Wheatley parlò della banca e degli interessi Tern e della fusione con Askew-Merritt che avrebbe più che raddoppiato il capitale della nuova Tern Aviation Company. «Vi sorprende che sia così informato di tutte queste cose, Charley… ma ecco quel che pensavo: quel giovanotto è un genio meccanico, ma non tiene d’occhio il lato finanziario… non si rende conto di quel che i suoi interessi in quest’impresa significano per lui e per il mondo finanziario.» «Ecco, conosco certi bravi amici che mi danno l’imbeccata» disse Charley. «È più che giusto» rispose il signor Wheatley «è più che giusto, ma ora che siamo in famiglia, anche un po’ del mio consiglio, il risultato di vent’anni di esperienza nella banca, laggiù da noi a Birmingham, e poi qui in questa nuova, grande, abbagliante Detroit…» «Ma certo, sarò ben contento di ascoltarvi, signor Wheatley» balbettò Charley. Il signor Wheatley tirò innanzi e parlò di un terreno sul lungofiume di Grosse Pointe, con diritti ripari, che aveva in mente di offrire ai ragazzi come regalo di nozze, e come essi dovessero senz’altro farci costruire, non fosse che come investimento nella più esclusiva area residenziale di tutti gli Stati Uniti d’America. «Ora, figlio mio, se vorrai passare all’ufficio, dopo colazione, ti farò vedere i progetti per le più belle casette che tu abbia mai vedute in stile inglese antico, da costruire su quel terreno. Me li sono fatti disegnare per fare una sorpresa a mamma e Gladys, da Ordway and Ordway… Tudor mezzolegno, lo chiamano. Ma ho pensato di passare tutta la faccenda a voi ragazzi, dato che sarebbe troppo grande per mamma e me, adesso che Gladys si sposa. Così io penso al terreno e tu pensa alla casa. Metteremo tutto a nome di Gladys per i figli eventuali.» Finirono di mangiare. Mentre si alzavano, il signor Wheatley prese a Charley la mano e gliela strinse. «Ragazzo mio, sinceramente spero e faccio voti, perché vengano dei figli.» Dopo il giorno di Grazie le pagine mondane di tutti i giornali di Detroit erano piene di una serata danzante data dai signori Horton B. Wheatley per annunciare il prossimo matrimonio della loro figlia Gladys col signor Charley Anderson, inventore, asso di guerra, e capo
del reparto Ricerche del grande stabilimento aeronautico Tern. Il vecchio Bledsoe non rivolse più la parola a Charley dopo l’annuncio del fidanzamento, ma Anne venne a cercare Charley e Gladys la sera del ballo della vigilia d’Ognissanti al Country Club e disse che comprendeva perfettamente e augurava loro ogni felicità. Qualche giorno prima delle nozze, Taki si licenziò. «Ma io credevo che saresti restato… Sono certo che anche mia moglie ne sarebbe lieta. Potremmo darti un aumento.» Taki sorrise e s’inchinò. «È un peccato» disse «che io serva soltanto per le case degli scapoli… ma vi auguro in futuro ogni contento.» Quel che ferì di più Charley fu che, quando scrisse a Joe Askew pregandolo di fargli da testimonio, lui gli telegrafò in risposta una semplice parola: «No». Le nozze si fecero alla chiesa battista dell’Emmanuele. Charley indossava il frac e scarpe nere nuove che gli ammaccavano i piedi. Badava a ricordarsi di non portar la mano alla cravatta. Nat Benton venne da New York per fargli da testimone e fu di grande aiuto. Mentre aspettavano in sacrestia, Nat tirò fuori, dalla tasca dei pantaloni una fiaschetta e cercò di indurre Charley a bere un sorso. «Hai il muso piuttosto lungo, Charley.» Charley scosse il capo e fece un gesto col pollice nella direzione da cui veniva la musica dell’organo. «Sei sicuro di avere l’anello?» Nat rise e tracannò. Si schiarì la gola. «Dunque, Charley, dovresti farmi le congratulazioni per aver saputo indovinare uno che aveva dell’avvenire… Se sapessi mettere il dito sul mercato come lo so mettere su un giovanotto in gamba, sarei senz’altro a quattrini.» Charley era tanto nervoso che balbettò: «No… non pensarci, Nat, provvederò io a te». Risero tutti e due, e si sentirono meglio. Un inserviente faceva loro cenni frenetici dall’uscio della sacrestia. Gladys con tutti quei volantini di raso e il velo di pizzo e i fiori d’arancio, e un bambino in raso bianco che le reggeva lo strascico, aveva l’aria di qualcuna che Charley non aveva mai veduta. Tutti e due dissero «sì» piuttosto forte e senza guardarsi in faccia. Al ricevimento che seguì, non c’era liquore nel ponce per via dei Wheatley. Charley si sentiva soffocare all’odore dei fiori e delle
pellicce femminili e ai tentativi di dir qualcosa a tutte le vecchie signore elegantissime cui lo presentavano, che tutte ripetevano la stessa cosa, quant’era stata bella la cerimonia. Si era appena liberato per salire le scale e mutarsi d’abito, quando vide Ollie Taylor, brillo completo, incespicare in un tappeto persiano nel corridoio e cadere quant’era lungo ai piedi della signora Wheatley che usciva allora dalla sala di ricevimento, pallidissima e lacrimosa, in color lavanda e orchidee. Charley tirò dritto per le scale. Sebbene il matrimonio fosse stato secco, Nat e Farrell avevan certo preso qualcosa, perché i loro occhi luccicavano e avevano un inumidimento intorno alla bocca quando entrarono nella camera dove Charley stava cambiandosi in un abito marrone da viaggio. «Carogne fortunate» disse. «Dove ne avete trovato?… Giuda, avreste potuto lasciare fuori Ollie Taylor.» «Se n’è andato» disse Nat. Aggiunsero in coro: «Pensiamo noi a tutto». «Cristo» disse Charley. «E io che stavo pensando che bella cosa aver mandato gli inviti a mio fratello di Minneapolis e a tutta la squadra troppo tardi per arrivare a tempo. Mi par di vederlo il vecchio zio Vogel che corre da tutte le parti e pizzica le dame gridando Hochzeit.» «Mi dispiace assai per Ollie» disse Nat. «È uno dei più simpatici camerati che ci siano al mondo.» «Povero vecchio Ollie» fece eco Charley. «Ha perso il controllo di sé.» Bussarono alla porta. Era Gladys, con la faccina pallida e capellidorata e meravigliosa al centro di un enorme collo di cincilla. «Charley, bisogna che andiamo. Dispettoso, non credo che tu abbia ancora dato un’occhiata ai regali.» Li condusse in un salone disopra, accatastato di vetreria e argenteria da tavola e fiori e servizi per fumare e servizi per toeletta e shaker per cocktail, tanto che pareva un emporio. «Non sono carini?» disse. «Mai visto niente di simile in vita mia» disse Charley. Videro certi ospiti entrare dall’altra parte e scapparono di nuovo nel corridoio retrostante. «Quanti poliziotti ci sono?» chiese Charley. «Quattro»
disse Gladys. «E allora?» disse Charley. «Ce ne andiamo.» «Be’, è tempo che ci ritiriamo» fece coro Farrell, e Nat d’un tratto si piegò ridendo. «O che possiamo baciare la sposa?» «Sicuro» disse Charley. «Ringraziate gli inservienti da parte mia.» Gladys dimenò la mano. «Siete dei cari… ora andate.» Charley cercò di stringerla a sé, ma lei lo respinse. «Papà ha fatto portare tutti i bagagli dalla porta della cucina… Oh, facciamo presto… Non so più quel che dico.» Corsero giù per le scale di servizio e saltarono in un tassì, dov’era il bagaglio. Quello di Charley era di porco; il suo era d’un nero lucente. Le valigie avevano un odore nuovo e costoso. Charley vide Farrell e Nat avanzarsi da sotto le colonne del grande portico coloniale, ma prima che potessero gettare i coriandoli l’autista aveva premuto l’acceleratore ed eccoli partiti. Alla stazione non c’era altri che i Wheatley; la signora Wheatley che piangeva insaccata nel soprabito di martora, il signor Wheatley che arringava intorno alla famiglia americana, l’ascoltassero o no. Nel tempo che ci volle prima che il treno si mettesse in moto, anche Gladys aveva finito per mettersi a piangere e Charley le sedeva di fronte con un senso di avvilimento, non sapendo come diavolo cominciare. «Vorrei che fossimo partiti a volo.» «Sai bene che non sarebbe stato possibile con questo tempo» disse Gladys, e scoppiò un’altra volta in lacrime. Per avere qualcosa da fare, Charley ordinò un po’ di pranzo nella vettura ristorante e mandò l’inserviente negro a cercare un secchiello di ghiaccio per lo champagne. «Oh, i miei nervi» gemette Gladys, premendosi la mano guantata sopra gli occhi. «Dopo tutto, bella, non è come se si trattasse del primo venuto… Siamo tu ed io» disse Charley gentile. Gladys rise silenziosamente. «Devo proprio essere una sciocchina.» Quando l’inserviente ridendo, rispettosamente cordiale, ebbe sturato lo champagne, Gladys vi bagnò le labbra. Charley vuotò il suo
bicchiere e tornò a riempirlo. «Ecco qua, Glad, così è la vita.» Quando l’inserviente se ne fu andato, Charley le chiese perché non beveva. «Al circolo, Glad, eri una vera spugna.» «Non voglio che neanche tu beva.» «Perché?» Gladys avvampò di rossore. «Mamma dice che se i genitori bevono, avranno bambini idioti.» «Oh povera piccola» disse Charley, con gli occhi che si riempivano di lacrime. Stettero seduti a lungo guardandosi a vicenda, mentre sfumava la spuma dello champagne dai bicchieri e lo champagne si versava sul tavolino agli scossoni del treno. Quando giunse il pollo arrosto, Gladys non riuscì a mangiarne un solo boccone. Charley mangiò le due porzioni e finì lo champagne e sentì che si comportava come un porco. Il convoglio rintronava e rombava alle orecchie attraverso la notte nevosa. Dopo che l’inserviente ebbe sparecchiato i piatti della cena, Charley si tolse la giacca e sedette accanto a Gladys e cercò di farci un po’ all’amore. Ma lei si lasciò solamente baciare e abbracciare, come avevan già fatto prima di sposarsi. Quando Charley cercò di scioglierle il vestito, lei lo respinse. «Dopo, dopo.» Gladys entrò nel gabinetto per mettersi in camicia da notte. Charley credeva d’impazzire, tanto tempo lei stette. Sedeva in pigiama nella folata diaccia e polverosa che entrava per la fessura della finestra e venne il momento che batteva i denti. Alla fine cominciò a menar colpi sull’uscio del gabinetto. «È accaduto qualcosa, Glad? Che c’è, tesoro?» Gladys venne fuori in una morbida vestaglia di pizzo. Si era troppo truccata in viso. Le tremavano le labbra sotto l’imbratto del rossetto. «Oh, Charley, no questa notte sul treno, è già così orribile.» Lo assalì d’improvviso un furore irrefrenabile. «Ma sei mia moglie. Io sono tuo marito, porco mondo.» Spense la luce. Sentì le mani diacce di lei sulle sue. Afferrandola per tirarla a sé, si sentì i muscoli delle braccia gonfiarsi robusti dietro la sua schiena flessuosa. Gli fece piacere il modo in cui il pizzo e la seta gli si lacerarono sotto le mani. Dopo, Gladys lo fece uscire dal suo letto e distendersi sul divano,
avvolto in una coperta. Nessuno dei due dormì. L’indomani lei era tanto smorta che ebbero paura di doversi fermare in qualche luogo per consultare un dottore. Verso sera si sentiva meglio, ma ancora non poteva mangiar nulla. Tutto il pomeriggio era stata semidormente distesa sul divano, mentre Charley le sedeva accanto reggendole le mani, con un mucchio di riviste intatte sulle ginocchia. Fu come uscire di prigione, quando scesero dal treno a Palm Beach e videro l’erba verde e le palme e le siepi di ibisco in fiore. Gladys, quando vide le ampie camere del loro appartamento d’angolo al Royal Poinciana, dove aveva voluto scendere perché qui erano scesi il babbo e la mamma durante il loro viaggio di nozze, e vide il salotto riempito di fiori mandati dalle conoscenze, gli gettò le braccia intorno al collo e lo baciò prima ancora che l’ultimo inserviente fosse uscito dalla camera. «Oh, Charley, perdonami se sono stata così odiosa.» L’indomani mattina giacquero felici a fianco a fianco nel letto, dopo che ebbero fatto colazione e contemplato dalla finestra il mare al di là delle palme, e odorato il fresco della risacca e ascoltato i suoi tonfi lungo la spiaggia. «Oh Charley,» disse Gladys «che tutto per noi sia sempre così.» Il loro primo figlio nacque in dicembre. Era un maschio. Gli misero nome Wheatley. Quando Gladys ritornò dall’ospedale, invece di rientrare nell’alloggio andò nella nuova casa di Grosse Pointe che sapeva ancora di vernice e d’intonaco fresco. Fu allora che, tra le spese d’ospedale e le note per il mobilio e Natale, Charley dovette prendere ventimila dollari a prestito dalla banca. Passava ora più tempo che mai in conferenze telefoniche con l’ufficio di Nat Benton a New York. Gladys comperava innumerevoli abiti nuovi e teneva coppe di cristallo, colme di fresie e di narcisi, sparse per tutta la casa. Persino sul tavolino della sua camera da bagno, c’erano sempre dei fiori. La signora Wheatley diceva che le derivava quell’amore dei fiori dalla nonna Randolph, perché i Wheatley non erano mai stati capaci nemmeno di distinguere un fiore dall’altro. Quando il figlio successivo si chiarì una femmina, Gladys, giacendo all’ospedale, il viso stirato e smorto contro i guanciali candidi accanto al grande mazzo di smaglianti orchidee bianche che Charley aveva ordinato
dalla fioraia a cinque dollari l’una, disse che avrebbe desiderato metterle nome Orchid. Finirono per chiamarla Marguerite, come la nonna Randolph. Gladys non guarì troppo bene dopo la nascita della bambina e dovette subire diverse leggere operazioni che la tennero in letto tre mesi. Quando si rimise in piedi, fece ridecorare la grande camera, accanto a quella dei bambini e quella della bambinaia, a bianco e oro per servirsene da camera da letto. Charley borbottò parecchio a questa novità, perché la sua camera era all’altra estremità della casa. Quando si presentava in accappatoio prima di ritirarsi e cercava di entrare in letto con lei, Gladys lo teneva a distanza con un freddo sorriso, e se Charley insisteva gli dava qualche bacio a scatti e gli spiegava di non fare alcun rumore, altrimenti svegliava i bambini. Qualche volta lacrime d’ira gli salivano agli occhi. «Santo Dio, Glad, ma non mi vuoi proprio nessun bene?» E Gladys rispondeva che, se davvero lui le avesse voluto bene, sarebbe ritornato a casa quella sera che c’erano a cena gli Smyth Perkins, invece di telefonare all’ultimo momento che doveva fermarsi all’ufficio. «Ma, accidenti, Glad, se non guadagnassi i quattrini, come farei a pagare le note?» «Se mi volessi bene, avresti più riguardi, ecco tutto» gli rispondeva, e due linee ricurve le apparivano in viso dalle narici agli angoli della bocca come le linee sul viso di sua madre, e Charley la baciava rispettosamente e diceva povera piccola e ritornava in camera sua, sentendosi come un cane bastonato. Le volte che lo lasciava fermarsi, se ne giaceva fredda e cheta parlando del male che lui le faceva, in modo che Charley se ne tornava nel letto a baldacchino della sua grande camera con un senso tale di nervoso e di inquietudine che ci volevano diversi whisky puri per metterlo in forma da andare a letto. Una sera, che aveva portato Bill Cermak, ora caporeparto allo stabilimento Flint, in un locale sulla strada maestra dall’altra parte di Windsor per discorrere con lui delle difficoltà che sorgevano coi modellatori e gli stampatori, dopo ch’ebbero sorbito un paio di whisky Charley si trovò a interrogare invece Bill intorno alla vita
coniugale. «Di’ un po’, Bill, non hai mai difficoltà con tua moglie?» «Certo, padrone» rispose Bill ridendo. «Ne ho e come. Ma la vecchia è a posto, la conoscete, bravi ragazzi, buona cucina, sempre all’erta per farmi andare in chiesa.» «Senti, Bill, da quando ti è venuta quell’idea di chiamarmi padrone? Da’ un taglio.» «Con quel fottio di soldi» disse Bill. «Diavolo, un altro whisky.» Charley bevette il suo. «E poi una birra, come ai bei tempi… Ti ricordi quella festa di Natale a Long Island City e quella bionda della birreria?… Giuda, e pensare che ho sempre creduto di essere un demonio con le donne… Mia moglie non è mica convinta.» «Avete già due bei ragazzi; che diamine, siete troppo ambizioso forse.» «Non lo crederesti, Bill… una volta soltanto da quando è nata la piccina.» «Molte donne diventan più calde dopo un po’ che sono sposate… È per questo che i ragazzi ce l’hanno col vostro maledetto esperto d’efficienza.» «Stauch? Stauch è un genio della produzione.» «Può darsi, ma non lascia ai nostri ragazzi il respiro per la riproduzione.» Bill rise e si forbì la birra dalla bocca. «Bravo vecchio Bill» disse Charley. «Perdio, un bel giorno ti faccio entrare nel consiglio dei direttori.» Bill non rideva più. «Davvero, senza scherzi. Quel maledetto testone fa lavorare talmente quei ragazzi che le mogli protestano. Io sono solo lo spauracchio, e un lavativo, secondo che dicono, ma hanno ragione.» Charley se la rideva. «Sei un testone anche tu, Bill, e non so che cosa ci posso fare, io: non sono anch’io che un impiegato della compagnia… O una produzione efficiente o si parte. Anche Ford adesso costruisce aeroplani.» «Perderete tutti gli operai migliori… Sfruttare a questo modo può andar bene nell’industria delle automobili, ma metter su un motore d’aeroplano richiede gente che sappia il fatto suo.»
«Ah cribbio, vorrei pasticciare ancora dietro a quel motore del boia e non aver da pensare tutto il tempo ai quattrini… Bill, vado in bolletta. Prendiamo un altro whisky?» «Meglio mangiare.» «Bene, ordina una bistecca… quello che vuoi. Di’, Bill, ti pare che mi venga la pancia?… In bolletta, con la pancia, e la moglie che non mi vuol dormire insieme… Credi anche tu che io sia una spugna, Bill? Qualche volta penso che farei meglio a smetter sul serio. Non sono mai riuscito a molto, quando bevevo.» «Diamine, no, un giovanotto in gamba come voi, uno dei più in gamba, specialista in atterraggi di fortuna e pokerista… Dio mio.» «A che giova quando la moglie non vuol dormirti insieme?» Charley non toccò cibo. Bill mangiò tutte e due le bistecche. Charley non smetteva di bere whisky da una bottiglia che teneva sotto il tavolino, e birra per lavarsi la bocca. «Ma, dimmi un po’… tua moglie, si lascia fare tutte le volte che vuoi?… I ragazzi del laboratorio, anche loro la moglie non li lascia dormire, eh?» Anche Bill era un po’ brillo. «La mia fa quel che le dico di fare.» Finì che Bill dové lui ricondurre la nuova Packard di Charley al chiattone. Una volta in Detroit, Bill fece bere a Charley una quantità di acqua di selz in una farmacia, ma quando tornò in macchina Charley si afflosciò sul volante. Lasciò che Bill lo riportasse lui a Grosse Pointe. Poté sentire Bill discutere con le guardie lungo la strada e ciascuna voleva vedere il signor Anderson bell’e andato nell’interno della macchina prima di lasciare che Bill procedesse, ma a lui importava un cavolo, gli pareva tanto comica che cominciò a ridersela da solo. La più bella fu quando il custode dovette dare una mano a Bill, per riuscire a portarlo nella sua camera. «Il padrone non sta tanto bene, vedete, è il troppo lavoro» diceva Bill ogni volta e poi si picchiava sulla testa con un gesto solenne. «Lavoro cerebrale.» Charley ce la fece ad arrivare in camera e fu in grado di articolare disordinatamente: «Bill, sei un campione… George, chiama un tassì per ricondurre il signor Cermak… Fortunato del boia andare a casa con sua moglie». Poi si allungò sul letto con una scarpa sì e l’altra no e s’addormentò in pace.
Quando fu di ritorno dal suo successivo viaggio a New York e Washington, chiamò al telefono Bill dalla fabbrica. «Ehilà, Bill, come va il bambino? Tua moglie fa sempre quel che le dici, ah, ah. Io sto da cane, un viaggio d’affari massacrante, vedi… mai bevuto tanto in vita mia e con figure più sporche… Senti, Bill, non preoccuparti se ti licenziano, tu sei ai miei stipendi diretti, mi capisci… Stiamo per licenziare tutti quanti… Giuda, se non gli piace lavorare per noi, che provino a divertirsi lavorando per qualche altro… Quest’è un paese dove c’è libertà. Non mi permetterei mai di trattenere un uomo contro sua voglia… Senti, quanto ti ci vorrà per mettere in forma quel modellino Moth, sai bene, numero 16… il Mosquito del sottoscritto?… Perbacco… Bene, se possiamo averlo pronto in tempo perché serva da modello, capisci, per quelle descrizioni di brevetto… Accidenti, Bill, se ci riusciamo… siamo a cavallo, Bill. Non avrai più da preoccuparti che i bambini possano andare o no al collegio… porco mondo, potrete andare al collegio tu e tua moglie, anche… Perbacco.» Charley ripose il ricevitore sulla scrivania. La sua segretaria, signorina Finnegan, era sulla porta. Aveva i capelli rossi e una magnifica carnagione con qualche lentiggine intorno al nasetto vivace. Si vestiva a meraviglia. Fissava Charley con gli occhi brunochiari tutti umidi e spalancati, mentre lui dettava la legge al telefono. Charley si sentì gonfiare il torace. Tirò indietro la pancia più nettamente che poté. “Cristo,” si diceva in fondo al cranio “chi sa che non possa farmela con Elsie Finnegan.” Qualcuno gli aveva posato un vaso di giacinti azzurri sulla scrivania; ne emanava un profumo di primavera, che istantaneamente gli fece ricordare Bar-le-Duc e quando pescava le trote nel Red River. Era un altro fiorodoroso mattino di primavera quando Charley uscì dall’ufficio, diretto in auto allo stabilimento per il volo di prova del Mosquito Anderson. Era riuscito a dare per la prima volta un bacio a Elsie Finnegan e la lasciava tutta raggomitolata e tremante al tavolino. Bill Cermak aveva detto al telefono che il minuscolo apparecchio era tutto ripassato e in ottima forma. Fu un sollievo andarsene dall’ufficio dove si era agitato inquieto per un paio d’ore cercando di sbrigare una telefonata con l’ufficio di Nat Benton intorno
a certi titoli di cui aveva telegrafato di realizzare il vantaggio. Dopo averla baciata, aveva detto a Elsie Finnegan di passargli la comunicazione al campo di prova. Quale senso di benessere guidare attraverso la città in costruzione, attraverso il corso ingorgato di furgoni pieni di materiale da costruzione, lanciando la macchina in mezzo ai furgoni, con un senso di ostentazione e di forza al funzionamento perfetto della frizione e alla docile risposta del cambio. L’uomo del cancello aveva già pronta per lui la chiamata da New York. La connessione era perfetta. Nat aveva incassato per lui tredici bigliettoni. Appendendo l’ascoltatore pensò: poveretta d’un’Elsie, bisognava che le comprasse qualcosa di veramente bello. «Non è una gran giornata, Joe?» disse all’uomo del cancello. Bill lo aspettava accanto al nuovo apparecchio all’entrata del capannone, forbendosi il grasso dalle tozze dita con una manciata di stracci. Charley gli batté sulla schiena. «Bravo vecchio Bill… Non è un gran giorno questo per il nostro genere?» Bill ci cascò. «Che genere, 2 padrone?» «Il genere umano, zuccone… Davvero, Bill,» continuò mentre si toglieva i guanti e il suo ben fatto soprabito leggero «non posso nascondere che oggi mi sento un padreterno… vinto tredici bigliettoni in Borsa ieri… senza muovermi di qui a lì.» Mentre Charley s’infilava in una tuta, i meccanici spinsero il nuovo apparecchio sull’erba perché Bill vi passasse l’ispezione generale. «Giuda, com’è bello.» Il minuscolo apparecchio d’alluminio riluceva nel sole sull’erba verde come un oggetto nella vetrina di un gioielliere. C’eran nell’erba bocche di leone e trifoglio, e uno sciame turbinante di farfalle candide s’innalzò proprio da sotto ai suoi scarponi neri, quando Bill ritornò verso Charley e gli si fermò accanto. «Ridi, su, lavativo,» disse Charley «non ti rimette in vita, questo tempo?» Bill gli volse addosso il suo quadrato faccione slavo. «Sentite, signor Anderson, voi mi avete sempre trattato bene… fin dai tempi di Long Island. Sapete chi sono: fare il mio lavoro, tornare a casa, chiudere il becco.» «Cos’hai in mente, Bill?… Occorre che ti faccia offrire un altro aumento? Perbacco.» Bill crollò il pesante faccione quadrato e si sfregò il naso con l’indice nero. «La Tern Company prima era un posto che faceva
piacere lavorarci, buon lavoro buona paga. Sapete chi sono, signor Anderson, io non sono un bolscevico… ma nemmeno una spia.» «Ma, porco mondo, Bill, non puoi dire a quei tali di mettere un po’ di pazienza?… stiamo preparando un progetto per la compartecipazione agli utili… Ho lavorato anch’io al tornio, ai miei tempi… Ho lavorato da meccanico in tutto questo porco paese… So che cosa hanno in mente i ragazzi, ma so anche quel che ha in mente la direzione… Giuda, quest’industria è ancora bambina, di giorno in giorno versiamo nell’azienda capitali più grossi… Abbiamo una responsabilità verso gli azionisti. Dove credi che vada quel denaro che ho fatto ieri? ma nell’azienda. L’officina d’una volta era una gran bella cosa, con tutti che ridevano e fumavano e contavano storielle sporche, ma ora la pressione è troppo forte. Se ogni reparto non scatta come una macchina, siam bell’e fottuti. Se i ragazzi vogliono il sindacato, ebbene gli daremo un sindacato. Fa’ tu un’assemblea e spiegagli i nostri sentimenti, ma spiegagli che dobbiamo avere un po’ di patriottismo. Spiegagli che l’industria è il primo coefficiente della difesa nazionale. Manderemo giù Eddy Sawyer a parlare… a far capire a tutti i nostri problemi.» Bill Cermak scosse il capo. «Ce n’è già un mucchio che lo fanno.» Charley s’aggrottò. «Via, vediamo come va» sbottò impaziente. «Perdio, è un gioiello.» Il rombo del motore impedì loro di parlar oltre. Il meccanico discese dai montanti e Charley si arrampicò su. Bill Cermak prese posto dietro. L’apparecchio partì saltellando veloce attraverso il campo verde. Charley lo mise al vento e diede benzina. Al primo balzo di volo ci fu uno scossone. Mentre capitombolava innanzi, Charley tolse i contatti. Lo stavano trasportando per il campo su una barella. Ad ogni passo dei due individui che reggevan la barella, due cose infrante gli si urtavano insieme nella gamba. Si provò a dir loro che aveva un pezzo di qualcosa nelle costole, ma la sua voce era sommessa e roca. Nella penombra del capannone, ecco che tentò di sollevarsi sul gomito. «Che diavolo è successo? E Bill?» I due scossero il capo. Poi tornò a perdere i sensi, come quando in un’auto la benzina vien meno.
Nell’ambulanza cercò di interrogare l’uomo in giacchetta bianca su Bill Cermak e di ricordarsi esattamente che cosa fosse accaduto, ma la gamba lo teneva troppo occupato a sforzarsi di non urlare. «Ehi, dottore,» riuscì a gemere «non mi potete levare dal fianco queste schegge d’alluminio? Quel dannato apparecchio deve avermi dato la giravolta addosso. Forse è l’ala che non ce l’ha fatta, ma è ora che mi levino il motore d’addosso. Ehi, dottore, perché non si sbrigano?» Quand’annusò il primo sentore d’ospedale, c’era una quantità d’individui in giacchetta bianca che gli scivolavano e sussurravano intorno. L’ospedale sapeva forte di etere. Il brutto era che lui non poteva respirare. Qualcuno certo aveva versato quel maledetto etere. No, non sulla mia faccia. Il motore rombava. Doveva aver veduto cose strane. Il rombo del motore scivolò in una cantilena. Proprio, l’apparecchio andava bene, stabile come uno di quei vecchi da bombardamento. Quando si risvegliò, una infermiera lo aiutava a rigettare dentro una scodella. Quando si risvegliò un’altra volta, porco mondo basta con l’etere, no, invece eran fiori, e Gladys stava dritta accanto al letto con un gran mazzo di fiordipiselli in mano. In volto aveva un’aria afflitta. «Ciao, Glad, come sta la piccola?…» «Oh, sono stata così in pena, Charley. Come ti senti? Oh, Charley, un uomo della tua posizione rischiare la vita in voli di prova… Perché non li lasci fare alla gente cui tocca, domando io.» C’era qualcosa che Charley voleva chiedere. Aveva una gran paura di qualcosa. «E di’, stanno bene i bambini?» «Wheatley si è sbucciato un ginocchio e temo che la piccola abbia un po’ di febbre. Ho telefonato al dottor Thompson. Credo però che non sia nulla.» «E Bill Cermak, sta bene?» A Gladys tremò la bocca. «Oh, sì» disse, tagliando seccamente le parole. «Così, questa faccenda vuol dire che la nostra serata è rinviata… Pensa che venivano gli Edsel Ford.» «Giuda, no, perché non darla lo stesso? Il sottoscritto potrà presenziare in carrozzella. Di’, è buffa che mi hanno messo la camicia di forza… Scommetto che ho le costole rotte.» Gladys annuì; la bocca andava facendolesi piccina e sottile. Poi d’un tratto si mise a piangere. Entrò l’infermiera e disse in tono di rimprovero: «Ma signora
Anderson…». Charley fu ben felice quando Gladys se ne andò lasciandolo solo con l’infermiera. «Dite, infermiera, non potete metter le mani sul dottore? Ditegli che mi sento bene e che vorrei dare un’occhiata all’estensione dei danni.» «Signor Anderson, non dovete avere nessuna preoccupazione.» «Già, già: dite alla signora Anderson di mettersi a contatto con l’ufficio.» «Ma è domenica, signor Anderson. Una gran folla di persone è stata sotto, ma non credo che il dottore lasci già salire.» L’infermiera aveva un viso fresco e, nel parlare, una leggera cadenza scozzese. «Scommetto che siete canadese» disse Charley. «Proprio» disse l’infermiera. «Una volta ne ho conosciuta una straordinaria, che era canadese. Se avessi avuto la testa sul collo, avrei sposato quella.» Il dottore dell’ospedale era un tipo faccia tonda con un modo blando e gioviale, quasi come un capocameriere di grande albergo. «Dite, dottore, deve proprio farmi così male, la gamba?» «Capite che non ve l’abbiamo ancora fissata. Avete cercato di offendervi un polmone, ma non ci siete riuscito bene. Ci toccò asportarvi qualche scheggia di costola.» «Non dal polmone…» «No, fortunatamente.» «Ma perché diavolo non mi avete subito fissato anche la gamba?» «Ecco, aspettiamo che arrivi da New York il dottor Roberts… la signora Anderson è stata irremovibile. Ne siamo tutti lietissimi, il dottore è uno dei più eminenti della sua professione… si tratterà di un’altra operazioncella.» Solamente dopo che fu rinvenuto dalla seconda operazione, gli dissero che Bill Cermak era morto per frattura della scatola cranica. Charley rimase tre mesi nell’ospedale con la sua gamba ingessata. La frattura alle costole guarì presto, ma gli permanevano disturbi di respirazione. Gladys s’occupava lei delle note di casa e veniva un momento ogni pomeriggio. Aveva sempre fretta e sempre era terribilmente preoccupata. Charley dovette passare una procura a Moe Frank, il suo avvocato, che soleva venirlo a trovare un paio di volte la settimana per discutere le faccende. Charley non aveva molto da dire: non poteva ripetere a tutti che lui soffriva tanto. Fu ben più contento quando Gladys mandò Wheatley a fargli visita. Wheatley aveva adesso tre anni e trovò che l’ospedale era una
gran cosa. Gli piaceva vedere l’infermiera manovrare tutti i minuscoli contrappesi e le pulegge della gabbia in cui era sospesa la gamba. «Papalino vive nell’aeroplano» fu quanto non smise più di ripetere. Aveva capelli di stoppa e il naso cominciava a guardargli all’insù e Charley trovava che prendeva da lui. Marguerite era ancor troppo piccola per esser divertente. L’unica volta che Gladys la fece condurre dalla governante, lei strillò talmente all’aspetto della terrificante gabbia che dovettero riportarla via. Gladys non le permise di tornare più. Gladys e Charley ebbero un aspro litigio, se si doveva lasciar venire Wheatley, poiché lei, diceva, non voleva che il bimbo ricordasse suo padre all’ospedale. «Ma Glad, avrà tutto il tempo che vorrà per dimenticarsene, per dimenticarsene ben più presto, giuda, che non potrò io.» Gladys increspò le labbra e non disse nulla. Quando se ne fu andata, Charley stette là pieno d’odio, chiedendosi come mai avevano potuto fare insieme dei figli. Proprio intorno al tempo che cominciò a capire chiaramente che tutti s’aspettavano che sarebbe rimasto storpio per il resto della vita, ebbe un principio di miglioramento ma venne l’inverno prima che fosse in grado di tornare a casa sulle stampelle. Tuttora soffriva ogni tanto di una specie di difficoltà nervosa al respiro. La casa gli parve estranea, quando vi si strascinò intorno, Gladys aveva fatto ridecorare tutte le camere mentre lui non c’era, e tutta la servitù era mutata. A Charley non diede affatto il senso che fosse casa sua. Ciò che trovava più piacevole era il massaggio, che subiva tre volte la settimana. Passava le giornate giocando coi bimbi e discorrendo con la signorina Jarvis, la governante inglese rigida e già vecchia. Dopo che questi erano andati a letto, lui sedeva nel salone a bere scotch con selz e si sentiva rigonfio e nervoso. Mondo fottuto, ingrassava troppo. Gladys aveva un gran sangue freddo in quei giorni; persino quando Charley era preso da accessi di rabbia e le gettava imprecazioni, lei si fermava a fissarlo con un freddo sguardo di disgusto sul viso accuratamente truccato. Dava assai ricevimenti, ma lasciava capire alla servitù che il signor Anderson non era abbastanza in salute per scendere. Cominciò a sentirsi, a casa sua, come un parente povero. Una volta che c’erano i Farrell, si vestì da
sera e scese a cena, zoppicando sulle stampelle. La sua posata non c’era e tutti lo guardavano come fosse un fantasma. «Evviva» gridò Farrell con la sua voce latrante. «Mi ripromettevo di salire a far quattro ciance, dopo cena.» Si chiarì poi che ciò di cui Farrell voleva parlare era un risarcimento di cinquecentomila che qualche maledetto avvocato aveva indotto la vedova di Cermak a chiedere alla compagnia. Farrell aveva in mente che, se Charley andava a trovare quella donna, poteva forse indurla a mostrarsi ragionevole e accontentarsi di una piccola rendita annuale. Charley rispose che non sarebbe andato, neanche a morire. Durante la cena si sbronzò e alla fine rovesciò le tazze del caffè con la stampella e scappò a letto su tutte le furie. Quel che trovava più piacevole, oltre giocare coi bimbi, era comprare e vendere titoli e discorrere con Nat sull’interurbana. Nat gli andava ripetendo che lui aveva il senso del mercato. Nat lo metteva in guardia e Charley sapeva anche troppo bene che la sua posizione alla Tern era malsicura e che, se non avesse fatto qualcosa, l’avrebbero costretto ad andarsene, ma si sentiva troppo giù per presentarsi all’assemblea dei direttori; quel che fece fu di vendere circa metà delle sue azioni a piccoli pacchetti. Nat badava a ripetergli che facesse soltanto un passo avanti e avrebbe avuto il controllo di tutta la baracca prima che Andy Merritt portasse a termine la sua nuova riorganizzazione, ma Charley si sentiva troppo nervoso e malandato per fare quello sforzo. Tutto quel che pareva sapesse fare era di brontolare e parlare a Julius Stauch e menar baccano sulle minuzie. Stauch aveva continuato i suoi tentativi intorno al nuovo monoplano e condotto a termine un piccolo apparecchio che aveva superato a bandiere spiegate tutte le prove. Quando deponeva il ricevitore, Charley si versava un po’ di scotch e si riadagiava sul divano sotto la finestra e borbottava tra sé: «Questa volta sei proprio servito». Una sera Farrell venne a trovarlo e fece una lunga seduta e disse che a Charley occorreva una crociera di pesca; non si sarebbe mai ristabilito se continuava in quel modo. Disse che aveva parlato col dottor Thompson e che quello raccomandava tre mesi di libertà ed esercizio intenso, se mai voleva buttar via le stampelle.
Gladys non poteva venire per via che la vecchia signora Wheatley stava male, e così Charley salì nella sua berlina Lincoln, lui solo, con l’autista a guidare, e un mucchio di coperte per star caldo, e una fiasca di whisky e una bottiglia termos di caffè bollente, deciso a scendere tutto solo fino a Miami. A Cincinnati si sentiva così malandato che passò un giorno intero a letto nell’albergo. Si fece cercare dall’autista libercoli sulla Florida in un’agenzia di viaggi, e alla fine mandò un telegramma a Nat Benton invitandolo a passare con lui la settimana alla pescheria del Key Largo. L’indomani mattina ripartì di buon’ora. Aveva avuto una buona notte di sonno e si sentiva meglio e cominciava a godere il viaggio. Ma gli pareva d’esser troppo stupido, a star là seduto portato come una vecchia, tutto infagottato di coperte. Si sentiva anche solo, per via che l’autista non era quel tipo di cristiano con cui si possa scambiare una parola. Era un franco-canadese dall’aria arcigna, che Gladys aveva preso perché le pareva chi sa che eleganza dare gli ordini in francese attraverso il tubo; ma Charley era sicuro che quel furfante l’aveva truffato sulle spese di benzina, olio e riparazioni, lungo tutta la strada; quella maledetta Lincoln era divenuta un pozzo di San Patrizio in fatto di benzina e olio. A Jacksonville sfolgorava il sole. Charley si concesse la soddisfazione di licenziare l’autista appena si fermarono all’entrata dell’albergo. Poi andò a letto con un litrozzo di perfida acquavite che gli vendé l’inserviente, e dormì come un tronco. Al mattino si destò tardi, con un senso di sete, ma allegra. Dopo colazione uscì dall’albergo e girò un poco in macchina per la città. Fu una soddisfazione cinghiare lui la sua valigia e salire nel posto anteriore e guidare lui la sua macchina. La città aveva un aspetto allegro e disordinato, nella luce del sole, sotto le grosse nubi candide e il cielo azzurro. Al caffè vicino alla stazione degli autobus, si fermò per bere un bicchierino. Si sentiva così bene che uscì dalla macchina senza le stampelle e attraversò zoppicando il marciapiede tepido. Il vento scompigliava le pagine delle riviste e i fogli rosa e verdepallido dei giornali, di là dalla vetrina
del caffè. Charley era senza fiato per lo sforzo quando si lasciò scivolare su un seggiolino al banco. «Datemi una cedrata e niente zucchero, prego» disse al giovane faccia di topo, che stava al rubinetto. Il cameriere non si voltò neanche, stava guardando dall’altra parte. Charley si sentì avvampare. La prima idea fu lo faccio mandar via. Poi guardò dove guardava il giovanotto. C’era laggiù una bionda che mangiava un panino, all’estremità del banco. Niente da dire, era carina. Aveva un cappellino nero, un bell’abito grigio turchino e un merletto bianco intorno al collo e ai polsi. Faceva una faccia stupefatta come avesse sentito allora qualcosa di straordinariamente buffo. Dimenticando di secondare la gamba gigia, Charley sgusciò sopra diversi seggiolini alla sua volta. «Ehi, ragazzo, e questa cedrata?» gridò tutto allegro al cameriere. La bionda guardava Charley. Davvero i suoi occhi erano di un perfetto azzurro. Ecco che gli parlava. «Forse sapete quanto ci vuole di qui a Miami in autobus, signore. Questo tipo crede d’esser spiritoso e non mi riesce di cavarne nulla.» «Si potrebbe provare insieme e vedere un po’» disse Charley. «Ma guarda come sono allegri in Florida… Un altro umorista.» «Macché, parlo sul serio. Se lasciate che vi porti io in macchina, farete una grande carità a un povero malato.» «Siete certo che non sarà una fine peggiore della morte?» «Sarete perfettamente sicura con me, signorina. Sono quasi uno storpio. Vi mostrerò le mie stampelle in auto.» «Che cosa vi è successo?» «Un disastro in aeroplano.» «Un pilota, siete?» Charley annuì. «Non troppo magro per Lindbergh» disse la bionda, squadrandolo. Charley diventò rosso. «Ho passato un poco il peso. È che sono stato ingabbiato per questa gamba maledetta.» «Ebbene, voglio provare. Vuol dire che se monto nella vostra macchina e mi sveglierò a Buenos Aires, sarà stata la mia cattiva fortuna.» Charley tentò di pagarle il caffè e il panino, ma lei non lo permise.
Qualcosa nei modi di quella donna lo faceva ridere tutto il tempo. Quando si alzò e lei vide come zoppicava, increspò la bocca. «Euh, in che stato.» Quando vide la macchina, si piantò ferma. «Nespole,» disse «siamo milionari coi fiocchi.» Ridevano salendo in macchina. C’era qualcosa nel suo modo di fare osservazioni, che lo metteva in allegria. Non gli volle dire il suo nome. «Chiamatemi Madame X» dichiarò. «Allora vi toccherà chiamarmi signor A» disse Charley. Risero e continuarono a ridacchiare per tutta la strada fino a Daytona Beach, dove si fermarono ed entrarono nelle onde a fare un bagno. Charley si vergognò della pancetta e della pelle smorta e dello zoppicamento, attraversando la spiaggia con lei abbronzata e snella nel costume azzurro. Aveva una ben graziosa personcina, benché le anche fossero un po’ larghe. «Però non è grave al punto da restare con una gamba più corta dell’altra. Il dottore dice che mi rimetterò alla perfezione, se farò il debito esercizio.» «Sono certa che starete presto a meraviglia. E io che là al caffè vi credevo un vecchio ganimede a quattrini.» «A me voi parete una stella, Madame X.» «Fate attenzione a non mettere nulla per scritto, signor A.» La gamba gli faceva un male d’inferno, quando uscì dall’acqua, ma ciò non gli impedì di sentirsi un appetito formidabile per la prima volta dopo mesi. Dopo un solenne pranzo di pesce, ripartirono. La ragazza si addormentò in macchina con la bella testina sulla spalla di Charley. E lui si sentiva felice a guidare sul liscio rettilineo di cemento, benché fosse ormai stanco. Quando giunsero a Miami quella sera, la ragazza si fece portare a un alberghetto fuori mano presso la ferrata e non gli permise di entrare con lei. «Ma, accidenti, non ci troveremo un’altra volta?» «Ma certo, potete venirmi a vedere ogni sera al Palms… faccio là la spiritosa.» «Davvero… L’avevo capito che eravate una ragazza spiritosa, ma non sapevo che foste professionista.» «Mi avete reso un gran servizio, signor A. Adesso si può raccontarlo… Ero in bolletta e non mi restavano che i soldi per quel
panino di prosciutto; se voi non mi aveste portata, avrei perduto ogni possibilità di lavorare… Una volta o l’altra ve ne parlerò.» «Come vi chiamate? Vorrei telefonarvi.» «Come vi chiamate, voi?» «Charles Anderson. Mi fermerò, annoiandomi a morte, al Miami Biltmore.» «Dunque è vero che siete il signor A… Arrivederci allora, signor A, e grazie, ancora un milione di grazie.» Entrò correndo nell’albergo. Charley ne era già cotto. Era talmente stanco, che a malapena giunse al suo albergo. Salì in camera e si lasciò cadere sul letto e, per la prima volta dopo mesi, prese sonno senza prima ubriacarsi. Nat Benton, quando arrivò, otto giorni dopo, fu sorpreso di trovare Charley così in forma. «Non c’è niente come cambiare» disse Charley, ridendo. Scesero in macchina insieme verso i Keys. Charley aveva in tasca la fotografia di Margo Dowling, una fotografia professionale di lei vestita in costume spagnolo per il suo numero. Era stato al Palms tutte le sere, ma non era ancora riuscito a farla decidere di uscir con lui. Se proponeva qualcosa, lei crollava il capo e faceva una smorfia e diceva: «Una volta o l’altra vi parlerò di tutto questo». Ma la sera prima gli aveva dato un numero di telefono dove poteva cercarla. Nat tentava con insistenza di parlare del mercato e della grande riorganizzazione della Tern e dell’Askew-Merritt che Merritt promuoveva, ma Charley gli tappava la bocca con un «Via, parliamo d’altro, che diavolo». Il campeggio andò a meraviglia, ma le zanzare divoravan vivi. Trascorsero una bella giornata sugli scogli a pescare barracude e garrupe. Si portarono una fiasca di Bacardi sulla lancia a motore e pescarono e bevettero e mangiarono panini. Charley raccontò a Nat com’era andata la disgrazia. «Davvero non credo sia stata colpa mia. Fu uno di quei casi dannati che non si possono evitare… Ora mi pare di aver perduto l’ultimo amico che avevo al mondo. Davvero, avrei dato tutto quel che possedevo purché non fosse toccata a Bill.» «Dopo tutto» disse Nat «era soltanto un meccanico.» Un giorno, di ritorno dalla pesca, brilli e con calzoni squamosi, e le facce arse dal sole e dal riverbero, e storditi per lo strepito e l’odor del
motore e il movimento a scatti della lancia, trovarono ad attenderli un telegramma dall’ufficio di Benton. MISTERIOSO PANICO TERN STOP SCENDE QUATTRO PUNTI MEZZO STOP TELEGRAFARE ISTRUZIONI «Istruzioni un cavolo» disse Benton, ficcando la sua roba nella valigia. «Andremo su a vedere. Ci starei a noleggiare un aeroplano qui a Miami.» «Tu prendi l’aeroplano» disse Charley senza scomporsi. «Io verrò in treno.» A New York sedeva tutto il giorno nel retro dell’ufficio di Nat Benton, fumando troppi sigari, tenendo d’occhio il segnalatore, stizzito e smanioso; correndo su e giù per la città in tassì, a prendere le informazioni da svariati amici, tutte facce gialle, di Nat e di Moe Frank. Alla fine della settimana aveva perduto quattrocentomila dollari e mollato fin l’ultimo titolo aeronautico da lui posseduto. Per tutto il tempo che stava là seduto dandosi tante arie da finanziere, contava, a quel modo che faceva da ragazzo alla scuola, i minuti che ci volevano perché il mercato chiudesse e poter così finalmente lasciare il centro e ficcarsi in uno spaccio clandestino della Cinquantaduesima, dove lo aspettava una ragazza tinta all’henné, di nome Sally Hogan, conosciuta con Nat al Dover Club. Era stata la sua prima conquista quando era arrivato in città. Non che gli importasse nulla di lei, ma una ragazza o un’altra doveva pure averla. S’eran firmati all’albergo come il signore e la signora Smith. Un mattino che facevano colazione a letto, bussarono discretamente alla porta. «Avanti» gridò Charley, convinto che fosse il cameriere. Due individui male in arnese piombarono nella camera, seguiti da O’Higgins, uno sporco avvocato che lui aveva veduto un paio di volte a Detroit. Sally cacciò uno strillo e si coprì la testa col cuscino. «Salute, Charley» disse O’Higgins. «Sono assai spiacente, ma tutto questo rientra nell’esercizio del mio dovere. Voi non negate di essere Charley Anderson, vero? E così, sarà meglio che ve lo dica io, piuttosto che dobbiate leggerlo in termini legali. La signora Anderson vi muove causa di divorzio nel Michigan… Va bene, ragazzi.» I due frusti individui s’inchinarono docilmente e uscirono
indietreggiando. «Di tutte le porcate più luride…» «La signora Anderson vi ha messo i poliziotti alle calcagna fin da quando licenziaste il suo autista a Jacksonville.» Charley aveva un tale mal di testa che spaccava, e si sentiva talmente debole per la sbronza della sera prima, che non riusciva a levare il capo. Avrebbe voluto alzarsi e stangare quel lavativo di O’Higgins, ma quel che poté non fu altro che starsene a letto e pigliarla come veniva. «Ma non me ne ha mai parlato nelle sue lettere. Ha sempre continuato a scrivermi. Non abbiamo mai litigato noi due.» O’Higgins crollò il capo rosso ricciuto. «Brutta faccenda» disse. «Forse, se vi trovaste con lei, potreste mettervi d’accordo. Il mio parere costante in queste cose è tenerle più che si può fuori del tribunale. Allora, sono proprio desolato, vecchio mio, di aver causato a voi e alla vostra incantevole amica quest’imbarazzo… senza rancore, spero, vecchio Charley… Ho pensato che sarebbe stato più simpatico, più franco, più carte in tavola, se venivo io stesso, se vi si mostrava una faccia amica, per così dire. Sono certo che la faccenda si potrà aggiustare all’amichevole.» Stette là un istante fregandosi le mani e accennando del capo e poi andò in punta di piedi alla porta. Fermandosi con una mano sulla maniglia, sventolò l’altra grossa pala verso il letto. «Addio, allora, Sally… Noi ci vedremo al mio ufficio.» Poi si chiuse dietro pian piano la porta. Sally era saltata via dal letto, e si precipitava alla porta con un viso atterrito. Charley cominciò a ridere nonostante quel mal di capo che spaccava. «Ah, lascia perdere, piccola» le disse. «Mi sta bene, sono proprio stupido… Dobbiamo pure tutti guadagnarci da vivere… Ritorna qui a letto.» 1. Festa americana che cade la prima domenica di settembre. (NdT) 2. Nel testo la freddura è passabile: race significa tanto “corsa”, quanto “razza, genere”. (NdT)
Cine-giornale LX Era di Céline la colpa? Per il giovane Scotty il matrimonio era uno scherzo, una scappata bell’e buona. Ma quando essa cominciò a chieder denaro e tutte le cose stravaganti ch’egli non poteva pagare, si sforzò Céline di venirgli incontro? O non piuttosto fu cieca al significato di questa sacra parola: una moglie? COMPLICE CHE LASCIATO FUORI NELLA SPARTIZIONE DEL BOTTINO RIVELA IL SEGRETO DI UN DELITTO PER RESPINGERE L’APPROVAZIONE DEL TUBO DI GHISA Nella piccola Spagna fu una notte così un senso di speculazione venne incoraggiato all’apertura della settimana dal chiarimento della situazione. L’atmosfera favorevole faceva assai per eliminare quei segni di esitazione ultimamente mostrati da diversi titoli Mi sono innamorato un’altra volta è primavera Il mio cuore beato – chi m’ascolta – è una tastiera IL PRURITO SE NE VA IN UNA NOTTE migliaia di donne prospere e felici cominciarono a guadagnare il doppio e il triplo dei loro salari d’un tempo e talvolta anche più presto Sissignore è il mio bambino sissignore è il mio piccino IL CAPRO ESPIATORIO DEL PROCESSO DELLA SCIMMIA CONFERIRÀ COI PROCURATORI Il misterioso signor Y farà da teste un’incantevole copia in miniatura di un’assolata casetta di campagna sulle rive del Rodano costruita audacemente sulla cresta del Sunset Ridge dominante i più bei laghi del New Jersey dove ogni finestra incornicia un quadro di meravigliosa bellezza
E il mio canto dirà non sarò più il ragazzo che fugge ma il ragazzo che resta e si strugge I VICINI PROIBISCON LE GRIDA NOTTURNE IN UN BAGNO TURCO TUTTA LA POLIZIA MOBILITATA ALLA CACCIA DEL BANDITO COMINCIA LA CAMPAGNA DI STAMPA DELLA CONGOLEUM nella sesta settimana i carri merci hanno superato in questo paese il milione, indicando che la prosperità è generale e che dappertutto si conquistano primati e se ne abbattono Addio a est e addio a ovest Addio a nord e a tutto il resto Salve tesoro!
Margo Dowling Quando Margo ritornò in città dopo la sua primavera a Miami, tutti fecero le meraviglie di come stava bene così abbronzata e con gli occhi azzurri e i capelli chiari sbiancati dal sole della Florida. Ma è un fatto che si trovò senza lavoro. I Mandeville se la passavan male. Frank aveva fatto tre mesi d’ospedale e l’avevano operato asportandogli un rene. Di ritorno a casa, era ancora talmente malato che Agnes abbandonò il suo lavoro per fermarsi a curarlo; lei e Frank s’erano dati alla Scienza 1 e non volevano più saperne del dottore. Non la smettevano di ripetere che ci volevano pensieri sani e che la vita di Frank era stata salvata dalla signorina Jenkins, una medichessa conosciuta da Agnes nella sua sala da tè. Dovevano cinquecento dollari in visite del dottore e in spese d’ospedale, e non la smettevano di parlare di Dio. Fortuna che il signor Anderson, il suo nuovo amico, era una persona assai ricca. Il signor A, come lei lo chiamava, badava a offrirle di mettere su un appartamento in Park Avenue, ma lei rispondeva sempre: «Niente da fare», chi credeva che fosse, una mantenuta? Lo lasciava tentare per lei qualche speculazione in Borsa, e comprarle vestiti e gioielli e portarla a Long Beach e Atlantic City il sabato. Era stato pilota e decorato nella grande guerra, e aveva grossi investimenti in compagnie aeronautiche. Beveva più che non gli facesse bene; era un tipo florido e bovino che mostrava più in là dei suoi anni, grande spaccone, e non facile da prendere quando aveva bevuto, ma era generosissimo e gli piaceva assai ridere e scherzare quando si sentiva a posto. Margo lo giudicava un individuo soddisfacente. «Comunque, cosa vuoi fare, quando uno prende in mano il telefono e ti versa in tasca mille dollari, tutti per te?»: questo diceva ad Agnes quando lei voleva contargliela. «Margie cara, non devi parlare così» diceva Agnes. «Suona così venale.» Agnes parlava, senza mai smettere, dell’amore e dei pensieri veri e che bisogna esser sincere e questi buoni tempi. Margo preferiva assai sentire il signor Anderson vantare i suoi colpi in Borsa e gli apparecchi che aveva disegnati, e come ora intendeva organizzare tutta una rete di aviolinee che avrebbe ridotto
la Pennsylvania Railroad a far la figura di un’interurbana d’autobus. Tutte le sere, Margo doveva sedergli insieme negli spacci clandestini, per il quartiere della Cinquantesima, a bere whisky e ascoltarlo discorrere di quest’affare e di quest’altro e i grossi maneggi di titoli giù in Wall Street, e come stava per servirli, quella banda di Detroit, che volevano mollarlo fuori della Standard Airparts e intorno al suo divorzio e tutto quel che gli costava. Una notte allo Stork Club mentre le faceva vedere i ritratti dei suoi bimbi, ebbe uno schianto e cominciò a singhiozzare. Da poco il tribunale aveva aggiudicato la custodia dei figli alla moglie. Aveva sì, i suoi grattacapi il signor A. Uno dei peggio era una ragazza rossa con la quale l’avevano pescato in un albergo i poliziotti di sua moglie. Costei tutto il tempo gli faceva ricatti, e minacciava una querela per rottura di promessa e di passar tutta la storia alla stampa Hearst. «Oh, che orrore» Agnes ripeteva tutte le volte, quando Margo gliene parlava su una tazza di caffè a pranzo. «Se soltanto quest’uomo avesse i pensieri veri… Bisogna che tu gli parli e che lo convinca a provare… Se soltanto comprendesse, so che tutto andrebbe ben diversamente… Un uomo di successo come lui, dovrebbe esser pieno di pensieri veri.» «Pieno di Canadian Club, 2 è questo il suo male… Dovresti vedere che vita faccio a portarlo a casa, certe sere.» «Tu sei la sola amicizia che gli resti» diceva Agnes, levando gli occhi in su. «È ben nobile da parte tua, che gli stia al fianco.» Margo pagava tutte le note arretrate della casa e aveva aperto un piccolo conto corrente alla Bowery Savings Bank, tanto per essere sul sicuro. S’accorgeva di andare acquistando un discreto senso della Borsa. Pure, si sentiva avvilita a non far nulla e le dava i brividi star sdraiata per la casa i pomeriggi d’estate, quando Agnes leggeva a Frank Scienza e salute a cantilena; e allora cominciò a visitare le sartorie per vedere se trovava da impiegarsi come indossatrice. «Voglio imparare di più, in fatto di vestiti… i miei sembrano sempre fatti di sacchi vecchi» spiegò ad Agnes. «Sei certa che non dispiacerà al signor Anderson?» «Se non gli piace, gli piacerà lo stesso» disse Margo, rigettando indietro il capo.
Nell’autunno l’assunsero finalmente alla nuova sartoria femminile Piquot sulla Cinquantasettesima Strada. Era un lavoro molesto, ma le lasciava libere le sere. Confidò ad Agnes che se mai avesse perduto d’occhio una sera il signor A, una qualche troietta se ne sarebbe impadronita, poco ma sicuro. Agnes era incantata che Margo avesse lasciato il palcoscenico. «Ho sempre avuto l’impressione che fosse indegna di te, quella vita, e ora credo che potrai riuscire davvero uno stimolo di bene per il povero signor Anderson» disse. Ogni volta che Margo raccontava loro di un nuovo salto nel vuoto fatto dal signor Anderson alla Borsa, Agnes e Frank facevano per lui la meditazione. Jules Piquot era un francese di mezz’età, faccia tonda, che camminava curiosamente a traballoni come un’anitra e credeva tutte le ragazze cotte di lui. Mise una grande simpatia a Margo, o forse fu perché scoprì chi sa come che il suo protettore, così lui si espresse, era un milionario. Diceva che lei avrebbe sempre dovuto conservare quella stupenda abbronzatura dorata e la convinse a portare i capelli lisci sul capo invece che a riccioli, come s’era sempre pettinata da quando era stata una ballerina di rivista. «Che giova fare splendidi vestiti per le donne americane, quando ci stanno bianche e rosse come mungessero la vacca?» diceva. «Quanto occorre per rendere interessante un vestito è qui» e si picchiava con un tozzo pugno inanellato sullo sparato di seta pieghettata. «È il dramma… Voi in America non vi curate d’altro che della perfetta quarantina.» «Oh immagino come ci giudicate ordinali» diceva Margo. «Se solamente avessi i capitali» gemeva Piquot, crollando il capo mentre tornava nel suo ufficio del mezzanino, tutto vetro e color guscio d’uovo per via delle suppellettili d’alluminio. «Saprei fare di New York la città più elegante del mondo.» A Margo piaceva pavoneggiarsi nei modelli parigini e nelle raffazzonate creazioni dello stesso Piquot sui profondi tappeti color biacca. Era meglio assai che dimenare il sedere in un corpo di ballo. Non doveva scendere alle sale di mostra che tardi. Le sale di mostra erano calde e immacolate, con un lieve sentore aspro, nell’aria, di nuove stoffe e tinture e naftalina, traversato da una punta di profumate sigarette egiziane. Le indossatrici avevano un gabinetto
dietro, dove si poteva star sedute, legger riviste e chiacchierare di cure di bellezza, di teatro e del campionato di calcio, quando non c’erano clienti. Solamente altre due ragazze c’erano, che venivano regolarmente, e i clienti non abbondavano. Le ragazze dicevano che Piquot stava andando in rovina. Quando si presentarono i modelli dopo Natale, Margo fece venire Agnes il mattino di un lunedì a comprarle tre sbalorditivi vestiti per trenta dollari l’uno; si mise d’accordo con Agnes su ciò che doveva comprare e finse di non conoscerla quando entrò pavoneggiandosi a esporre i nuovi modelli di primavera. Non c’era più dubbio che Piquot stesse andando in rovina. Gli esattori di fatture tempestavano nel piccolo ufficio del mezzanino, il salario di tutti era in arretrato di tre settimane e il faccione a luna di Piquot s’allungava in minuscole rughe cascanti. Margo decise ch’era meglio cominciare a darsi d’attorno per un nuovo posto, tanto più che le sbornie del signor A erano sempre meno facilmente trattabili. Tutte le mattine Margo studiava i listini di Borsa. Non aveva più la fede del passato nei suggerimenti del signor A, ora che una volta aveva comprato Sinclair e aveva dovuto coprire la differenza, lasciandoci la bellezza di trecento dollari. Un certo sabato vi fu grande agitazione nel magazzino di Piquot. Piquot in persona faceva sortite dal suo ufficio, agitando le corte braccia, ora stizzito ora chiocciante e ridente, intento a cacciarsi innanzi le signorine commesse e le indossatrici, come un galletto recente nel pollaio. Qualcuno doveva venire a prendere fotografie per «Vogue». Il fotografo, quando finalmente giunse, era un giovanotto ebreo viso sparuto, dalla pelle floscia e dai cerchi scuri sotto gli occhi. Aveva una vera enorme macchina fotografica e una gran quantità di lampadari a lampo, tutti argentincrespati all’interno, che Piquot non smetteva di raccogliere e tenere in mano in modo assai cauto, lanciando esclamazioni. «Straordinaria invenzione… Non ho mai voluto fotografare prima d’ora perché detesto le esplosioni e poi il pericolo d’incendio.» Era una tiepida giornata di febbraio e nelle sale di mostra, riscaldate a termosifone, si soffocava. Il giovanotto che doveva
prendere le foto era tutto madido di sudore quando usciva da sotto il panno nero. Piquot non lo lasciava un solo istante. Dovette fotografare Piquot nell’ufficio, Piquot al tavolino da disegno, Piquot fra i modelli. Le ragazze credevano che il loro turno non sarebbe più venuto. Il fotografo badava a ripetere: «Lasciatemi fare, signor Piquot… voglio trovare qualcosa d’artistico.» Tutte le ragazze cominciarono a ridere. Alla fine Piquot andò via e si chiuse nel suo ufficio, offeso. Lo vedevano tutti là dentro, attraverso la tramezza di vetro, seduto alla scrivania con la testa fra le mani. In seguito l’ambiente si calmò. Margo e il fotografo s’intesero benissimo insieme. Non smetteva di sussurrarle se non poteva far qualcosa per tener fuori dalle fotografie il vecchio signore. Quando uscì per salire al magazzino sotto i tetti, dove i vestiti si cucivano, il fotografo le tese il suo biglietto chiedendole se non gli avrebbe concesso di farsi fotografare nel suo studio una domenica o l’altra. Per lui avrebbe voluto dir molto e a lei non sarebbe costato nulla. Era convinto che ne avrebbe cavato qualcosa di veramente artistico. Margo prese il biglietto e disse che sarebbe passata il giorno dopo. Sul biglietto era scritto: “Margolies, fotografo d’arte”. Quella domenica il signor A la portò a colazione al Pennsylvania e, dopo, Margo riuscì a farsi condurre in macchina allo studio di Margolies. Immaginò che quel giovanotto non fosse troppo a quattrini e pensò che il signor A avrebbe benissimo potuto pagare una serie di fotografie. Il signor A fu seccatissimo di andarci, perché aveva preso la sua macchina grande e intendeva portar Margo a fare una gita lungo lo Hudson. Comunque, ci andò. Era curioso, lo studio di Margolies. Dappertutto drappeggi di velluto nero e poi paraventi di formato diverso in nero, bianco, giallo, verde, argento, drizzati per tutto quel camerone polveroso, sotto i lucernari sudici. Anche il giovanotto si comportava in modo curioso, come se non li avesse attesi. «Tutto ciò è finito» disse. «Quest’è lo studio di mio fratello Lee. Mi occupo della sua clientela finché lui è all’estero… I miei interessi vanno tutti alla vera arte del futuro.» «Che roba è?» chiese il signor A spuntando di cattivo umore un sigaro, mentre si cercava intorno un posto per sedere. «Il cinematografo. Io sono Sam Margolies… Sentirete parlare
di me, se non avete ancor sentito.» Il signor A sedette scontroso su un polveroso divano da posa in velluto. «Presto, sbrigatevi… La macchina ci aspetta.» Sam Margolies parve contrariato che Margo fosse venuta semplicemente in abito da passeggio. La squadrò a lungo con i suoi petulanti occhi grigi. «Può darsi che non riesca a far nulla… Non so creare quando mi si mette fretta… Vi avevo veduta maestosa in nero, alla spagnola.» Margo si mise a ridere. «Non sono esattamente questo tipo.» «Il tipo di una piccola infanta di Velázquez.» Aveva uno spiccato accento straniero quando parlava con fervore. «Ebbene, una volta sono stata sposata a uno spagnolo… ne ho avuto abbastanza, di grandi di Spagna e tutto il resto, da durarmi per tutta la vita.» «Ci sono ci sono» disse Sam Margolies, passettandole tutt’intorno. «Lo vedo, prima in abito da passeggio e poi…» Si precipitò fuori della camera e fu di ritorno con uno scialle di merletto nero. «Un’infanta della corte della vecchia Spagna.» «Voi non sapete quel che voglia dire averne sposato uno» disse Margo. «E vivere in una casa piena di nobili parenti di quei paesi.» Mentre Sam Margolies la faceva posare in abito da passeggio, il signor A camminava su e giù ciancicando inquieto il sigaro. Doveva essersi fatto nuvolo fuori, perché il lucernario là in alto s’oscurava sempre più. Quando Sam Margolies le diresse addosso i riflettori, il lucernario si fece azzurro, come in scena. Poi quando volle che posasse in scialle spagnolo e le fece togliere l’abito e abbassare le sottovesti, in modo che non le restava altro addosso al disopra della vita che lo scialle, Margo osservò che il sigaro del signor A si era spento e lui la fissava intensamente. Il riverbero del riflettore gli faceva lampeggiare gli occhi. Quando il fotografo ebbe finito, mentre scendevano la scricchiolante scala di legno dello studio, il signor A disse: «Non mi va quel tipo… ha tutta l’aria di un ruffiano». «Oh, no, è solo perché è così artistico» disse Margo. «Quanto ha detto che venivano, le fotografie?» «Care» rispose il signor A.
Nel vestibolo buio che sapeva di cavoli cuocenti chi sa dove l’afferrò a sé e la baciò. Attraverso il vetro della porta d’entrata Margo poté vedere uno svolazzio di neve nella via deserta sotto i lampioni. «Ah vada all’inferno quel tale» disse il signor A, stendendole le dita intorno alla cintola. «Siete una gran bella bambina, sapete? Cristo. Come mi piace questa casa. Mi ricorda i tempi d’una volta.» Margo scosse il capo e batté le palpebre. «Che peccato per la nostra gita» disse. «Nevica.» «Gita un corno» disse il signor A. «Facciamo conto tutti e due di volerci bene, almeno stanotte… Prima di tutto, andiamo al Meadowbroock a bere una volta… Cristo, vorrei avervi conosciuta prima di mettermi nei quattrini, quando stavo anch’io in via le cimici e tutto il resto.» Margo gli abbandonò un istante la testa sul petto. «Charley, siete irresistibile» bisbigliò. Quella sera il signor Anderson riuscì a farle dire che, quando Agnes avrebbe condotto Frank dalla sorella nel New Jersey, come progettava, per tentare se un po’ d’aria di campagna non gli facesse bene, lei sarebbe venuta a convivere con lui. «Se sapeste come ero stufo di questa vita di baldoria continua» le disse. Margo lo fissò dritto negli occhi gonfi turchini. «Credete che a me piaccia, signor A?» Volle assai bene a Charley Anderson quella notte. Dopo quella domenica Sam Margolies telefonò a Margo quasi ogni giorno, in casa e da Piquot, e le mandò fotografie di lei, già montate per appenderle, ma lei non cercò mai di vederlo. Aveva anche troppo da pensare, e perché adesso era rimasta sola nell’appartamento, avendo alla fine Agnes portato Frank in campagna con l’aiuto di una medichessa e di grandi letture di Scienza e salute, e perché c’erano le note da pagare e per via delle quotidiane lettere di Tony, che aveva scovato il suo indirizzo e si diceva malato e supplicava qualche soldo e il permesso di venirla a trovare. Poi, la mattina di un lunedì, arrivò sul tardi da Piquot e trovò l’uscio di legno e una folla di ragazze sbandate e vocianti là innanzi. Il povero Piquot era stato trovato nella sua vasca da bagno ucciso da una dose di cianuro di potassio e non restava più nessuno per pagar loro i salari arretrati.
La morte di Piquot diede a Margo la pelle d’oca e non osava ritornare a casa. Scese da Altman e fece qualche compera e a mezzodì telefonò all’ufficio del signor A per dirgli di Piquot e sentire se non volesse far colazione con lei. Ora che il povero Piquot era morto e l’impiego sfumato, non c’era altro da fare che dar la stoccata al signor A per una somma cumulativa. Due bigliettoni le sarebbero bastati, e poteva levar di pegno il diamante solitario donatole da Tad. E chi sa, se lo pigliava un poco in giro, le avrebbe magari suggerito qualcosa di buono in Borsa. Quando telefonò, le risposero che il signor Anderson non sarebbe stato all’ufficio fino alle tre. Andò allora allo Schrafft e mangiò polpette di pollo, tutta sola, in mezzo a una folla di ridacchianti commesse. Aveva già l’appuntamento col signor A per quella sera in uno spaccio francese della Cinquantaduesima, dove cenavano sovente. Quando Margo tornò dalla pettinatrice che l’aveva lavata e ondulata, era ancora presto per vestirsi, ma cominciò ugualmente ad armeggiar per casa coi vestiti, perché non sapeva che altro fare e tutto era tranquillo e solitario nell’appartamento deserto. Ci mise un tempo lunghissimo a farsi le unghie e poi cominciò a provarsi un abito dopo l’altro. Ricoprì il letto di abiti gettati alla rinfusa. Dappertutto pareva ci fossero macchie. Stava quasi per piangere quando alla fine s’infilò la pelliccia su un abito da sera giallopallido, che veniva da Piquot, ma del cui effetto non era sicura, e scese sul miserevole ascensore nel puzzolente vestibolo della casa. L’inserviente le chiamò un tassì. C’erano colonne bianche nel salone della sontuosa residenza familiare in stile antico, trasformata in ristorante, e un tepido e costoso fulgore rossiccio di lampade velate. Posando il piede sul folto tappeto, Margo si sentì nell’intimità più che non le fosse accaduto in tutta la giornata. Il capocameriere l’accompagnò, inchinandosi, a un tavolino e lei sedette là sorsettando un bicchierino, sentendo che gli uomini della sala la fissavano e ghignando un poco con se stessa, quando le veniva in mente quel che le ragazze di Piquot avrebbero detto di una dama che giungeva prima del tempo all’appuntamento con l’amico. Desiderò che facesse presto ad arrivare, e così potesse raccontargli il fatto e cavarsi di testa l’immagine del povero vecchio Piquot
afflosciato nella vasca da bagno, ucciso dal cianuro. L’aveva tutta sulla punta della lingua, pronta da raccontare. Invece del signor A, ecco che un giovanotto spavaldo dalla lunga testa rossiccia e dalle guance scarne si piegava sul suo tavolino. Margo si drizzò sulla sedia per dargli un’occhiata velenosa, ma invece gli fece un sorriso quando quello si piegò e disse in tono confidenziale: «Signorina Dowling… scusate… sono il segretario del signor Anderson. Ha dovuto saltare in aereo per un affare importante a Detroit. Sapeva che smaniavate d’andare alla prima del Music Box e allora mi ha mandato a prendere i biglietti. Eccoli qua, ho quasi dovuto rompere la testa a un tale per trovarli. Il padrone dice che magari vorrete condurvi la signora Mandeville.» Aveva detto tutto questo in fretta, come avesse paura che lei gli tappasse la bocca; trasse un grande respiro e sorrise. Margo prese i due biglietti verdi e li batté stizzosamente sulla tovaglia. «Che rabbia… Non saprei proprio da chi farmi accompagnare ora, è così tardi. La signora è in campagna.» «Dio mio, che affare… E non sarebbe possibile sostituire il padrone?» «Di sfacciati…» cominciò Margo; poi d’un tratto si trovò a ridere. «Ma non avete l’abito.» «Lasciate fare a me, signorina Dowling… Voi cenate e vedrete che io ritorno in abito da sera e vi porto a teatro.» Alle otto, svelto, eccolo di ritorno coi capelli lustri e vestito di un deteriorato abito nero, troppo corto ai polsi. Mentre salivano in tassì, Margo gli chiese se aveva denudato un cameriere e il giovanotto si cacciò la mano sulla bocca e disse: «Non una parola, signorina Dowling… è in affitto». Negli intervalli le andò additando tutte le celebrità, compreso se stesso. Le disse che si chiamava Clifton Wegman, ma che tutti gli dicevano Cliff, e che aveva ventitré anni e sapeva suonare il mandolino ed era un piccolo demonio in fatto di biliardini da tasca. «Davvero, Cliff, siete un ragazzo che ha dei numeri» gli disse. «Dei numeri buoni?» «Caspita.»
«Un popolare laureato della School of Business di New York… cercasi occasioni.» Se la passarono insieme, come non se l’eran mai passata. Dopo lo spettacolo Cliff disse che lui moriva di fame, perché non aveva cenato, tra la caccia ai biglietti e la divisa e tutto il resto, e Margo lo portò al Dover Club a mangiare un boccone. Niente da dire: appetito ne aveva. Era un piacere vederlo sparecchiare una bistecca coi funghetti. Bevettero qualche bicchierino e risero da staccarsi la testa allo spettacolo in sala; poi, quando Cliff cercò di fare il furbo nel tassì, Margo gli lasciò andare uno schiaffo, ma non troppo secco. Quel tipo sapeva cavarsi con la sua parlantina da qualunque situazione. Quando furono al portone di casa, chiese se poteva salire e Margo, prima di pensare a fermarsi, gli aveva risposto di sì, purché si comportasse da gentiluomo. Cliff disse che ciò non era facile con una ragazza come lei, ma avrebbe provato, e risero e si dibatterono, cosicché davanti alla porta le cadde di mano la chiave. Tutti e due si piegarono a raccoglierla. Quando Margo si rialzò avvampata dal bacio che aveva ricevuto, s’accorse che quell’uomo seduto tutto raggomitolato sulle scale, accanto all’ascensore, era Tony. «Buona notte, allora, Cliff, e grazie per aver voluto accompagnare a casa una povera ragazza» disse Margo gaia. Tony si mise in piedi e venne barcollando verso la porta aperta dell’alloggio. Aveva il viso di un pallore verdastro e gli abiti come se avesse dormito nella mota tutta la notte. «Questo è Tony» disse Margo. «È un… un mio parente… non nel migliore degli stati.» Cliff guardò l’uno e poi l’altra, cacciò un sommesso sibilo e se ne andò giù per le scale. «E adesso, adesso mi dirai perché ti è venuto in mente di gironzare intorno a casa mia… Ho una gran voglia di farti arrestare come ladro.» Tony poteva appena parlare. Aveva il labbro insanguinato e tutto gonfio. «Dove andare?» disse. «Una banda mi ha picchiato.» Ciondolava talmente che Margo dovette afferrare la manica del suo lurido soprabito per impedirgli di cadere. «Oh, Tony,» disse «sei
proprio un letamaio. Entra, su, ma se mi fai ancora uno scherzo come l’ultima volta… giuro davanti a Dio che non ti lascio più un osso intero.» Lo mise a letto. L’indomani mattina Tony stava così male, che si dovette chiamare un dottore. Il dottore disse che soffriva le conseguenze dell’uso di stupefacenti e delle privazioni e consigliò una cura in un sanatorio. Tony stava disteso nel letto, sbiancato e tremante. Pianse come un vitello, ma fu docile assai e diceva che sì, avrebbe fatto tutto quanto voleva il dottore. Un certo momento riuscì a prendere la mano di Margo, e la baciò e la supplicò di perdonarlo perché potesse morire contento, se le aveva rubato il denaro. «Tu non muori, di certo» fece Margo, lisciandogli via dalla fronte gli spessi capelli neri con la mano libera. «Non ho questa fortuna.» Uscì a fare una passeggiata sul corso per cercar di decidere che poteva fare. Il dolcevertiginoso e persistente odore di paraldeide, che il dottore aveva dato come sedativo a Tony, le aveva fatto venire la nausea. Alla fine della settimana quando Charley Anderson ritornò da Detroit e si trovò con lei al solito posto della Cinquantaduesima per cenare, aveva un aspetto preoccupato e sofferente. Margo mise fuori la sua triste storia, ma lui non la prese troppo in buona parte. Disse che era a corto di quattrini, che sua moglie lo aveva vincolato in tutti i modi, che aveva avuto grosse perdite in Borsa; poteva trovarle cinquecento dollari, ma avrebbe dovuto depositare dei valori per farle questo favore. Allora lei disse che, immaginava, sarebbe dovuta ritornare alla sua antica scrittura di danzatrice al Palms di Miami, e lui disse: «Perbacco, se non fate più che attenzione, vengo anch’io a farmi mantenere. Non capisco perché tutti si ficcano in testa ch’io debba essere uno sporco milionario. Tutto quel che cerco è di uscire dalla baracca con abbastanza quattrini per mettermi a posto e lavorare nei motori. Non fosse stato per questo lavativo d’un divorzio, da un pezzo ne sarei fuori. Ma quest’inverno faccio conto di cavarmela e uscire. Tanto non sono che un meccanico senza voce in capitolo». «Voi volete uscire e io voglio rientrare» disse Margo, guardandolo fisso negli occhi. Tutti e due risero insieme. «Via, saliamo in casa vostra, visto che non c’è nessuno. Sono stufo di questi maledetti
locali.» Margo scosse il capo, sempre ridendo. «Formicola di parenti spagnoli» disse. «Non si può.» Ritirarono una valigia all’albergo di lui e filarono a Brooklyn in tassì, a un albergo dove erano ben noti come il signore e la signora Dowling. Lungo la strada nel tassì, Margo riuscì a farsi elevare a mille l’anticipo. L’indomani portò Tony in un sanatorio dei Catskill. Tony fece tutto quel che lei disse, da bravo ragazzo, e parlava di trovarsi un impiego, una volta che uscisse, e accennava all’onore e alla virilità. Di ritorno in città, Margo telefonò all’ufficio e le dissero che il signor A era tornato a Detroit, ma aveva lasciato istruzioni al suo segretario, che le prendesse il biglietto e lo scompartimento e pensasse a ogni cosa per il viaggio a Miami. Margo chiuse l’alloggio, e s’occupò di immagazzinare il mobilio, dell’imballaggio e tutto. Quando si recò al treno, trovò là Cliff che attendeva la sua comparsa, col ghignetto di chi la sa lunga e il cappello sulle ventitré. «Ma è stato davvero gentile» disse Margo appuntandosi alla pelliccia certi mughetti, che Cliff le porgeva, mentre due berretti rossi si precipitavano sulle sue valigie. «Chi è stato gentile?» bisbigliò Cliff. «Il padrone o io?» Nello scompartimento c’erano rose e Cliff aveva provveduto «Theatre» e «Variety» e «Zit’s Weekly» e «Town Topics» e «Shadowland». «Dio mio, quanta roba» disse Margo. Cliff strizzò l’occhio. «Il padrone diceva di farvi partire nel migliore dei modi.» Cavò una bottiglia dalla tasca del soprabito. «È Teacher’s Highland Cream… Be’, tanti saluti.» S’inchinò leggermente e se ne andò per il corridoio. Margo si mise a suo agio nello scompartimento e quasi desiderava che Cliff non se ne fosse andato così in fretta. Avrebbe almeno potuto darle un addio un po’ più lungo. Accidenti, era ben sfacciato, quel ragazzo. Il treno era appena partito, quand’eccolo di ritorno, con le mani nelle tasche dei pantaloni, una faccia ansiosa e masticava gomma a tutt’andare. «Ebbene?» fece Margo accigliandosi «che succede?» «Ho preso il biglietto per Richmond… Viaggio troppo poco… libertà dalle preoccupazioni d’ufficio.»
«Sarete licenziato.» «No-o-o… oggi è sabato. Sarò di ritorno vispo e arzillo lunedì mattina.» «Ma lo verrà a sapere.» Cliff si levò il soprabito, lo ripiegò con cura e lo depose sul portabagagli, poi sedette in faccia a lei e tirò, chiudendo, la porta dello scompartimento. «No, se non glielo dite voi.» Margo fece per alzarsi in piedi. «Questa poi! ce ne sono degli sfacciati.» Cliff continuava sullo stesso tono. «Voi non glielo direte e io non gli dirò… di…» «Ma, idiota che siete, quello era il mio ex marito…» «Ebbene, io voglio diventare il vostro ex amico… No, sul serio, so che vi piacerò… piaccio a tutte.» Si piegò innanzi per prenderle la mano. La sua era diaccia. «No, Margo, sul serio, che differenza c’è dall’altra sera? Nessuno ne saprà nulla. Lasciate fare tutto a me.» A Margo cominciava a scappar da ridere: «Sapete, Cliff, che dovreste avere un cartello?». «Un cartello come?» «Vernice fresca.» 3 Margo si alzò e gli sedette accanto. Nel rumorio tremolante del treno, lo sentì che tremava. «Ma bel signorino,» disse «avete avuto una paura gialla tutto il tempo.» 1. La Scienza Cristiana, specie di setta tra mistica e terapeutica che consiste nel curare le malattie con la Fede, suggestionandosi fino a rifiutare di credere alla loro realtà. (NdT) 2. Sotto regime proibizionista, il Canada era grande fornitore clandestino di liquori agli spacci dell’Unione. (NdT) 3. Fresh, fresco e sfacciato. (NdT)
Cine-giornale LXI In alto in alto su tra le vette dove le nuvole passano al vento genio, fatica, grandi risorse, e il potere e la volontà di giungere a qualcosa di più singolare, qualcosa di più bello, di più affascinante, per il gusto e il giudizio dei meglio intendenti, che non siano le cose che hanno fatto la spiaggia odierna di Coral Gables, e che domani potranno essere migliori, più grandi, più irresistibilmente belle In alto in alto su tra le vette AERONAVE GIGANTE CHE SI SPEZZA IN DUE DURANTE IL VOLO qui giovani e vecchi accorreranno a ricrearsi nella fresca e rinvigorente acqua salsa, o a scambiare pigre chiacchiere nelle logge che sovrastano la piscina scintillante e la notte la voce della musica vi tenterà a passare il tempo in danze Dando la mano al firmamento Sono i Primi Investitori che Profitteranno al Massimo Grado del Vasto e Rapido Rialzo di Valori che Terrà Dietro a un Simile Significativo Sviluppo Cos’è l’oro che ha in bocca e perché par che rida? Donde viene quell’uomo? viene dalla Florida IL TERRENO DI JUPITER VENDUTO PER DIECI MILIONI DI DOLLARI come Aladino con la magica lampada, il Capitalista, l’Investitore e il Costruttore trasformarono ciò ch’era un tempo una palude desolata in meravigliosa città allacciata da una rete di viali sfavillanti Occhi chiusi, occhi chiusi su sveglia c’è il sole nel cielo è mattino ACRI D’ORO PRESSO TAMPA come un magnifico scialle color zaffiro e giada, tempestato di multicolori gemme a miriadi, le colorite acque del basso Atlantico vi gettano un fascino di eterno incanto. Il sito dove la vostra gioia, soddisfazione e felicità future sono
tanto assicurate che volgersi altrove è trascurare la più importante occasione della vostra vita SEGUE LA MOGLIE E SALTA DALLA FINESTRA LOTTA DI ASSASSINI IMPAZZITI DAGLI STUPEFACENTI E Lulù vuol sempre fare tutto quello che le pare Un distaccamento di poliziotti in motocicletta apriva il corteo e sgombrava il passaggio per le colonne biancovestite. Dietro la polizia sbucò A.P. Schneider, il maresciallo in capo. Lo seguivano la banda del signor Sparrow e membri dell’Unione decoratori. Poi venivano gli operatori cinematografici; e i lavoratori del tabacco, i vetrai, i musicanti, e decoratori d’insegne e la confraternita Ferrovieri seguivano per ordine. Gli squartatori chiudevano la fila del primo gruppo. Il secondo gruppo era composto di più di 3500 falegnami. Il terzo gruppo l’apriva la Clown Band e lo formavano elettricisti, fabbri, modellatori, compositori, stampatori, postini, piombatori e manometristi. Il quarto gruppo l’aprivano i siderurgici, muratori, la confraternita Macchinisti, i macchinisti costruttori, l’Unione tipografi, tornitori, tagliatori di lastre, sarti e meccanici Non condurre Lulù ché la porto già io
Charley Anderson «Vedrai, Cliff… Daremo loro una bella stangata» disse Charley al suo segretario, mentre uscivano dall’accalcato ascensore nel vestibolo brulicante del Woolworth Building. «Signorsì» disse Cliff, annuendo giudiziosamente. Aveva un lungo viso dalla pelle sottile, incartapecorita, stirata da sotto lo scuro cappello di feltro sugli zigomi sporgenti e il naso sparuto. La sua bocca priva di labbra non s’apriva mai troppo sulla spessa mandibola. Ripeté nell’angolo della bocca: «Signorsì, brutto scemo… una bella stangata». Uscirono per le porte girevoli in mezzo alla folla delle cinque, che riempiva fino all’orlo i marciapiedi della Lower Broadway, nella pioggerella crepuscolare di una cruda giornata di febbraio. Charley trasse una quantità di gonfie buste dalle tasche del suo impermeabile inglese e le porse a Cliff. «Portale su all’ufficio, e accertati che passino nella cassaforte privata di Nat Benton. Possono andare in banca domani mattina… poi non c’è altro. Fatti vedere alle nove, intesi? Ieri eri un po’ in ritardo… Non ho intenzione di occuparmi di nulla, fino a domani.» «Sissignore, riposatevi con una buona nottata di sonno» disse Cliff e scomparve tra la folla. Charley fermò un tassì di passaggio e si abbandonò sul sedile. Quando faceva quel tempo, gli doleva ancora la gamba. Trangugiò un sospiro; qual era quel numero del diavolo? «Risalite per Park Avenue» gridò all’autista. Non riusciva a ricordare il numero di quel maledetto locale… «Alla Cinquantaduesima Est. Vi mostrerò la casa.» Si riassettò contro i cuscini. «Cristo, sono stanco» bisbigliò tra sé. Seduto là abbandonato, sbatacchiato dagli arresti e dalle riprese del tassì nel traffico, sentiva la cinghia tagliargli il ventre. L’allentò di un foro, stette meglio, si cavò un sigaro dal taschino e lo spuntò con un morso. Ci volle qualche tempo per accendere il sigaro. Ogni volta che aveva pronto il fiammifero, il tassì ripartiva o s’arrestava. Quando l’accese, non vi trovò un gran sapore. «Accidenti, ho fumato troppo oggi… quel che ci vuole è un bicchierino» brontolò a voce alta. Il tassì s’allontanava a scatti dal centro. Di tanto in tanto con la coda dell’occhio Charley sorprendeva sagome grigie d’uomini in altri
tassì o in macchine private. Appena aveva distinto un gruppo di figure, ecco che un altro ne prendeva il posto. In Lafayette Street il traffico era più regolare. L’intero flusso di metallo, vetro, imbottiture, soprabiti, merceria, carne e sangue s’allontanava dal centro. Macchine s’arrestavano, riprendevano, cambiavano velocità, all’unisono come manovrate da un solo impianto di campanelli. Charley sedeva abbandonato, conscio dello strato di grasso sul ventre contro i calzoni, conscio del grasso della guancia contro il colletto rigido. Perché mai non riusciva a ricordarsi quel numero del diavolo? Era da un mese che tutte le sere ci andava. Una venetta nella palpebra sinistra non smetteva di pulsare. «Bonjour, monsieur» disse il portiere in borghese. «Come state, mon capitaine?» disse Freddy, il proprietario dai denti di topo, abbassando la lucida testa nera. «Monsieur pranza con Mademoiselle stasera?» Charley scosse il capo. «C’è un tale che pranza con me alle sette.» «Bien, monsieur.» «Datemi uno scotch con selz mentre aspetto, e ricordatevi che non sia quell’acqua marcia che avete cercato di caricarmi ieri.» Freddy fece uno smunto sorriso. «Fu un errore, signor Anderson. Abbiamo la bottiglia autentica. Vedete il cartellino. È ancor umido di sale.» Charley grugnì e si lasciò cadere in una poltrona nell’angolo della saletta. Tracannò subito un whisky e centellinò poi il selz. «Ehi, Maurice, un altro» gridò al vecchio cameriere svizzero, brizzolato e raggrinzito. «Portamene un altro. Che sia doppio, eh… in un bicchierone grande. Sono stanco stasera.» La golata di whisky gli riscaldò i visceri. Si raddrizzò sulla poltrona. Guardò ghignando il cameriere. «Dunque, Maurice, non mi hai detto quel che te ne pare oggi del mercato.» «Non sono troppo sicuro, signore… Ma, vedete, signor Anderson… Solo che voi voleste, potreste dirmelo.» Charley allungò le gambe e rise. «Dare una bella stangata, eh?… Oh, è un mestiere fetente. Voglio dimenticarlo.» Quando vide Eddy Sawyer che si apriva una strada alla sua volta attraverso le facce, i vestiti ordinari, le mani reggenti bicchieri di
fronte al banco dei cocktail, si sentiva già a posto. Si alzò in piedi. «Come sta il piccolo, Eddy? Come vanno le cose in quella cara vecchia Detroit? Crederanno tutti che sono un bel lavativo, no? Vuotate il sacco, Eddy.» Eddy trasse un sospiro e si sprofondò nella molle poltrona accanto. «Ecco, è una lunga storia, Charley.» «Che ne direste di un Bacardi con una goccia d’assenzio?… Fatto, portane due, Maurice.» Il volto di Eddy era giallo e raggrinzito come una mela d’estate, che sia rimasta troppo tempo sull’albero. Quando sorrideva, rughe anche più profonde gli scattavano dalla bocca e dagli occhi a diffondersi sulle guance. «Vecchio Charley, fa piacere rivedervi… Sapete che vi chiamano il giovane mago della finanza aeronautica?» «È così dunque che mi chiamano?» Charley batté il sigaro spento contro l’orlo d’ottone del portacenere. «Mi è già capitato di sentirne di peggio.» Quand’ebbero passato il terzo cocktail, Charley era in uno stato che non poteva più smettere di parlare. «E allora, potrete giusto dire a J.Y. da parte mia che c’è stato un giorno che avrei potuto mandarlo fuori col fagotto, e che non l’ho fatto. Perché non l’ho fatto? Ma perché non me ne importava un porco diavolo. Io ero padrone dei miei titoli sul serio. Loro avevano impegnato fin la camicia e ancora non arrivavano a coprire, capite… Io pensavo: che diavolo, sono amici miei. Quel buon vecchio di J.Y. Diavolo, dissi a Nat Benton quando lui voleva che facessi piazza pulita, quando ancora sarebbe servito a qualcosa… Sono amici miei. Che ci tengano compagnia. E adesso guardateli che mi danno tutti l’assalto d’accordo con Gladys. Sapete che cifra di alimenti si è fatta aggiudicare Gladys? Quattromila dollari al mese. Il giudice è amico del vecchio… magari spartiscono. Mi hanno tolto i figli… mi han vincolato fin l’ultima miseria che possedevo… È carina, vero, questa di portar via a un uomo i suoi figli? Sentite, Eddy, so che voi non avete avuto mano in questo, ma quando sarete ritornato a Detroit e vedrete quelle sporche carogne che hanno avuto bisogno di ficcarsi dietro le sottane di una donna perché non ce la facevano con me in nessun altro modo… voi gli potrete dire
da parte mia che stavolta ho intenzione di portargli via anche la camicia, dal primo all’ultimo… Comincio proprio adesso a pigliarci la mano. Ho fatto due o tre lanci… il giovane mago, eh?… Ebbene, ditegli che non hanno veduto niente. Loro credono che io non sia altro che uno zuccone di inventore… un meccanico come il povero Bill Cermak… Giuda, mangiamo, su.» Erano seduti al tavolino e il cameriere andava posando antipasti multicolori nel piatto di Charley. «Porta via… Mangio una bistecca, nient’altro.» Eddy stava mangiando svelto. Levò gli occhi verso Charley e il suo volto cominciò a raggrinzirsi in una freddura: «Quest’è un altro caso, mi sembra, di “la donna paga 1 sempre”». Charley non rise. «Gladys non ha mai pagato nulla in vita sua. Voi sapete tanto quanto me che cosa valesse. Tutti questi Wheatley sono spilorci. Lei somiglia al vecchio… E vuol dire che avrò imparato la lezione… Basta con le vacche a quattrini… Ma se la più lurida di quelle del giro non si sarebbe comportata come si è comportata quella vacca… Ebbene, potrete dire a tutti, quando sarete ritornato dai padroni a Detroit… So a che scopo vi hanno mandato qui… A vedere se il giovanotto resiste ancora al bicchiere… Tanto berrà che si ammazzerà, è così che dicono, vero? Ebbene, io ce la faccio ancora a mandarvi sotto il tavolo, vecchio Eddy, sì o no? Ditegli solo questo, Eddy, che il giovanotto è più in gamba che mai, e che s’è fatto assai più furbo… Credevano di averlo seduto per terra con il divorzio, eh? ebbene, dite che stiano a vedere. E dite a Gladys che il primo passo falso che fa… basta uno, che non si metta in mente che non abbia anch’io i miei agenti che le stanno dietro… Ditele che intendo di riprendermi i figli e portarle via fin l’ultimo lurido soldo che ha in mano… E che batta i marciapiedi, non me ne importa un corno.» Eddy gli batteva sulla schiena. «Be’, vecchio mio, io debbo scappare… State certo che mi ha fatto piacere di trovarvi in gamba e con voglia di lavorare.» «E di dare stangate» gridò Charley, scoppiando a ridere. Eddy se n’era andato. Il vecchio Maurice s’ingegnava di fargli mangiare la bistecca che aveva riportato a riscaldare. Charley non riusciva a mandar giù un boccone. «Portala a casa ai tuoi» disse a Maurice. Lo
spaccio s’era fatto deserto per la pausa dell’ora degli spettacoli. «Portami una bottiglia di champagne, Maurice, vecchio mio, e poi forse potrò mandarla giù. È così che fanno a casa vostra, eh? Non dirmi che ho bevuto già troppo… Lo so… Quando fin l’ultimo individuo in cui avevate un po’ di fiducia vi ha fregato in pieno, non vi importa più un corno di niente.» Un tale dai capelli neri tagliati rasi e dai baffi tagliati rasi stava piegato su un bicchierino di cocktail guardando Charley. «Dico che non ve ne importa più niente di niente» urlò Charley a quel tale, quando ne incontrò gli occhi. «A voi no, forse?» «Perdio, no, avete qualcosa da obiettare?» disse l’altro, mettendosi in guardia rivolto al tavolino. «Maurice, porta un bicchiere al signore.» Charley si mise in piedi e barcollò inchinandosi civilmente al disopra del tavolino. Il sorvegliante, che era sbucato da una porticina del retro forbendosi le mani rosse al grembiale, uscì di nuovo indietreggiando. «Anderson mi chiamo… Felicissimo signor…» «Budkiewitz» disse quello dai capelli neri, che avanzava, torvo e barcollando un poco, verso l’altro lato del tavolino. Charley additò una sedia. «Sono ubriaco… beaucoup miscela di champagne… accettate un bicchiere.» «Con piacere se la prendete in questo modo… Sempre meglio bere che fare a pugni… Ai bei tempi della Rainbow Division.» «Siete stato laggiù?» «E già, qua la mano, camerata.» «Quelli eran tempi.» «E adesso uno ritorna e non trova più qui che una banda di carogne bugiarde.» «Gente d’affari… tutte all’inferno… carogne bugiarde dico anch’io.» Il signor Budkiewitz si mise in piedi, nuovamente torvo. «Di che generi d’affari parlate?» «Di affari miei. State tranquillo, camerata.» Il signor Budkiewitz tornò a sedersi. «Giuda, Maurice, tira fuori un’altra bottiglia, e che sia fresca. Mai bevuto quel vino di Saumur, signor Budkibbitzer?»
«Se ho bevuto il Saumur? E perché non dovrei? Ci ho fatto tre mesi d’istruzione.» «Così dicevo tra me. Quel giovanotto è stato in Francia» disse Charley. «Giuraddio, e che lo sappia il mondo.» «Di che cosa vi occupate, signor Buchanan?» «Sono inventore.» «Abitiamo allo stesso piano. Mai sentito dello starter AskewMerritt?» Lui non aveva mai sentito dello starter Askew-Merritt e Charley non aveva mai sentito della lavatrice Autorinse, ma presto si chiamarono Charley e Paul. Paul aveva avuto anche lui dei dispiaceri con la moglie, disse che sarebbe andato in galera prima di pagarle ancora gli alimenti. Charley disse che sarebbe andato in galera anche lui. Andarono invece a un club notturno, dove trovarono due stupende ragazze. Charley raccontava alle stupende ragazze come avrebbe sistemato Paul, il caro vecchio Paul, negli affari, nell’azienda delle lavatrici. Girarono locali in tassì sotto l’aerea con le ragazze. Andarono in un locale del Village. Charley avrebbe trovato a tutte le ragazze, a quelle care ragazze simpatiche, dei posti nel corpo di ballo. Charley spiegava come avrebbe levato fin la camicia a quelle carogne di Detroit. Avrebbe trovato posti alle ragazze nel corpo di ballo, perché potessero levarsi la camicia. Si divertivano un mondo. Nella luce del mattino era seduto solo in un locale dalle tendine strappate. Il caro vecchio Paul era sparito e le ragazze eran sparite, e lui era seduto a un tavolino ricoperto di mozziconi di sigaretta e di vino rosso versato, con gli occhi indolenziti dal fulgore che entrava per le sdruciture della tendina. Non era un albergo né una casa equivoca, era una sorta di tampa coi tavolini e puzzava di vecchio fumo di sigaro, di spaghetti della sera prima, di salsa di pomodoro e di vino rosso. Qualcuno gli dava scrolloni. «Che ora è?» Un grassone e un giovane dai capelli lustri, in maniche di camicia sporche, lo stavano scrollando. «È ora di pagare e andarsene. Ecco il conto.» Un mucchio di roba era scritta su quel cartoncino. Charley ce la
fece a leggere solamente con un occhio alla volta. Il totale erano settantacinque dollari. I due avevano l’aria minacciosa. «Ci avete detto di dare a quelle ragazze venticinque dollari a testa in acconto.» Charley cercò i soldi. Un dollaro, restava. Dove diavolo era andato il portafogli? Quello giovane giocherellava con una mazzetta nera di cuoio, che s’era cavata dalla tasca posteriore. «Un biglietto da cento non sarebbe caro per quel che avete speso, voi, e le ragazze e tutto… L’avete ancora l’orologio, no? Qui non siamo in una trappola.» «Che ora è?» «Che ora è, Joe?» «Bisogna che telefoni all’ufficio. Faccio venire qui il mio segretario.» «Che numero? Come si chiama?» Il giovane lanciò in aria la mazzetta e la riafferrò. «Gli parlo io. Ve la cavate a buon prezzo ancora. Non vogliamo rancori, noi.» Dopo che ebbero telefonato all’ufficio e lasciato detto che il signor Anderson si sentiva male, venissero subito, gli diedero un po’ di caffè con rum che lo fece stare peggio che mai. Alla fine ecco Cliff piegato su di lui, tutto fresco e sbarbato. «Vedi, Cliff, non sono più il bevitore di una volta.» Nel tassì perse conoscenza. Riaprì gli occhi nel suo letto all’albergo. «Ci dovevano essere gocce di narcotico nel caffè» disse a Cliff che sedeva alla finestra leggendo il giornale. «Signor Anderson, ce l’avete proprio fatta bella. È stata una gran fortuna che non sapessero chi avevano preso, in quella trappola. Se l’avessero saputo, ci sarebbe costato dieci bigliettoni a cavarvi fuori.» «Cliff, sei un bravo ragazzo. Questa volta ti aumento lo stipendio.» «Mi sembra di averne già sentito parlare altre volte, signor Anderson.» «Benton è al corrente?» «Qualcosa ho dovuto dirgli. Gli ho raccontato che avevate mangiato del pesce guasto e vi eravate avvelenato di ptomaina.» «Niente male per i tuoi anni. Cristo, penso se è mai possibile che diventi un alcoolizzato… Come vanno le cose in città?»
«A rotoli. Il signor Benton è quasi diventato matto, tanto vi ha cercato al telefono ieri.» «Santo Dio, avevo in testa… Di’ un po’, Cliff, tu non credi che diventerò un alcoolizzato, vero?» «Qui c’è un po’ di medicina che ha lasciato il dottore.» «Che giorno è della settimana?» «Sabato.» «Cristo, credevo fosse venerdì.» Trillò il telefono. Cliff andò a rispondere. «È il massaggiatore.» «Digli di venir su… Di’ un po’, Benton si ferma in città?» «Sicuro che è in città, signor Anderson, e cerca di metter la mano su Merritt per vedere di fermare il massacro… Merritt…» «All’inferno, lo sentirò anche troppo presto. Di’ a questo massaggiatore di entrare.» Dopo il massaggio, che fu uno strazio, specialmente le gaie osservazioni sul tempo e il campionato di hockey pronunciate alla tedesca dal grosso svedese ricciuto che aveva l’aria di un guardaportone, Charley si sentì abbastanza in gambe per andare al gabinetto e rigettare un po’ di bile verde. Poi prese una doccia fredda e ritornò in letto e gridò a Cliff, che dattilografava lettere nel salotto, di suonare al ragazzo che portasse ghiaccio pesto da mettersi in una borsa di gomma sul capo. Si riadagiò sui cuscini e cominciò a sentirsi un poco meglio. «Ehilà, Cliff, che ne diresti di lasciar entrare un po’ di luce? Che ora è?» «Quasi mezzogiorno.» «Cristo… Di’, Cliff, nessuna donna ha telefonato?» Cliff scosse il capo. «Lodato il cielo.» «Ha telefonato un tale che diceva di essere un autista, e che voi gli avevate detto che gli trovavate un posto in una fabbrica d’aeroplani… Gli ho risposto che siete andato a Miami.» Charley cominciava a sentirsi un poco meglio. Stava steso nel morbido e comodo letto sui guanciali croccanti di bucato e girava gli occhi per il lindo stanzone d’albergo. La camera era assai in alto. Luce argentina fluiva dall’ampia finestra. Attraverso l’A delle tendine della finestra, si vedeva un pezzo di cielo smagliante e fioccoso come seta. Charley cominciò a sentire un vago senso di trionfo, come chi supera la fatica di un lungo viaggio o una scalata montana pericolosa.
«Di’, Cliff, che ne diresti di un po’ di gin e amaro con molto ghiaccio?… Credo che ciò mi ridarebbe proprio l’anima.» «Signor Anderson, il dottore ha detto di far solenne giuramento di ripudio e prendere un po’ di quel preparato, ogni volta che vi venisse voglia di bere un bicchiere.» «Ogni volta che ne prendo, questa roba mi fa rigettare. Ma chi crede che sia: una testa di turco?» «Bene dunque, signor Anderson, il padrone siete voi» disse Cliff contraendo la bocca sottile. «Evviva, Cliff… Allora: proverò un po’ di spremuta di pompelmo e se questa mi sta nello stomaco mangio una bella colazione e vadano tutti all’inferno… Com’è che non ci sono i giornali?» «Eccoli, signor Anderson… Sono tutti piegati alla pagina finanziaria.» Charley scorse i listini di Borsa. Gli occhi non gli andavano ancor bene a fuoco. Gli riusciva meglio se ne chiudeva uno. Un paragrafo di “News and Comment” lo fece saltar su, seduto. «Ehilà, Cliff,» esclamò «hai visto qua?» «Certo» disse Cliff. «Lo dicevo che le cose andavano male.» «Ma se continuano così, significa che Merritt e Farrell hanno le procure, poco ma sicuro.» Cliff annuì giudiziosamente con la testa un po’ ripiegata da una parte. «Dove diavolo è Benton?» «Ha telefonato ora, signor Anderson, attraversa la città per venire da noi.» «Avanti, dammi quella bibita, prima che arrivi, e poi metti via tutte le medicine e ordina la colazione.» Benton entrò nella camera dietro al vassoio della colazione. Indossava un abito marrone e la bombetta. Aveva una faccia che pareva un vecchio asciugapiatti, a onta del vestito elegante. Charley parlò per il primo: «Ehi, Benton, sono dunque col culo per terra?» Benton adagio e con cura si tolse i guanti, il cappello e il soprabito e li depose sul tavolo di mogano presso la finestra. «Imbottito lo è, il marciapiede» disse. «Va benissimo, Cliff… Sarà meglio che finisci quella corrispondenza.» Cliff si chiuse discretamente alle spalle la porta. «Ce
l’ha fatta Merritt?» «Lui e Farrell battono insieme. Non ti resta altro che riconoscere la batosta e prepararti a un’altra mano.» «Porco mondo, Benton…» Benton si levò in piedi e camminò su e giù per la camera, ai piedi del letto. «Inutile bestemmiare con me… Sono io oggi che ho da bestemmiare. Che te ne pare di uno che va a fare baldoria in un momento critico com’era questo? Un tradimento, lo chiamo… Hai quello che ti meriti… e ho avuto il mio daffare anch’io a salvar la mia pelle, sta’ certo. Ascolta, io ti ho messo l’occhio addosso come uno che aveva dell’avvenire, Anderson, e sono ancora persuaso che se sai dare un taglio alle pazzie potrai entro dieci anni farti una fortuna sul serio. E adesso, sta’ a sentire una cosa, giovanotto: sei ormai arrivato al punto massimo a cui potevi col tuo stato di servizio di guerra, e sta’ tranquillo che sei andato ben più avanti di tanti. Quanto a questa trovata dell’invenzione… sai bene quanto me che non può rendere un soldo a chi non ha il genio organizzativo necessario. Hai avuto un gran successo iniziale e ti sei messo in testa di fare il giovane mago e di poter far accettare qualunque sciocchezza ti venisse in mente.» «Ehilà, Nat, non crederai mica che sia tanto stupido da non saperlo?… Questo lurido divorzio e stare tanto tempo all’ospedale, mi ha cambiato, non so come, ecco.» «Scuse.» «Che cosa dovrei fare, secondo te?» «Dovresti andartene per un po’ da questa città… Non ci staresti a metterti con tuo fratello nel Minnesota?» «Ritornare al paesello e vendere macinini… è un avvenire straordinario.» «Dove credi che li abbia fatti i quattrini Henry Ford?» «So, so. Però tiene in bolletta i venditori… Quel che mi occorre è di rimettermi in forma fisicamente. La Florida è un posto dove sto bene. Potrei andar là e distendermi al sole per un mese.» «D’accordo, purché ti guardi da quelle speculazioni sui terreni.» «Certo, Nat, non giocherò nemmeno a poker… Vado laggiù a riposarmi. A rimettermi sul serio la gamba in forma. Poi, quando ritorno, ne vedremo delle belle. Dopo tutto ci sono ancora quei titoli
dell’Airparts.» «Non sono più quotati.» «Perbacco.» «Be’, ottimista, mia moglie mi aspetta a pranzo… Fa’ buon viaggio.» Benton se ne andò. «Ehi, Cliff» gridò Charley attraverso la porta. «Di’ che vengano a portar via questo maledetto vassoio. Non è andata troppo bene. E telefona a Parker di preparare la macchina. Attenzione che gli pneumatici siano in regola. Parto lunedì per la Florida.» In un attimo Cliff cacciò la testa alla porta. Era rosso in faccia. «Avete… avrete bisogno della mia presenza laggiù, signore?» «No, avrò bisogno che resti qui a tener d’occhio quei ragazzi… Mi occorre qui qualcuno di fiducia… Ma ti dirò quello che dovrai fare prima… andare a Trenton e accompagnare la signorina Dowling fino a Norfolk. Io la raccoglierò là. Adesso è a Trenton in visita dai suoi. Le è morto il vecchio, o non so che cosa. Potrai sbrigarla senz’altro questa faccenda, no? Sarà per te un bel viaggetto.» Charley fissava Cliff in faccia. Cliff raggrinzò anche più la bocca da un lato e s’inchinò come un maggiordomo. «Bene, signore» disse. Charley tornò ad adagiarsi sui cuscini. La testa gli pulsava, lo stomaco era come aggruppato in nodi. Se chiudeva gli occhi, rossi splendori turbinosi gli sbocciavano davanti. Cominciò a pensare a Jim e come Jim non gli avesse mai liquidato la sua parte dei quattrini della vecchia da lui messi nell’azienda. Però Jim non ce l’aveva un apparecchio, due auto, un appartamento al Biltmore e un segretario pronto ad andare in capo al mondo per lui, e una ragazza come Margo. Cercò di ricordarsi com’era la faccia di lei, quel comico stupore con cui spalancava gli occhi quando stava per dire qualcosa di buffo. Non riuscì a ricordarsi un accidente, solamente quel senso di sofferenza in tutto il corpo e i globi rossi che gli sbocciavano davanti. Poco dopo prese sonno. Era ancora talmente malfermo quando partì per il Sud, che prese con sé Parker per guidare. Sedeva cupo nel nuovo soprabito di pelo di cammello, con le mani penzolanti tra le ginocchia, sbarrando gli occhi innanzi a sé nel vuoto rimbombante della Holland Tunnel, pensando a
Margo, a Bill Edwards l’avvocato brevetti che doveva incontrare a Washington per il processo, ricordando le parcelle nel cassetto di Cliff e chiedendosi dove diavolo avrebbe preso i soldi per sostenere il processo di brevetto contro Askew-Merritt. Aveva un mille dollari in biglietti in tasca e ciò ad ogni modo gli faceva buon sangue. Cristo, gran cosa i quattrini, si disse. Uscirono dalla galleria nel mattino grigiopioggia e nel rombo e nel frastuono degli autocarri di Jersey City. Poi il traffico si rarefece a poco a poco ed ora filavano attraverso le piatte campagne del New Jersey paglierine e rossastre per via dell’inverno. A Filadelfia Charley si fece portare da Parker in Broad Street. «Non ho la pazienza di continuare, prenderò il treno del pomeriggio. Vieni al Waldman Park, quando ci sei.» Fissò uno scompartimento nella vettura diurna e andò a coricarcisi cercando di dormire. Il treno strepitava e rimbombava talmente, e il cielo grigio, i campi lavanda, i pascoli gialli e i rametti degli alberi che cominciavano a brillare rossi e verdi e giallopallidi in un anticipo di primavera lo fecero sentirsi così disperato, così voglioso di urlare come un cane, che ne ebbe abbastanza di stare ingabbiato in quel maledetto scompartimento e ritornò alla vettura comune per fumare un sigaro. Stava abbandonato sul sedile di cuoio, brancicandosi nel taschino del panciotto a cercare il tagliasigari, quando il passeggero corpulento del posto accanto levò gli occhi da un involto turchino di carte legali che stava esaminando. Charley guardò gli occhi neri, il glabro volto azzurrastro e la testa calva ancor decentemente impiastrata di una chiazza di capelli neri simili a un’ala d’uccello, senza riconoscerlo subito. «Dunque, Charley, giovanotto, mi fa l’effetto che siate innamorato.» Charley si raddrizzò e tese la mano. «Come va, senatore?» disse, balbettando un poco come faceva ai tempi d’una volta. «Andate alla capitale?» «Tale è il mio triste destino.» Gli occhi del senatore Planet lo frugarono dalla testa ai piedi. «Charley, ho sentito che avete avuto un accidente.» «Ne ho avuto tutta una serie» disse Charley, diventando rosso. Il
senatore Planet scosse il capo in segno di comprensione e fece uno schiocco con la lingua. «Che roba… che roba… Caro mio, parecchia acqua è passata sotto i ponti dal tempo che voi e il giovane Merritt avete pranzato con me quella sera a Washington… Non c’è nessuno tra noi che ringiovanisca.» Charley ebbe la sensazione che gli occhi neri del senatore ritraessero un notevole piacere dall’esplorare le linee flaccide dove il suo collo incontrava il colletto e il rigonfiamento del ventre sotto il panciotto. «Non c’è nessuno tra noi che ringiovanisca» ripeté il senatore. «Voi ringiovanite, senatore. Potrei giurare che sembrate più giovane adesso che non l’ultima volta che vi ho veduto.» Il senatore sorrise. «Vedete, spero che vorrete perdonarmi se ne parlo… ma la vostra è stata una delle carriere più sensazionali cui io abbia avuto la fortuna di assistere in tanti anni di vita pubblica.» «È una nuova industria, ecco. Tutto si svolge in fretta.» «Incomparabile» disse il senatore. «Viviamo in un’epoca di progresso incomparabile… dappertutto tranne che a Washington… Dovreste scendere al nostro pacifico villaggetto un po’ più sovente… Avete molti amici laggiù. Leggo sui giornali, come diceva il signor Dooley, che c’è stata una certa riorganizzazione a Detroit. Occorreva una più ampia base, immagino.» «Molti li hanno buttati fuori a picchiare della loro base per terra» disse Charley. Credette che il senatore non avrebbe più cessato di ridere. Il senatore tirò fuori un gran fazzoletto di seta con iniziali, per asciugarsi le lacrime dagli occhi, e lasciò cadere la stia manuccia grassa sul ginocchio di Charley. «Dio del Cielo, dobbiamo berci sopra.» Il senatore ordinò whiterock all’inserviente e con aria misteriosa vi cacciò un paio di cariche di ottimo rye whisky, dalla bottiglia che aveva nella lunga valigia. Charley cominciò a star meglio. Il senatore diceva ora che ci si doveva aspettare sviluppi assai interessanti dallo sviluppo delle aviolinee. Il bisogno di sovvenzionamenti era ammesso ormai da tutti, se questa grande nazione doveva pure mettersi al passo in fatto di trasporti aerei. La questione – si sa – sarebbe stata quale delle tante ditte concorrenti godeva la fiducia dell’amministrazione. C’era più avvenire nelle aviolinee che non ce ne
fosse mai stata nelle forniture e vettovagliamenti navali. «Una questione di fiducia da parte dell’amministrazione, giovanotto.» Alla parola fiducia gli occhi neri del senatore Planet rilucevano. «Ecco perché, giovanotto, sono lieto di vedervi qui. Tenetevi vicino al nostro villaggio sul Potomac, giovanotto.» «Perbacco» disse Charley. «Quando sarete a Miami, cercate del mio vecchio amico Homer Cassidy… Ha un bellissimo battello… vi porterà in mare alla pesca… Gli scriverò, Charley. Se potessi strapparmi di qui, chi sa che anch’io il mese prossimo non passi una settimana laggiù. Proprio adesso si stan guadagnando quattrini a palate laggiù.» «State sicuro, senatore, ben gentile da parte vostra, senatore.» Quando arrivarono alla Union Station, Charley e il senatore parlavan grosso. Discorrevano di tronchi e connessioni, aeroporti e beni immobili. Charley non riusciva a capire se era lui che prendeva al suo servizio il senatore Planet per averne la protezione o se il senatore Planet prendeva a servizio lui. Si lasciarono quasi affettuosamente al posteggio dei tassì. L’indomani, nel pomeriggio, si mise in macchina attraverso la Virginia. Era una piacevole giornata di sole. I siliquastri cominciavano a mostrarsi rossi sulle coste riparate dei colli. Aveva due bottiglie di quell’ottimo rye whisky che il senatore Planet gli aveva mandato all’albergo. Mentre guidava, cominciò a sentir malumore contro l’autista, Parker. Quella carogna non faceva altro che intascare somme sui pezzi di ricambio, sulla benzina e sull’olio. Ecco che aveva messo in nota otto pneumatici nuovi, il mese scorso; che cosa diavolo faceva degli pneumatici, li mangiava? Quando traversarono il ponte a pedaggio entrando in Norfolk, Charley era più inviperito che mai. Dovette contenersi per non perder le staffe e menare a quella carogna una botta sulla smorta mascella di quella glabra faccia da lacchè. Davanti all’albergo sbottò. «Parker, siete licenziato. Ecco qua il vostro mese e il biglietto di ritorno a New York. Ma se vi vedo in giro per la città domani, vi faccio metter dentro per furto. Sapete bene quel che voglio dire: come lo so io. Autisti del boia, vi credete d’esser tanto furbi. Tutto il trucco io lo
conosco, capito?… Io lavoro per i soldi che spendo, tanto quanto voi. E per provarvelo d’ora innanzi guiderò io.» Odiò il glabro viso immobile di quell’altro. «Benissimo, signore» disse Parker freddamente. «Debbo restituire l’uniforme?» «Tenetevi l’uniforme e ficcatevela…» Charley s’arrestò. Stava pestando i piedi, rosso in faccia sul lastricato all’ingresso dell’albergo tra una corona di sghignazzanti inservienti negri. «Ehi, ragazzo, porta dentro questo bagaglio e fa’ condurre l’auto alla rimessa… Bene, Parker, avete le mie istruzioni.» Entrò a gran passi nell’albergo e ordinò il più grande appartamento doppio che avessero. Firmò il suo nome vero. «La signora Anderson sarà qui presto.» Poi telefonò agli altri alberghi per scoprire dove diavolo era Margo. «Ciao, bella» disse quando finalmente sentì la sua voce all’altro capo del filo. «Vieni, su. Sei la signora Anderson e nessuna domanda. Oh, che vadano al diavolo: nessuno mi detterà quel che debbo fare, chi vedere e come disporre dei miei quattrini. Ne ho abbastanza di questa storia… Vieni subito. Sono pazzo dalla voglia di vederti…» Quando Margo entrò seguita dall’inserviente con le valigie, aveva certo un’aria più adorabile che mai. «Ma, Charley,» disse quando l’inserviente se ne fu andato «quest’è la crème de la crème… Devi aver trovato petrolio.» Girò correndo tutte le camere, ritornò e gli si raggomitolò sul petto. «Chi sa che strage hai fatto in Borsa.» «Hanno cercato di farmela, ma non attacca. Nessuno la fa a me… Beviamo un bicchierino, Margo… Sbronziamoci un pochetto, prima, Margo… Perdio, avevo paura che non venissi.» Margo si rifaceva il viso allo specchio. «Io? Io non sono che la prima venuta» disse con quel rauco tono sommesso che a Charley metteva un brivido giù per la spina dorsale. «E di’ un po’, dov’è Cliff?» «Il giovane amico dalla faccia affilata che fu tanto gentile da accompagnarmi all’incontro col mio signore e padrone? Se n’è partito col treno delle sei.» «Ma chi gliel’ha detto? Avevo delle istruzioni da dargli.»
«Ha detto che hai detto “trovarsi all’ufficio martedì mattina” e lui ci si sarebbe trovato a costo di mettersi a volare. Davvero, Charley, se quello è un campione dei tuoi impiegati, devono tutti baciare il terreno dove tu passi. Non la smetteva più di descrivermi che gran tipo tu sei.» «Sì, sanno che sono a posto, che vengo dalla gavetta… e capisco il loro punto di vista. Non è da molto che lavoravo anch’io a un tornio.» Charley si sentiva bene. Versò per tutti e due un altro bicchiere. Margo prese quello di Charley e riversò metà del rye nella bottiglia. «Non vogliate sbronzarvi troppetto, signor A» disse con quella nuova voce sommessa e carezzevole. Charley la strinse a sé e la baciò stretto sulla bocca. «Perdio, se sapessi davvero come ho sempre desiderato di avere una vera donna bella tutta per me. Mi sono capitate certe vacche… Gladys, sapessi che vacca era. È stata sul punto di rovinarmi… ha cercato di portarmi via fin l’ultimo centesimo che avevo in mano… mi è saltata addosso con certi… io li credevo amici miei… Ma ascoltami bene, piccola. Gliela farò vedere a tutti. Fra cinque anni mi verranno tutti ai piedi, strisciando sul ventre. Non so cosa sia, ma ho come un senso speciale dove ci siano molti quattrini… Nat Benton dice che l’ho… so di averlo. Con una semplice trovata io vado lontano, vedi. Quelle carogne avevan tutti del denaro per cominciare.» Dopo che ebbero ordinato la cena e mentre prendevano un ultimo bicchierino soltanto, attendendo, Margo tirò fuori qualche biglietto che teneva nella borsetta. «Sta’ tranquilla, li investirò subito.» Charley se li ficcò in tasca senza guardarli. «Vedete, signor A, non avrei bisogno di darvi noia per queste sciocchezze se avessi un conto a mio nome.» «Che ne dici di dieci bigliettoni nella First National Bank, appena arrivati a Miami?» «Fa’ tu, Charley… Io non ho mai capito niente di affari più in là del mio salario settimanale, lo sai. Una vera ballerina non capisce altro. Mi ha lasciato in bolletta, sistemare i miei vecchi a Trenton. Davvero costa dei soldi morire, in questo paese di Dio.» Gli occhi di Charley si empirono di lacrime. «Era il tuo babbo, Margery?»
Margo fece una smorfietta. «Oh no. Il vecchio è morto di una bicchierite acuta, quand’ero ancora una mocciosa coi capelli giù dalle spalle… Quest’era il secondo marito della mia matrigna. Io voglio bene alla matrigna, incredibile ma vero… È stata la sola amica che ho avuto al mondo. Un giorno o l’altro ti dirò. È una vera storia.» «Quanto ti è costato? Ci penserò io.» Margo scosse il capo. «Non son mai stata tipo da caricare i miei parenti sulle spalle di nessuno» disse. Quando il cameriere entrò con un vassoio pieno di grossi piatti d’argento, seguito da un altro cameriere che spingeva una tavola già apparecchiata, Margo si staccò da Charley. «Così, questa è la vita» sussurrò in un modo che lo fece ridere. Il resto del viaggio fu come al circo. Il tempo era bello. Inoltrandosi nel Sud, cominciava ad apparire una verde nuvola di primavera sui boschi. C’eran fiori nei sabbioni delle pinete. Cantavano uccelli. L’auto filava come un sogno. Charley la teneva a sessanta sulle strade asfaltate, guidando attento, godendosi la guida, gli ottimi freni a quattro ruote, lo scorrevole ronzio del motore sotto il cofano. Margo era una ragazza straordinaria, gli voleva un bene pazzo e diceva continuamente freddure. Bevettero quanto occorreva per farsi buon sangue. Arrivarono a Savannah a tarda notte e s’erano fatti così buon sangue che si sbronzarono al punto che il direttore minacciò di cacciarli fuori del grande albergo antico. Fu allora che Margo tirò un portacenere per la finestra a traversa. Erano troppo bevuti per divertirsi abbastanza in letto, quella notte, e si risvegliarono con la bocca che sapeva di rame e una testa da non si dire. Margo era terrea, verde, la pelle sotto gli occhi cascante, prima che prendesse il bagno. Charley le preparò un’ostrica di prateria a colazione, come diceva che facevano gli aviatori inglesi laggiù, e Margo la rigettò senza nemmeno romperne il tuorlo. Lo chiamò che venisse a vederlo nel gabinetto, prima di tirar l’acqua. Ecco là il tuorlo crudo che li fissava, come fosse uscito allora dal guscio. Non poterono tenersi dal ridere nonostante il mal di capo. Eran le undici quando partirono. Charley guidava senza pigliarsela calda, giù per la strada serpeggiante attraverso la regione
boscosa della Georgia meridionale, tagliata da bracci d’acqua e marcite marine, dalle quali s’innalzavano a volo le gru e una volta uno stormo candido di aironi. Si sentivano piuttosto malconci, quando furono a Jacksonville. Nessuno dei due riuscì a mangiar altro che una costoletta d’agnello innaffiata con un certo gin schifoso che pagarono in ragione di otto dollari al quart all’inserviente negro, che pretendeva fosse il miglior gin inglese arrivato la sera prima da Nassau. Bevettero il gin con amari e andarono a letto. Per il resto del viaggio da Jax e Miami, il sole fu davvero scottante. Charley voleva a tutti i costi abbassare il mantice per avere aria a sazietà, ma Margo non volle nemmeno sentire. A questo proposito lo fece ridere. «Una ragazza può sacrificare ogni cosa per un uomo, ma non la carnagione.» Non riuscirono a mangiare per tutta la strada, benché Charley continuasse a riempirsi di quel gin. Quando arrivarono a Miami, andarono difilato al vecchio Palms, dove Margo aveva lavorato, e ottennero una grande ovazione da Joe Kantor e Eddy Palerm e dai ragazzi dell’orchestra. Tutti dicevano che aveva l’aria di una luna di miele e scherzavano e volevano vedere la licenza. «È soltanto una conoscenza casuale… uno che ho raccolto alla stazione di Jax» badava a ripetere Margo. Charley ordinò il miglior pranzo che ci fosse all’albergo e da bere per tutti e champagne. Ballarono tutta la sera, nonostante la sua gamba gigia. Quando perse conoscenza, lo portarono disopra nella camera di Joe e della signora Kantor. Quando cominciò a svegliarsi, Margo stava seduta tutta vestita, fresca come una rosa, sulla sponda del letto. Era tardo mattino. Gli portò la colazione lei stessa su un vassoio. «Statemi bene a sentire, signor A» gli disse. «Siete venuto quaggiù per riposarvi. Più niente vita notturna per un po’. Ho affittato per noi una villetta sulla spiaggia, vi collocheremo all’albergo per evitare ogni scandalo e vedrete che vi piacerà. Quel che ci occorre è l’atmosfera della casa… Voi ed io, signor A, abbiamo sempre girato sul carro.» La villetta era in stile missione spagnola, e veniva a costare un occhio, ma è un fatto che se la passavano bene alla spiaggia di Miami. Giocavano alle corse canine e alla roulette e Charley entrò con un gruppo di giocatori di poker notturni, attraverso Homer Cassidy,
l’amico del senatore Planet, un grosso, sorridente, raffinato e canuto meridionale, in uno sformato abito di lino, che venne a cercarlo all’albergo. Dopo un sacco di chiacchiere su questo e quello, Cassidy giunse finalmente al fatto, che lui stava comprando opzioni di terreno per il nuovo aeroporto e ne avrebbe fatto parte a Charley per amore delle sue conoscenze, ma ci volevano pronti contanti. A poker Charley aveva gran fortuna, guadagnava sempre tanto da avere in tasca un grosso rotolo di biglietti, ma il suo conto in banca era tutt’altro paio di maniche. Cominciò a tempestare di telegrammi l’ufficio di Nat Benton a New York. Margo si provava a farlo smettere di bere; le sole volte che Charley poteva davvero bagnarsi il becco era quando usciva a pescare con Cassidy. Margo a pescare non veniva, diceva che non le piaceva il modo come i pesci la guardavano quando uscivano dall’acqua. Un giorno Charley era sceso all’imbarco per andare alla pesca con Cassidy, ma trovò che l’aquilone levatosi in mattinata spirava troppo gagliardo. E fu una gran fortuna, perché proprio mentre Charley lasciava l’imbarco un fattorino della Western Union arrivò in bicicletta. Il vento si faceva più violento di minuto in minuto e gettava il polverone freddo in faccia a Charley, che leggeva il telegramma. Era da parte del senatore: AMMINISTRAZIONE PREPARA BIADA PER PEGASO. Appena fu di ritorno alla spiaggia, Charley parlò con Benton sull’interurbana. L’indomani i titoli aeronautici ebbero un sussulto, quando giunse sui fili la notizia che si presentava un progetto di finanziamento delle aviolinee. Charley vendette al massimo tutto quel che aveva, coprì le sue differenze e se la dormiva tra due cuscini quando i giornali del pomeriggio sgonfiarono la storia. Otto giorni dopo, ricominciò a comprare a venti punti di ribasso. Comunque, avrebbe avuto i contanti per riempire i suoi prestiti e mettersi con Cassidy nelle opzioni. Quando disse a Cassidy che era disposto a mettersi con lui, uscirono al largo sul battello per discutere la cosa. Un cameriere negro preparava loro poncini alla menta. Sedettero a poppa, con le loro lenze e i gran cappelli di paglia per riparare gli occhi dal sole e i poncini su un tavolino alle loro spalle. Quando furono al confine dell’acqua azzurra, cominciarono ad
annaspare le lenze in cerca di palombi. Era una giornata di cielo azzurro con grosse, molli, biancorosee nubi, color lavanda sotto, che si muovevano nel sole. C’era abbastanza vento spirante al largo contro la direzione della corrente del Golfo perché certe onde irte e tagliuzzate si facessero verdi rompendosi e azzurre e purpuree negli avvallamenti. Seguirono le lunghe strisce d’alga color senape, ma non avvistarono nessun palombo. Cassidy prese un delfino e Charley ne lasciò fuggire uno. Il battello beccheggiava talmente che Charley non poteva smettere di trangugiare poncini se voleva tenersi a posto lo stomaco. Quasi tutta la mattinata incrociarono avanti e indietro di fronte alla foce del Miami River. Di là dall’erte onde scure potevano scorgere la tranquilla acqua bruna e assolata della baia e contro l’orizzonte i nuovi edifici che smagliavano candidi fra un rosso ordito di travature da costruzione. «Edilizia, è questo che mi piace guardare» diceva Homer Cassidy, agitando verso la città una mano venata che portava un grosso e antico anello d’oro con sigillo. «E comincia solo ora… Giovanotto, io mi ricordo quando Miami era un salto nel mare, una scarsa raccolta di baracche cadenti, tra la ferrata e il fiume, e vi so dire che le zanzare mangiavan vivi. C’era un certo numero di disgraziati quaggiù che coltivavan pomodori e stavano a letto metà del tempo coi brividi e con la febbre… e adesso date un’occhiata… pensare che a New York cercano di farci credere che questo rialzo non è serio.» Charley annuì senza parlare. Lottava con un pesce alla sua lenza. Diventava rosso in faccia e s’ingranchiva la mano ad annaspare. «Non è altro che un piccolo bonito» disse Cassidy. «Il modo come cercano di farvi credere che la pesca non val nulla… È tutta propaganda per la Costa Occidentale… Giovanotto, debbo ammettere che mi sono accorto che i tempi venivano, tanti anni fa, quando lavoravo col vecchio Flagler. Quello era un uomo che prevedeva. Ho viaggiato con lui sul primo treno che ha traversato il prolungamento transmarino di Key West… Ero un legale della ferrovia, allora. Le scolaresche gli buttarono le rose sotto i piedi per tutta la strada dalla sua macchina privata alla vettura… Ne abbiamo avuto quasi un migliaio spezzati dagli uragani prima che la linea fosse terminata… e ora la nuova
Miami… e Miami Beach, che ve ne pare di Miami Beach? È il sogno di Flagler fatto realtà.» «Ecco, quel che mi piacerebbe fare» cominciò Charley e si fermò per dare una tracannata al nuovo poncino che il cameriere gli porgeva in quel momento. Cominciava a sentirsi a meraviglia, ora che quell’ombra di mal di mare l’aveva lasciato. Il pescatore che faceva loro da guida s’era portato a prua la lenza di Charley per adattarvi un nuovo amo, e così Charley stava là seduto in poppa al battello, sentendosi il sole mordere la schiena e spruzzetti di schiuma salsa asciugare in faccia, senza nulla da fare che centellinare il poncino, senza nulla da pensare. «Cassidy, questa è vita davvero… perché un disgraziato non può scegliersi la vita che vuole? Stavo proprio per dire che il mio desiderio è di cavarmi da questa mischia… gli investimenti, tutto questo rischio… A me piacerebbe uscirmene con un gruzzoletto e trovarmi una casa e mettermi a pasticciare nei motori, e disegnare apparecchi, cose del genere… Ho sempre avuto in mente che, se riuscivo ad andarmene con abbastanza quattrini, avrei voluto costruirmi una galleria a vento di mia invenzione… sapete, è dove si provano i modelli d’aeroplano.» «Va da sé» disse Cassidy «che sarà l’aviazione a fare Miami… Ma pensate, diciotto, quattordici, dieci ore da New York… Non c’è bisogno di dirvi… voi, io e il senatore… noi entriamo nel numero dei padri fondatori con quell’aeroporto… Giovanotto, è tutta la vita che aspetto per fare un colpo sul serio. Per tutta la vita ho fatto il comodo degli altri… nel tribunale, legale delle ferrovie, e via dicendo… Mi sembra adesso che sia l’ora di farmi un gruzzolo mio.» «E se poi scelgono qualche altro posto? noi allora restiamo come tanti salami. Dopo tutto, è già capitato altre volte» disse Charley. «Ragazzo mio, non possono farlo. Sapete anche voi che quella è la posizione ideale e poi… Non dovrei dirvi queste cose, ma, tanto, presto ve ne sareste accorto voi stesso… dunque, conoscete il nostro amico di Washington, ebbene, quello è uno degli uomini più lungimiranti d’America… I denari che ho investito non vengono dal capitale di Homer Cassidy, perché Homer Cassidy non ha un soldo. È questo che mi guasta il sangue anche adesso. Io sono semplicemente il
suo agente. E in tutti gli anni che ho lavorato col senatore Planet, posso giurare sull’anima mia che non l’ho mai veduto investire un quattrino quando l’affare non fosse sicuro.» Charley cominciò a ghignare. «Guarda, quel vecchio lavativo.» Cassidy rideva. «Sapete quel detto: a buon intenditore… Che ne direste di un buon panino con prosciutto di Virginia?» Bevettero un altro bicchiere sui panini. Charley cominciò a sentirsi voglia di parlare. Era una gran giornata. Cassidy era straordinario. Se la passava divinamente. «Curioso,» disse Charley «la prima volta che ho visto Miami è stato dal largo come ora. Non mi sarei mai immaginato di trovarmi ora qui a spalar soldi… Allora non c’erano tutti questi gran palazzi, neppure. Mi recavo a New York su un vapore di cabotaggio. Ero solo un ragazzo e venivo da New Orleans dov’ero andato per il Mardi Gras e vi so dire ch’ero in bolletta. Montai sul vapore per venirmene a New York e diventammo amici con un bighellone della Florida… era un tipo buffo… Venimmo insieme a New York. Lui diceva che quel che bisognava fare era andare in Francia a vedere la guerra e allora tutti e due, da quegli idioti che eravamo, ci arruolammo in quei corpi volontari di sanità. In seguito io passai nell’aviazione. È così che ho cominciato nel mio ramo. A quel tempo Miami non era nulla per me.» «Davvero, è stato Flagler che mi ha dato l’abbrivo» disse Cassidy. «E non mi vergogno di riconoscerlo… comperando il diritto di transito per la Costa Orientale della Florida… Flagler ha dato l’abbrivo a me e a Miami.» Quella sera, quando rientrarono cotti dal sole e un po’ ebbri della giornata trascorsa sulla corrente del Golfo, ficcarono le opzioni nella cassaforte dell’ufficio del giudice Cassidy e se ne andarono al Palms a distrarsi dai pensieri d’affari. Margo indossava il suo abito d’argento e faceva addirittura restare a bocca aperta. C’era una sottile brunetta dall’aria irlandese, chiamata Eileen, che pareva conoscesse Cassidy da tempo addietro. Tutti e quattro cenarono insieme, Cassidy si ridusse bell’e sbronzo e cominciò a spalancare una bocca come un pesce, ciarlando del grande aeroporto e dicendo che avrebbe fatto entrare anche le ragazze in qualche lotto della speculazione. Charley era
brillo, ma non brillo al punto da dimenticare che Cassidy avrebbe dovuto tenere il becco chiuso. Quando ballò con Eileen, le parlò seriamente all’orecchio spiegandole che lei doveva far chiudere il becco al suo amico, finché la cosa non fosse resa pubblica da chi di dovere. Margo li vide con le teste accostate e fece una scenataccia di gelosia e si mise a lavorare Cassidy per andarsene. Quando Charley la fece ballare, Margo s’atteggiò a statua muta e non rispondeva ai suoi tentativi. Charley la lasciò al tavolino e si recò al banco a bere una volta. Qui entrò a litigare con un tale magro che aveva l’aria di uno straccione. Eddy Palerm, con un untuoso sorriso sulla faccia colore e forma d’oliva, si precipitò tra loro. «Non potete far rissa con questo signore, signor Anderson, è il procuratore del distretto… So che i signori potranno andare d’accordo… Signor Pappy, il signor Anderson è stato uno dei nostri primi assi di guerra.» Abbassarono i pugni e rimasero a fissarsi a vicenda, con quell’omino in mezzo che dimenava il capo e ghignettava. Charley porse la mano. «E va bene, qua la mano, amico.» Il procuratore del distretto gli diede uno sguardo cattivo e si cacciò le mani in tasca. «Procuratore un…» disse Charley. Barcollava. Dovette appoggiare la mano alla parete per raddrizzarsi. E si volse e marciò fuori dalla porta. Fuori trovò Eileen che usciva allora dal gabinetto delle signore e si stava aggiustando la lucida capigliatura di fronte allo specchio, accanto al guardaroba. Lo soffocavano il whisky, il fumo di sigaro, il brusio sussultante dell’orchestra e lo scarpiccio. Doveva uscire all’esterno. «Vieni, piccola, andiamo a fare un giro, a prendere un po’ d’aria.» Prima che la ragazza potesse aprir bocca, l’aveva trascinata fuori, al posteggio delle macchine. «Oh, ma non dobbiamo lasciare gli altri» badava a ripetere lei. «Sono tutti ubriachi come porci e non se ne accorgeranno nemmeno. Ti ricondurrò in cinque minuti. Un po’ d’arietta fa bene a una signorinetta, specialmente a una bella signorinetta come te.» Il cambio stridette, perché non aveva abbassato la frizione. La macchina ebbe un sobbalzo; Charley riattaccò il motore e senz’altro aprì tutto il gas. Il motore s’imballò per un momento ma cominciò a
guadagnar velocità. «Vedi,» disse «niente male il macchinino.» Mentre guidava, parlava dall’angolo delle labbra ad Eileen. «È l’ultima volta che entro in quel buco… Quegli straccioni di politicanti, che puzzano ancora di trementina, è inutile che facciano i puzzoni con me. Io li compro e li vendo senza disturbo, come comprare un sacchetto di noccioline. Come quella carogna di Farrell. Comprerò e venderò anche lui. Non sai chi sia, tu, ma non occorre di sapere se non che è una sporca figura, una delle più sporche figure di tutto il paese, e lui credeva, tutti quelli della banda credevano, che mi avrebbero buttato fuori, come hanno fatto con quel povero Joe Askew. Ma l’uomo dal bernoccolo, l’uomo che sa i trucchi, costui non lo buttano fuori. Io son capace di farli fessi proprio nella loro partita. Quaggiù abbiamo qualcosa di più grosso che loro non abbiano mai sognato. E l’amministrazione già bell’e preparata. Va a essere una gran cosa, piccola, la più gran cosa che hai mai veduto e farò entrare anche te, io. D’ora innanzi dormiremo fra due cuscini. E quando dormirai fra due cuscini, tu lo dimenticherai quel povero vecchio Charley Anderson, l’amico che ti ha dato l’imbeccata.» «Fa così freddo» gemette Eileen. «Torniamo indietro. Tremo tutta.» Charley si piegò e le gettò il braccio intorno alle spalle. Mentre s’era distolto, l’auto sbandò. Charley la rimise con una sterzata sull’asfalto. «Oh, vi prego, fate attenzione, signor Anderson… Andiamo a ottantacinque ora… Oh non fatemi paura, vi prego.» Charley si mise a ridere. «Cara, che simpatica sei. Guarda, siamo scesi a quaranta, rotoliamo in santa pace a quaranta. E adesso voltiamo e torniamo, è l’ora che i pulcini vadano a letto. Ma tu non devi avere mai paura in una macchina, quando guido io. Se c’è una cosa che so fare, è guidare una macchina. Ma non mi piace guidare una macchina. Se avessi ora qui il mio apparecchio! Ti piacerebbe di fare adesso un bel giretto in aeroplano? Me lo sarei già fatto mandare, non fosse che è in pegno per le note delle riparazioni. Han dovuto metterci un altro motore. Ma ora non ho più freddo. Me lo farò pilotare fin qua da qualcuno di quei ragazzi. Allora sì che ci divertiremo. Tu, io e Margo. La mia Margo è una ragazza coi fiocchi, però ha un caratteraccio, quando le salta. Quest’è un’altra cosa che so
fare io: so sceglierle le donne.» Quando si volsero per filare di ritorno a Miami, videro la lunga striscia dell’alba dietro i vasti sabbioni punteggiati di pini morti e semicostruite casette di stucco e stazioni di servizio chiuse e baracche. «E adesso abbiamo il vento con noi. Ti riporteremo indietro prima che tu possa rifiatare.» Stavan filando accanto a una strada ferrata. Stavano per raggiungere due fanali rossi. «Chi sa se è il treno di New York.» Ecco che lo raggiungevano, e passavano l’illuminata vettura panoramica, passavano le vetture letto senza luce, eccetto per i finestrini smerigliati dei gabinetti all’estremità delle vetture. Rimontavano il bagagliaio, e i carri postali, e la locomotiva enorme e alta e tutta nera con un leggero brivido luccicante prodotto dai fari di Charley nell’oscurità. Il convoglio aveva nascosto la striscia rossa dell’alba. «Giuda, vanno come lumache.» Quando sorpassarono la garetta, il fischio lacerò l’aria. «Giuda, lo batto al passaggio a livello.» I lumi del passaggio a livello erano laggiù in fondo e altresì il lungo raggio del faro della locomotiva, che rendeva la striscia rossa e gialla dell’alba all’orlo delle nubi, smorta e remota. Al passaggio la sbarra era calata. Charley premé l’acceleratore. Piombarono, schiantando la sbarra, infrangendo i fari. La macchina sbandò lateralmente. Avevano gli occhi accecati dal bagliore del faro della locomotiva e dallo stridore del fischio. «Niente paura, siamo passati» urlò Charley alla ragazza. La macchina sbandò di fianco sulla rotaia e non si mosse. Charley menava colpi allo starter col piede. Lo schianto non fu nulla. Quando rinvenne, capì subito che era in un ospedale. Prima cosa, cominciò a domandarsi se gli sarebbe venuto il mal di capo. Muoversi non poteva. Tutto era buio. Giù dal fondo d’un pozzo poteva vedere il soffitto. Poi poté vedere la punta di una cuffia da infermiera e un’infermiera che si piegava. E per tutto questo tempo parlava. Non poteva smettere di parlare. «Ah, ho creduto che fosse finita. Dite, infermiera, dove abbiamo fatto il capitombolo? Era all’aeroporto? Sarei più tranquillo se me lo ricordassi. È stato così, infermiera… avevo portato in volo quella piccola perché provasse quel nuovo apparecchio Boeing… sapete, quel coso… ce l’avevo a morte con qualcuno, doveva essere mia
moglie, povera cara Gladys, però che sporco affare mi ha fatto. Ma ora, dopo quest’affare dell’aeroporto, li compro e li vendo, tutta la banda insieme. Dite, infermiera, com’è stato? Era all’aeroporto?» Viso e capelli dell’infermiera eran gialli sotto la cuffia candida. Aveva un viso magro, senza labbra, e mani magre che gli passarono sugli occhi, distendendogli il lenzuolo sotto il mento. «Dovete cercar di dormire» disse. «Altrimenti vi dovrò fare un’altra iniezione.» «Dite, infermiera, siete canadese? Scommetto che siete canadese.» «No, sono del Tennessee… Perché?» «Sbaglio io. Sapete, tutte le volte che sono stato all’ospedale sinora, le infermiere erano sempre canadesi. Ma non è un po’ troppo buio qui? Vorrei potervi raccontare com’è stato. Hanno telefonato all’ufficio? Credo proprio che bevo troppo. D’ora innanzi non penserò più che agli affari. Vi dico io che un uomo ha da tener gli occhi aperti in questo gioco… Dite, non potete portarmi un po’ d’acqua?» «Sono l’infermiera notturna. Non è ancor giorno. Cercate di dormire un po’.» «Credo che abbiano telefonato all’ufficio. Vorrei che Stauch desse un’occhiata all’apparecchio prima che qualcuno tocchi. È buffa, infermiera. Non mi sento troppo male, ma sono in uno stato da far pietà.» «Sono le iniezioni» disse la voce vivace e sommessa dell’infermiera. «Adesso riposate tranquillo e domattina vi sveglierete e vedrete che starete assai meglio. Potete soltanto sciacquarvi la bocca con questo.» «Perbacco.» Non poteva smettere di parlare. «Vedete, è andata così. Ho avuto non so che lite con un tale. Mi state a sentire, infermiera? Credo proprio di avere una paglia sulla spalla, da quando continuano a saltarmi addosso a questo modo. C’era una volta che pensavo che tutti fossero amici miei, capite. Ora so che dal primo all’ultimo tutti sono carogne… persino Gladys si è dimostrata la peggiore carogna del mazzo… Dev’essere la sbornia che mi dà questa sete terribile.» L’infermiera era di nuovo china su di lui. «Temo proprio che
dovremo darvi un po’ di quel sonnifero, amico… E adesso, rilassatevi. Pensate a qualcosa di bello. Bravo ragazzo.» La sentì che gli batteva sul braccio con qualcosa di freddo e bagnato. Sentì la puntura dell’ago. Il letto duro, dove giaceva sveglio, gli crollò a poco a poco sotto. Affondava, e nessuna dolcezza di sonno veniva, affondava nel buio. Stavolta era una tozza donna inamidata che gli stava sopra. Era giorno. Le ombre eran mutate. Gli ficcava certe carte sotto il naso. Aveva una voce dura e gaia. «Buon giorno, signor Anderson, posso fare qualcosa per voi?» Charley era sempre giù in un pozzo profondo. La camera, la tozza donna inamidata, le carte, erano lontano sul suo capo chi sa dove. Tutto intorno gli occhi gli facevan male, tanto scottavano. «Dite, non mi pare di essere tutto d’un pezzo, infermiera.» «Sono la sopraintendente. Restano certe formalità, se non vi dispiace… se vi sentite in grado.» «Non avete mai avuto l’impressione che tutto sia già avvenuto un’altra volta?… Dite, dove, in che città cioè?… Non importa, non ditemi niente, ora ricordo tutto.» «Sono la sopraintendente. Se non vi spiace, l’economato vorrebbe un assegno in anticipo per la prima settimana e poi c’è qualche altro onorario.» «Non pensateci. Ho quattrini, io… In nome di Dio, datemi da bere.» «Sono i regolamenti, nient’altro.» «Ci dev’essere un libretto d’assegni da qualche parte nella mia giacca… Oppure, cercate di Cliff… il signor Wegman, il mio segretario… Lui può farvi un assegno.» «Ma non preoccupatevi di nulla, signor Anderson… L’economato ha preparato un assegno in bianco. Scriverò io al nome della banca. Voi firmate. Sarà un deposito di duecentocinquanta dollari.» «Bankers Trust, New York… Cristo, riesco appena a scrivere il mio nome.» «Quanto al questionario lo faremo riempire in seguito dall’infermiera… per i nostri archivi… Arrivederci, signor Anderson,
spero che avrete un piacevole soggiorno tra noi e vi auguro una pronta guarigione.» La tozza donna inamidata era scomparsa. «Ehi, infermiera» chiamò Charley. Improvvisamente ebbe paura. «Che buco è questo, insomma? Dove sono? Dite, infermiera, infermiera.» Urlò con tutta la sua forza. Gli sprizzò il sudore sulla faccia e sul collo e gli scorse nelle orecchie e negli occhi. Poteva muovere la testa e le braccia, ma la bocca dello stomaco: niente. Non sentiva affatto le gambe. La bocca era secca per la sete. Una nuova, rosea infermiera carina si chinò su di lui. «Che posso fare, signore, per voi?» Gli deterse la faccia e gli mostrò il campanello che gli penzolava accanto alla mano. «Infermiera, ho una sete tremenda» disse con voce debole. «Dovete soltanto sciacquarvi la bocca. Il dottore non vuole che mangiate o beviate nulla finché non avrà fatto il drenaggio.» «Dov’è questo dottore?… E perché adesso non è qui?… Perché non si è trovato subito qui? Se non sta attento, lo licenzio e ne prendo un altro.» «Ecco il dottor Snyder in persona» disse l’infermiera in un sussurro riverente. «Dunque, Anderson, l’avete scampata bella, è un fatto. Probabilmente vi siete immaginato tutto quel tempo di essere in aeroplano… Curiosa, non ho ancor conosciuto un pilota aviatore che sapesse guidare un’auto. Mi chiamo Snyder. Il dottor Ridgely Snyder di New York. Il dottor Booth, primario dell’ospedale, mi ha chiamato a consulto. Può darsi che dobbiamo rammendarvi un po’ l’interno. Sapete che quando vi hanno raccolto, da quel che mi dicono, una buona parte dell’automobile vi pesava sul tronco… un caso ben fortunato che non vi abbia accoppato là sul posto… Mi capite, vero?» Il dottor Snyder era un omone dalle piatte guance rasate a zero e dalle mani quadre terminate da unghie quadre. Una canzone che il vecchio Vogel soleva cantare attraversò il cervello fievole di Charley, mentre guardava il dottore piantato enorme, quadrato e panciuto nel vestito bianco: sembrava William Kaiser il grosso macellaio ma non si conoscevano e facevano un bel paio. «Dev’essere la droga, ma il mio cervello non è troppo in sesto…
Fate del vostro meglio, dottore… e non badate alla spesa. Ho proprio adesso combinato un certo affaruccio, che farà fischiar le orecchie a qualcuno… Dite, dottore, e quella piccola? Non c’era una piccola, nell’automobile?» «Oh, per lei non preoccupatevi. Sta benissimo. È stata lanciata nettamente fuori. Una leggera scossa; qualche contusione, se la cava splendidamente.» «Avevo paura a chiedere.» «Dovremo fare una piccola operazione… sutura dell’intestino, un problema interessantissimo. Voglio che non abbiate preoccupazioni di nessun genere, signor Anderson… Non si tratterà che di un punto qui e un punto là… vedremo quel che si potrà fare. Immaginavo d’esser venuto quaggiù per le vacanze, ma naturalmente sono sempre lieto di dare una mano in caso di una disgrazia.» «Grazie, allora, dottore, per tutto quel che potrete fare… Credo proprio che ho fatto male a bere tanto… Ma dite, perché non mi lasciano bere un po’ d’acqua?… È buffa, ma appena rinvenni qui ho creduto di essere in un’altra tampa. Però a Doris non le sarebbe piaciuto, sapete, che parlassi così: parole volgari, una condotta indegna d’un ufficiale e d’un gentiluomo. Ma vedete, dottore, quando si arriva al punto che si possono vendere e comprare tutti quanti come un vecchio sacco di noccioline, un sacco di fave marce, non ci si pensa più a quel che si beve. Sapete, dottore, può darsi che mi serva assai esser costretto a letto, può darmi il modo di smettere di bere e di pensare a molte cose… Mai pensato alle cose della vita, dottore?» «Quanto penso in questo istante, signor Anderson, è che vorrei vedervi assolutamente calmo.» «E va bene, fate voi la vostra parte, dottore… Mandatemi qui quella bella infermiera, ché possa parlare. Ho voglia di parlare del vecchio Bill Cermak… Era l’unico individuo onesto che ho mai conosciuto, lui e Joe Askew… Chi sa cos’ha provato, quand’è morto… Sapete, l’altra volta che fui, diciamo così, invalidato permanentemente… lui e io ci siamo sfracellati in un apparecchio… il nuovo Mosquito… vale milioni, ma quelle carogne mi hanno portato via i titoli… Dite, dottore, non è mai capitato a voi di morire?»
Non c’era altro che il soffitto bianco su di lui, più luminoso dove la luce entrava dalla finestra. Charley si ricordò del campanello alla sua portata. Suonò una, due volte. Nessuno giunse. Allora si mise a dar strattoni, finché non sentì il cordone cedere lontano. La faccia rosea e carina dell’infermiera gli spuntò sopra, come un primo piano al cinema. Quella giovane pocobaciata bocca si moveva. Charley la vedeva fare un suono come un gorgoglio, ma un frastuono nelle orecchie come quello dell’interurbana gli impediva di sentire che dicesse. Solamente parlando non si sentiva impaurito. «Sentite bene, ragazza…» udiva se stesso parlare. Era contento di udirsi parlare. «Sono io che pago le note in quest’ospedale e intendo avere ogni cosa come piace a me… Voglio che vi sediate qui e mi ascoltiate quando parlo, capito? Vediamo, che cosa stavo dicendo a quel tale? Può darsi che sia un dottore, ma per me ha tutta l’aria di William Kaiser il grosso macellaio. Siete troppo giovane per sapere questa canzone.» «C’è una visita per voi, signor Anderson. Volete che vi rinfreschi un poco il viso?» Charley girò gli occhi. Il paravento era stato aperto. Nel rettangolo grigio della porta ecco Margo. Era in giallo. Lo stava fissando con gli occhi tondi come quelli di un uccello. «Margery, non sei furiosa con me?» «Sono peggio che furiosa, sono preoccupata.» «Tutto andrà per il meglio, Margo. C’è un dottore ben in gamba, di New York. Mi riparerà come si deve. Somiglia a William Kaiser il grasso macellaio in tutto, tranne i baffi… che cosa ne sai tu, dimenticavo i baffi… Non guardarmi in quel modo strano, sto benissimo. Soltanto, mi sento meglio se parlo, capisci. Scommetto che sono il paziente più chiacchierone che sia mai entrato in quest’ospedale… Margo, sai che avrei potuto diventare un alcoolizzato, se avessi continuato a bere a quel modo. È un bene, così, esser stato fermato.» «Ascolta, Charley, ti senti abbastanza in forze da riempire un assegno? Bisogna pure che abbia qualche soldo. Sai che mi dovevi dare una commissione su quell’affare dell’aeroporto. E adesso bisogna che io ti cerchi un avvocato anche. I parenti di Eileen vogliono far
causa. Quel procuratore ha spiccato un mandato. Ti ho portato il tuo libretto d’assegni.» «Perdio, Margo, un certo gruzzolo l’ho messo insieme, ma non sono mica la Banca d’Inghilterra.» «Ma, Charley, avevi detto che mi aprivi un conto.» «Lascia che prima metta i piedi fuori dell’ospedale.» «Charley, povero, disgraziato, signor A… non crederai che sia un piacere per me darti noia in un momento come questo… ma devo anch’io mangiare come gli altri… e se avessi qualche soldo potrei far tacere quel procuratore… e tenere la cosa fuori dai giornali e tutto. Sai bene che razza di scandalo ne vorranno fare… ma bisogna che abbia subito denari.» «E va bene, prepara un assegno di cinquemila… Bella fortuna per te che non mi sono rotto il braccio.» L’infermiera rosea e carina era di ritorno. Con una voce fredda, tagliente, gelida, disse: «Temo sia ora». Margo si piegò su di lui e lo baciò in fronte. Charley ebbe l’impressione di essere sotto vetro. C’era il contatto delle sue labbra, il sentore del suo abito, dei suoi capelli, il suo profumo solito, ma queste cose non le poteva sentire. Come una scena al cine, osservò il passo di lei che usciva, l’ondeggiamento dei suoi fianchi sotto l’abito attillato, il modo nervosetto con cui si sventolava sotto il mento l’assegno per asciugarvi l’inchiostro. «Dite, infermiera, è come un panico in Borsa… Si saranno messi in testa che la vecchia istituzione non è più solida… Questa volta è un ordine, capite: dite giù all’entrata che non voglio più visite, inteso? Io, voi e il dottor Kaiser William bastiamo, no?» «Intanto è venuta l’ora di un viaggetto per il corridoio» disse l’infermiera rosea e carina, con una voce allegra come dovessero andare a uno spettacolo o a una partita di baseball. Entrò un inserviente. La camera cominciò ad allontanarsi dal lettuccio, ecco che un grigio corridoio sfuggiva all’indietro, ma ciechi spasimi di dolore gli si avventavano su per le gambe, a quel movimento. Riaffondò un’altra volta in un’acida vomitante tenebra. Quando tornò la luce, era tutto assai remoto. La lingua gli stava secca
in bocca, tanto aveva sete. Su ogni cosa era una nebbia sanguigna. Lui parlava, ma a distanza, chi sa dove. Sentiva le parole passargli per la gola, ma non le udiva. Quel che udiva era la voce del dottore che diceva peritonite come fosse la più bella cosa del mondo, come chi dicesse Buon Natale. C’erano altre voci. Aveva gli occhi aperti, c’erano altre voci. Certo aveva il delirio. C’è Jim seduto, laggiù, con una faccia ansiosa, scontrosa, cupa, come soleva vederlo da ragazzo i pomeriggi della domenica esaminare i suoi registri. «Sei tu, Jim? Come sei arrivato qui?» «A volo» rispose Jim. Fu una sorpresa per Charley che la gente potesse udirlo, la sua voce era così remota. «Tutto è in regola, Charley… non devi fare il minimo sforzo. Penserò io a tutto.» «Ma mi senti, Jim? è come una cattiva comunicazione sull’interurbana.» «Va tutto bene, Charley… Ci occuperemo noi di tutto… Tu riposa soltanto. Di’ un po’, te lo chiedo soltanto come precauzione: testamento l’hai fatto?» «Di’, era peritonite che ho sentito dire da qualcuno? Brutta roba, no?» Il viso di Jim era bianco e lungo. «È… una piccola operazione. Ho pensato che sarebbe meglio per te se mi dessi una procura generale, perché tu non abbia più niente da pensare, capisci. L’ho già bell’e pronta e c’è qui il giudice Grey da testimone e Hedwig entrerà subito… Dimmi un po’, sei sposato con quella donna?» «Io sposato? Non mi pescano più… Caro vecchio Jim, lui vuole sempre che la gente firmi. È un peccato che non mi sia rotto il braccio. E così che cosa ne pensi adesso degli aeroplani, Jim? Non sono ancora pratici, eh? Pratici abbastanza però, da guadagnare più quattrini che tu non abbia mai fatto con tutte le tue trappole… Non offenderti, Jim… Di’, Jim, mi raccomando di prendere tutti i migliori dottori… Sto ben male, sai?… Uno si sente così rauco… di’ che mi lascino bere un po’ d’acqua, Jim. Non bisogna fare economia coi dottori… Voglio discorrere come una volta, ti ricordi, quando andavamo a pescare su per il Red River, che non c’era nessuno. Proveremo a pescare qui al largo… C’è una pesca magnifica appena fuori di Miami… Sento di
nuovo che perdo i sensi. Di’ a quel dottore che mi dia qualcosa. Questa sì che è una puntura. Grazie, infermiera, mi ha rimesso a posto, si schiarisce tutt’intorno. Ti dico, Jim, che tutto ronza nell’aria… sovvenzionamenti… aeroporti… queste nuove aviolinee… saremo i padri fondatori di tutti… Hanno creduto di mettermi in strada, ma li ho ancora fregati… Giuda, Jim, vorrei poter smettere di parlare e addormentarmi. Perdo i sensi stavolta: non è più come addormentarsi, è come la… una porcheria.» Doveva continuare a parlare, ma a che serviva? Era troppo rauco. La sua voce era un fievole gracchio, aveva tanta sete. Non potevano sentirlo. Doveva farsi sentire. Era troppo debole. Ecco che cadeva, turbinava, qualcosa lo succhiava giù nel 1. In inglese nasce la freddura dai due sensi di to pay: “pagare” e “rendere, valere, compensare”. (NdT)
Cine-giornale LXII LE STELLE PRESAGISCONO DISGRAZIE PER COOLIDGE Se non puoi dire al mondo ch’è una buona ragazza tu non devi dir nulla Way senior aveva tentato per parecchi anni di mettere in vendita uno speciale disinfettante per i sedani. L’inchiesta sull’accusa che era stato percosso rivelò che Way aveva ricevuto l’avviso di smetter la corrispondenza, ma portò in luce altresì il fatto che i principali coltivatori di sedano adoperavano un disinfettante contenente un poderoso veleno. Finché sei triste ragazza mia tu ne hai bisogno di simpatia I MINATORI RIEVOCANO GLI ORRORI DEL POZZO DELLA MORTE in quanto che le banche hanno fastidi attualmente in Florida, gli assegni non passano così rapidamente come dovrebbero. Per evitare ritardo favorite inviarci vaglia postale espresso invece di un assegno garantito Come fa la libellula che la pioggia sorprende che si strugge pei fiori che risogna gli amori del lontano cespuglio ove il sole risplende TURISTI CHE DERUBANO UNA STAZIONE DI RIFORNIMENTO LA RISCOSSIONE DEI PROFITTI NON BASTA A FERMARE L’ASCESA DEI TITOLI il clima produce ottimismo e riesce difficile al pessimismo di sopravvivere nel luminoso sole e nelle brezze balsamiche che spirano dal Golfo e dall’Atlantico Chissà mai se pioverà UN URAGANO FLAGELLA LA FLORIDA MERIDIONALE LA FLORIDA MERIDIONALE È DEVASTATA 1000 MORTI 38.000 SENZA TETTO
BUSSE A UNA REGINA DI BROADWAY E la volpe ha un bel codino ma l’opossum non l’ha più l’ha il coniglio piccolino un ciuffetto volto in su I SOVVENZIONAMENTI PER LA FLORIDA NON BASTANO È IMMINENTE LA LEGGE MARZIALE Certo più non pioverà secondo gli accertamenti della polizia la comitiva passò la sera del sabato a Hillside Park, un ritrovo di Belleville e verso mezzanotte andò al villino. Le ragazze Bagley s’erano ritirate, dissero alla polizia, e quando gli uomini entrarono nella stanza una di esse saltò dalla finestra Come fa la gente a dire certo più non pioverà?
Margo Dowling Agnes discese dalla vettura letto vestita da capo a piedi di crespo nero. Aveva messo su peso e la faccia mostrava un’aria smorta e strapazzata che Margo non vi aveva osservato mai. Margo poggiò il capo sulla spalla di Agnes e scoppiò in lacrime proprio là nella calca e nel sole della stazione di Miami. Salirono sulla Buick per recarsi alla spiaggia. Agnes non s’accorse nemmeno della macchina, dell’autista in uniforme né d’altro. Prese la mano di Margo e stettero sedute fissando gli occhi da parti opposte nelle vie assolate piene di gente lenta dai vestiti leggeri. Margo si premeva gli occhi col fazzoletto di pizzo. «Non dovresti metterti in lutto?» diceva Agnes. «Non ti sentiresti confortata, se ti mettessi in lutto?» Fu solamente quando l’azzurra Buick venne a fermarsi all’ingresso della villetta sulla spiaggia e Raymond, il magro autista mulatto, saltò fuori, sorridendo rispettoso, a prendere le valigie, che Agnes cominciò ad accorgersi di qualcosa. «Oh, che macchina deliziosa» esclamò. Margo la guidò attraverso la casa e fuori, nel portico cintato, sotto le palme, in faccia al mare violazzurro e l’acqua verde lungo la costa e i frangenti candidi. «Oh, è troppo delizioso» disse Agnes e si lasciò cadere in un’amaca Gloucester, sospirando: «Sono talmente stanca». Poi si rimise a piangere. Margo andò a rifarsi il viso al lungo specchio del vestibolo. «Dunque» disse quando fu di ritorno, incipriata e rosea «ti va la casa? Una bella baracchetta, no?» «Oh, non potremo più restare… Che cosa faremo ora?» Agnes piagnucolava. «So che è tutto per la perversa irrealtà della materia… Oh se soltanto avesse avuto pensieri sani.» «A buon conto la pigione del mese venturo è già pagata» disse Margo. «Ma la spesa» singhiozzò Agnes. Margo stava fissando gli occhi per la porta della cinta verso una grossa nave-cisterna nera che passava all’orizzonte. Volse il capo e parlò stizzita, sopra la spalla. «Però non c’è niente che mi vieti di far fuori qualche opzione, no? Ti so dire che quel che bolle qui in pentola è un rialzo. Chi sa che non ci riesca di fare un buon colpo. Tutte le
persone di questa città che son qualcuno, le conosco. Aspetta e vedrai, Agnes.» Eliza, la cameriera negra, entrò con un servizio da caffè d’argento e un piatto di crostini su un vassoio d’argento ricoperto di un tovagliolo di merletto. Agnes rigettò il suo velo, sorseggiò a centellini un po’ di caffè e prese a mordicchiare un crostino. «Spalmaci un po’ di marmellata» disse Margo, accendendosi una sigaretta. «Non credevo che tu e Frank ammetteste il lutto.» «Non ho potuto farne a meno. Mi è stato di conforto. Oh, Margo, non hai mai pensato che, se non fosse per la nostra orribile incredulità, potrebbero essere quest’oggi con noi?» Si asciugò gli occhi e ritornò al caffè e crostini. «Quando sarà il funerale?» «Lo faranno nel Minnesota. Si sono occupati di tutto i suoi. Io passo per essere la peste.» «Povero signor Anderson… Sarai accasciata, povera piccola.» «Dovresti vederli. Suo fratello Jim toglierebbe i quattrini dagli occhi di un morto. Minaccia di far causa per riavere certi valori che pretende fossero di Charley. Faccia causa, se vuole. Il mio avvocato è Homer Cassidy e quanto lui dice è vangelo nella città… Agnes, bisogna che tu ti tolga queste gramaglie da vedova e ti comporti umanamente. Che penserebbe Frank, se fosse qui?» «È qui» urlò Agnes e tornò a sfasciarsi e riprese i singhiozzi. «Ci sta vigilando anche ora. Lo so!» Si asciugò gli occhi e tirò su dal naso. «Oh, Margie, mentre venivo in treno pensavo che forse tu e il signor Anderson v’eravate segretamente sposati. Deve aver lasciato una sostanza enorme.» «La maggior parte è vincolata… Ma Charley non si è dimenticato di me, mi ha sistemata cammin facendo.» «Ma pensa, Margo, due cose tanto spaventose accadere nello stesso inverno.» «Agnes» disse Margo, levandosi in piedi «se continui su questo tono, io ti rispedisco subito a New York… Non sono già stata abbastanza depressa? Hai il naso tutto rosso. Fa paura… Sentimi bene, tu mettiti in libertà. Io debbo uscire per cose d’affari.» «Oh, ma non posso restare. Mi sento un non so che» singhiozzò Agnes. «E allora,
puoi venire con me, purché ti tolga quell’orribile velo. Sbrigati, ho un appuntamento.» Le fece aggiustare i capelli e indossare una camicetta bianca. Il vestito nero davvero le si addiceva assai. Margo volle che si truccasse un po’. «Ecco, cara. E adesso sei un amore» disse e la baciò. «Ma è davvero la tua macchina, questa» sospirò Agnes, sprofondando nel sedile della Buick turchina. «Non posso crederlo.» «Vuoi forse vedere le carte di registrazione?» disse Margo. «Va’ pure, Raymond, sai dov’è l’ufficio dell’agente.» «Certo che so, signorina» disse Raymond, portando la mano alla lucida visiera del berretto, mentre il motore prendeva a ronzare sotto l’intatta vernice del cofano. All’ufficio dell’agente vi era la consueta folla anziana e ben vestita, in abito sportivo, che riempiva i sedili, individui che tenevano sulle ginocchia il panama in insieme da spiaggia e calzoncini di lino, donne fruscianti in abiti rosa, verdi, bruno chiaro e candidi. Facevano sempre a Margo un po’ d’impressione, come essere in chiesa, tutti quei bisbigli, i modi riguardosi, i giovanotti pronti e attenti alle lunghe lavagne segnate di colonne di simboli, il ticchettio del telegrafo, la voce ferma che leggeva le quotazioni del segnalatore a una scrivania in fondo alla stanza. Mentre entravano, Agnes con una voce spaventata bisbigliò all’orecchio di Margo se lei non avrebbe fatto meglio ad andarsi a sedere nell’auto, finché Margo non avesse sbrigato il suo affare. «No, resta con me» disse Margo. «Vedi, quegli impiegati scrivono a gesso su quelle lavagne gli alti e i bassi della Borsa… Comincio ora a ritrovarmi in questa faccenda.» Due signori d’età, capelli bianchi e nasi ebraici dalle larghe pinne, fecero loro sorridendo posto su una panca in fondo alla stanza. Parecchie teste si volsero e fissarono Margo. Lei udì la voce di una donna sibilare all’uomo che le stava accanto qualcosa intorno ad Anderson. Ci fu un leggero scompiglio di bisbigli e gomitate. Margo si sentiva benvestita e non vi fece caso. «Dunque, mia cara signorina,» le ronzò dietro la voce del giudice Cassidy «si compra o si vende, oggi?» Margo volse il capo. C’era il lampo di un dente d’oro in quel sorriso sulla larga faccia rossa, sotto il tetto dei capelli argentei colore dell’abito di lino grigio attraversato da
un altro lampo d’oro sotto forma della catena dell’orologio passata due volte sopra l’ampia rotondità del panciotto del giudice. Margo scosse il capo. «Non c’è troppo da fare oggi» disse. Il giudice Cassidy levò di scatto la testa e si diresse alla porta. Margo si alzò e gli tenne dietro, tirandosi Agnes alle spalle. Quando furono usciti nel sole frizzante della breve viuzza che correva allo spiazzo balneare, Margo presentò Agnes come il suo angelo custode. «Spero che non vorrete deluderci oggi come avete fatto ieri, mia cara signorina» cominciò il giudice Cassidy. «Forse potremo convincere la signora Mandeville…» «Temo di no» interruppe Margo. «Capite che questa poveretta è talmente stanca… Arriva adesso da New York… Senti, Agnes, noi dobbiamo andare a vedere certi terreni. Raymond ti porterà a casa, e per te è già ordinato il pranzo e ogni cosa… Mi raccomando di riposarti bene.» «Certamente mi occorre un po’ di riposo» disse Agnes, rossa in faccia. Margo l’aiutò a salire sulla Buick che Raymond aveva allora ricondotta dal posteggio, la baciò e poi proseguì a piedi col giudice lungo l’isolato, dove la sua Pierce-Arrow da viaggio attendeva lucida e scintillante nel torrido sole meridiano. Il giudice guidava lui la sua macchina. Margo gli sedette accanto sul sedile anteriore. Appena l’auto fu in moto, gli chiese: «E dunque, questo assegno?». «Vedete, mia cara signorina, ho un grande timore che senza fondi significhi senza fondi… Immagino che potremo risarcirci sul patrimonio.» «Giusto in tempo per versare una prima quota di affitto della tomba.» «Ecco, queste cose voglion tempo… pare che quel disgraziato ragazzo abbia lasciato i suoi affari in notevole disordine.» «Povero diavolo» disse Margo, guardando lontano traverso le file delle palme alle distese brune della Biscayne Bay. Qua e là per le isolette verdi facevan capolino le grezze nuove costruzioni di stucco, come scenari esposti in strada alla luce del giorno. «Davvero io ho fatto quanto ho potuto per mettergli la testa a partito.» «È un fatto… È un fatto che possedeva una notevole sostanza… È stata quella vita pazzesca di New York. Quaggiù noi prendiamo le
cose con calma, sappiamo lasciar maturare il frutto sulla pianta.» «Arance» disse Margo «e limoni.» Si mise a ridere, ma il giudice non le fece eco. Né l’uno né l’altra dissero nulla per un poco. Giunsero al fondo della via selciata e girarono davanti alle baracche giallicce degli scali nel fitto trambusto della banchina di Miami. Dappertutto nuovi alti edifici intonacati come torte sorgevano da impalcature e rottami di costruzione. Mentre passavano rintronando sul provvisorio ponte di legno buttato sul Miami, nel fragore degli asfaltatori e in un nuvolo di polvere che veniva dalle costruzioni, Margo disse, levando un viso impassibile dagli occhi tondi verso il giudice: «Credo proprio che dovrò impegnare la vetreria». Il giudice rise e disse: «Posso assicurarvi che la banca vi offrirà ogni agevolazione… Non rompetevi questa bella testina a pensarci. Avete in mano delle opzioni notevoli, se non sbaglio». «Non penso nemmeno che, su questo fondamento, voi vogliate imprestarmi un paio di biglietti da mille per tirare avanti, giudice.» Correvano ora su una larga strada d’asfalto nuova, in mezzo a una fitta macchia tropicale. «Mia cara signorina,» diceva il giudice Cassidy con la sua gioviale voce lenta «come potrei fare questo per voi?… pensate alla falsa interpretazione… alle frivole chiacchiere. Siamo un poco all’antica quaggiù. Prendiamo le cose genialmente ma una volta che la voce dello scandalo… Guardate, persino mostrarsi in auto con una così incantevole compagna per le vie di Miami è una follia, una deliziosa follia. Ma dovete rendervi conto, mia cara signorina… Un uomo nella mia posizione non può concedersi… Non comprendete male le mie ragioni, cara signorina. Non ho mai abbandonato un amico nella mia vita… Ma disgraziatamente la mia posizione non sarebbe giudicata in questo modo. Solamente un marito o un…» «È una proposta che mi fate, giudice?» interruppe Margo seccamente. Le bruciavano gli occhi. Era difficile trattenere le lacrime. «Niente più che un consiglio a una cliente…» Il giudice sospirò. «È un peccato che io sia un uomo di famiglia.» «Deve ancora durare un pezzo questo rialzo?» «Non occorre che vi rammenti quale tipo di bestia nasca ogni
minuto. 1» «Non occorre» disse Margo aspra. Entravano al posteggio, dietro il grande albergo nuovo color caramella. Scendendo dall’auto Margo disse: «Può darsi che a qualcuno sia lecito il lusso di rimetterci di tasca sua, ma noi non possiamo, vero, giudice?». «Mia cara signorina, questa parola non la si trova nel radioso dizionario della giovinezza.» Il giudice la stava introducendo col suo fare paterno nella sala da pranzo. «Ah, ecco, i ragazzi ci sono.» A un tavolo rotondo nel centro dell’affollato salone sedevano due giovanotti grassi in faccia, dalle grandi bocche, indossanti camicie rosa a strisce, cravatte verde pallido e due completi bianchi. S’alzarono continuando a masticare e pomparono la mano di Margo quando il giudice li presentò. Eran gemelli. Mentre tornavano a sedersi, uno dei due strizzò l’occhio e agitò un grasso indice. «Vi vedevamo sempre al Palms, piccola, birichina birichina.» «Be’, ragazzi,» disse il giudice «come va?» «Va d’incanto» uno dei due rispose con la bocca piena. «Vedete qua, ragazzi,» disse il giudice «questa signorina vorrebbe fare qualche piccolo investimento a pronto realizzo…» I due gemelli grugnirono e continuarono a masticare. Dopo il pranzo il giudice li portò tutti in macchina alla Venetian Pool dove William Jennings Bryan seduto su una poltrona galleggiante sotto un tendone a strisce parlava alla folla. Dov’eran loro non si sentiva quel che dicesse, ma solamente le risate e i battimani della folla nelle pause. «Sapete, giudice,» disse uno dei gemelli mentre si aprivano una strada attraverso gli estremi gruppi di folla intorno al laghetto «se il vecchione non avesse sprecato il tempo a far della politica, chi sa che imbonitore sarebbe.» Margo cominciò a sentirsi stanca e avvizzita. Seguì i gemelli nell’ufficio immobiliare pieno di individui sudati in maniche di camicia. Il giudice le trovò una sedia. Margo sedette tamburellando col piede calzato di capretto candido il pavimento a mattonelle, con un fascio di cianografie in grembo. I prezzi eran tutti così alti. Si trovava fuori del suo elemento e sentiva la mancanza del signor A, che certo avrebbe saputo che cosa comprare. All’esterno, le panchine
sul prato eran tutte occupate. Dappertutto saliva uno schiamazzio di voci. L’asta cominciava. I due gemelli sulla piattaforma agitavano le braccia e menavano rimbombi coi loro martelli. Il giudice camminava su e giù, dietro la schiena di Margo, esaltando il rialzo a chiunque lo stesse a sentire. Quando questi s’arrestò a trarre il fiato, Margo levò gli occhi a guardarlo e disse: «Giudice Cassidy, potreste chiamarmi un tassì?». «Mia cara signorina, vi porterò io stesso a casa. Sarà un piacere.» «D’accordo» disse Margo. «Non vi manca il cervello» le sussurrò il giudice Cassidy all’orecchio. Mentre camminavano lungo l’orlo della folla, uno dei gemelli con cui avevano pranzato scese dalla piattaforma dell’asta e si tuffò tra la gente in loro traccia. «Signorina Dowling,» disse «è permesso venirvi a trovare, io e Al?» «Certo» disse Margo, sorridendo. «Il nome è nella guida del telefono sotto Dowling.» «Verremo, verremo.» E tornò di corsa alla piattaforma. Margo aveva avuto paura di non aver fatto colpo sui due gemelli. Ora sentì le rughe di stanchezza scomparirle, rilassandosi, dal viso. «Ebbene, che ve ne pare del grande sviluppo di Coral Gables?» disse il giudice mentre la faceva salire nell’auto. «Qualcuno certo guadagna dei quattrini» disse Margo asciutta. Una volta a casa, si tirò via il cappello e disse a Raymond, che nel pomeriggio aveva funzioni di maggiordomo, di preparare qualche Martini, trovò un sigaro per il giudice e si scusò per qualche minuto. Disopra trovò Agnes seduta in camera sua, in vestaglia lavanda, intenta a rifarsi le unghie alla toeletta. Senza dire una parola, Margo si lasciò cadere sul letto e scoppiò a piangere. Agnes si alzò voluminosa, cascante e amabile, e venne alla volta del letto. «Ma dunque, Margie, se non piangi mai…» «Lo so che non piango» singhiozzò Margo «ma è tutto così insopportabile… Sotto c’è il giudice Cassidy, scendi e fagli conversazione…» «Povera piccola. Subito scendo, ma sei tu che vorrà vedere… Hai sofferto troppo.» «Non voglio ritornare al corpo di ballo… non voglio» singhiozzò Margo. «Oh, no, non piacerebbe nemmeno a me… Ma ora scendo… È la prima volta, dopo mesi, che mi sento davvero riposata» disse Agnes. Margo quando fu sola smise subito di frignare. «Ma come, sono
quasi peggio che Agnes» brontolò tra sé, levandosi in piedi. Aprì l’acqua per fare un bagno. Era tardi quando si fu infilato un abito da pomeriggio, e discese. Il giudice aveva un’aria ben truce. Stava seduto, tirando a un mozzicone di sigaro e sorsettando un cocktail, mentre Agnes gli parlava della Fede. Saltò su, quando scorse Margo che scendeva le scale. Lei mise al grammofono dischi da ballo. «Quando sono in casa vostra, sono come quel famoso sapiente greco nella casa delle sirene… Dimentico i doveri familiari, gli impegni, ogni cosa» disse il giudice, venendole incontro a passo di one-step. Ballarono. Agnes ritornò disopra. Margo s’accorse che il giudice era lì lì per metterle addosso le mani. Stava pensando che ripiego prendere, quando d’un tratto nella stanza venne introdotto Cliff Wegman. Il giudice diede al giovanotto un’occhiata tra sgomenta e sospettosa. Margo s’accorse che gli passò in mente ch’era bell’e servito. «Oh, signor Wegman, non vi sapevo a Miami.» Alzò la puntina dal disco e fermò il grammofono. «Giudice Cassidy, vi presento il signor Wegman.» «Fortunatissimo, giudice. Il signor Anderson parlava sovente di voi. Ero il suo segretario personale.» Cliff aveva un’aria sparuta e nervosa. «Arrivo adesso in questa vecchia cittadina» disse. «Spero di non disturbare.» Fece un sorriso a Margo. «Ormai lavoro per il patrimonio Anderson.» «Povero giovane» disse il giudice Cassidy, alzandosi. «Ho avuto l’onore di essere assai amico del tenente Anderson…» Crollando il capo, attraversò alla volta di Margo il soffice tappeto color susina. «Bene, mia cara signorina, dovete scusarmi. Ma il dovere mi chiama. È stato veramente delizioso.» Margo lo accompagnò fuori, alla macchina. La serata rosea svaniva nel crepuscolo. Un uccello motteggiatore cantava in un albero di pepe, accanto alla casa. «Quando posso portarvi le gioie?» disse Margo, piegandosi verso il giudice sopra il sedile anteriore dell’auto. «Forse farete bene a passare dal mio ufficio domani a mezzodì. Andremo insieme alla banca. Naturalmente la perizia sarà fatta a spese della cliente.» «Intesi, e spero che, entro allora, vi sarà venuto in mente qualche modo di far rendere subito la somma. A che serve un rialzo, se non si può
approfittarne?» Il giudice si piegò a darle un bacio. Quelle labbra umidicce le passarono sull’orecchio mentre lei ritraeva il capo. «Siate serio, giudice» disse. Nella stanza, Cliff andava su e giù come un matto. Si fermò di botto e venne verso Margo coi pugni serrati, come stesse per batterla. Stava masticando gomma; la mandibola stretta che si muoveva avanti e indietro gli dava un muso da pecora. «Dico io, che il padrone è ben trattato dalla povera orfanella.» «Cliff, se è tutto questo che sei venuto a dirmi fin quaggiù, puoi riprendere il treno e tornartene a casa.» «Ascolta, Margo, sono venuto per un affare importante.» «Un affare?» Margo si abbandonò su una poltroncina rosa troppo imbottita. «Siediti, Cliff… ma non c’era nessun bisogno di entrare qui come un usciere. Si tratta del patrimonio di Charley?» «Patrimonio un corno… Io voglio che tu mi sposi. I frutti sinora sono scarsi, ma una grande carriera mi attende.» Margo cacciò uno strillo e abbandonò la testa sullo schienale della poltroncina. Cominciò a ridere e non riusciva più a smettere. «No, sul serio, Cliff» diceva a sbruffi. «Ma io non voglio sposare nessuno ora… Cliff, insomma, bel bambino. Ti posso dare un bacio.» Cliff le venne addosso e cercò di abbracciarla. Margo scattò in piedi e lo respinse. «E neanche ho intenzione di lasciarmi rovinar la carriera da cose di questo genere.» Cliff s’accigliò. «Un’attrice non la sposerò mai… Le sciocchezze dovrai smetterle.» Margo scoppiò di nuovo a ridere. «Nemmeno un’attrice cinematografica?» «Al diavolo, tu scherzi soltanto e io che ammattisco per te.» Sedette sul divano e si torse la testa fra le mani. Margo gli venne accanto e sedette con lui. «Dimentica tutto, Cliff.» Cliff saltò in piedi. «Questo ti posso dire: dove credi d’arrivare facendo la stupida con quel vecchio baggiano di Cassidy? È un uomo sposato e così storto che deve ficcarsi di fianco nelle porte per passare. Ha truffato fin la camicia al padrone, in quell’affare dell’aeroporto. Boia… Ma questa non è certo una novità per te. Probabilmente eri
d’accordo e ci hai raschiato la tua parte… E poi credi che sia tutto da ridere quando un povero fesso fa tutto questo viaggio fino in fondo agli Stati per offrirti la protezione del suo nome. E va bene, io ne ho abbastanza. Buona… notte.» E se ne andò sbattendo la porta a vetri dell’entrata così forte che una lastra s’infranse e cadde tintinnando sul pavimento. Agnes si precipitò dalla sala da pranzo. «Oh che spavento» disse. «Ho ascoltato tutto. Credevo che il povero signor Anderson ti avesse lasciato un fondo di garanzia.» «Quel giovanotto ha dei grilli nel cervello» disse Margo. Un minuto dopo, trillò il telefono. Era Cliff con le lacrime nella voce, che chiedeva perdono, supplicava di poter ritornare a parlare della cosa con calma. «Neanche per sogno» disse Margo, e riattaccò. «Dunque, Agnes,» disse Margo venendo dal telefono «così è… Dobbiamo pensale a quel che si fa… Cliff dice bene di quel vecchio idiota di Cassidy. Comunque nessuno l’ha mai preso sul serio.» «Una persona tanto distinta» disse Agnes facendo un chioccolio con la lingua. Raymond annunciò la cena. Margo e Agnes mangiarono sole, ciascuna a un’estremità del lungo tavolo di mogano, ricoperto di sottocoppe e vasellame d’argento. La minestra era fredda e troppo salata. «Ho detto cento volte a quella sciocca ragazza di non toccare il brodo, soltanto vuotarlo dalla scatola e metterlo al fuoco» disse Margo stizzita. «Oh Agnes, te ne prego, occupati tu della casa… Io non riesco a ottenere nulla di ben fatto.» «Quanto mi piacerebbe» disse Agnes. «Però non ho mai tenuto una casa di queste proporzioni.» «Sta’ tranquilla che non la terrai» disse Margo. «Dovremo abbassar le pretese.» «Forse sarà meglio che scriva alla signorina Franklyn caso mai avesse ancora un posto per me.» «Aspetta solo un po’ di tempo» disse Margo. «Qui possiamo restare ancora un paio di mesi. Mi è venuto in mente che potrebbe essere un buon posto per Tony quaggiù. Che ne dici di mandargli un biglietto ché ci raggiunga? Credi che l’andrebbe ancora a vendere e tornerebbe agli stupefacenti?» «Ma è guarito. Me l’ha detto lui stesso che era interamente cambiato.» Agnes si mise a piagnucolare sul
piatto. «Oh, Margo, sei una ragazza col cuore in mano tu… Proprio come la povera mamma… sempre in pensiero per gli altri.» Tony quando giunse a Miami era smorto come una larva, ma stendersi sulla spiaggia al sole e tuffarsi nei frangenti lo rimise ben presto in buona forma. Era buono come il pane, pareva pieno di riconoscenza e aiutava Agnes nelle faccende domestiche, visto che avevano licenziato le cameriere; Agnes aveva dichiarato che non poteva cavarne nulla e preferiva far lei il lavoro. Quando venivano a trovarla uomini di sua conoscenza, Margo lo presentava come un parente cubano. Ma tanto lui che Agnes solitamente si tenevano nascosti, quando c’erano visite. Tony fu contento come una pasqua, quando Margo propose che imparasse a guidare la macchina. Subito guidò a meraviglia e poterono licenziare Raymond. Un giorno mentre Tony si preparava per condurla a un appuntamento con certi importanti sensali di terreni al Cocoanut Grove, Margo propose, così per scherzo, che Tony provasse se la vecchia uniforme di Raymond gli andava bene. Ci figurava benissimo. Quando gli propose di mettersela le volte che guidava la macchina, Tony ebbe un accesso di stizza e parlò di onore e di virilità. Margo lo calmò ripetendo che era tutto per scherzo e lui disse: «Sta bene» e la tenne. Margo comprese che l’uniforme non gli dispiaceva affatto, perché lo vide ammirarcisi nella specchiera dell’entrata. Ogni proprietà immobiliare a Miami era bloccata, eppure Margo riuscì a fare un guadagno di centomila dollari sulle opzioni che aveva in mano; sulla carta. Il brutto era che di questi guadagni non si poteva incassar nulla. I due gemelli conosciuti a Coral Gables le davano consigli in abbondanza, ma lei stava in guardia, e non le diedero mai altro che consigli. Erano sempre fra i piedi, la sera e la domenica, mangiavano ogni cosa che Agnes avesse in ghiacciaia, e bevevano tutto il liquore e facevano discorsi grandiosi a proposito di tutte le belle cose che avrebbero offerte a tutti quanti. Agnes diceva che non vuotava mai la sabbia fuori dalle sue pianelle da spiaggia senza aspettarsi di trovarci dentro uno dei due. E nemmeno si disobbligarono mai con qualche invito da parte loro, non arrivarono nemmeno una volta con una
bottiglia di scotch. Agnes era un po’ tenera con loro, perché Al le menava intorno un gran scalpore, mentre Ed cercava di dirsela con Margo. Una domenica, dopo che erano stati tutto il pomeriggio distesi al sole sulla spiaggia sorbendo cocktail, Ed irruppe nella stanza di Margo mentre lei si vestiva – eran rientrati per togliersi i costumi e vestirsi – e cominciò a strapparle di dosso l’accappatoio. Margo gli tirò un urlone, ma Ed era ubriaco come una scimmia e le tornò addosso peggio che mai. Lei dovette allora strillare perché corresse Tony e facesse il marito energico. Tony era bianco come un foglio di carta e tremava in tutte le membra, ma ce la fece a levare in aria una sedia e stava per menarla sulla testa di Ed, quando arrivarono Al e Agnes a vedere cosa fosse quel baccano. Al prese le parti di Ed e diede uno spintone a Tony e strillò ch’era un ruffiano e loro due un paio di puttane. Margo ebbe paura. E non se li sarebbero più levati di casa, se Agnes non fosse andata al telefono minacciando di chiamare la polizia. I gemelli dissero che non bastava, la polizia c’era apposta per cacciare fuori di città le donne come loro, ma comunque si buttarono addosso i vestiti e se ne andarono e fu quella l’ultima volta che Margo li vide. Dopo che furon partiti, Tony ebbe una crisi di pianto e disse che lui non era un ruffiano e questa vita era impossibile e si sarebbe ammazzato, se lei non gli dava il denaro per tornarsene all’Avana. Per indurlo a restare, dovettero promettergli che avrebbero lasciato Miami al più presto possibile. «Via, Tony, sai bene che anche tu vuoi andare in California» ripeteva Agnes e lo coccolava come un neonato. «Tanto i moscerini si fan sempre più noiosi sulla spiaggia» disse Margo. Scese in salotto e sbatté un altro cocktail per tutti e tre. «Ormai la baracca è sfondata. È tempo di lasciarla perdere» disse. «Ne ho abbastanza.» Era una giornata tanto torrida che friggeva, quando accatastarono le loro robe nella Buick e partirono con Tony al volante, non in uniforme ma in un nuovo attillato vestito di lino bianco. La Buick era talmente accatastata di valigie e aggeggi casalinghi che per Agnes nel sedile posteriore non rimase quasi posto. La chitarra di Tony pendeva al soffitto. Il baule guardaroba di Margo era assicurato dietro, con cinghie. «Santo Cielo,» disse Agnes, quando uscì dalla saletta
d’aspetto del distributore di West Palm Beach, dove s’eran fermati a far benzina «abbiamo l’aria di un baraccone ambulante.» Fra tutti possedevano un centinaio di dollari spicci, consegnati da Margo ad Agnes che li tenesse nella sua borsetta nera. Il primo giorno Tony non parlava d’altro che del suo futuro successo in cinematografia. «Se ci riesce Valentino, sarà facile per me» diceva, tendendo il collo per vedere il suo netto profilo bruno nello stretto specchio di guida in cima al parabrezza. Di notte si fermavano nei campeggi turistici, tutti in una sola baracca per fare economia, e mangiavano nelle scatole. Agnes ne era incantata. Diceva che era come ai bei tempi, quando lavoravano per l’organizzazione Keith, e Margo era una piccola attrice. Margo ribatteva piccola attrice un corno, a lei faceva l’effetto d’essere una vecchiaccia. Verso il pomeriggio Tony si lagnava di fitte lancinanti ai polsi e Margo doveva guidar lei. Costeggiando il golfo, sulle sponde dell’Alabama, del Mississippi e della Louisiana, le strade erano spaventevoli. Fu un bel sollievo quando giunsero nel Texas, benché i piovaschi vi fossero continui. Credettero che non avrebbero più veduto il fondo, però, dello Stato del Texas. Agnes disse che non aveva mai saputo che al mondo ci fosse tanta alfalfa. A El Paso dovettero comperare due nuovi pneumatici e far riparare i freni. Agnes cominciò a far la faccia preoccupata, quando contava il rotolo di biglietti nella sua borsetta. Negli ultimi due giorni di deserto alla volta di Yuma non mangiarono altro che una scatola di fave arrostite e un mazzo di salsicciotti. Faceva un caldo tremendo, ma Agnes non permetteva loro nemmeno una Coca-Cola negli spacci polverosi delle cittadine isolate, perché diceva che dovevan risparmiare fin l’ultimo centesimo se non volevano arrivare a Los Angeles in bolletta assoluta. Mentre andavano sbatacchiandosi nel polverone dello stradale non finito presso Yuma, un luccicante treno espresso della Southern Pacific passò loro innanzi: grossa imponente locomotiva nuova, vetture pullman, vettura ristorante, vetture ritrovo con ragazze e signori in abiti leggeri, sdraiati sulla piattaforma panoramica. Il treno li superò adagio e i facchini negri si sporgevano dai pullman ridendo e agitando la mano.
Margo ricordò le sue corse in Florida in scompartimento riservato e trasse un sospiro. «Non pensarci, Margie» intonò Agnes dal sedile posteriore. «Siamo quasi arrivati.» «Ma arrivati dove? Dove? Questo, voglio sapere» disse Margo, con le lacrime agli occhi. La macchina diede uno scossone che quasi infranse le molle. «Niente paura,» disse Tony «quando avrò fatto il punto, guadagnerò migliaia di dollari la settimana e viaggeremo in vettura privata.» A Yuma dovettero scendere all’albergo perché i campeggi erano zeppi, e questo fu un bel salasso. Non ne potevan più nessuno dei tre, e Margo si destò nella notte con un febbrone dovuto al caldo, alla polvere e alla fatica. L’indomani mattina la febbre l’aveva lasciata, ma le restavano gli occhi rossi ed enfiati e tutta insieme era uno spettacolo. Aveva bisogno di lavarsi la testa, i suoi capelli eran asciutti e filacciosi come una manciata di stoppa. L’indomani erano troppo stanchi per godersi la vista quando attraversarono le alte montagne fragranti e uscirono nella vallata di San Bernardino piena di curatissimi frutteti e aranceti che avevano ancora qualche fiore, e del fresco sentore dei fossati d’irrigazione. A San Bernardino, Margo disse che doveva assolutamente lavarsi la testa fosse magari l’ultima cosa che faceva in questo mondo. Avevano ancora venticinque dollari che Agnes a Miami aveva fatto uscire dalla spesa giornaliera, e dei quali non aveva mai parlato. Mentre Margo e Agnes andavano a un salone di bellezza, diedero un paio di dollari a Tony perché portasse a lavare la macchina. Quella sera fecero un vero pranzo da mezzo dollaro, alla trattoria, e poi andarono al cinematografo. Dormirono in una bella baracca spaziosa sulla strada di Pasadena in un campeggio che la donna del salotto di bellezza aveva loro indicato, e l’indomani mattina partirono di buon’ora, prima che la nebbia candida e viscida si fosse sollevata. La strada era ottima e attraversava miglia e miglia d’aranceti. All’ora che giunsero a Pasadena il sole s’era già levato, e Agnes e Margo dichiararono che quello era il più incantevole luogo che avessero mai veduto in vita loro. Ogni volta che passavano innanzi a una residenza particolarmente bella, Tony l’additava e diceva che là sarebbero andati a stare non appena lui avesse fatto il punto.
Videro cartelli che indicavano Hollywood, ma chi sa perché attraversarono tutta la città senza accorgersene, e si andarono a fermare di fronte a un piccolo ufficio di appigionamenti, a Santa Monica. Tutte le villette ammobiliate che quel tale aveva in lista erano troppo care e per giunta insisteva su un mese di pigione anticipato: risalirono in macchina. Finirono per scendere nel polveroso cortile di una villetta di stucco alla periferia di Venice, dove l’uomo parve impressionato dalla Buick turchina e dal baule guardaroba, e li lasciò occupare un alloggio chiedendo solamente una settimana d’anticipo. A Margo pareva un posto orribile, ma Agnes era entusiasta. Disse che Venice le ricordava Holland’s Beach dei bei tempi. «È proprio questo che a me dà la nausea» disse Margo. Tony entrò e si lasciò cadere sul letto e Margo dovette ricorrere ai vicini che l’aiutassero a portare le valigie e il baule guardaroba. Abitarono nel cortile di quella villa più mesi che Margo non volesse ammettere, neanche quando ancora ci stava. Margo s’iscrisse all’agenzia come Margo de Garrido. Venne assunta subito nelle scene di società come comparsa, per via dei suoi vestiti eleganti e di un certo qual modo d’indossarli che aveva imparato dal vecchio Piquot. Tony stava seduto nell’agenzia o bighellonava davanti al cancello di tutti i teatri di posa dove si mettesse in scena qualche film spagnolo o sudamericano, con un Cordoba a larghissima tesa acquistato da un vestiarista e calzoni stretti alla vita e qualche volta stivali e speroni da cow-boy, ma la sola cosa di cui c’era abbondanza era il tipo latino. Si fece triste e irritabile, e si diede a scarrozzare con l’auto piena di giovincelli smancerosi raccolti in giro, finché Margo non puntò il piede a terra e disse che l’auto era sua e di nessun altro, e non le portasse più in casa quei fantocci. Tony se la prese e uscì di casa, ma Agnes, che s’occupava delle faccende domestiche e maneggiava tutti i quattrini che Margo guadagnava, disse che non gli avrebbe più dato un soldo per le spese, finché non avesse chiesto scusa. Tony stette via due giorni e ritornò con un’aria affamata da cane bastonato. Da quella volta Margo gli fece indossare la vecchia uniforme d’autista, quando la conduceva al teatro di posa. Sapeva che vestito
così non sarebbe andato in nessun posto lasciando lei, ma subito a casa a cambiarsi, e allora Agnes gli poteva togliere la chiave dell’auto. Margo a volte tornava spossata da una giornata interminabile al teatro di posa, e trovava che lui se n’era restato in casa tutto il giorno a strimpellare It Ain’t Gonna Rain No More sulla chitarra, a dormire e sbadigliare su tutti i letti e buttare dappertutto la cenere delle sigarette. Diceva che Margo gli aveva rovinato la carriera. Quel che Margo più detestava di lui era il modo come sbadigliava. Una domenica, dopo che da tre anni abitavano la periferia di Los Angeles, trasferendosi da una villetta all’altra, e Margo se la cavava abbastanza soddisfacentemente nei teatri di posa come comparsa – ma nessun direttore le aveva mai posto gli occhi addosso – e riusciva a metter da parte qualche soldo per pagare gli interessi – ma non mai abbastanza in somma globale da riscattare una volta tanto i gioielli alla banca di Miami – s’eran recati nel pomeriggio in macchina ad Altadena. Sulla via del ritorno si fermarono a una autorimessa per far riparare una gomma e fuori, di fronte alla rimessa, c’erano in vendita certe macchine d’occasione. Margo passeggiava avanti e indietro osservandole, tanto per far qualcosa mentre aspettavano. «Non vi converrebbe una Rolls-Royce, signora?» disse l’inserviente scherzando, mentre toglieva il martinetto da sotto la macchina. Margo s’arrampicò nella grande berlina nera con lo stemma rosso sugli sportelli e provò il sedile. Certo era comodo. Si sporse fuori e disse: «Quanto la mettete?». «Mille dollari… è regalata.» «La metà sarebbe ragionevole» disse Margo. Agnes era uscita dalla Buick e s’avvicinò: «Sei pazza, Margie?». «Può darsi» disse Margo e chiese quanto le avrebbero scontato, se in cambio lasciava la Buick. L’inserviente chiamò il padrone, un giovanotto faccia di rospo col monogramma sulla camicia di seta. Lui e Margo discussero intorno al prezzo per un’ora di alti e bassi. Tony si provò a guidare la macchina e disse che filava come un sogno. Era tutto ringalluzzito all’idea di guidare una Rolls, anche se vecchia. Alla fine quel tale prese la Buick e cinquecento dollari a rate settimanali di dieci. Firmarono il contratto là su due piedi, Margo diede i nomi del giudice Cassidy e di Tad Whittlesea come referenze; cambiarono di
posto al vasellame e quella sera tornarono a Santa Monica, dove abitavano allora, in Rolls-Royce. Mentre a Beverly Hills voltavano nel boulevard Santa Monica, Margo disse con noncuranza: «Tony, quella manopola che regge la spada non ricorda assai lo stemma dei conti de Garrido?». «Questa gente di qui è così ignorante che non s’accorgerebbe della differenza» disse Tony. «La lasceremo dov’è» disse Margo. «Certamente» disse Tony «sta molto bene.» Le altre comparse certo spalancarono gli occhi l’indomani, quando Tony nella sua attillata uniforme bigia la portò al teatro di posa, ma Margo conservò il suo viso impassibile. «È il vecchio carrozzone di famiglia» disse, quando una ragazza le fece la domanda. «Finora era in pegno.» «È vostra madre, quella?» domandò ancora la ragazza, puntando il pollice ad Agnes che s’allontanava seduta dentro l’enorme auto lucente, vestita del suo più bel nero, il naso levato all’insù. «Oh no» disse Margo freddamente. «Quella è la mia compagna.» Molti uomini cercarono di fissare un appuntamento con Margo, ma erano quasi tutti comparse o fotografi o fornitori o carpentieri, e lei ed Agnes non vedevano che potesse giovarle imbrancarsi con loro. Era una vita solitaria dopo tutte le amicizie e gli spasimanti e i maneggi d’affari e ogni cosa di Miami. Quasi tutte le sere lei e Agnes giocavano a banco russo o bridge col morto, se Tony era in casa e di umore non troppo cattivo per adattarsi. Qualche volta andavano al cinema o alla spiaggia se faceva abbastanza caldo. Uscivano in macchina tra la folla sul boulevard Hollywood le sere che c’era una prima al Grauman’s Chinese Theatre. La Rolls era così elegante e Margo aveva ancora un bell’abito da sera non troppo giù di moda; tanto che la gente le pigliava per stelle. Un polveroso sabato pomeriggio di mezz’inverno Margo si sentiva particolarmente disperata, perché la moda era mutata al punto che non poteva più indossare i suoi vecchi abiti e non aveva denaro per altri nuovi. Balzò in piedi dalla sedia sparpagliando sul pavimento il mazzo di carte da solitario e gridò ad Agnes che le occorreva un po’ di svago altrimenti lei ammattiva. Agnes disse se non volevano allora andare a Palm Springs a vedere il nuovo albergo mondano. Avrebbero
cenato là se non costava troppo e poi passato la sera in un campeggio turistico sulla spiaggia del Salton Sea. Provare almeno a levarsi dalle ossa il gelo della nebbia di Los Angeles. Quando furono a Palm Springs, Agnes s’accorse che ogni cosa aveva un’aria troppo costosa e voleva tirare innanzi sull’auto, ma Margo si trovò senz’altro nel suo elemento. Tony indossava l’uniforme e doveva aspettarle in macchina. Era così truce in viso che Margo pensò che sarebbe scoppiato quando gli disse di andarsi a cercare un po’ di cena a una bancarella di salsicce, ma lui non osò ribattere perché c’era là il guardaportone. Erano state al gabinetto delle signore a rinfrescarsi un po’ il viso e passeggiavano su e giù sotto le grandi palme da datteri guardando nella folla, caso mai riconoscessero qualche attore cinematografico, quando Margo sentì una voce che le era familiare. Un individuo fosco e sparuto in sergia bianca, che discorreva con un calvo signore ebreo dall’aria importante, la stava fissando. Lasciò il suo compagno e s’accostò. Aveva un passo rigido, come un ufficiale che ispezioni una compagnia piantata sull’attenti. «Signorina Dowling,» le disse «che fortuna per tutti e due.» Margo guardò sorridente quel viso smorto e contratto, dalle borse scure sotto gli occhi. «Ma voi siete il fotografo» disse. Quello la fissò duro: «Sam Margolies» disse. «Lo sapete che ho frugato tutta l’America e l’Europa in cerca di voi… Favorite trovarvi al mio ufficio per il provino domani alle dieci… Irwin vi dirà i particolari.» Sventolò leziosamente la mano alla volta dell’individuo grasso. «Vi presento il signor Harris… la signorina Dowling… perdonate, io non mi prendo mai la responsabilità di presentar persone… Ma voglio che Irwin vi veda… questa è una delle più belle donne d’America, Irwin.» Abbassò la mano davanti a Margo a qualche centimetro dal viso di lei, dimenando le dita come se modellasse qualcosa nella creta. «Ordinariamente sarebbe impossibile fotografarla. Io soltanto posso mettere quel viso sullo schermo…» Margo si sentì correre un gelo per la schiena. Sentì dietro a sé la bocca di Agnes spalancarsi in un anelito. Lasciò spuntarsi un lento sorriso di scherno agli angoli della bocca. «Guardate, Irwin» esclamò Margolies,
afferrando l’uomo grasso alla spalla. «È lo spirito vero della commedia… Ma perché non siete mai venuta a cercarmi?» Parlava con uno spiccato accento straniero. «Che cosa ho mai fatto perché doveste trascurarmi?» Margo ebbe un’aria seccata. «La signora Mandeville, la mia… compagna… Stiamo dando un’occhiata alla California.» «Che altro c’è tranne i teatri di posa?» «Forse vorrete condurre la signora Mandeville a fare un giro per un teatro di posa. È così ansiosa di visitarne qualcuno e in questa parte del mondo io non conosco un’anima… non un’anima.» «Ma certo, domani vi farò condurre da qualcuno a visitare tutto ciò che desiderate. Non c’è nulla da vedere che cose stupide e volgari… Irwin, questo è il viso che ho tanto cercato per la piccola bionda… ricordate… Mi parlate di agenzie, comparse… sciocchezze, non sono attori che mi occorrono… Ma, signorina Dowling, dove siete stata? Ero quasi sicuro di trovarvi a Baden-Baden l’estate scorsa… Siete il tipo di Baden-Baden. È un posto ridicolo, ma bisogna pure andare da qualche parte… Dove siete stata?» «Florida… l’Avana… questi paesi.» Margo pensava tra sé che l’ultima volta che s’eran visti lui non usava l’a larga. «E avete rinunciato al teatro?» Margo diede una scossetta di spalle. «In casa ne erano così indignati.» «Oh, non mi è mai piaciuto che calcasse il palcoscenico» esclamò Agnes che era in attesa dell’occasione di introdurre una parola. «Vi piacerà lavorare per il cinema» disse blando quello grasso. «Mia cara Margo,» disse Margolies «non è una parte molto ampia, ma voi ci state alla perfezione, alla perfezione. Saprò esprimere da voi il mistero occulto… Non ve lo dicevo, Irwin, che si doveva uscir fuori del teatro e vedere il mondo?… aprire il libro della vita?… In questo ridicolo caravanserraglio ecco che troviamo il volto, lo spirito della commedia, il sorriso di Monna Lisa… È un quadro famoso a Parigi, che si dice valga cinque milioni di dollari… Non chiedetemi come sapessi che l’avrei trovata qui… Ma lo sapevo. Certo, fin dopo il provino non possiamo avere la certezza definitiva… Mai mi comprometto io…»
«Ma, signor Margolies, non so se potrò fare quanto dite» disse Margo, col cuore che picchiava. «Siamo qui di scappata… Abbiamo affari importanti da badare a Miami… cose di famiglia, mi capite.» «Non ha importanza. Vi troverò un amministratore… manderemo qualcuno… I particolari meschini non hanno nessuna importanza per me. Beni immobili, immagino.» Margo annuì vagamente. «Circa due anni fa la casa dove abitavamo, era così incantevole, venne spazzata in mare» disse Agnes d’un fiato. «Avrete una casa migliore… Malibu Beach, Beverly Hills… Odio le case… Ma son stato villano, vi ho trattenute qui… Però dimenticherete Miami. Abbiamo ogni cosa qui… Ricordate, Margo carissima, quando vi ho detto quel giorno che il cinematografo aveva un grande avvenire… voi e… sapete, quel grande magnate dell’automobile, ho dimenticato il nome… Ve lo dissi che avreste sentito parlare di me in cinematografia… Raramente io faccio predizioni, ma non sbaglio mai. Sono fondate sulla fede in un sesto senso.» «Oh, sì,» interruppe Agnes «è così vero: se credete di riuscire veramente, non potete fallire: è quanto ripeto sempre a Margie…» «Meravigliosamente detto, cara signora… Signorina Dowling, cara, Continental Attractions, alle dieci… Metterò qualcuno di sentinella al cancello in modo che lascino proseguire il vostro autista fino al mio ufficio. È impossibile avermi al telefono. Nemmeno Irwin può arrivare fino a me, quando lavoro a un film. Sarà un’esperienza per voi, vedermi al lavoro.» «Intesi, se ce la farò e il mio autista troverà la strada.» «Verrete» disse Margolies e tirò con sé Irwin Harris per un corto braccio di flanella bianca nella sala da pranzo. Gente molto elegante fissava i due mentre se ne andavano. Poi fissarono Margo e Agnes. «Andiamo alla bancarella a dirlo a Tony. Tutto quel che penseranno sarà che siamo eccentriche» bisbigliò Margo all’orecchio di Agnes. «Ti assicuro che non avevo mai pensato che il grande Margolies fosse lui.» «Oh, non è una cosa prodigiosa?» disse Agnes. Erano così eccitate che non poterono mangiare. Ritornarono quella
sera a Santa Monica e Margo andò subito a letto per essere ben riposata l’indomani. Il mattino dopo quando giunsero al teatro di posa alle dieci meno un quarto, il signor Margolies non aveva lasciato detto nulla. Nessuno sapeva di un appuntamento. Attesero mezz’ora. Agnes faceva fatica a trattenere le lacrime. Margo rideva. «Scommetto che quel tipo era pieno di cocaina e non si ricorda più di nulla.» Ma dentro stava orribilmente. Tony aveva già riacceso il motore e stava per partire, perché a Margo non garbava farsi vedere in attesa davanti al cancello a quel modo, quando una candida berlina Pierce-Arrow con Margolies tutto in flanella candida e berretto candido seduto solo, dietro, giunse al loro fianco. Margolies aguzzava gli occhi dentro la Rolls-Royce, e Margo lo vide trasalire per la sorpresa, quando l’ebbe riconosciuta. Con una mazza dal pomo di porcellana tamburellò sul vetro della propria auto. Poi discese a terra e si sporse all’interno a prendere la mano di Margo. «Non chiedo mai scusa… Sovente mi è necessario far attendere la gente. Verrete con me. Forse la vostra amica vorrà venirvi a cercare alle cinque… Ho molte cose da dirvi e da mostrarvi.» Salirono in ascensore su per un alto caseggiato dalla facciata comune. La introdusse per successivi uffici, dove giovanotti in maniche di camicia lavoravano a tavoli da disegno, stenografe battevano a macchina, attori aspettavano seduti su panche. «Frieda, subito un provino per la signorina Dowling, fate il favore» disse passando davanti a una segretaria a una grande scrivania, nell’ultima stanza. Poi la introdusse nell’ufficio suo, tappezzato di quadri cinesi e con una sola enorme poltrona gotica scolpita posta al riverbero di un minuscolo riflettore contro una vasta scrivania gotica scolpita. «Sedete, vi prego… Margo carissima, come posso farvi comprendere il piacere che mi dà un viso incontaminato dall’obiettivo? Come vedo che non ha tensione… Voi non vi inquietate. La freschezza celtica che si fonde al disdegno della nobile Spagna… Come vedo che non siete mai stata prima d’ora davanti a un obiettivo… Perdonate.» Si sprofondò nella poltrona dietro alla scrivania e cominciò a telefonare. Di tanto in tanto veniva una stenografa e prendeva appunti che Margolies le dettava a voce sommessa. Margo sedeva sempre. Pensò
che Margolies si fosse dimenticato di lei. La stanza era calda e sapeva di chiuso e cominciava a insonnolirle gli occhi. Stava lottando per tenerli aperti, quando Margolies saltò su dal posto e disse: «Venite, carissima, scenderemo ora». Margo si piantò a destra e a sinistra per un certo tempo davanti a diverse macchine fotografiche in una stanza a pianterreno, che sapeva di gesso, e poi Margolies la portò a colazione nell’affollato ristorante del teatro. Margo sentiva che tutti levavan gli occhi dal piatto per vedere chi fosse la nuova ragazza che Margolies portava a colazione. Mentre mangiavano, le fece domande sulla sua vita nella grande piantagione di zucchero a Cuba e sugli esordi infantili di New York. Poi le parlò di Carlsbad, Baden-Baden, Marienbad e di come la California meridionale stesse spogliandosi della sua primitiva ridicola volgarità. «Abbiamo qui tutto ciò che potete trovare in qualunque altro paese» disse. Dopo la colazione andarono a vedere i provini nella sala di proiezione. Comparve anche il signor Harris con un sigaro in bocca. Nessuno parlava mentre guardavano l’enorme faccia bianco-grigia di Margo, che rideva, si volgeva, s’atteggiava a una smorfia, spalancava e chiudeva la bocca, arrovesciava il capo, torceva gli occhi. Dava a Margo un grande senso di disagio, guardare, benché solitamente le piacessero le sue fotografie. Non poteva abituarsi a veder la sua faccia così enorme. Di tanto in tanto il signor Harris grugniva e la punta rossa del suo sigaro avvampava. Margo provò un sollievo, quando il film fu finito e ricadde il buio. Poi s’accesero le lampade, e sfilarono fuori della sala di proiezione passando davanti a un operatore in maniche di camicia e rosso in faccia, che aveva spalancato l’usciolo del piccolo sgabuzzino nero dov’era la macchina e diede a Margo uno sguardo mentre passava. Margo non poté capire che impressione gli aveva fatto. Sul pianerottolo della scala esterna, Margolies tese freddamente la mano e disse: «Arrivederci, cara Margo… sono atteso da un centinaio di persone». Margo credette che tutto fosse perduto. Poi Margolies continuò: «Voi e Irwin penserete alla sistemazione finanziaria… Io non ci capisco nulla di queste cose… Son certo che passerete un
delizioso pomeriggio». Si volse per tornare nella sala di proiezione, roteando la mazza mentre entrava. Il signor Harris spiegò che il signor Margolies le avrebbe fatto sapere quando avesse bisogno di lei e che intanto avrebbero messo insieme il contratto. Aveva un amministratore la signorina? Se non l’aveva, lui le consigliava che gli lasciasse chiamare l’amico signor Hardbein alla tutela dei suoi interessi. Quando fu nell’ufficio, col signor Harris seduto di là dalla scrivania e il signor Hardbein, un uomo dal viso infossato e un pesante fare scherzoso, seduto accanto, si trovò a leggere un contratto per tre anni a trecento settimanali. «Mio Dio,» disse «ho paura che ne avrò fin sopra i capelli dopo tutto questo tempo… Vi dispiace se faccio venir qui la mia compagna, la signora Mandeville?… M’intendo così poco di queste cose.» Poi telefonò ad Agnes e rimasero a cianciare della pioggia e del bel tempo finché Agnes non giunse. Agnes fu meravigliosa. Parlò di impegni e d’affari importanti da concludere e d’una sostanza a cui pensare, e disse che per quella cifra non valeva la pena che la signorina Dowling rinunciasse alla sua crociera intorno al mondo, vero, cara? e se insomma compariva nel film era solo per compiacere all’antica amicizia col signor Margolies: certo, la signorina Dowling ne aveva sempre fatti di sacrifici per il suo lavoro; e anche lei ci si era sacrificata e se era necessario si sarebbe logorata le dita fino all’osso per darle modo di arrivare a quel successo in cui credeva, ed era certa di vederla arrivare perché, se si crede con un cuore puro, Dio fa accadere le cose proprio nel modo che si vuole. Agnes continuò a parlare su che cosa orribile fosse l’incredulità e alle cinque, giusto all’ora in cui chiudevano l’ufficio, se ne uscirono alla volta della loro macchina con un contratto per tre mesi a cinquecento settimanali nella borsetta di Agnes. «Speriamo che i negozi siano ancora aperti» diceva Margo. «Bisogna che trovi qualche abito.» Un individuo terreo dall’aria brutale e dai chiari capelli stopposi stava seduto in costume di cavallerizzo nel sedile anteriore a fianco di Tony. Margo e Agnes fulminarono un’occhiata su quella nuca piatta, mentre salivano nell’auto. «Portaci da Tasker and Harding in Hollywood Boulevard… La sartoria parigina» disse Agnes. «Mio Dio,
come è bello che tu ti prenda qualche abito nuovo» bisbigliò all’orecchio di Margo. Quando Tony depose lo sconosciuto all’angolo di Hollywood e Sunset, quello s’inchinò rigidamente e s’allontanò sul largo marciapiede. «Tony, non so quante volte ti ho già detto che non devi caricare i tuoi amici nella mia macchina» cominciò Margo. Tra lei e Agnes gliene dissero tante, che quando fu giunto a casa Tony era fuori di sé e annunciò che l’indomani se ne sarebbe andato. «Tu non hai fatto altro che sfruttarmi e intralciarmi la carriera. Quel tale era Max Hirsch. È un conte austriaco e un famoso giocatore di polo.» L’indomani, proprio sul serio Tony fece su le cose sue e se ne andò. I cinquecento settimanali non furono troppi, come Agnes e Margo avevano creduto. Prima cosa l’amministratore Hardbein ne scalò il dieci per cento, poi Agnes volle a tutti i costi che ne depositassero cinquanta per saldare il debito di Miami e così riavere i gioielli di Margo. Poi, trasferirsi in una nuova casa nel quartiere elegante di Santa Monica venne a costare un occhio. C’erano da pagare i salari di una cuoca e di una cameriera e, ora che Tony se ne era andato, dovettero anche prendere un autista. E restavano gli abiti e l’incaricato della pubblicità e ogni sorta di beneficenze e di regalie nel teatro di posa, a cui non ci si poteva sottrarre. Agnes era meravigliosa. Badava lei a tutto. Ogni volta che si presentava qualche problema d’amministrazione, Margo si premeva le dita ai due lati della fronte e teneva gli occhi chiusi un istante e gemeva. «È una bella seccatura, ma davvero la mia testa non ce la fa in affari.» Fu Agnes che trovò la nuova casa, una villetta stile Porto Rico, coi più incantevoli balconi, piena zeppa di antico mobilio spagnolo. La sera, Margo sedeva su una poltrona imbottita nel grande salone di fronte al camino aperto e giocava a banco russo con Agnes. Ricevettero diversi inviti da parte di attori e di gente che Margo incontrava al teatro di posa, ma lei diceva che non sarebbe uscita in società prima d’avere ben capito qual era l’eletta del posto. «Neanche ce ne accorgeremmo e ci faremmo vedere con qualche banda di gentaglia che ci farebbe più male che bene.» «Com’è vero ciò» sospirò Agnes. «Pensa a quegli odiosi gemelli di Miami.»
Non seppero più nulla di Tony finché, una domenica sera che Sam Margolies doveva venire a trovarle per la prima volta, eccolo che comparve sbronzo, circa alle sei, a dire che lui e Max Hirsch volevano aprire una scuola di polo e gli occorrevano mille dollari seduta stante. «Ma Tony,» disse Agnes «dove vuoi che Margie li trovi?… Sai anche tu che spese forti abbiamo.» Tony fece una scenataccia, tempestò e pianse e disse che Agnes e Margo gli avevano rovinato la carriera teatrale e adesso s’eran messe a rovinargli quella cinematografica. «Sono stato troppo tollerante» strillò, picchiandosi sul petto. «Mi son lasciato rovinare da due donne.» Margo badava a sbirciare l’orologio sul camino. Erano quasi le sette. Tirò allora fuori venticinque dollari e gli disse di ritornare in settimana. «Si è ridato agli stupefacenti» disse, dopo che lui fu partito. «Uno di questi giorni gli dà di volta il cervello.» «Poveretto,» sospirò Agnes «non è un ragazzo cattivo, solo è troppo debole.» «Quello che mi fa paura è se quell’austriaco gli mette addosso le mani e ci prepara delle noie… Quel tale aveva una faccia da penitenziario… credo che il meglio sia ancora cercare un avvocato e tentare un divorzio.» «Ma pensa alla pubblicità» gemette Agnes. «A buon conto» disse Margo «Tony deve uscirmi dai piedi. Non ho più niente da guadagnare con quel lavativo.» Sam Margolies giunse con un’ora di ritardo. «Che pace» si mise a dire. «Come potete trovarla nella frenetica Hollywood?» «Vedete, Margie è semplicemente una tranquilla bambina che ama il suo lavoro» disse Agnes, raccogliendo il cestello del cucito e muovendosi per sgusciar fuori. Lui sedette nella poltrona imbottita senza levarsi il berretto candido e allungò le gambe storte verso il fuoco. «Odio tutto quest’artificio.» «Nevvero?» disse Agnes dall’uscio. Margo gli offrì un cocktail, ma lui disse che non beveva. Quando la cameriera portò la cena, su cui Agnes aveva lavorato tutto il giorno, lui non volle toccar nulla, se non crostini e lattuga. «Non mangio né bevo mai, all’ora dei pasti. Vengo soltanto per guardare e parlare.» «È per questo che siete così sottilino» scherzò Margo. «Vi ricordate com’ero in quei giorni lontani? Il mio periodo di New York. Non parliamone. Io non ho memoria. Vivo solamente nel presente. Ora, io
penso al film di cui sarete la protagonista. Non vado mai a ricevimenti, ma stasera dovete venire con me da Irwin Harris. Ci sarà gente che dovrete conoscere. Fatemi vedere i vostri vestiti. Vi sceglierò quel che dovete indossare. D’ora innanzi dovrete sempre farmi venire con voi quando comprate un vestito.» Salendole dietro per la scala scricchiolante alla volta della camera da letto, le disse: «Ci vorrà per voi un’altra cornice. Questa non va. È suburbana». Faceva un effetto curioso a Margo passare in macchina per i viali di palme di Beverly Hills seduta accanto a Sam Margolies. Le aveva fatto indossare il vecchio abito da sera giallo comperato anni prima da Piquot, che Agnes le aveva recentemente fatto ripassare e allungare da un piccolo sarto francese scovato a Los Angeles. Margo aveva le mani diacce e temeva che Margolies le sentisse il cuore picchiare contro le costole. Cercò di trovare qualcosa di buffo da dire, ma tanto non serviva a nulla: Margolies non rideva mai. Si chiedeva che cosa stesse pensando. Poteva vederne il volto, la fronte bassa sotto il ciuffo nero, le labbra imbronciate, il profilo grifagno fosco contro i lampioni, mentre le sedeva rigidamente accanto con le mani sulle ginocchia. Vestiva ancora la sua flanella candida, con una fascia candida al collo e, sopra, una spilla di diamanti in forma di una mazzetta da golf. Mentre l’auto infilava un’entrata alla volta di una fila di alte finestre a balcone illuminate in mezzo agli alberi, si volse a lei e disse: «Voi temete di dovervi annoiare… Vi sorprenderà. Troverete che abbiamo qui qualcosa che vale la società straniera e newyorkese cui siete avvezza». Mentre le volgeva la faccia, la luce gli brillò sul bianco degli occhi e sulle borse flosce sottostanti e sulle grosse labbra umide. Continuò a sussurrare stringendole la mano mentre l’aiutava a scendere. «Sarete qui la donna più elegante, ma soltanto come una stella è più luminosa delle altre stelle.» Passando nell’ingresso accanto al maggiordomo, Margo si colse sul punto di sogghignare. «Non la smettete mai» disse. «Voi parlate, parlate come un… come un genio.» «È così che mi dicono, infatti» esclamò Margolies a voce alta, gettando indietro le spalle e piantandosi rigido sull’attenti per farsela passare innanzi, attraverso i grandi battenti a vetri, nel vestibolo.
Il passo più difficile fu andare nella sala da toeletta a deporre il mantello. Le donne che stavan truccandosi e battendo un’ultima carezza sui capelli si volsero tutte e le diedero una rapida squadrata che cominciò dalle scarpette, corse su per le calze, cercò ogni gancio ed occhiello del vestito, girò intorno al collo per vedere se c’eran rughe e fin nei capelli per vedere se eran tinti. Senz’altro Margo capì che ci voleva un mantello d’ermellino. C’era una vecchia signora, che stava in piedi fumando una sigaretta presso la porta del lavabo in un abito tutto fatto di ghiaccio pesto: costei aveva degli occhi radioscopici. Margo la sentì leggerle il cartellino del prezzo sulla biancheria. La cameriera negra, ricevendo sul braccio il suo soprabito, le rivolse un bel sogghigno dentuto, che la rimise in sesto. Margo andandosene sentì le occhiate piombarle in fascio sulla schiena e restar là attaccate come una latta alla coda di un cane. Qui ci vuole muso duro, non ti mangiano mica, ripeteva a se stessa, mentre la porta della sala per signore si chiudeva alle sue spalle. Desiderò ci fosse Agnes per dirle come tutti erano amabili. Margolies la stava attendendo nel vestibolo pieno di scintillanti candelieri. C’era un’orchestra che suonava e tutti ballavano in una grande sala. La condusse al camino, in fondo. Irwin Harris e il signor Hardbein, che si somigliavano come due gocce d’acqua nei loro abiti da sera stretti, s’avvicinarono salutando. Margolies diede loro una mano ciascuno, senza guardarli, e sedette al caminetto con la schiena alla folla in una grande poltrona scolpita, come quella che aveva nel suo ufficio. Il signor Harris la invitò a ballare. Da quel momento fu come in una qualunque altra accolta di abiti da sera. Almeno, finché non si trovò a ballare con Rodney Cathcart. Lo riconobbe subito dalle fotografie, ma fu un colpo vedere che quel viso era colorito e che sotto quell’assassino abito da sera c’erano muscoli e tiepido sangue. Era un giovanotto alto, abbronzato, dai capelli color pesciolino dorato e dal modo inglese di brontolare le parole. Margo aveva sentito brividi di freddo finché non cominciò a ballargli insieme. Dopo aver ballato con lei una volta, la invitò di nuovo. Tra un ballo e l’altro la condusse al buffè in fondo alla sala e cercò di farla bere. Lei portava ogni volta alle labbra uno scotch con
selz in un bicchierone azzurro e vi dava un sorsetto, mentre lui buttava giù un paio di scotch e mangiava un gran piatto d’insalata di pollo. Pareva leggermente brillo, ma non pareva mai peggiorare. Non diceva una parola e nemmeno lei diceva una parola. Ballare con lui le piaceva. Di tanto in tanto, quando nel giro del ballo giungevano in fondo alla sala, lei aveva una visione di tutta la sala nell’enorme specchio sopra il camino. Una volta, quando furono all’angolo giusto, le parve di vedere la faccia di Margolies che la fissava seduto nella scolpita poltrona dall’alto schienale fronteggiante i ceppi in fiamme. Pareva fissarla con grande attenzione. La vampa del fuoco che gli giocava sul volto gli dava una calda aria vivace, che Margo non vi aveva mai notato prima. Subito teste bionde, teste ricciute, teste calve, spalle nude, spalle nere entrarono frammezzo e le nascosero quell’angolo della sala. Doveva essere circa mezzanotte, quando lo trovò ritto accanto al tavolino dov’era lo scotch. «Ciao, Sam» disse Rodney Cathcart. «Come vanno le cosette?» «Bisogna che ce ne andiamo, ora, la povera ragazza è spossata da tutto questo frastuono… Rodney, devi lasciare in libertà la signorina Dowling.» «Bene, socio» disse Rodney Cathcart; e volse le spalle per mescersi un altro bicchiere di scotch. Quando Margo ritornò con la sua roba, trovò il signor Hardbein che l’attendeva nel vestibolo. S’inchinò stringendole la mano. «Dunque, non vi nascondo, signorina Dowling, che avete fatto un gran colpo. Tutte le ragazze van chiedendo che cosa usate per tingervi i capelli.» Una risata gli rumoreggiò sotto il largo panciotto. «Vorreste passare al mio ufficio? Potremmo mangiare un boccone e parlare un po’ delle nostre faccende.» Margo diede un piccolo fremito. «È un amabile pensiero questo, signor Hardbein, ma io non entro mai in un ufficio… Non li capisco gli affari… Ci telefonerete, vero?» Quando uscì sotto il portico coloniale c’era Rodney Cathcart seduto accanto a Margolies nella lunga auto candida. Margo mostrò un risolino e si ficcò tra i due altrettanto disinvolta che se si fosse sempre attesa di trovare là Rodney Cathcart. La macchina partì. Nessuno disse nulla. Margo non capiva dove andassero, tutti i viali di
palme e le fughe di lampioni si somigliavano. Fermarono a un grande ristorante. «Penso che sarebbe bene fare uno spuntino… Non avete preso nulla in tutta la sera» disse Margolies, dandole una strizzata alla mano mentre l’aiutava a discendere. «Cosa videro le mie pupille» esclamò Rodney Cathcart ch’era saltato per primo giù dall’auto. «Queste danze mettono una fame da lupi.» Il capocameriere s’inchinò quasi fino a terra e li condusse attraverso il ristorante pieno d’occhi a un tavolino riservato per loro sul bordo del palchetto. Margolies bevve latte con biscottini di grano tostato, Rodney Cathcart mangiò una bistecca, e Margo si portò alla bocca in punta di forchetta qualche pezzetto di pasticcio d’aragosta. «Dopo di che un disgraziato ha bisogno d’un sorso» borbottò Rodney Cathcart, respingendo il piatto donde aveva spolverato fin l’ultima patata fritta. Margolies levò due dita. «Qui è proibito… Come siamo sciocchi in questo paese… Come sono sciocchi.» Rotò gli occhi alla volta di Margo. Lei colse a tempo un ammicco per trasformarlo in battito della palpebra e gli rivolse quel lento sorriso sospeso, sul quale lui aveva menato tanto scalpore a Palm Springs. Margolies si alzò in piedi. «Venite, Margo carissima… Ho qualcosa da mostrarvi.» Mentre lei e Rodney Cathcart gli andavano dietro verso l’uscita sul tappeto rosso, Margo sentiva onde di eccitamento correre per la folla del ristorante, a quel modo che le aveva sentite quando andava in qualche posto a Miami dopo che Charley Anderson s’era ammazzato. Margolies li portò in auto a un gran caseggiato color crema. Salirono dentro un ascensore. Aprì una porta con la chiavetta e li introdusse. «Questo» disse «è il mio nido di scapolo.» Era una grande camera buia con un balcone in fondo, dalle cortine ricamate. Le pareti eran coperte di quadri a olio ciascuno illuminato dall’alto da una piccola luce particolare. C’erano tappeti orientali ammucchiati l’uno sull’altro sul pavimento e divani contro tutte le pareti ricoperti di pelli di zebra e di leone. «Oh, che meraviglia di stanza» disse Margo. Margolies si volse a lei, sorridendo. «Un po’ feudale, vero? È quel tipo d’interno che siete avvezza a vedere nel castello di un grande di Castiglia.» «Proprio» disse Margo. Rodney Cathcart si abbandonò lungo e disteso sopra uno dei divani. «Di’ un
po’, Sam, vecchio mio,» disse «ne hai ancora di quella grandiosa birra canadese? Si potrebbe metterci un goccio di Guinness?» Margolies entrò in una dispensa e l’uscio a molla gli si chiuse alle spalle. Margo gironzolò osservando i quadri a vivaci colori e le file di figure cinesi contorcentisi. Le mettevano paura degli spettri. «Ehilà» esclamò Rodney Cathcart dal divano. «Venite fin qui, Margo… Siete simpatica… Dovete chiamarmi Si… Così mi chiamano gli amici. E più americano.» «Per me, d’accordo» disse Margo, venendosene alla volta del divano. Rodney Cathcart tese le mani. «Qua la mano, socia» disse. Quando Margo gli ebbe data la sua, lui la serrò e cercò di tirarsela addosso sul divano. «Non vuoi proprio darmi un bacio, Margo?» Aveva una presa terrificante. Margo sentiva quanto fosse robusto. Margolies ritornò con bottiglie e bicchieri su un vassoio e depose il tutto su uno sgabello d’ebano presso il divano. «È qui che faccio il mio lavoro» disse. «Il genio non può nulla senza l’ambiente adatto… Sedete.» Additò il divano dove giaceva Cathcart. «Ho ucciso io stesso quel leone… Scusatemi un istante.» Salì su per la scala nella galleria e una luce s’accese lassù. Poi una porta si chiuse e la luce si spense. La sola illuminazione della camera era quella dei quadri. Rodney Cathcart s’era seduto sulla sponda del divano. «Sacro Dio, sorellina, bevete qualcosa…» Margo fece un risolino. «D’accordo, Si, potete darmi un goccio di gin» gli disse, e sedette accanto a lui sul divano. Era simpatico. Margo si trovò nell’atto di lasciarsi baciare, ma senz’altro quella mano le salì su per la gamba e lei dovette alzarsi e andare verso l’altra parete della camera, a guardare ancora i quadri. «Oh, non fate la sciocca» sospirò lui, lasciandosi ricadere lungo e disteso sul divano. Dal piano disopra non veniva rumore. Margo cominciava a domandarsi che diavolo Margolies facesse lassù. Ritornò al divano per versarsi un altro goccio di gin e Rodney Cathcart balzò in piedi di botto, le gettò da dietro le braccia intorno e le addentò un orecchio. «Smettete di far l’uomo delle caverne» disse Margo senza muoversi. Non voleva dibattersi per paura che le scompigliasse il vestito. «Io sono così» le mormorò all’orecchio. «Ti trovo eccitante.»
Margolies era lì davanti con certi fogli in mano. Margo si chiese da quanto fosse presente. Rodney Cathcart si lasciò ricadere steso sul divano e chiuse gli occhi. «E ora sedete, Margo carissima» diceva Margolies con una voce calma. «Voglio raccontarvi una storia. Ditemi se non risveglia nulla in voi.» Margo si sentì avvampare. Alle sue spalle Rodney Cathcart dava lunghi profondi respiri come se fosse addormentato. «Voi siete stufa del folle vortice delle capitali europee» diceva Margolies. «Voi siete la figlia di un vecchio ufficiale dell’esercito. Vostra madre è morta. Voi andate dappertutto: balli, cene, avventure. Molti chiedono la vostra mano. Vostro padre è un generale francese oppure spagnolo. La sua patria lo chiama. Viene mandato in Africa per respingere i barbari mori. Vorrebbe lasciarvi in un convento, ma voi insistete per andare con lui. Mi seguite?» «Oh sì» disse Margo con slancio. «S’imbarcherebbe magari di nascosto pur di andare in guerra con lui.» «Sul medesimo piroscafo c’è un giovane studente americano che è scappato dalla patria per arruolarsi nella legione straniera. Vedremo la ragione più tardi. Sarà l’amico vostro Si. Fate conoscenza… Tutto va come un sogno tra voi. Vostro padre è gravemente malato. A questo punto siete già in un fortino di fango, assediato dai nativi, ululanti selvaggi assetati di sangue. Si trova una via per sfuggire alla morsa e si allontana in cerca della medicina necessaria a salvare la vita di vostro padre… Al suo arrivo è arrestato come disertore. Voi vi precipitate a Tangeri, chiedendo l’intervento del console americano. Viene salvata la vita di vostro padre. Voi tornate a cavallo appena in tempo per fermare il plotone d’esecuzione. Si è un cittadino americano e viene decorato. Il generale lo bacia sulle gote e affida la sua bella figliola a quelle braccia gagliarde… Vorrei che per ora non ne parlaste… Che vi si stampi profondo nella mente. Va da sé che è soltanto un abbozzo rudimentale. La storia è stupida ma presenta qualche opportunità al direttore. Io posso vedere voi, che arrischiate ogni cosa, la reputazione, la vita stessa per salvare l’uomo che amate. E ora vi accompagnerò a casa… Guardate, Si dorme. Non è altro che una bionda bestia, un bruto.»
Posandole il mantello addosso, Margolies lasciò indugiare un istante le mani sulle sue spalle. «C’è un’altra cosa che vorrei vi scendesse nel cuore… non nell’intelligenza… nel cuore… Non rispondetemi ora. Parlatene con la vostra deliziosa compagna. Fra qualche tempo, quando questo lavoro sarà finito, io voglio sposarvi. Sono libero. Anni fa in un altro mondo avevo una moglie, com’è degli uomini avere una moglie, ma convenimmo di non comprenderci e ce ne andammo per la nostra via. Per ora avrò troppo da fare. Voi non avete idea dell’intenso lavoro di particolari che un film richiede. Quando dirigo un film, non posso pensare ad altro, ma quando il lavoro creativo sarà compiuto, forse fra tre mesi, voglio che mi sposiate… Ora non rispondetemi.» Non dissero nulla per tutto il tempo che le sedette accanto alla strada del ritorno a Santa Monica, guidando adagio dentro la spessa, candida, vischiosa nebbia mattutina. Quando l’auto si fermò alla sua porta, Margo si piegò innanzi e gli diede un colpetto sulla guancia. «Sam,» disse «mi avete fatto passare una serata deliziosa.» Agnes non la smetteva di garrire dove mai fosse stata fino a così tardi. Girava passeggiando in vestaglia e accese tutte le luci di casa. «Avevo un vago senso d’ansia quando tu sei partita, Margo. E allora telefonai a Madame Esther per sentire che ne pensasse. Aveva per me un messaggio da parte di Frank. Sai che la volta scorsa ci disse che stava sforzandosi di superare influssi disgraziati.» «Oh Agnes, che diceva il messaggio?» «Diceva che il successo tu l’hai in pugno, tieni duro. Oh, Margie, devi proprio sposarlo… È questo che Frank ha tanto cercato di dirci.» «Accidenti» fece Margo, cadendo sul letto, quando fu al piano disopra «non sto più in piedi. Sii buona, Agnes, ritirami tu i vestiti.» Margo era troppo eccitata per dormire. La camera aveva troppa luce. Non cessava di vedere rossa la luce attraverso le palpebre. Eppure doveva dormire. Chi sa che faccia avrebbe avuto l’indomani se non dormiva. Chiamò Agnes che le portasse una pastiglia d’aspirina. Agnes la sostenne con una mano e le diede con l’altra il bicchiere d’acqua che doveva cacciar giù la pastiglia; fu come quando era
ancora una bimba e Agnes soleva darle la medicina quand’era malata. Poi d’un tratto si trovò a sognare che era sul punto di finire il numero Everybody’s Doing It e la rosata spelonca di facce muggiva d’applausi e lei correva tra le quinte dove Frank Mandeville l’attendeva nel suo mantello nero con le braccia spalancate e lei gli correva fra le braccia e il mantello si chiudeva d’ogni parte ed ecco che era a terra col mantello che la soffocava e lui le stava sopra strappandole il vestito, e oltre quella spalla, ecco Tony che rideva, Tony tutto in bianco con un berretto candido e un diamante a mazzetta da golf sulla faccia del collo, che saltabeccava e batteva le mani. Doveva essere stato quel suo urlo a far correre Agnes. No, Agnes le diceva qualche cosa. Margo sedette nel letto, tutta un brivido. Agnes era scalmanata. «Oh, è terribile. Giù c’è Tony. Vuole vederti a tutti i costi, Margie. Ha letto la notizia nei giornali. Sai che i giornali sono pieni della notizia che tu farai coppia con Rodney Cathcart nel prossimo film di Margolies. Tony è fuori di sé. Dice che è tuo marito e che tocca a lui occuparsi dei tuoi affari. Dice che ha diritto per legge.» «Brutto mascalzoncello» fece Margo. «Portalo qui… Che ora è?» Saltò giù dal letto e corse alla toeletta per raggiustarsi il viso. Quando li sentì giungere per la scala, si gettò addosso il giubbetto di pizzo rosa e saltò di nuovo nel letto. «Che c’è dunque, Tony?» disse. «Io muoio di fame e tu guadagni tremila dollari alla settimana… Ieri Max e io non avevamo un soldo per cenare. Ci sfratteranno anche dall’appartamento. Per legge tutto quello che guadagni è mio… sono stato troppo tollerante… mi sono lasciato truffare.» Margo sbadigliò. «Qui non siamo a Cuba, caruccio.» Sedette sul letto. «Stammi a sentire, Tony, lasciamoci da buoni amici. Il contratto non è ancora firmato. Ti propongo, quando lo sarà, di fissare un tanto per te perché col tuo amico possiate andare ad aprire la vostra scuola di polo all’Avana. Il tuo male è che soffri di nostalgia.» «Non sarebbe una cosa magnifica?» fece eco Agnes. «Cuba è proprio il luogo adatto… con tutti i turisti che vanno laggiù e ogni cosa.» Tony s’impettì rigidamente. «Margo, noi siamo cristiani. Abbiamo la fede. Sappiamo che la Chiesa vieta il divorzio… Agnes non può
comprendere.» «Sono assai più cristiana di te, io… tu sai che tu…» cominciò a strillare Agnes. «Andiamo, Agnes, non vorremo discutere di religione prima di aver fatto colazione.» Margo sedette nel letto e si trasse le ginocchia fino al mento sotto le coperte. «Io e Agnes crediamo che Mary Baker Eddy 2 ha insegnato la verità, Tony, capisci? Siediti anche tu, Tony… Ma tu diventi grasso, Tony, i bei ragazzi non ne vorranno più sapere di te se perdi la tua aria di signorina… Stammi a sentire, tanto tu che io ci siamo aiutati a passarne delle belle.» Tony sedette sul letto e accese una sigaretta. Margo gli carezzò all’indietro i lucidi capelli neri. «Non vorrai guastarmi il gioco ora che ho la più grande occasione della mia vita.» «Io sono un cane. Io non valgo nulla» disse Tony. «Facciamo mille al mese? Non è che un terzo di quel che guadagni. Tanto tu li sprecheresti. Le donne non han bisogno di denari.» «Accidenti se non ne hanno bisogno. Sai che costa quattrini far quattrini in quest’industria.» «E va bene… facciamo cinquecento. Le cifre non le capisco, lo sai. Lo sai che sono solo un bambino.» «Bene, neanch’io me ne intendo. Tu e Agnes andate sotto e discutete la cosa, mentre io prendo un bagno e mi vesto. Deve venire qui la sarta e bisogna che mi trovi pettinata. Ho più di cento impegni quest’oggi… Bravo bambino, Tony.» Gli diede un colpetto sulla gota e lui se ne andò con Agnes, mansueto come un cagnolino. Quando Agnes risalì, dopo che Margo ebbe preso il bagno, le disse bisbetica: «Margie, avremmo dovuto pensare a divorziare da Tony da molto tempo. Questo tedesco che gli ha messo le mani addosso è un brutto tipo. Tu sai quel che ne pensi il signor Hays degli scandali». «Io so soltanto che sono stata una gran stupida.» «Voglio interrogare Frank su questa faccenda. Ho un appuntamento con Madame Esther per quest’oggi. Frank potrebbe rivelarci il nome di qualche buon avvocato.» «Non possiamo rivolgerci a Vardaman. È già avvocato di Hardbein e di Sam. È davvero stupida una ragazza a mettere qualcosa per
scritto.» Trillò il telefono. Era il signor Hardbein che chiedeva per il contratto. Margo spedì Agnes all’ufficio, che gli parlasse. Per tutto il pomeriggio, piantata là davanti alla lunga specchiera, mentre la sarta si dava d’attorno con la bocca piena di spilli, lei si tormentò per decidere che fare. Quando Sam fece una scappata alle cinque per vedere i nuovi abiti, la trovò ancora coi capelli nell’essiccatore. «Come siete seducente con la testa in quell’arnese,» diceva «con la vestaglia di pizzo e il triangoletto di pizzo di Bruxelles tra le ginocchia… Me ne ricorderò. Ho la facoltà di richiamarmi tutto, io. Non dimentico mai una cosa che ho visto. È questo il segreto dell’immaginazione visiva.» Quando Agnes ritornò a prenderla con la Rolls, ebbe una certa difficoltà a liberarsi di Sam. Lui voleva portarle sulla sua macchina dovunque fossero dirette. «Non dovete aver segreti per me, Margo carissima» disse tenero. «Vedrete che io comprendo tutto… tutto… vi conosco meglio che non vi conosciate voi. È per questo che son certo di sapervi dirigere. Ho studiato ogni piano del vostro viso e della vostra bella anima bambina traboccante di desideri… Nulla di quanto facciate può sorprendermi o urtarmi.» «Buono a sapersi» disse Margo. Margolies se ne andò offeso. «Oh, Margie, non dovresti trattarlo così, il signor Margolies» piagnucolò Agnes. «Posso fare a meno di lui più che lui non possa fare a meno di me» disse Margo. «Ha bisogno assoluto di una nuova stella. E a buon conto dicono che è nei pasticci.» «Il signor Hardbein spiega che è perché ha licenziato il suo agente di pubblicità» disse Agnes. Era tardi quando si misero per strada. La casa di Madame Esther era già al centro in un meschino quartiere di Los Angeles. Si fecero lasciare dall’autista a due isolati dalla casa e vi si diressero a piedi giù per un vicolo tra polverosi cortili di villette, simili ai luoghi dove avevano abitato quand’eran giunte la prima volta sulla costa anni prima. Margo diede un colpo col gomito ad Agnes. «Non ti ricorda nulla?» Agnes si volse a lei, aggrottata. «Si devono ricordare soltanto
le cose belle, Margie.» La casa di Madame Esther era un antico e grande edificio in legno, con ampi portici e screpolate tegole anch’esse di legno. Persiane eran chiuse su tutte le sudice finestre. Agnes bussò a una porticina di vetro smerigliato, sul retro. Una sparuta zitella, dai capelli grigi alla maschietta, aprì subito. «Siete in ritardo» bisbigliò. «Madame si trova in trance. Non amano dover attendere. Sarà difficile spezzare la catena.» «Ha avuto nulla da parte di Frank?» sussurrò Agnes. «Frank è irritatissimo. Temo che non risponderà più… Datemi la mano.» La zitella prese la mano di Agnes, e Agnes quella di Margo e si cacciarono in fila indiana giù per un buio corridoio, dove non c’era che una piccola lampadina rossa accesa, e passarono per una porta in una stanza interamente buia, piena di gente che respirava forte e muoveva i piedi. «Credevo fosse una seduta privata» mormorò Margo. «Sst!» le sibilò Agnes all’orecchio. Quando i suoi occhi furono abituati all’oscurità, poté vedere la facciona gonfia di Madame Esther dondolarsi in fondo a un gran tavolo rotondo e chiazze pallide di altre facce tutt’intorno. Fecero posto ad Agnes e Margo, e Margo si trovò seduta con l’umida mano di un altro stretta nella sua. Sul tavolo davanti a Madame Esther c’erano tanti taccuini di carta bianca. Tutto taceva tranne il fiato pesante di Agnes accanto. Parve passassero ore prima che accadesse qualcosa. Poi Margo vide che gli occhi di Madame Esther erano spalancati, ma non ne scorse il bianco. Una profonda voce baritonale le usciva dalle labbra e parlava una lingua che lei non capiva. Qualcuno della catena rispose nella stessa lingua, evidentemente facendo domande. «È Sidi Hassan l’indù» sussurrò Agnes. «Riceve splendide informazioni di Borsa.» «Silenzio» strillò Madame Esther con una stridula voce femminile che quasi gettò Margo fuori di senno per lo spavento. «Frank attende. No, è stato richiamato. Ha lasciato un messaggio che tutto andrà bene. Ha lasciato un messaggio che domani comunicherà l’informazione per gli interessati e che la sua bimba non deve assolutamente fare nessun passo senza consultare la sua adorata Agnes.» Agnes scoppiò in singhiozzi isterici e una mano battè Margo sulla
spalla. La stessa zitella grigia le ricondusse alla porticina. Aveva una boccetta di sali che fece annusare ad Agnes. Prima di aprire il vetro smerigliato disse: «Sono cinquanta dollari, prego. Venticinque a testa… E Madame dice che la bimba bella non deve venire, potrebbe esser pericoloso per lei, siamo circondate da influssi ostili. Ma la signora Mandeville deve venire a prendere i messaggi. Nulla di male le può toccare, dice Madame, perché ha il cuore di un fanciullo». Mentre uscivano nel vicolo scuro, accorgendosi ch’era già notte e dappertutto erano accesi i lampioni, Margo si tirò la pelliccia intorno al viso perché nessuno potesse riconoscerla. «Vedi bene, Margie,» disse Agnes mentre si adagiavano nel profondo sedile della vecchia Rolls «tutto andrà per il meglio, con il mio Frank che veglia su di noi. Dice chiaramente che tu devi esser risoluta e sposare al più presto il signor Margolies.» «Già, dopo tutto non è poi peggio che firmare un contratto di tre anni» disse Margo. Ordinò all’autista di filare a tutta velocità, perché Sam quella sera doveva portarla a una prima al Grauman. Quando vennero a fermarsi, girato l’ingresso, alla porta, la prima cosa che videro fu Tony e Max Hirsch seduti sulla panca di marmo in giardino. «Parlerò io» disse Agnes. Margo si precipitò al piano disopra e prese a vestirsi. Era seduta in sottoveste e si guardava nello specchio, quando Tony si precipitò nella stanza. Quando fu nell’alone di luce sovrastante la toeletta, Margo s’accorse che aveva un occhio nero. «Ehi, ci diamo all’arte gentile, Tony?» disse senza voltarsi. Tony parlò trafelato. «Max mi ha pestato un occhio, perché io non volevo venire. Margo, mi ammazzerà se non mi dai mille dollari. Non ce ne andremo di qui finché non ci darai un assegno, e poi ci occorrono anche dei contanti perché Max dà una festa stanotte e il contrabbandiere fa la consegna soltanto se si paga a pronta cassa. Max dice che tu tenti il divorzio. Com’è possibile? Non c’è divorzio sotto la Chiesa. È un peccato di cui non voglio macchiarmi. Non puoi ottenere il divorzio.» Margo si alzò e, voltandosi, gli fu di fronte. «Dammi la vestaglia che è là sul letto… Non val la pena che mi prenda una polmonite… Non ti sembra, Tony, che divento troppo grassa? La settimana scorsa
ho guadagnato due libbre… Senti bene, Tony, quel testone sarà la tua rovina. Faresti meglio a lasciarlo perdere e andartene in qualche posto a curarti un’altra volta. Mi dispiacerebbe che la questura federale dovesse impacchettarti per uso di stupefacenti. Hanno fatto una grossa retata solo ieri a San Pedro.» Tony scoppiò in lacrime. «Ma bisogna che tu me li dia. Altrimenti mi rompe le ossa.» Margo guardò il suo orologio da polso posato sulla toeletta accanto alla grande scatola della cipria. Le otto. Da un momento all’altro, ora, poteva giungere Sam. «E va bene» disse «ma d’ora innanzi la casa sarà sorvegliata dai poliziotti… Ficcatelo bene in testa» disse. «La più piccola delle storie e finite tutti e due dentro. Se t’immagini che Sam Margolies non sia capace di tenere questa faccenda fuori dai giornali, ti sbagli di grosso. Va’ sotto ora e di’ ad Agnes che ti faccia un assegno e ti consegni tutti gli spiccioli che ha in casa.» E tornò a vestirsi. Qualche istante dopo Agnes salì in lacrime. «Che faremo ora? Gli ho dato l’assegno e duecento dollari… Oh, è terribile. Perché Frank non ci ha avvertite? Lo so che veglia su di noi, ma avrebbe potuto anche dirci che fare di quest’uomo impossibile.» Margo entrò nello sgabuzzino e s’infilò un abito da sera, nuovo dalla sartoria. «Quel che faremo, prima cosa sarà di fermare quell’assegno domattina. Telefona all’agenzia di vigilanza privata che mandino qui due poliziotti in servizio diurno e notturno. Ne ho abbastanza stavolta.» Margo era fuori di sé, misurava a gran passi la camera, nel nuovo abito pagliettato e guarnito di penne di struzzo. Si scorse nel grande triplice specchio rizzato fra i letti. Andò a fermarsi là davanti. Guardò le tre immagini di sé nell’abito bianco pagliettato. Aveva gli occhi di un azzurro fiammante e le guance avvampate. Agnes le si accostò alle spalle porgendo il diadema di strass che Margo doveva mettersi nei capelli. «Oh Margie,» esclamò «non sei mai stata così affascinante.» Salì la cameriera a riferire che il signor Margolies attendeva. Margo diede un bacio ad Agnes e disse: «Non avrai paura coi poliziotti, vero, cara?». Si tirò sulle spalle il mantello d’ermellino che le avevano mandato quel giorno in prova e uscì verso l’auto. C’era là Rodney Cathcart disteso sul sedile posteriore, in abito da sera. Una fila di
denti perfetti gli brillò nel lungo volto bruno, quando le sorrise. Sam era disceso per darle la mano a montare. «Margo carissima, noi siamo a bocca aperta, sapevo bene che era l’abito che ci voleva» disse. Gli lucevano gli occhi più del solito. «Stasera è una serata molto importante. È il decreto delle stelle. Ve ne parlerò poi. Ho fatto prendere i nostri oroscopi.» Nell’affollato e sussultante vestibolo Margo e Rodney Cathcart dovettero fermarsi al microfono e dire due parole del loro nuovo film e della loro collaborazione con Sam Margolies, quando entrarono sotto il violento riverbero delle luci e degli sguardi dirigendosi all’ingresso. Quando il maestro delle cerimonie cercò di far parlare Margolies, questi gli volse le spalle irritatissimo e si cacciò nella sala come se fosse deserta, senza guardare né a destra né a sinistra. Dopo lo spettacolo andarono a un ristorante e sedettero un poco al tavolino. Rodney Cathcart ordinò un rognone in umido. «Non dovete mangiar troppo, Si» disse Margolies. «Il pièce de résistance è su da me.» C’era davvero una gran mensa apparecchiata con salmone freddo e insalata d’aragosta e un maggiordomo filippino che sturava champagne, tutta per loro tre, quando furon di ritorno dopo che la folla cominciò a diradarsi nel ristorante. Stavolta Margo si sfrenò e mangiò e bevve tutto quel che ci stava. Rodney Cathcart sparecchiò quasi tutto il salmone brontolando ch’era straordinario, e persino Sam, ripetendo che ci avrebbe lasciata la pelle, mangiò un piatto d’insalata d’aragosta. Margo provava un folle solletico d’ubriachezza, quando s’accorse che il filippino e Sam Margolies s’erano eclissati e che lei e Si stavan seduti insieme sul divano dov’era gettata la pelle di leone. «E così sposerete Sam» disse Si, tracannando un bicchiere di champagne. Margo annuì. «Brava figliola.» Si, togliendosi giacca e panciotto, li appese accuratamente su una sedia. «Odio i vestiti» disse. «Dovete venire nel mio ranch… Cose da pazzi.» «Ma li portate così bene» disse Margo. «Quel che ci vuole» disse Si. Allungò le braccia e se la sollevò contro il ginocchio. «Ma, Si, non dobbiamo, e proprio sul leone di Sam.» Si le mise la bocca sulla bocca e la baciò. «Mi trovi eccitante? Dovresti vedermi nudo.» «No, no»
disse Margo. Non poteva impedirlo, era troppo robusto, quelle mani la stringevano tutta, sotto il vestito. «Al diavolo, non me ne importa un corno» Margo disse. Si andò al tavolo e le versò un altro bicchiere di champagne. Per sé riempì una scodella che al principio della sera aveva contenuto ghiaccio pesto. «Quanto a quel leone son tutte balle. L’ha ucciso Sam, sì, ma l’ha ucciso allo zoo, quell’ipocrita. Facevano fuori i più vecchi in un allevamento e hanno pensato di sparare qualche colpo. Non si poteva sgarrare. Un assassinio vergognoso, è stato.» Mandò giù lo champagne e d’improvviso le balzò addosso. Margo cadde sul divano schiacciata da quelle braccia. Aveva il capogiro. Camminava su e giù per la stanza, tentando di trarre il fiato. «Salute, bell’agnolotto» le disse Si e accuratamente si rimise la giacca e il panciotto e se ne andò per la porta. Margo aveva il capogiro. Tornava Sam e le mostrava una filza di calcoli su un foglio di carta. Gli occhi di Sam sporgevano lucidi verso il viso di lei che cercava di leggere. Gli tremavano le mani. «È stanotte,» badava a ripetere «è stanotte che le nostre linee della vita si attraversano… Noi siamo sposati, che lo vogliamo o no. Io non credo nel libero arbitrio. E voi, Margo carissima?» Margo aveva il capogiro. Non riusciva a dir nulla. «Venite, piccola, voi siete stanca.» La voce di Margolies le brusiva blanda alle orecchie. Lasciò che la conducesse nella camera da letto e che con cura la spogliasse tutta e la posasse tra le nere lenzuola di seta del grande letto a colonne. Era giorno pieno quando Sam la ricondusse a casa. Il poliziotto fuori si portò la mano al berretto, quando svoltarono nell’ingresso. Le diede un senso di benessere vedere quel faccione schiacciato, posto là di guardia alla sua casa. Agnes era alzata e passeggiava su e giù, in una veste da camera a fiorami trapuntata, nella sala, con un giornale in mano. «Dove sei stata?» esclamò. «Oh, Margie, ti guasterai la linea se continui così, proprio adesso che sei all’inizio… Guarda qui… e sii coraggiosa… ricorda che è tutto per il meglio.» Porse il «Times» a Margo, additando un titolo con l’aguzza e rosea
unghia manicurata dell’indice. «Non te lo dicevo che Frank vegliava su di noi?» UNA COMPARSA DI HOLLYWOOD ASSASSINATA DURANTE UNA BALDORIA Noto giocatore di polo che s’eclissa Il fermo di due marinai Sono stati fermati per procedere al loro interrogatorio due marinai in uniforme, George Cook e Fred Costello, della nave da guerra Kenesaw, trovati privi di conoscenza sotto l’azione dell’alcool o di stupefacenti al piano terreno di un caseggiato n. 2234 Higueras Drive, San Pedro, dove gli inquilini affermano che per tutta la notte si svolse una baldoria. Accanto a loro si trovò il cadavere di un giovane col cranio fratturato da un colpo d’oggetto contundente, e questi venne identificato per un cubano, Antonio Garrido, in passato comparsa in vari importanti teatri di prosa. Non era ancora spirato, quando la polizia irruppe sollecitata dalle telefonate di protesta dei vicini. Il quarto membro del gruppo, un cittadino tedesco di nome Max Hirsch che da qualcuno si suppone sia un nobile austriaco, il quale condivideva a Mimosa un alloggio in un elegante villino col bellissimo giovane cubano, s’era eclissato prima che la polizia sopravvenisse sul luogo della tragedia. Nelle prime ore del mattino la polizia non l’aveva ancora rintracciato. Margo sentì la stanza balenarle intorno al capo a grandi cerchi. «Oh, Dio» disse. Salendo la scala dovette tenersi afferrata alla ringhiera per non cadere. Si strappò di dosso gli abiti e aprì da sé l’acqua calda nel bagno, adagiandosi in esso con gli occhi serrati. «Oh, Margie,» gemeva Agnes dall’altra stanza «il tuo abito nuovo così bello è uno straccio.» Margo e Sam Margolies andarono a Tucson in aeroplano per sposarsi. Erano presenti solamente Agnes e Rodney Cathcart. Dopo la cerimonia, Margolies diede al giudice di pace un biglietto da cento dollari nuovo. Il volo di ritorno fu piuttosto agitato e il grosso trimotore Ford rintronante diede loro un’insaccata coi fiocchi traversando il deserto. Margolies aveva una faccia di tutti i colori sotto il berretto candido, ma disse ch’era una cosa deliziosa. Rodney
Cathcart e Agnes vomitarono senza rispetto nei loro sacchetti di cartone. Margo sentiva il suo bel sorriso contrarsi in una smorfia disperata, ma riuscì a tenere in corpo lo spuntino nuziale. Quando l’apparecchio finalmente si fermò in pace all’aeroporto, fecero attendere i fotografi mezz’ora prima di potersi fidare a discendere per la passerella, avvampati e sorridenti, in una pioggia di stelle filanti e di coriandoli gettati dal seguito e nel ronzio delle macchine da presa. Rodney Cathcart dovette bere quasi una bottiglia di scotch per rimettersi il terreno sotto i piedi. Margo apriva il suo sorriso su un ammasso di orchidee gialle che l’avevano attesa nel frigorifero dell’aeroporto e Agnes contenta come una pasqua per via che Sam aveva mandato anche a lei orchidee, color lavanda stavolta, volle a tutti i costi scendere la passerella verso gli obiettivi con gli altri. Fu un gran sollievo, dopo il riverbero del deserto e il rullio dell’apparecchio nei vuoti d’aria, ritornarsene nei tranquilli camerini del teatro di posa. Per le tre del pomeriggio eran truccati. Nella stanzetta del pianterreno Margolies si rimise subito al lavoro riprendendo primi piani di Margo e Rodney Cathcart stretti in amplesso sullo sfondo di un angolo del fortino di fango. Si era a torso nudo con due cartuccere incrociate sul petto e un chepì di tela da legionario in capo e Margo in abito da sera candido con scarpette di raso a tacco alto. Non ce la facevano con quell’amplesso, per via delle cartuccere. Margolies, facendosi sibilare innanzi la mazza dal pomo di porcellana, continuava a incedere su e giù dal palchettino dov’era appollaiato dietro la macchina sotto il riverbero della lampada klieg dove Margo e Si si allacciarono e staccarono una dozzina di volte prima di indovinare una posizione che gli andasse a genio. «Mio caro Si,» badava a ripetere Margolies «dovete fare che tutti lo sentano. Ogni piega dei vostri muscoli deve far sentire la passione… voi siete rigido come un merluzzo. Lei tutti l’amano, una creatura di fragile adorabile palpitante femminilità, disposta a sacrificare tutto per l’uomo che ama… Margo carissima, voi svenite, vi abbandonate nelle sue braccia. Se le sue braccia gagliarde non fossero lì pronte a sostenervi, voi scivolereste a terra. Si, mio caro Si, voi non siete un istruttore che insegna a nuotare a una signorina, siete un amante
disperato, dinanzi alla morte… Tutti sentono di essere in voi, voi l’amate per tutti loro, per i milioni che vogliono amore, bellezza, esaltazione, ma dimenticateli, lasciatevi andare, mio caro Si, dimenticate che ci sono qua io e c’è la macchina, voi siete insieme soli, afferrati a un attimo disperato, siete soli tranne i vostri due cuori che battono, voi e la fanciulla più bella del mondo, la nuova fidanzata di tutta l’America… Benissimo… restate… Si gira.» 1. Allusione al motto famoso dell’affarista americano: «Ogni minuto nasce un imbecille; basta saperlo trovare». (NdT) 2. La fondatrice della Christian Science. (NdT)
Cine-giornale LXIII ma qualche minuto dopo, questo miraggio di terra scomparve altrettanto rapidamente e misteriosamente com’era sorto e io mi vidi innanzi l’immensa distesa del mare silenzioso e non il minimo indizio di vita visibile Gridano le civette e discende la notte E io volo… al mio paradiso IL PERICOLO CORSO DA LINDBERGH MENTRE UN’ONDA L’INGANNA A PRUA D’UN INCROCIATORE Laggiù nel Tennessee fra le montagne lontano dai peccati della terra pensando alla figliola di Zeb Turney il figlio di Dan Kelly si prepara alla sua guerra ACCLAMATO DA FOLLE IMMENSE PER LE VIE Prende istantanee da un pennone a rischio di precipitare Era un giovane pronto di mano era venuto su forte e virtuoso AFFASCINATA DALL’IMPRESA AUDACE TUTTA LA CITTÀ ACCLAMA DAL PROFONDO DEL CUORE Gli piangeva nel cuore l’amore di lei dunque carica il fido fucile LE AUTORITÀ URLANO ALLA VISTA DEL PILOTA CONFUSIONE IN UN ALBERGO L’Aviatore Quasi Precipita dall’Auto mentre Infila un Passaggio nella Folla Andò errando fra i monti e le rocce questo figlio del Tennessee forte una fiamma nell’occhio e il fucile a Zeb Turney prepara la morte LA PROCESSIONE SFILA IN UN DILUVIO DI PIOGGIA L’uragano dei manifestini ingorga Broadway Rimbombavano i colpi sui monti
rimbombavano i colpi sul vento LINDBERGH DIRIGERÀ UNA GRANDE LINEA AEREA Tutto il mondo racconta di Dan come uscito sui monti sparava ammazzando a ogni colpo qualcuno del clan e si prese la figlia di Turney un ometto basso, quasi calvo, col volto teso per l’emozione, sbucò da una massa di spettatori dove si era tenuto nascosto e corse ad arrampicarsi nell’apparecchio come se temesse di venir fermato. Portava gli abiti ordinari e un panciotto di pelle invece della giacca. Era a capo scoperto. Si ficcò accanto a Chamberlin, senza guardare né la gente né la moglie che si trovava quasi dinanzi all’apparecchio, da una parte, con gli occhi sbarrati per la sorpresa. Il motore rombò e l’apparecchio si mosse lungo la passerella, s’arrestò e riprese la marcia e infine si innalzò nel cielo in modo impeccabile
Architetto In un’umida e pesante giornata di primavera nel milleottocentottantasette un giovanottone diciottenne dai begli occhi e dal portamento simpatico e arrogante giunse a Chicago con sette dollari in tasca avanzati nell’acquisto del biglietto da Madison, resto di una somma raggranellata impegnando le Vite di Plutarco, la Decadenza e caduta dell’impero romano del Gibbon e una vecchia giacca impellicciata. Prima di partirsene per farsi una carriera in qualche studio d’architetto (nel Wisconsin non c’erano scuole d’architetto a ingombrargli la mente con scipiti disegni accademici), il giovanotto aveva veduto sfasciarsi la cupola del nuovo palazzo di Stato a Madison, per colpa della cattiva muratura dei piloni in pietra grezza, sparagno di materiali da parte di qualche ladro appaltatore che aveva da farne uscire la bustarella per i politicanti, e magari un impercettibile ma fatale errore nei progetti dell’architetto; egli non dimenticò mai il fragore dei muri schiantati, il volar dell’intonaco, l’avvolgente nube di polvere, i corpi sfracellati dei morti e dei moribondi, volti immobili illividiti da chiazze di gesso. Camminando a zonzo per le vie di Chicago, traversando e ritraversando i ponti sul Chicago River fra lo strepito e il frastuono del traffico, il rimbombo dei furgoni e carretti carichi e il calpestio dei grossi cavalli da tiro e l’ululo dei rimorchiatori coi barconi e il cupo sibilo dei vapori in attesa, pensava all’immenso continente disteso un migliaio di miglia a oriente a sud a nord, tremila miglia ad ovest, e dappertutto, nei centri minerari, sulle rive dei porti appena dragati, lungo i canali d’acqua, ai nodi ferroviari, sorgevano baracche prigioni carbonaie silos negozi magazzini case d’affitto, grandi ville per i ricchi nel mezzo di prati alberati, palazzi a cupola sulle colline, alberghi chiese teatri sale concerto. Camminava a grandi passi ansiosi verso il libero futuro che s’apriva senza ostacoli in ogni direzione per un giovane deciso a piegare la schiena al lavoro e il pronto
ingegno a inventare. Lo stesso giorno trovò un posto in uno studio d’architetto. Frank Lloyd Wright era il nipote di un predicatore e cappellaio gallese che s’era stabilito in una ricca vallata del Wisconsin, Spring Valley, e qui aveva allevato una grossa famiglia di agricoltori e predicatori e maestri di scuola. Il padre di Wright fu anch’esso predicatore, un irrequieto spostato nuovinglese che studiò la medicina, predicò in una chiesa battista a Weymouth, Massachusetts, e poi da unitario nel Centro, insegnò musica, leggeva il sanscrito e alla fine piantò la famiglia in asso. Wright il giovane nacque nel podere del nonno, frequentò le scuole di Weymouth e di Madison, lavorando d’estate in un podere di suo zio nel Wisconsin. La sua preparazione d’architetto furono le letture di Viollet-le-Duc, l’apostolo del secolo decimoterzo e dei puri rapporti matematici della muratura gotica, e i sette anni che lavorò con Louis Sullivan nello studio di Adler and Sullivan a Chicago. (Fu Louis Sullivan che, dopo Richardson, inventò tutto quello che venne inventato nell’architettura americana del secolo decimonono.) Quando Frank Lloyd Wright lasciò Sullivan, aveva già lanciato uno stile suo, l’architettura della prateria. In Oak Park costruì spaziose dimore suburbane per ricchi, che furono i primi edifici a spezzare la dipendenza degli architetti americani da secoli di passatiste abitudini, dai consunti capitello e plinto e frontone strascicati nei secoli sullo stampo dell’Acropoli, dalle tradizionali stantie decorazioni della muratura romana, dai mezzo obliterati disegni del Palladio. Frank Lloyd Wright stava aprendosi un’ampia via nuova che portava alle rapide costruzioni di vetro e di acciaio adombrando le attuali. Gioiosamente volse lo sguardo ai nuovi materiali, l’acciaio in tensione, il vetro, il cemento, i milioni di nuovi metalli e leghe. Il figlio e nipote di predicatori divenne egli stesso un predicatore in cianografie, progettando costruzioni secondo il futuro d’America, non secondo il passato d’Europa.
Inventore di piani, escogitatore di frasi maestre per il domani, egli predica ai giovani che maturano in un’epoca di oppressione imprigionati dalle posticce pareli del tran-tran finanziario, la loro vita e i loro piani impoveriti dalle imposizioni feudali del parassitico capitale che s’impianta su tutti i sistemi per sbarazzarsi del progresso e continuare a ritagliare le sue cedole: Il cittadino urbanizzato secondo le regole è divenuto un sensale, che tratta specialmente in debolezze umane o in idee ed invenzioni altrui, un tiratore di leve, un premitore dei bottoni di una potenza astratta, ch’è sua per merito del macchinismo… e sopra, accanto, e sotto a lui, persin dentro il suo cuore, quando dorme, vi è il tassametro del reddito, a stimolare in qualche modo la lotta incessante di questo ansioso consumatore per o contro un più o meno generoso o spietato guadagno. Ai giovani che impiegano i giorni e le notti componendo i progetti per i nuovi accozzi affittati di celle affittate sospese su duri marciapiedi, egli predica, gli orizzonti della sua infanzia, un futuro che non è un rialzo di qualche punto in un centinaio di titoli scelti, né un aumento di vetture ferroviarie né una moltiplicazione del credito in banca né un rialzo nella scala dei premi, ma una nuova decente costruzione, dalle fondamenta, poggiata sugli usi e le necessità, rivolta al futuro d’America invece che al passato intriso di sofferenza d’Europa e d’Asia. Usonia lui chiama l’ampia pregnante cintura di questa nuova nazione attraverso l’enorme continente dall’Atlantico al Pacifico. Egli predica un progetto per Usonia: È facile convincersi come la complessità delle crude costruzioni utilitarie nell’infanzia macchinistica del nostro sviluppo, simile alla cruda impalcatura di un maestoso edificio, abbia fatto violenza al paesaggio… Il crudo proposito del tempo dei pionieri è stato raggiunto. L’impalcatura si può adesso abbattere e l’opera vera, la cultura di tutta una civiltà, apparire. Come accadde a molti predicatori, profeti, esortatori, anche l’esistenza di Frank Lloyd Wright fu tempestosa. Egli ha cresciuto bambini, litigando con mogli, trasgredito confini, si è cacciato in
pasticci con la legge, in tribunali di divorzio, in fallimenti, sempre la stampa gialla che gli latrava alle costole, sempre le sue disgrazie stamburate a grossi titoli sui giornali della sera: avventure con donne, l’orrore d’incubo quando nel Wisconsin gli bruciò la casa. Per una bizzarra ironia l’edificio che è più interamente suo, l’Imperial Hotel di Tokyo, fu una delle poche costruzioni a uscire intatta dal terremoto del 1923 (il giorno quando il cablogramma gli annunciò che l’edificio aveva tenuto duro, risparmiando tante centinaia di vite, egli scrive, fu uno dei più felici della sua vita) e fu leggendo pubblicazioni tedesche che i più fra gli americani sentirono parlare la prima volta della sua opera. La sua vita è stata piena di arroganti progetti non attuati. (Quante volte il predicatore non sente riecheggiare vacua la voce nella sala deserta, il disegnatore guarda la polvere brulicare sui suoi piani con tanta cura tirati, l’architetto vede i rotoli azzurri arricciarsi ingialliti e fragili nella stanza d’archivio.) Due volte ricostruì la casa dove lavora nella valle del nonno in Wisconsin, dopo incendi e disastri che avrebbero spezzato chiunque altro per sempre. Egli lavora nel Wisconsin, un vecchio eretto scarno dai capelli bianchi, i suoi figli gli sono architetti, da tutte le parti del mondo vengono allievi a lavorare con lui, e progetta la nuova città (ch’egli chiama Broadacre City 1). Il Vicino e il Lontano sono battuti (per immaginare la nuova città, dovete cancellare ogni assorbita abitudine del passato, ricostruire una nazione dalle fondamenta con i nuovi strumenti). Per l’architetto non vi sono che gli usi: l’incredibile moltiplicarsi delle funzioni, la potenza e la tensione nel metallo, la dinamo, il rocchetto elettrico, la radio, la cellula fotoelettrica, il motore a combustione interna, il vetro il cemento;
e le necessità. (Diteci, dottori in filosofia, quali sono le necessità dell’uomo. È almeno necessario per l’uomo di non soffrire né prigione né paura né fame né freddo, non passar senz’amore, non faticare per una potenza che lui non vede e che non bada affatto agli usi e ai bisogni di un uomo, di una donna, di un bimbo.) Costruire una casa è costruire l’esistenza di chi lavora e dimora in questa casa. Gli edifici determinano la civiltà come le cellette del favo le funzioni delle api. Forse è malgrado se stesso che l’arrogante progettista, il dilettante del cemento, l’artista bohème per danarose signore che desiderano pagare la distinzione con la stupefacente elaborazione della loro casa, è stato sospinto dalla logica degli usi e delle necessità, dalla lotta di tutta la sua vita contro la strascinante corrente del denaro incamerato in manomorta, a tracciare progetti che per il loro compimento richiedono una nuova vita; solamente come uomini liberi noi possiamo costruire la città usonica. I suoi progetti si vanno animando. Le sue cianografie, come un tempo le parole di Walt Whitman, scuotono i giovani: Frank Lloyd Wright, il patriarca della nuova architettura, non privo d’onori eccetto che in patria. 1. Broad, “largo”; acre, un acro, uno iugero inglese. (NdT)
Cine-giornale LXIV LA CATTURA DI UN PESCE MISTERIOSO NEL MARE DEI SARGASSI nottetempo mentre tutto taceva nell’edificio cupe figure dalle orribili maschere antigas lavoravano nel lungo e basso stanzone dietro il laboratorio delle ricerche LA CATENA DEL RUM CONGIUNGE I POPOLI Tutti intorno al serbatoio mentre aspettano il convoglio L’ASSASSINIO D’UNA DONNA – L’ARRESTO DEL MARITO Gli Uomini d’Affari Non Sono Allarmati dalle Prossime Elezioni A MOSCA SI TEME IL PEGGIO I CAPI DEL MOVIMENTO PROLETARIO CACCIATI DAI PULPITI l’immaginazione indietreggia sbigottita alle notizie da Mosca. Questi assassini hanno passato ogni limite. Si sono rivelati le belve del mondo I PRINCIPALI DI WALL STREET BANDISCONO I GRATTACAPI NATALIZI A SUON DI DIVIDENDI Ho lasciato la bella sui monti l’ho lasciata che intorno pioveva SI ACCLAMA LA NOSTRA SUPREMAZIA AEREA UNA TERRA COSÌ MOSTRUOSA CHE SI REGGE COME IN BILICO Mi son messo in un grosso pasticcio ho sparato alla guardia Nel Mistero della Notte Non Avete Sentito Avvicinarsi Passi Furtivi? TROCKIJ ATTACCA STALIN Un cadavere strozzato in strada Piango… perché il mio caro mi ha lasciata, piango LA CACCIA ALLA DONNA ARMATA DI SCURE CHE ASSALÌ
UNA DAMA DI SOCIETÀ STRINGE LA MANO AGLI EROI UNA RAGAZZA MORIBONDA PER UN TUFFO MISTERIOSO Quello è l’uomo che ci vuole per una donna come me Sperduto nella Nebbia sul Messico AFFERMA CHE LA RUSSIA SI SOLLEVA Quando danzo ho le lacrime agli occhi la fanciulla che stringo non sei tu SEICENTO ESECUZIONI IMMEDIATE A CANTON SI PREPARA UN ANNO DI PROSPERITÀ questa verifica noi la facciamo per voi nel nostro servizio di consulenza per gli investitori noi analizziamo ogni garanzia individuale in vostro possesso e ve ne diamo un’imparziale notizia e valutazione. Periodicamente durante tutto l’anno vi teniamo avvisati di ogni importante sviluppo. Se compaiono improvvisamente segni di pericolo ve ne informiamo subito
Occhio fotografico (49) camminando da Plymouth a North Plymouth attraverso l’aria cruda della baia di Massachusetts a ogni passo un piccolo freddo mollusco nella suola di una scarpa dando occhiate oltre le grigie baracche sotto il verde cielo d’aprile tra le bianche paranze ancorate nei bassifondi verde bottiglia tra i gialli banchi di sabbia e la distesa grigio ardesia della baia che si scompiglia azzurra al largo è qui che approdarono gli immigrati le teste tonde 1 i saccheggiatori di castelli i regicidi nell’odio dell’oppressione è qui che si fermarono in gruppo dopo lo sbarco dalla nave zeppa che sapeva di sentina sulla spiaggia che non apparteneva a nessuno tra l’oceano che non apparteneva a nessuno e la foresta enorme che non apparteneva a nessuno che si stendeva sui colli dov’erano i sentieri dei cervi su per le verdi vallate fluviali dove i pellirosse coltivavano a campi quella loro alta meliga per sempre nell’incredibile Ovest per trecent’anni gli immigrati sudarono nell’Ovest e oggi ora camminando da Plymouth a North Plymouth d’un tratto dopo una svolta della strada di là da un piccolo stagno e gialli intrichi di salici vaporosi di verde ecco le corderie grosse tettoie edifici case dell’azienda tutte grosse ugualmente tutte sporche d’un colore uguale un grande comignolo quadro lunghi tetti taglienti quadri e rettangoli in fila che nascondono il mare le corderie di Plymouth è qui che un altro immigrato lavorava nell’odio dell’oppressione affamato di un mondo senza barriere licenziato dalle corderie fece il pescivendolo gli immigrati nelle scure baracche lo conoscevano compravano i suoi pesci lo stavano a sentire mentre girava col carretto di porta in porta vi chiedete Che tipo era? ma perché hanno paura di parlare di Bart 2 paura di averlo conosciuto paura negli occhi neri impiccioliti dal terrore? un barbiere l’uomo della piccola drogheria la donna che lo tenevano a pigione con la paura nella voce domandano Ma perché non gli credono? Noi lo conoscevamo Lo vedevamo tutti i giorni Perché non gli credono che
quel giorno comprammo le anguille? solamente il ragazzo non ha paura la matita butta giù nel taccuino i frammenti di ricordo le spezzate mezzefrasi lo sforzo di incastrare parola a parola di addentellare detto a detto di ricostruire con gli storpiati ricordi incrollabilmente (oh Ponzio Pilato) la verità il ragazzo occhi bruni mi accompagna timidamente verso la stazione parla di come Bart lo aiutava nei lavori di casa vuole farsi strada perché dovrebbe fargli danno aver conosciuto Bart? vuole andare all’università di Boston ci stringiamo la mano non aver paura di quella gente solita la carrozza fumatori solita la confusione di facce che scorrono comodamente come in casa loro alla volta di Boston dentro la notte che scende come posso convincerli di come i nostri padri i nostri parenti nell’odio dell’oppressione vennero a questa costa come dire Non abbiate paura di quella gente come posso convincerli quali sono i tuoi oppressori America ricostruire le distrutte parole fatte viscose in bocca agli avvocati ai pubblici ministeri ai presidenti dei collegi ai giudici senza le antiche parole che gli immigrati nell’odio dell’oppressione portarono a Plymouth come puoi capire quali sono i tuoi traditori America o che questo pescivendolo che tieni nel carcere di Charlestown è uno dei tuoi fondatori o Massachusetts? 1. Roundheads: nomignolo dato ai partigiani di Cromwell nella rivoluzione puritana del Seicento. (NdT) 2. Bartolomeo Vanzetti. (NdT)
Cine-giornale LXV UN TEMPORALE OSTRUISCE LA SOTTERRANEA; ROVESCI E FULMINI METTONO AL BUIO LA CITTÀ Amore amore amore spensierato che giungi come un ladro nella notte GLI ASTANTI URLANO ALLELUIA ALLA DISCESA DELLA COLOMBA DELLA PACE; SI DICE ABBIA DIVISO 200.000 DOLLARI UN COLLASSO SCONVOLGE LA BORSA Mettetemi un cuscino sotto il capo e picchiateci sopra col martello perché a me il whisky mi ha distrutto il corpo e le donnine tolto il cervello LA FEDE NELLE IMBARCAZIONI DI GOMMA Ma vorrò bene a questo mio bambino finché avrà sale il mare Questo magnifico nuovo riflettore vi abbronza alla distanza di due miglia Finché il sole non spezzi le rocce non è duro? Dietro regolare domanda Smythe venne assunto a verificare la viscosità dell’olio di lubrificazione nelle fabbriche di Okmulgee il 12 luglio 1924. Una delle sue mansioni consisteva in versare benzolo dentro una caldaia bollente dove questo si condensava, in modo che se ne potessero verificare i residui. Giorno per giorno egli respirò i non gradevoli vapori della caldaia. Un mattino circa un anno dopo Smythe si tagliò il viso radendosi e s’accorse che il sangue non smetteva per ore di uscire in grande quantità dalla minuscola ferita. Anche i suoi denti presero a sanguinare strofinandoli e visto che il flusso dopo parecchi giorni non s’era fermato egli consultò un dottore. La diagnosi fu che i vapori del benzolo gli avevano distrutto le pareti dei vasi sanguigni. Dopo diciotto mesi di letto, durante i quali Smythe dormì soltanto sotto l’effetto di narcotici, gli asportarono la milza e le tonsille.
Frattanto si ricorreva alle trasfusioni periodiche di sangue nello sforzo di mantenere quasi normale la massa di circolazione. In tutto più di diciotto litri di sangue gli vennero trasfusi nelle braccia finché, quando le vene furono distrutte, divenne necessario incidere nella carne per aprirne delle altre. Per tutto questo tempo fino a otto ore avanti la morte, diceva la citazione, egli fu cosciente di quanto soffriva.
Mary French Il primo impiego che Mary French ebbe a New York, lo trovò attraverso un’amica di Ada. Consisteva nello starsene seduta tutto il giorno in una galleria d’arte dell’Ottava Avenue, dove c’era un’esposizione di scultura, e rispondere alle domande di svolazzanti signore in batik che venivano nel pomeriggio per farsi vedere intenditrici d’arte. Dopo due settimane di questo lavoro, la ragazza che lei sostituiva ritornò e Mary, che badava a ripetersi che quanto le occorreva era di tenersi in rapporto con qualcosa di reale, si trovò un impiego nel reparto vestiario per signore e signorine, da Bloomingdale. Quando venne la stasi estiva, la licenziarono ma, una volta a casa, lei scrisse un articolo per il «Freeman» sui dipendenti d’emporio e per merito di questo trovò un posto a far ricerche sui salari, sul costo della vita e sulla sperequazione fra prezzi all’ingrosso e prezzi al minuto nell’industria delle mode, per l’International Ladies’ Garment Workers. Le piacevano le lunghe ore trascorse a scovare statistiche, i colloqui con gli organizzatori, i radicali saputi, i lavoratori e le ragazze che entravano nell’ufficio sporco e affollato, da lei condiviso con due o tre altri ricercatori. Finalmente sentiva di fare qualcosa di reale. Ada era tornata dai suoi nel Michigan, lasciando Mary nell’alloggio di Madison Avenue. Fu un sollievo per Mary, che se ne andasse; le voleva sempre bene, ma i loro interessi eran troppo diversi e facevano sciocche discussioni sull’importanza rispettiva dell’arte e della giustizia sociale che le lasciavano spossate e vicendevolmente irritate, tanto che a volte non si parlavano più per giornate intere; e poi ciascuna a vicenda detestava le amicizie dell’altra. Pure Mary non poteva fare a meno di voler bene ad Ada. Erano amiche da così lunga data e Ada contribuiva con tanta generosità per i comitati di difesa degli scioperi, i fondi di soccorso legale e ogni altra cosa che Mary proponesse; era una ragazza davvero di cuore, ma il suo punto di vista era disperatamente ricco, non aveva coscienza sociale. Anche l’alloggio dava sui nervi a Mary French coi suoi ninnoli color pastello e il Whistler autentico e i tappeti troppo folti e le molle del letto
troppo soffici e i detestabili fiocchetti di raso dappertutto; però Mary guadagnava così poco che non pagar l’affitto era un grande aiuto. L’alloggio di Ada fu una provvidenza, la sera del grande comizio tenuto nel Madison Square Garden per salutare le vittime della lotta di classe rilasciate da Atlanta. Mary French, che era stata invitata a sedere sul palco, colse a volo le parole di certi membri del comitato che si lagnavano di non aver un posto per ricoverarci Ben Compton. Erano in cerca di un tranquillo nascondiglio dove quello potesse riposarsi e togliersi dalle calcagna gli agenti che, da quando era a New York, non lo avevano lasciato un istante. Mary si avvicinò e offrì con un bisbiglio casa sua. Così dopo il comizio attese in un tassì giallo all’angolo della Ventinovesima e di Madison Square, finché un uomo alto e pallido dal berretto a quadretti tirato sul viso non entrò sedendosi barcollante al suo fianco. Quando l’auto partì, si rimise gli occhiali cerchiati di acciaio. «Guardate dietro se ci segue una sedan grigia» disse. «Non vedo nulla» rispose Mary. «Oh, non la conoscereste, anche se la vedeste» borbottò quello. Per essere più sicuri scesero dal tassì alla Grand Central Station e andarono a piedi, senza scambiar parola, un tratto su per Park Avenue, poi a occidente per una via trasversale e ridiscesero Madison Avenue. Mary gli tirò la manica per farlo fermare davanti alla porta. Una volta in casa, quello le fece tirare il chiavistello e si abbandonò su una sedia senza levarsi il berretto né il soprabito. Non diceva una parola. Le spalle gli tremavano. Mary non trovò troppo piacevole fissarlo. Non sapeva che fare. Armeggiò un poco per la camera, accese il gas nel caminetto, fumò una sigaretta e poi entrò nella cucina a fare un po’ di caffè. Quando ritornò, quello si era tolta la roba e si scaldava le grosse giunture delle mani al gas del caminetto. «Devi scusarmi, compagna» disse con una voce secca e rauca. «Non mi reggo più in piedi.» «Oh non inquietarti per me» disse Mary. «Ho pensato che potevi volere un po’ di caffè.» «No, caffè no… latte bollente» rispose in fretta. Gli battevano i denti come avesse freddo. Mary ritornò con un tazzone di latte bollente. «È possibile avere anche un po’ di zucchero?» chiese quasi
sorridendo. «Ma certo» disse Mary. «Hai fatto un discorso stupendo, così sobrio e insieme ardente… È stato il migliore di tutto il comizio.» «Non ti è parso che mi mostrassi agitato? Avevo paura di andare in tanti pezzi e di non riuscire a finire… Sei certa che nessuno conosce quest’indirizzo o il numero del telefono? Sei certa che non ci abbiano seguiti?» «Sono sicura che nessuno ti troverà qui in Madison Avenue… È l’ultimo luogo dove penserebbero di cercare.» «So che stanno sulle mie tracce» disse lui con un fremito e si lasciò un’altra volta cadere su una sedia. Stettero a lungo silenziosi. Mary poteva udire il gas del caminetto e i sorsetti risucchianti con cui il suo compagno sorbiva il latte bollente. Poi disse: «Dev’essere stata una cosa terribile.» Lui sorse in piedi e scosse il capo, come se non avesse voglia alcuna di parlare. Era un giovane dalle membra magre, ma camminava su e giù davanti al camino con un passo da vecchio, stranamente strascicato. Aveva un viso bianco come un agarico e sotto gli occhi pieghe di pelle brunastra. «Vedi,» disse «è come chi sia stato malato e debba imparare da capo a camminare… non badarci.» Bevve diverse tazze di latte e poi si mise a letto. Mary entrò nell’altra camera, chiuse la porta e si distese sul letto con un fascio di libri e di opuscoli. Doveva controllare certi particolari legali. Le era appunto venuto sonno e s’era ficcata anche lei sotto le coperte, quando un busso la destò. Diede di piglio all’accappatoio e balzò a terra e aprì la porta. Ben Compton era lì tremante, vestito d’una sottoveste di cotone. S’era tolti gli occhiali e questi gli avevano lasciato una riga rossa sull’arco del naso. Aveva i capelli scarmigliati e nudi i piedi nodosi. «Compagna,» balbettò «ti dispiace se io… ti dispiace se io… ti dispiace se io mi corico nel letto con te? Non posso dormire. Non posso stare solo.» «Oh povero ragazzo… Vieni a letto, tu batti i denti» disse Mary. Si distese accanto a lui, senza togliersi l’accappatoio e le pantofole. «Debbo spegnere la luce?» Quello annuì. «Vuoi forse un po’ d’aspirina?» Scosse il capo. Mary gli rimboccò le coperte sotto il
mento, come a un bimbo. Stava là disteso supino, con gli occhi neri sbarrati al soffitto. Serrava i denti. Mary gli posò la mano sulla fronte come avrebbe fatto a un bimbo, per sentire se era febbricitante. Lui rabbrividì e si ritrasse. «Non toccarmi» disse. Mary spense la luce e cercò di raccogliersi e dormire sul letto accanto a lui. Dopo un poco, il compagno le afferrò la mano e la tenne stretta. Giacquero là nel buio a fianco a fianco sbarrando gli occhi al soffitto. Poi Mary sentì la presa alla mano allentarsi; cadeva a poco a poco addormentato. Giacque là accanto a lui con gli occhi aperti. Temeva che il più lieve sussulto potesse svegliarlo. Ogni volta che pigliava sonno, sognava che i poliziotti irrompevano dalla porta e trasalendo si svegliava con un brivido. L’indomani mattina, quando uscì per recarsi all’ufficio, il compagno dormiva ancora. Gli lasciò una chiave e un biglietto che spiegava come in ghiacciaia ci fossero cibo e bevande. Quando rientrò quel pomeriggio, nel salire con l’ascensore il cuore le batteva accelerato. Il suo primo pensiero quand’ebbe aperta la porta fu che lui se ne fosse andato. La stanza da letto era vuota. Poi s’accorse che la porta del bagno era chiusa e ne veniva un canterellio. Bussò. «Sei tu, compagno Compton?» «Esco subito.» La voce suonava più ferma, più simile alla voce ricca e profonda con cui aveva parlato al comizio. Venne fuori sorridendo, le lunghe gambe pallide, irte di peli neri, spuntavano strambamente da sotto l’accappatoio color lavanda di Mary. «Ciao, ho fatto un bagno caldo. È il terzo che prendo. Il dottore diceva che fanno bene… Sai, rilassarsi…» Si trasse da sotto il braccio una edizione in pelle rosa del Dorian Gray di Oscar Wilde e gliela agitò davanti. «Ho letto queste balle… Sto meglio… Di’, compagna, in casa di chi siamo, dunque?» «Una mia amica che fa la violinista… È via fino a quest’autunno.» «Mi piacerebbe fosse qui a suonarci qualcosa. Sarei contento di sentire un po’ di buona musica… A te piace la musica?» Mary scosse il capo. «Ti senti di mangiare qualcosa a cena? Ho comprato qualcosa.» «Proverò… niente di troppo fine… Sono diventato terribilmente
dispeptico… Davvero ti è parso che abbia parlato bene?» «Mi sei parso magnifico» disse Mary. «Dopo cena guarderò i giornali che hai portato… Se soltanto la stampa pagata non falsificasse tutto ciò che diciamo…» Mary fece scaldare una minestra di piselli e preparò crostini e uova al lardo, e lui mangiò tutto quanto gli diede. Mentre mangiava, ebbero un tranquillo e intimo scambio d’idee intorno al movimento. Mary gli parlò delle sue esperienze nel grande sciopero dell’acciaio. S’accorgeva che Ben cominciava a trovare in lei qualcosa d’interessante. Non avevano quasi finito di cenare, che Ben cominciò a sbiancarsi in viso. Andò nella stanza da bagno e rigettò. «Ben, povero disgraziato» gli disse, quando tornò sbattuto e sussultante. «È spaventevole.» «Strano» disse lui con la voce debole. «Quand’ero nel penitenziario del distretto di Bergen laggiù nel Jersey, ne sono uscito che stavo bene… ma questa volta ci son cascato.» «Ti trattavano molto male?» Ben serrò i denti e i muscoli della mascella si contrassero, ma scosse il capo. D’un tratto le afferrò la mano e gli s’empirono gli occhi di lacrime. «Mary French, tu sei troppo buona con me» disse. Mary non poté tenersi dal gettargli le braccia al collo e stringerlo a sé. «Tu non sai quanto vuol dire trovare una… trovare una buona compagna» le fece, staccandola da sé teneramente. «E adesso fa’ vedere come i giornali hanno conciato quel che ho detto.» Da quasi una settimana Ben era nascosto nell’alloggio, quando un sabato sera tutti e due decisero che si amavano. Mary non era mai stata così felice in vita sua. Ruzzarono tutta la domenica come monelli e uscirono a passeggio in un giardino a sentir suonare la banda nel crepuscolo. Nello stanzino da bagno si tirarono l’un l’altro le spugne e si burlarono a vicenda spogliandosi; dormirono strettamente allacciati l’uno nelle braccia dell’altra. Per quanto non uscisse mai se non di sera, nelle giornate seguenti le guance di Ben cominciarono a colorirsi un poco e il suo passo a farsi più elastico. «Tu mi hai fatto ritornare un uomo, Mary» le diceva una dozzina di volte al giorno. «Ora ricomincio a sentirmi in grado di far di nuovo qualcosa. Dopo tutto comincia solo adesso, il movimento
rivoluzionario, in questo paese. La corrente cambia, vedrai. È cominciato con il trionfo della rivoluzione in Russia.» C’era qualcosa di commovente per Mary nel modo come lui pronunciava quelle parole: Lenin, Trockij, Russia… Dopo una quindicina di giorni, cominciò a recarsi a riunioni coi capi radicali. Mary non sapeva mai se l’avrebbe o no trovato in casa, quando tornava dal lavoro. Qualche volta venivano le tre o le quattro del mattino prima che lui rientrasse stanco e sbattuto. Sempre aveva le tasche rigonfie di letteratura e stampati. Il salotto elegante di Ada si riempì a poco a poco di gazzette malstampate e opuscoletti e fogli ciclostilati. Sulla cappa del camino, tra le figurine di Dresda che suonavano strumenti musicali, erano accatastati i tre volumi di una famosa opera di economia piena di segni fatti a matita. La sera lui le leggeva frammenti di un opuscolo a cui lavorava ricalcando sul Che fare? di Lenin e le chiedeva con la fronte corrugata se era chiaro, se i semplici lavoratori potevano comprendere ciò che lui voleva dire. Una domenica nell’agosto Ben la fece venire con sé a Coney Island dove aveva fissato un incontro coi suoi; aveva pensato che sarebbe stato più agevole vederli in mezzo alla folla. Non aveva nessun desiderio che i poliziotti lo pedinassero fino a casa e poi dessero delle noie ai vecchi o a sua sorella che aveva una buona posizione come segretaria di un importante uomo d’affari. Quando si incontrarono, passò qualche tempo prima che i Compton s’accorgessero di Mary. Sedettero attorno a un grande tavolo rotondo da Stauch e ordinarono birra. Mary trovò difficile starsene calma sulla sedia, mentre tutti i Compton insieme le piantavano addosso gli occhi. I vecchi furono assai gentili e di modi cortesi, ma lei s’accorse che avrebbero preferito non fosse venuta. La sorella di Ben, Gladys, le diede una guardata dura e cattiva e poi non le fece più attenzione. Il fratello Sam, un ebreo corpulento e prosperoso, che Ben aveva detto proprietario di una piccola azienda, probabilmente uno sfruttatore, fu gentile e untuoso. Solamente Izzy, il più giovane, aveva un poco l’aria di un lavoratore, e con molta probabilità era un bandito. Questi la trattava con una familiarità scherzosa, Mary vedeva bene che la giudicava la femmina di Ben. Tutti ammiravano Ben, di questo s’accorse; lui era l’aquila
della famiglia, lo studioso, ma tutti erano spiacenti per quel suo radicalismo, come fosse stata una disgraziata malattia da lui contratta. Pure, il suo nome sul giornale, l’applauso del Madison Square Garden, i discorsi che lo designavano un eroe del proletariato, li avevano colpiti. Dop che Ben e Mary lasciarono i Compton e stavano entrando nella stazione della sotterranea, Ben le disse all’orecchio aspramente: «E così, quest’è la famiglia giudea… Che cosa te ne pare? È una bella camicia di forza… Sarebbe lo stesso se avessi ammazzato qualcuno o tenuto una catena di postriboli… Nemmeno nel movimento uno può liberarsene.» «Ma, Ben, c’è anche il suo bello… farebbero qualunque cosa al mondo, per te… io e mia madre invece ci odiamo proprio a morte.» Ben aveva bisogno d’un abito e altrettanto Mary; da una settimana all’altra non le avanzava mai un quattrino dello stipendio, e così per la prima volta in vita sua scrisse a sua madre chiedendole cinquecento dollari. Sua madre le mandò un assegno con una lettera piuttosto amabile, dicendo ch’era stata eletta commissaria del partito repubblicano e che ammirava l’indipendenza di Mary, perché aveva sempre professato che le donne hanno altrettanto diritto degli uomini a guadagnarsi la vita e poteva darsi che le donne in politica esercitassero un miglior influsso di quanto lei non avesse creduto un tempo, e certo Mary mostrava del fegato ad aprirsi così risolutamente una carriera, ma lei sperava che ben presto sarebbe arrivata a convincersi che poteva trovare una carriera altrettanto interessante se ritornava a Colorado Springs e occupava la posizione sociale cui la situazione della madre le dava diritto. Ben fu talmente felice quando vide l’assegno, che non domandò per che farne Mary avesse cercato quel denaro. «Cinquecento svanziche, sono giusto quel che mi occorre» disse. «Non avevo voluto dirtelo ma mi hanno chiesto di capeggiare uno sciopero a Bayonne… le fabbriche di rayon… sai bene, le antiche fabbriche di munizioni, trasformate in filature di seta artificiale… È una dura città e i lavoratori sono così poveri, che non riescono a pagare le quote sindacali… ma c’è un sindacato radicale in gamba, laggiù. È importante avere un piede nelle nuove industrie… è qui che le vecchie organizzazioni vendute dell’AFL 1 non ce la fanno…
Cinquecento svanziche serviranno a pagare le spese di tipografia.» «Oh Ben, ma non ti sei ancora riposato. Ho paura che ti arrestino un’altra volta.» La baciò. «Niente di grave.» «Ma Ben, volevo comprarti un vestito.» «Questo è un abito bellissimo. Cos’ha che non va quest’abito? Non me l’ha dato lo Zio Sam in persona?… Una volta che la baracca sia incamminata, faremo venire anche te, per la pubblicità… così estendi la tua esperienza nel campo dell’abbigliamento. Oh Mary, sei proprio una ragazza d’oro, aver trovato quei quattrini.» Quell’autunno, quando Ada fu di ritorno, Mary lasciò l’alloggio e si trovò un paio di stanzette sulla Quarta Strada Ovest nel Villagge, perché Ben potesse avere una casa quando ritornava a New York. Quell’inverno Mary lavorò tremendamente, conservando sempre il suo antico impiego e contemporaneamente attendendo alla pubblicità per gli scioperi che Ben dirigeva in parecchie città del Jersey. «Non è nulla questo, rispetto a quanto dovremo lavorare quando faremo la rivoluzione in America» le diceva Ben, quando lei gli chiedeva se non credesse che avrebbero fatto un miglior lavoro non cercando sempre di occuparsi di tante cose in una volta. Non sapeva mai prima, quando Ben si sarebbe fatto vedere. Alle volte eccolo tutte le sere per una settimana di fila e alle volte stava via per un mese; e lei ne sapeva nuove soltanto attraverso resoconti di comizi, scioglimento di picchetti, dibattiti d’ordinanze in tribunale. Una volta decisero di sposarsi e avere un bambino, ma i compagni fecero chiamare Ben per organizzare le cittadine intorno a Passaic e Ben disse che il matrimonio lo avrebbe stornato dal suo lavoro, che tutti e due eran giovani e dopo la rivoluzione ci sarebbe stato tutto il tempo per quella faccenda. Adesso, era il momento della lotta. Certo, se lei voleva nessuno le impediva di avere il bambino, ma per parecchi mesi la gravidanza avrebbe abbassato il suo rendimento nella lotta e, secondo lui, non era quello il momento. Fu quella la prima volta che bisticciarono. Mary disse che lui non aveva cuore. Ben disse che dovevano sacrificare per il proletariato ogni sentimento personale e uscì di casa, tempestando su tutte le furie. Alla fine, Mary fece un
aborto, ma dovette di nuovo scrivere a sua madre che le mandasse il denaro per pagarlo. Si buttò a lavorare per il comitato dello sciopero più accanitamente che mai. Certe volte, per settimane intere non dormiva più di quattro o cinque ore ogni notte. Si mise a fumare enormemente. C’era sempre una sigaretta poggiata sull’angolo della macchina da scrivere. La cenere fine entrava fra le pagine via via che uscivano dal multigrafo. Ogni volta che nell’ufficio potessero fare a meno di lei, andava in giro facendo collette presso signore danarose, inducendo noti liberali a venirsi a fare arrestare nei picchetti, strappando articoli ai giornalisti, viaggiando per tutto il paese per scovare gente caritatevole disposta a dar garanzie per le cauzioni. Gli scioperanti, gli uomini, le donne, i bambini dei picchetti, delle cucine di soccorso, intervistati nei lugubri salotti d’entrata delle loro case denudate del mobilio di cui non erano arrivati a versar l’ultima rata, gli autocarri zeppi di crumiri, le guardie civiche e i poliziotti col moschetto di guardia agli alti steccati dei silenziosi sterminati rettangoli degli opifici dalle finestre nere: tutto le passava innanzi in una specie di nebbia sonnolenta, come una scena a teatro, fra quel continuo dattilografare e multigrafare, la stesura di lettere, la compilazione di petizioni, la lunga oppressione del lavoro d’ufficio che le assorbiva le giornate e le nottate. Lei e Ben non conducevano più affatto un’esistenza in comune. Mary fremeva per Ben, a quel modo che fremevano gli operai nei comizi, quando lui saliva sul palco in un tumulto di scarpiccio e d’applausi e parlava con le gote avvampate e gli occhi lucenti, parlava chiaramente direttamente a ciascun uomo e a ciascuna donna, incoraggiandoli, mettendoli in guardia, spiegando loro la situazione economica. Le ragazze degli opifici andavano tutte pazze per lui. Suo malgrado, Mary French provava un senso di disagio alla bocca dello stomaco vedendo il modo come lo guardavano e come qualche fresca donna alta e formosa talvolta lo fermava nel corridoio fuori dell’ufficio e gli posava la mano sul braccio e lo costringeva a darle ascolto. Mary incalzando il lavoro alla sua scrivania, con la lingua amara e la bocca disseccata dal troppo fumare, si guardava le dita macchiate di giallo, si rigettava via dalla fronte i capelli non ricci e
arruffati, e si sentiva malamente vestita, sfiorita, antipatica. Se soltanto Ben le faceva un sorriso per lei sola, prima di scacciarla urlando davanti a tutto l’ufficio perché i foglietti non erano pronti, per tutto il giorno lei si sentiva felice. Ma il più delle volte Ben pareva essersi dimenticato che un tempo erano stati innamorati. Dopo che i funzionari dell’AFL da Washington, vestiti di soprabiti costosi e sciarpe di seta, gente che fumava sigari da venticinque cents e sputava sul pavimento dell’ufficio, ebbero levato lo sciopero di mano a Ben e messo a posto ogni cosa, lui ritornò alla stanza della Quarta Strada una sera tardi, proprio mentre Mary stava mettendosi a letto. Aveva gli occhi cerchiati di rosso per la privazione di sonno e le gote incavate e terree. «Oh Ben» disse Mary e scoppiò a piangere. Lui fu amaro, freddo, disperato. Stette seduto per ore sulla sponda del letto di Mary e le raccontava con una voce netta e monotona del tradimento e delle contese fra l’ala sinistra e i socialisti della vecchia guardia e i capi del movimento proletario, e come, ora che tutto era finito, ecco che saltava su il suo processo per oltraggio al magistrato. «Mi sa così male di spendere per me il denaro dei lavoratori… Vorrei piuttosto andar dentro senz’altro… ma è il precedente… Dobbiamo disputare ogni caso e questo è l’unico modo in cui possiamo adoperare gli avvocati liberali, quei luridi chiacchieroni… E costa assai, l’Unione è in bolletta e non mi piace che spendano per me i quattrini… ma dicono che se vinciamo il mio, tutti i processi contro gli altri compagni non avranno più luogo…» «Quello che occorre» disse Mary lisciandogli i capelli all’indietro «è di rilassarsi un poco.» «Spetta a te dirmelo?» fece lui e cominciò a slacciarsi le scarpe. Passò molto tempo prima che Mary potesse indurlo a mettersi a letto. Lui se ne stava a sedere semivestito nel buio, battendo i denti e parlando degli errori che si erano commessi nello sciopero. Quando alla fine si fu spogliato d’ogni indumento e si rizzò per deporli su una sedia, apparve come uno scheletro nell’ampio fascio di luce grigiastra che emanando dal lampione fuori della finestra attraversava la stanza. Mary scoppiò un’altra volta a piangere vedendo quel torace incavato e i vuoti profondi sopra le clavicole. «Cos’hai, sciocca?» disse aspro Ben. «Piangi perché non hai un Valentino che ti venga a letto insieme?»
«Che stupidaggine, Ben, pensavo davvero che hai bisogno di ingrassare… poveretto, lavori proprio troppo.» «Uno di questi giorni tu te la batterai con qualche agente di Borsa, bel giovane, come ne conoscevi una volta a Colorado Springs… So quel che mi debbo attendere… Non me ne importa un fico… Posso da solo continuare la lotta.» «Oh Ben, non dirle queste cose… tu lo sai che sono anima e corpo…» Lo tirò a sé. D’improvviso, lui la baciò. L’indomani mattina bisticciarono aspramente mentre si vestivano, sul valore del suo lavoro di ricerca. Mary disse che dopo tutto lui non poteva parlare; lo sciopero non era poi stato quell’enorme successo. Ben allora uscì senza toccare la colazione. Mary corse all’ufficio in una stretta rabbiosa di dolore, mandò all’aria l’impiego, e qualche giorno dopo si recava a Boston a lavorare per il caso Sacco-Vanzetti col nuovo comitato che s’era allora formato. Non era mai stata a Boston. La città nelle assolate giornate d’inverno aveva nei suoi mattoni rossi un’aria di antica incisione, che le piacque. Prese una stanzetta sull’orlo dei quartieri poveri dietro Beacon Hill e decise che, una volta vinto il processo, avrebbe scritto un romanzo su Boston. Comperò certi quaderni scolastici in una piccola cartoleria che sapeva di chiuso e cominciò subito a prendere appunti per il romanzo. Il sentore del quaderno nuovo con le sue indistinte righe azzurre le diede un senso di esser fresca e nuova. D’ora in poi avrebbe osservato la vita. Non si sarebbe mai più innamorata di un uomo. La mamma le aveva mandato per Natale un assegno. Con esso si comperò qualche capo di vestiario e un cappellino che le stava assai bene. Riprese ad arricciarsi i capelli. Il suo lavoro consisteva nel tenersi in contatto coi giornalisti e cercare di far entrare cenni favorevoli nella stampa. Eran sudori. Benché la massima parte dei giornalisti comunque interessati al processo pensassero che i due erano stati indiziati a torto, badavano a dire che si trattava, tutto sommato, di due anarchici europei, che diavolo dunque pigliarsela? Dopo essere stata al penitenziario di Denham a parlare con Sacco e a Charlestown a parlare con Vanzetti, Mary cercò di spiegare all’inviato della Union Press quel che provava per loro, un sabato sera che quello la portò a cena in una trattoria
italiana di Hanover Street. Era l’unico dei giornalisti con cui avesse fatto veramente amicizia. Era una spugna spaventosa, ma aveva assai girato e veduto e usava cortesi e disinvolti modi che le piacevano. Per un motivo o per l’altro lei gli piaceva, benché la canzonasse spietatamente per quello che lui chiamava il suo fanatismo giovanile. Quando la invitava a cena e le faceva bere vino rosso in quantità, lei si diceva che quello non era sprecare il tempo, ma che importava assai tenersi in contatto coi servizi della stampa. Si chiamava, costui, Jerry Burnham. «Ma, Jerry, come potete tollerarlo? Se lo Stato di Massachusetts può assassinare quei due innocenti di fronte alla protesta di tutto il mondo, vorrà dire che non ci sarà mai più nessuna giustizia in America.» «Quando mai c’è stata in passato?» chiese lui con un risolino freddo, piegandosi a riempirle il bicchiere. «Mai sentito di Tom Mooney?» Il bianco ricciuto di quei capelli dava un’aria stranamente giovanile al rosso viso turgido. «Ma c’è qualcosa di così sereno, così onesto in loro; se ne ritrae un tale senso di grandezza. Veramente, sono grandi uomini.» «Ogni cosa che dite rende più sorprendente che non siano già stati giustiziati anni fa.» «Ma i lavoratori, la gente del popolo, non lo permetteranno.» «È la gente del popolo quella che più si diverte a veder torturare e giustiziare i grandi uomini… Se non fosse risalire troppo lontano, gradirei sapere chi fu che chiese l’esecuzione del nostro comune amico Gesù Cristo Santo.» Fu Jerry Burnham che le insegnò a bere. Quanto a lui, viveva in una quotidiana nuvola d’alcool portando il suo liquore in modo così accurato e circospetto come un acrobata che passeggia per un filo teso con una tavolata di piatti in equilibrio sulla testa. Era così abituato ad attendere al suo servizio delle ventiquattro ore, che sbrigava i telegrammi e le faccende dell’ufficio altrettanto distrattamente come avrebbe pagato il conto in uno spaccio clandestino prima di girare l’angolo e ficcarsi in un altro. Aveva i reni bell’e andati e coltivava la vigna, diceva lui, ma Mary osservò spesso che il fiato gli sapeva di whisky, le volte che entrò nel suo ufficio. Era talmente esasperante che lei giurava a se stessa, ogni volta che gli usciva insieme, che quella era l’ultima. Non c’era più da perder tempo, ora che gli istanti eran così
preziosi. Ma la prossima volta che la invitava, lei s’animava subito e sorrideva e diceva di sì e sprecava un’altra serata a bere vino e ascoltarlo cicalare. «Deve finire tutto in cecità e morte istantanea» le disse una notte, lasciandola in un tassì all’angolo della via. «Ma chi se ne infischia?… Chi in questo lurido, puzzolente mondo se ne fotte anche tanto così?» Ora che, una revisione dopo l’altra, tutto era stato inutile e la inacidita primavera di Boston s’intiepidì nell’estate e la commissione governativa riferì sfavorevolmente e non rimaneva altra speranza che una grazia da parte del governatore, Mary lavorava sempre più disperatamente accanita. Scriveva articoli, parlava con uomini politici e pastori, discuteva con direttori di giornali, faceva discorsi nelle sale delle unioni sindacali. Scrisse a sua madre lettere pietosamente umilianti per cavarle denaro, sotto tutti i pretesti. Fin l’ultimo centesimo che poteva raggranellare andava nel lavoro del suo comitato. C’era sempre da pagare cancelleria, francobolli, telegrammi e telefonate. Mary passò lunghe sere tentando di persuadere comunisti, socialisti, anarchici, liberali a lavorare insieme. Correndo per le vie lastricate di pietra sussurrava a se stessa: “Bisogna salvarli, bisogna salvarli”. Quando poi finalmente si metteva a letto, i suoi sogni erano pieni di compiti impossibili, tentava di incollare insieme i pezzi rotti di una teiera e, appena ne aveva rappezzato un fianco, l’altro ritornava in pezzi, tentava di rammendarsi uno strappo nella sottana e, una volta ricucito il fondo, ecco che s’era staccata la cima; tentava di ricongiungere frammenti di un foglio scritto a macchina, il telegramma era della massima importanza, lei non riusciva a vederlo, era tutto una nebbia davanti ai suoi occhi, quella testimonianza li avrebbe costretti a una revisione del processo, gli occhi non le servivano, quando aveva messo insieme una parola con quelle lettere enfiate e palpitanti dimenticava la precedente; ecco che saliva il pendio malfermo di una collina in mezzo a case nere sventrate, sporte ad angoli pazzeschi, dimora dei siderurgici, a ogni passo le scivolava il piede, era troppo erto, gridava aiuto, urlava, scivolava. Poi calde voci rassicuranti, come quella di Ben Compton quand’era in salute, le dicevano che la Pubblica Opinione non l’avrebbe tollerato, che dopo
tutto gli americani avevano il senso della Giustizia e del Buon Gioco, che i Lavoratori si sarebbero sollevati; vedeva comizi affollatissimi, motti di guerra, bandiere, luminosi cartelli dalle lettere drizzate in prospettiva che dicevano: Lavoratori del Mondo Unitevi, lei marciava in mezzo alle folle in cortei di protesta. Non Debbono Morire. Si risvegliava con un sussulto, faceva il bagno, si vestiva in fretta e furia, e si precipitava all’ufficio del comitato, dando di piglio per strada a una spremuta d’arancia e a una tazza di caffè. Era sempre la prima all’ufficio; se rallentava un momento il lavoro, ecco che vedeva i loro visi, quello pallido, fattezze taglienti e occhi accesi, del calzolaio e i filosofici baffi del pescivendolo dai meditabondi occhi sgombri da terrore. E vedeva dietro a loro la sedia elettrica altrettanto chiaramente che se fosse davanti alla sua scrivania nel chiuso ufficio accalcato. Luglio scappò via anche troppo presto. Venne agosto. Una folla crescente di gente d’ogni risma cominciò a dilagare nell’ufficio: vecchi amici, internazionalisti che un po’ a piedi e un po’ a sbafo erano venuti fin dalla costa, politicanti interessati al voto della colonia italiana, avvocati con suggerimenti da offrire per la difesa, scrittori, giornalisti disoccupati, mattoidi e lestofanti d’ogni sorta attratti dalle voci di un enorme fondo di difesa. Mary tornò un pomeriggio che aveva parlato in una sala d’unione a Pawtucket e trovò G.H. Barrow seduto alla sua scrivania. Barrow aveva scritto un fascio di telegrammi personali a senatori, deputati, pastori, capi del movimento proletario, chiedendo che si unissero nella protesta in nome della giustizia, della civiltà e della classe dei lavoratori, lunghi telegrammi e cablogrammi alle tariffe massime. Mary calcolò la spesa mentre li elencava. Non sapeva come il comitato avrebbe potuto pagarli, ma li porse al fattorino che aspettava fuori. Non poteva quasi credere che quelle parole le avessero fatto fremere le vene solamente poche settimane prima. La spaventò pensare quanto insignificanti le sembrassero ora, come i bigliettini che si ritirano per un cent dalla macchina della buona ventura. Erano ormai sei mesi che tutti i giorni leggeva e scriveva le medesime parole. Mary non ebbe il tempo di sentirsi imbarazzata nell’incontro con George Barrow. Uscirono insieme a prendere un piatto di brodo in un
caffè e non parlarono d’altro che del caso Sacco-Vanzetti, come se prima non si fossero mai conosciuti. I picchetti di protesta davanti alla State House eran ricominciati e, uscendo dal ristorante, Mary gli si rivolse e disse: «Dunque, George, che ne direste di andare lassù a farvi arrestare?… C’è ancora tempo per comparire nei giornali del pomeriggio. Il vostro nome ci ridarebbe la prima pagina». Barrow arrossì, e restò là davanti al ristorante tra la folla meridiana, alto, nervoso, occhi fuori, nel suo attillato completo grigio chiaro. «Ma mia cara rag-g-gazza, io… se credessi che servisse anche solo minimamente, io… mi farei arrestare o investire da un autocarro… ma credo che ciò mi priverebbe anche di quella poca utilità che posso avere.» Mary French lo guardò fisso negli occhi, col viso sbiancato dall’ira. «Immaginavo che non avreste corso questo rischio» disse staccando ogni parola e sputandogliela in faccia. Gli voltò le spalle e ricorse all’ufficio. Fu come un sollievo quando venne arrestata anche lei. Aveva deciso di girare sempre alla larga dalle guardie, poiché le avevan detto che la sua opera era troppo preziosa e non si poteva farne a meno, ma doveva pur correre su per la collina con un fascio di cartelli per un nuovo picchetto di dimostranti che erano partiti a mani vuote. Stava giusto attraversando Beacon Street quando due grosse guardie civiche riguardose le apparvero a un tratto ai fianchi. Uno di loro disse: «Spiacente, signorina, favorite venire con noi» e Mary si trovò seduta nella buia vettura cellulare. Durante la corsa al posto di polizia, provava un blando senso di abbandono e d’irresponsabilità. Era la prima volta, da settimane, che non si rilassava così. Al posto di Joy Street la registrarono ma non la misero in cella. Sedette su una panca in faccia alla finestra, con due ebrei lavoratori dell’abbigliamento e una donna elegante dal fiorito abito estivo e una collana di perle al collo, e osservò il gruppo dei dimostranti che cacciavano allora in cella. Le guardie eran riguardose, tutti erano gai; pareva una sorta di gioco, era difficile credere che ci fosse di mezzo qualcosa di reale. In un gruppo scaricato allora dal cellulare nella ripida via davanti al posto, Mary scorse un uomo alto che riconobbe per Donald Stevens
dal ritratto del «Daily». A ciascun braccio gli stava attaccata una guardia rossa in faccia. Aveva la camicia strappata al collo, e la cravatta pareva un cordino, come se qualcuno vi si fosse attaccato. La prima cosa che Mary pensò fu che bel contegno teneva. Aveva i capelli grigiacciaio, una pelle bruna d’aria e di sole, e gli occhi grigi luminosi sugli zigomi alti. Quando lo condussero via dalla scrivania, Mary seguì con gli occhi quelle spalle ampie nel buio delle celle. La donna accanto a lei sussurrò con la voce spaventata che l’avevano arrestato per incitamento alla rivolta invece che per vagabondaggio e infingardaggine come tutti gli altri. Cinquemila dollari di cauzione. Aveva cercato di tenere un comizio in Boston Common. Mary era là da una mezz’ora, quando il piccolo signor Feinstein dell’ufficio arrivò con un signore alto in un elegante completo di lino, che sborsò per lei la cauzione. Contemporaneamente venne anche rilasciato Donald Stevens. Tutti e quattro si allontanarono insieme, scendendo a piedi, dal posto di polizia. All’angolo l’uomo vestito di lino disse: «Voi due eravate troppo preziosi per lasciarvi là dentro tutto il giorno… Spero che ci vedremo al Bellevue… appartamento D, secondo piano». Poi sventolò la mano e se ne andò. Mary era talmente ansiosa di parlare con Donald Stevens che non pensò di chiedere il nome di quel tale. Gli eventi le scorrevano intorno più veloci che lei non potesse appuntarci sopra l’attenzione. Mary tirò la manica a Donald Stevens, tanto lei e il signor Feinstein dovevano correre per tenersi al livello di quel lungo passo. «Sono Mary French» disse. «Che possiamo fare?… Qualcosa dobbiamo fare.» Quello le si rivolse con un aperto sorriso, come se la notasse allora per la prima volta. «Ho sentito di voi» disse. «Siete una ragazzina di fegato… avete messo su una vera lotta a dispetto del vostro comitato liberale.» «Ma hanno fatto del loro meglio» disse lei. «Dobbiamo far uscire per le vie tutti i lavoratori di Boston» disse Stevens con quella profonda voce rimbombante. «Abbiamo fatto uscire i lavoratori dell’abbigliamento, ma è tutto qua.» Stevens si picchiò un pugno sulla palma della mano. «E la colonia italiana? E il North End? Il vostro ufficio dov’è? Guardate quanto
abbiamo fatto a New York. Perché non potete fare altrettanto qui?» Si piegò verso di lei con un fare carezzevole, confidenziale. Di colpo quel senso di spossatezza e oppressione la lasciò; senza pensarci gli posò la mano sul braccio. «Andremo a parlare con il vostro comitato; poi parleremo al comitato italiano. Poi daremo uno scossone alle Unioni.» «Ma, Don, non ci restano che trenta ore» disse il signor Feinstein con la voce secca e stremata. «Ho più fiducia in una pressione politica esercitata sul governatore. Voi sapete che ha ambizioni presidenziali. Credo che commuterà le sentenze, il governatore.» Nell’ufficio Mary trovò Jerry Burnham che l’aspettava. «Eccoci, Giovanna d’Arco,» disse «stavo appunto per venire a cauzionarvi. Ma vedo che vi han già messo in libertà.» Jerry e Donald Stevens s’erano evidentemente già conosciuti altrove. «Dunque, Jerry,» fece Donald Stevens con aria selvaggia «neanche questo non vi leva di dosso un po’ della vostra cinica posa?» «Non vedo perché dovrebbe. Non è per me una novità che i presidenti dei collegi siano tutti farabutti.» Donald Stevens saltò contro la parete come si trattenesse dal menare a Jerry un pugno in faccia. «Io non posso capire come un uomo che abbia ancora un po’ di sangue nelle vene non diventi un rosso… anche se è un giornalista piccolo-borghese.» «Mio caro Don, a quest’ora dovreste saperlo che il nostro sangue nelle vene l’abbiamo ipotecato tutto per un quattrino, intorno ai tempi della Prima guerra mondiale… cioè, se pure ne avevamo… Immagino che ci siano pareri discordanti su questo punto.» Donald Stevens s’era già ficcato con un mezzo giro nell’ufficio interno. Mary si trovò a guardare la faccia scarlatta di Jerry, e non sapeva che dirgli. «Intesi, Mary, se avete bisogno di un gocciolo, quest’oggi… E mi dà l’aria che ne avrete bisogno… Io sono al solito posto.» «Oh, non avrò tempo» disse Mary freddamente. Sentiva la voce profonda di Donald Stevens dall’ufficio interno. Si precipitò dietro a lui. Gli avvocati avevano perduto. Parlando, altercando, discutendo di come si poteva organizzare una protesta in punto estremo, Mary sentiva le ore scorrere, le ore dell’esistenza di quegli uomini. Sentiva i minuti sgocciolare e passare, altrettanto vividamente che se fossero il
sangue che le uscisse dai polsi. Si sentiva debole, sofferente. Non riusciva a pensare a nulla. Fu un sollievo uscire per la strada trotterellando per tenersi a livello del lungo passo di Donald Stevens. Fecero un giro per i comitati. Era quasi mezzodì, nulla di fatto. Giù in Hanover Street un italiano dalla faccia pallida dentro una malandata sedan Ford fece loro segno. Stevens aprì lo sportello dell’auto. «Compagna French, questo è il compagno Strozzi… ci porterà lui in macchina.» «Siete cittadino americano?…» domandò lei aggrottandosi ansiosa. Strozzi crollò il capo e sorrise un tagliente sorriso. «Può darsi che mi paghino il viaggio di ritorno al paesello» disse. Mary non ricordò mai quel che fecero nel resto della giornata. Scarrozzarono per tutti i più miseri sobborghi di Boston. Sovente, gli uomini che cercavano erano fuori. Una gran parte del tempo Mary la passò in cabine telefoniche chiamando numeri sbagliati. Non pareva più capace di far nulla bene. Fissava, con occhi sbarrati e torpidi da sotto palpebre che le parevano di cartavetro, gli uomini e le donne che si pigiavano nell’ufficio. Stevens aveva smesso quel suo modo pungente e irritato dei primi momenti. Discuteva ora coi funzionari delle Unioni, coi socialisti, coi pastori, con gli avvocati, in un freddo e sarcastico distacco. «Dopo tutto, sono uomini coraggiosi. Non importa più se vengano o no salvati, ma quello che importa salvare è la forza dei lavoratori» diceva. Dappertutto girava la stessa opinione. Una dimostrazione finirà nella violenza, distruggerà la possibilità che il governatore commuti la pena all’ultimo minuto. Mary aveva perso tutta la sua iniziativa. Di colpo era diventata la segretaria di Donald Stevens. Era un po’ meno infelice solo quando correva a far per lui qualche commissione. A tarda ora quella notte girò tutti i ristoranti stranieri di Hanover Street in cerca di un anarchico che Stevens voleva vedere. Ognuno di quei luoghi era vuoto. Dappertutto pesava il silenzio. La veglia della morte. La gente si evitava, come per tener lontano un contagio. Al fondo di una stanza in un piccolo spaccio del primo piano, vide Jerry Burnham seduto solo a un tavolino con un bicchiere di whisky e una bottiglia di zenzero innanzi. Aveva il viso bianco come un tovagliolo e si dondolava lievemente nella sedia. Le fissò gli occhi addosso senza
vederla. Il cameriere gli si piegava sopra scrollandolo. Era fradicio, senza speranza. Fu un sollievo ritornare di corsa all’ufficio dove Stevens cercava ancora di mettere insieme uno sciopero generale. Le diede un’occhiata scrutante, quando lei entrò. «Fallito un’altra volta» disse Mary amaramente. Lui posò il ricevitore del telefono, si alzò, andò alla fila di ganci della sudicia parete gialla e tirò giù cappello e giacca. «Mary French, non state più dritta. Vi accompagnerò a casa.» Dovettero fare il giro di diversi isolati per evitare il cordone di polizia che sorvegliava la State House. «Mai giocato al tiro alla fune?» diceva Don. «Voi tirate con tutta la vostra forza, ma quelli dall’altra parte sono più pesanti e vi sentite trascinare verso di loro. Siete tirata innanzi più presto che voi non tiriate indietro… Non lasciatemi parlare da disfattista… Non siamo una coppia di liberali fottuti» disse e scoppiò in una secca risata. «Non li odiate voi, gli avvocati?» Erano davanti alla bassa facciata della casa in mattoni, dove Mary aveva la sua camera. «Buona notte, Don» disse. «Buona notte, Mary, cercate di dormire.» Il lunedì fu come un’altra domenica. Si svegliò tardi. Fu una morte scendere dal letto. Fu una lotta indossare gli abiti, recarsi all’ufficio e far fronte a quegli occhi sconfitti. La gente che incontrava per via pareva distogliere gli occhi quando le passava accanto. La veglia della morte. Le vie erano calme, persino il traffico pareva soffocato come se l’intera città stesse sotto il terrore di morire quella notte. La giornata passò in un monotono borbottio di parole, colonne nei giornali, chiamate al telefono. La veglia della morte. Quella sera Mary ebbe un attimo di fiera esaltazione quando lei e Don partirono per Charlestown, per unirsi al corteo di protesta. Non s’era aspettato che fossero in tanti. Folate di canto, versi sparsi dell’Internazionale scoppiavano e svanivano sulla calca delle teste tra le finestre nere delle case tenebrose. La veglia della morte. A un fianco di Mary c’era un ometto dagli occhiali che disse d’essere un insegnante di musica, all’altro una ragazza ebrea, un’iscritta alla Ladies’ Full-Fashioned Hosiery Workers. Si presero a braccetto. Don era in prima fila, un poco innanzi. Stavano attraversando il ponte. Stavano camminando
sui ciottoli di una via male illuminata sotto le travature dell’aerea. In alto rombavano treni. «Pochi isolati e siamo al carcere di Charlestown» gridò una voce. Stavolta le guardie usarono le mazze. Si sentì sull’acciottolato il fracasso degli zoccoli dei cavalli tra i sibili e i tonfi, i sibili e i tonfi delle mazze. E in distanza il tintinnio delle carrozze cellulari. Mary provò uno spavento terribile. Un grosso autocarro le stava piombando addosso. Saltò su un fianco sgombrando la strada, dietro uno dei piloni. Due guardie la tenevano. Si afferrò al pilone sporco. Una guardia le pestava la mano a colpi di mazza. Mary non sentì troppo male, era in una vettura cellulare, aveva perduto il cappello e tutti i capelli le si eran disciolti. Si colse nel punto di pensare che doveva tagliarseli alla maschietta, se in avvenire l’attendeva ancora questa vita. «Nessuno sa dov’è Don Stevens?» la voce di Don giunse un poco malferma dall’oscurità di fronte. «Siete voi, Mary?» «Come la va, Don?» «D’incanto. Un poco demolito sulle orecchie.» «Sanguina che fa spavento» disse un’altra voce d’uomo. «Compagni, cantiamo» gridò la voce di Don. E Mary dimenticò ogni cosa quando la sua voce si unì a quella di lui, a tutte le voci, le voci delle folle ricacciate di là dal ponte, cantando: In piedi o schiavi della fame… 1. American Federation of Labor. (NdT)
Cine-giornale LXVI HOLMES NEGA LA PROROGA Nasce un mondo migliore Le Piccole Vespe Importate dalla Corea. Combattono a Morte con lo Scarafaggio Asiatico UN BIMBO TRASCINATO PER UN MIGLIO DA UNA FOGNA E RICETTATO FUORI VIVO I COMIZI A CHICAGO SONO VIETATI La giustizia ha parlato ha tuonato condanna Washington Tiene d’Occhio i Radicali In piedi o calpestati PARIGI, BRUXELLES, MOSCA, GINEVRA UNISCONO LE LORO VOCI È la lotta suprema che ciascuno sia pronto Un geologo rimane sei giorni sperduto in una grotta Questo grande partito SACCO E VANZETTI MORIRANNO Coprirà tutto il mondo Ho molto pensato a te giacendo nella casa della morte – quei canti, quelle tenere voci di bimbi dai giardini dov’era tutta la vita e la gioia della libertà – a due passi dal muro che contiene come in una tomba l’agonia di tre anime sepolte. Mi ricordava tanto spesso te e tua sorella e continuamente desidero di potervi vedere, ma credo meglio che non veniate alla casa della morte per non vedere l’orribile scena di tre che vivono agonizzanti in attesa della sedia elettrica.
Occhio fotografico (50) ci hanno cacciati a bastonate dalle vie sono i più forti sono ricchi comprano e licenziano i politicanti i redattori dei giornali i vecchi giudici gli uomini minuti che hanno una reputazione i presidenti dei collegi i cagnotti (sappiatelo voi uomini d’affari presidenti giudici l’America non dimenticherà i suoi traditori) comprano gli uomini armati le uniformi le macchine della polizia le vetture cellulari va bene avete vinto voi uccidete quei coraggiosi i nostri amici stanotte non ci resta nulla da fare siamo sconfitti noi gli sconfitti ci ammucchiamo insieme in queste sporche vecchie aule scolastiche di Salem Street strisciamo le suole su e giù per i terrosi scalini scricchiolanti sediamo aggobbiti con la testa china sulle panche e ascoltiamo le antiche parole degli odiatori dell’oppressione rinnovate nel sudore e nelle angosce di stanotte la nostra opera è compiuta le frasi scarabocchiate i comunicati battuti stanotte il sentore della stamperia l’esalazione pungente dei foglietti appena stampati la corsa al telegrafo infilando parole in messaggi la ricerca di parole sferzanti per farli sentire quali sono i tuoi oppressori America l’America la nostra nazione è stata sconfitta da stranieri che hanno girato il nostro linguaggio al rovescio che hanno preso le chiare parole pronunciate dai nostri padri e le hanno ridotte viscose e sudice i loro uomini comprati siedono sul banco della Corte appoggiano la schiena coi piedi sul tavolo sotto la cupola della State House ignorano le nostre credenze hanno i dollari i fucili le forze armate gli impianti hanno costruito la sedia elettrica e comprato il boia che dia la corrente va bene siamo due nazioni l’America la nostra nazione è stata sconfitta da stranieri che hanno comprato le leggi e cintato i prati e abbattuto le foreste a farne cellulosa e ridotto le nostre belle città in bassifondi e succhiato la ricchezza del nostro popolo e quando hanno voglia comprano il boia
che dia la corrente ma lo sanno che le antiche parole degli immigrati si rinnovano stanotte nel sangue e nell’angoscia? lo sanno che l’antica parola degli odiatori dell’oppressione si rinnova stanotte sulle labbra di una vecchia di Pittsburgh di un ruvido calderaio di Frisco che saltando sui treni merci è venuto fin dalla Costa sulle labbra di un lavoratore sociale di Back Bay sulle labbra di un tipografo italiano di un vagabondo dell’Arkansas la lingua della nazione sconfitta non ci tace alle orecchie stanotte quegli uomini nella casa della morte han rinnovato le antiche parole prima di morire Se non fosse stato per questi avvenimenti, avrei vissuto la mia vita parlando sugli angoli delle strade a gente sprezzante. Sarei morto ignorato, inosservato, un buono a nulla. Quest’è la nostra carriera e il nostro trionfo. Mai più in tutta una vita noi potevamo sperare di fare un’opera simile per la tolleranza, la giustizia, la comprensione dell’uomo con l’uomo, come ora per un caso facciamo. ora l’opera loro è compiuta gli immigrati odiatori dell’oppressione giacciono tranquilli rivestiti di nero nella sala mortuaria di North End la città è tranquilla gli uomini della nazione vittoriosa non si vedono per le vie hanno vinto perché hanno paura che li vedano per le vie? per le vie si vedono solo le facce abbattute degli sconfitti le vie appartengono alla nazione sconfitta per tutta la strada che va al cimitero dove i corpi degli immigrati verranno arsi noi orliamo le banchine nella pioggia pungente noi riempiamo i marciapiedi bagnati a fianco a fianco muti pallidi fissando con gli occhi atterriti le bare noi l’America dei vinti
Cine-giornale LXVII quando le cose si capovolgono, viene sempre il caos, disse il signor Ford. Il lavoro può far meraviglie e vincere una situazione caotica. Quando le masse russe impareranno a desiderare più che non abbiano, quando desidereranno colletti bianchi, sapone, migliori abiti, migliori calzature, migliori alloggi, migliori condizioni di vita Levo il dito e dico psspss shsh susu vieni È STATA VOTATA LA FUSIONE DEGLI ACCIAI REPUBLICTRUMBULL Laggiù sulle rive dell’Amazzoni io t’ho baciato oggi il mio amore l’hai dimenticato IL GRANO GIÀ CARO SALE A PREZZI PIÙ ALTI E i sogni durano la prima cosa che i volontari pompieri fecero fu di aprire le finestre per sfogare il fumo. Ciò produsse una corrente e le fiamme con quel gagliardo vento che spirava dall’oceano fecero il resto DIVIDENDI DI PRIMATO NELLE ASSICURAZIONI MENTRE LA CONTRATTAZIONE PROGREDISCE all’esterno la scena era un vero manicomio. Eleganti signore passeggiavano innanzi e indietro torcendosi le mani, impotenti a salvare le loro cose, e intanto dalle finestre dei piani superiori pioveva un diluvio di bauli, valigie e vestiario, buttato giù a casaccio. Gioielli e ninnoli per un valore elevatissimo vennero raccolti sull’erba dagli spettatori, che si cacciavano gli oggetti sotto la giacca e dileguavano I PRESTITI DI BORSA SALGONO Basta coi cieli grigi fanne un cielo più gaio e spazza via le ragne dalla luna I MERCATI SONO OTTIMISTICI imparare nuove applicazioni del cemento. Come sviluppare una
azienda redditizia. Come giudicare il materiale. Come mettere in cifre il lavoro. Come rinforzare il cemento. Come costruire forme, strade, marciapiedi, pavimenti, fondamenta, tubazioni, cantine Dican pure in Irlanda e in Olanda che la cosa non è memoranda ma non sbagliano tanti francesi LA BANDA DALLA BANDIERA STELLATA DERUBA GENTE A TAVOLA IL DELITTO SFRENA LE FANTASIE QUACCHERE L’assassino giocatore di poker viene elogiato Oh Rosa di Hollywood piccola cara sei tanto sola nessuno in Hollywood più ti comprende né ti consola CINQUECENTO MILIONI IN UN’OPERAZIONE DI BANCA Voglio bene ai capelli d’argento che sanno i tuoi anni e alla fronte piegata che sa tanti affanni e ti bacio le dita che sono sì stanche LA SOCIETÀ CARBONIC INCAMERA LE AZIONI DELLA DRY ICE MARATONA DI CHIACCHIERE ALLA CONQUISTA DELL’ORO CORSA IN BROADWAY la vasta pubblicità data alle contrattazioni di rialzo, l’ampia diffusione dei servizi di segnalazione, l’adozione, in tutte le agenzie succursali di Borsa, dei segnalatori, nastri di quotazione trasparenti, amplificati, translucidi, hanno avuto il naturale risultato di svegliare l’interesse di tutta la nazione nell’attività borsistica
Povero bambino milionario William Randolph Hearst era figlio unico, l’unico pulcino nel ben imbottito nido di George e Phebe Hearst. Nel milleottocento e cinquanta George Hearst aveva lasciato parenti e podere nel distretto di Franklin, Missouri, e guidato un tiro di buoi in California. (Nel quarantanove l’improvvisa enorme vampa dell’oro aveva empito l’Ovest; i giovani non potevano continuare a condurre l’aratro, a versare la lavatura ai porci, a trebbiare il grano mentre le fiamme dell’oro correvano il declivio del Pacifico. Il colera li seguiva nelle carraie, morivano di colera intorno ai fuochi dei campeggi, nelle affrettate baracche pullulanti di cimici, ad uno ad uno li abbattevano gli indiani ostili, nelle risse si facevano saltare le cervella.) George Hearst fu uno dei pochi che ce la fecero; rivelò il bernoccolo del minatore; come ricercatore aveva un occhio fino per scovare un’aurifera vena di quarzo; dopo sette anni nel distretto di El Dorado era milionario, l’Anaconda cominciava, lui possedeva un sesto della miniera di Ophir, s’era ficcato negli scavi Comstock. Nel sessantuno ritornò a casa sua nel Missouri con le tasche piene di pepite e sposò Phebe Apperson e la ricondusse in piroscafo attraverso Panama e San Francisco, la nuova collinosa capitale dei minatori milionari, e le comprò una villa accanto al Golden Gate sulla grande costa nebbiosa del Pacifico. Era padrone di vaste tenute e fattorie, allevava bestiame, faceva correre cavalli, fece scavi nel Messico, impiegava cinquemila uomini nelle sue miniere e nei suoi possedimenti, perdeva e guadagnava fortune in contratti minerari, giocava a poker a un biglietto da cento per marca, non usciva mai senza una borsa di monete da distribuire a vecchi amici giù di corda, e morì a Washington senatore,
diamante grezzo, vigoroso ben voluto barbabianca d’un vecchio col gran becco e gli occhi grifagni del bruciatore di sentieri, i cigli prominenti sotto il gran cappello nero dell’altra generazione. Il bambino della signora Hearst nacque nel sessantatré. Null’era di troppo per l’unico figlio. Gli Hearst erano infatuati del loro bambino; lo sparuto spilungone crebbe solenne e caparbio in mezzo a gente di servizio e mercenari, factotum, ispettori, parassiti, vecchi pensionati; i nonni lo viziavano; faceva sempre quel che voleva. Il bambino della signora Hearst doveva aver tutto di prima qualità. Niente penuria di pepite d’oro, pezze da venti dollari, patacche d’argento. Il bambino aveva pochi compagni; era troppo ricco per mescolarsi con gli altri nella democratica baraonda dei ragazzi che in quegli anni venivano su a San Francisco. Era troppo timido e troppo arrogante; non lo soffrivano. La mamma poteva sempre affittargli compagni di gioco coi gelati, i frutti rari canditi, i costosi giocattoli, i cavallini, i fuochi artificiali sempre pronti a partire. Ma quelli che si compravano lui li disprezzava, agognò sempre quegli altri. Era un campione a far burle e pigliar per il naso gli adulti; quando inaugurarono il nuovo Palace Hotel con un ricevimento al generale Grant, lui e un suo amico si divertirono un mondo a buttare manciate di pallini da schioppo sulla volta di vetro del cortile con grande costernazione dei pezzi grossi e dei manichini sottostanti. Dovunque andavano fastosamente gli Hearst si aprivan la strada a quattrini su e giù per la costa californiana, traverso fattorie e centri minerari nel Nevada e nel Messico, nel palazzo di Porfirio Díaz; il vecchio aveva vissuto nel mondo, a spalla a spalla con ricchi e con poveri, s’era sbattuto in giro negli inferni dei minatori, s’era aperto una strada per sentieri inesistenti con una mula da soma. Per tutta la vita il bambino della signora Hearst doveva agognare quel
mondo che gli era nascosto da una nebbia di milioni; il bambino aveva una testa, degli appetiti, una imperiosa volontà; ma non poté mai allontanarsi da quelle sottane dorate; visitare i bassifondi diventò un’avventura. Venne mandato convittore nel collegio di St. Paul, a Concord, New York Hampshire. I suoi capricci misero a rumore la scuola. Lo espulsero. Si corresse e andò a Harvard dove fece flagello come direttore amministrativo del «Lampoon», un brillante foglio umoristico; non che lui bevesse molto, era anzi affabile e silenzioso; ma ubriacava gli altri giovani e pagava il conto, pagò i fuochi d’artificio per celebrare l’elezione di Cleveland, chiamò le fanfare, comperò le torte alla crema da lanciare sugli attori dal palco dell’Old Howard, i petardi per spegnere le lanterne delle carrozze pubbliche, lo champagne per le ballerine. Venne sospeso e finalmente scacciato da Harvard, così raccontano, per aver mandato a diversi professori certi orinali con sopra artisticamente inciso il ritratto del professore. Andò a New York. Era maniaco dei giornali. Già prima bazzicava intorno alle redazioni di Boston. A New York lo colpi Pulitzer col suo giornalismo nuovo conio. Non che sognasse di scrivere; voleva essere giornalista. (I giornalisti erano parte di quel tagliente mondo dei fatti che lui voleva veder chiaro, il mondo della vita reale che gli appariva deformato dalla nebbia dei milioni, il livellato basso mondo della Democrazia Americana.) Il bambino della signora Hearst sarebbe stato un giornalista e un democratico. (I giornalisti vedevano udivano mangiavano bevevano toccavano cavalcavano scherzavano si mescolavano agli uomini veri facevano i porci; quest’era vita.) Ritornò a casa in California, da giovanotto silenzioso, sorridente, solenne, abbigliato nello splendore della moda londinese.
Quando suo padre gli chiese quel che voleva fare nella vita disse che voleva dirigere l’«Examiner», un foglio moribondo di San Francisco che il padre aveva accettato a saldo di un cattivo credito. Al vecchio non sembrò un gran desiderio. Non poteva spiegarsi come mai Willie volesse quello straccio invece di una miniera o d’una fattoria, ma il bambino della signora Hearst aveva sempre partita vinta. Il giovanotto un giorno si recò all’«Examiner» e mise sottosopra la direzione. Aveva un bernoccolo per scovare e adoperare giovanotti d’ingegno, aveva un bernoccolo per adoperare la prurigine bramosa che a lui ispiravano le voglie e i rancori di quel semplice basso mondo di uomini e donne squattrinati (il visitatore dei bassifondi vede soltanto le prostitute, gli spacci di stupefacenti, i numeri di nudo, e ritorna nei suoi quartieri dicendo che conosce la classe lavoratrice); il più basso comun denominatore; concime da piantarci una carriera, la putredine della democrazia. Sopra questa putredine crebbe vivace un impero di stampa. (Forse egli si compiaceva di pensare a se stesso come a un giovane Caio Giulio che butta via i milioni, che strappa giù ogni emblema e tradizione, che fa boccacce ai privilegi togati, al monopolio, ai manichini in carica; la vita di Cesare come la sua fu uno scapriccio da milionario. Forse W.R. aveva letto di repubbliche mandate in rovina nel passato; Alcibiade, pure, era stato un campione di burle.) L’«Examiner» di San Francisco aumentò la tiratura, titillò le prurigini bramose del lettore squattrinato divenne il «Monarch of the Dailies». Quando il vecchio morì, la signora Hearst uscì dall’Anaconda per sette milioni e mezzo di dollari. W.R. ebbe da lei i quattrini per entrare sulla piazza di New York; comperò il «Morning Journal», e cominciò coi Pulitzer la gara a chi avrebbe incassato di più sull’emozione del brivido. In politica era il democratico del popolo; sostenne Bryan nel novantasei; sulla Costa combatté la Southern Pacific e i servizi
pubblici e gli avvocati della compagnia che strappavano lo Stato di California alle mani dei primi coloni; il giorno delle elezioni del novantasei i suoi tre giornali di New York uscirono in più di un milione e mezzo di copie, un primato che costrinse il «World» a discendere a due soldi. Quando non c’è notizie, bisogna fabbricarle. “Voi fornitemi le foto, io fornirò la guerra” si dice abbia telegrafato a Remington all’Avana. I pasticci di Cuba furono una miniera d’oro per la sua tiratura, quando Mark Hanna ebbe regalato la politica nazionale impiantando McKinley alla Casa Bianca. Hearst fece organizzare da uno dei suoi giovanotti d’ingegno l’evasione di Evangelina Cisneros, una bella rivoluzionaria cubana cacciata in segreta da Weyler, e le allestì un grandioso ricevimento in Madison Square. Remember the «Maine». Quando McKinley fu costretto a dichiarare la guerra alla Spagna, W.R. aveva già pronti i piani per comprare e affondare un piroscafo inglese nel canale di Suez ma la flotta spagnola non prese quella strada. Affittò la Sylvia e il Buccaneer e scese a Cuba anche lui con una stamperia portatile e una flotta di rimorchiatori e agitando un pistolone passò in lancia i frangenti e catturò sulla riva ventisei marinai spagnoli inermi, mezzo affogati, e li fece inginocchiare e baciare la bandiera americana davanti all’obiettivo. Manila Bay portò la tiratura del «Morning Journal» a un milione seicentomila. Quando gli spagnoli furon sonati, non restò più nessuno da tartassare se non i mormoni. La poligamia titillava i passeggeri dei tram, e con la poligamia la vita sessuale dei ricchi, i disegni a penna di donne in sottoveste e i mostri preistorici a quattro colori. Fu lui che scoprì la strappalacrime: Annie Laurie, Dorothy Dix, Beatrice Fairfax. Fece un effetto sensazionale coi pupazzetti, Bibì e Bibò, Buster Brown, Krazy Kat. Eccitarsi quando si eccita il pubblico; i suoi articoli di fondo martellavano i malfattori dalle grandi
sostanze, i trust, il farsi-avanti-a-tutti-i-costi, Mark Hanna e McKinley così rumorosamente che quando fu assassinato McKinley i più dei repubblicani considerarono in certo qual modo Hearst responsabile della sua morte. Hearst ribatté battezzando il «Morning Journal» l’«American» e avanzandosi alla ribalta con un abito nero da cerimonia e il cappello da mezza brenta, stoffa da presidente, il candidato milionario dell’uomo qualunque. Bryan lo fece presidente della National Association of Democratic Clubs e gli consigliò di fondare un giornale a Chicago. Dopo la seconda sconfitta di Bryan, Hearst si portò con Charles F. Murphy a New York e venne eletto al Congresso. Il suo quartiere generale fu Holland House; la notte che venne eletto diede un grandioso spettacolo gratuito di fuochi artificiali nel Madison Square Garden, e qui scoppiò un mortaio che ne uccise o ferì qualcosa come un centinaio; ecco una notizia creata dai suoi dipendenti che non comparve nella prima pagina dei suoi giornali. Nella Camera dei rappresentanti non fu popolare; ritornavano i tempi della scuola: la moscia stretta di mano, gli occhi solenni sopra il lungo naso, il vizzo sorrisetto sprezzante, erano fuori luogo tra quei picchiaschiene di Washington. Non si sentiva a suo agio senza la banda dei suoi. Era più felice quando riceveva primaioli e astri della scena a Holland House. In quei tempi che Broadway arrivava soltanto alla Quarantaduesima Strada, Millicent Wilson ballava in The Girl from Paris; lei e la sorella recitarono insieme in un atto unico; Millicent vinse una gara di popolarità nel «Morning Telegraph» e la mano di William Randolph Hearst. Nel novecento e quattro spese un sacco di quattrini scrivendo il suo nome a lampadine nella convenzione di Chicago per condurre in porto la candidatura democratica, ma il giudice Parker e Wall Street gliela soffiarono.
Nel novecento e cinque si portò sindaco di New York con un programma di diritti municipali. Nel novecento e sei quasi soffiava il governatorato al baffi-solenne Hughes. Ci furon circoli per Hearst presidente in tutto il paese. Si faceva una strada in politica spendendo milioni all’aria di Waltz Me Around Again, Willie. Riuscì a portare il suo competitore James Gordon Bennett in tribunale sotto l’accusa di aver stampato nello «Herald» avvisi indecenti e a farlo condannare a 25.000 dollari, una impresa che non giovò troppo alla sua popolarità in certi ambienti. Nel novecento e otto stampava rivelazioni sulla Standard Oil: le lettere Archbold, che dimostravano come i trust ungessero sfacciatamente la zampa dei politicanti. Era il candidato del partito indipendente composto quasi esclusivamente, così pretendevano gli avversari, di impiegati suoi. (I suoi colleghi in milioni lo giudicavano un traditore della classe, ma quando lo tacciarono di insanità mentale lui rispose: Voi sapete che io credo nella proprietà e sapete dove io stia in fatto di fortune personali, ma non è forse meglio che rappresenti io i malcontenti di questo paese invece di qualche altro che potrebbe non avere le stesse relazioni patrimoniali ch’io ho?) Nel novecento e quattordici, benché fosse il più grande proprietario di giornali in tutto il paese, il padrone di centinaia di miglia quadrate tra le fattorie e le miniere della California e del Messico, i suoi affari erano un tale caos che ebbe da sudare a trovare un milione di dollari; e politicamente, la bestia nera. Tutti i milioni che firmò, tutta la sua destrezza a ficcare le idee dentro il cranio del passeggero dei tram, non bastarono a fargli valicare il sottile Rubicone che divide la politica dilettante da quella professionista (forse gli riusciva troppo facile dimenticare un insuccesso comperando un grande scrittore o una pianella ricamata attribuita a Carlomagno o il letto dorato dove si
supponeva che avesse dormito l’amante di un re). Qualche volta era abbastanza al disopra della mischia da vederci chiaro. Buttò tutto il peso dei suoi giornali, tutto il suo prestigio di editore nello sforzo di mantenere sano e neutrale il paese durante la Prima guerra mondiale; si oppose ai prestiti per gli Alleati, secondò Bryan nella sua lotta solitaria mirante a mantenere gli interessi degli Stati Uniti come un tutto supremo sopra gli interessi delle banche Morgan e degli anglofili affaristi dell’Est; in compenso lo urlarono come germanofilo; e dichiarata la guerra, gli ficcarono poliziotti tra la servitù, agenti del servizio segreto gli rovistarono le carte private, e gli girarono calzati di gomma in sala da pranzo a Riverside Drive investigando su voci di strani lumi colorati apparsi alle sue finestre. Si oppose alla pace di Versailles e alla lega delle nazioni vittoriose e concluse dimostrando di esser altrettanto patriota che chiunque altro e sostenne la coscrizione e stampò i suoi giornali con margini bianchi rossi e azzurri e bandierine americane ai due lati dell’intestazione e non la smetteva di stuzzicare torbidi di là dal Rio Grande e di gonfiare lo spauracchio del Yankee Doodle, 1 la più grande flotta del mondo. Quelli di New York City appoggiarono Hearst eleggendo il suo candidato a sindaco, l’integerrimo John Hylan, ma Al Smith, ch’era ancora l’eroe dei marciapiedi, gli pestò le dita quando lui tentò di riarrampicarsi sul convoglio democratico. A dispetto delle enormi spese non ci fu la guerra col Messico. A dispetto di una pioggia di centinaia di migliaia di dollari in teatri di posa non gli riuscì di imporre la sua stella preferita e fidanzata di tutta l’America. E ogni giorno di più l’imperatore delle gazzette si ritirò nel suo feudo di San Simeon sulla Costa Pacifica, dove raccolse uno zoo, continuò a dilettarsi di cinematografia, mise insieme interi magazzini di tappeti, selle messicane, ninnoli, porcellane, broccati, ricami, antichi
cassettoni, tavole e sedie, tutto il bottino della morta Europa, si costruì un palazzo andaluso e una sala da banchetto moresca e là trascorse i suoi ultimi anni fra le riposanti adulazioni di stelle, scrittori pubblicitari, scrittori di scenari, organizzatori, redattori, editori milionari, monarca di quel nuovo El Dorado dove i rancidi sogni ad occhi aperti di tutti i ghetti sono sbattuti in una nube oppiacea che più sgomenta ed abbacina gli squattrinati, più frutta milioni, che non tutta la sonante abbondanza di doppie aquile coniate da Hearst padre di quel distretto di El Dorado nei giorni del passato (l’impero della carta stampata continua potente per l’inerzia della mole; ma quest’altra potenza sui sogni degli adolescenti del mondo cresce e avvelena come un cancro), e dai vapori della Costa Occidentale giunge ogni tanto la querula voce di un vecchio che rivendica l’imposta di vendita che sibila ingiurie ai difensori delle libertà civili per i lavoratori; tutti in galera i rossi, che elogia i vantaggi di Baden-Baden sotto il regime di sangue e randello del bell’Adolfo (cara e personale invenzione di Hearst, il più basso comun denominatore salito al potere dalla putredine della democrazia) che si lagna delle tasse sul reddito di California, che strepita sui pericoli del pensiero nelle università. Deportazione; galera. Finché non morirà le magnifiche presse meccaniche senza fine rotanti traboccheranno stampa per lui, le macchine di proiezione dappertutto ronzanti getteranno immagini per lui, uno sprecato Cesare invecchiato sprecando, mai uomo abbastanza da passare il Rubicone. 1. Era il titolo di una canzone britannica del Settecento, adottata
dalle truppe americane nella guerra di Liberazione. È riportata anche in uno dei cine-giornale di questo libro. (NdT)
Richard Ellsworth Savage Dick Savage camminava per Lexington Avenue alla volta dell’ufficio in Graybar Building. La mattinata di dicembre era tagliente come l’acciaio, sfolgorii luminosi gli battevano gli occhi, frantumandosi sulle vetrine, sugli occhiali della gente che incontrava per strada, sugli orli cromati dei fari delle macchine. Non era ben certo se dalla sera prima gli era restato il mal di capo. Nella vetrina di un gioielliere si scorse il volto contro l’appoggio di velluto nero: sotto gli occhi c’era qualcosa di enfiato e sbattuto. Si sentiva brusco e marcito nel mezzo come una pera guasta. Entrò in uno spaccio e ordinò un bromo-seltzer. Presso il sifone si fermò a guardarsi nello specchio dietro le scansie di vetro piene di bottiglie di zenzero; il suo nuovo abito di panno turchino scuro gli stava, a buon conto, assai bene. Gli occhi neri dell’inserviente cercavano d’incontrare i suoi: «Serata pesante, eh?». Dick annuì e sorrise. L’inserviente si passò una mano smagrita e rossonocchiuta sui capelli di cuoio verniciato. «Io non ho potuto esser libero che all’una e mezzo e di qui a casa con la sotterranea ci metto un’ora. Non c’è pericolo che possa…» «Sono in ritardo, stamattina» disse Dick e pagò e se n’uscì, ruttando leggermente, nella scintillante via mattutina. Camminava svelto, traendo profondi respiri. Quando fu salito nell’ascensore con un gruppo di individui sulla quarantina atticciati e ben vestiti, dirigenti com’era lui che giungevano tardi all’ufficio, sentiva ormai un acuto mal di testa. Aveva appena allungate le gambe sotto la scrivania, quando scattò il telefono interno. Era la voce della signorina Williams: «Buon giorno, signor Savage. Eravamo in attesa di voi… Il signor Moorehouse dice per favore di passare nel suo ufficio, vuole parlarvi un momento prima della seduta generale». Dick si alzò e rimase un attimo con le labbra increspate dondolandosi sulla punta dei piedi, spaziando gli occhi fuori della finestra sugli isolati cinerognoli che si stendevano in una serie di stampi di ghisa verso l’Est, verso i camini degli impianti per l’elettricità e il ponte e la striscia di fiume rilampeggiante acciaio all’azzurro acciaio del cielo. I martellatori stridulamente strepitavano
dal nuovo enorme edificio che saliva, una travatura dopo l’altra, all’angolo della Quarantaduesima. Tutti insieme gli facevano dentro la testa come il trapano di un dentista. Ebbe un brivido, ruttò e attraversò rapido il corridoio verso il grande ufficio d’angolo. J.W. 1 fissava il soffitto e la sua gran faccia mascelluta era altrettanto inespressiva che quella d’una mucca. Fissò gli occhi pallidi su Dick senza un sorriso. «Vi rendete conto che ci sono settantacinque milioni di persone in questo paese che non vogliono o non possono ricorrere al dottore quando son malate?» Dick contorse il viso a darsi un’aria del più vivo interesse. Ha parlato con Ed Griscolm, disse fra sé. «E sono le persone cui debbono venire incontro i prodotti Bingham. Sinora non ha toccato che gli orli di questo immenso mercato possibile.» «Il suo interesse sarebbe di convincere la gente che si può essere più furbi dei cani grossi che vanno a Battle Creek» disse Dick. J.W. s’aggrottò sopra pensiero. Era entrato Ed Griscolm. Era un tipo lungo e giallo con una vampa d’entusiasmo negli occhi che spariva e si riaccendeva come insegna luminosa. Aveva un modo di tenere le braccia, che pareva un capobanda sul punto di dare il via a un’acclamazione studentesca. Dick disse: «Salute» senza calore. «Che mattinata, Dick… un po’ rimminchionito, eh?… Male, ragazzo mio, male.» «Stavo appunto dicendo, Ed,» continuò J.W. nella sua voce lenta e uguale «che i nostri punti di discussione dovevano vertere, primo, sul fatto che questo possibile mercato di settantacinque milioni non l’hanno nemmeno sfiorato, e, secondo, che una campagna condotta come si deve può sradicare quel pregiudizio che tanti conservano contro gli specifici e sostituirvi un senso di fierezza in chi ne faccia uso.» «Fatevi furbi e risparmiate i soldi… frasi del genere» esclamò Ed. «Fare da sé» disse Dick. «Spiegargli che il commesso medio di farmacia ne sa oggi di più in fatto di medicina che non il dottore di famiglia venticinque anni fa.» «Credono che ci sia qualcosa di provinciale nelle specialità» strillò Ed Griscolm. «Dobbiamo far entrare le specialità in Park Avenue.» «Gli specifici» disse J.W. con tono di rimprovero.
Dick riuscì a cancellarsi di faccia il sorriso. «Dobbiamo sezionare quest’idea» disse «in tutte le componenti.» «Esatto.» J.W. prese un tagliacarte di avorio scolpito e lo osservò sollevandoselo a diversi angoli davanti al viso. C’era nell’ufficio un tale silenzio che potevano sentire il muggito del traffico fuori e il sibilo del vento fra l’intelaiatura d’acciaio e la finestra d’acciaio. Dick e Ed Griscolm tennero il fiato. J.W. cominciò a parlare. «Il pubblico americano s’è fatto complicato… quand’ero ragazzo a Pittsburgh non pensavamo ad altro che alla pubblicità visiva, il richiamo dell’occhio. Ora, essendo aumentata la complicazione, dobbiamo pensare agli altri tipi di richiamo, e sradicare i pregiudizi… Bingo… questo nome è sorpassato, è un errore. Uno si vergognerebbe di pranzare al Metropolitan Club con una bottiglia di Bingo in tavola… questo dev’essere il punto di discussione… Ieri il signor Bingham pareva disposto ad andare avanti. Esitava un poco per il costo della campagna…» «Niente paura,» squittì Ed Griscolm «lo accalappieremo di certo quel vecchio baggiano.» «Penso che ci voglia con lui molto tatto, come appunto dicevate ieri sera, J.W.» disse Dick con voce blanda e sommessa. «Mi han raccontato che Halsey dell’Halsey O’Connor è finito a letto con l’esaurimento per aver cercato di far prendere una decisione a Bingham.» Ed Griscolm scoppiò in una sussultante risata. J.W. si alzò in piedi con un lieve sorriso. Quando J.W. sorrideva, sorrideva pure Dick. «Credo che si possa portarlo ad apprezzare i vantaggi connessi col nome… la dignità… le aderenze stabilite…» Senza smetter di parlare, J.W. aprì strada giù per il corridoio alla volta di una grande sala, con un lungo tavolo ovale di mogano nel mezzo, dove tutto l’ufficio era riunito. J.W. veniva per primo con la sua notevole pancetta sussultante da una parte e dall’altra mentre camminava, e Dick e Ed Griscolm, ciascuno con una bracciata di progetti dattiloscritti in buste azzurro pallido, venivano a un passo di distanza. Sul punto che stavano mettendosi a sedere dopo un certo numero di colpi di tosse e soffiate di naso e J.W. cominciava col fatto che c’erano settantacinque milioni di gente, Ed Griscolm scappò via e
ritornò di corsa con una carta ben disegnata, scritta in turchino rosso e giallo, mostrante il piano della proposta campagna. Un mormorio d’ammirazione corse intorno al tavolo. Dick colse un’occhiata trionfale a lui rivolta da Ed Griscolm. Guardò verso J.W. con la coda dell’occhio. J.W. stava guardando la carta con un viso inespressivo. Dick andò alla volta di Ed Griscolm e gli batté sulla spalla. «Un bel lavoro, vecchio Ed» bisbigliò. Le labbra contratte di Ed Griscolm si rilassarono in un sorriso. «Dunque, signori, quel che vorrei sentire ora è una vivace discussione» disse J.W. con un lampo maligno nell’occhio pallido che s’appaiò per un attimo al lampo dei piccoli diamanti nei suoi bottoni dei polsini. Mentre gli altri parlavano, Dick seduto fissava le mani di J.W. allargate sul fascio dei dattiloscritti sopra il tavolo, in faccia a lui. Polsini all’antica inamidati sporgevano dalle maniche della giacchetta grigia a doppio petto tagliata alla perfezione e da essi uscivano due mani carnose, stranamente campagnole, chiazzate di rosso epatico. Per tutto il tempo che durò la discussione Dick fissò quelle mani, per tutto quel tempo buttando giù frasi sul taccuino e cancellandole. Non riusciva a pensare a nulla. Il cervello gli pareva infracidito. Continuava a cancellare con la matita quelle frasi, prive di senso. Non fu prima dell’una che si sciolse la seduta. Tutti andavano congratulandosi con Ed Griscolm per quel piano. Dick sentì la propria voce dire ch’era magnifico, ma bisognava dargli un senso leggermente diverso. «Benissimo» disse J.W. «Che ne direste di elaborare nella giornata di domenica questo senso leggermente diverso? Quest’è l’idea che voglio lasciare in ciascuno di voi, quanti siete qui. Lunedì a mezzogiorno sono a pranzo col signor Bingham. Debbo avere un progetto finito da sottoporgli.» Dick Savage ritornò all’ufficio e firmò un mucchio di lettere che la segretaria gli aveva lasciato. Poi d’un tratto ricordò che aveva detto a Reggie Talbot che sarebbe andato con lui a pranzo al 63, per far la conoscenza della sua ragazza, e si precipitò fuori, aggiustandosi la sciarpa mentre scendeva nell’ascensore. Li scorse tutti e due a un tavolino, le teste appoggiate, nelle spire del fumo, in fondo allo spaccio accalcato dalla folla del sabato. «Oh Dick, ciao» disse Reggie,
balzando in piedi col suo sorriso mansueto, afferrando la mano di Dick e tirandolo alla volta del tavolino. «Non vi ho aspettato all’ufficio, perché dovevo incontrare costei… Jo, ecco il signor Savage. L’unica persona di New York che veramente se ne infischi… Che cosa bevete?» La ragazza era davvero un capolavoro. Dick, quando si fu lasciato cadere sul sofà di cuoio rosso, accanto a lei, in faccia alla sottile testa biondocenere di Reggie e a quei grossi occhi indagatori brunochiari, si sentì fradicio di liquore e spossato. «Oh, signor Savage, che cosa è stato di quell’affare Bingham? Ci faccio il tifo. Reggie non parla d’altro. So che è da indiscreti chiedere.» La ragazza lo fissava intenta in faccia con gli occhi neri dalle lunghe ciglia. Facevano davvero una bella coppia. «Si raccontano i fatti di scuola, eh?» disse Dick, dando di piglio a un grissino e spezzandoselo in bocca. «Ma vedete, Dick, Jo ed io… noi ci diciamo tutto… e non esce mai di fra noi… Ma sul serio tutti gli impiegati più giovani dicono che è una vergogna che J.W. non abbia scelto il vostro piano… Griscolm finirà di rovinarci l’affare, se non sta più attento… non va, ecco… credo proprio che al padrone cominci a rammollirsi il cervello.» «Sapete, ho pensato diverse volte in questi tempi che J.W. non fosse più in perfetta salute… Peccato. È la figura più eminente in tutto il campo dei pubblici rapporti.» Dick udì nella sua voce una nota untuosa e se ne vergognò davanti a quella gioventù; tacque di botto. «Ehi, Tony» gridò stizzito al cameriere. «Vogliamo fare questi cocktail? Portami un Bacardi con una goccia d’absinthe, sai bene, il mio solito… Santo Dio, mi sento addosso più di cent’anni.» «La candela si consuma dalle due parti, eh?» domandò Reggie. Dick contorse la faccia in una smorfia. «Oh, questa candela» disse. «Me ne dà dei dispiaceri.» Arrossirono tutti. Dick ridacchiò. «Dio del Cielo, non credo che restino in questa città altre tre persone che sappiano ancora arrossire.» Ordinarono altri cocktail. Mentre bevevano, Dick si sentì gli occhi scuri e gravi della ragazza fissi in faccia. E brandiva il bicchiere verso di lui. «Reggie dice che siete stato così buono con lui all’ufficio… Dice che sarebbe già licenziato, non fosse stato per voi.» «Chi può fare a meno di esser buono con Reggie?
Guardatelo.» Reggie diventò rosso come un pomodoro. «Ha certo presenza, la canaglia» disse la ragazza. «Ma ha poi cervello?» Al ristretto di cipolle e al terzo cocktail Dick cominciò a sentirsi meglio. Cominciò a raccontar loro che li invidiava perché erano ragazzi e si sposavano. Promise loro che avrebbe fatto da testimone. Quando gli domandarono perché non si sposava anche lui, ordinò confusamente da bere e spiegò che la sua vita era un caos. Guadagnava quindicimila all’anno, ma non aveva mai un soldo. Conosceva una dozzina di belle donne, ma al bisogno non trovava mai una ragazza. Durante tutto questo discorso, continuò in fondo al cranio a progettare uno sproloquio sulla necessità di esser liberi e curarsi da sé. Non gli era possibile smettere di pensare a quel maledetto affare Bingham. Cominciava a imbrunire, quando uscirono dal 63. Lo punse un senso d’invidia, mentre faceva salire i due giovani in un tassì. Si sentiva affezionato, amoroso, deliziosamente cullato dall’irraggiante tepore del cibo e dell’alcool che aveva nel ventre. Si fermò un istante all’angolo di Madison Avenue osservando la vivace folla prenatalizia traboccare per il marciapiede contro le luminose vetrine, ogni sorta di visi avvampati e sani, una volta tanto, nel pungente freddo serale fra gli obliqui riflessi. Poi si fece portare in tassì nella Dodicesima Strada. La cameriera negra, che gli venne ad aprire, portava un bel grembialino di pizzo. «Ciao, Cynthia.» «Come state, signor Dick?» Dick si sentiva il sangue pulsare impaziente alle tempie, camminando innanzi e indietro in attesa, sul vecchio palchetto ineguale. Eveline sorrideva quando sbucò dalla camera interna. Si era cacciata in faccia troppa cipria per la fretta eccessiva, e questa le faceva risaltare le rughe stiracchiate fra le narici e la bocca, e le dava un’aria farinosa al naso. La sua voce aveva ancor sempre una vibrazione struggente. «Dick, credevo mi aveste piantata.» «Ho dovuto lavorare come una bestia… Mi son ridotto al punto che il cervello non funziona più. Ho pensato che poteva farmi bene, vedervi una volta.» Eveline gli porse una scatoletta cinese di porcellana piena di sigarette. Sedettero a fianco a fianco su un vacillante divano all’antica. «E Jeremy?» domandò Dick con un tono
allegro. La voce di lei cadde. «È andato nell’Ovest con Paul, per Natale.» «Ne sentirete la mancanza… Sono un po’ deluso, anch’io. Voglio bene al marmocchio.» «Paul ed io abbiamo finalmente deciso di divorziare… all’amichevole.» «Eveline, mi dispiace assai.» «Perché?» «Non so… Sembrerà una sciocchezza… Ma Paul mi è sempre stato simpatico.» «Era diventato un fastidio continuo… Così sarà assai meglio, per lui.» C’era in Eveline qualcosa di pacatamente amaro, mentre gli sedeva là accanto nel suo abito da pomeriggio, un po’ troppo arricciolato. A Dick dava l’impressione di trovarsi con lei per la prima volta. Ne raccolse la lunga mano azzurrovenata, la depose sul tavolino davanti e vi batté sopra con la sua. «Comunque… mi piacete di più.» Gli suonò falso all’orecchio, come una frase che rivolgesse a un cliente. Saltò in piedi. «Sentite, Eveline, io do una telefonata a Settee che ci porti un poco di gin. Mi ci vuole assolutamente un sorso… Non riesco a levarmi di testa l’ufficio.» «Se andate fino in ghiacciaia, troverete dei cocktail squisiti, preparati a tutto punto. Li ho fatti solo ora. Verrà gente, un po’ più tardi.» «Più tardi quando?» «Verso le sette… perché?» Gli occhi di lei lo seguirono provocanti mentre usciva per la porta a vetri. Nella dispensa la ragazza negra si stava infilando il cappellino. «Cynthia, la signora Johnson sostiene che qui ci sono dei cocktail preparati.» «Certamente, signor Dick, vi do subito i bicchierini.» «Avete uscita oggi?» «Sì, vado in chiesa.» «Al sabato pomeriggio?» «Sì, nella nostra chiesa abbiamo le funzioni il sabato pomeriggio… molti al giorno d’oggi non hanno più la domenica libera.» «Sono arrivato a un punto che non ho più libera né questa né altro, io.» «È una gran brutta cosa, signor Dick.» Ritornò nella stanza d’entrata reggendo sussultante il vassoio con lo shaker che vi saltellava sopra. I due bicchieri tinnivano. «Oh, Dick,
dovrò farvi cambiar vita. Vi tremano le mani come quelle di un vecchio barbabianca.» «Ma lo sono un vecchio barbabianca. Mi sto mangiando l’anima a pensare se quel malandrino d’un re degli specifici metterà lunedì il nome in calce.» «Non parlatene… Solo a sentire, è spaventoso. Anch’io ho lavorato moltissimo. Cerco di mettere in scena un lavoro.» «Eveline, ma questa è una gran notizia. Di chi è?» «Charles Edward Holden… È un capolavoro meraviglioso. Mi tiene tutta eccitata. Credo che me la saprò cavare… Immagino che non ve la sentiate di entrarci con un paio di biglietti da mille, Dick.» «Eveline, sono in bolletta… Sono arrivati a bloccarmi lo stipendio; mamma la debbo mantenere in quel tono a cui è avvezza e poi c’è la fattoria del fratello Henry in Arizona… è impegolato in un’ipoteca… Credevo Charles Edward Holden fosse soltanto un giornalista.» «Quest’è un lato di sé che non aveva mai rivelato… Credo sia il vero poeta della moderna New York… aspettate e vedrete.» Dick si versò un altro cocktail. «Parliamo invece solo di noi, per un minuto… Mi sento così sfasato… Oh, Eveline, sapete quel che voglio dire… Una volta eravamo ottimi amici.» Eveline lasciò che le prendesse la mano, ma non gli rese la stretta che lui v’impresse. «Ricordate che dicevamo sempre che tra noi due c’era un’attrazione fisica… e non è la più bella cosa del mondo questa?» Dick si spostò lateralmente fino a toccarla, sul divano, le diede un bacetto sulla guancia, cercò di farle torcere il viso. «Non vuoi proprio neanche un briciolo di bene a questo povero peccatore?» «Dick, non posso.» Si levò in piedi. Le si contrassero le labbra e parve sul punto di scoppiare in lacrime. «C’è qualcuno al quale voglio molto… molto bene. Ho deciso di dare un senso alla mia vita, finalmente.» «Chi è? Quel maledetto giornalista?» «Non importa chi sia.» Dick si nascose il viso tra le mani. Quando abbassò le mani, rideva. «Mondo cane, se non è questo il mio destino… Il posto preso e io pieno di bacchica tenerezza domenicale.» «Via, Dick, sono certa che non vi mancano le pretendenti.»
«Mancano proprio… Sono solo e disperato. La mia vita è un caos.» «Ma è una frase letteraria.» «Pensavo anch’io che lo fosse ma, sul serio, sono in uno stato ineffabile… Ieri sera mi è capitata curiosa. Ve ne parlerò un’altra volta, quando vi sarò meno antipatico.» «Dick, perché non andate da Eleanor? 2 Darà un ricevimento ai suoi boiari.» «Ma è proprio vero dunque che sposa quell’insopportabile principonzolo?» Eveline annuì con quella stessa ombra gelida e amara negli occhi. «Probabilmente un titolo è il non plus ultra in fatto di decorazione artistica… Perché non entra Eleanor con qualche soldo?» «Non me la sento di chiederglieli. Di soldi ne è insozzata però, ha avuto un autunno fortunato. Credo che tutti diventino tirchi con l’andar degli anni… E che ne pensa del principe il povero Moorehouse?» «Vorrei sapere quel che pensa di qualsiasi altra cosa. Sono anni ormai che lavoro per lui e non ho ancora capito se sia un genio o un pagliaccio… Mi domando se ci sarà, da Eleanor. Ho bisogno di vederlo un momento stasera… Ma che buon’idea… Voi, Eveline, mi fate sempre del bene in un modo o nell’altro.» «Sarà meglio che telefoniate prima… È capacissima di non farvi entrare se arrivate senz’essere invitato; specialmente con quella caterva di emigrati russi in tiara.» Dick andò al telefono e fece il numero. Dovette aspettare a lungo prima che giungesse Eleanor. La sua voce suonò stridula e acuta. Dapprima disse perché non veniva invece a cena un’altra settimana. La voce di Dick si fece suadente. «Via, lasciatelo vedere anche a me il famoso principe, Eleanor… E poi ho da parlarvi di una cosa molto importante… Dopo tutto voi siete sempre stata il mio angelo custode, Eleanor. Se non mi è permesso di venire da voi, quando sono nei guai, da chi debbo andare?» Alla fine, Eleanor cedette e disse che poteva venire, però fermarsi poco. «Potrete parlare col povero J. Ward… ha l’aria un po’ derelitta.» E la voce finì in una risata stridente che fece vibrare il ricevitore e gli urtò l’orecchio. Quando fu di ritorno al divano, Eveline s’era buttata indietro sui
cuscini e rideva, rideva silenziosamente. «Dick,» disse «siete un infinocchiatore nato.» Dick le fece una smorfia, la baciò sulla fronte e lasciò la casa. L’appartamento di Eleanor scintillava tutto di lampadari e vetri incisi. Quando Eleanor gli venne incontro sull’uscio del salotto, il suo visetto appariva liscio e fragile come un vaso di porcellana sotto i capelli arricciati con cura e sopra un grosso spillone di strass che le chiudeva un colletto di pizzo. Alle sue spalle usciva il basso profondo e il falsetto acuto degli uomini e delle donne russe in conversazione, e un sentore di tè e di carbonella. «Bene, Richard, eccovi qua» gli disse in un rapido bisbiglio sibilante. «Non dimenticate di baciare la mano alla granduchessa… ha avuto delle prove così tremende. Sarete buono e farete queste piccole cose che la confortano, vero?… Ora, Richard, mi preoccupa Ward… Ha un’aria così stanca… Spero che non sia un principio di esaurimento. È il tipo, sapete, da spezzarsi a questo modo… Li conosciamo bene, questi grossi biondi dal collo basso.» C’era un alto samovar d’argento sul tavolino Buhl davanti al camino di marmo e accanto sedeva una voluminosa donna piuttosto vecchia in un vistoso scialle, coi capelli fatti su alla Pompadour e sfaldature di cipria su uno stanco viso pustoloso. Era molto aggraziata e le lustravan persino gli occhi; stava ammonticellando caviale su una fetta di pane nero, prendendolo da una scodella di cristallo inciso, e rideva a bocca piena. Intorno le stavano aggruppati russi in tutti gli stadi dell’età e dello sfacelo, quale in tunica, quale in abito comune da lavoro; quali ragazze dall’aspetto rancido, e un paio eran giovanotti dai capelli lucidi e dal viso da ragazzi cantori. Tutti bevevano il tè o bicchierotti di vodka. Tutti menavano cucchiaiate nel caviale. Dick venne presentato al principe, ch’era un giovanotto olivastro dalle ciglia nere e baffetti neri a punta, indossava una tunica nera e stivali neri di morbido cuoio e aveva una vita straordinariamente sottile. Tutti erano gai come fringuelli e cinguettavano e muggivano in russo, in francese e in inglese. Stavolta Eleanor si butta via Dick si colse a pensare, mentre scavava nel grosso ammasso del caviale grigiastro. J.W. con un’aria pallida e stremata era in piedi in un angolo e volgeva la schiena a un’icona davanti a cui bruciavano tre candele.
Dick rammentò distintamente di aver veduto qualche settimana prima l’icona nella vetrina di Eleanor sopra un fondo di broccato purpureo. J.W. stava parlando con un ecclesiastico in sottana nera dalle guarnizioni purpuree, il quale, quando Dick s’avvicinò, si sentì che aveva un accentaccio irlandese. «Vi presento l’archimandrita O’Donnell, Dick» disse J.W. «Ho capito bene?» L’archimandrita sogghignò e annuì. «Mi stava parlando dei monasteri della Grecia.» «Volete dir quelli dove vi issano su in un cestino?» disse Dick. L’archimandrita dimenò quella faccia ghignante, flosciolabbruta. «Avrò io stesso l’onore e il piacere di iniziare la nostra cara Eleanor ai misteri della vera fede. Stavo raccontando al signor Moorehouse la storia della mia conversione.» Dick si trovò squadrato da un impudente occhio roteante. «Può darsi che v’interessi qualche giorno, signor Savage, venire a sentire il nostro coro. L’incredulità si dissolve nella musica come un pezzo di zucchero in un bicchiere di tè caldo.» «Sì, gusto assai il coro russo» disse J.W. «Non credete anche voi che la nostra cara Eleanor vi attinga serenità e gioventù?» L’archimandrita guardava raggiante la folla del salotto. J.W. annuì dubitoso. «Oh, una cara adorabile creatura è, pronta d’ingegno… Forse, signor Moorehouse e voi, signor Savage, vorrete accettare di venire alla funzione e poi a pranzo con me… Ho qualche idea intorno a un libretto sulle mie esperienze del Monte Athos… Potrebbe uscirne una festicciola simpatica.» Dick fu stupefatto di sentirsi menare un pizzicotto nel sedere dall’archimandrita e prontamente si scostò d’un passo, ma non prima di aver colto nell’occhio sinistro dell’altro un cauto e vigoroso ammicco. La sala era tutta piena di tintinnii e brindisi, e di tanto in tanto il fracasso di un vetro rotto. Un gruppetto di russi più giovani cantavano con profonde voci muggenti che facevano vibrar loro sul capo il lampadario di cristallo. Il caviale era partito tutto, ma due cameriere in uniforme stavano introducendo un tavolino imbandito con hors d’œuvre contornanti un gran salmone bollito. J.W. toccò del gomito Dick. «Penso che possiamo andarcene altrove, dove sia possibile parlare.» «Stavo appunto aspettando voi,
J.W. Credo di avere trovato quel senso nuovo. Stavolta andrà, ne son certo.» Erano appena usciti, aprendosi la via tra la folla, a raggiungere la porta, quando una giovane russa in nero dai begli occhi neri e dalle sopracciglia arcuate li raggiunse di corsa. «Oh, non dovete andar via. Piacete assai a Leocadia Pavlovna. A lei piace molto qui, si sta alla buona… una bohème. Questo è quanto ci piace in Leonora Ivanovna. Anche lei è bohème. L’amiamo.» «Temo che dovremo andarcene per un appuntamento d’affari» disse solenne J.W. La giovane russa schioccò le dita con un: «Come son disgustosi gli affari… Sarebbe così carina l’America senza gli affari». Quando uscirono in strada, J.W. cacciò un sospiro. «Povera Eleanor, temo si sia messa in qualche pasticcio… Quei russi le mangeranno anche le pietre della casa. Credete che voglia davvero sposare questo principe Mingraziali? Ho preso informazioni sul suo conto… È tutto quel che dice d’essere. Ma santo Cielo!» «Corone e tutto,» aggiunse Dick «la data è fissata.» «Dopo tutto, Eleanor sa quel che fa. Ha avuto grandi successi, sapete.» La macchina di J.W. era alla porta. L’autista scese con una coperta sul braccio e stava per chiudere lo sportello alle spalle di J.W. quando Dick fece: «J.W., non avete qualche minuto per discorrere di quell’affare Bingham?». «E come no? Stavo dimenticandomi» disse J.W. con una voce stanca. «Venite a cenar fuori con me a Great Neck… Laggiù sono solo, non fosse per i bambini.» Con un sorriso Dick saltò all’interno e l’autista gli chiuse dietro lo sportello della grande berlina nera. Fu una cosa piuttosto lugubre mangiare nel salone di casa Moorehouse, fra i pannelli italiani dipinti, col maggiordomo e l’aiutante che giravano senza far rumore nella luce scura, e soltanto Dick, J.W. e la signorina Simpson, la governante visolungo dei bambini, tanto distinta, sedevano al lungo tavolo illuminato da candele. Poi, quando passarono nel piccolo antro candido a fumare e parlare dell’affare Bingham, Dick ringraziò la sua stella vedendo comparire il vecchio maggiordomo con una bottiglia di scotch, ghiaccio e bicchieri. «Dove l’avete scovata, Thompson?» domandò
J.W. «Era in cantina da prima della guerra, signore… quelle cassette che la signora Moorehouse comperò in Scozia… Sapevo che al signor Savage non dispiace un goccetto.» Dick si mise a ridere. «Ecco i vantaggi di una cattiva reputazione» disse. J.W. pronunziò con voce solenne: «È il migliore che si trovi, quest’è certo… Credereste che a me il bere non ha mai detto molto, e così l’ho smesso, ancor prima del proibizionismo?». J.W. aveva acceso un sigaro. D’un tratto lo gettò nel fuoco. «Non credo che fumerò stasera. Il dottore dice che tre sigari al giorno non mi possono far male… ma è tutta la settimana che non mi sento a posto… Dovrei smettere la Borsa, ecco… Spero che voi, Dick, non ci mettiate piede.» «I miei creditori non mi lasciano nemmeno tanto da comprarmi un biglietto della lotteria.» J.W. fece due o tre passi attraverso la stanzetta foderata di tutti gli scrittori più in vista, in raccolte di marrocchino che non mostravano un graffio, e poi si arrestò volgendo le spalle al caminetto fiorentino, con le mani dietro la schiena. «Ho sempre il gelo nelle ossa. Non credo di aver troppo in ordine la circolazione… Forse è stata la mia visita a Gertrude… I dottori hanno ammesso stavolta che il suo caso è disperato. È stato un grande colpo per me.» Dick si alzò e posò il bicchiere. «Mi dispiace assai, J.W. … Però si sono viste delle cure sorprendenti nelle malattie del cervello.» J.W. stava dritto, le labbra tese in una linea sottile, la grossa mascella tremolante. «Non per la schizofrenia… Ho avuto il mio successo in ogni cosa, tranne in questo… Sono un uomo solitario» disse. «E pensare che una volta m’immaginavo di riuscire un compositore di canzonette.» Sorrise. Sorrise anche Dick e tese la mano. «Qua la mano, J.W.,» disse «salutate i resti di un altro poetino.» «Comunque» disse J.W. «avranno i bambini i vantaggi che non ebbi io… Vi seccherebbe assai, prima di venire agli affari, se salissimo a dar loro la buona notte? Sarei lieto che li vedeste.» «Ma niente affatto, mi piacciono i bambini» disse Dick. «Anzi, a dir la verità nemmeno io son troppo riuscito a crescere.»
In cima alle scale la signorina Simpson venne loro incontro col dito alle labbra. «La piccola Gertrude dorme.» Sfilarono in punta di piedi nel corridoio tutto bianco. I bambini erano a letto, ciascuno in una cameretta tipo ospedale, gelida per la finestra spalancata; su ogni guanciale, una testa di pallidi capelli paglierini. «Staple è il più alto… dodici anni» bisbigliò J.W. «Poi viene Gertrude, poi Johnny.» Staple disse buona notte garbatamente. Gertrude non si destò quando accesero la luce. Johnny sedette nell’incubo, i lucenti occhi azzurri sbarrati, gridando: «No, no» con l’esile vocina atterrita. J.W. sedette sulla sponda del letto, coccolandolo un momento, finché non lo riaddormentò. «Buona notte, signorina Simpson» e ridiscesero in punta di piedi le scale. «Che cosa ve ne pare?» J.W. si volse raggiante a Dick. «Sono davvero uno spettacolo consolante… Vi invidio» disse Dick. «Sono lieto che siate qua con me… Mi sarei sentito assai solo senza di voi… Bisogna che riceva di più» disse J.W. Si riassettarono nelle poltrone accanto al fuoco e presero a riesaminare il piano da presentarsi alla Bingham Products. Quando suonarono le dieci, J.W. cominciò a sbadigliare. Dick sorse in piedi. «J.W., volete la mia sincera opinione?» «Caro mio, dite, sapete bene che a me voi potete dire tutto ciò che vi piace.» «Ebbene, ecco qua.» Dick tracannò il fondo tiepido e debole del suo scotch. «Credo che non riusciamo più a vedere la foresta per via dei tronchi… siamo impegolati in un groviglio di particolari minimi. Voi dite che il vecchio è un testone… uno di quei caratteri da strillone a presidente… Ebbene, io non credo che questa roba dia abbastanza risalto alla campagna che ci avete abbozzato un mese fa.» «Non ne sono troppo soddisfatto, a dir la verità.» «C’è una macchina da scrivere in questa casa?» «Credo che Thompson o Morton ne troveranno qualcuna da qualche parte.» «Ecco, spero di riuscire a mettere un po’ più in luce la vostra idea fondamentale. Secondo me, è una delle idee più grandiose mai esibite nel mondo degli affari.»
«Naturalmente è opera di tutto l’ufficio.» «Lasciatemi provare a smontarla a pezzi e rimetterla di nuovo insieme entro oggi e domani. Dopo tutto, non ci perdiamo nulla… O leviamo di netto quel vecchio fuori del pantano o se ne impadronisce Halsey.» «Gli stanno intorno senza lasciarlo un istante, come una muta di lupi» disse J.W. levandosi sbadigliante. «Ebbene, lascio la cosa nelle vostre mani.» Quando giunse alla porta, J.W. si fermò e volse. «Certo questi aristocratici russi sono socialmente parlando quanto c’è di meglio. In questo senso è un grande vantaggio per Eleanor… Ma vorrei che non ne facesse nulla… Voi lo sapete, Dick, Eleanor ed io abbiamo avuto un’amicizia molto bella… Il consiglio e la simpatia di questa piccola donna hanno contato assai nella mia vita… Vorrei che non ne facesse nulla… Allora, vado a letto.» Dick salì nella grande camera da letto, dov’erano appese stampe inglesi da caccia. Thompson gli portò una macchina da scrivere nuova e silenziosa e la bottiglia del whisky. Dick sedette tutta la notte a lavorare, in pigiama e accappatoio, fumando e bevendo il whisky. Ci dava ancor dentro quando le finestre cominciarono a inazzurrarsi nel giorno e Dick cominciò a discernere fra le pesanti cortine neri ammassi, a ricamo, di alberi nevicosi, aggruppati intorno a un praticello fradicio. Si sentiva la bocca inacidita dalle troppe sigarette. Entrò nella stanza da bagno, affrescata di delfini, e cominciò a fischiettare mentre apriva l’acqua calda nella vasca. Si sentiva stordito e gli occhi impastati, ma un nuovo piano l’aveva. L’indomani a mezzodì, quando J.W. ritornò dalla chiesa coi bambini, Dick era vestito, rasato, e passeggiava sul lastrico del terrazzo nell’aria cruda. Aveva gli occhi come vuoti e la testa che trafiggeva, ma J.W. rimase incantato del suo lavoro. «Naturalmente far da sé, indipendenza e individualismo è quanto avevo detto a quei ragazzi al ben principio. Questa promette di riuscire una campagna di americanismo… Dopo la colazione manderò la macchina a prendere la signorina Williams, che ci trascriva un po’ di dettatura. C’è più sostanza in questo, che non pensiamo, Dick.» «È un fatto» disse Dick, arrossendo. «Quanto a me non ho avuto che da ricostruire la vostra
concezione originaria, J.W.» A colazione i bambini vennero seduti a tavola e Dick si divertì con loro un mondo, facendoli discorrere e raccontando storie sui coniglietti che allevava lui quand’era piccolo nel Jersey. J.W. era raggiante. Dopo il pasto, Dick giocò a ping-pong nella sala da biliardo del pianterreno con la signorina Simpson, Staple e la piccola Gertrude, mentre Johnny raccoglieva loro le palle. J.W. si ritirò nel suo antro a schiacciare un sonnellino. Più tardi misero insieme il prospetto che la signorina Williams doveva battere a macchina. Lavorarono tutti e tre beatamente davanti al fuoco, quando comparve sulla porta Thompson e domandò reverente se il signor Moorehouse voleva degnarsi di parlare al telefono col signor Griscolm. «Bene, datemelo qua a questo telefono» disse J.W. Dick si sentì gelare là dov’era seduto. Gli arrivava dall’altro capo della linea, la voce acuta, strepitante eccitata. «Ed, non datevi pena» diceva adagio J.W. «Prendetevi un bel riposo, ragazzo mio, così che domattina siate fresco come una rosa, perché dovrete riveder le bucce all’abbozzo definitivo che la signorina Williams ed io abbiamo elaborato questa notte. Mi è venuto in mente qualche ritocco… Sapete come il sonno porti consiglio… Perché non andate a giocare un po’ alla palla quest’oggi? Una buona sudata fa un gran bene a tutti, lo sapete. Se non fosse così umido, farei anch’io le mie diciotto buche di golf. Intesi, arrivederci domattina, Ed.» J.W. posò il ricevitore. «Sapete, Dick,» disse «credo che Ed Griscolm farà bene a prendersi un paio di settimane di vacanza a Nassau o un luogo consimile. Va perdendo un poco la sua fermezza… Credo che glielo proporrò. Ci è stato assai prezioso in ufficio, vedete.» «È uno degli uomini più brillanti in tutto il campo dei pubblici rapporti» disse Dick piattamente. Si rimisero al lavoro. L’indomani mattina Dick rientrò in macchina con J.W. ma fece fermare nella Cinquantasettesima per fare una scappata in casa della mamma nella Cinquantaseiesima e cambiarsi la camicia. Quando giunse all’ufficio, l’addetto al centralino nel vestibolo gli rivolse un largo sorriso. Tutto vibrava e fremeva dell’affare Bingham.
Nell’ingresso si imbatté nell’inevitabile signorina Williams. Quel volto acido e segnato, di vecchia zitella, era contorto in un mellifluo sorriso. «Signor Savage, il signor Moorehouse vi manda a dire se vi disturberebbe trovarvi con lui e col signor Bingham al Plaza alla mezza, quando andranno a colazione.» Passò la mattinata al lavoro ordinario. Verso le undici Eveline Johnson gli telefonò e disse che aveva bisogno di vederlo. Dick propose la fine della settimana. «Ma sono già qui sotto» disse Eveline con un tono offeso. «Oh, salite su, però ho molto da fare… Sapete com’è il lunedì.» Eveline aveva un’aria di tensione nella luce cruda e vivida che dilagava per la finestra dal cielo annuvolato. Portava un soprabito grigio, dal colletto di pelliccia che appariva un po’ frusto, e uno spinoso cappellino grigio di paglia, strettamente aderente alla testa, che aveva un po’ l’aria dell’anno prima. Le pieghe dalle pinne del naso agli angoli della bocca parevano più segnate e aspre che mai. Dick si alzò in piedi e le prese le mani. «Eveline, sembrate stanca.» «Credo d’averci l’influenza.» Parlava rapida. «Sono entrata semplicemente per vedere una faccia di amico. Ho un appuntamento con J.W. alle undici e un quarto… Credo che m’intenderò con lui. Se ne trovo diecimila, gli Shubert metteranno il resto. Ma dev’essere una cosa fatta subito, perché c’è qualcuno che ci ha una specie di opzione che scade domani… Sono così disgustata di non far mai nulla… Holden ha delle idee meravigliose su questa produzione e darà a me l’arredamento e i costumi… se invece la prende qualche produttore di Broadway guasterà tutto… Dick, so che è un capolavoro.» Dick si accigliò. «Questo non è il momento più adatto… siamo tutti non poco preoccupati stamattina.» «Va bene, non vi disturberò oltre.» Erano in piedi, contro la finestra. «Come fate a sopportare dal mattino alla sera quei martellatori?» «Anzi, Eveline, quei martellatori alle nostre orecchie sono altrettanta musica, ci fanno cantare come canarini nel temporale. Sono moneta sonante… Se J.W. ascolta me, l’avremo lassù la nostra nuova sede.»
«Arrivederci, allora.» Eveline gli porse una mano dal frusto guanto grigio. «So che metterete per me una buona parola… Qui dentro voi siete il cocco della fortuna.» Uscì lasciando nell’ufficio una lieve, familiare scia di colonia e di pelliccia. Dick passeggiò un poco davanti alla scrivania accigliandosi. D’un tratto si sentì nervoso e agitato. Decise di uscir fuori a prendere una boccata d’aria e magari un bicchierotto prima di andare a colazione. «Se qualcuno telefona» disse alla segretaria «ditegli di telefonarmi dopo le tre. Ho una commissione da fare e poi un appuntamento col signor Moorehouse.» Nell’ascensore c’era J.W. che scendeva allora, in un nuovo soprabito dal grosso collo di pelliccia e una fodera grigia nuova. «Dick,» gli disse «se arriverete in ritardo al Plaza vi torcerò il collo… Vi tocca la parte del cieco arciere.» «Per saettare Bingham nel cuore?» Gli ronzavano le orecchie, mentre l’ascensore calava. J.W. annuì, sorridendo. «A proposito, ditemi in stretta confidenza che ne pensate del progetto che ha la signora Johnson di mettere in scena un dramma?… È certamente una donna adorabile… Una volta erano grandi amiche con Eleanor… Dick, ragazzo mio, perché non vi sposate?» «Chi? Eveline? È già sposata.» «Pensavo solamente ad alta voce, non badateci.» Uscirono dall’ascensore e attraversarono insieme la Grand Central nel turbine della folla meridiana. Il sole s’era scoperto e lanciava lunghi raggi obliqui pieni di pulviscolo trasversalmente sotto il grande soffitto azzurro lassù. «Ma che ne pensate di questa speculazione drammatica? Vedete bene che son legato mani e piedi in Borsa… Immagino che potrei trovare la somma alla banca.» «Il teatro è sempre rischioso» disse Dick. «Eveline è una gran ragazza e tutto, e piena d’ingegno, ma non so quanto la sua testa le possa servire negli affari. Mettere in scena un dramma è una faccenda rischiosa.» «Mi piace dare una mano alle vecchie amicizie… ma ho pensato che, se gli Shubert credessero che ci fosse da guadagnare, ce li
metterebbero loro i quattrini… Senza dubbio la signora Johnson ha molto gusto.» «Senza dubbio» disse Dick. Alla mezza era nel salone d’entrata del Plaza, in attesa di J.W. e masticava Sen-Sen per levarsi dal fiato il sentore dei tre whisky che aveva tracannato da Tony per via. Ai tre quarti vide, che usciva dalla guardaroba, la grossa faccia a pera di J.W. coi suoi occhi azzurropallidi e i lucenti capelli grigiopaglia e gli stava accanto un tipo alto e sparuto dai canuti capelli scomposti arricciolati in frange sulle orecchie. Dall’istante che i due misero il piede nella sala, Dick cominciò a sentire un rauco e testardo vocione dalle labbra dell’uomo alto. «… mai stato uno di quelli capaci di conservare la calma, regnando l’ingiustizia nel pubblico mercato. Fu una lunga lotta e tale che, dalla sommità di questi settant’anni promessi dai profeti d’un tempo all’uomo su questa terra, posso ammettere sia stata largamente rimunerata con successo materiale e spirituale. Forse la ragione sta nella mia iniziale educazione al pulpito, ma io sono sempre stato convinto, e questa convinzione, signor Moorehouse, non è rara tra i più eminenti uomini d’affari del paese, che il successo materiale non è tutto… c’è ancora il conseguimento dello spirito di servizio. Perciò vi dico francamente che sono stato afflitto e ferito da questa tenebrosa congiura. Chi m’invola la borsa, invola fango ma chi 3… com’è?… la mia memoria non è più quella… il mio povero nome… Ah, sì, come state, signor Savage?» Dick fu sorpreso dallo schianto che la stretta di mano gli inferse al braccio. Si trovò di fronte a uno sparuto e dinoccolato vecchio dal groviglio di capelli bianchi su un grosso cranio prognatico, donde la pelle arsa dal sole penzolava a pieghe come il muso di un cane da caccia. J.W. pareva piccino e sommesso accanto a lui. «Sono ben lieto di conoscervi, signore» diceva E.R. Bingham. «Ho detto varie volte alle mie ragazze che se mi fosse capitato di crescere nella vostra generazione, avrei trovato un felice ed utile campo di lavoro nei pubblici rapporti. Ma, ahimè, ai miei tempi era più duro il sentiero per un giovane che entrasse nella vita con null’altro che l’eccellente
tradizione di fervore morale e religione naturale, che io succhiai, se così posso esprimermi, col latte materno. A noi toccò metter le spalle alla ruota in quei tempi ed era la ruota di un vecchio carro infangato tirato da muli, non la ruota di una lussuosa automobile.» E.R. Bingham fece strada nel salone da pranzo senza smettere il vocione rimbombante. Uno stormo di pallidi camerieri si raccolse intorno, e scostavano sedie, apparecchiavano il tavolo, porgevano i menù. «Ragazzo, è inutile dare a me la lista.» E.R. Bingham si rivolgeva al capocameriere. «Vivo secondo la natura. Non mangio che frutta secca e vegetali e bevo latte crudo… Portami degli spinaci cotti, un piatto di carote abbrustolite e un bicchiere di latte non pastorizzato… E il risultato è, signori, che quando visitai giorni fa un celebre dottore, dietro richiesta di una delle più grandi compagnie di assicurazione della città, questi rimase sbalordito esaminandomi. Non voleva quasi convincersi che io non gli raccontassi una storiella, quando gli dissi che avevo settantun anni. “Signor Bingham,” dice “avete lo stupendo fisico di un atleta di quarantacinque in piena salute…” Sentite questo, giovanotto.» E.R. Bingham fletté il braccio sotto il naso di Dick. Dick tastò il muscolo con due dita. «Una mazza» disse accennando del capo. E.R. Bingham s’era già rimesso a parlare. «Vedete ch’io metto in pratica quanto predico, signor Moorehouse… e intendo che gli altri faccian lo stesso… Posso aggiungere che in tutto il catalogo dei rimedi e degli specifici sotto il controllo della Bingham Products e della Rugged Health Corporation, non ce n’è uno solo che contenga un minerale, una droga o qualsiasi altro ingrediente pericoloso. Ho sacrificato tanto tempo e centinaia di migliaia di dollari per cancellare dal mio catalogo un composto giudicato dannoso o assuefacente dal dottor Gorman e dagli altri splendidi campioni maschili e femminili, che formano il nostro reparto delle ricerche. Le nostre medicine e i nostri sistemi di dieta e di cura sono i rimedi naturali, erbe e semplici raccolti nelle campagne selvagge dei quattro angoli del globo, secondo la tradizione di tutti i saggi e i ritrovati della sana medicina.» «Prendete adesso il caffè, signor Bingham, o più tardi?» «Il caffè, mio caro signore, è un veleno mortale, e tali sono l’alcool,
il tè e il tabacco. Se le donne dai capelli tagliati e gli uomini dai capelli lunghi e gli esaltati pazzoidi, usciti dalle scuole di medicina, che tentano di strappare al popolo americano la sua libertà di cercar la salute e il benessere, limitassero le loro attività all’eliminazione di questi letali veleni i quali minano la virilità dei nostri giovani e la fecondità delle nostre belle donne americane, non avrei nulla da ridire. Anzi farei ogni cosa in mio potere per aiutarli e spalleggiarli. Verrà il giorno che metterò tutta la mia fortuna a disposizione di una tale campagna. So che la gente semplice di questo paese la pensa come me, poiché sono uno di loro, nato e cresciuto in un podere di gente semplice e timorata di Dio. Il popolo americano ha bisogno di esser protetto dai birbanti.» «Questa, signor Bingham,» disse J.W. «sarà la chiave di volta della campagna che abbiamo abbozzato.» Arrivavano le scodelle per sciacquarsi le dita. «Bene, signor Bingham,» disse J.W. levandosi in piedi «è stato davvero un piacere. Disgraziatamente dovrò lasciarvi per recarmi al centro a una seduta di dirigenti troppo importante, ma il signor Savage, qui, ha tutto sulla punta delle dita e so che è in grado di rispondere a qualunque altro vostro quesito. L’incontro col vostro reparto Vendita è, mi pare, alle cinque.» Non appena furono soli, E.R. Bingham si piegò sul tavolo verso Dick e disse: «Giovanotto, sento molto il bisogno di distrarmi un poco, quest’oggi. Forse vi è possibile di venire come mio ospite a qualche trattenimento… Chi troppo lavora… conoscete il proverbio. I miei quartieri sono sempre stati a Chicago e tutte le volte che son passato a New York ho sempre avuto troppo da fare per uscire un po’… Forse mi saprete suggerire qualche sorta di spettacolo o di capriccio musicale. Appartengo alla semplice gente, andiamo dove la semplice gente va». Dick annuì in atto di comprensione. «Vediamo, il lunedì pomeriggio… Dovrò telefonare all’ufficio… Dovrebbero esserci riviste… Non mi viene altro in mente ora se non uno spettacolo di burlesque.» «Questo, ci vuole: musica e donne giovani… ho grande considerazione per il corpo umano. Le mie figlie, sia lode a Dio, sono stupendi esemplari di fisico… Lo spettacolo di un corpo femminile ben fatto è rilassante e sedativo. Venite dunque, siete mio ospite. Ciò
mi aiuterà a prendere una decisione su questa faccenda… Tra noi, il signor Moorehouse è un uomo straordinario. Sono convinto che potrà infondere la necessaria distinzione… Ma non dobbiamo dimenticare che ci rivolgiamo alla semplice gente.» «Ma la semplice gente non è più semplice come una volta, signor Bingham. Le piacciono le cose alquanto sofisticate, ora» disse Dick, seguendo i passoni rapidi di E.R. Bingham alla volta della guardaroba. «Non porto mai né cappello né pastrano, soltanto quella sciarpa, signorina» rimbombava la voce di E.R. Bingham. «Avete dei bambini, signor Savage?» domandò E.R. Bingham, quando furono seduti nel tassì. «No, per ora non sono sposato» disse Dick barcollando, e accese una sigaretta. «Volete perdonare a un uomo tanto vecchio, che potrebbe essere vostro padre, se vi dà un consiglio?» E.R. Bingham prese la sigaretta di Dick tra due lunghe dita nocchiute e la gettò dal finestrino dell’auto. «Amico mio, voi vi state avvelenando con stupefacenti e distruggete la vostra virilità. Quando avevo intorno a quarant’anni, mi trovai preso in una severa lotta economica. Il mio grande organismo era ancora tutto nella sua infanzia. Fisicamente ero un rottame. Ero uno schiavo dell’alcool e del tabacco. Vivevo separato dalla mia prima moglie, e se ne avessi avuta una non sarei stato in grado di… fare con lei quanto un uomo dovrebbe. Ebbene un giorno mi dissi: “Dottor Bingham,” – gli amici mi chiamavano dottore a quei tempi – “come il vecchio Cristiano 4 tu sei sul cammino della città di Distruzione e, una volta che te ne andrai, non ci sarà nemmeno un marmocchio a versare una lacrima per te”. Cominciai a interessarmi alla corretta cultura del mio corpo… il mio spirito, posso dirlo, era già stato sviluppato in gioventù dalla mia familiarità coi classici e da una memoria che molti hanno definita un prodigio… E il risultato fu il successo dei miei tentativi, in ogni senso… Qualche giorno conoscerete la mia famiglia e vedrete quanta dolcezza e bellezza può ritrovarsi in una sana famiglia americana.» E.R. Bingham era ancora intento a parlare, quando scesero il passaggio, alla volta dei posti di prima fila, in un teatro di burlesque. Non ebbe tempo a dire bai, Dick, che si trovò a fissar gli occhi in alto su una serie di nude gambe femminili dimenanti, qualcuna chiazzata
dalla vaccinazione. L’orchestra rimbombava e squillava, le ragazze si contorcevano, cantavano e si svestivano in un lezzo di polvere, d’ascelle, di cipria e di cerone, sotto il riverbero del riflettore mobile che ogni volta accendeva la testa bianca di E.R. Bingham. E.R. Bingham fu particolarmente felice quando una delle ragazze si curvò e tubò: «Ma guarda il Nonnino» e gli cantò sulla faccia e dimenò alla sua volta la gamba. E.R. Bingham diede di gomito a Dick e bisbigliò: «Fatevi dare il suo telefono». Dopo che la ragazza fu passata, non smetteva di esclamare: «Mi sento ragazzo». Nell’intervallo Dick riuscì a telefonare alla signorina Williams in ufficio e dirle che suggerisse agli altri di non fumare durante la seduta. «Dite a J.W. che quel vecchio gufo considera le sigarette tanto tossico» disse. «Oh, signor Savage» disse la signorina Williams con tono di rimprovero. Alle cinque Dick cercò di farlo venir via, ma quello volle restare fino alla fine dello spettacolo. «Tanto mi aspetteranno, state tranquillo» gli disse. Quando furono di ritorno in tassì alla volta dell’ufficio, E.R. Bingham ridacchiò: «Dio del Cielo, mi piace sempre una bella fila di gambe, del corpo umano la divinità… Sarà bene, amico mio, tener la storia di questo pomeriggio sotto chiave». Menò sul ginocchio di Dick una pacca tremenda. «Sempre bello marinar la scuola.» Alla seduta la Bingham Products mise in calce la firma. Il signor Bingham disse di sì a ogni cosa e non badava affatto a quel che si faceva. A metà dei negoziati disse di sentirsi stanco e che tornava a casa a letto, e partì sbadigliando, lasciando il signor Goldmark e un rappresentante della compagnia J. Winthrop Hudson incaricato della pubblicità per i prodotti Bingham a esaminare i particolari del progetto. Dick non poté fare a meno di ammirare i modi pacati e imperiosi che J.W. usò con costoro. Dopo la seduta Dick s’ubriacò e cercò di intendersi in tassì con una ragazza di sua conoscenza, ma non fu nulla e dovette ritornare a casa nell’alloggio vuoto, sentendosi come un cane. L’indomani mattina dormì troppo. Lo destò il telefono. Era la signorina Williams che lo cercava dall’ufficio. Voleva esser tanto gentile il signor Savage da farsi preparare la valigia e mandarla alla
stazione, per esser pronto ad accompagnare il signor Moorehouse a Washington sul Congressional? «E, signor Savage,» aggiunse «scusatemi se ve lo dico, ma qui all’ufficio siamo tutti convinti che si deve a voi la conclusione dell’affare Bingham. Il signor Moorehouse diceva che dovete averli ipnotizzati tutti.» «Questo è gentile assai da parte vostra, signorina Williams» disse Dick con la sua voce più soave. Dick e J.W. presero uno scompartimento sul treno. La signorina Williams venne con loro e lavorarono per tutto il viaggio. Dick era pazzo dalla voglia di bere un sorso, ma non osava farlo, benché avesse una bottiglia di scotch nella valigia, perché certo la signorina Williams l’avrebbe pescato nell’atto di tirar fuori la bottiglia, e avrebbe fatto qualche osservazione in quel suo vago acido modo «domando scusa» e poi sapeva di ber troppo, secondo l’idea di J.W. Si sentiva così nervoso che fumò sigarette finché la lingua non cominciò a disseccarglisi in bocca e allora si mise a masticare gommini. Dick tenne occupato J.W. con nuove trovate, finché J.W. non si coricò a schiacciare un sonnellino dicendo che si sentiva un poco sfatto; allora Dick portò la signorina Williams nella vettura ristorante a prendere una tazza di tè e le raccontò barzellette che non la lasciavano più respirare dalle risa. Quando finalmente giunsero alle fumose gallerie di Baltimora, Dick si sentiva pressoché pronto per la cella imbottita. Si sarebbe messo a dire alla gente che era lui Napoleone, quando ancora non erano giunti a Washington, se non gli fosse riuscito di dare una buona golata allo scotch, mentre la signorina Williams s’era chiusa nel gabinetto per signore e J.W. stava sprofondato in un pacco di corrispondenza, passatogli da E.R. Bingham, un carteggio tenuto fra la Bingham Products e il loro uomo di Washington, il colonnello Judson, alla minaccia di un decreto sui cibi puri. Quando Dick poté finalmente rifugiarsi dentro la sua camera nell’appartamento d’angolo che ogni volta J.W. prendeva al Shoreham, si mescé un buon bicchiere da bersi da solo in santa pace, con selz e ghiaccio, e intanto preparava un telegramma burlesco da spedire alla ragazza con la quale quella sera aveva un appuntamento per cenare al Colony Club. S’era appena bagnate le labbra che trillò il
telefono. Era la segretaria di E.R. Bingham, che parlava dal Willard e domandava se Dick poteva cenare col signore e la signora e le signorine Bingham. «Andateci assolutamente» disse J.W. quando Dick gli chiese se avrebbe avuto bisogno di lui. «Nulla di più facile, sapete, che io completi i negoziati sposandovi a qualcuna di quelle simpatiche signorine.» Le signorine Bingham erano tre giovani gagliarde e prosperose chiamate Hygeia, Althea e Myra, e la signora Bingham era una grassa bionda sfiorita, dal viso piatto, che portava tondi occhiali montati in acciaio. La sola della famiglia che non portasse occhiali e non avesse i dentacci era Myra che pareva aver preso di più del padre. Che parlasse senza smetter mai, era un fatto. Era altresì la più giovane e E.R. Bingham, che andava intorno a gran passi in pantofole all’antica con la camicia aperta al collo e un pezzo della maglia rossa di flanella esposto sul petto, la presentò come il membro artistico della famiglia. Lei fece molti sogghigni sul fatto che sarebbe andata a New York a studiar pittura. Disse a Dick che dalla sua aria s’indovinava un temperamento artistico. Mangiarono in mezzo a una certa confusione, per via che il signor Bingham non la smetteva di rimandare i piatti, e s’accese d’una collera grandiosa perché i cavoli eran troppo cotti e le carote crude erano ancor verdi e imprecò e bestemmiò contro i camerieri e alla fine fece chiamare il direttore. In complesso non avevano mangiato che brodo di patate e cipolle lesse seminate di nocciole e burro di pistacchio spalmato su pane puro grano, il tutto innaffiato di Coca-Cola, quando comparvero due giovanotti con un microfono da parte della NBC 5 perché E.R. Bingham trasmettesse la sua chiacchierata delle otto sulla salute. Di botto tornò sorridente e cordiale e la signora Bingham ricomparve dalla camera da letto, dove si era rifugiata in lacrime con le mani sulle orecchie per non sentire le parolacce del vecchio. Ritornò con gli occhi rossi e una bottiglietta di sali da naso in mano, giusto in tempo per farsi cacciare un’altra volta dalla stanza. E.R. Bingham ruggì che le donne distoglievano la sua attenzione dal microfono, ma fece restare Dick ad ascoltare la trasmissione sulla salute e la dieta e i consigli d’esercizio, e l’annuncio della marcia campestre annuale da
Washington a Louisville, promossa dal «Rugged Health», organo ufficiale della Bingham Products, marcia che, disse, avrebbe nei primi tre giorni condotto lui in persona, tanto per dare il passo ai giovincelli. Dopo la trasmissione, la signora Bingham e le ragazze entrarono tutte rossettate e incipriate, con orecchini di diamanti e collane di perle e mantelli di cincilla. Invitarono Dick e i due giovanotti della radio a venire con loro al Keith, ma Dick spiegò che aveva da lavorare. Prima di uscire, la signora Bingham gli fece promettere che sarebbe venuto a trovarli nella loro casa di Eureka. «Verrete a passare un mese, giovanotto» vociò E.R. Bingham interrompendola. «Laggiù faremo un uomo di voi. La prima settimana, spremute d’arancia e spugnature, massaggio, riposo… In seguito, vi rimettiamo in piedi con grano tostato, latte con crema in abbondanza, un po’ di pugilato e di corsa, nessun risparmio di camminate sotto il sole, senza addosso tutto quel soffoco di vestiti, e ritornerete un uomo, il capolavoro della natura, il paragone dei bruti… conoscete i versi del vate immortale… e avrete del tutto dimenticato quella malsana vita di New York che vi avvelena l’organismo. Venite laggiù, giovanotto… Buona sera. Quando avrò finito la mia respirazione ritmica, sarà l’ora di mettermi a letto. Qui a Washington mi alzo sempre alle sei e spezzo il ghiaccio del Basin… Che ne direste di venire anche voi a fare un tuffo domani? Ci saranno gli operatori Pathé… col vostro tipo d’azienda varrebbe la pena.» Dick si scusò in fretta, dicendo: «Un’altra volta, signor Bingham». Al Shoreham trovò J.W. che finiva di cenare col senatore Planet e il colonnello Judson, un individuo liscio e roseo, faccia rospina, dai blandi modi carezzevoli. Il senatore s’alzò in piedi e serrò con calore la mano a Dick. «Be’, giovanotto, ci attendevamo di vedervi tornare vestito di una pelle di tigre… Vi ha mostrato la sua capacità toracica il vecchio?» J.W. s’era aggrottato. «Per questa volta, no, senatore» disse Dick tranquillamente. «Ma, senatore,» disse J.W. con una certa impazienza, riprendendo evidentemente un discorso al punto dov’era stato interrotto «è il principio della cosa. Una volta che l’interferenza governativa negli affari sia stabilita come un precedente, sarà la fine della libertà e
dell’iniziativa privata, in questo paese.» «Sarà l’inizio della rossa tirannia del bolscevismo russo» aggiunse il colonnello Judson con enfasi iraconda. Il senatore Planet rideva. «Non vi sembrano parole un po’ grosse, Joel?» «Quello a cui questo decreto mira è di togliere al popolo americano il diritto di curarsi da sé. Una squadra d’impiegati fannulloni e di mantenuti sarà in grado di dettarvi quale lassativo dovete prendere e quale no. Come tutte le cose del genere, finirà nelle mani di birbanti e di traffichini. Certamente il popolo americano ha il diritto di scegliere i prodotti che intende comprare. È un insulto fatto all’intelligenza dei nostri compatrioti.» Il senatore sollevò inclinandola la tazzina del caffè per sorbirne l’ultimo centellino. Dick s’accorse che bevevano brandy in grossi bicchieri a sfera. «Ecco» disse il senatore adagio «quanto dite può esser vero, ma il decreto ha un certo appoggio da parte del paese e voi signori non dovete dimenticare che in questo io sono un agente non del tutto libero. Mi tocca consultare i desiderata dei miei elettori…» «Per quanto ci vedo io» interruppe il colonnello Judson «tutti questi decreti sui cosiddetti cibi e rimedi puri non sono altro che legislazione di classe in favore della professione medica. È naturale che i dottori vogliano che li consultiamo prima di comprare uno spazzolino da denti o un pacchetto di polvere di liquirizia.» J.W. riattaccò dove l’altro tacque. «La tendenza dello sviluppo nella preparazione scientifica degli specifici è stata di rendere il profano libero e bastante a se stesso, in grado di curarsi di molti dei malanni meno gravi senza consultare nessun medico.» Il senatore terminò il suo brandy senza rispondere. «Bowie» disse il colonnello Judson, dando mano alla bottiglia e mescendo dell’altro. «Voi sapete quanto lo so io, che la gente semplice del vostro stato non ha nessuna voglia di vedere la sua libertà di scelta ostacolata da un qualunque ficcanaso o traffichino di Washington… E noi abbiamo quattrini e organizzazione che ci saranno di grande aiuto in questa campagna. Il signor Moorehouse è sul punto di lanciare una delle più enormi ondate educative che il paese abbia mai visto, per mettere la gente a conoscenza della verità sugli specifici, non solo nei distretti cittadini ma anche nei rurali. Raccoglierà una grande marea
d’opinione di cui il Congresso dovrà pure tener conto. Gliel’ho visto fare altre volte.» «Squisito brandy» disse il senatore. «Da anni il buon armagnac è il mio favorito.» Si schiarì la gola, prese un sigaro da una scatola nel centro del tavolo e l’accese con molta flemma. «Ho ricevuto ultimamente molte critiche – va da sé che si tratta di gente irresponsabile – per quello che hanno denominato il mio assodamento reazionario con l’alto mondo degli affari. Conoscete il richiamo demagogico.» «È particolarmente in tempi come questi che una organizzazione condotta con intelligenza può riuscire utilissima a un personaggio pubblico» disse il colonnello Judson fervidamente. Gli occhi neri del senatore Planet sfavillarono; egli si passò una mano sul ciuffo di irti capelli neri che gli era ricaduto sulla fronte bassa, lasciandogli calvo un tratto del cocuzzolo. «Credo che l’affare si riduca a conoscere l’entità dell’appoggio» disse alzandosi. «Il parallelogramma delle forze.» Anche gli altri si alzarono. Il senatore scosse la cenere dal sigaro. «La forza della pubblica opinione, senatore» disse J.W. solennemente. «Questo è quanto abbiamo da offrirvi.» «Va bene, signor Moorehouse, ora dovete scusarmi, ho certi discorsi da preparare… È davvero stato un piacere… Dick, dovete venire a pranzare con me, finché state a Washington. Abbiamo sentito la vostra mancanza durante le nostre cenette… Buona notte, Joel, ci vediamo domani.» Il cameriere di J.W. stava reggendo al senatore il soprabito dalla fodera di pelliccia. «Il signor Bingham» disse J.W. «ha un forte senso sociale, senatore, è disposto a spendere una somma assai considerevole.» «La spenderà» disse il senatore. Quando la porta si chiuse dietro al senatore Planet, gli altri stettero un istante silenziosi. Dick si versò un bicchiere di quell’armagnac. «E così, il signor Bingham non dovrà inquietarsi» disse il colonnello Judson. «Ma la faccenda gli costerà quattrini. Bowie e i suoi amici cercano semplicemente di far mettere le poste in tavola. Voi sapete che li conosco come le mie tasche… Dopo tutto, sono quindici anni che giro questa città.»
«È un’umiliazione e un’assurdità che una legittima impresa debba abbassarsi a tali sistemi» disse J.W. «Certamente, J.W., mi avete levato le parole di bocca… Se volete la mia opinione, vi dirò che ci occorre in questo paese un uomo energico che mandi a carte quarantotto tutti questi politicanti… Non crediate ch’io non li conosca… Ma questa piccola cena è stata assai preziosa. Voi siete un elemento nuovo nella situazione… Una preziosa atmosfera di distinzione, mi capite… Buona notte, dunque.» J.W. era già in piedi con la mano tesa, il viso bianco come un foglio di carta. «Allora, scappo anch’io» disse il colonnello Judson. «Potete garantire al vostro cliente che quel decreto non passerà… Prendetevi una buona notte di riposo, signor Moorehouse… Buona notte, capitano Savage…» Il colonnello Judson tamburellò affettuosamente sulle spalle tanto di J.W. quanto di Dick, con lo stesso gesto delle due mani. Rimasticando il sigaro, sgusciò fuori della porta, lasciandosi dietro un largo sorriso e uno sbuffo di forte fumo azzurro. Dick si volse a J.W. che s’era lasciato affondare in una poltrona di felpa rossa. «Siete certo di non sentirvi male, J.W.?» «Soltanto un po’ d’indigestione» disse J.W. con un filo di voce, il viso contratto dallo spasimo, adunghiando con le due mani i braccioli della poltrona. «Be’, credo che sarà meglio andare a letto» disse Dick. «Ma, J.W., non volete che si chiami un dottore per darvi un’occhiata domattina?» «Vedremo, buona notte» disse J.W. parlando con difficoltà, a occhi chiusi. Dick s’era appena addormentato quando un busso alla porta lo svegliò di soprassalto. Andò alla porta a piedi nudi. Era Morton, l’anziano cameriere londinese di J.W. «Chiedo scusa, signore, se vi ho svegliato, signore» disse. «Mi preoccupa il signor Moorehouse, signore. È venuto il dottor Gleason… Temo sia un attacco al cuore. Soffre da non si dire, signore.» Dick s’infilò l’accappatoio granata di seta e le pantofole e corse nella saletta dell’appartamento, dove si scontrò col dottore. «Ecco il signor Savage, signore» disse il cameriere. Il dottore aveva i capelli grigi, i baffi grigi e un fare solenne. Fissò fieramente nell’occhio Dick e gli disse: «Il signor Moorehouse ha bisogno per qualche giorno di un’assoluta quiete. Si tratta di una
leggerissima angina pectoris… non seria per stavolta, ma sarebbero assai indicati alcuni mesi di completo riposo. Dovrebbe sottoporsi a una visita medica generale… cercate domani di convincerlo senza parere. Mi pare che voi siate il socio del signor Moorehouse, vero, signor Savage?» Dick divenne rosso. «Sono uno dei collaboratori del signor Moorehouse.» «Toglietegli dalle mani quanto più lavoro potete.» Dick annuì. Ritornò in camera sua e giacque sul letto il restante della notte senza riuscire a prender sonno. L’indomani mattina quando Dick andò a vederlo, J.W. era seduto nel letto, puntellato con guanciali. Aveva il viso di un bianco raggrinzito e ombre viola sotto gli occhi. «Dick, questa volta mi sono preso un bello spavento.» La voce di J.W. era debole e tremula, quasi Dick si sentiva le lacrime agli occhi ascoltandola. «E adesso, quanto a noialtri?» «Ecco, Dick, temo che dovrò scaricare sulle vostre spalle E.R. Bingham e un certo numero di altre faccende… E ho anche pensato che forse farei meglio a trasformare l’intera ragione sociale della ditta. Che ne direste: Moorehouse, Griscolm e Savage?» «Dico che sarebbe un errore mutare il nome, J.W. Dopo tutto J. Ward Moorehouse è un’istituzione nazionale.» La voce di J.W. salì di forza tremolando. Continuamente aveva da schiarirsi la gola. «Credo abbiate ragione, Dick» disse. «Sarei lieto di potere tener duro fino a che non avrò dato l’avvio a quei ragazzi.» «Che cosa siete disposto a scommettere che verrete in tuba al mio funerale, J.W.? In primo luogo può essere stato un attacco acuto di indigestione appunto come credevate voi. Non possiamo stare semplicemente al parere di un dottore. Che ne direste di un viaggetto alla clinica Mayo? Quanto vi occorre è una ripassata, una smerigliata di valvole, con sistemazione al carburante, cose del genere… A proposito, J.W., non vorremo lasciare che il signor Bingham s’accorga che i suoi sacri specifici glieli maneggiava un uomo di miseri quindicimila annui, no?» J.W. rise debolmente. «Va bene, quanto a questo vedremo… Credo che sarà meglio se tornate subito stamane a New York, per occuparvi dell’ufficio. Qui terremo la posizione la signorina Williams ed io… È più brusca di un sottaceto ma vale un tesoro, ve l’assicuro.»
«Non sarebbe magari meglio che mi fermassi finché uno specialista non vi abbia dato una guardata?» «Il dottor Gleason mi ha riempito di non so che droga e me ne sto abbastanza bene. Ho telegrafato a mia sorella Hazel, insegna attualmente a Wilmington, è l’unica della famiglia che ho visto un po’ sovente da quando sono morti i vecchi… Arriverà quest’oggi. Sono le sue vacanze natalizie.» «Morton vi ha già portato le quotazioni d’apertura?» «Tanti razzi sembrano… Mai veduto niente di simile… Ma, sapete, Dick, ho intenzione di vendere e lasciar andare un poco i remi… È curioso come una simile esperienza vi toglie tutto il coraggio.» «A voi e a Paul Warburg» disse Dick. «Può darsi sia l’età» disse J.W. e chiuse gli occhi un attimo. Il suo viso parve afflosciarsi in un ammasso di rughe grigie e viola, sotto lo sguardo di Dick. «Dunque, pigliatevela calma, J.W.» disse Dick, e uscì dalla stanza in punta di piedi. Prese il treno delle undici e giunse in tempo all’ufficio per rimettere a posto ogni cosa. Disse a tutti che J.W. aveva un leggero attacco di influenza e sarebbe stato in letto alcuni giorni. C’era tanto di quel lavoro ammonticchiato, che lui diede alla signorina Hilles, sua segretaria, un dollaro per la cena e le disse di tornare alle otto. Quanto a sé, prese qualche panino imbottito e un cartoccetto di caffè che si fece mandare da un Delicatessen. Fu mezzanotte prima che avesse finito. Nei corridoi deserti dell’edificio spento incontrò due vecchie rugginose che venivano con secchie e spazzoloni a pulire l’ufficio. Il guardiano notturno dell’ascensore era vecchio e terreo. Era caduta la neve e s’era fatta poltiglia e dava a Lexington Avenue una tenebrosa aria sventrata come di strada in un villaggio abbandonato. Un vento crudo gli sferzava viso e orecchie, mentre s’allontanava dal centro. Dick pensò all’alloggio nella Cinquantaseiesima, pieno dei mobilio materno, le poltrone dorate nell’anticamera, tutti i detestabili oggetti che aveva conosciuto da bambino, lo Stag at Bay e le incisioni del Forum Romanorum, in camera sua, i letti d’acero; poteva vedere ogni cosa lucidamente come fosse là, e intanto svoltava nel vento. Era già
brutto quando c’era sua madre, ma quando poi lei era a St. Augustine, spaventoso. «Mondo cane, è tempo che guadagni abbastanza da riorganizzarmi la vita» si disse. Saltò nel primo tassì che trovò e si fece portare al 63. C’era una tiepida intimità al 63. Mentre lo aiutava a levarsi soprabito e sciarpa, la guardarobiera biondo platino sostenne un’elaborata botta e risposta che durava da tutto l’inverno su come lui l’avrebbe condotta a Miami e a far fortuna nelle corse di Hialeah. Poi Dick si fermò un istante a scrutare attraverso l’ingresso nella bassa sala piena di teste ben curate, tavolini, bicchieri, spire di sigaretta contorte davanti alle lampade rosee. Scorse il ciuffo nero di Pat Doolittle. Era laggiù seduta nella nicchia con Reggie e Jo. Il cameriere italiano corse alla sua volta, fregandosi le mani. «Buona sera, signor Savage, eravamo spersi senza di voi.» «Sono stato a Washington.» «Freddo laggiù?» «Oh, così così» disse in faccia a Pat. «Oh, guarda chi c’è con noi» disse quella. «Vi credevo tutto occupato ad avvelenare il pubblico americano sotto la cupola del Campidoglio.» «Non sarebbe poi tanto male se avvelenassimo qualcuno di quei legislatori dell’Ovest» disse Dick. Reggie tese la mano. «Via, qua la zampa, Alec Borgia… Immagino che sarai per il bourbon, se ti sei mescolato coi padri coscritti.» «Prendo sì, il bourbon… ragazzi, sono stanco… Mangerò qualcosa. Non ho ancora cenato. Vengo ora dall’ufficio.» Reggie aveva l’aria discretamente brilla; e così pure Pat. Jo era in sé, evidentemente, e assai seccata. Questa la debbo aggiustare, pensò Dick e cinse Pat alla vita col braccio. «Di’ un po’, l’hai ricevuto il telegramma?» «Ci ho riso tanto da star male» disse Pat. «Perdio, Dick, fa piacere riaverti nella classe dei bevitori.» «Dimmi, Dick,» disse Reggie «c’è qualcosa di vero in questa voce che il vecchio panada ha dato il giro?» «Il signor Moorehouse ha avuto un leggero attacco di indigestione acuta… ma stava meglio quando sono partito» disse Dick con una voce che gli suonò un po’ troppo solenne alle orecchie. «A forza di non bere ci restano, un bel giorno» disse Reggie. Le ragazze risero. Dick buttò giù tre bourbon l’uno dopo l’altro, ma non
ne cavava nessun sollievo. Semplicemente era affamato e giù di corda. Teneva il capo ritorto da una parte nel tentativo di fare un segno al cameriere per sapere che diavolo fosse successo al suo filet mignon, quando sentì Reggie sentenziare: «Dopo tutto, J. Ward Moorehouse non è un uomo… è un nome… E non ci si può rattristare quando si ammala un nome». Dick si sentì una vampa d’ira salire al capo. «È uno dei sessanta personaggi più importanti di tutto il paese» disse. «Dopo tutto, Reggie, vivi dei suoi quattrini…» «Santo Cielo,» esclamò Reggie «è salito sul pulpito.» Pat si volse a Dick, ridendo: «Possibile che a Washington tutti diventino sacri?». «Macché, sapete che mi piace scherzare tanto quanto a un altro… Ma quando a un uomo come J.W., che ha fatto forse più di qualunque altro contemporaneo, vi piaccia o no quello che ha fatto, per formare il pubblico pensiero in questo paese, gli capita che sta male, penso che le freddure studentesche sian piuttosto di cattivo gusto.» Reggie era sbronzo. Si mise a parlare nel peggior dialetto del Sud. «Be’, compare, non lo sapevo che voi foste il signor Moorehouse in persona. Vi credevo solamente un conculcato mercenario come noi altri ragazzotti.» Dick voleva star zitto, ma non si tenne. «Vi piaccia o no, la formazione di un pubblico pensiero è uno dei fatti più importanti che avvengono in questo paese. Non fosse per essa, il mondo americano degli affari si troverebbe in un bel guaio… Ora, può piacerci il modo come opera il nostro mondo degli affari o non piacerci, ma storicamente è un fatto tanto quanto la catena dell’Himalaia, e non c’è freddura che basti a mutarlo. È solamente attraverso l’azione sui pubblici rapporti che gli affari riescono protetti contro gli esaltati pazzoidi e i demagoghi sempre all’erta per ficcare un bastone tra le ruote della nostra macchina industriale.» «Bravo, bene» gridò Pat. «Sarete la prima, voi, a strillare quando vi taglieranno il reddito delle obbligazioni ipotecarie del vostro vecchio» disse Dick seccamente.
«Senatore,» intonò Reggie, corroborato da un altro bicchierino «mi sia concesso di congratularmi… sull’anima mia, senatore, mi sia concesso di congratularmi… per gli incalcolabili servigi da voi resi a questa sconfinata cosa pubblica che si estende dall’Atlantico oceanico fino al grande e glorioso Pacifico.» «Sta’ zitto, Reggie» disse Jo. «Lasciagli mangiare la bistecca in pace.» «Ecco, non si può dire che tu non abbia fatto strillar l’aquila, Dick,» disse Pat «ma siamo giusti, pare anche a me che tu abbia ragione.» «Dobbiamo pure esser realisti» disse Dick. «Io credo» disse Pat Doolittle, rigettando indietro il capo e ridendo «che gli abbia mollato finalmente quell’aumento.» Dick non poté tenersi dal ghignare e far cenno di sì. Si sentiva meglio, ora che aveva mangiato. Ordinò un altro giro di bicchierini e cominciò a parlare di andar tutti in Harlem a ballare allo Smalls Paradise. Disse che non poteva andare a letto, era troppo stanco, aveva bisogno di rilassarsi un po’. Pat Doolittle disse ch’era entusiasta di Harlem, ma non aveva portato soldi con sé. «Pago io» disse Dick. «Ho in tasca un fottio di spiccioli.» S’incamminarono con una fiaschetta di whisky a testa, le ragazze nelle loro borsette, Dick e Reggie nella tasca deretana dei pantaloni. Reggie e Pat nel tassì cantarono The Fireship. Dick bevette in quantità, nel tassì, per rimontare gli altri. Scendere per i gradini da Small fu come scendere sott’acqua in uno stagno caldo e denso. L’atmosfera era piena dei sentori muschiati di cipria profumo rossetto e abiti dei mulatti e sussultava come carne viva alla cadenza blanda dell’orchestra. Dick e Pat si misero subito a ballare, abbracciati insieme assai stretti. Il passo andava liscio come l’olio. Dick si trovò le labbra di lei sotto le sue e le baciò. Pat gli rese il bacio. Quando la musica tacque, barcollavano un poco. Tornarono alla volta del tavolino col sussiego degli sbronzi. Quando l’orchestra riattaccò, Dick fece ballare Jo. Baciò anche lei. Jo lo respinse da sé un poco. «Dick, non dovete.» «Ma a Reggie non importa. Resta tutto in famiglia…» Passavano ballando accanto a Reggie e Pat, chiusi in una oscillante nebbia di coppie. Dick lasciò cader la mano di Jo e posò la sua sulla
spalla di Reggie. «Reggie, non v’importa se una volta tanto bacio per voi la vostra futura moglie?» «Andate fin dove volete, senatore» disse Reggie. Aveva la voce spessa. Pat aveva il suo da fare a tenerlo dritto in piedi. Jo diede un’occhiata dispettosa a Dick e per tutto il resto del giro tenne il viso rivolto altrove. Appena furon di ritorno al tavolino, disse a Reggie che eran passate le due e lei doveva rientrare: lei almeno, l’indomani aveva da fare. Quando furono soli e appunto Dick cominciava a corteggiare Pat, lei gli si volse e disse: «Oh, Dick, portatemi in qualche posto davvero bassofondo… Non c’è mai nessuno che voglia portarmi nei bassifondi». «Direi che qui è abbastanza bassofondo per una matricolina» disse Dick. «Ma qui è più per bene che in Broadway, e io non sono una matricolina… Sono la donna nuova.» Dick scoppiò a ridere. Risero insieme e ci bevettero sopra e di nuovo s’intenerirono l’uno per l’altro e Dick le chiese d’un tratto perché non sarebbero stati insieme sempre. «È vile da parte vostra. Non è il posto, qui, per dichiararsi a una ragazza. Pensate: ricordare per tutta la vita che ci si è fidanzati in Harlem… Voglio vedere la vita reale.» «E va bene, cara signorina, ci andremo… ma non pigliatevela poi con me, se le forze non ve la dicono.» «Non sono mica un’educanda» disse Pat irritata. «So benissimo che la cicogna non c’entra.» Dick pagò e finirono uno dei mezzilitri. Fuori, nevicava. Le vie, i pianerottoli, i marciapiedi eran candidi, innocenti, tranquilli, sfavillanti di neve recente sotto i lampioni. Dick s’informò dal guardaportone, nero e occhi bianchi, circa una tampa di cui aveva sentito e il guardaportone diede l’indirizzo all’autista. Dick cominciò a sentirsi beato. «Perdiana, Pat, che bella cosa» non smetteva di esclamare. «Quei ragazzi non ce la fanno. Ci vogliamo noi adulti per farcela… Dite, Reggie si fa troppo impertinente, lo sapete?» Pat gli teneva stretta la mano. Le avvampavano le gote e aveva in viso una gran tensione. «Che emozione» diceva. Il tassì si fermò davanti a un uscio di legno grezzo, sotto il livello della strada, sormontato da una lampadina elettrica in un’aureola di fiocchi. Ci volle del bello e del buono per entrare. Non c’era un solo bianco là dentro. Era una camera di termosifone piena di semplici tavoli da
cucina e sedie. Dai tubi del riscaldamento, in alto, pendevano nastri di carta colorata. Una grossa donna scura in veste rosa, grossi occhi rotanti come staccati nelle occhiaie fosche e labbra che si contraevano, li guidò a un tavolo. Mostrava una viva simpatia per Pat. «Entra presto, tesoro» diceva. «Dove sei stata finora?» Il whisky era finito e così bevettero gin. Tutto cominciava a turbinare nella testa di Dick. Non riusciva a staccarsi dal pensiero di come ce l’aveva su con quel moccioso di Reggie. Ma come, lui l’aveva coccolato nell’ufficio per un anno e quello adesso gli faceva l’erlo. Quel bischero. Non c’era altra musica che un piano, dove un negro dal vitino sottile solleticava gli avori. Dick e Pat ballarono, ballarono, e Dick la fece vorticare finché i negri cioccolato e i mulatti li acclamarono e applaudirono. Poi Dick scivolò e lasciò andare Pat, che prillando finì contro un tavolo dove sedevano ragazze. Teste fosche indietreggiarono, labbra di gomma rosa si tesero, bocche spalancate. Denti d’oro e avorio cacciarono un urlo. Pat ballava con una pallida mulatta così carina nell’abito giallo. Dick ballava con un ragazzo marrone dalla mano carezzevole, vestito attillato del color della pelle. Il ragazzo sussurrava all’orecchio di Dick che il suo nome era Gloria Swanson. Dick d’un tratto se ne staccò e filò da Pat e la strappò alla ragazza. Poi ordinò da bere per tutti, il che mutò le facce cupe di nuovo in sorrisi. Ebbe il suo da fare a ficcare Pat nel soprabito. La donna grassa fu di grande aiuto. «Ma sì, tesoro,» diceva «non vorrai bere più stanotte, guastare la tua bellezza.» Dick l’abbracciò e le diede un biglietto da dieci. Nel tassì Pat ebbe un accesso isterico e lo batté e lo morse, mentre lui la teneva saldamente cercando d’impedirle di aprire lo sportello e saltar fuori nella neve. «Voi guastate ogni cosa… Non sapete pensare che a voi» strillava Pat. «Non sapete far nessuna cosa fino in fondo.» «Ma, Pat, sii ragionevole,» gemeva lui «mi è parso che fosse ora di dare un taglio.» Quando poi il tassì venne a fermarsi davanti al grande caseggiato quadro in Park Avenue dove lei abitava, Pat gli stava singhiozzando, ormai placata, sulla spalla. Dick la mise nell’ascensore e rimase a lungo a baciarla nel corridoio disopra, prima
di lasciarle ficcar la chiave nel buio della serratura. Stavan là barcollando, allacciati insieme, finché Dick non udì il sibilo dell’ascensore che saliva e le aprì la porta e la cacciò dentro. Quando uscì dal portone, trovò che il tassì lo attendeva. Aveva dimenticato di pagare l’autista. Non gli pareva tollerabile l’idea di tornare a casa. Non si sentiva ubriaco, si sentiva immensamente baldanzoso e padrone di sé e innocuamente eccitato. Patricia Doolittle la detestava più di chiunque al mondo. «Quella vacca» non smetteva di dir forte. Si chiese, chi sa che effetto ritornare alla tampa, e provare che succedeva ed ecco che c’era e quella grassa lo baciava, quella che si dimenava stringendolo a sé e chiamandolo il suo piccolo caro e lui teneva in mano una bottiglia di gin e versava da bere a tutti e ballava a gota a gota con Gloria Swanson che gli ronzava paroline d’amore all’orecchio. Era il mattino. Dick vociava che la festa non poteva finire, dovevan tutti venire con lui a colazione. Non c’era più un’anima e lui saliva in tassì con Gloria Swanson e un poderoso maschiaccio che Gloria chiamava la sua amica Florence. Ebbe tremende difficoltà a ficcare la chiave nella serratura. Incespicò e cadde verso la luce cilestrina che filtrava alle finestre per le tendine merlettate di sua madre. Qualcosa di assai molle lo picchiò sulla nuca. Si destò ancora vestito, nel suo letto. Era giorno chiaro. Il telefono trillava. Che trillasse. Sedette. Si sentiva la testa vuota, ma nessuna nausea. Si portò la mano all’orecchio e la ritrasse tutta insanguinata. Doveva esser stata una calza piena di sabbia, a colpirlo. Si mise in piedi. Era tutto barcollante, ma poteva camminare. La testa cominciò a dolergli spaventosamente. Tese la mano al punto del tavolo dove usualmente lasciava l’orologio. Neanche l’ombra. I suoi vestiti erano appesi in ordine su una sedia. Trovò il portafogli al solito posto, ma il fascio di biglietti era partito. Sedette sulla sponda del letto. Più idiota di tutti gli idioti di questo mondo. Mai mai mai più correre un rischio simile. Adesso avevano nome indirizzo telefono. Un ricatto, Dio santo! Che sarebbe successo quando la mamma ritornando dalla Florida avesse trovato che suo figlio, venticinquemila annui, giovane socio di J. Ward Moorehouse, si faceva ricattare da quegli sporchi bagascioni
negri? Dio santo. E Pat Doolittle e quelle signorine Bingham. Tutta la vita rovinata. Per un secondo pensò di entrare in cucina e aprire la chiavetta del gas. Raccolse tutte le sue forze e prese un bagno. Poi si vestì con ogni cura, indossò cappello e soprabito e uscì. Erano soltanto le nove. Vide l’ora nella vetrina di un gioielliere in Lexington. In quella medesima vetrina c’era uno specchio. Si guardò la faccia. Non era poi così segnata, si sarebbe fatta peggio in seguito, ma radersi doveva e provvedere a quel sangue raggrumato sull’orecchio. Non aveva un soldo, ma aveva il libretto degli assegni. Si diresse a piedi verso un bagno turco, presso la Grand Central Station. Gli inservienti lo presero in giro circa la grande rissa da cui usciva. Dick cominciò a dominare un poco il suo spavento e a dir parole grosse su come aveva conciato quell’altro. Accettarono il suo assegno senza fiatare, e poté persino pagarsi un sorso avanti colazione. Quando giunse all’ufficio, aveva ancora un mal di capo che spaccava, ma si sentiva in buona forma. Dovette tenere le mani nelle tasche perché la signorina Hilles non s’accorgesse come tremavano. Grazie al cielo non ebbe da firmar lettere fino al pomeriggio. Entrò Ed Griscolm e sedette sull’angolo della scrivania a discorrere delle condizioni di J.W. e dell’affare Bingham, e Dick fu con lui tutto zucchero. Ed Griscolm fece un gran parlare circa un’offerta da parte di Halsey, ma Dick gli disse che, certo, non toccava a lui dargli consigli, ma quanto a lui l’unico posto in tutto il paese dove avrebbe voluto trovarsi era qui, specialmente ora che c’erano maggiori cose in vista che non ci fossero mai state: lui e J.W. ne avevano fatto una lunga conversazione sul treno. «Credo sì che abbiate ragione» disse Ed. «Credo che fosse l’uva non matura.» Dick s’alzò. «Seriamente, vecchio mio, non dovete pensare neanche per un secondo che J.W. non apprezzi la vostra opera. Ha persino accennato a un aumento.» «È stato davvero generoso da parte vostra mettere una parola per me, vecchio» disse Ed e si strinsero la mano calorosamente. Mentre usciva dall’ufficio Ed si volse e disse: «Sentite, Dick, vorrei che diceste quattro parole a quel giovincello di Talbot… So che è un amico vostro e perciò non amo farlo io, ma Dio santo, ha di nuovo
telefonato che è in letto con l’influenza. È la terza volta in un mese.» Dick aggrottò le sopracciglia. «Non so che posso farci, Ed. È un ragazzo simpatico, non lo nego, ma se non si decide a sgobbare sul serio… credo che dovremo lasciarlo in libertà. Non possiamo permettere che il vizio dell’alcool danneggi l’efficienza in ufficio. Tutti questi ragazzi, del resto, bevon troppo.» Dopo che Ed se ne fu andato, Dick trovò sulla scrivania una grossa busta color lavanda soprascritta “Sue Mani”. Un buffo di acuto profumo ne uscì, quando l’aperse. Era un invito di Myra Bingham all’inaugurazione del suo studio in Central Park South. Era ancora intento a leggere, quando la voce della signorina Hilles suonò nel telefono interno. «C’è il signor Henry B. Furness della Furness Corporation che vuole parlare subito al signor Moorehouse.» «Datemelo al mio telefono, signorina. Gli parlerò io… e, a proposito, segnate un impegno di società nel mio promemoria… il 15 gennaio alle cinque… ricevimento signorina Myra Bingham, 36 Central Park South.» 1. John Ward Moorehouse, personaggio che ha già gran parte nel 42° parallelo e in Millenovecentodiciannove, i due precedenti romanzi di questa trilogia. (NdT) 2. Altro personaggio del 42° parallelo e di Millenovecentodiciannove. (NdT) 3. Ricordo dell’Otello. (NdT) 4. Personaggio del Pilgrim’s Progress di Bunyan, romanzo allegorico moraleggiante del ‘600 inglese, notissimo. (NdT) 5. National Broadcasting C., C. Nazion. Trasmissioni Radiofoniche. (NdT)
Cine-giornale LXVIII STUPORE A WALL STREET Non è la 38 è la vecchia 97 bisogna che arriviamo in tempo IL MERCATO SI RISTABILIRÀ DALLA CADUTA Declino nei contratti LA POLIZIA USA LE MITRAGLIATRICI CONTRO GLI SCIOPERANTI DEL COLORADO 5 MORTI 40 FERITI alcuni simpatizzanti comparvero sul luogo nell’istante stesso che migliaia di impiegati si riversavano fuori per la colazione. E sollevando costoro il cartellone ben alto e cominciando a far la spola da una parte e dall’altra, vennero canzonati e urlati non soltanto dagli impiegati ma anche da certi operai ch’erano su un palazzo in costruzione SI VEDONO NUOVI METODI DI VENDITA Le Squadre di Soccorso Tentano di Raddrizzare il Disgraziato Bastimento mentre si Aspettano i Pontoni. E lui si guarda intorno e dice al suo fuochista forza con quella pala quando attraverseremo tutte quelle montagne la vedrai come fila la tua 97 Trovo i vostri articoli interessanti e cerco consiglio. Ho risparmiato quattromila dollari che vorrei investire perché mi rendano di più. Credete farei bene a comperare azioni? L’ASSASSINO DEL POLIZIOTTO BUTTA VIA LA SIGARETTA MENTRE S’AVVIA TREMANDO AL SUO DESTINO AGENZIE TEATRALI IMMISCHIATE NELLA TRATTA DELLE BIANCHE Un don Giovanni escluso dall’avvocatura Oh, i fabbricanti di vestiti di destra e i falsari socialisti
sai che fanno con noi lavoratori? il doppio gioco! Predicano il socialismo ma praticano il fascismo tutto per tenere in sella sai che cosa? il capitalismo! IL CONGRESSO DI MOSCA ESPELLE GLI OPPOSITORI Da Lynchburg a Danville c’è una gran brutta strada e una lunga salita fu per quella salita che perse pressione e per lui fu finita I BANDITI DELLA FABBRICA IN UNA SPEDIZIONE CRIMINOSA ecco l’esempio più pericoloso di come all’istante decisivo l’ideologia borghese liquida la solidarietà di classe e trasforma un passato amico della classe lavoratrice nell’odierno miserabile propagandista d’imperialismo PICCHETTI ROSSI MULTATI PER PROTESTE Quando usciamo di casa al mattino diamo un bacio ai piccini I FUNZIONARI SPERANO ANCORA DI SALVARLI Scendeva per la china a novantaquattro all’ora e a un tratto fischiò forte dentro lo ritrovarono, davanti alla caldaia tutto ustionato a morte I RADICALI COMBATTONO A COLPI DI SEDIA NEL COMIZIO PER L’UNIFICAZIONE POLIZIOTTI CHE PROTEGGONO I ROSSI LA CAMERA DI COMMERCIO RACCOMANDA LA FIDUCIA I VALORI NON FITTIZI RESTANO INTATTI I padroni ci fanno sudare i bambini non fanno che piangere e ogni volta dobbiamo pagare IL PRESIDENTE PREVEDE VICINA LA PROSPERITÀ Non ci resta un quattrino da spendere
non un soldo da mettere via RULLO A VAPORE MESSO IN AZIONE CONTRO MILITANTI MINATORI CONTRO CRUMIRI Non possiamo nutrire i bambini i salari non bastano a niente ascoltatemi lavoratori donne e uomini e povera gente sia per essi la grande vittoria siate certi che non è peccato SQUILLANO LE CAMPANE SULLA SINGING TOWER il presidente dichiarò ch’era impossibile considerare gli accresciuti vantaggi delle masse senza sorridere di coloro che poco tempo fa esprimevano tanto timore che il nostro paese potesse cadere sotto il controllo di pochi individui dalle grandi ricchezze FOLLE LIETE ACCORRONO ALLA CERIMONIA su un’isoletta annidata come una verde gemma nel lago che rispecchia la Singing Tower, il presidente oggi prese parte all’inaugurazione di un tempio degli uccelli e del suo squillante carillon, adempiendo il sogno di un piccolo immigrato
Occhio Fotografico (51) in fondo alla valle nell’ombra delle colline sull’impiantito rotto di una sfasciata baracca un uomo mezzo seduto mezzo disteso è sostenuto da una vecchia due ragazze rugose che potrebbero essere giovani tocchi di carbone divampano nel focolare riverberano su quella faccia pallida e floscia come pasta annerano la bocca rientrata la gola incordata il ventre enfiato enorme per la ferita riportata lavorando alla frana del carbone la ragazza scalza gli porta una tazza d’acqua la donna deterge il sudore da quella faccia stillante con la sudicia manica di cotone il riflesso del fuoco gioca in quegli occhi dilatati dalla febbre negli occhi atterriti delle donne nelle facce sbiancate dei forestieri senza soccorso nella valle circondata da scure colline silenziose per lo sciopero quest’uomo morirà (mio padre morì sappiamo cosa sia veder morire un uomo) le donne lo comporranno sul giaciglio sgangherato i minatori lo seppelliranno nel carcere c’è luce rovente il calorifero sibila parliamo attraverso le verdi sbarre di ferro a un alto e pallido vecchio baffuto minatori sorridenti in maniche di camicia un ragazzo facce pallide della miniera hanno già l’aria cerosa del carcere forestieri che possiamo dire ai morti? forestieri che possiamo dire ai carcerati? il rappresentante del partito parla in fretta attraverso le sbarre Fate causa comune con noi e nessun altro sindacato vi manderemo tabacco dolci solidarietà i nostri legali scriveranno memoriali oratori grideranno i vostri nomi ai comizi porteranno i vostri nomi scritti sui cartelloni nei cortei i carcerati si stringono nelle spalle sorridono appena nostri sguardi incontrano i loro attraverso le sbarre che posso dire? (in un altro continente ho veduto le facce guardare attraverso le inferriate delle cantine dietro gli stivali della sentinella cenciosa ho veduto innanzi all’alba prigionieri sbandati e spedati sospinti per le vie zoppicanti tra le baionette udito la scarica ho veduto i cadaveri stesi a terra in quelle lontane più profonde vallate) che possiamo dire ai carcerati?
nell’ufficio della legge siamo in piedi contro la parete la legge è un omone dallo sguardo irritato sulla facciona a zucca che siede e sbarra gli occhi verso di noi forestieri importuni attraverso l’uscio le guardie coi loro fucili allungano il collo sono i sorveglianti delle miniere bloccano ai minatori le cucine di soccorso hanno tagliato la strada della valle mercenari armati stanno pronti a sparare (hanno fatto di noi dei forestieri nella terra dove siamo nati sono l’armata conquistatrice che è riuscita a infiltrarsi inosservata nel paese hanno occupato di sorpresa le posizioni hanno imposto pedaggi sono pronti nelle miniere sono pronti alle urne sono là quando gli uscieri sequestrano i mobili della famiglia buttata dall’alloggio in strada sono là quando le banche protestano un podere sono in agguato e pronti a mitragliare gli scioperanti che marciano dietro la bandiera per le svolte della strada verso i pozzi e buttano in carcere quelli che scampano al piombo) la legge attraverso la scrivania spalanca gli occhi irritati la sua faccia s’arrossa a chiazze come il collo di un tacchino e si gonfia della potenza delle mitragliatrici dei moschetti dei gas lacrimogeni dei gas vomitori la potenza di chi ti può nutrire o lasciar morire di fame siede comodo alla scrivania ha le spalle coperte si sente forte dietro di sé sente il pubblico ministero il giudice un proprietario anch’esso il caporione politico l’ispettore minerario il comitato di direzione il presidente del servizio pubblico il manipolatore della compagnia finanziaria solleva la mano verso il telefono le guardie si affollano all’uscio noi abbiamo soltanto parole
Energia Superenergia 1 Verso l’Ottanta del secolo scorso, quando gli agenti di Edison stavano impiantando il primo telefono a Londra, un ambizioso giovanotto cockney dai germoglianti favoriti a costoletta rispose all’annuncio che inserirono i giornali in cerca di un segretario e stenografo. Ebbe un posto di fattorino e studiò stenografia e contabilità nei ritagli di tempo. Usciva da un ceppo di piccoli bottegai puritani; e già picchiava con la fronte testarda contro l’acerba struttura di casta che condannava i ragazzi del suo rango a un’esistenza di giacchette d’alpaga, di scrivanie e di subordinazione. Lavorare con una ditta americana era mettere il piede sul primo piolo di una scala che l’avrebbe portato nel cielo. Il giovanotto fece del suo meglio per rendersi indispensabile ai nuovi padroni; era così entusiasta che lo lasciarono sedere al centralino per mezz’ora quando s’aprì il servizio telefonico; a lui non occorreva riposo, era sempre pronto; niente storie di ore o di ferie; Edison stesso notò la sapiente stringatezza dei suoi rapporti settimanali sulla situazione commerciale inglese e lo mandò a chiamare per farsene uno dei suoi segretari personali. L’immigrante sbarcò in America in un crudo giorno di marzo. Senz’altro venne condotto a Menlo Park e guidato a visitare il piccolo gruppo di laboratori. Vide le file delle lampadine elettriche risplendere a intervalli lungo i cortili nevosi, tutte accese dalla prima centrale elettrica del mondo, vide un nuovo secolo in quei nudi filamenti crudamente splendidi nella limpida aria d’America. Edison lo mise subito al lavoro e non si finì che a mezzanotte. Gli dissero di tornare alle sei. Il giovanotto era abbastanza solido da sopportare quel passo. Niente storie di ore o di ferie. Niente sciocche teorie o perditempo nei laboratori. Samuel Insull usciva da un solido ceppo di bottegai non conformisti. Si mise all’organizzazione commerciale, comprare a poco prezzo e vendere caro, e ci diede dentro finché arrivò a settant’anni. L’energia elettrica trasformò la scala in un ascensore.
Il giovane Insull si rese indispensabile al mago dell’elettricità e assunse in misura sempre crescente il controllo dei suoi affari. Edison soleva dire di lui ch’era spietato, sicuro, instancabile come il flusso e riflusso e fieramente deciso a farsi strada. Nel novantadue indusse Edison a mandarlo a Chicago come presidente della Chicago Edison Company. Ora, finalmente faceva da sé. Tutta la mia meccanica, disse poi una volta in un discorso, quando era ormai abbastanza zar di Chicago da permettersi il lusso di parlar chiaro, l’ho essenzialmente diretta a meccanizzare il rendimento del dollaro. Era un uomo rubizzo, arcigno e arrogante, dai baffetti corti; abitava sul lungolago e andava in ufficio puntualmente alle sette e dieci ogni mattina. Gli ci vollero quindici anni per fondare le cinque compagnie elettrotecniche nella Commonwealth Edison Company. Ben presto mi accorsi che il requisito più essenziale, come in altre branche di pubblica utilità, era di operare a monopolio. Quando si fu assicurato un saldo potere nel campo dell’elettricità, fagocitò il gas, diramato nei centri circostanti dell’Illinois settentrionale. Quando i politicanti gli mettevano i bastoni fra le ruote, lui li comperava, quando i capi del movimento proletario gli mettevano i bastoni fra le ruote, lui li comperava. La sua potenza crebbe sino all’inverosimile. Trattava i banchieri dall’alto in basso, gli avvocati erano al suo soldo. Introdusse il suo procuratore a Chicago come consulente corporativo, e per mezzo suo fece il bello e il brutto tempo in città. Quando, con suo grande stupore, dovette constatare che a Chicago c’erano uomini che non si lasciavan comperare (fra i quali anche un paio di giovani avvocati, Richberg e Ickes), decise che l’unica cosa da farsi era allestire una messinscena per il pubblico; Big Bill Thompson, the Builder: dàgli sul naso a re Giorgio!, la caccia al pesciolino che s’arrampica sull’albero, l’Opera lirica di Chicago. Fu sin troppo facile, il pubblico aveva denaro, di imbecilli ne nasceva uno al minuto, 2 e con la fondazione della Middlewest Utilities 3 nel 1912 Insull cominciò a servirsi del denaro pubblico per espandere il suo impero. Le sue compagnie cominciarono a tenere
pubbliche assemblee di azionisti, a farsi una propaganda sfacciata: il piccolo investitore poteva assistervi per una giornata intera ascoltando i discorsi dei pezzi grossi. È pur bello farsi infinocchiare. I sindacati di sua ispirazione ed emanazione ipnotizzarono i suoi dipendenti; tutti dovevano acquistare azioni delle sue compagnie, i dipendenti dovevano uscire a vendere azioni: giovani d’ufficio, sorveglianti di linea tranvieri. Persino Owen D. Young aveva paura di lui. Mi risulta per esperienza diretta che il massimo coefficiente di rendimento nella mano d’opera è una bella coda di gente che aspetta alla porta. La guerra tappò la bocca ai progressisti (basta con le solite ubbie come scioglimento dei trust, controllo sui monopoli, beneficio pubblico) e portò Samuel Insull alle stelle. Fu eletto capo del consiglio di Difesa dello Stato di Illinois. Adesso, uscì a dire compiaciuto, posso fare quello che mi pare e piace. Fu come dire il continuo centro dell’attenzione pubblica, il gusto purpureo dell’impero. Chiunque non approvava l’operato di Samuel Insull era un traditore. E perdio, Chicago lo tenne chiuso, il becco. Le compagnie Insull si estesero e si fusero, misero fuori combattimento i concorrenti finché Samuel Insull e il suo fido fratello Martin controllarono mediante gli ingranaggi delle compagnie a catena, direttorati e blocchi di azioni di minoranza la luce e l’energia, le miniere di carbone e le compagnie trasporti dell’Illinois, Michigan, dei due Dakota, del Nebraska, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Maine, Kansas, Wisconsin, Virginia, Ohio, North Carolina, Indiana, New York, New Jersey, Texas, del Canada, della Louisiana, della Georgia, della Florida e dell’Alabama. (Si calcola che un dollaro nella Middlewest Utilities, la compagnia finanziaria centrale, controllasse 1750 dollari investiti dal pubblico nelle compagnie sussidiarie che effettivamente s’incaricavano di produrre l’energia. Con la delicata leva di una consulta deliberativa che controllava le azioni delle due società madri, egli controllava un dodicesimo della produzione americana di energia.) Samuel Insull cominciò a pensare che tutto ciò egli lo possedeva al modo che si possiede un fascio di banconote ficcate nella tasca
posteriore dei calzoni. Lui aveva sempre trattato i banchieri dall’alto in basso. A Chicago ne aveva in mano un buon numero. Ma i banchieri di New York lo aspettavano al varco; lo giudicavano uno scarpone, andavano mormorando che non aveva solide basi finanziarie. Altre dita smaniavano di afferrare la leva di comando che con tanta delicatezza manovrava questo enorme potere sulle nostre vite, sovrappotenza o superenergia, come amava definirlo Insull. Un certo Cyrus S. Eaton di Cleveland, pastore battista in ritiro, fu il Davide che abbatté questo Golia. Fosse vero o no, riuscì a far credere a Insull che lui avesse il sostegno di Wall Street. Si mise a comprar azioni delle tre Utilities di Chicago. Insull, preso dal panico di perdere la propria posizione di controllo, scese in lizza contro di lui nel mercato azionario. Da ultimo il reverendo Eaton gli lasciò ricomprare definitivamente tutte le azioni, menandogli così un colpo di ben venti milioni di dollari. Tracollo in Borsa. La valuta cartacea sdrucciolava. Le compagnie di Insull erano concatenate in un intrico che nessun ragioniere è mai riuscito a dipanare. Il pallone crepato si sgonfiava a vista d’occhio. Insull lasciò da parte il suo orgoglio d’imperatore dell’elettricità e andò a Canossa dai banchieri. Era qui che lo volevano! Tanto per salvare la faccia dello zar vacillante, lo fecero curatore delle sue stesse imprese. Ma il vecchio non riusciva a togliersi dalla testa il chiodo che il denaro delle compagnie fosse stato suo. Quando venne a galla che stava adoperando i fondi degli azionisti per pagare le commissioni di agenzia dei suoi fratelli, la fu troppo grossa anche per un giudice federale. Insull fu costretto a dimettersi. Occupava posti direttivi in ottantacinque compagnie, era consigliere delegato di sessantacinque, presidente di undici: gli ci vollero ben tre ore per firmare le dimissioni. Quale compenso dei servigi da lui resi alla causa del monopolio le sue compagnie si quotarono per una pensione annua di diciottomila
dollari. Ma il pubblico reclamava a gran voce un’azione penale. Una volta cessate le elargizioni, giornali e politicanti gli si misero contro. C’era aria di rivolta contro i pascià della finanza. Samuel Insull la fiutò e se la svignò in Canada con la moglie. Pratiche di estradizione. Fuga a Parigi. Quando le autorità presero a incalzarlo dappresso anche lì, lui se la batté in Italia, andò in aereo a Tirana, di lì prese un altro aereo per Salonicco e quindi il treno per Atene. Qui la vecchia volpe si rintanò. Ad Atene il linguaggio della moneta sonante aveva la stessa forza persuasiva che aveva avuto a Chicago ai bei tempi. L’ambasciatore americano cercò di fargli piombare fra capo e collo l’estradizione. Insull assoldò un coro di avvocati e politicanti greci e se ne stette beato e tranquillo a sorbirsi il caffè nell’atrio del Grande Bretagne, mentre quelli pensavano a impigliare l’ambasciatore in un groviglio di cavilli complicato quanto la contabilità delle sue società madri. I pronipoti di Demostene ne gongolarono. Rimase temporaneamente soddisfatto il prurito ancestrale di chissà quanti elleni. Samuel Insull si sistemò magnificamente ad Atene, si emozionò alla vista del Partenone, contemplò le capre pascenti sui pendii pentelici, visitò l’Areopago, ammirò frammenti marmorei attribuiti a Fidia, parlò coi banchieri locali di riorganizzare i pubblici servizi della Grecia, fece parlare di sé come promotore della lignite macedone. Era il beniamino degli ateniesi; Madame Kouryoumdjouglou, vivace moglie di un mercante di datteri di Bagdad, gli dedicò le proprie attenzioni. Quando fallì il primo tentativo di estradizione, il vecchio signore dichiarò in aula nel sottrarsi agli abbracci dei suoi quattro avvocati: La Grecia è un paese piccolo, ma grande. L’idillio fu interrotto quando il governo Roosevelt cominciò a levare il pelo al ministero degli Esteri greco. A Chicago gli avvocati della pubblica accusa andavano raccogliendo carrettate di prove e stilando denunce su denunce, sempre più drastiche. Infine dopo molti rinvii (oltre agli avvocati, lui aveva pensato ad assoldare dei medici, i quali strillavano ai quattro venti che lasciare il clima propizio della piana attica gli sarebbe stato esiziale), ricevette l’ordine di lasciare la Grecia quale straniero
indesiderabile, con grande indignazione della buona società balcanica e di Madame Kouryoumdjouglou. Lui noleggiò il Maiotis, un piccolo e sgangherato battello greco da carico, e atterrì i corrispondenti esteri svignandosela per destinazione ignota. Corse voce che il novello Odisseo si dirigesse alla volta di Aden, delle isole dei mari del Sud, che fosse stato invitato in Persia. Di lì a pochi giorni comparve nel Bosforo con un po’ di mal di mare, per proseguire, stando alle voci, alla volta della Romania, dove Madame Kouryoumdjouglou gli aveva consigliato di mettersi sotto la protezione della Lupescu, sua amica personale. Su richiesta dell’ambasciatore americano i turchi furono ben lieti di prelevarlo dal battello greco per ficcarlo in un carcere tutt’altro che confortevole. Ancora una volta si era fatto venir denaro chissà come dall’Inghilterra, il toccasana cominciò a scorrere, si trovarono avvocati per i cavilli, interpreti per le rimostranze, dottori per le diagnosi; ma ad Angora comandavano i turchi e Insull fu spedito via mare a Smirne, per essere consegnato al viceprocuratore distrettuale federale, che aveva fatto quel po’ po’ di viaggio per arrestarlo. I turchi non vollero nemmeno permettere a Madame Kouryoumdjouglou, di ritorno da Bucarest dove aveva mosso le sue pedine, di scendere a riva per parlare con lui. In baruffa con i funzionari sul piroscafo la povera signora finì per cadere in mare, ed essere ripescata dal Bosforo con qualche difficoltà. Una volta messo con le spalle al muro, il vecchio stette buono buono e si lasciò riportare in patria a bordo dell’Exilona, si mise a scrivere le sue memorie, si rese simpatico ai compagni di viaggio, fu sbarcato a Sandy Hook e spedito per direttissima a Chicago per esservi processato. A Chicago il governo perfidamente gli inflisse due notti di gattabuia; uomini a lui sconosciuti, a detta dei giornali, si fecero avanti per pagargli la cauzione di centocinquantamila dollari. Fu trasferito a un ospedale già da lui sovvenzionato. Solidarietà. Gli uomini d’affari più in vista di Chicago vi si fecero fotografare nell’atto di fargli visita.
Venne anche Henry Ford. Il processo fu una cosa stupenda. La pubblica accusa si impantanò nelle questioni di tecnica finanziaria. Il giudice non era ostile. Gli Insull profittarono dell’occasione. Loro eran gente in gamba, sorridevano ai giornalisti, posavano per i fotografi, si recavano al tribunale in autobus. Sì, forse era vero che i titolari degli investimenti ci avevano rimesso l’osso del collo, ma (e lo fecero sapere in giro) gli Insull erano fatti così: il capitano era andato a fondo con la sua nave. Il vecchio Samuel Insull, passeggiando amabilmente in su e in giù, raccontò la sua vita: da giovane d’ufficio a magnate dell’energia elettrica, la lotta sostenuta per fare del bene, il suo amore per la casa e i bambini. Non negò di aver commesso errori; e chi non ne aveva commessi? ma erano errori onesti. Samuel Insull pianse. Il fratello Martin pianse. Gli avvocati piansero. Con voce soffocata dall’emozione le figure di primo piano dell’affarismo di Chicago testimoniarono tutto quello che Insull aveva fatto a Chicago per il mondo degli affari. Nella giuria nessuno aveva gli occhi asciutti. Messo poi con le spalle al muro dal pubblico ministero, Samuel Insull confessò di aver bensì commesso un errore di circa dieci milioni di dollari nella contabilità, ma era stato un errore onesto. Verdetto: Innocente. Sorridendo fra le lacrime, gli Insull, contenti come pasque, si diressero alla loro berlina fra gli applausi della folla. Migliaia di investitori rovinati – o almeno così dissero i giornali –, che ci avevano rimesso i risparmi di tutta una vita, piansero sui giornali locali al pensiero di tutto quello che aveva sofferto il signor Insull. I banchieri gongolavano, i banchieri avevano allungato le mani sulle sue proprietà. In odore di santità il monarca deposto della superenergia, il giovane d’ufficio che faceva del bene, si gode gli anni del suo declino spendendo la pensione di ventunmila dollari annui che i direttori delle sue vecchie compagnie gli hanno doverosamente ripristinato. Dopo cinquant’anni di lavoro, egli ha detto, la mia opera è (compiuta). 1. Bisogna notare che il testo inglese (Power Superpower) consente
un gioco di doppio significato tra “energia elettrica” e “potenza”. (NdT) 2. Riferimento al già citato proverbio: «Nasce un imbecille al minuto; bisogna trovarlo». (NdT) 3. “Pubblici servizi del Centro-ovest”. (NdT)
Mary French Mary French dovette fermarsi fin tardi all’ufficio e non giunse al salone che quando il comizio era quasi finito. Non c’erano più posti e restò in piedi in fondo. Tanta gente le stava in piedi davanti che lei non poteva veder Don, ma solamente udiva la sua voce aspra e sonora e sentiva la tesa attenzione di tutti nel silenzio delle pause. Quando un rombo d’applausi accolse le ultime parole e il salone si riempì immediatamente di voci e dello scalpitio e stropiccio dei piedi, lei corse fuori prima della ressa su per la viuzza alla porticina di servizio. Don stava appunto uscendo dalla porta di lamiera nera e volgeva il capo sulla spalla a parlare, uscendo, a due delegati dei minatori. Si fermò un attimo a tener spalancata per loro la porta, con un lungo braccio. C’era sul suo viso il sorriso avvampato, e nei suoi occhi lo sfavillio che aveva sovente dopo un discorso: l’aria, si diceva Mary, di un uomo che venisse allora dall’appuntamento con la sua ragazza. Passò un po’ di tempo prima che Don la scorgesse nel gruppo che gli si formò intorno, nella viuzza. Senza guardarla, la raccolse insieme con gli uomini cui stava parlando, nella sua marcia svelta verso l’angolo della via. Occhi li seguivano, mentre loro si allontanavano dai gruppi di lavoratori pellicciai e lavoratori dell’abbigliamento, ch’eran sparpagliati sulla via davanti al salone. Mary vibrava tutta nel senso di caldo possesso, che avevano gli sguardi dei lavoratori seguendo con gli occhi Don Stevens lungo la via. Non fu che quando si trovarono seduti in una piccola trattoria sotto l’aerea che Don si volse a Mary e le serrò la mano. «Stanca?» Mary annuì del capo. «E tu, Don?» Don rise e disse adagio: «No, io non sono stanco. Sono affamato». «Compagna French, mi pare che vi avevamo incaricata di badare a che il compagno Stevens prendesse i suoi pasti regolarmente» disse Rudy Goldfarb con i denti lampeggianti nel fosco viso di tipo meridionale. «Non mangia mai neanche un boccone, quando deve parlare» disse Mary. «Mi rifaccio dopo» disse Don. «Di’, Mary, spero che avrai qualche
soldo. Non credo d’avere in tasca un centesimo.» Mary fece segno di sì, sorridente. «Mamma ha di nuovo mandato» bisbigliò. «Soldi» interruppe Steve Mestrovich. «Dobbiamo trovare soldi, altrimenti siamo suonati.» «Il furgone è partito oggi» disse Mary. «Per questo ho fatto così tardi al comizio.» Mestrovich si passò la grossa mano sudicia sulla faccia lividamente sbiancata, dove un naso tutto pepato di pori neri volgeva bruscamente all’insù. «Se i cosacchi non lo pescano.» «Eddy Spellman è un ragazzo in gamba. Riesce a passare come un’ombra. Non capisco come faccia.» «Voi non sapete cosa voglion dire quegli indumenti, per le donne e i bambini e… sentite bene, compagna French, non buttate via niente, per stracci che siano. Non ci sono stracci più stracci di quelli che i nostri bambini hanno già addosso.» «Eddy ha cinque casse di latte condensato. Ne troveremo altre appena sarà tornato.» «Di’, Mary,» disse Don d’improvviso, levando gli occhi dal suo piatto di brodo «e se telefonassimo a Sylvia? Ho dimenticato di chiedere quanto abbiamo raccolto al comizio.» Il giovane Goldfarb s’alzò. «Telefono io. Avete l’aria stanca, compagna French… Qualcuno ha un nichel?» «Qua, ecco un nichelino» disse Mestrovich. Rigettò indietro il capo e scoppiò a ridere. «Quest’è comica… un minatore che ha un nichel. Giù da noi il minatore lo mette in cornice e lo manda al museo del signor Carnegie… è rarissimo.» Si alzò nel fragore del suo riso e si mise in testa il berretto nero a visiera lunga, da minatore. «Buona notte, compagno, vado a piedi a Brooklyn. Comitato di soccorso alle nove… va bene compagna French?» Mentre camminava verso la porta, il passo massiccio degli stivali neri faceva tintinnare sui tavolini le zuccheriere. «Dio mio» Disse Mary, mentre le venivano d’un tratto le lacrime agli occhi. «Era l’ultimo nichel che aveva.» Goldfarb ritornò dicendo che la colletta non aveva reso molto. Sessantanove dollari e qualche pegno. «Si avvicina Natale… lo sapete. Sono tutti in bolletta a Natale. » «Che discorso schifoso ha fatto Henderson» brontolò Don. «Diventa ogni giorno più
nazionalsocialista.» Mary sedeva con loro sentendo la stanchezza in tutte le ossa del corpo, in attesa che Don fosse pronto a rientrare. Era troppo insonnolita per seguire quello di cui parlavano, ma di tanto in tanto queste parole: comitato centrale, espulsioni, oppositori, separatisti, le urtavano le orecchie. Poi, ecco che Don le batteva sulla spalla e lei si svegliava e gli camminava a fianco lungo le vie buie. «È curioso, Don,» diceva Mary «mi vien sempre sonno quando voi parlate della disciplina del partito. Forse è perché non mi piace sentirne parlare.» «Non serve a niente farci i sentimentali» disse Don selvaggiamente. «Ma è forse da sentimentali provar maggiore interesse per il salvataggio delle unioni dei minatori?» disse lei, ritrovandosi repentinamente ben sveglia. «Va da sé che tutti crediamo in questo, ma dobbiamo seguire le direttive del partito. Troppi di quei ragazzi… Goldfarb è uno… Ben Compton un altro… credono che questa sia un’accademia di discussione. Se non stanno più che attenti, finiranno di trovarsi fuori, col sedere per terra… Vedrai.» Una volta che furono giunti traballando in cima alle cinque rampate, nell’alloggetto sporco dove Mary aveva sempre contato di appendere le tendine, senza mai trovare il momento, Don cedette di botto alla fatica e si buttò sul letto e prese sonno senza nemmeno levarsi le scarpe. Mary cercò di scuoterlo ma lasciò perdere. Gli slacciò lei le scarpe e gli gettò sopra una coperta, e poi si mise a letto tentando di pigliar sonno. Fissava gli occhi sbarrati, contava vecchie paia di calzoni, laceri capi di mutande di lana, vecchie camicie militari senza maniche, calze bucate che non appaiavano. Vedeva i bimbi rachitici dalle pance gonfie attraverso i cenci; le donne smagrite e arruffate, contorte le mani dal lavoro; i ragazzi martellati e insanguinati sul cranio dalle mazze degli uomini della Coal and Iron; la fotografia del cadavere di un minatore bucherellato dalle pallottole di mitragliatrice. Scese dal letto e bevve due o tre sorsate dalla bottiglia di gin che teneva nell’armadio medicine del bagno. Il gin le arse la gola. Tossendo Mary ritornò nel letto e sprofondò in un sonno bollente, senza sogni. Verso il mattino Don la destò entrando nel letto. Le diede un bacio.
«Cara, ho caricato la sveglia per le sette… Svegliami, mi raccomando. Ho un’adunanza di comitato importantissima… Mi raccomando, svegliami.» E ricadde subito addormentato, come un bimbo. Mary giaceva accanto a quel corpo scarno dalle grandi ossa, ascoltandone il respiro regolare, con un senso di felicità e sicurezza là nel letto, insieme a lui. Eddy Spellman riuscì ancora una volta a passare col suo furgone e distribuire la roba a diverse sezioni minerarie in sciopero nel distretto di Pittsburgh, benché andasse a brucio quando gli agenti gli tesero un agguato presso Greensburg. E l’avrebbero colto, se un tale di sua conoscenza – un contrabbandiere d’alcool – non gli apriva l’occhio. Il medesimo contrabbandiere l’aiutò a cavarsi da un nevaio dov’era slittato sulla via del ritorno scendendo la collina verso Johnstown. Eddy ne rideva ancora, mentre aiutava Mary a far su il nuovo carico. «Voleva darmi dell’alcool… È un tipo simpatico, lo credereste, signorina Mary?… Un poco brusco… quel mestiere inasprisce, certo… ma è una perla quando lo si conosce… “Diavolo no, Ed,” – si chiama anche lui Ed – gli dico quando ha cercato di rifilarmi un litro “non bevo più un goccio fin dopo la rivoluzione e anche allora toccherò talmente il cielo col dito che non ne avrò bisogno”.» Mary rideva. «Dovremmo far tutti così, Eddy… Ma certe notti, mi sento così stanca e scoraggiata.» «Sì» disse Eddy, facendosi serio. «Butta giù pensare che gli altri hanno tutte le armi e i quattrini e noi niente.» «C’è una cosa che vi faremo avere, compagno Spellman, ed è un paio di guanti caldi e un buon pastrano prima che vi mettiate di nuovo in viaggio.» Il viso lentigginoso di Eddy arrossì fino alle radici dei capelli rossi. «Ma davvero, signorina Mary, non ho freddo. A dirvi la verità il motore scalda talmente in questa vecchia trappola che mi tiene al caldo, per freddo che faccia… Finito quest’altro viaggio dovrò far cambiare l’innesto e ci vorrà per questo più quattrini che non si possa farne uscire dal latte… Vi so dire che le cose van male nei campi carboniferi quest’inverno.» «Ma i minatori hanno mostrato uno spirito così stupendo» disse Mary.
«Il brutto è, signorina Mary, che lo spirito non si può tener su più che tanto, con lo stomaco vuoto.» Quella sera Don passò all’ufficio per accompagnare Mary a cena. Era assai gaio e il suo viso sparuto e ossuto mostrava più colorito del solito. «Ebbene, piccola, che ne diresti se traslocassimo a Pittsburgh? Dopo il comizio plenario, potrei girare e organizzare un po’ la Pennsylvania occidentale e l’Ohio. Mestrovich dice che laggiù hanno bisogno di qualcuno che li scuota un po’.» Eddy Spellman levò gli occhi da una balla d’indumenti che stava legando. «Vi dico io, compagno Stevens, ne hanno bisogno sì.» Mary sentì attraversarsi da un gelo. Don certamente notò il pallore che la invadeva. «Non ci saranno rischi» aggiunse in fretta. «Questi minatori sanno guardare i compagni, vero, Eddy?» «Sanno sì… Dovunque la sezione è abbastanza in forze, sarete più al sicuro che non siate qui a New York.» «Comunque» disse Mary, la gola tesa e disseccata «se devi andare, devi andare.» «Voi due andate a cenare» disse Eddy. «Io finisco… tanto me la dormo qui. Salva la spesa di un altro buco… Fatela mangiare bene la signorina Mary, compagno Stevens. Non abbiamo nessun bisogno che si ammali… Se tutti i veri membri del partito lavorassero come lei, avremmo… diavolo, avremmo una rivoluzione coi fiocchi entro questa primavera.» Uscirono ridendo e s’incamminarono per Bleecker Street e sedettero felici a un tavolino in una trattoria italiana e ordinarono il pranzo da settantacinque cents e una bottiglia di vino. «Hai trovato in Eddy un grande ammiratore» disse Don, sorridendole attraverso il tavolino. Quindici giorni dopo, Mary rientrò in una agghiacciata sera invernale e trovò Don occupato a far la valigia. Non poté trattenersi dal cacciare un grido, i suoi nervi ogni giorno era più difficile dominarli. «Oh, Don, non sarà già a Pittsburgh?» Don crollò il capo e continuò il lavoro. Quando ebbe serrato la valigia di vimini, le si fece incontro e le posò il braccio intorno alla spalla. «Mi tocca di attraversare l’oceano con… tu sai chi… interessi essenziali del partito.»
«Oh, Don, vorrei tanto venire anch’io. Non sono mai stata in Europa né in nessun posto.» «Starò via solo un mese. Salpiamo a mezzanotte… e tu, Mary cara… se qualcuno mi cerca, io sono a Pittsburgh, capisci?» Mary si mise a piangere. «Dovrò dire che non so dove sei… Non mi riesce mai di raccontare una bugia.» «Cara Mary, saranno pochi giorni… non fare la sciocchina.» Mary sorrise fra le lacrime. «Ma io sono… io sono una gran sciocchina.» Don le diede un bacio e le batté leggermente sulla spalla. Poi sollevò la valigia e scappò fuori della stanza con un grosso berretto a scacchi tirato sugli occhi. Mary passeggiava innanzi e indietro nella stanza angusta, con le labbra spasimanti, lottando per soffocare i singhiozzi isterici. Per avere qualcosa da fare si mise a studiare come poteva venir rifatto l’alloggio perché non avesse più quell’aria squallida, al ritorno di Don. Tirò fuori il letto e lo spinse davanti alla finestra come un divano. Poi vi tirò innanzi il tavolo e intorno al tavolo dispose le sedie. Decise che avrebbe verniciato di bianco il legno e scelto tendine paonazze. L’indomani mattina aveva bevuto metà del suo caffè in una tazza screpolata senza piattino, e si sentiva amaramente sola nell’alloggio deserto, quando trillò il telefono. A tutta prima, non riconobbe di chi fosse quella voce. Rimase confusa e balbettava: «Con chi parlo, prego?» dentro il ricevitore. «Ma, Mary,» diceva quella voce in tono esasperato «devi sapere chi sono. Parla Ben Compton… bi e enne… Ben. Ho bisogno di vederti per una cosa. Dove possiamo trovarci? Non lì da te.» Mary tentò di non avere una voce secca e gelida. «Oggi debbo trovarmi fuori. Debbo far colazione con una tale che forse darà qualcosa per i minatori. È un’orribile perdita di tempo, ma non posso farne a meno. Non contribuirà un centesimo se non ascolto tutta la sua triste storia. Ti va di trovarci davanti alla biblioteca pubblica alle due e mezzo?» «Sarà meglio dentro… È quasi allo zero oggi. Mi alzo adesso dall’influenza.» Mary quasi non riconosceva Ben, tanto invecchiato appariva. Aveva del grigio nei capelli che gli spuntavano disordinati da sotto il berretto. Si curvò e la fissò nel viso dolentemente attraverso gli occhiali spessi. Non le diede la mano. «Dunque, tanto vale che te lo dica subito… lo saprai quanto prima, se già non lo sai… Sono stato
espulso dal partito… oppositore… obiettore… tutte queste balle… Be’, non importa nulla, sono sempre un rivoluzionario… continuerò a lavorare al difuori del partito.» «Oh, Ben, quanto mi dispiace.» Mary non seppe dir altro. «Sai che son sempre all’oscuro di tutto, eccetto quel che leggo nel “Daily”. Mi pare una cosa spaventosa.» «Usciamo fuori, il guardiano ci osserva.» All’esterno Ben cominciò a rabbrividire dal freddo. Gli sporgevano i polsi rossi dal soprabito verde e consunto, a maniche troppo corte per le sue lunghe braccia. «Dove possiamo andare?» badava a ripeter Mary. Alla fine entrarono in un distributore automatico a fior di strada e sedettero, parlando a voce sommessa tra un sorso e l’altro di caffè. «Non volevo venire a casa tua, perché non volevo incontrarmi con Stevens… Io e Stevens non siamo mai stati amici, lo sai… Adesso si è messo con quelli del Comintern. Formerà il comitato centrale, una volta che avranno spazzato via tutti quelli che hanno una testa per ragionare.» «Ma, Ben, si può avere opinioni differenti e lo stesso…» «Un partito di “signorsì”… sarà proprio una bellezza… Ma, Mary, io avevo bisogno di vederti, mi sono sentito d’un tratto così solo… tu sai, tagliato fuori da tutto… Sai che se non fossimo stati degli stupidi avremmo avuto allora quel bambino… adesso ci vorremmo ancora bene… Mary, sei stata tanto buona con me quand’ero appena uscito dal carcere… E dimmi un po’, dov’è la tua amica Ada, quella musicista che aveva quell’appartamento di lusso?» «Oh quella è sempre la stessa stupida… corre in giro con non so che violinisti.» «Ho sempre amato la musica… Avrei dovuto conservarti, Mary.» «Molta acqua è passata da allora sotto i ponti» disse Mary freddamente. «Sei felice con Stevens? Non ho il diritto di domandartelo.» «Ma Ben, a che serve rivangare tutti questi vecchiumi?» «Vedi, tante volte uno giovane pensa: sacrifico ogni cosa; e poi quand’è tagliato via da tutto quel lato della vita, non si sente più forte come nel passato, mi capisci? Per la prima volta in vita mia, manco di
contatti. Pensavo che forse tu eri in grado, in qualche modo, di farmi lavorare nel soccorso. La disciplina non è tanto rigida nelle organizzazioni di soccorso.» «Non credo che abbiano bisogno di influssi separatisti nell’ILD» disse Mary. «Così, anche per te sono un separatista?… E va bene, verrà un giorno che i lavoratori giudicheranno tra noi.» «Non parliamo di questo, Ben.» «Vorrei che sottoponessi la cosa a Stevens e gli chiedessi di tastar terreno dove di dovere… non mi sembra di chieder molto, no?» «Ma Don non c’è attualmente.» Non fece a tempo di trattenersi, che l’aveva spiattellato. Ben la fissò negli occhi con una repentina occhiata vivace. «Non s’è per caso imbarcato alla volta di Mosca, con certi altri compagni?» «È andato a Pittsburgh con un incarico segreto del partito e, in nome di Dio, piantala con questa storia. Tu mi hai cercata soltanto per farmi parlare.» Mary scattò in piedi, col viso in fiamme. «Tanti saluti, signor Compton… Non sarete mica una spia, oltre che un separatista, spero?» Il volto di Ben Compton si sfasciò di colpo, a quel modo che fa il volto di un bimbo quando sta per piangere. Era là seduto, fissandola, raschiando insensato il cucchiaino intorno intorno nella tazza vuota. Mary era a mezza scala, quando d’impulso ridiscese e rimase un secondo a guardare la testa abbassata di Ben. «Ben» disse con voce più dolce «non avrei dovuto dir questo… senza prove… Non credo sia vero.» Ben Compton non sollevò il capo. Mary risalì le scale uscendo nel vento tagliente, si precipitò per la Quarantaduesima Strada nella calca pomeridiana e prese la sotterranea diretta in Union Square. L’ultimo dell’anno Mary French ricevette un telegramma all’ufficio, da parte di Ada Cohn. PREGO COMUNICA MAMMA IN CITTÀ AL PLAZA PARTE PER EUROPA VUOLE VEDERTI IGNORA INDIRIZZO CHE DEBBO DIRLE. Il giorno di Capodanno non ci fu molto da fare all’ufficio. Mary era stata la sola a venirci e così a metà della mattina telefonò al Plaza e chiese della signora French.
Nessuno che rispondesse a quel nome era là. Poi telefonò ad Ada. Ada non smetteva più di parlare e come la mamma di Mary si era risposata con un certo giudice Blake, un personaggio molto in vista, giudice federale a riposo, un uomo così simpatico con la barbetta bianca a punta; e lei Ada doveva vedere lei Mary, la signora Blake era stata così buona con lei e l’avevano invitata a pranzo al Plaza e volevano esser messi al corrente di tutto quanto faceva Mary e lei aveva dovuto ammettere che non si vedevano mai benché fosse la sua più cara amica; lei era stata a una veglia di fine d’anno e aveva una tale emicrania che non poteva suonare, aveva invitato gente molto simpatica per il pomeriggio, non voleva venire, Mary? le sarebbero certamente piaciuti. Quasi quasi Mary le riattaccava il ricevitore in faccia, tant’era insulsa quella cicalata, ma disse che l’avrebbe richiamata non appena parlato con sua madre. Finì che se ne tornò a casa, indossò il suo abito più bello e si recò al Plaza a incontrare il giudice e la signora Blake. Cercò qualche luogo dove farsi arricciare la testa, perché sapeva che prima cosa sua madre avrebbe detto che faceva spavento, ma dappertutto era chiuso per via di Capodanno. Il giudice e la signora Blake si disponevano a far colazione in un grande salotto d’angolo riservato, che guardava le gibbose collinette di neve del parco, irte di rami brulli e intersecate di rapide, luccicanti correnti di traffico. La mamma di Mary non sembrava invecchiata di un sol giorno, vestiva di verdecupo e davvero appariva stupenda con un candido colletto pieghettato intorno al collo seduta là tanto comodamente, con anelli alle dita i quali scintillavano nella grigia luce invernale che entrava per i finestroni. Il giudice aveva una morbida voce carezzevole. Parlò elaboratamente della figliuola prodiga e del vitello grasso finché sua madre non l’interruppe per dire che andavano in Europa a spassarsela; tutti e due avevan fatto nello stesso giorno grossi colpi in Borsa e s’erano accorti di meritare finalmente un po’ di riposo e di svago. E continuò accennando quanto l’aveva fatta soffrire che tutte le sue lettere venissero respinte dall’ultimo indirizzo di Mary; che aveva scritto più e più volte ad Ada e Ada rispondeva sempre che Mary si trovava a Pittsburgh o Fall River o in qualche altro
luogo impossibile, intenta a far lavoro sociale, e che ormai le pareva tempo che smettesse di pensare soltanto ai poveri e ai derelitti e dedicasse un po’ delle sue cure anche a quelli di casa. «Sento che sei una signorina assai temibile, mia cara Mary» disse il giudice, blando, scodellandole nel piatto un po’ di crema di sedano. «Spero che non avrai portato bombe con te.» Parvero tutti e due convinti che fosse una battuta assai spiritosa e risero, risero. «Ma per parlare più seriamente» continuò il giudice «so che la diseguaglianza sociale è una cosa molto grave e getta un’ombra sul bel nome della democrazia americana. Però più s’invecchia, mia cara, più s’impara a vivere e lasciar vivere, e che bisogna sapersi accontentare di prendere il brutto col bello.» «Mary cara, perché non vai un poco all’estero con Ada Cohn, a pigliarti un bel riposo?… Troverò io il denaro per il viaggio. Sono certa che ti farà bene… Tu sai che non ho mai approvato la tua amicizia con Ada Cohn. Laggiù da noi siamo forse un poco antiquati in queste cose. Qua sembra che la ricevano dappertutto. Di fatto sembra che conosca tutti i personaggi più in vista del mondo musicale. Quanto poi valga come musicista naturalmente io non sono in grado di giudicare.» «Cara Hilda,» disse il giudice «Ada Cohn ha un cuore d’oro. Trovo ch’è una piccina assai cara. Suo padre era un distintissimo avvocato. Ricordati che abbiamo deciso di lasciare un poco da parte i nostri pregiudizi… non è vero, cara?» «Il giudice mi sta emendando» rise timidamente la madre di Mary. Mary era così nervosa che s’accorse di esser sul punto di strillare. Il pesante cibo imburrato, le delicate attenzioni del cameriere, la simpatia paterna del giudice, quasi la facevan recere. «Guarda, Mamma,» disse «se davvero hai qualche soldo d’avanzo, potresti darmi qualcosa per il nostro fondo del latte. Dopo tutto i bimbi dei minatori non ne hanno nessuna colpa.» «Mia cara, ho già dato considerevoli contributi alla Croce Rossa… Dopo tutto, abbiamo avuto sulle spalle uno sciopero minerario nel Colorado ben peggio che quello di Pennsylvania… Ho sempre pensato, cara Mary, che se i tuoi interessi vanno alle condizioni del
lavoro, il tuo posto è laggiù a Colorado Springs. Se proprio devi fare studi su queste cose, non c’era assolutamente bisogno di venirli a fare nell’Est.» «Persino l’IWW ha tornato a drizzare la sua testa deforme» disse il giudice. «Non approvo affatto la tattica dell’IWW» disse Mary duramente. «Voglio sperare» disse sua madre. «Mamma, non credi proprio di potermi prestare un paio di biglietti da cento?» «Per spenderli con questi odiosi agitatori? può darsi che non siano non-voglio-lavorare, 1 ma valgono altrettanto.» «Ti prometto che fin l’ultimo centesimo va in latte per i bambini.» «Ma così non si fa che dare i minatori in mano a quei miserabili agitatori russi. È naturale che, se distribuiscono il latte ai bambini, ciò li rende popolari, li mette in una posizione in cui possono ingannare peggio che mai quei poveri diavoli di emigrati.» Il giudice si piegò innanzi attraverso il tavolo e posò la sua mano azzurrovenata dal candido polsino inamidato sulla mano della madre di Mary. «Non voglio dire che noi manchiamo di simpatia per la condizione delle donne e dei bambini dei minatori o che non comprendiamo la terribile situazione dell’intera industria mineraria… ne sappiamo in ogni senso anche troppo, non è vero, Hilda? Ma…» Mary s’accorse a un tratto che aveva piegato il tovagliolo e s’era alzata in piedi tremando. «Non vedo ragione di continuare questo colloquio, che deve esser penoso per te, Mamma, come è per me…» «Potrei forse arbitrare» disse il giudice, sorridente, alzandosi col tovagliolo in mano. Mary ebbe la sensazione di una stretta disperata come d’un cerchio di metallo intorno al capo. «Debbo andarmene, Mamma… Oggi non sto troppo bene. Fa’ buon viaggio… non voglio discutere.» Prima che potessero fermarla, era già nel corridoio e poi dentro l’ascensore che scendeva. Mary era talmente sconvolta che sentì il bisogno di parlare con qualcuno e così entrò in una cabina telefonica e chiamò Ada. La voce di Ada era rotta dai singhiozzi, diceva ch’era accaduta una cosa
spaventosa, che aveva già disdetto il ricevimento e lei Mary doveva venir subito da lei. Prima ancora che Ada le aprisse l’uscio dell’appartamento di Madison Avenue, a Mary giunse una zaffata del profumo Forêt Vierge che Ada aveva adottato fin dai primi giorni ch’era a New York. Ada aprì l’uscio avvolta in una vestaglia di seta verde e rosa, a fiorami, donde penzolavano ogni sorta di fiocchetti. Cadde al collo di Mary. Aveva gli occhi rossi e tirava su dal naso parlando. «Dunque, che cosa c’è, Ada?» domandò Mary, fredda. «Cara, ho avuto ora la più spaventosa delle liti con Hjalmar. Ci siamo lasciati per sempre… E così ho dovuto disdire il ricevimento perché lo davo per lui.» «E chi è Hjalmar?» «È qualcuno così bello… e così cattivo… Ma parliamo di te, Mary cara… Spero che l’avrai aggiustata con tua madre e il giudice Blake.» «Li ho piantati e son venuta via… A che serve discutere? Loro sono da una parte delle barricate e io dall’altra.» Ada andò a gran passi su e giù per la stanza. «Non posso sentir dire queste cose… Mi sconvolgono tutta… Almeno, berrai qualcosa… Io bisogna che beva, son stata troppo nervosa, per suonare ancora.» Mary si fermò da Ada tutto il pomeriggio, bevendo cicchetti, mangiando i panini imbottiti e i tortellini ch’eran stati preparati in cucina per il ricevimento, e discorrendo dei tempi passati e di quell’infelice amore di Ada. Ada fece leggere a Mary tutte le lettere di lui e Mary disse ch’era un solennissimo idiota e meno male che se n’era andato. Allora Ada si mise a piangere e Mary le chiese se non aveva vergogna, lei non sapeva nemmeno dove stesse di casa la sventura vera. Ada stette a sentire assai contrita e andò alla scrivania e firmò senz’altro con la mano tremante un assegno di cento dollari per il fondo del latte dei minatori. Ada fece portare su per tutte e due un po’ di cena dal vicino Longchamps, e dichiarò che quello era il più felice pomeriggio che avesse passato da anni. Si fece promettere che Mary sarebbe venuta al suo concerto nel piccolo salone dell’Aeolian la settimana dopo. Quando Mary fu per andarsene, Ada le fece accettare un paio di dollari per il tassì. Tutte e due erano un po’ vacillanti, in attesa dell’ascensore, nel corridoio. «Siamo riuscite a fare una coppia
di vecchie beone» disse Ada allegra. Fu un bene che Mary avesse deciso di prendere un tassì, perché le riusciva difficile tenersi in piedi. Quell’inverno la situazione dei minatori nel distretto di Pittsburgh si fece sempre più triste. Cominciarono gli sfratti. Famiglie con bambini piccoli vivevano sotto le tende e in cadenti baracche di carta incatramata prive di riscaldamento. Mary viveva entro un senso d’incubo, scrivendo lettere, mimografando appelli, tenendo discorsi in comizi di lavoratori sarti e pellicciai, sollecitando liberali danarosi. Il denaro che entrava non era mai abbastanza. Lei non riceveva stipendio per il suo lavoro e così dovette farsi imprestare soldi da Ada per pagare la pigione. Era sottile e scarna, e tossiva continuamente. Troppe sigarette, spiegava. Eddy Spellman e Rudy Goldfarb se ne inquietavano. Mary s’accorse che avevano conchiuso che lei non mangiava abbastanza, perché trovava sempre sull’angolo della scrivania dei panini in un sacchetto di carta o una tazza di caffè, che uno dei due le aveva portato. Una volta Eddy le portò un dolce in un grande involucro, che sua madre, vicino a Scranton, aveva preparato con le sue mani. Mary non riuscì a mangiarlo e si sentiva colpevole ogni volta che lo vedeva coperto di muffa verde nella ghiacciaia dove non c’era più ghiaccio, perché aveva smesso di far cucina ora che Don era via. Una sera Rudy entrò nell’ufficio, tutto sorrisi in volto. Eddy era curvo a far su i vecchi indumenti in balle come al solito, per il prossimo viaggio. Rudy gli tirò un calcio leggero nel fondo della schiena. «Ehilà, trockista» disse Eddy, saltandogli addosso e strappandogli fuori la cravatta. «Si sorride quando si dice così» disse Rudy tempestandolo di pugni. Ridevano tutti quanti. Mary si sentì come una vecchia maestra zitella che osserva i ragazzi imperversare davanti alla cattedra. «L’ordine ritorna nell’adunanza» s’intromise. «Han cercato di farmela, ma non ci sono riusciti» disse Rudy ansante, riaggiustandosi la cravatta e i capelli in disordine. «Ma quel che stavo per dire, compagna French, era che ho pensato che vi interessasse sapere che un certo compagno arriva domani con l’Aquitania… in classe turistica.» «Rudy, ne siete certo?» «Ho veduto il cablogramma.» Mary giunse al porto troppo presto e dovette aspettare due ore.
Tentò di leggere i giornali del pomeriggio ma i suoi occhi non tenevano dietro alle righe. Faceva troppo caldo nella sala d’aspetto e fuori troppo freddo. Si dibatteva in una disperata irrequietezza finché finalmente vide l’enorme parete fosca di lamiera scivolare lungo gli sportelli dello scalo con le sue file di finestrini illuminati. Aveva diacci le mani e i piedi. Tutto il corpo le doleva dall’ansia di sentirsi circondata da quelle braccia, di udir nelle orecchie l’asprezza di quella voce profonda. Per tutto il tempo una vaga inquietudine le trepidò in fondo all’anima, perché non aveva ricevuto da lui una sola lettera in tutto il tempo ch’era stato lontano. E d’un tratto eccolo là che scendeva dalla passerella reggendo in una mano la vecchia valigia di vimini. Aveva indosso un nuovo impermeabile tedesco a cintura ma lo stesso berretto a scacchi. Eccoli a faccia a faccia. Le diede un piccolo abbraccio, ma non la baciò. C’era qualcosa di strano nella sua voce. «Ciao, Mary… non mi aspettavo di trovarti qui… Non vorrei essere notato, capisci.» Quella voce aveva un impercettibile suono furtivo alle orecchie di Mary. Don cambiava nervosamente di mano la valigia. «Ci vediamo a giorni… Avrò da fare assai.» Mary si volse senza una parola e corse via per lo scalo. Si precipitò trafelata per la via trasversale alla volta dell’aerea della Nona Avenue. Quando spalancò l’uscio di casa, le nuove tendine paonazze le diedero negli occhi come una staffilata. Non poteva ritornare all’ufficio. Non poteva reggere al pensiero di far fronte ai compagni e alla gente che conosceva, a quelli che li avevano conosciuti insieme. Telefonò dicendo che aveva un brutto attacco d’influenza e le toccava stare in letto un paio di giorni. Rimase tutta la giornata nel deserto squallore di quelle stanze anguste. Verso sera s’andava assopendo sul divano. Si destò di soprassalto parendole di aver udito un passo fuori nel corridoio. Non era Don, i passi continuarono a salire la rampata successiva. Da quel momento, non dormi più. L’indomani mattina il telefono la svegliò, proprio mentre si stava disponendo nel letto a sonnecchiare un poco. Era Sylvia Goldstein che si diceva spiacente che Mary avesse l’influenza e domandava se poteva far nulla. Oh no, era a posto, sarebbe soltanto rimasta in letto
tutto il giorno, rispose Mary con una voce morta. «Certamente sapevi del compagno Stevens e della compagna Lichfield… eravate così intimi… si sono sposati a Mosca… lei è una compagna inglese… ha parlato al gran comizio del Casino di Bronx ieri notte… ha un grande ciuffo di capelli rossi… una meraviglia, però qualche compagna dice che sono tinti. Molti di noi non sapevamo che tu e il compagno Stevens aveste rotto… non è triste che nel movimento debbano succedere di queste cose?» «Oh roba passata… Addio, Sylvia» disse Mary aspramente e riattaccò. Telefonò a un contrabbandiere di sua conoscenza e gli disse di mandarle una bottiglia di gin. L’indomani pomeriggio si sentì un leggero busso alla porta e, quando Mary schiuse di una fessura, eccoti Ada avvolta in una volpe argentata e spirante una gran raffica di Forêt Vierge. «Mary, tesoro, lo sapevo che c’era qualcosa… Certe volte sono una vera medium. E quando non ti ho veduta al mio concerto, prima son stata fuori di me, ma poi mi sono detta: certo quella povera ragazza è malata. E allora senz’altro vado al tuo ufficio. Ci ho trovato un giovanotto così bello e semplicemente mi son fatto mostrare dove stavi. Ha detto che avevi l’influenza e così son corsa subito. Ma, cara mia, perché non sei a letto? Hai una faccia…» «Sto benissimo» brontolò Mary sordamente, ricacciandosi dal volto i capelli che parevano tante corde. «Facevo… facevo progetti… come meglio si possa organizzare questa campagna di soccorso.» «Insomma, adesso vieni subito con me nella mia stanza libera e lascerai che ti curi un po’ io… Non credo sia l’influenza, dev’essere il troppo lavoro… Se non stai attenta, finirai con un esaurimento nervoso.» «Qualcosa di simile magari.» Mary non articolava più bene le parole. Non pareva avesse più forza alcuna di volontà; fece tutto ciò che le diceva Ada. Quando fu collocata in quel letto libero di Ada, lindo e profumato alla lavanda, mandarono a cercare un po’ di barbital, che la fece dormire. Mary restò là parecchi giorni mangiando i pasti che la cameriera di Ada le portava, bevendo tutto quel che Ada le propinava, in ascolto del continuo miagolio degli esercizi di violino, che veniva per tutta la mattinata dalla stanza vicina. Ma, la notte, non poteva dormire se non si riempiva di droga. Non pareva le restasse
più volontà. Ci metteva mezz’ora per decidersi a scendere e andare al gabinetto. Dopo che fu stata una settimana con Ada, cominciò a pensare che doveva tornare a casa. Cominciò a farsi insofferente delle allusioni traverse di Ada agli amori infelici, ai cuori infranti, e alla bellezza dell’abnegazione, e le tagliava la frase in bocca ogni volta che quella cominciava. «Buon segno» diceva Ada. «Ritorni maligna com’eri.» Da qualche tempo Ada s’ingegnava di far cadere il discorso su qualcuno di sua conoscenza che era stato pazzo di Mary anni e anni e moriva dalla voglia di rivederla. Alla fine Mary cedette e accettò di andare a un cocktail-party in casa di Eveline Johnson dove Ada diceva di esser certa che lui sarebbe venuto. «Eveline dà delle riunioni magnifiche. Non so come ce la faccia, perché non ha mai un soldo, ma si può esser certi che ci sarà la gente più interessante di New York. Ci sono sempre tutti. Anche i radicali, sai. Eveline non può vivere senza il suo gruppetto di rossi.» Mary indossò uno degli abiti di Ada che però non le andava troppo bene e uscì nella mattinata per farsi arricciare la testa al Saks dove andava sempre Ada. Presero qualche cocktail in casa di Ada, prima di mettersi in cammino. All’ultimo istante Mary disse che non veniva più, perché aveva finalmente strappato ad Ada che era George Barrow quello che si sarebbe trovato alla riunione. Ada le fece bere un altro cocktail e un senso di temeraria indifferenza allora la prese, e disse: «Va bene, vediamo il seguito». C’era alla porta una ridente cameriera negra, dall’elegante crestina e grembiale di pizzo, che le condusse per il corridoio in una camera da letto piena di soprabiti e pellicce, dove anche loro dovevan togliersi i mantelli. Mentre Ada si rifaceva il viso alla toeletta, Mary le bisbigliò all’orecchio: «Pensa soltanto tutto quello che il comitato di Soccorso potrebbe fare coi denari che questa donna spreca in questi sciocchi ricevimenti». «Ma è così simpatica» bisbigliò Ada tutta eccitata. «Sul serio, vedrai che ti piacerà.» S’era aperto l’uscio alle loro spalle schiudendo come una raffica un baccano di voci, risate, tintinnio di bicchieri, un buffo di profumi, di crostini, di sigaretta e di gin. «Oh Ada» fece una voce sonora. «Cara Eveline, come siete affascinante…
Ecco Mary French, ricordate che vi dissi che l’avrei portata… È la mia più antica amica.» Mary si trovò che stringeva la mano a una donna alta e slanciata in abito grigioperla. Aveva il viso assai bianco e le labbra assai rosse e gli occhi lunghi e grandi esagerati dal trucco. «Proprio gentile a venire» disse Eveline Johnson, e sedette di colpo fra le pellicce e i mantelli del letto. «Un bel ricevimento, a giudicare da quanto sento» esclamò Ada. «Odio i ricevimenti. Non capisco perché ne do ancora» disse Eveline Johnson. «Dunque, immagino che debbo tornare al serraglio… Ah Ada, sono talmente stanca.» Mary si trovò che studiava le aspre rughe disperate nascoste sotto il belletto intorno alla bocca e la sforzata tensione delle corde del collo della signora Johnson. È la vita stupida che fanno a conciarle così, diceva a se stessa. «E che ne è del dramma?» domandava Ada. «Mi ha tanto interessato, quando ne ho sentito parlare.» «Oh, quest’è storia antica ormai» disse Eveline Johnson, seccamente. «Lavoro a un’idea per trapiantare qui il balletto… farne qualcosa di americano… Un altro momento ve ne parlerò.» «Dite, Eveline, è venuta la stella?» domandò Ada con un ghignetto. «Oh sì, quelle vengono sempre.» Eveline Johnson trasse un sospiro. «È così bella… Dovete conoscerla.» «Certo qualunque persona al mondo verrebbe ai vostri ricevimenti, Eveline.» «Non capisco perché… a me sembra una tal seccatura.» Eveline Johnson le stava introducendo per certe porte scorrevoli in una sala dall’alto soffitto, oscurata dalle lampade a paralume e dal fumo di sigaretta, dove vennero inghiottite in una ressa di gente elegante che discorreva, faceva smorfie e agitava la testa sopra bicchieri di cocktail. Non pareva ci fosse posto per stare in piedi e allora Mary sedette all’estremità di un divano accanto a un tavolinetto di marmo. Le altre persone del divano ciarlavano tra loro e non le prestarono alcuna attenzione. Ada e la padrona erano scomparse dietro una parete di abiti neri e vestiti da pomeriggio. Mary ebbe il tempo di fumare un’intera sigaretta prima che
tornasse Ada seguita da George Barrow, il viso sottile del quale appariva animato e il pomo d’Adamo più che mai sporgeva sopra il colletto. Aveva in ciascuna mano un cocktail. «Ma come, come, come, piccola Mary French, dopo tutti questi anni» badava a dire con una specie di chiasso forzato. «Sapeste che fatica mettere le mani su questi attraverso la calca.» «Salve, George» disse Mary con noncuranza. Prese il cocktail che le porgeva e se lo buttò in gola. Dopo gli altri bicchieri che aveva già bevuto, questo le fece girare il capo. In qualche modo George e Ada riuscirono ad entrare sul divano, appiattandosi a ciascun lato di Mary. «Voglio sapere ogni cosa dello sciopero del carbone» disse George corrugando le sopracciglia. «È un peccato che le sezioni in lotta siano andate a scegliere proprio il momento in cui uno sciopero diceva contro l’opera dei rappresentanti.» Mary s’irritò. «Questa è proprio l’osservazione che mi sarei attesa da un uomo come voi. Se aspettassimo il momento favorevole, non ci sarebbero mai scioperi… Non è mai il momento favorevole per i lavoratori.» «Che tipo d’uomo è un uomo come me?» domandò George Barrow con falsa umiltà, così parve a Mary. «È ciò che mi domando sovente.» «Oh, non ho voglia di discutere… Sono stanca e disgustata di discutere… Cercatemi un altro cocktail, George.» George si alzò ubbidiente, e cominciò ad aprirsi il passo per traversare la sala. «Via, Mary, non bisticciare col povero George… È così amabile… Lo sai, che c’è davvero Margo Dowling… e suo marito e Rodney Cathcart… sono sempre insieme. Sono in viaggio per la Riviera.» Ada le parlava nell’orecchio con un forte sussurro da palcoscenico. «Sono disgustata di vedere gli attori sullo schermo,» disse Mary «non ho nessuna voglia di vederli in realtà.» Ada era sgusciata via. Ecco George di ritorno con altri due cocktail e un piatto di salmone freddo e cetrioli. Mary non volle mangiar nulla. «Non credete che vi farebbe bene, con tutto quel che bevete?» Mary scosse il capo. «E allora, mangerò io… Lo credereste, Mary,» continuò «sovente mi sono domandato in questi anni se non sarei vissuto più felice restando per tutta la vita impiegato ferroviario nella South Chicago, sposando qualche simpatica lavoratrice e facendo una serqua
di bambini… Starei meglio come finanze e come salute oggi, mi fossi anche messo negli affari.» «A guardarvi, non sembrate troppo mal ridotto» disse Mary. «Sapete quanto mi faccia male essere attaccato come un opportunista del lavoro da voialtri rossi… Può darsi che io creda nei compromessi, ma è un fatto che vittorie sostanziose in dollari sonanti ne ho riportate… Quel che voi radicali non volete capire è che sovente ci sono due punti di vista.» «Non sono iscritta al partito, io» disse Mary. «Lo so… ma lavorate con loro… Perché poi dobbiate credere di saper voi che cosa ci vuole per i minatori meglio dei loro capi provati e fedeli!» «Se i minatori avessero mai l’occasione di votare nelle loro riunioni, vi accorgereste quanta fiducia nutrano per i vostri venduti.» George Barrow scosse il capo. «Mary, Mary… sempre la stessa ostinata ragazza dal cuore generoso.» «Sciocchezze, non ho più l’ombra di un sentimento. Ho veduto come van le cose sul campo… Non occorre un gran cuore per capire quale estremità del fucile ti puntano addosso.» «Mary, sono un uomo assai infelice.» «Cercatemi un altro cocktail, George.» Mary ebbe il tempo di fumare due sigarette, prima che George tornasse. I visi tentennanti, cicalanti, gli abiti, i gesti delle mani, tutto le fluttuava innanzi agli occhi in un vapore di fumo. La calca cominciava un poco ad assottigliarsi, quando George ritornò animato e sorridente. «Dite, ho avuto il piacere di scambiare qualche parola con la signorina Dowling, era incantevole… Ma sapete quanto mi ha detto Red Haines? Mi domando se può essere vero… Sembra che la sua carriera sia finita; sembra che non valga nulla per il parlato… una voce come il gracchio di una vecchia cornacchia, nell’altoparlante» disse con un risolino brillo. «Eccola là, va via ora.» Nella stanza s’era fatto un silenzio. Entro le spire vertiginose del fumo Mary vide una piccola donna, dalle palpebre azzurre e dalle fattezze regolari come quelle di una bambola di porcellana sotto una massa di capelli biondopallidi, volgersi per un attimo a sorridere verso qualcuno prima di scomparire entro la porta scorrevole. Aveva indosso un abito giallo e una quantità di grossi zaffiri. Un attore
slanciato e bronzeo e un ometto gambestorte e smorto la seguirono, ed Eveline Johnson che parlava, parlava trafelata col suo fare incessante, tenne loro dietro. Mary guardava tutto ciò traverso un velo di brusio come dal fumo della galleria una scena al teatro. Ada venne e si fermò davanti a lei, roteando gli occhi e spalancando la bocca nelle parole. «Un ricevimento meraviglioso davvero… Le ho parlato. Aveva dei modi così fini… Non so perché, mi attendevo che fosse piuttosto grossolana. Dicono che venga proprio dalla strada.» «Non è affatto vero» disse George. «I suoi erano spagnoli di nobile origine, stabiliti a Cuba.» «Ada, voglio andare a casa» disse Mary. «Un minuto solo… Non ho ancora potuto dire una parola alla cara Eveline… Oggi sembra maledettamente stanca e nervosa, poveretta.» Un giovane dal pallore del giglio le sfiorò mentre passava, ridendo, col volto sopra la spalla di una donna più anziana di lui coperta d’un lamé d’argento, che lo seguiva: il magro collo, dove la cipria copriva i bargigli, allungato e il naso adunco tremolante e gli occhi sporgenti sopra borse malcelate. «Ada, voglio andare a casa.» «Credevo che tu ed io e George avremmo cenato insieme.» Mary vedeva facce indistinte ingigantire venendo alla sua volta, mutar di forma passandole accanto, dileguare nell’ombra come pesci che spalancano e chiudon la bocca in un acquario. «Che ne dite? Signorina Cohn, avete veduto da queste parti Charles Edward Holden? Solitamente è l’ornamento delle serate di Eveline.» Mary detestava l’aria caparbia, gli occhi fuori della testa di George Barrow. «Questo sì ch’è una persona intelligente. Gli si può parlare insieme tutta la notte.» Ada aguzzò gli occhi, piegandosi verso George Barrow, e gli sussurrò stridula nell’orecchio: «Si è fidanzato con un’altra. Eveline ha troncato tutto. Si tiene su con la sua forza d’animo». «George, se è necessario che mi fermi…» disse Mary «cercatemi un altro cocktail.» Una donna in lustrini, faccia larga e gote assai rosse, che sedeva sul
divano accanto a Mary, si piegò e disse in un sussurro da palcoscenico: «Non è una cosa orribile?… Sono convinta che questa è nera ingratitudine da parte di Holdy dopo tutto quanto Eveline ha fatto per lui… nel rispetto mondano… da quando se n’è occupata lei… ora è ricevuto dappertutto. Conosco la ragazza… una civetta se altre mai… nemmeno a quattrini». «Sst» fece Ada. «Ecco qui Eveline… Ebbene, cara Eveline, i capitani e i monarchi se ne vanno. Presto non ci sarà più che gentarella come noi.» «Non mi è poi parsa così brillante» disse Eveline lasciandosi cadere su una sedia accanto. «Lasciate che vi cerchi da bere, cara Eveline» disse Ada. Eveline scosse il capo. «Quel che vi occorre, mia cara Eveline» disse quella dalla faccia larga, piegandosi un’altra volta lungo il divano «… è un bel viaggetto all’estero. New York è insopportabile passato gennaio… Io non tenterò nemmeno di restare… Vorrebbe semplicemente dire per me un esaurimento nervoso.» «Pensavo di andare al Marocco una volta o l’altra se trovo i soldi» disse Eveline. «Provate Tunisi, mia cara. Tunisi è divina.» Quand’ebbe bevuto il cocktail che portò Barrow, Mary restò là seduta scorgendo facce, ascoltando voci, in una vacua nube di odio. Ci voleva tutta la sua attenzione per non dondolare sulla sponda del divano. «Debbo proprio andare.» Stava afferrata al braccio di George traversando la stanza. A camminare ce la faceva, ma non ce la faceva a parlare. Nella camera da letto Ada l’aiutava a infilarsi il soprabito. C’era anche Eveline Johnson coi suoi grandi occhi nocciola e la sua cantilena provocante. «Oh, Ada, siete stata troppo buona a venire… Oh, signorina French, volevo tanto parlar con voi dei minatori… Non ho mai un momento per parlare delle cose che davvero m’interessano. Sapete, Ada, credo che non farò mai più nulla di simile… È davvero troppo seccante.» Si portò la lunga mano alla tempia e si sfregò lenta le dita attraverso la fronte. «Ada, spero che se ne vadano presto… Ho un tale mal di capo.» «Ma dovreste prendere qualcosa.»
«Lo farò. Ho un rimedio portentoso. Invitatemi la prossima volta che suonerete Bach, Ada… Mi piace tanto. Capite che è davvero troppo sciocco passar la vita a riempire stanze di gente malassortita che in realtà si detestano a vicenda.» Eveline Johnson li seguì lungo tutto il corridoio fino alla porta d’ingresso come se non volesse lasciarli andar via. Si fermò nel suo abito sottile dentro la folata di vento freddo che entrava dalla porta spalancata, mentre George andava all’angolo a cercare una macchina. «Eveline, rientrate, sarà la vostra morte» disse Ada. «Arrivederci allora… siete state care a venire.» Mentre la porta le si chiudeva adagio dietro, Mary osservò le strette spalle di Eveline Johnson che, risalendo il corridoio, rabbrividiva. Mary barcollò sentendosi repentinamente ubriaca nell’aria gelida e Ada la cinse col braccio, per sostenerla. «Oh Mary,» le disse all’orecchio «quanto vorrei che non fossero tutti così infelici.» «È lo spreco» gridò Mary selvaggiamente, capace a un tratto di articolare. Ada e George Barrow l’aiutavano a salire nel tassì. «Il cibo che sprecano e il denaro che sprecano, mentre il nostro popolo muore di fame nelle baracche di carta incatramata.» «Le contraddizioni del capitalismo» disse George Barrow con una grinta perspicace. «Che ne direste di mangiare un boccone?» «Portate me a casa, prima. No, non da Ada» quasi strillò Mary. «Son nauseata di questa vita da parassiti. Domani ritorno all’ufficio… Stasera bisogna che telefoni per sapere se tutto è andato bene con quel carico di latte condensato…» Raccolse la mano di Ada, sentendosi di botto come ai tempi d’una volta e la strinse. «Ada, sei stata un tesoro, mi hai davvero salvato la vita.» «Ada è la cura perfetta per gente isterica come noi» disse George Barrow. Il tassì s’era fermato accanto alla fila delle pattumiere sotto la casa dove stava Mary. «No, posso salir da sola» disse, di nuovo aspra e irritata. «È soltanto che, stanca come sono, un bicchiere mi fa subito effetto. Buona notte. Domani verrò a ritirare la valigia da te.» Ada e Barrow se ne andarono nel tassì con le teste accostate parlottando e ridendo. Mi hanno già dimenticata, pensò Mary mentre badava a salire le scale. Le scale le fece benissimo, ma trovò qualche difficoltà a
cacciare la chiave nella serratura. Quando l’uscio finalmente s’aprì, andò diritta al sofà nella camera di fronte, si distese e cadde in un sonno profondo. Il mattino si sentì riposata come non era più stata da anni. Si alzò di buon’ora e mangiò una gran colazione con uova al lardo, al Childs sulla strada dell’ufficio. C’era giù Rudy Goldfarb, seduto alla sua antica scrivania. Si alzò e le spalancò addosso gli occhi senza parlare, per un istante. Aveva gli occhi rossi e insanguinati e i capelli neri, solitamente lustri, gli ricadevan sulla fronte. «Che succede, Rudy?» «Compagna French, hanno beccato Eddy.» «L’hanno arrestato, insomma?» «Arrestato un corno, gli han sparato.» «L’hanno ucciso.» Mary sentì nascere in sé un’ondata di nausea. La camera prese a vorticarle intorno. Serrò i pugni e la camera ritornò a posto. Rudy le raccontava come certi minatori avevano trovato l’autocarro sfasciato in un fosso. A tutta prima avevano pensato che fosse stata una disgrazia, ma quando raccolsero Eddy Spellman aveva una pallottola nella tempia. «Ma dobbiamo tenere un comizio di protesta… lo sanno tutto questo al partito?» «Certamente, e tentano di ottenere il Madison Square Garden. Però, compagna French, era un diavolo di ragazzo in gamba.» Mary tremava in tutto il corpo. Trillò il telefono. Rudy rispose. «Compagna French, vi vogliono laggiù subito. Vogliono che siate la segretaria del comitato per il comizio di protesta.» Mary si abbandonò nella sedia della scrivania per un attimo e poi cominciò ad annotare i nomi delle organizzazioni da avvertire. D’un tratto levò il capo e guardò Rudy fisso nell’occhio. «Sapete quel che dobbiamo fare?… dobbiamo trasferire il comitato di Soccorso a Pittsburgh. L’ho sempre saputo che avremmo dovuto essere a Pittsburgh.» «Un bel rischio.» «Avremmo dovuto essere a Pittsburgh fin da principio» disse Mary ferma e calma. Il telefono trillò un’altra volta.
«È qualcuno che vi cerca, compagna French.» Appena il ricevitore toccò l’orecchio di Mary ecco Ada che parlava, parlava. A tutta prima Mary non riusciva a capire di che si trattasse. «Ma, Mary, tesoro, non li hai letti i giornali?» «No, ho detto di no. È di Eddy Spellman che parli?» «No, tesoro, ma che cosa orribile, ricordi che eravamo là solo ieri per un cocktail-party… ma devi ricordarti: Eveline Johnson, che orrore. Ho mandato a prendere tutti i giornali. Naturalmente tutte le cronache parlano di suicidio.» «Ada, non capisco.» «Ma, Mary, sto cercando di spiegarti… Sono così sconvolta che non so parlare… era una donna così adorabile, così intelligente, un’artista veramente… Ebbene, quando la cameriera è entrata stamattina, l’ha trovata morta nel letto e noi che eravamo là solo dodici ore prima. Mi dà i brividi. Qualche giornale dice che è stata la dose eccessiva di sonnifero. Non era possibile che avesse quest’intenzione. Se soltanto avessimo saputo, saremmo state in grado di far qualcosa, sai che ha detto che aveva mal di capo. Non potresti venire da me, non posso star qui sola, sono in uno stato…» «Ada, non posso… È accaduto un fatto molto serio in Pennsylvania. Ho un enorme lavoro da fare per organizzare una protesta. Ciao, Ada.» Mary riattaccò, aggrottandosi. «Rudy, se Ada Cohn ritelefona, ditele che non sono in ufficio… Ho troppo da fare per sprecare il tempo a occuparmi di donne isteriche in una giornata simile.» Si ficcò in testa il cappello, raccolse le sue carte e corse all’adunanza del comitato. 1. Dalle iniziali di International Workers of the World si ricava il bisticcio I Won’t Work, “non voglio lavorare”. (NdT)
Vagabondo Il giovanotto aspetta sul margine dell’asfalto, con una mano stringe una valigia graffiata, di cuoio scadente, l’altra mano stretta a pugno, pollice in su, l’agita quasi ad arco quando una macchina scivola accanto, un autocarro romba sferraglia; il vento delle macchine che passano gli scompiglia i capelli, gli dà schiaffi di polvere in viso. La testa gira, la fame gli torce il ventre, si è spellato un calcagno traverso la calza lacera, i piedi dolgono nelle scarpe rotte, sotto l’abito frusto accuratamente spazzolato con la mano, le mutande lacere danno un senso d’appiccicaticcio, il senso di chi ha dormito vestito; nelle narici persiste il tanfo dei corpi scoraggiati ammonticchiati in un campeggio transitorio, il puzzo acido del carcere, sulle gote stirate la vampa di vergogna agli sguardi trafiggenti di poliziotti e guardie e sorveglianti di linea (loro mangiano tre pasti al giorno, sono bene abbottonati in abiti ben fatti, hanno una moglie con cui dormire, bambini con cui giocare dopo cena, lavorano per i pezzi grossi che possono pagare, buttano fuori il petto con la sicurezza di chi ha la forza alle sue spalle). Fuori dai piedi, moschino. Taglia la corda, che fai meglio. Cattivo, eh? Credi di farcela? Il pugno in faccia, la botta sulla testa col bastone, il polso stretto e ritorto dietro la schiena, il ginocchio piantato secco nell’inguine, la camminata fuori città coi piedi rotti a star in attesa sul margine della sibilante fuggente catena di macchine dove il sentore d’etere vernice e benzina si disperde nell’odore silenzioso erboso della terra. Occhi cerchiati dallo sfinimento cercano gli occhi dei conducenti, un passaggio, un centinaio di miglia di strada. Lassù nell’azzurro ronza un aeroplano. Occhi seguono il Douglas argenteo che getta uno sfolgorio nel sole e prosegue la sua facile via scomparendo nell’azzurro. I passeggeri transcontinentali siedon bene, pezzi grossi dai conti in banca, stipendi altissimi, i portieri li salutano, le telefoniste gli dicono buon giorno. Ieri notte dopo un buon pranzo, qualche bicchiere con
gli amici, hanno lasciato Newark. Frastuono di motori in salita obliqua nella cappa d’inchiostro. Le luci scompaiono in basso. Un’ora di contemplazione di una gran luna solitaria lungo un’ala argentata, filando all’Ovest tra la schiumaglia di nuvole. Lampeggia la linea dei fari attraverso l’Ohio. A Cleveland l’apparecchio s’abbassa planando in dolce spirale, la fila di luci lungo il lago oscilla in cerchio. Di nuovo frastuono di motori in salita; abbandonati contro il morbido sedile si sonnecchia lungo la piatta notte lunare. Chi. 1 Un’occhiata al Gran Carro. Altro tuffo a spirale dall’aria fresca a un calore denso di polvere e di sentori di praterie bruciate. Oltre il Mississippi l’alba striscia fuori sopra la tenebra della grande pianura. Guazzi di nebbia s’imbiancano nelle colline dell’Iowa, fattorie, steccati, silos, lampi d’acciaio da un fiume. Gli occhi stanchi dei fari s’arrossano alla luce. Letti d’acqua venano le colline erose. Omaha. Grandi nuvole a cumulo, d’un color rame schiumato a crema a bianco argento, sollevano gonne scure di pioggia sulle piane accaldate. Sodaglie, gialle e rosse, figurine cornute di bestiame. Cheyenne. L’alta atmosfera odora fresca di erbadolce. Le compresse nuvole d’occidente scoppiano e si sparpagliano in brandelli sopra le colline color paglia. Monti azzurri dalle rocce dolomitiche. L’apparecchio affronta una grandiosa nuvolona crollante e scivola sull’aria elastica traverso verdi e vermiglie pendici nella gloria del sole a Salt Lake. Il passeggero transcontinentale pensa contratti, profitti, viaggi in vacanza, il gran continente fra l’Atlantico e il Pacifico, energia, ronzio di dollari sui fili, città zeppe, colline deserte, il sentiero indiano e la carraia pioniera, l’inghiaiata a barriera, l’orizzonte di asfalto; treni, aeroplani; la storia la velocità miliardaria, e nell’aria elastica sulle alture desertiche verso Las Vegas si sente male e vomita nel sacchetto di cartone la bistecca coi funghi mangiata a New York. Niente paura, in tasca spiccioli, nel portafogli biglietti, vaglia, assegni garantiti, non mancano i ristoranti a L.A. 2 Il giovanotto aspetta sull’orlo della strada; l’aeroplano è
scomparso; agita il pollice ad arco quando una macchina piomba e sibila via. Gli occhi cercano gli occhi del conducente. Un centinaio di miglia di strada. La testa gira, il ventre si serra, lo sfinimento gli striscia sulla pelle come formiche; è andato a scuola, i libri dicevano occasione, gli annunzi promettevano pronta carriera, siate il padrone in casa vostra, spendete più del vostro vicino, la voce della radio sussurrava belle bambine, fantasmi di bambine biondoplatino lusingavano dallo schermo, milioni di guadagni erano scritti a gesso sulle lavagne degli uffici, la busta paga pronta per le mani volenterose, il tavolo sgombro del dirigente con tre telefoni; aspetta con la testa che gira, la fame gli morde nel ventre, le mani in ozio intorpidiscono, accanto alla fuga del traffico. Un centinaio di miglia di strada. 1. Chicago. (NdT) 2. Los Angeles. (NdT)
Meccano U.S.A. a cura di Cinzia Scarpino e Sara Sullam La trilogia nel suo complesso funziona come una vera e propria “piattaforma” in cui spazio, tempo, personaggi e diverse tecniche e generi narrativi collaborano a fornire un grande affresco dell’America del Novecento. A colpire in U.S.A. sono la vastità della mappa su cui si muovono i protagonisti; la quantità di vicende, private e pubbliche, reali e fittizie, interconnesse fra loro; la compresenza, all’interno della stessa opera, di veri e propri romanzi nel romanzo, della biografia e del giornalismo, e di capitoli – quelli dell’Occhio fotografico – che restituiscono, in uno stile a metà strada tra verso libero e monologo interiore, la Bildung sentimentale, politica e artistica del narratore – o sarebbe meglio chiamarlo “arrangiatore” – della trilogia. È nell’interazione di questi quattro aspetti che Dos Passos scrive il “grande romanzo americano” del Novecento, per cui non si può considerarli separatamente. In U.S.A. Dos Passos combina non solo le diverse “voci” della «fetta di continente» ma anche diverse voci letterarie, che raccolgono e superano l’eredità del realismo così come quella del modernismo degli anni Venti. Oggi U.S.A. sarebbe un’opera multimediale: video, cartine geografiche, parti da leggere e alcune, forse, da declamare. È per dare rappresentazione a questo potenziale che forniamo di seguito alcuni “strumenti” di lettura, di cui costituiscono parte integrante le quattro tavole a colori presenti in fondo al volume.
Mappe Penso che lo SPAZIO sia il fatto centrale per un uomo nato in America. Charles Olson «Il mondo intero gli giaceva steso innanzi come una carta»: così leggiamo quando Charley Anderson inizia il lungo viaggio che lo porterà lontano da Twin Cities. La collocazione, sulla mappa degli Stati Uniti, di personaggi, storie e narrazioni permette di delineare una vera e propria enciclopedia della letteratura e della storia americana. Se la cultura e la letteratura americane sono fondate sullo
spazio, U.S.A. è un romanzo da leggere con una cartina degli Stati Uniti davanti agli occhi. Il titolo della trilogia, così come quello del primo volume, forniscono una chiara indicazione sulla dimensione geografica che funge da vero elemento di coesione su diversi livelli: per la struttura generale dell’opera, per le quattro modalità discorsive, per le vite dei personaggi fittizi così come di quelli reali, e per le narrazioni americane a cui fanno riferimento. U.S.A. è un romanzo in cui ci si muove molto: se il «giovane uomo» del Prologo cammina tra la folla, i dodici protagonisti fittizi del romanzo sono invece ritratti in viaggi più lunghi a bordo di treni (riprendendo così un consolidato tema ferroviario nella letteratura americana), di navi (civili o militari) che solcano gli oceani allargando così la mappa degli Stati Uniti nell’epoca della loro massima espansione, in automobile e, ancora più significativamente, in aereo, il mezzo (e l’industria) del futuro. È infatti proprio su un volo transcontinentale che si chiude il romanzo, con un capitolo speculare al Prologo, intitolato Vag. Il giovane uomo è fermo sul marciapiede e il suo sguardo segue la scia di un aereo della Douglas, nel suo percorso – che immagina nominando città dopo città – da Newark a Los Angeles. Gli spostamenti dei personaggi delle parti narrative compongono un mosaico geografico, linguistico e culturale che costituisce uno degli aspetti più affascinanti di U.S.A., la cui geografia non si limita all’andirivieni tra New York e Parigi tipico di molta letteratura degli expats (si pensi a romanzi quali The Sun Also Rises – Fiesta, 1926 – di Ernest Hemingway e Tenera è la notte di F.S. Fitzgerald, 1934). Se i Cine-giornale forniscono le coordinate che portano allo scoppio di un conflitto mondiale e delle sue ripercussioni globali, gli spostamenti dei personaggi ci mostrano diversi luoghi dell’immaginario americano novecentesco: la metropoli per eccellenza, New York, l’altra grande metropoli, porta del Midwest, Chicago. I due volti della Pennsylvania, la Philadelphia culla dell’ethos dei padri fondatori e la Pittsburgh del capitale industriale. L’Ovest all’indomani della chiusura della Frontiera – Nevada Utah Colorado e Idaho, regno di Big Bill a cui è dedicata una delle prime biografie – e poi la California, vero e proprio
laboratorio politico, sociale, economico e culturale del Novecento, dell’eterno presente e del futuro americani nel ventesimo secolo. E, ancora, la linea del Nordovest pacifico – la Fargo di Charley Anderson ma anche Seattle. E, infine, il Sud: la Florida del land boom indissolubilmente legata a Cuba, e il Texas di Anne Trent. Le linee disegnate dagli spostamenti dei personaggi individuano spesso trame salienti delle diverse narrazioni americane: guardando le mappe, per esempio, ci si accorge di come le figure più legate alla trama politica della trilogia – Mac, Benny Compton e Mary French – conoscano tutte significativi passaggi dall’Ovest; o della grande mobilità, quasi sempre in direzione nord-sud, di Charley Anderson. O, ancora, della scelta dell’Ovest, dove si rifà letteralmente una vita, da parte di Margo Dowling. E, infine, la trama East Coast (con l’eccezione dei periodi europei) dei personaggi di maggiore, seppure effimero, successo: John Ward Moorehouse, Richard Ellsworth Savage ed Eleanor Stoddard, ai quali non serve tanto muoversi per cambiare la propria situazione quanto tessere reti di relazioni nell’epicentro del romanzo e del mondo dell’epoca: New York.
Personaggi U.S.A., è stato osservato da più parti, è un romanzo “collettivo”, in cui non esiste una vera e propria gerarchia tra i protagonisti delle parti narrative. Le origini dei diversi personaggi rimangono sullo sfondo, costellazioni di personaggi minori, e nelle oltre novecento pagine della trilogia non si formano famiglie ma nemmeno comunità alternative. Esistono legami di amicizia o di affari, sodalizi in nome di un ideale politico. Ma il movimento incessante che abbiamo tracciato sulla mappa degli Stati Uniti inibisce la sedimentazione e la cristallizzazione di una trama relazionale di lunga durata. Il personaggio che ha forse maggiore preminenza è John Ward Moorehouse, presente in tutti e tre i volumi, e ispirato all’inventore delle pubbliche relazioni. Come è stato da più parti osservato (cfr. l’Introduzione di Cinzia Scarpino), non è un caso che le pubbliche relazioni – l’abilità di creare una (falsa) lingua comune alle diverse parti sociali – siano centrali per il romanzo. Personaggio relativamente “stanziale” rispetto ad altri, John Ward Moorehouse occupa una
posizione centrale nell’architettura del romanzo, ed è il personaggio più “connesso” agli altri. Che lo si definisca “incrocio” o “rete”, il sistema dei personaggi di U.S.A. individua, a seconda di come lo si attraversa, delle relazioni che si sceglie di mettere in dominante, diverse linee narrative che talvolta coincidono con generi consolidati all’interno della letteratura americana. Le narratives di Mac e Ben Compton si iscrivono nel romanzo proletario, quella di Margo nello “Hollywood novel”, quella di Charley Anderson è modellata su An American Tragedy di Theodore Dreiser, Joe Williams e Dick Savage riprendono le movenze del “war novel”, si pensi a Addio alle armi (1929) di Hemingway, Eleanor ed Eveline si incanalano in parte nella tradizione di Sister Carrie, sempre di Dreiser, in parte nei romanzi incentrati su figure femminili emancipate, Figlia su romanzi dedicati allo scontro intergenerazionale. I dodici personaggi di U.S.A. danno il titolo a ogni capitolo delle parti narrative e vanno considerati sia nella loro interazione, sia nella loro permanenza lungo l’intera trilogia.
Il 42° parallelo
Millenovecentodiciannove
Un mucchio di quattrini
Mac
X
Janey Williams
X
X
X
John Ward Moorehouse
X
X
X
Eleanor Stoddard
X
X
X
Charley Anderson
X
Joe Williams
X
Richard Ellsworth Savage Eveline Hutchins
X
Figlia Ben Compton
X
X X
X
X
X
X X
X
X
Margo Dowling
X
Mary French
X
(riquadro grigio: il nome del personaggio corrisponde ai titoli di capitolo; riquadro bianco: il personaggio compare nel racconto di altri personaggi; sottolineato: il personaggio compare nell’intera trilogia)
Il nastro trasportatore a quattro canali Le diverse tecniche e i generi narrativi e il loro alternarsi sono messi in evidenza nell’Indice che segue, con questi accorgimenti: – il corsivo segnala i Cine-giornali – il tondo è utilizzato per l’Occhio fotografico – il maiuscolo indica i capitoli che seguono le vicende dei personaggi fittizi – il maiuscoletto segnala le biografie dei personaggi storici.
Inserto fotografico
Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall’editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l’alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell’editore e dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche. Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto dell’editore. In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l’opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo. www.librimondadori.it U.S.A. La trilogia di John Dos Passos The Forty Second Parallel copyright © 1930 and © renewed 1958 by John Dos Passos 1919 copyright © 1932 and © renewed 1959 by John Dos Passos The Big Money copyright 1933, 1934, 1935, 1936 and © renewed 1963, 1964 by John Dos Passos © 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano Ebook ISBN 9788852098703 COPERTINA || COVER DESIGN: LAURA ZUCCOTTI
.
Frontespizio Il libro L’autore Introduzione. U.S.A., ieri e oggi. Cronaca modernista del fallimento di una “democrazia da favola” di Cinzia Scarpino Nota alla traduzione. Cesare Pavese lettore e traduttore di U.S.A. di Sara Sullam Nota dell’editore U.S.A. Prologo U.S.A. IL 42° PARALLELO. Traduzione di Cesare Pavese Cine-giornale I: «Eran quelli i patrioti» Occhio fotografico (1): quando si cammina per la via MAC Occhio fotografico (2): filiamo rollando come in una barca MAC Cine-giornale II: «Venite a sentire» Occhio fotografico (3): Ô qu’il a de beaux yeux AMANTE DELL’UMANITÀ Occhio fotografico (4): si torna indietro nella pioggia MAC Cine-giornale III: «Ci vuol del fegato per vivere in questo mondo» Occhio fotografico (5): e giocavamo alla battaglia di Port Arthur Cine-giornale IV: «Ho trovato il mio amore sull’Alamo» Occhio fotografico (6): Dàgli Madison dàgli Madison Cine-giornale V: Le cimici scacciano un biologo MAC Cine-giornale VI: Parigi finalmente scandalizzata Occhio fotografico (7): andavamo a pattinare sullo stagno IL MAGO DELLE PIANTE Cine-giornale VII: Asserisce che questo sarà il secolo dei miliardi Occhio fotografico (8): uno sedeva sul letto slacciandosi le scarpe MAC Occhio fotografico (9): tutto il giorno le fabbriche di concime puzzavano BIG BILL Occhio fotografico (10): il vecchio maggiore mi portava di solito al Campidoglio MAC Cine-giornale VIII: Il prof. Ferrer, già direttore della Escuela Moderna di Barcellona Occhio fotografico (11): i Pennypacker andavano alla chiesa presbiteriana Cine-giornale IX: Stelle compromesse bevendo MAC Occhio fotografico (12): quando tutti se n’andavano in viaggio Cine-giornale X: Il brevetto di Moon è tutto fumo Occhio fotografico (13): lui era capitano di rimorchiatore JANEY Occhio fotografico (14): il signor Garfield aveva una bellissima voce Cine-giornale XI: il governo degli Stati Uniti deve insistere JANEY Occhio fotografico (15): Alla foce dello Schuylkill salì a bordo il signor Pierce Cine-giornale XII: Greci combattenti che fuggono davanti ai poliziotti IL RAGAZZO ORATORE DEL PLATTE Occhio fotografico (16): faceva caldo come in un forno J. WARD MOOREHOUSE Occhio fotografico (17): la primavera che si poteva vedere la cometa di Halley Cine-giornale XIII: Ero in faccia alla piazza nazionale ELEANOR STODDARD Occhio fotografico (18): era una signora molto alla moda ELEANOR STODDARD Occhio fotografico (19): la moglie del pastore metodista era una donna alta sottile Cine-giornale XIV: Un artigliere ferma un australiano IMPERATORE DEI CARAIBI Occhio fotografico (20): quando i tranvieri fecero sciopero J. WARD MOOREHOUSE Occhio fotografico (21): quell’agosto non venne una goccia d’acqua Cine-giornale XV: si spengono le luci PRINCIPE DELLA PACE Occhio fotografico (22): tutta la settimana la nebbia non si staccò dal mare J. WARD MOOREHOUSE Occhio fotografico (23): l’amica di mammà era una donnina tanto carina Cine-giornale XVI: il filadelfiano aveva compiuto il tredicesimo giro ELEANOR STODDARD Occhio fotografico (24): pioveva nella storica Quebec JANEY IL MAGO DELL’ELETTRICITÀ Occhio fotografico (25): quelle notti di primavera le ruote dei tram stridono Cine-giornale XVII: un attacco di uno stormo di aeronavi nemiche MAC PROTEO
5 3 4 6 35 54 57 58 61 62 65 66 72 73 81 83 84 87 88 110 111 112 114 115 116 136 137 138 140 141 142 148 149 152 153 162 163 165 166 183 184 186 188 201 202 204 219 220 222 225 226 257 258 259 272 273 285 286 288 291 292 305 307 309 310 311 318 319 320 326 328 338 342 344 345 364
JANEY Occhio fotografico (26): il giardino era zeppo Cine-giornale XVIII: «Ciao Piccadilly, addio Leicester Square» ELEANOR STODDARD Cine-giornale XIX: Gli Stati Uniti in guerra Occhio fotografico (27): c’erano preti e monache sull’Espagne BOB IL COMBATTENTE CHARLEY ANDERSON MILLENOVECENTODICIANNOVE. Traduzione di Glauco Cambon Cine-giornale XX: «Oh la fanteria la fanteria» JOE WILLIAMS Occhio fotografico (28): quando arrivò il telegramma GIOCHERELLONE JOE WILLIAMS Cine-giornale XXI: «Addio Broadway» Occhio fotografico (29): le gocce di pioggia cadono a una a una RICHARD ELLSWORTH SAVAGE Cine-giornale XXII: L’anno venturo promette una rinascita Occhio fotografico (30): ricordando le grigie dita rattrappite RANDOLPH BOURNE Cine-giornale XXIII: «Se non ti va il buon Zio Sam» EVELINE HUTCHINS Occhio fotografico (31): un materasso coperto di roba di Vantine EVELINE HUTCHINS Cine-giornale XXIV: non si può immaginare l’entità colossale dei prestiti Occhio fotografico (32): à quatorze heures précisément IL LIETO GUERRIERO Occhio fotografico (33): 11.000 prostitute di mestiere JOE WILLIAMS Occhio fotografico (34): la sua voce era mille miglia lontana Cine-giornale XXV: le forze del generale Pershing hanno occupato oggi la fattoria UN DON CHISCIOTTE DELL’INDIANA Cine-giornale XXVI: L’Europa sul filo del rasoio RICHARD ELLSWORTH SAVAGE Cine-giornale XXVII: Intenta causa al marito e lo smaschera Occhio fotografico (35): c’erano sempre due gatti color latte caldo EVELINE HUTCHINS Cine-giornale XXVIII: «Oh le aquile che volano alte» JOE WILLIAMS Cine-giornale XXIX: l’arrivo della notizia provocò l’ingombro delle linee telefoniche Occhio fotografico (36): quando vuotavamo le gamelle sottovento “MISTER VILSON” Cine-giornale XXX: I cannoni giganti eliminati? Occhio fotografico (37): in ordine alfabetico e di grado Cine-giornale XXXI: lavatisi e vestitisi in fretta scesero a pianterreno FIGLIA Cine-giornale XXXII: La voce d’oro di Caruso aleggia sulle folle cittadine Occhio fotografico (38): timbrato firmato e consegnato Cine-giornale XXXIII: Sostiene di non ricordarsi d’aver ucciso la sorella EVELINE HUTCHINS Cine-giornale XXXIV: Il mondo intero a corto di platino LA DINASTIA MORGAN Cine-giornale XXXV: il Grand Prix de la Victoire Occhio fotografico (39): il giorno sgorga da una quiete rossastra Cine-giornale XXXVI: A gloria della Francia eterna RICHARD ELLSWORTH SAVAGE Cine-giornale XXXVII: Le guardie rosse arretrano Occhio fotografico (40): percorsi tutta la città a piedi Cine-giornale XXXVIII: «C’est la lutte finale» FIGLIA Cine-giornale XXXIX: lo spettacolo dei villaggi ridotti in macerie Occhio fotografico (41): non venite al picnic anarchico? Cine-giornale XL: Un detenuto in pigiama sega le sbarre JOE HILL BEN COMPTON Cine-giornale XLI: negli ambienti del Colonial Office britannico Occhio fotografico (42): per quattro ore noi militari di passaggio ammucchiamo rottami Cine-giornale XLII: per Seattle fu un giorno di gala PAUL BUNYAN RICHARD ELLSWORTH SAVAGE Cine-giornale XLIII: ai radicali furono strappati i cartelli LE SPOGLIE MORTALI DI UN AMERICANO UN MUCCHIO DI QUATTRINI. Traduzione di Cesare Pavese CHARLEY ANDERSON Cine-giornale XLIV: «Yankee Doodle la canzone» CHARLEY ANDERSON Cine-giornale XLV: «Senza cipria e la parrucca»
367 385 386 388 397 398 400 403 444 445 447 452 454 459 508 510 511 537 539 541 544 545 564 566 576 578 579 585 588 609 611 613 619 621 647 649 650 662 664 672 674 675 683 685 688 689 718 720 721 723 763 765 770 772 774 776 825 828 830 832 845 847 848 849 851 878 880 881 882 887 892 894 900 901 908 909 915
IL PIANO AMERICANO Cine-giornale XLVI: questi sono gli individui Occhio fotografico (43): un nodo alla gola quando il piroscafo Cine-giornale XLVII: giovane che cerca una posizione offriamo Occhio fotografico (44): l’innominato viaggiatore CHARLEY ANDERSON Cine-giornale XLVIII: davvero la Steel Corporation si aderge MACININO Cine-giornale XLIX: «Fante di quadri fante di quadri» CHARLEY ANDERSON Cine-giornale L: «No la colpa non è della mia Broadway» L’AMARO CALICE Cine-giornale LI: «La mia casa è senza sole» MARY FRENCH Occhio fotografico (45): la stretta camera gialla pullula di chiacchierio MARY FRENCH Occhio fotografico (46): cammina e cammina per le vie Cine-giornale LII: riuniti al servizio divino per i cari defunti L’ARTE E ISADORA Cine-giornale LIII: «Addio bel merlo» MARGO DOWLING Cine-giornale LIV: non ci fu nulla di significativo TANGO LENTO Cine-giornale LV: Folla nelle vie Occhio fotografico (47): sirene scoppiarono nella nebbia sul porto CHARLEY ANDERSON Cine-giornale LVI: il suo primo passo fu di salire su un treno rapido Occhio fotografico (48): alla volta dell’Occidente MARGO DOWLING Cine-giornale LVII: il medium si spogliò di ogni indumento MARGO DOWLING Cine-giornale LVIII: «Dolce terra che ci afferra» I CAMPEGGIATORI DI KITTY HAWK Cine-giornale LIX: lo straniero che viene la prima volta a Detroit CHARLEY ANDERSON Cine-giornale LX: Era di Céline la colpa? MARGO DOWLING Cine-giornale LXI: «In alto in alto» CHARLEY ANDERSON Cine-giornale LXII: Le stelle presagiscono disgrazie per Coolidge MARGO DOWLING Cine-giornale LXIII: ma qualche minuto dopo ARCHITETTO Cine-giornale LXIV: La cattura di un pesce misterioso Occhio fotografico (49): camminando da Plymouth a North Plymouth Cine-giornale LXV: Un temporale ostruisce la sotterranea MARY FRENCH Cine-giornale LXVI: Holmes nega la proroga Occhio fotografico (50): ci hanno cacciati a bastonate dalle vie Cine-giornale LXVII: quando le cose si capovolgono POVERO BAMBINO MILIONARIO RICHARD ELLSWORTH SAVAGE Cine-giornale LXVIII: Stupore a Wall Street Occhio fotografico (51): in fondo alla valle nell’ombra delle colline ENERGIA SUPERENERGIA MARY FRENCH VAGABONDO Meccano U.S.A. Inserto fotografico
916 921 922 924 926 928 941 942 951 952 982 984 995 996 1013 1015 1036 1038 1039 1046 1048 1070 1072 1077 1078 1080 1116 1118 1122 1134 1136 1155 1157 1163 1165 1200 1202 1215 1217 1250 1252 1295 1297 1302 1304 1306 1308 1328 1329 1331 1333 1343 1382 1385 1387 1395 1419 1422 1427