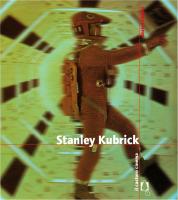Malevic. L'ultima icona. Arte, filosofia, teologia. Ediz. illustrata 8816605995, 9788816605992
Il libro propone un'analisi del rapporto tra Kazimir Malevic ― l'artista che più di ogni altro ha affrontato i
109 14 12MB
Italian Pages 251 [240] Year 2019
Polecaj historie
Table of contents :
Pagina vuota
Citation preview
Massimo Carboni MALEVIC L’ULTIMA ICONA ARTE, FILOSOFIA, TEOLOGIA
Jaca Book
©2019 Editoriale Jaca Book Srl, Milano tutti i diritti riservati
Prima edizione ottobre 2019
Redazione Jaca Book Impaginazione Elisabetta Gioanola
ISBN 978-88-16-60599-2
Editoriale Jaca Book ria Frua 11.20146 Milano, tei. 02/48561520 [email protected]; www.jacabook.it Seguici su RD
Indice
Avvertenza .............................................................................. 7 Prima parte .............................................................................. 9 Seconda parte ...................................................................... 45 Indice dei nomi ................................................................. 243
Avvertenza
Ogni cerchio, prima o poi, si chiude. Il cerchio che con
questo lavoro si chiude riguarda la ricerca che negli ultimi
trent’anni abbiamo condotto —a varie riprese e attraverso
tentativi di un approfondimento via via maggiore— sul rap porto tra la filosofia dell’icona e l’opera di Kazimir Malevic.
Il tema è comparso per la prima volta nell’articolo II sublime rovesciato, pubblicato su “aut-aut”, n. 231, 1989. Poi ha as
sunto la forma più estesa di un capitolo sia in li Sublime è Ora,
1993, sia nella seconda edizione di Non vedi niente? Sentieri
tra arti e filosofie del presente, del 2005. Nicola Cusano e Ka zimir Malevic. iconologia dell’ascesi si intitolava la relazione tenuta al convegno su “Eros e filosofia" (Università di Roma “La Sapienza”, 1997), i cui atti sono stati pubblicati due anni
dopo in “Almanacchi nuovi” (2,1998-99). Più recentemente, nel maggio 2018 e nell’aprile 2019, il tema è stato oggetto di
conferenze tenute al Museo Riso di Palermo e a La Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
7
Prima parte
L’immagine è ri-presenfazione, cioè in definitiva resurrezione
Roland Barthes
Il cinema è la resurrezione del reale Jean-Luc Godard
L’eresia dell’iconoclasmo, e la tremenda crisi che essa provoca nel mondo cristiano e che non cesserà di far sentire le sue ripercussioni per lungo tempio (basti solo pensare alla
Riforma Protestante avvenuta oltre un millennio più tardi), con le questioni e gli interrogativi radicali che essa pone, fa parte integrante della teologia delle immagini e della dialet tica ontologica dell’icona. Lungi dal risultarle estraneo, l’i conoclasmo ne esprime invece il versante tragico, poiché in terroga la paradossalità dell’icona come scandalo dell’appa rizione visibile dell’invisibile. Accenni contro il culto delle immagini —giustificati in parte dalla necessità di contrapporsi al paganesimo— si tro vano già nei testi paolini. All’interno dell’ecumene cristiana —a Costantinopoli, in Grecia, in alcune province dell’Anato lia— il culto rasentava l’idolatria aumentando l’ascendente dei monaci e del clero sul popolo a detrimento dell’autorità statale. La controversia iconoclastica fu aperta istituzional mente dall’imperatore bizantino Leone ni Isaurico, che emi se i primi due decreti contro l’uso e il culto delle immagini sacre nel 726 e nel 730, decreti il cui testo non possediamo.
9
L’imperatore fece distruggere l'imago Christi sul frontone della porta Chalkè del palazzo imperiale e la fece sostituire con la croce. Sembra che una folla di donne abbia violente
mente protestato contro gli incaricati del lavoro, e a questo proposito può far riflettere il fatto che furono proprio due imperatrici a restaurare il culto delle icone, Irene e Teodo ra1. L’offensiva variò di contenuto e di intensità: all’inizio fu diretta soltanto contro le degenerazioni del culto e non si ve rificarono distruzioni sistematiche delle immagini; successi
vamente si pervenne alla radicale abolizione non solo del loro culto ma anche del loro uso. Sul piano politico, la con troversia iconoclasta fu essenzialmente una lotta tra il cesa ropapismo esplicito di alcuni imperatori bizantini (Leone in e soprattutto il figlio Costantino v Copronimo) e il movi mento monacale che non cessava di rivendicare l’indipen
denza del messaggio evangelico dal mondo terreno. Germano patriarca di Costantinopoli (637-733), prima del suo allontanamento dalla corte di Bisanzio sotto la pres sione imperiale, usava già con grande chiarezza, a favore del le immagini, l’argomento cristologico dell’incarnazione sto rica, e a lui dobbiamo, grazie alle sue lettere redatte tra il 715 e il 730, la prima reazione al nascente movimento iconocla sta di cui possediamo una testimonianza scritta:
«Noi permettiamo la produzione di icone dipinte con cera e colori, non per pervertire la perfezione del culto divino. Per ché, dell’invisibile divinità, noi non facciamo né icone né ri produzioni né alcuna figura [...] Ora, però, l’unigenito Figlio che è nel seno del Padre [...] ha benignamente deciso di farsi uomo. Egli è divenuto partecipe della nostra carne e sangue, si-
1 Sull'episodio cfr. A. Grabar, Liconoclasme byzantin, Flammarion, Paris 1984, pp. 150-66, e G. Ostrogorsky, Storia dall’impero bizantino (1965); trad, it. Einaudi, Torino 1968, pp. 149-50, ma vedi l’intero cap. L’età della crisi ico noclastica (711-H4Ì). Sia lo studio di Grabar sia quello di Ostrogorsky sono fondamentali per comprendere la posta in gioco, sia sul piano politico sia su quello teologico, della controversia sulle immagini. Ricordiamo che la dottri na apologetica sulle immagini è una legittimazione operata in sede teologica di un culto popolare già da tempo molto diffuso nel mondo cristiano.
10
mile a noi in tutto eccetto il peccato. Per questa ragione noi rappresentiamo in immagini i suoi tratti umani così come egli appariva come uomo secondo la carne e non secondo la sua in visibile e incomprensibile divinità [...] Cristo non si è fatto uomo solo apparentemente, come un’ombra, ma realmente e veracemente [...] In ragione di questa incrollabile fede in Cri sto, noi rappresentiamo l’espressione (charakiera) della sua santa carne sulle icone e a queste tributiamo onore inchinan doci davanti ad esse con la dovuta riverenza, perché mediante esse noi veniamo richiamati alla sua incarnazione vivificante e indicibile»2. Nella convinzione che la fede cristiana non è credere in alcune verità pronunciate o declamate, ma nell’esibizione ef fettiva della verità concretizzata in un’esistenza singola, fin dall'inizio della speculazione teologica a difesa dell’icona, dunque, questa (cioè la tradizione non scritta) è pensata e giustificata quale diretta conseguenza della realtà dell’incar nazione, senza che ciò possa negare o compromettere l’indicibilità-invisibilità della ousia, della ’sostanza’ divina. All’in
terno di questo equilibrio, l'icona (e questo resterà un locus classìcus nella dogmatica sulle immagini sacre) rappresenta il medio, il tramite per richiamare alla mente e al cuore, per
rammemorare quel mistero vivificante. Al Concilio di Roma del 731, Gregorio m scomunica gli iconoclasti. Non avendo la possibilità di colpire direttamente il pontefice, per tutta ri sposta Leone Isaurico stacca l’Italia meridionale, compresa la Sicilia, rilliria e la Dalmazia, dalla giurisdizione ecclesia stica romana subordinandole al patriarcato di Costantino poli. La difesa delle immagini viene assunta da un umile mo naco del monastero di San Saba in Palestina, Giovanni Da masceno (675-749), che insiste sul sovvertimento avvenuto con la discesa incarnata di Dio tra gli uomini:
2 Cfr. C. Schònbom, L'icona di Cristo. Fondamenti teologici (1976; 1984); trad. it. ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 161.
11
«Nei tempi antichi Dio, incorporeo e senza forma, non poteva essere raffigurato; ma ora, poiché Dio è stato visto mediante la came e ha vissuto in comunanza di vita con gli uomini, io raf figuro ciò che di Dio è stato visto. Io non venero la materia, ma il Creatore della materia che è diventato materia a causa mia, nella materia ha accettato di abitare e attraverso la materia ha operato la mia salvezza»1.
Nel 753, Costantino V Copronimo (bollato dagli iconofìli con questo titolo infamante di ‘nome di sterco’) riunì a Hieria, sulla riva asiatica del Bosforo, più di trecento vesco vi per sei mesi. Il Concilio (che non fu evidentemente ecu menico ma che pretendeva di esserlo) dichiarò empia e sa crilega l’arte della pittura in quanto attentava a riprodurre Cristo, i Santi e la Theotokòs, la Madre di Dio, e il culto del le immagini fu dichiarato proveniente da Satana. Radicale e spietato fu l’uso che Costantino fece di queste deliberazioni dogmatiche: le immagini furono quasi totalmente distrutte, i monaci violentemente perseguitati e a molti di loro furono amputate o bruciate le mani per aver dipinto icone. Vivono in queste deliberazioni sia l’eredità dell’esasperato spiritua lismo ellenico post-platonico, sia la necessità di porsi in rap porto con il nascente Islam, anch’esso, e come d’altronde anche l’Ebraismo, contrario alla raffigurazione del divino.
Presupposto teologico degli iconoclasti era che la theosis, la ‘deificazione’ di Cristo ne sopprimesse il carattere umano, e siccome l’immagine, Veikon, era creduta —con un atteggia mento fondamentalmente ancora magico, vedremo meglio in seguito— della stessa sostanza del prototipo, essa, nella sua materialità, non poteva adeguatamente realizzare tale
identificazione. Si comprende bene già da questo passaggio come nella controversia iconoclasta sia in gioco niente meno che lo stesso futuro statuto dell’immagine in generale, reli giosa o secolare che sia, e quanto -sebbene l’icona non sia opera d’arte ma opera testimoniale— l’arte e il pensiero
1 Giovanni Damasceno, Difesa delle immagini sacre. Primo Discorso, 16; trad. it. Città Nuova, Roma 1983.
12
sull'arte così come modernamente li intendiamo vi siano profondamente coinvolti. Sotto Irene imperatrice reggente, arriviamo nel 787 al vii Concilio, il secondo di Nicea e l’ultimo della Chiesa indivisa prima del grande scisma del 10544. Si revocano i decreti di Hieria e si restaura il culto delle immagini, pur condannan do ufficialmente la simonia, cioè il commercio delle immagi ni sacre. Negli atti di questo Concilio (che riporta integral mente gli atti della precedente assemblea iconoclasta di Hieria, e solo per questo ne conosciamo il contenuto) del quale non si sopravvaluterà mai l’importanza e la decisività, si riaf ferma che Dio non è rappresentabile nella sua natura, ma
che mediante l’icona facciamo memoria dei prototipi che essa raffigura, e che ciò non significa affatto separare la car ne di Cristo dalla sua divinità. Anzi, al contrario, l’icona è ri tenuta la prova della fede nel fatto che la sua carne è deifica ta e viene confessata ima con la divinità. Possiamo conclude re dunque, argomentano gli iconoduli, che se il Verbo si è mostrato in un corpo di carne, la bellezza di ogni corpo umano non è altro che il riflesso della bellezza del Verbo. Gli stessi Padri della Chiesa non avevano affatto negato la cor
poralità, arrivando ad esempio ad affermare quasi temera riamente che guardare una donna significa sentirsi portati a lodare Dio che ha creato tanta bellezza, e in tal modo lo sguardo di ammirazione viene trasfigurato. È nota la storia del vescovo Nono di Edessa che pianse di commozione di fronte al fascino femminile di una prostituta che, commossa a sua volta, cambiò vita e divenne santa. La materia è quindi ricolma —proprio in virtù dell’incarnazione— di energia divi
4 È ormai opinione comune e consolidata che quelle antiche decisioni del del Niceno il e tutto il dibattito di cui qui forniamo soltanto uno schema estre mamente sintetico a fronte della sua complessità, abbiano contribuito a pla smare la concezione e lo statuto stesso dell’immagine nella cultura occidenta le. Cfr. su questo -anche per quanto riguarda il repertorio bibliografico— M. Andaloro, Il secondo Concilio di Nicea e l’età deU’itnmagine, in Vedere l’invisi bile. Nicea e lo statuto dell'tmmagme, a cura di L. Russo, Aestltetica, Palermo 1997, che contiene gli atti del Concilio.
13
na e di grazia, così che nella bellezza terrestre, generata, si può riconoscere la bellezza celeste, ingenerata. Il Concilio niceno stabilì che l’icona va però “venerata” e non “adora ta”. Il termine greco usato negli atti del Concilio è proskynesis, che indica la situazione in cui l’icona è posta direttamen te davanti ai fedeli inginocchiati e pronti alla venerazione.
Ma nella traduzione latina degli atti conciliari usata da Car lo Magno, il termine fu tradotto con adoratio, e per questo nei Libri Carolini si respingono le risoluzioni di Nicea. Nella prima metà del secolo ix si riapre -e trova anche la sua chiusura- il secondo e ultimo periodo iconoclasta, ove ancor più chiaramente emerge che sul piano del potere poli tico-religioso la lotta è contro il monacheSimo ed è parte di quel più ampio conflitto tra Stato e Chiesa che si estenderà in Europa quantomeno per un altro millennio. Nell’815, sot to Leone v, il Concilio di Santa Sofìa a Costantinopoli rimi se in vigore i decreti iconoclasti di Hieria. Le due figure più grandi che al tempo emergono nella speculazione teologica
ortodossa sulle immagini sono quelle di Teodoro Studila (795-826) e di Niceforo patriarca (750-829). Nonostante il rischio di cadere nell’eresia nestoriana, essi riaffermano la piena umanità di Cristo. Scrive Teodoro: «l’inconcepibile viene concepito nel grembo di una Vergine; I’incommensurabile diventa alto tre cubiti; l’inqualificabile ac quista una qualità; l’indefinibile sta in piedi, si siede e si corica; colui che è in ogni luogo è posto in un presepio; colui che è aldi sopra del tempo raggiunge gradualmente l’età di dodici anni; colui che è senza forma appare in forma d’uomo e l’incorporeo entra in un corpo [... ] perciò egli è descrivibile e indescrivibile»5
5 Cfr. J. Meyendorff, La teologia bizantina. Sviluppi noria e temi dottrinali (1974, 1979); trad. it. Marietti. Casale Monferrato 1984, p. 194. Il libro di Meyendorff, che abbiamo tenuto costantemente presente, resta una guida im prescindibile per tutti i motivi che qui e in seguito affronteremo. Per quanto riguarda invece la dimensione storico-artistica della cultura e della teologia bi zantina, resta insuperato lo studio di E. Kitzinger, Il culto delle immagini. L’ar te bizantina dalle origini all'iconoclastia (1976); trad. it. La Nuova Italia, Fi renze 1992.
14
Sta qui tutto il paradosso, tutta l’aporia dell’icona, e la fede cristiana mostra una profonda struttura iconica6. La trascendenza si è fatta presenza, l'umano è visitato dal divi no: ma allora Cristo è la prima, vera e perfetta icona del Pa dre, nel senso che il Padre, primo Iconografo (cfr. Giovanni Damasceno, Secondo discorso, 20), mostra sé nel Figlio po tremmo dire come nel suo “autoritratto". Analizzeremo più avanti in dettaglio questo punto teologicamente delicatissi mo. Niceforo patriarca (deposto neU’815 da Leone v per la sua difesa delle immagini) respingeva la concezione di Origene (185-254) secondo cui la deificazione dell’umanità av venuta con l’incarnazione implicava la smaterializzazione e l’intellettualizzazione dell’esistenza. Cristo, afferma Nicefo ro, ha sofferto la fame, la sete, la fatica, il dolore: come ogni altro uomo, che non avrebbe potuto salvare se Egli non aves se assunto una carne affatto uguale a quella sua. Tale pienez za di umanità implicava quindi che potesse essere descritta, raffigurata, evocata nell’immagine. Ed ecco perché, secondo la celebre formula coniata da Basilio di Cesarea detto il Grande (330-379), l’onore riservato all'immagine si trasmet te all’archetipo, dal momento che ogni raffigurazione, di qualsiasi tipo, appartiene o risale originariamente a un ar chetipo, a un modello. Nel 843, con il Concilio di Costantinopoli, il culto delle
icone viene definitivamente ristabilito sotto Teodora impe ratrice (e ci sarebbe forse da fare una riflessione di genere, lo ripetiamo, sul fatto che furono due donne regnanti a restau rare il culto delle immagini), anche se la questione iconocla sta farà sentire le sue ripercussioni ancora per secoli fino a oggi, mai definitivamente rimossa proprio perché essa vive
nell’intimo della dialettica teologica dell’icona come coincidentia oppositorum, come evocazione di quella enosis, cioè
6 Non soltanto. Tutti i testi antichi in difesa delle immagini -canonicamen te appartenenti o meno alla patristica— sono percorsi incessantemente da con tinue e insistenti metafore, paragoni ed esemplificazioni die rinviano all’arte della pittura e al mestiere del pittore.
15
di quella unione tra epifania, manifestazione visibile, e di mensione apofatica, cioè affermazione dell’invisibile. * **
Quali osservazioni possiamo trarre da questa sintesi sto rica (certo molto parziale e schematica rispetto alla comples sità degli avvenimenti) di una controversia che non soltanto ha aperto la possibilità stessa di un'arte cristiana, ma che è
straordinariamente importante per tutta la cultura occiden tale dell’immagine? Prima di tutto occorre sottolineare che la speculazione teologica sull’icona non rigetta ma al contrario considera positivamente la proibizione veterotestamentaria all’imma gine, proprio perché vuole pensare la vera icona, quella che
diventa possibile soltanto dopo e in virtù dell’incarnazione, che fa parte deJl’oi^onomia divina, cioè del piano provvi denziale in cui Dio si rivela per la salvezza dell'umanità7.
Essa non è simulacro né finzione, soprattutto non è rappre sentazione artistica nel senso estetico e moderno del termi ne. A questo proposito bisogna ricordare che nei documen ti della controversia non troviamo nessuna traccia di rilievi o giudizi di carattere artistico-estetico, perché la partita si gio ca tutta sul piano della teologia trinitaria e dell’economia
cristologica. Prova ne sia che, secondo un paradosso solo apparente, sotto Irene e Costantino vi iconofili le opere mu sive erano aniconiche, e che grandi e preziosi lavori artistici
furono promossi da Teofilo imperatore iconoclasta. L’icona è dunque inno, preghiera, testimonianza; non è sostanziale presenza del divino né compiuta enosis, poiché la vera unio
ne estatica sarà possibile solo nella vita futura in Cristo. L’icona —cui si deve un culto comunitario e non “musea le”, non soggettivistico ma liturgico, ed è per questo che per essa è fondamentale l'assoluta precisione tecnica della sua
7 Cfr. su questo tema G. Agamben, // regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo. Neri Pozza, Vicenza 2007.
16
fattura trasmessa dalla tradizione— è il nome di Dio disegna to e dipinto, e il suo nome pronunciato è la sua icona verba le. Immagine e parola sono qui indissolubilmente intreccia te, tanto è vero che nella quinta sessione del Concilio niceno un’icona venne collocata al centro della sala accanto al libro dei Vangeli. L’icona è odoghetna, cioè guida, conduce verso il Prototipo che raffigura e aiuta a rammemorare; è porta aperta che si spalanca sull’infinito, che illumina in oro e co lori la misura della separazione tra umano e divino, facendo
traboccare la luce dell’altro mondo in questo mondo. Sull’i cona è dipinta la natura umana solo in quanto partecipa a quella divina, ed è dipinta la natura divina solo in quanto questa partecipa a quella umana: tale è il suo delicatissimo, fragile equilibrio. In essa vediamo solo il prosopon, il volto del Padre che si è “in-figurato", che si è reso immagine nel
Figlio; non vi vediamo la sostanza divina, ma solo la sua ipo stasi, cioè il suo farsi persona in Cristo che è parola divenu ta visibile quindi rappresentabile-raffigurabile.
D’altra parte sarebbe totalmente errato vedere nelle posi zioni iconodaste una semplice ripresa-ripetizione del divie to biblico all’immagine che HYWll dettò a Mosè sul Sinai, perché tali posizioni si pongono consapevolmente sul terre no della rivelazione. La cristologia iconoclasta sottolinea ed enfatizza quella dimensione apofatica che è interna e non esterna alla dialettica ontologica dell’icona: afferma cioè la dimensione irrappresentabile, irraffigurabile della divinità. Essa non rinnega affatto l’efficacia della pittura religiosa (anzi, bisognerebbe forse dire che gli iconoclasti la combat tevano proprio perché ne erano supremamente coscienti), ma interpreta quel movimento del fedele che —secondo la terminologia dogmatica— “solleva la mente dalle immagini agli archetipi”, secondo una prospettiva psicologica, empiri sta, sensista. Non è un caso che gli iconoclasti —separando nettamente sacramento e icona, e negando la stessa possibi lità di un nesso ontologico con il Prototipo- ammettessero come vere e uniche icone (che tali in realtà non sono) la cro ce, il pane e il vino, credendo che gli enti invisibili possano
17
rivelarsi soltanto tramite immagini che non hanno alcuna so miglianza con il loro oggetto. Torneremo su questo, ma già da ora possiamo osservare che, se pensata come raffigurazio
ne psicologico-associativa, l’icona davvero arretrerebbe a immagine idolatrica. Ma questa incomprensione del partito iconoclasta si fon da e riposa su una negazione ancora più profonda e abissa le, e qui forse sta il nodo davvero decisivo dell’intera que stione. L’iconoclasmo cioè nega la forza energetica e manife stante del divino, dell’inesprimibile. L’icona ci mostra, ci ri corda che il Dio cristiano sa donarsi, che è pura gratuità. Cioè in una parola Amore, vincolo di Amore espresso all’in terno dell’oikonomia divina, l’azione salvatrice di Dio che “adatta” la legge trascendente, che rimarrebbe incomprensi bile, alla realtà vivente e conoscente degli uomini. Oikono mia, dunque, come gestione, amministrazione, distribuzione storico-temporale della visibilità iconica; e Cristo, dunque, come icona vivente dell’amore. La teologia iconoclasta nega,
non comprende, rimuove questa infinita capacità energetica -ed economica nel senso appena precisato— di donarsi deU’inesprimibile, che invece può considerarsi il sigillo stes
so del mistero della creazione. Propriamente l’icona, scrive Florenskij, non è tanto una rappresentazione —che in quan to tale porta sempre con sé delle implicazioni di carattere soggettivistico, psicologico-associativo— quanto «una delle onde propagatrici nate dalla realtà stessa che l’ha suscita ta»8, ed è qui che si raccoglie il suo valore altamente quanto
letteralmente simbolico come segno che partecipa della real tà stessa di cui è segno segno-simbolo di luce. Luce che è onda, emanazione, energia irradiata dall’essenza che in quanto tale resta invisibile-impartecipabile, ma che proprio manifestandosi, incarnandosi in Cristo, si rivela essere Amo
8 Ihonostas di Pavel Florenskij è l’aureo contributo alla filosofia novecente sca dell’icona scritto nel 1922, trad. ir. Le porte regali, Adelphi, Milano 1977. La citazione è a p. 66. La “porta regale', come noto, è l’apertura centrale dell’iconòstasi. E celebre il sillogismo formulato da Florenskij: «Esiste la tri nità di Rublév, perciò Elio è», p. 64).
18
re, capacità donativa massimamente libera, volontà di offrir si gratuitamente senza alcuna aspettativa di un ritorno, abis sale scelta di alienarsi, di separarsi da sé tuttavia restando presso di sé. Tramite l’icona, il fedele può associarsi allora a questa energia. Se essa non è rappresentazione ma, secondo Florenskij, emanazione, allora vale come testimonianza con creta in oro e colori del trascendente, che nella sua infinita bontà (che appunto altro non è se non capacità di espander si, di aprirsi, di alienarsi) agisce in mezzo a noi, all’immanen te, poiché Dio ha rinunciato pur misteriosamente conser vandola alla sua essenza invisibile facendosi uomo per mo strarsi come tale. L’icona è lo sguardo di un Altro invisibile,
ma non si attenta a esprimere l’inesprimibile essenza divina; essa testimonia invece la misura della partecipazione dell’u manità al divino e del divino all’umanità. Ma precisamente in virtù di questa ragione, l’icona mostra un versante tragico, una dissonanza interna. Questa sua natu ra aporetica, contraddittoria, questo suo essere eminente mente dialogica, mai definitivamente “sedata”, e nello stesso tempo questo suo essere naturaliter sinergica, comunicativa, partecipativa, questa sua irrisolvibilità va mantenuta aperta, come “aperto” rimane e deve rimanere lo scandalo di un dio che muore sulla croce, contro ogni interpretazione di manie ra, pacificante, rassicurante, apologetica del cristianesimo. Ciò è perfettamente espresso nella figuralità dell’icona dal rapporto dialettico tra l’oro e il colore. «Tutto ciò che è manifestato è luce», scrive Paolo agli Efesini (5, 13). Luce, cioè grazia, perfetta gratuità dell’essere. Nella sottolineatura (razdelka) e nell’ombreggiatura [assistka) dell’oro dell’icona, si manifesta e si rende percepibile l’essere glorioso (vale a dire appunto luminoso) del Cristo, della Madre theotokòs (cioè colei che ha generato, “portato” il Figlio di Dio) e dei santi come testimoni della luce taborica (quella risplendente sul monte Tabor nella trasfigurazione di Cristo). Nel suo stesso processo tecnico-stilistico di produzione (sul quale torneremo), l’icona è graduale rivelazione dell’immagine dall'ombra verso la luce. I colori (l’oro non è considerato
19
tale), accesi, splendenti, senza ombre o chiaroscuri, alieni da ogni gioco prospettico, da ogni illusoria profondità “rinasci mentale”, muovono verso l’oro che è il loro diapason, il loro
lucente limite. Ma mai devono con esso confondersi. Oro e colore abitano nell’icona due separate e distinte sfere. Se l’i cona fosse solo-oro la Luce abbaglierebbe, accecherebbe e non potrebbe figuralmente mostrarsi; se fosse solo-colore, non apparirebbe, non potremmo esteticamente apprendere la sua provenienza e il suo vincolo d’amore da e con quella Luce. Dunque è necessario all’icona mantenersi nella distan za, nella differenza, nell’intervallo silenzioso tra oro e colo re, espressione, di nuovo, della sua dimensione aporetica, inconclusa, sospesa. Che deve riconfermarsi contro ogni in terpretazione piattamente apologetica e meramente conso latoria della fede in Cristo, che, ripetiamo, follia e scandalo deve rimanere. ★ A ★
«L’imperatore non può ammettere un’immagine di Cri sto senza voce e senza respiro, e la Scrittura si oppone alla raffigurazione della (sola) natura umana di Cristo; (ecco per ché) Leone e suo figlio il nuovo Costantino incidono sulla porta del Palazzo il segno tre volte santo della croce, gloria dei fedeli». Questa è l’iscrizione che Leone ni Isaurico fa ap porre sulla Porta Chalkè -l’accesso monumentale al palazzo imperiale di Costantinopoli— assieme alla croce, in sostitu
zione dell’icona di Cristo (probabilmente un mosaico) per ché ritenuta blasfema. Quell’immagine, così come ogni altra immagine, è afona, priva di parola; è inanimata, mancante del soffio vitale. Come Ifigenia sull'ara sacrificale nell\4gtfmennone, è «un’immagine incapace di parlare» (v. 242). Con
ogni evidenza, il presupposto è che vera immagine sia quel la che -senza tralasciare alcun tratto distintivo, caratteristi ca, proprietà— riproduce alla perfezione il modello. Come se
davvero potesse darsi riproduzione vivente del vivente, ciò che è esclusivamente riservato alla perfezione del rapporto
20
iper-iconico tra Padre e Figlio. Lo scrive esplicitamente Co stantino v nelle Peùseis (alla lettera, ‘questioni’), le direttive che costituirono la base dottrinaria seguita (ma in parte cor retta) dai Padri riuniti nel sinodo iconoclasta di Hieria: «ogni immagine è una copia del modello [...] per essere ve ramente immagine, deve essere uguale per essenza (consu stanziale) a ciò che è raffigurato [...] perché l’intero venga salvaguardato: altrimenti non è un’immagine» 9. Autentica icona sarebbe soltanto quella ontologicamente originata in
homoiousis., cioè “discesa” dalla stessa identica sostanza di ciò di cui è icona: ri-presentazione assoluta e senza scarto; mimesis che afferma la propria essenza cancellandosi; copia che, salvaguardando-custodendo l’intero del modello, si abolisce in quanto tale. Da questo punto di vista, gli autenti ci idolatri —paradossalmente ma poi non troppo— appaiono
gli iconoclasti, proprio coloro che (perlomeno nella prima fase della controversia, prima che questa acquisisse un carat tere esplicitamente cristologico) hanno sempre accusato di eresia idolatrica chi venerava le immagini sacre. In questa pretesa di un iconismo integrale e consustanziale all’archeti po (ma solo il Cristo figlio è immagine coeterna e della stes sa sostanza del Dio padre) vive l’empito, la tensione verso un eccesso mimetico che la proietta oltre il traguardo di sé stes sa e che sfocia in una forma di feticismo animistico. Viene assunta cioè una posizione che paradossalmente si spinge al di là di ogni contrapposizione di iconoduha o iconosofia, e si proietta su di un terreno di natura magico-apotropaica (e non, invece, di natura correttamente simbolica), dove l’indistinzione e l’unità originaria di rappresentato e rappresen tante si rivela «nel fatale regredire verso l’identificazione
primitiva dell’immagine con la cosa stessa»10. Assieme al motivo del disprezzo verso la materia —di ori gine neoplatonica e fondamentalmente gnostica— quello
9 Cfr. C. Schònbom, L'icona di Crino. Fondamenti teologici, cil., p. 142. 10 C. Brandi, Segno e immagine (1960); Aesthetics, Palermo 1986, p. 54, ma cfr. tutto il cap. Perché riformò un’iconografia bizantina.
21
conseguente che consiste nell’addebitare all'immagine come suo limite invalicabile il fatto di non essere animata, è alla ra dice delle posizioni degli oikonomachoi, i ‘nemici dell’imma gine’, e attraversa tutto il decorso storico della controversia: dall’Ocfózvtfj di Minucio Felice, risalente agli inizi del ni se colo, e dalla celebre lettera, databile tra il 313 e il 324, di Eu
sebio di Cesarea —il teologo di Costantino il Grande e segua ce di Origene— all’imperatrice Costanza che gli aveva chie sto un’immagine di Cristo, fino all’ultimo concilio iconocla sta dell’815, dove ancora si parla -comminando l’anatemadi «ritratti inanimati» e della «materia inanimata delle ico ne»11. Al culto delle immagini, gli iconomachi —già lo sap piamo— opponevano sia, come presso gli Armeni monofìsiti, il culto della croce, nel cui segno (segno, appunto, e non immagine) Dio dette la vittoria a Costantino nella notte pri ma della decisiva battaglia di Ponte Milvio, sia l’adorazione dell’eucarestia (a sua volta, però, il culto della croce era ri gettato dai Pauliciani, la setta sorta in Armenia nel vn seco lo, e ciò deve ricordarci quanto complessa, stratificata, irri ducibile a ogni semplificazione sia l’intera vicenda della cri si iconoclasta). La croce non è un’immagine che osi raffigu rare mimeticamente l’irraffìgurabile (dunque non espone al rischio dell’idolatria) ma un simbolo astratto che ricorda, che riporta alla mente e al cuore lo strazio della Passione; l’eucarestia è considerata l’unica autentica icona di Cristo appunto perché in essa è misteriosamente presente la sua so stanza. Le immagini, pur se consacrate al pari dell’eucare stia, non hanno il potere di trasformare il koinos, il ‘profa no’, in hagtos, in ‘sacro’. L’argomento del pane e del vino come le sole vere “im
magini” del Salvatore, tuttavia, è particolarmente debole, perché proprio quella somiglianza ontologica integrale che gli iconoclasti si aspettano o pretendono dall’immagine, de cade completamente nel caso dell’eucarestia, che non è “fì-
11 Cfr. D. Menozzi, La Chiesa e le immagini (1991), trad. it. San Paolo, Mi lano 1995, p. 114.
22
gura” ma verità sacramentale (così Niceforo e Teodoro), che deve essere consumata e non contemplata, che indica una metabolè, una ‘trasmutazione’ la cui essenza non ha nulla in comune con la sfera visiva, che in tutta evidenza non si inscrive in alcun registro mimetico e non ha nessuna relazione raffigurativa con alcunché. L’eucarestia non è af
fatto icona di Cristo, tantomeno la sua “unica vera icona”, ma, per via di irrisalibile transustanziazione, è il corpo e il sangue del Cristo vivente: l’ostia eucaristica non è fatta per essere “vista” ma per essere ingerita partecipando così al corpo mistico12. In realtà, forse l’argomento più consistente promosso dal
partito iconoclasta è un altro e, pur proiettandosi in una ra gione cristologica, riguarda l'ètimo stesso dell'antropologia cristiana. Non v’è alcun bisogno di alcuna immagine fabbri cata dall’uomo, di nessuna kakotechnia (come ci si esprime nelle risoluzioni del concilio iconoclasta dell’815), cioè di nessuna ‘cattiva procedura’, che non sarebbe altro che un colpevole artificio messo in atto dalla pittura figurativa e che induce all’adorazione della morta e disanimata materia. Non ve ne è alcun bisogno per la semplice, eppure a suo modo abissale ragione che già l’essere umano stesso è, fin dal det tato biblico, imago divina: immagine vivente, che parla e che respira. Anche questo argomento attraversa l’intera storia della crisi iconoclasta dai suoi antecedenti fino al suo com pleto dispiegamento. «Perché dovremmo formarci un’im magine materiale di Dio, quando l’uomo stesso è proprio l’immagine materiale di lui?», chiede nell 'Octavius il cristia no Ottavio al pagano Cecilio mentre stanno dialogando a passeggio sulla spiaggia di Ostia, in tempi, quelli appunto in cui visse Minucio Felice, in cui lo sforzo principale dei cri stiani era quello di opporsi (e di non cedere) all’idolatria pa gana*5. E cinque secoli dopo, quando la controversia ha or
12 Cfr. J.-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini ( 1997); trad. it. Einaudi, Torino 1999, pp. 216-8. 15 Cfr. D. Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 70.
23
mai acquisito un evidente carattere cristologico, il sinodo di Hieria anatemizza «chi si applica a fissare l’aspetto dei santi in icone inanimate e mute con colori materiali [...] invece di
riprodurre in sé stessi come icone viventi le virtù dei santi»1,1. Come —sul piano della perichoresis, cioè della misteriosa, si nergica relazione intradivina— il fare del Figlio e la sua dedi zione filiale fino allo strazio della croce rende visibile l’amo re del Padre permettendo la salvezza dell’umanità, così l’uo mo, nel suo agire, nella qualità cristiana del suo comporta mento, deve “iconicamente” tendere alla perfezione ultraterrena, anche se si tratterà sempre e comunque di una ten sione asintotica poiché egli sa bene che quella perfezione
non potrà essere raggiunta nella vita terrena. In questo sen so Agostino diceva che Gesù il Cristo d chiama a non esse re soltanto uomini, d chiama al fare alla luce dell’impossibi le, perché se non trascendiamo noi stessi allora non si ha fede nella trascendenza. Il Verbo si è fatto uomo, l’uomo — non per natura ma nella grazia— praticando le virtù cristiane può elevarsi spiritualmente e, direbbe Dante, indiarsi. Egli partedpa così del divino sul modello di ciò che accadde a Pietro, Giovanni e Giacomo, allorché sul monte Tabor non soltanto videro apparire davanti ai loro occhi il Cristo trasfi gurato nella luce supremamente diafana, ma loro stessi furo no investiti e partecipati dalla gloria divina. Quando il fedele traccia sul proprio corpo trascrivendovelo il segno della cro ce, diventa perdostesso, attraverso questo gesto di geroglifìa sacra, primo protagonista di quella che potrebbe chiamarsi una vera e propria iconosofìa vivente. Tanto più che nel mon do cristiano orientale il segno della croce non si fa —come nella liturgia romana— tenendo la mano distesa, ma con il
pollice, l’indice e il medio raccolti per indicare la confessione dell’unità nella trinità divina: tre persone, una sostanza. L’argomento -ormai sgandato dalla controversia, ma co munque inserito in una riflessione dottrinale sull’immagi ne— si ritrova in Tommaso d’Aquino. Proprio distinguendo-
H
24
Cfr. C. Schònbom, L’icona di Cristo, cit., p. 141.
la dall’inarrivabile qualità iconica di Cristo, egli precisa quel la dell’uomo definendola nei termini di una tensione al su peramento, di uno sforzo verso l’oltremondano:
«L’immagine di una data cosa può trovarsi nei vari soggetti in due differenti modi. Primo, in un soggetto della stessa natura specifica: come l’immagine del re si trova nel suo figlio. Secon do, in un soggetto di natura diversa: come l’immagine del re si trova nella moneta. Ora, il Figlio (di Dio) è immagine del Pa dre nella prima maniera; l’uomo invece è detto immagine nella seconda. Per indicare quindi che nell'uomo l’immagine è im perfetta non si dice semplicemente che l’uomo è immagine, ma a immagine, per designare cioè la tendenza alla perfezione. Del Figlio di Dio invece non si può dire che è a immagine del Pa dre, poiché ne è l’immagine perfettissima» (Summa theologiae, q. 93, a. 2). L’essere non “immagine” ma a immagine di Dio, dunque, è la definizione che nel linguaggio teologico di Tommaso si gla lo status iconico dell’uomo, e lo determina come colui che ricerca, tende, anela “mimeticamente” al Prototipo. Queste parole furono scritte quattro secoli dopo la fine del la terribile crisi iconoclasta che scosse l’intera cristianità, ma gli oppositori delle immagini certamente le avrebbero fatte
proprie. Prospettato il problema da questo vertice ottico, il parti to iconoclasta aveva tutte le ragioni nel contrapporre ai suoi
avversari questo argomento intrinseco all’antropologia cri stiana. Attraverso la mediazione del Figlio, solo l’uomo è la vera icona del Padre: lo è appunto al modo della tensione, del desiderio, dello sprone a esserlo nella maniera più com piuta. Se Cristo è «immagine del Dio invisibile» (Colossesi 1,15) e «impronta della sua sostanza» (Ebrei 1,3), nostro compito è Yimitatiti Christi, che ci impegna a diventare a no stra volta la sua immagine, la sua impronta, presi dal deside rio di anticipare, per quanto possibile, su questa terra ciò che sarà in cielo. «Sii tu stesso come un’immagine che sta da vanti agli occhi», scrive lo stesso Giovanni Crisostomo nella
25
Omelìa sulla lettera a Timoteo'5. Proprio per questo, essa può comportare quella fuga mundi di tipo ascetico, monasti co o addirittura eremitico che troviamo in qualche modo prefigurata prima da Luca («H Regno di Dio è dentro di voi», 17,21) epoi da Paolo nella Letteraa Tito (2,11-3).E17mttatto Christi —in cui il fedele si fa letteralmente cristo-foro,
‘portatore di Cristo’— non è null’altro se non la trasposizio ne-trascrizione-inscrizione dello spirito del Salvatore su di sé e in sé, l’unico modo per riconquistare-restaurare-richiamare quell’/OTdgo dei, quell’armonia edenica che il peccato originale aveva corrotto, inquinato, sfregiato. Tuttavia proprio questo argomento, e questa concezione, dell’icona vivente non fa che ricondurci di nuovo al proble ma dello statuto ontologico dell’immagine. Ciò che gli ico noclasti non comprendono (e resteranno per tutta la durata della controversia fermi sul punto) è che essa non è che non sia immagine se non riproduce fedelmente e senza difetto al cuno il modello originario. Anzi, e sembra un’owietà ricor darlo, un’immagine è davvero tale precisamente per quel tanto che si differenzia dal prototipo. Ciò era già chiarissimo nel Terzo discorso della Difesa delle immagini sacre (cfr. ad esempio 16 e 17) del Damasceno. Si tratta di uno scarto let teralmente istitutivo, di un’alterità senza la quale per l’ap punto non può darsi qualcosa come un’immagine, e dalla quale deriva il suo carattere parzialmente convenzionale. È
questo uno degli argomenti semiologicamente più sottili di Niceforo. Dio si è in-fìgurato in Cristo, che si è s-fìgurato, de-fìgurato nello strazio carnale della croce. È in questo
dramma (umiliazione di Dio, salvezza dell’uomo) che si esprime la formidabile dialettica tutta interna all’icona e al registro iconico tra la possibilità e l’impossibilità di rappresentare-rifigurare il trascendens, ciò che per principio va al di là di ogni rappresentabile-fìgurabile. Così l’incarnazione libera dall’idolatria non in maniera negativa, cioè soppri-
15 Passo non a caso citato dal Damasceno nel Terzo discorso (110) della sua Difesa delle immagini sacre.
26
mende, liquidando, bandendo ogni immagine, ma in manie ra positiva, cioè rivelando, nel Cristo che si è presentato, il volto di Dio rivolto verso di noi. E che, da allora, si può ri-presentare nella rappresentazione. Se l’immagine, all’op posto dell’idolo, rivela, proprio perché immagine, la sua dif ferenza dal prototipo, allora davvero l’icona sacra è a sua
volta il modello, V exemplum massimo di ogni immagine ge nuina, poiché è in sé stessa che si manifesta questa distanza, questa differenza: proprio dipingere il Volto rivela che la differenza non è abolita, superata, ma trattenuta, conservata nell’immagine che la svela in quanto tale. Sul piano tecnico-espressivo ne sono appunto prova, nell’icona dipinta, l’assenza di ogni realismo naturalistico, il radicale anti-illusionismo, la stilizzazione simbolica, che non sono lì altro che per rammentarci che non siamo davanti al suo modello ipercategoriale. Al punto che potrebbe dirsi — siccome l’iconografo sa bene che il suo è un compito di per sé incompibile e il suo problema ab initio irresolubile— che, pre cisamente quanto paradossalmente, è proprio il fallimento predeciso dell’intento iconico nel raffigurare l’irraffigurabile a esprimere e garantire al più alto grado la sua vera essenza e la natura stessa della preghiera in linee e colori con cui si iden tifica. In questo senso l’icona, proprio raffigurando il Verbo incarnato soltanto e unicamente nella sua ipostasi umana — cioè nella sua esistenza personale e individuale sussistente per sé— raffigura e in qualche modo misura il limite oltre il quale Cristo non è più rappresentabile nella sua natura divina. Ma qui diventa allora decisivo sottolineare che quella to tale identificazione che gli iconoclasti pretendono tra l’im magine e il suo modello, a ben vedere, non si realizza nem
meno all’interno del rapporto iconico prototipico, quello tra Padre e Figlio: perfino qui non è raggiunta la simmetria per fetta, anche perché altrimenti non si tratterebbe di un rap porto, di una relazione, che può stabilirsi soltanto tra diver si. II Figlio è della medesima natura del Padre (dunque con sustanziale così come gli iconoclasti vorrebbero fosse l’im magine), ma il Padre è archetipo —in quanto tale irraggiun
27
gibile, direbbe Kant16— e il Figlio è immagine dell’Archetipo, dunque in quanto immagine permane, anche se perfet tissima come dice Tommaso, nella dissimiglianza. Infatti il Figlio partecipa interamente e senza resto al Padre, ma il Pa dre, sia pure “relativizzandosi” ipostadcamente nel Figlio, non vi si dà, non vi si esaurisce per intero —Cristo avverte «Chi vede me vede il Padre» (Giovanni 14, 9), ma non ag giunge forse «H Padre è più grande di me» (Giovanni 14, 28)?— anche se la paternità (dunque il rapporto iconico-filia-
le) inerisce originariamente al Dio cristiano, è intrinseca alla sua natura, poiché Egli (a differenza di quanto sosteneva l’e resiarca Ario) è già sempre Padre, ancor prima che nascesse uomo il Figlio. Ed ecco perché quest’ultimo conserva (pun to essenziale per la teologia iconodula) la sua somiglianza con il Padre anche incarnandosi. Nel De civitate dei, Agosti
no pensa il Cristo come segno visibile del Dio invisibile sul modello della voce che manifesta il pensiero: «Come il suo no, infatti, d fa sentire un pensiero, sorto nel silenzio dell’in telligenza, senza coincidere con esso, così anche la forma nella quale è apparso Dio, per natura invisibile, non coindde con lui. Egli era visto nella forma corporale, così come
quel pensiero è percepito nel suono della voce» (x, 13). Né Dio si “risolve” in Cristo né il pensiero nella voce, anche se la differenza è comunque che Dio, generando il Verbo, ge nera appunto ciò che a Lui è già da sempre assolutamente intrinseco e non è possibile pensare a un Dio che nella sua natura già non sia costitutito come Padre nel Figlio, mentre
la stessa cosa non può sostenersi per il rapporto tra il pensie ro e la voce. L’icona è dunque quella somiglianza dissimile di norma evocata in un rapporto di filiazione: in essa si presentifica la distanza e si fa memoria dell’invisibile. Nel linguaggio della filosofia greca (quello in cui tutta la controversia iconocla sta, con le sue acrobatiche sottigliezze speculative, si è espressa) si potrebbe anche dire che gli avversari dell’imma-
16
28
I. Kant, Enciclopedia filosofica, trad. it. Bompiani, Milano 2003, p. 105.
gine non hanno mai compreso che il typos —impronta itera bile, fonte di forme particolari, determinate, replicabili— è un destino inscritto nell'idealità-invisibilità dell’ezì/or come possibilità (necessità) della (sua) ripetizione; non hanno mai compreso che l’idea è un modello proprio nella misura in cui può essere imitata, raddoppiata17* . Il logos-Verbo incar nato potrebbe dirsi, sotto questa prospettiva, la prima Ripe tizione, la prima memoria dell’e/Jor, il primo typos che ripe te come medesimo (nel senso sostanzialistico) il Padre: l’in-
visibilità divina può sì essere “ripetuta” e “riprodotta” nel vi sibile, ma dal Figlio soltanto. Gli iconoclasti pretendevano di poter “sostare" nella pura trascendenza (e forse questo è il
punto della loro massima vicinanza ideale all’ebraismo e all’i slam); gli iconoduli capiscono che è necessario “transitare” per l’icona, nella quale si contempla al tempio stesso l’indici bile e il rappresentato: non l’uno o l’altro, ma l’uno nelf altro. Non c’è un visibile in sé perfettamente defìnito-determinato cui in un secondo tempo e come incidentalmente si ag giunge un invisibile che lo trascende risultandone in tal modo il limite esterno, la pellicola che lo racchiuderebbe proteggendolo. L’invisibile è immanente al visibile, non ap pare per sottrazione che in esso, si mostra o avviene come non visto nella medesima deiscenza di ciò che si manifesta alla visione, così come l’incarnazione inerisce per essenza al
Dio cristiano. L’assoluto, se è veramente tale, è anche il suo altro, non può non passare attraverso, non può non “sop portare” il proprio contrario, così come l’essenza non è real mente tale se non si manifesta -celandosi e innervandola— nell’apparenza. Misteriosamente, in un movimento silenzio so che non cessa di stupirci «con ogni boccone visibile», scrive Kafka, «si riceve anche un boccone invisibile, con ogni veste visibile, anche una veste invisibile»1*. È la visibili
17 II riferimento d’obbligo è a J. Derrida, La farmacia di Platone, in La disse minazione (1972); trad. it. Jaca Book, Milano 1989, in particolare pp. 72-89. 1S E Kafka, Gli otto quaderni in ottavo, in Confessioni e diari, trad. it. Mon dadori, Milano 1972, p. 751.
29
tà stessa a comportare una invisibilità. E questa per il fedele non è soltanto il “doppio fondo" della visione, ma anche in qualche modo una mèta da raggiungere, un compito cui as solvere: che l’icona, nella sua dimensione protrettica ed energetica, stimola e accompagna. Se è vero che l’iconocla smo pretende quell’immagine senza differenza che abbiamo
visto a rigore non possiamo trovare neanche nella perfezio ne iconica del Figlio, allora proprio esso incorre nell’idola tria (da questo punto di vista, lo abbiamo accennato, para gonabile a una sorta di eccesso iconosofo) che deriva appun to dall’oblio della distanza incolmabile tra le facoltà umane e l’alterità divina, ne misconosce e rimuove lo scarto: l’idolo, infatti, è il dio. L’icona, al contrario, si fonda sullo statuto differenziale che è ontologicamente inerente all’immagine, vive e si alimenta su tale presupposto, convoca questa diffe renza nel luogo fenomenico del suo mostrarsi in quanto tale19. Perciò l’icona esibisce e spazializza l’invisibile nel sen so che lo raffigura, lo ritrae nel suo ritirarsi: ne mostra per intero la dialettica e il legame antinomico che intrattiene con il visibile. Dum patet, latet: ‘Mentre si mostra, si cela’. H Gesù umano che patet è simbolo ipostatico del Cristo divino che latet. L’icona mostra sì il “ritiro” di Dio, ma questo riti ro è insieme e nello stesso istante l’offerta del Figlio in cui il Padre fa kenosis, cioè si abbassa e si “svuota" per venire in contro all’uomo —«pur essendo nella condizione di Dio [...] svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo» (Filippesi 2, 6-7)— e per donarsi a lui. L’infinita differenza-distan za tra divinità e umanità viene salvaguardata, custodita ma proprio per questo resa percepibile nel Volto: l’umanità dell’uomo Gesù è la forma espressiva della divinità del Fi
glio eterno che con quell’umanità si mantiene unita nella dif ferenza teandrica, cioè nel chiasmo tra divino {theos) e uma no (anthropos). Nel linguaggio teologico della patristica gre ca posteriore allo Pseudo Dionigi Areopagita (v o vi secolo)
19 Cfr. sulla differenza tra idolo e icona J.-L. Marion, Lidolù e la dutanza (1977); trad. it. Jaca Book, Milano 1979, in particolare pp. 13-20 e 205-50.
30
—il primo esponente del «cristianesimo estatico»20- ‘tean drico’ (dal greco theandrìkos) indica il carattere duplice — senza confusione e senza separazione, secondo il credo del
Concilio di Calcedonia (451)- delle operazioni di Cristo. In tal modo l’icona esprime la sinergica, “ordinata” compene trazione tra Padre e Figlio, tra l’essenza divina e la sua ipo stasi personale, il suo tropos, il suo ‘modo’ umano: essa è scarto che unisce, differenza che accomuna, distanza che av vicina. Gli iconoclasti non negano —né ovviamente potreb bero farlo- l’incamazione, presupposto (fu Giovanni Da masceno, abbiamo visto, il primo a sostenere teologicamen te questo argomento) della possibilità di rappresentare il Cristo. Piuttosto, da un lato ne mettono in dubbio la realtà dunque i rapporti tra Dio e il mondo, tra la grazia e la natu ra; dall’altro non ne comprendono lo statuto intimamente antinomico, “illogiòzzabile”, che spinge Gregorio di Nissa (335-394) —assieme al fratello Basilio di Cesarea e a Grego rio di Nazianzo (329-390), il principale esponente dei Padri cappadoci, colui che ha formulato definitivamente la teolo gia trinitaria dell’Oriente cristiano— a dichiarare che l’imma gine, pur essendo identica al prototipo, è però al contempo diversa. Certamente essa si mostra in quanto mistero: epperò, appunto, esibisce un mistero che si mostra, si comuni ca, si dona alla visione. Questo delicatissimo equilibrio anti
nomico, questa inaggirabile dialettica è espressa in modo speculativamente raffinatissimo da Massimo il Confessore (580-662), il più grande teologo della tarda epoca patristica: «Nel suo aspetto, era identico e noi; infatti, nel suo sconfinato amore per l’uomo ha accettato di divenire creatura ma senza mutamento della sua divinità: così divenne immagine {typos) e simbolo di sé stesso. Egli si è mostrato in modo simbolico a partire da sé stesso; ha condotto l’intera creazione mediante sé stesso, in quanto visibile, a sé stesso in quanto invisibilmente, totalmente nascosto»21. 20 21
H. Ball, Cristianesimo bizantino (1923); trad. it. Adelphi, Milano 2015, p. 81. Cfr. C. Sehónbcm, L’icona di Cristo, eit., p. 123.
31
Nell’ambito della patristica, il paradosso teologico di un dio invisibile che pur restando tale si fa visibile, lo troviamo già nella Lettera in dello Pseudo Dionigi: Cristo rimane na scosto «anche dopo la sua apparizione o, per esprimermi in termini più divini, nella sua stessa apparizione»22* . Massimo il Confessore, con il suo mirabile acume filosofìco-teologico,
sviluppa il paradosso fino all’estrema sintesi cristologica. Se, come scrive Paolo, è Dio che ha fatto risplendere la cono scenza della sua gloria «sul volto di Cristo» (2 Corìnzi 4, 6), allora il volto visibile di Gesù il Cristo è simbolo (sym-ballein, ciò che lega i differenti) del volto invisibile, che tuttavia perciostesso non permane in un al di là alieno all’umano e indefinitamente trascendente. Se in Cristo visibile e invisibi le sono uno, allora il visibile come apparenza percepibile, manifestazione estetico-sensibile, non ci conduce ad altro che a sé stesso ma in quanto nascosto, al sé stesso celato alla visione. Ecco perché precisamente l’icona di Cristo che raf figura il Verbo incarnato aiuta a comprendere che la sua na tura divina non può essere rappresentata. Il Cristo, afferma Massimo il Confessore, è «simbolo di sé stesso», e questo si gnifica che Egli, sigillo vivente della sinergia tra umano e di
vino, tra finito e infinito, è via, odos verso sé stesso, ci fa giungere da sé stesso a sé stesso. L’unione ipostatica di cui l’icona è testimonianza in linee e colori rifiuta la separazione mantenendo la differenza. Scrive Giovanni Scoto Eriugena «Dum silet, damat, et dum clamar, silet; et invisibilis videtur, et dum videtur, invisibilis est» (De divisione naturae ni, 4). 'Mentre tace chiama (annuncia) e mentre chiama tace; e l’invisibile si vede (si presenta), e mentre è visto è inrisibile’. Tutta la teologia dell’icona —che così profondamente si inne sta nella lotta contro le eresie cristologiche del tempo— è una strenua difesa di questo carattere radicalmente, irreversibil mente antinomico della fede cristiana. * * -fr
22 P. Dionigi l'Areopaglia, Gerarchia celeste. Teologia mistica. Lettere, trad, it. Città Nuova, Roma 1986, p. 120.
32
Uno dei motivi centrali della speculazione patristica in difesa delle sacre icone -già vi abbiamo accennato- è l’affer mazione del vincolo dialettico di immagine e scrittura. Se Giorgio Piside -diacono e poeta ufficiale deH’imperatore Eraclio- chiamava “scrittura non scritta” l’immagine acheropìta (cioè non fatta da mano d’uomo), nelle risoluzioni del
rv Concilio costantinopolitano (870) -che in questo punto riprendono alla lettera le parole di Basilio Magno— si stabili sce una volta per tutte, ormai conclusa la controversia con la vittoria dell’ortodossia, che davanti all’icona di Cristo «ci si prostri così come si fa davanti al libro dei santi Vangeli. Come infatti tutti otteniamo salvezza dalle lettere contenute in esso, allo stesso modo tutti, letterati e analfabeti, ricevono la loro parte di beneficio dall’energia iconica (eikonurgias) dei co lori che sono a loro disposizione, poiché ciò che la parola (lo gos) annuncia e rende presente con i suoni, lo stesso il disegno (graphè) annucia e rende presente con i colori (en chromasi)^.
Già il secondo concilio di Nicea affermava che la rappre sentazione pittorica -nell’ambito delle tradizioni non scritte-
«è apportatrice di un benefìcio simile a quello del racconto evangelico, giacché cose che alludono reciprocamente l’una all’altra senza dubbio recano il riflesso l’una dell’altra»24.Vi abbiamo già accennato: parola e immagine sono equivalenti; linguaggio e visione si completano vicendevolmente e in pa rallelo nella trasmissione e nella diffusione del messaggio evangelico. La parola è immagine parlante, l’immagine è pa rola silenziosa, vi sono intime concordanze tra discorso e ico na, evento della parola ed evento della visione, filosofìa come amore della sapienza e fìlocalia come amore del bello. In greco i termini graphè, grapheìn rimandano alla radice comune dello scrivere e del disegnare-dipingere, associati nella medesima attività di segnare stabilmente su di un sup-25
25 Cfr. Conàliorum oecomenicorum decreta. Istituto per le scienze religiose, Bologna 1973, p. 168. 24 Cfr. Vedere Finvisibile. Nicea e lo statuto dell’immagine, cit., p. 147.
33
porto, di incidere, scalfire materialmente una superfìcie. Così il logographos sarà lo scrittore-poeta che scrive parole; lo zoograpbos sarà lo scrittore-pittore che scrive immagini direttamente tratte dalla vita. Quando Gregorio di Nissa, per differenziarla dalla sostanza (ousia) che è un concetto in determinato, comune e generale, definisce l’ipostasi come
quel concetto «che delimita e circoscrive attraverso caratte ristiche peculiari» l’istanza specifica del singolo e della sua esistenza individua e personale, egli usa il termine perigrapbè, pengraphetn, che significa appunto ‘circoscrivere’, ‘tracciare il contorno’, ‘delimitare'-5. Ma com e possibile, so stengono gli iconoclasti (questo era l’argomento principale e su questo punto specifico più insidioso di Costantino V e del Concilio di Hieria), circoscrivere (disegnare, dipingere) la so stanza divina di Cristo? Non è forse essa supremamente incircoscrivibile, cioè irrappresentabile, irraffìgurabile perché alla lettera inimmaginabile? Si può ritrarre una persona che non è solo umana? Agli iconoduli viene così posto un dram matico aut-aut, che in realtà è però una condanna pregiudi ziale poiché entrambe le scelte che esso contiene portano verso l’eresia. O affermano che l’icona raffigura soltanto l’u manità di Cristo, incorrendo così nell’eresia nestoriana dal momento che ne vengono separate le due nature. Oppure pretendono che essa rappresenti il Cristo sia Dio sia uomo, incorrendo in tal modo nell’eresia monofisita che confonde l’elemento umano e l’elemento divino. La prima eresia fu condannata nel Concilio di Efeso (431); la seconda nel Con cilio di Calcedonia25 26. Certamente non v’è alcuna possibilità di circoscrivere-delimitare in una rappresentazione, in quanto tale finita, l’o«-
25 Cfr C. Scbónbom, L'icona di Crino, cit. p. 25. Sull'essenza fenomenica del contorno ha straordinarie osservazioni Florenskij nelle lunghe pagine di Ikortoslas dedicate alla «metafisica concreta» dell’icona, cfr. in pan. pp. 150-1. 26 È probabile che una delle fonti del dibattilo suH’incircoscrivibilità dell’e lemento divino possa trovarsi nei Memorabilia di Senofonte (ut, 10) ove So crate, in dialogo con il pittore Parrasio e lo scultore Cleito, si interroga sull’ef fettiva possibilità di rappresentare visivamente la ptycbè, l’anima.
34
sia, l’infìnita sostanza divina. Ma proprio la questione posta dal partito iconoclasta ci riporta ancora alla sua concezione consustanziale, quindi mitico-magica dell’immagine come qualcosa che debba appunto, per essere davvero tale, perfet tamente e senza residui delimitare, racchiudere nel senso di “esaurire” ontologicamente, “concludere” mimeticamente, “clonare" potremmo addirittura dire, il suo modello. Pre supposto degli iconoclasti, infatti, è l’identificazione della perigraphè con l’immagine. Ma graphè non può affatto con siderarsi identico o immediatamente equivalente a peri graphè'. raffigurare una persona non è “circoscriverla ”, an che perché la relazione tra l’immagine e il prototipo —già lo
sappiamo, è l’argomento “semiologico” di Niceforo— non è essenziale- sostanziale bensì formale-funzionale27. Disegnare-dipingere non è sinonimo di circoscrivere (la circumscriptio della teoria dell’arte, vedremo tra poco), non coincide di rettamente con l’atto di confinare entro un limite, anche se certo raffigurare un oggetto significa tecnicamente, prima di ogni altra cosa, circoscriverne la forma: ma questo per la ra gione che un corpo è già per sua natura circoscritto, e tratto essenziale dell’ente —e di conseguenza della sua rappresen tazione— è quello di denunciare un limite che lo con-figura (ed un luogo, vedremo, che lo “accoglie" nel suo contorno). Il logos, la Parola, incarnandosi nell’uomo Gesù, ha as sunto un’espressione, un carattere intuibile dalla percezione visiva. Charakter è il tratto mimetico, la traccia incisa con in tento espressivo, referenziale, designativo, ed è il termine utilizzato nel canone 82 del Quinisesto, il sinodo costantino politano del 692 (detto in Trullo, dal luogo del palazzo im periale ove si svolse) che stabilì il passaggio della rappresen tazione di Cristo da agnello a figura antropomorfa:
& È importante ricordare inoltre che Niceforo è il primo teologo che, nel suo terzo Anhrrbehaji scritto tra 1’817 e 1'828, cioè subito dopo la ripresa dell’iconoclasmo da pane degli imperatori, riconosce i “diritti’’ die la sfera del Bello e deU’Omamento hanno sull’immagine, il primo insomma ad aprire una riflessione di natura estetica nell’ambito della controversia, cfr. A. Gra bar, Licortoclasme byzintin, cit., pp. 197-200.
35
«Anche se veneriamo, secondo la tradizione della Chiesa, gli antichi tipi e le ombre che ci sono stati tramandati come sim boli e prefigurazioni della verità, preferiamo la grazia e la veri tà stessa come compimento della Legge. E perché almeno in immagine questo compimento stia davanti agli occhi di tutti, disponiamo che d'ora in poi sulle icone, al posto dell’antico agnello, vengano dipinti i tratti umani (charaktera) di Cristo nostro Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Infatti noi capiamo così la profondità dell’abbassamento della Parola di Dio e veniamo così condotti a ricordarci della sua vita nella came, del suo patire, della sua morte salvifica e della salvezza del mondo in tal modo operata»28.
La possibilità di raffigurare il Cristo non più simbolicamente ma nei suoi tratti umani è qui espressamente concepi ta come una conseguenza “logica” dell’incarnazione tramite la quale Dio ha fatto kenosis {Filippesi 2,7 : heautou ekénosen ), ha fatto in sé il vuoto per farsi uomo, si è abbassato al suo li
vello. Questo e non altro vidima, autorizza, legittima l’immagine. Ciò che fa dell’icona il volto di Cristo non è la sua perigrapsia, la sua ‘drcoscrivibilità’ (che è comunque appun to intrinseca a ogni corpo in quanto tale, e Gesù era un cor po), ma il suo charakter, vale a dire ciò che fornisce a quel contomo il tratto mimetico, il grafo della rassomiglianza: cioè ne fa una vera e propria immagine. Non Yagnus astrat tamente simbolico, ma il charakter come marcatura espressi va, come riproduzione visibile dell’aspetto umano, è il lato intuibile del logos eterno che donandosi si lascia percepire dal senso della vista. L’icona attesta dunque la visibilità del la persona divino-umana del Cristo, e in essa contempliamo,
sotto l’aspetto della carne, la gloria divina, che è tanto po tente da mostrarsi nel suo contrario. Ciò che l’icona rappre senta —nella concretezza dei suoi tratti distintivi, singoli, in dividui— non è, ripetiamo, la natura ma la persona di Cristo;
28 Cfr. C. Schònbom, L'icona di Cristo, cit. p. 164. Sull’economia del tratto, cfr. il ns. De! tratto. Attraverso Heidegger, Ben/amin, Derrida, in “aut-aut", 220-221,1987.
36
raffigura la relazione, la soglia tra l’elemento umano e l’ele mento divino, il loro reciproco coinvolgersi senza confusio ne. Essa fa memoria del fatto che, se Dio non “esiste” perché non si pone al livello dell’esistenza creata, Gesù il Cristo è al lora — secondo la formula di Gregorio di Nazianzo, per cui il logos divino si ‘condensa’29— la “condensazione”, l’esisten za di ciò che non “esiste”. Dio si partecipa nel Figlio che è a lui somigliante perché sua «irradiazione» (Ebrei 1,3): ma ciò non significa forse che l’Incircoscrivibile si inscrive per sua propria insondabile scelta nel circoscrivibile? Questo non comprendono gli iconoclasti: non comprendono che, per usare una parafrasi heideggeriana, il Terribile è già accaduto. E soprattutto, e di conseguenza, non comprendono che, nel la sua essenza donativa, questo “Terribile” salva. La teologia iconoclasta resta ferma, bloccata sulla domanda inerente al perigraphein, cioè di come può l’incircoscrivibile essere cir coscritto; nega dunque, fedele alla tradizione platonica di svalutazione deU’et&off, dell’immagine, e influenzato dal co evo aniconismo dell’IsIam allora nascente, che Dio possa manifestarsi; nega che esso sia capace di negarsi per amore e che Cristo possa essere icona vivente di questo amore; di mentica come Dio sia infinitamente capace di dimenticarsi proprio allo scopo di ricordarsi dell’uomo; dispera, si po trebbe aggiungere, della capacità divina di autotrascendersi, cioè di amare. Che cos’è mai la kenosis, l'abissale abbassa mento-svuotamento di Dio nella carne di Cristo Gesù, se non la decisione, la scelta di “autocircoscriversi” in un corpo mortale per salvare l’umanità? Già Cristo è assunzione della perigraphè-, già la Parola ha limitato, ri-tratto sé stessa facen dosi carne per esprimere e comunicare il divino nell’esisten
za umana singola e individua dei tratti personali di Gesù; già il Padre circoscrive sé stesso per parteciparsi -attraverso suo
29 Prima di essere inglobato nel lessico trinitario, hypostasis -che dal neo platonismo in poi viene a significare ‘esistenza’- significava ‘residuo’, ‘sedi mento’. Cfr. su questo punto G. Agamben, L'uso dei corpi, Neri Pozza, Vicen za 2014, pp. 179-91.
37
Figlio in cui trova un limite, accetta una forma- all’umanità. L’icona non fa altro che con-seguire a questa decisione iperiniziale quanto misteriosa, a questa scelta archetipica quan to imperscrutabile. Per questo, l’incamazione divina è il fon damento dell’immagine, della sua possibilità. La funzione analogica -quella che più da vicino caratterizza l’elemento
mimetico-riproduttivo dell’immagine— deve essere superata dalla funzione anagogica —quella rivolta al senso simbolico-spirituale— riaffermando così la trascendenza dell’invisi bile che sì mostra sé nel visibile, ma che questo non esauri sce tantomeno sostituisce. Non è un caso se Teodoro Studi la sosteneva -già lo abbiamo richiamato- che la persona di Cristo è incircoscrivibile e circoscrivibile nello stesso tempo: incircoscrivibile secondo la natura divina, circoscrivibile se condo la natura umana. Credo quia absurdum est: questo re
sta il grande, irriducibile scandalo della fede cristiana. E d’altra parte anche il corpo resuscitato di Cristo non è forse un corpo, certo incorruttibile, ma «in carne e ossa» che mangia «pesce arrostito» (Luca 24, 39), quindi non è forse un ente finito, dunque circoscrivibile, cosa questa —nono stante l’apparenza del contrario- confermata, enfatizzata
proprio dal fatto che quel corpo passa attraverso le porte chiuse (Giovanni 20, 19 e 26) pur non essendo affatto un fantasma (Luca 24, 37 e 39)? Nulla nell’aspetto del risorto, nei suoi tratti, nei suoi charaktera, è mutato rispetto a quello già conosciuto dai discepoli. Nell’episodio del Noli me tan gere (Giovanni 20, 11-19), il corpo appena resuscitato non può essere toccato-trattenuto, epperò è visto da Maria di Magdala («Ho visto il Signore!» annuncia ai discepoli). E proprio la difficoltà da parte della donna di riconoscerlo al
primo sguardo —la stessa difficoltà dei due discepoli che lo incontrano sulla via di Emmaus (Luca 24, 16)- anche qui conferma ed enfatizza il fatto che l’intera scena è organizza ta attorno al registro visivo. È il corpo carnale a ri-velare il corpo glorioso del Figlio che sta per ascendere al Padre, ma il corpo carnale non “esaurisce”, non dissolve, non dà fondo al corpo glorioso. Il “realismo” corporale è sì immanente e
38
“contemporaneo” all’elemento divino, ma questo non cessa di delocarsi nell’invisibilità. Nella prima mattina del mondo redento perché la morte è stata sconfìtta, Gesù risorto parla a Maria di Magdala solo per dire che è già altrove, che sta prendendo congedo, che si sta allontanando: come sarà poi nella sua immagine iconica, la sua presenza consiste nel ri trarsi10. Così in Emmaus: non appena i discepoli che lo han no convinto a cenare con loro, lo vedono spezzare il pane, lo riconoscono come il Messia risorto; ma proprio in quel mo mento «egli sparì dalla loro vista» (Luca 24, 31). Visibilità e invisibilità si alternano continuamente, ma possono farlo soltanto perché sono immanenti l’una all’altra, perché al
fondo sono misteriosamente uno. Ed è questo e non altro che l’icona testimonia.
*** A questo punto della nostra analisi sarà allora interessan te notare che, nella teoria delle arti, l’istanza dell’inrisibilità emerge anche all’interno del plesso arcwwrcnp/rò-disegno — perno e presupposto della rappresentazione figurativa- ad
dirittura come imo dei suoi tratti istitutivi. Nella Naturalis Historia, Plinio ci narra circa le origini dell'arte del disegno. La fanciulla Butadès si innamorò di un giovane. Dovendo questi partire, ella, sfruttando la luce di una lanterna, tracciò i contorni dell’ombra del suo viso pro iettata sulla parete: «capta amore iuvenis, abeunte ilio pere-
gre, umbram ex facie eius ad lucemam in pariete liniis circumscripsit» (xxxv, 15). H disegno nasce dunque come rappresentazione sostitutiva e compensatoria di ciò che sta
partendo, che sta congedandosi; nasce come skiagraphia, memoriale 'scrittura di ombre’ (uno dei nomi greci della pit tura) dell’amato che si allontana. Precisamente e unicamen te la sua partenza dà origine, muove al disegno. Nella sua
w Cfr. J.-L. Nancy, Noli me tangere. Saggio sul levarsi del corpo (2005); trad, it. Bollati Borighieri, Torino 2005.
59
stessa genesi costitutiva, esso si riferisce a qualcuno o qual cosa in procinto di mancare, all’assente, a ciò che ci lascia o è sul punto di farlo. Già nel suo mito fondatore, dunque, l’arte del disegno non deriva dall’osservazione diretta della realtà visibile, dalla sua percezione immediata, ma da una proiezione, da una riduzione o un affievolirsi di quella real
tà. L’ombra circoscritta dal tratto rinvia a una presenza inde bolita e mediata, filtrata e insostanziale. All’origine della perigrapsia, della 'circoscnvibilità' che dovrebbe aprire e so vrintendere all’intuibile della riproduzione visiva, non ce tanto la percezione vivente e attuale ma la possibilità —que sta sì, sempre presente o sempre imminente— dell’oblìo, non la partecipazione piena ma la sottrazione e lo scarto. Sta alla radice del disegno la cosa, il reale mentre si ritira, l’essere mentre dilegua: è perpetuamente e per statuto sospeso tra il visibile che viene ritratto e l’invisibile in cui esso si ritrae51. Un altro esempio di questa dialettica lo troviamo nel De pictura di Leon Battista Alberti. La circonscrizione è certo il
primo atto della techne pittorica, ma intanto è importante sottolineare subito che essa non delimita un ente, una cosa, un oggetto,un corpo; delimita piuttosto il luogo che va a oc cupare: «Principio, vedendo qualcosa, diciamo questo esser cosa quale occupa uno luogo; qui il pittore, descrivendo questo spazio, dirà questo suo guidare uno orlo con linea es sere circonscrizione» (6, 3-4)52. L’orlo attornia e racchiude un luogo, de-scrive il suo spazio, prima di caratterizzare un oggetto; il bordo circoscrive ima possibilità prima di una presenzialità, un’assenza prima di una presenza, una virtua
51 Rimandiamo di nuovo al ns. Del tratto, rii., e alla Prima Pane (Cnxewa) del ns. Non vedi niente lì? Sentieri tra arti e filosofie del Novecento, Castelvecchi, Roma 1999. Questa sottrazione costitutiva implicata alla radice della pra tica del disegno è al centro del libro di J. Derrida, Memorie di cieco. L'autori tratto e altre rovine ( 1990); trad. it. Abscondita, Milano 2003. 5- Seguiamo la sistemazione redazionale proposta da Lucia Benolini, Polistampa, Firenze 2011. Sull’importanza del concetto di luogo nelT Alberti e sulla sua diretta ascendenza da) libro A della Fisica di Aristotele, cfr. P. Rocca secca, Filosofi, oratori e pittori. Una nuova lettura del Del pictura di Leon Bat tista Alberti, Campisano, Roma 2016, in particolare pp. 239-40.
40
lità prima di un’attualità; il contorno delimita prima di un corpo la sua pre-condizione, quando il corpo ancora non c’è. Non solo. Cruciale è qui per noi che questa scrittura dei
margini —Alberti parla del pavimento da raffigurare come «scritto con sue linee e paraleli» (9,7)— occorre «ch’ella sia di linee sottilissime fatta, quasi tali che fuggano esser vedute» (7,6) (corsivo nostro). La linea di contorno, proprio quella che rende possibile la determinatezza dell’apparenza visiva, la sua percezione oggettuale (torneremo più avanti su questi motivi), deve risultare cosi sottile, deve tracciarsi in modo tanto inapparente e impercepibile da confinare con l’invisibilità stessa. Lo stesso Plinio nella Naturalis Historia aveva già affermato che un’efficace riuscita visiva delle linee di contorno è la cosa più difficile da ottenersi, poiché esse han no a che fare con l'estremità dei corpi, con i margini degli oggetti, laddove l’essere confina con il non-esser-più: «exter na corporum et desinentis picturae modum includere rarum in successu artis invenitur» (xxxv, 6-8). La difficoltà sta dun que nel saper conchiudere il giro dei piani di scorcio della fi gura (che proprio attraverso questa operazione nasce a sé stessa) in un limite attomiante, in un orlo che fascia; nel si gillarlo e insieme abolirlo in quel luogo illocalizzabile ove termina l’oggetto raffigurato e il determinato sfugge e scom pare nell’indeterminato. «Ambire enim se ipsa debet extremitas et sic desinere ut promittat alias post se ostendatque quae occultai» (Ibidem)-, la linea di contorno deve girare su sé stessa come sul proprio asse, in modo che chi osserva sia indotto a immaginare ulteriori piani invisibili al di là della circumscriptio visibile. Ciò che è visibilmente afferrabile lo è sempre solo a partire da uno sfondo di inafferrabilità, lo è solo a partire della percezione di un’assenza. Torniamo così allo statuto differenziale dell’icona come perigraphè che mostra la distanza tra il divino in sé e il suo volto per noi. Della natura divina di Cristo non può darsi al cun perigraphein, non si può scrivere-disegnare alcun limite delle sue “superfìci” poiché essa non occupa alcun luogo fi gurabile nel senso di circoscrivibile, si mantiene oltre ogni
41
possibilità di tracciarvi intorno, e così racchiuderla, un am bitus, un bordo, un confine. In questo senso Cristo non è weZZ'icona; anzi, vi si ritrae. Ma l'icona è precisamente il luo go ove può ritrarsi. Non è che in essa il circoscrivibile supe ri e sia più forte dell’incircoscrivibile; piuttosto, senza di esso l’incircoscrivibile nemmeno potrebbe conoscersi come tale, cioè come mistero. La circumscriptio che dà luogo all’i cona non è la delucidazione che porrebbe fine al mistero, ma la sua esposizione. È il mistero finalmente illuminato ma non risolto, dunque finalmente riconosciuto come tale. Tor neremo su questo motivo: se non viene offerta nell’imma nenza, la trascendenza è per-niente e niente può trascende re. La verità incircoscrivibile, per rimanere tale, deve donar si, come tale, nel circoscrivibile; e quest’ultimo intrattiene sempre fin dalla sua genesi un rapporto radicale, essenziale e fondativo con ciò che gli sfugge, che deve sfuggirgli. È per
questo che il Cristo non è “catturato", “racchiuso”, “impri gionato" nella sua raffigurazione iconica, come gli iconocla sti pensavano che i difensori delle immagini pretendessero. A ★ ★
Se intendiamo seguire fino ai suoi ultimi sviluppi il vinco lo dialettico che sostiene la teologia dell’icona, dobbiamo al lora ricordare che l’intuibilità del suo corpo ipostatico non abbandona Cristo nemmeno nella trasfigurazione, quando appare in pura luce e pura gloria. Sul monte Tabor (il “nuo vo Sinai", dove ha luogo la seconda rivelazione escatologica, anticipazione della definitiva assunzione gloriosa alla destra del Padre) Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo, e si mostra conversare con Mosé ed Elia. Matteo (17, 1-8) e Marco (9, 2-8) raccontano l’episodio in termini per così dire oggettivi, esterni, impersonali, utilizzando la stessa espressione: «fu trasfigurato davanti a loro». Invece Luca (9,28-36) dà notizia di un ruolo in qualche modo attivo e personale dei tre discepoli: «videro la sua gloria e i due uo mini che stavano con lui». Gesù appare in una luce totale, as
42
soluta, perfettamente diafana, senza alcuna possibile giustap posizione di campì cromatici che possa permettere lo sta gliarsi e il definirsi di una figura di contro a uno sfondo55. Ep
pure —il testo di Luca non lascia dubbi— i discepoli videro corpi delimitati e perciostesso circoscritti così come si addice alla natura e alla costituzione stessa di ogni corpo finito, an che a quello dell’umanità glorificata e poi risorta del Cristo circonfuso di luce taborica54. Qui, in qualche modo parados sale, la divinità di Cristo si fa corpo sì perfettamente diafano, eppure corpo intuibile che Pietro, Giovanni e Giacomo effet tivamente vedono nel medesimo modo in cui vedevano il Gesù umano. L’episodio del monte Tabor è nei Vangeli -as sieme a quelli appena ricordati circa il risorto— uno tra quelli in cui più evidente appare la concordia diacor.s tra l’invisibilità divina e la visibilità della persona -individua, caratterizzata
eppure teandrica— di Cristo. Che nel racconto della trasfigu razione si succedono alternandosi una dopo l’altra. Quando Elohim gli parlò sull’Oreb {Deuteronomio 4, 15), il popolo ebraico udì soltanto una voce, non vide alcuna forma, alcuna figura, niente di percettivamente delimitato-circoscritto che si stagliasse contro uno sfondo. La venuta di Cristo, la sua in carnazione, è lo spartiacque che sposta l’evento teofanico dal registro dell’udibile al registro del visibile, che per certi versi e in certe occasioni viene condotto fino al registro del tattile. Non è un caso che l’episodio della trasfigurazione prosegua con l’entrata in scena della voce di Dio: «venne una nube che
55 Nell’O/nói di Tolomeo la giustapposizione di colori contrastanti è la con dizione perché qualcosa emerga alla determinatezza visiva, cfr. P. Roccasecca, Filosofi, oratori e pittori, cit., pp. 241 e 245. 54 E Niceforo a insistere particolarmente su questo realismo cristologico: «se anche il corpo assunto da Dio viene interamente divinizzato [...] esso non cessa tuttavia di essere corpo». La stessa posizione è in Teodoro Studila: «l’i cona non possiede alcuna unione naturale con la divinità (e questo non vale neppure del corpo divinizzato di Cristo! )», cfr. C. Schònbom, L'icona di Cri sto, cit., p. 190 e p. 201. L'opera del patriarca Niceforo è al centro dello stu dio di Marie-José Mondzain, Immagine Icona Economia. Le origini bizantine dell'immaginario contemporaneo (1996); trad. it. Jaca Book, Milano 2006, im portante anche per il significato specificamente economico della kenosis.
43
li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce» (Marco 9, 7). In Matteo (17,5) la nube è «luminosa», ma è chiaro che si tratta di una luce che abbaglia, acceca e nulla lascia intuire
alla vista (dovremo riprendere più avanti tutti questi motivi). Il visibile lascia il posto all’udibile e i discepoli non vedono più davanti a sé niente di “figurale’’ (sarebbe improprio asso ciare la comparsa della nube, anche se si esibisce la senso del la vista, al registro iconico), poiché tale l’essenza divina non può essere. H racconto taborico si conclude passando di nuo vo alla dimensione visiva. Pietro, Giacomo e Giovanni non fanno in tempo a riprendersi dallo spavento generato in loro dalla voce oltreumana di Dio, che «improvvisamente, guar dandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro» (Marco 9, 8). Cristo appare di nuovo nella sua im prescindibile realtà di corpo corruttibile, sussistente nella sua umana, carnale creaturalità. Ma poco prima i discepoli lo vi dero appunto nella sua gloria. Dato il contesto, forse qui glo ria significa soprattutto esposizione Ubera e assoluta. Infatti,
prima del peccato originale (Genesi 2, 25 e 3, 7). Adamo ed Èva —in quel tempo senza tempo e in quello spazio senza spa zio edenici da cui dovevano essere cacciati— potevano Ubera
mente, irriflessivamente esporre quelle parti del corpo (erano gloriando) che essi propriamente nemmeno vedevano, ma che, una volta perduta la grazia e apertisi i loro occhi, sento
no improvvisamente il bisogno di tenere nascoste (diventano pudenda), poiché ne provano per la prima volta vergogna (cfr. Agostino, De civitate dei, xrv, 17). Proprio alla luce di questa contrapposizione bibUca si misura la decisività dell’e vento teofanico che ebbe luogo sul monte Tabor e la consi stenza semantica della gloria che gU apostoli videro-, un corpo d’interminato candore in piena, autoevidente, assoluta e per fetta esposizione di sé stesso in quanto corpo unicamente estensivo, la cui unica opera consiste nel mostrarsi. Come se la potenza designata dall’esponibiUtà, dall’ostensibiUtà, si esi bisse in atto. Come se in quel corpo trasfigurato nella luce i futuri apostoU vedessero il vedere stesso. Perché in fondo l’invisibile che cos’è se non la vista stessa?
44
Seconda parte
Ho riposto sul nulla il mio destino
Wolfgang Goethe
Tutti i motivi che abbiamo sviluppato (fin troppo sinteti camente in rapporto alla mole delle loro implicazioni) li ri troviamo trascritti e inscritti nell’opera di Kazimir Malevic. Un’opera che, nella sua fase suprematista, soltanto in manie ra del tutto impropria e superficiale può considerarsi “ico noclastica”1, ma che certamente mostra come la questione iconoclasta non potrà mai essere definitivamente superata e liquidata: che continuerà a turbare, a scuotere, a interrogare fin dalle fondamenta lo statuto dell’immagine iconica. Il Quadrato nero che Malevic ha datato 1913 è uno dei riti e dei miti di fondazione del Moderno; con il readymade di Duchamp, uno dei suoi emblemi più potenti e radicali. Ma,
1 E l'errore commesso da J.-J. Goux nel suo Gli iconoclasti. Marx. Freud e il monoteismo (1978); trad. il. Marsilio, Padova 1979 (cfr. pp. 107-19), che pure contiene spunti interessanti sulla questione. A. Besangon nel suo Vintage in terdite. Une bistoire intellectuelle de l'iconocLssme, Fayard, Paris 1994, forni sce un'interpretazione più accorta dell’opera di Malevid alla luce dell’icono clasmo (cfr. pp. 477-98), ma evade completamente il problema specifico dell’i cona di cui essa si alimenta. Il libro è comunque importante per una riflessio ne storica ed estetico-filosofica sullo statuto dell’immagine.
45
proprio per questo, indica una rottura irreversibile con la storia e insieme un commento alla sua secolare tradizione, fa segno verso un profondo, complesso intreccio tra apparte
nenza e discontinuità, memoria e oblìo. Questo e non altro è il dramma del visibile che esso inscena. Se vogliamo cercare di comprendere questo dramma, il dramma che sostiene l’o pera più enigmatica del xx secolo, dobbiamo ripercorrerne e analizzarne la genealogia2* . Il campo pittorico è totalmente risolto in percezione non oggettuale. Il massimo contrasto cromatico —belji e cèmji, ‘bianco’ e ‘nero’, indissolubile vincolo luminoso degli op posti— prende vita in uno spazio intuito e mostrato come pura ostensione di sé stesso. Non vi è nessun vettore privi legiato del senso, e nell’assenza di gravità non è percepibile alcuna direzione, né alto né basso, né destra né sinistra. Ge ometria non più geo-metria, non più misurazione del terre stre: geometrica perfezione del Nulla. «Mi sono trasforma to nello zero delle forme [...] Ho annientato l’anello dell’o rizzonte e sono uscito dal cerchio delle cose [...] questo anello maledetto che svela sempre nuove cose allontana il pittore dallo scopo della distruzione»*, scrive Malevic rie cheggiando l’intuizione zerologica della matematica india na e poi araba, connessa all’intimo legame tra la nozione del nulla e i fondamentali assiomi logico-matematici. Nell’U/riarque cosmi (1617) del mistico rosacrociano Robert Fludd compare un quadrato nero di 5x5 centimetri attorno al qua le, su ogni lato, ri è la scritta su fondo bianco «et sic in infi nitum». Recita il Tao te king-. «L’infinito è un quadrato sen za angoli»4. Come nell’idealismo fichtiano, l’io si contrap
2 In questo percorso abbiamo costantemente tenuto presente M. Cacciati, Icone della legge, Adelphi. Milano 1985, in particolare il capitolo L’angelo sigillato. 5 K. Malevic, Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo, in Scritti (1975). a cura di A.B. Nakov, trad, ir., Feltrinelli, Milano 1977, p. 176. 4 Ricordiamo che questo verso del Tao te king è citato anche da Pétr Dem’janovic Uspenskij —alla cui opera in cosi grande misura ha guardato tutta l’avan-
46
pone alla cosa e la nullifica. La verità non consiste nel cor rispondere o nell’adeguarsi ad essa ma al contrario nel ne garla mostrandola eckhartianamente come nulla: per Mei ster Eckhart tutto ciò che pro-duciamo, che ex-primiamo, che “gettiamo-fuori”, diventa oggettivo, cioè morto per Io spirito. Per Malevic la figurazione è morte perché riprodu ce la finitezza, la limitatezza degli oggetti. Vita è invece la non figurazione, perché la vita non ha lingua né forma fini ta, non può ridursi agli oggetti che la popolano bensì è la loro condizione di possibilità, il loro orizzonte non totaliz zabile. «Io ho dato la vita», ripete spesso Malevic a propo sito del Quadrato nero, e se pensiamo che altrettanto spesso lo chiama “infante regale", non può non apparire evidente l’evocazione cristologica del Bimbo-Re che sconfìggerà la
morte. Il conflitto tra il “tema” inteso come sviluppo di idee pit toriche e la letteralità materiale del piano di posa è portato alla massima espressione. Nell’abolizione di ogni nesso sin tattico e “logico-discorsivo”, di ogni imprestito naturalistico-descrittivo, gli elementi di base sono ricondotti al loro punto zero, e la forma-limite del quadrato non a caso ripe te en ahimè il formato della tela. Il fondo bianco indica il completo superamento dell’impianto prospettico, la liqui dazione definitiva della gabbia geometrico-spaziale entro cui collocare gli oggetti; è annichilito l’apriori stesso della loro possibile rappresentazione; è abolita la loro struttura pre-raffigurativa, e nessuna immagine “nominale”, “asso ciativa” può imporsi in questa spazializzazione del silenzio mistico. «Il mondo messianico», recita lo Zohar, il libro profetico più importante della tradizione cabalistica ebrai
ca, «sarà un mondo senza immagini, in cui non ci sarà più paragone possibile tra l’immagine e ciò che essa rappresen ta». Mondo utopico, letteralmente senza-luogo, in cui final mente si è in presenza della cosa stessa, Liberati da quella
guardia russa del tempo - nel suo Tertium arganum uscito nel 1912, trad. it. Astrolabio, Roma 1985, p. 272.
47
«sconcertante maledizione dell’essere-segno» di cui parlava il giovane Lukàcs negli stessi anni del Quadrato nero5. Pro prio le cose sensibili dalle quali siamo circondati, e che il co dice storico dell’arte pittorica imponeva fino ad allora di raf figurare, impediscono di giungere, distruggendo ogni con venzione ereditata, alla Cosa ultima, alla Cosa escatologica, che non è più metafora, segno, immagine di alcunché. H Quadrato nero presentifica il Nulla “ingoiando” ogni ogget to senza più restituirlo: i suoi margini rappresentano l’oriz zonte degli eventi, come gli astrofisici chiamano il confine ol tre il quale tutto, anche la stessa luce, viene attratto nel buco nero da una forza di gravità tanto potente da deformare il tessuto spaziotemporale che finisce per avvolgersi su sé stes so. Per di più, la “distruzione" degli oggetti esibita nella nu dità del linguaggio liberato dalle forme convenute, l’aboli zione di ogni immagine associativa che esso rappresenta è letterale: i risultati degù esami ai raggi Rongten effettuati nel 1990 hanno rivelato sotto la forma quadrata lacerti di imma gini di oggetti, prova che Malevic ha utilizzato una tela già dipinta. Viene alla mente il Piranesi visionario del Parere su l’architettura (1765), che in una febbre di nientifìcazione
produttiva immagina «edifizii senza pareti, senza colonne, senza pilastri, senza fregi, senza cornici, senza volte, senza tetti, piazza, piazza, campagna rasa». Quel Piranesi “loosiano” che —dopo averne sovraccaricato fino all’inverosimile la facciata con un pastiche neomanierista di fregi scolpiti— pas sando attraverso una sorta di progressivo “sfumato” scul tuale, svuota spettralmente di ogni figura, di ogni “narrazio ne” il retro dell’altare di Santa Maria del Priorato. Come l'icona sacra è immagine della pace che presiede all’ordine divino in cui la nostra vita oltremondana si troverà eternamente trasfigurata nella futura unità spirituale di tut
to il creato, il Quadrato nero non è “segno” ma presenza di pace: esso stesso, anzi, non è più un segno, nel senso che non
5 G. Lukacs, Filosofia dell'arte. Primi scritti sull'estetica (1912-1918) (1971); trad, it., Sugar, Milano 1973, p. 26.
48
ha più niente e che fare con alcuna semiomachia, con nessu na guerra combattuta tra i segni allo scopo di venire ricono sciuti dall’altro, dal contendente, dal nemico. Pace è la con dizione della cosa stessa, che non è metafora né segno di al cunché, che nulla conosce dello sfibrante, interminabile rin vio a un assente e poi a un altro e poi a un altro ancora. Pace è —esattamente come nel mondo messianico dello Zohar— dò che si dà finalmente, al pari della visione beatifica, in praesentiat>. L’inapparenza è anche un’inappartenenza: il Quadrato nero, che nulla raffigura o restituisce di preceden te o di presupposto, di dò che oggettivamente-illusoriamente appare, proprio perciò non ha alcun “principio di presta zione" da soddisfare, non chiede né ha bisogno di essere ri conosciuto in senso identitario, non appartiene né risale ad alcunché, e da ciò consegue che non può neanche essere og
getto di contesa6 7. Così, in tal senso, potrebbe anche dirsi che il Quadrato nero è una Deposizione. La vera, finale Deposi zione di un’iconografia ormai interamente consumata, per ché in esso e con esso viene deposto ogni corpo, ogni segno, ogni figura che pretenda un’appartenenza, che aspiri al rico noscimento sia percettivo sia metafìsico. Non è un caso se lo spazio equidimensionale che esso mostra, indica che non de ridere tra l’alto e il basso, tra la destra e la sinistra, è espres sione della libertà finalmente attinta nella sua sostanza aporetica: libertà che si mantiene pura proprio perché, nella mi sura in cui non decide, non abolisce sé stessa come tale.
6 Su questo motivo della pace come assenza radicale di ogni segno di rico noscimento identitario, cfr. G. Agamben, Idea della prosa, Feltrinelli, Milano
1985, pp. 54-5. 7 È del tutto ovvio che stiamo argomentando sul piano metafìsico e non sul piano storico-effettuale, dove come noto e come vedremo, nel clima infuoca to caratteristico delle avanguardie del tempo, certamente il Quadrato nero fu oggetto di scandalo, contese e aspre polemiche dalle quali il suo autore dovet te ben difenderlo. D’altra pane fin da ora teniamo a sottolineare die quando si dice che Malevic era un dogmatico esattamente come tutti gli appanenenti alle avanguardie del tempo, si è solo ricordato quello che sapevamo già, e non si è fatto un passo avanti nella ricerca.
49
Più che mai vengono meno le cose, quelle da vivere,
perché quel che le sostituisce e rimuove è un fare senza immagine Rainer Maria Rilke
La rovina è uno stato possibile dell'oggetto Ernst Bloch
Sebbene abbia sempre utilizzato il termine bespred'metnost, bespred’metny, ‘inoggettivo’, ‘non-oggettività’8, nessun artista quanto Malevic ha operativamente e concettualmente interrogato in modo così perentorio e radicale, estremo e “definitivo’’ il problema dell’tfjfrtfzxòrte. Si tratta allora di analizzarne qui i fondamenti ontologici e lo statuto teorico. Non prima di aver debitamente sottolineato che il congedo da ciò che si è convenuto chiamare “figurazione” è molto più significativo in Malevic che non in Kandinskij o in Mondrian.
Potremmo perfino affermare che a confronto con la feroce, impietosa e coraggiosa lucidità con cui Malevic porta alle estreme conseguenze l’astrazione suprematista, Kandinskij
sembra un retore accademico letterario e romanticheggiarne particolarmente interessato al “supplemento d’anima”. Occorre prima di tutto partire da un punto incontrover tibile. ff paradigma dell’astrazione, l’orizzonte di senso che essa dischiude nell’arte e nella cultura del Novecento, segna un mutamento genetico che non si lascia ridurre e inscrivere nella successione “innocente" delle correnti e delle tenden ze, delle scuole degli stili. La ragione è che siamo con essa di
8 Bisognerebbe riflettere, quasi a conferma della communis opinio circa la capacità “preveggente’’ degli artisti di anticipare i tempi, su quanto profonda mente la nazione di inoggettiintà abbia a che fare con la smaterializzazicme e la digitalizzazione della nostra epoca attuale.
50
fronte a una metanoia, a una trasformazione totale nel modo di significare, a un viraggio semiotico che mette in gioco la struttura stessa della rappresentazione in generale, che rom
pe con tutta una concettualità mimetologica, con tutta una retorica dello specchio, del riflesso, della trascendenza. D paradigma della figuratività analogico-associativa manifesta nel suo meccanismo profondo, “noumenale", il bisogno tut to umanistico di riconoscersi ovunque, di ritrovarsi a casa in ogni forma, in ogni figura “naturalmente" riconoscibile, in grado dunque di confortarci e garantirci circa il nostro essere-nel-mondo. Nei suoi strati psichici e antropogenetici pro fondi, il modello rappresentativo tradisce il desiderio di pa droneggiare, di possedere l’oggetto ritratto, di esercitarvi magicamente la propria signorìa. Ma il desiderio di appro priarsi dell’oggetto può essere letto anche come il sintomo del tentativo di compensarne la perdita attraverso la sua ri petizione-duplicazione-conservazione, che non può avveni re altro che sul piano fantasmatico. Essa è dunque la fede in
un mondo fatto per l’uomo e insieme la rievocazione funera ria del già-dato. La duplicazione del sensibile che la pittura figurativa comporta —necessariamente attraverso schematiz zazioni antropomorfiche— è ancora intrinsecamente gover nata da quelle relazioni di causalità che sono state conven zionalmente stabilite per arrivare a conoscere, indagare e prevedere i fenomeni naturali. Essa cade sotto la giurisdizio ne e la legalità di una tecnica proiettiva subordinata a cose, strutture, situazioni già date, precostituite, in sé perfetta
mente indifferenti a diventare o meno oggetto di replica. E questo accade anche quando è la deformazione stilistica (che nella sua versione più radicale e significativa è legata alla modernità) a sancire il rapporto tra il dato visivo reale e la sua rappresentazione. Nell’astrazione, il non ri-presentare, il non ri-esporre il mondo, l’astenersi dall’associazione con l’intuizione sensibi le, da ogni riconoscibile contenuto raffigurativo, fa sì che il
significante pittorico —erodendo la struttura triadica del se gno- non sia più “convertibile”, non surroghi più alcunché
51
e passi dal riflessivo all’operativo svincolandosi da ogni inve stimento feticistico. Siamo come liberati dal vedere ogget tuale, dal vedere costretto (d)alle cose, agganciato (d)agli
oggetti. Con essa sembra non vi siano più dati preliminari all’inizio del fare, che deve fondare sé stesso come sbatten do, direbbe Kafka, contro la propria fronte. Ma ciò non si
gnifica altro se non darsi la possibilità di un nuovo, consape vole, autoassegnato inizio, che non deve nulla o il meno pos sibile a protocolli predecisi né può dedursi da datità prece denti. Significa in qualche modo mettere in questione l’idea stessa di qualcosa come un presupposto. L’astrazione è appetitus infinito e mai sedato, giacché non riconosce nell’ogget
to alcun principio o misura di sazietà; essa somiglia solo a sé stessa, è imparagonabile proprio come il sublime di Kant: «ciò che è assolutamente grande [...] ciò che è grande al di
là di ogni comparazione»9. Se l’arte rappresentativa è desi derio di cose, di oggetti —è quello che Lévi-Strauss chiama il suo aspetto possessivo-rappresentativo10— l’astrazione, sgan ciata da ogni imitatio, è allora abbandono, lasciar-essere, de siderio del desiderio stesso, pulsione senza oggetto: «nella non-oggettività», scrive Malevic, «non c’è alcun deside rio»11. Essa liquida il regime della relazione empatica, finali stica, partecipativa, e indica il passaggio alla costruzione non illusivo-imitativa di un percetto organizzato da marche auto nome non derivate da procedure causalistiche nei confronti del dato, sottratte alla logica dell’effetto conclusivo, della “prestazione’*, del “risultato”. Costruzione, abbiamo detto. Perché se l’arte “autofigurativa", non analogica, è certo im-
9 I. Kant, Critica del Giudizio (1790); trad. it. Laterza, Bari 1970, p. 96. 10 Cfr. G. Charbonnier-CLLévi Strauss, Colloqui (1964); trad. it. Silva, Mila no 1966, pp. 55 sgg. 11 K. Malevif, Suprematiimo. il mondo della non-oggettività (1962); trad. it. DeDonato, Bari 1969, p.63. Per ('avventurosa storia del manoscritto di questo testo redatto a Vitebsk nel 1922, che rappresenta forse lo sforzo filosofico maggiore di Malevic, cfr. la Prefazione di Hans von Riesen. «Desiderare a vuoto», dice Simone Weil, «Distaccare il nostro desiderio da tutti i beni e at tendere», in Lomhra e la grazia (1943); trad. it. Rusconi, Milano 1972, p. 27.
52
pegnata in un processo di idealizzazione, questo non va inte so però secondo il significato che solitamente si dà al termi ne, cioè un atto di separazione, di sottrazione. Bisogna in tenderlo invece nel senso che Nietzsche ha indicato: «Libe riamoci qui di un pregiudizio: l’idealizzare non consiste, come si crede comunemente, in una sottrazione o elimina zione di ciò che è piccolo, accessorio. Il punto decisivo sta piuttosto nel tirar fuori grandiosamente i tratti principali, così da far scomparire in tal modo gli altri»12*.L’idealizzazio
ne è in questo senso la condizione elementare e preliminare dell’opcrari artistico che si produce e si offre nell’Aperto. L’astrazione, e soprattutto quella di Malevic, non può e non
deve quindi identificarsi immediatamente (luogo comune ed errore diffuso nella vulgata degli storici dell’arte) con la ri duzione dei mezzi, con il minimalismo delle forme, non bi sogna pensarla sotto il segno della perdita e della rinuncia, della diminutio e dell’ablazione. Non è questo il versante da privilegiare. L’aspetto eminente è piuttosto quello del repe rimento e della costruzione dei Grundrisse, dei ‘tratti fonda mentali’: non è tanto una sottrazione quanto un’offerta, una donazione, un accrescimento ontologico1’. Nell’arte che
sopprime l’impegno mimetico e la costituzione d’oggetto non si nomina più, non si esercita più il compito adamitico di imporre nomi. Il Quadrato nero, il Quadrato bianco e tut
te le altre opere suprematiste non hanno “nome’’: l’errore
12 E Nietzsche, Crepuscolo degli idoli in Opere, a cura di G. Colli e M. Mon tinari, Adelphi, Milano 1971. voLvi, lui, p. 113. 1S «L’artista (...) non deve in generale guardare, deve dare», scrive Nietz sche [La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Mila no 1992, p. 441). Sottolineando il fatto che Malevif -nell’agguerriia competi zione tra le avanguardie del tempo— fu comunque lontano da ogni sviluppo o ipoteca di natura costruttivista, ricordiamo che egli ha sempre preferito e uti lizzato nei suoi scritti e nel suo insegnamento il termine dinamico “costruzio ne’ invece del termine più tradizionale ‘composizione’. Sulla differenza tra i due concetti, cfr. P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte (1923-1924), la raccolta di testi sull’analisi della spazialità e del tempo nelle arti figurative e delle lezioni tenute da Florenskij al VchlTEMAS (la scuola d’arte sperimentale aperta a Mosca nel 1920), trad. it. Adelphi, Milano 1995, pp. 87-131.
53
dell’uomo, dice Malevic con una “sentenza” profondamen te nietzscheana, è stato di credere che «quando tutto fosse stato battezzato, il mondo gli sarebbe divenuto familiare»14.
L’errore di credere, insomma, che dando un nome ad ogni cosa sarebbe venuto a capo dell’essere. All’interno di questa crisi del linguaggio, appaiono in tut ta chiarezza evidenti i nessi con le contemporanee scienze della natura, e ineludibile è il confronto con il “mondo aper to” che esse designano. Insieme alle conoscenze incondizio natamente derivanti dalla pura ragione, le scoperte della nuova fisica revocano in questione l’uso del linguaggio ordi nario concresciuto alla nostra esperienza comune, la sua ca pacità o prensilità designativa, la stessa nominabilità degli oggetti che esso presuppone e a cui si riferisce. Se la particel la elementare non è, a rigore, un ’entità individuale, allora il linguaggio risulterà drammaticamente carente e fatalmente inadeguato a esprimerne l’irriducibile singolarità statistica. I quanta poco o nulla hanno a che fare con 1’“essere” e con 1’“avere”, cioè con i fondamenti grammaticali della lingua e con la loro estensione semantica, sui quali il fìsico è costret to a esercitare una particolare circospezione quando non un
radicale scetticismo. Come noto, la fìsica novecentesca, assieme allo spazio e al tempo deterministicamente assoluti di Newton, ha dovuto ridurre la portata gnoseologica e ricusare l’estensibilità dei giudizi sintetici apriori della critica kantiana. La legge che connette in modo determinato e incondizionatamente pre vedibile una causa a un effetto non può più essere applicata a livello microfìsico nella teoria dei quanta —i grani elemen tari della materia- ove insorge e domina il concetto di pro
babilità nella definizione dello stato di un sistema meccani co. Tale concetto, da Newton fino ad Einstein, faceva parte della teoria degli errori, poiché l’oggetto era pensato di per
14 K. Malevic, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, cit., p. 112. «Piccola cosa è quella che ha nome», dice Cusano nel De deo abscondito, in II Dio naicoito, a cura di L. Mannarino, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 7.
54
sé del tutto completo ed esterno all’osservatore, e le leggi probabilistiche erano credute sopraggiungere solo nel rap porto tra la mente conoscente finita e l’oggetto della cono
scenza. Gli esponenti del “nuovo corso” delle scienze natu rali e della fisica elementare, invece, si rendono sperimental mente conto che i loro metodi e i loro strumenti d’osserva zione non lasciano inalterato l’oggetto osservato. È il princi pio di indeterminazione di Heisenberg. Non si tratta, però, di una casualità a parte subiceli, dipendente dalle carenze e dai limiti concettuali od operativi dell’osservatore e della sua strumentazione, che una volta affinati e migliorati riuscireb bero per così dire a determinare il caso quindi a liquidarlo in
quanto tale inscrivendolo all’interno di un ordine prevedibi le. Da questo punto di vista, la casualità equivarrebbe né più né meno alla nostra ignoranza. Ciò che a noi appare contin gente potrebbe per una Mente Suprema essere perfettamen te necessario, potrebbe essere l’improvviso balenare dell’Ordine che rimane a noi esseri finiti, umani troppo umani, im perscrutabile e inattingibile. «Ma per nessun altro motivo diciamo contingente una cosa», scrive Spinoza nell’Eric^, «se non per il difetto della nostra conoscenza» (Prop, xxxni,
scolio l). Si tratta invece, ben più radicalmente, di una casua lità intrinseca, ontologica, che opera al livello più profondo della natura, e che sembra mostrare la caratteristica di di sporsi probabilisticamente, di essere perciò insostanziale e “spontanea”. I fenomeni subatomici non “accadono”, piut tosto hanno tendenza ad accadere, sono governati da onde di probabilità e non da assiomi necessitanti dedotti dal riscon tro empirico di ferree leggi causali. D’altra parte, già in Epi curo e Lucrezio il clinamen, la possibilità della deviazione
degli atomi in caduta che origina l’evento, era inscritta nella natura stessa. Il principio di indeterminazione introduce relazioni di in certezza nella connessione epistemica tra soggetto e oggetto, e implica la drastica rinuncia ai concetti intuitivi e alle leggi causali nella descrizione dei fenomeni atomici, ma nulla ha a che vedere con l’incompiutezza della nostra conoscenza. Ne
55
consegue che non può darsi un'immagine o una resa ogget tiva della realtà, non può darsi cioè una rappresentazione definitivamente “vera” e costante della grammatica intima del mondo. È il concetto stesso di realtà a venire profonda
mente ridefinito e destabilizzato in conseguenza dell’emer sione di continue antinomie, aporie e paradossi che ne lace rano lo statuto classico-tradizionale, quello a cui siamo da secoli abituati, che non è altro (Malevic lo sapeva bene) se non un’immagine sensibile-tridimensionale del “vero” ma impercepibile continuum multidimensionale dello spazio tempo, della “danza di Siva” che regge l’universo cosmico. Non è un caso che neU’esperienza sapienziale e filosofica orientale la rappresentazione —declinata in termini negativi come non-verità— è il velo di Maya che cela la vera realtà quintessenziale. H linguaggio, la comunicazione mediante
segni e immagini, la distinzione tra un soggetto e un oggetto sono tutte mere rappresentazioni, funzionali ma ben lontane dall’essenza del vero Sé, nelle cui vicinanze si può arrivare soltanto incrinando, “aprendo" la rappresentazione stessa. L’attuale è solo un caso del possibile. Non esistono fatti puri e assoluti. Qualcosa come un fatto, come un oggetto, esiste solo all’interno di un sistema di rilevazione che lo co nosce e lo definisce come tale. Non si tratta quindi tanto di “descrivere" quanto piuttosto di costruire. «Le parallele esi
stono dopo, non prima del postulato di Euclide», scrive Ga ston Bachelard, «La forma estesa dell’oggetto microfisico esiste dopo e non prima che sia stato enunciato il metodo di fissazione geometrica»1’. Si rivela qui la straordinaria poten za anticipatrice dei “semplici” ma abissali interrogativi posti dal Nietzsche “speleologo della conoscenza”. È il Nietzsche dei Frammenti Postumi che incrociano la stesura della Vo lontà di potenza, deciso a scendere fino alla radice, alla gene si costitutiva della categoria logica dell’oggettualità. E sono gli interrogativi che non cessano di tormentare le apparenti
15 G. Bachelard, Il nuovo spirito scientifico (1954); trad. it. Laterza, RomaBari 1978, p. 126.
56
certezze sulle quali si fonda il nostro linguaggio comune. «Come possiamo sapere che ci sono cose? La “cosalità” è sta ta creata da noi. La questione è se non ci possano essere an cora molti modi di creare un tal mondo apparente, e se que sto creare, logicizzare, ordinare, falsificare non sia esso stes so la realtà meglio garantita; insomma se non sia reale solo
ciò che “pone cose”»16. Già la lingua naturale, dunque, è fondata su presupposti metafìsici. Proprio Bachelard sem bra riprendere queste riflessioni quando osserva che alle frontiere raggiunte dalla fisica moderna, «non appena si mette il concetto di cosa sotto le proprietà dell’elemento cor puscolare, bisogna pensare i fatti dell’esperienza ritirando
Veccesso di immagine che si trova in questa povera parola cosa. Bisogna, in particolare, togliere alla cosa le sue pro prietà spaziali. Allora il corpuscolo si ridefinisce come un cosa-non-cosa»17. La realtà profonda è intessuta di eventi probabilistici, non è fatta di “cose”, non è fatta di “oggetti”. Si apre qui un fronte attinente alla teoria della conoscen za percettiva, che già abbiamo evocato nella prima parte del la nostra ricerca analizzando il motivo della perigraphè. Con sideriamo atto ineludibile e inaggirabile della coscienza quello di selezionare il continuum sensoriale in base a ogget ti. Individuare-rintracciare oggetti, e non “formazioni” di verse, rendendo pertinenti alcuni stimoli o tratti del flusso
dell’esperienza percettiva a detrimento di altri, è pratica co gnitiva innestata sull’inesitabile carattere intenzionale della coscienza. Il “puro vedere” non è altro che un’astrazione dogmatica: noi percepiamo-intenzioniamo oggetti, che sono kantianamente fonte dei concetti, i quali a loro volta inner vano il linguaggio. Questi due passaggi formano un legato
16 E Nietzsche, Frammenti Postumi 1887-1888, in Opere, a cura di G. Galli e M. Montinari. Adelphi, Milano, 1971, voi. vili, t. il, p. 55. Poco prima Nietz sche aveva affermato che «il nastro credere a cose è il presupposto per credere alla logica» (p. 51). 17 G. Bachelard, Epistemologia ( 1971): trad. it. Laterza, Roma-Bari 1975, p. 58. H saggio dal quale è tratta la citazione è L'attività razionalista della fisica contemporanea, del 1951.
57
così indiroccabile che noi “sentiamo” la struttura percettiva del visibile affine alla struttura linguistico-discorsiva che ne garantisce la verbalizzazione. Ma come accade che alcune zone, fasce o segmenti della banda sensoriale continua, del campo percettivo totale, tendano irriducibilmente quanto con ogni apparenza spontaneamente a coagularsi proprio in oggetti, cioè in formazioni unitarie, circoscritte, distinte e numerabili, de-fìnite da un contorno'*'? Perché i miliardi di sense data si organizzano originando proprio x che chiamia mo ‘cose’? Perché si articolano precisamente in modo di dar luogo a ‘oggetti’? La teoria della Gestalt risponde assumen do il dato primario e non ulteriormente risalibile della strut
turazione del campo percettivo in quanto ritagliata e artico lata in cose-oggetti, giacché è in questa e non in altra direzio ne che va il senso immanente alla nostra facoltà schematico-percettiva. Qualcosa come un oggetto è un elemento già organizzato concettualmente. E questo è il risultato della nostra attività di costruzione del senso operata sullo sfondo di un isomorfismo naturale e intrascendibile tra la datità fe nomenica e i processi neurofisiologici che ne permettono la percezione-comprensione, cioè tra mondo e coscienza; iso morfismo che deriverebbe in ultima istanza dalla comune appartenenza del percepito e del percipiente, dell’intenzio nato e dell’intenzionante, al medesimo universo fìsico sotto posto alle medesime leggi. Non intuiamo mai direttamente il continuum-, percepiamo soltanto il ritaglio che su di esso operiamo. Non ci confrontiamo mai con puri, semplici, nudi “stati di fatto", perché quello che noi chiamiamo “oggetto” presuppone un’attività conoscitivo-strutturante messa a punto per percepire proprio quella x come oggetto. Credere
che vi siano oggetti è per noi umani il presupposto indispen sabile per credere alla nostra logica, che deve rendere il mon-
«Che cos’è lui contorno?» si domanda Merleau-Ponty nelle mirabili No/e di lavoro a II visibile e Pinvisibile (1964); trad. ir. Bompiani. Milano 1969, p. 217. Altra domanda ‘‘abissalmente" semplice. Si ricorderà che nella Prima parte abbiamo già riflettuto su questo motivo a proposito della perigrapbè teo logica e della circon scrizione albeniana.
58
do —nient’affatto di per sé “logico”— formulabile, calcolabi le, manipolabile: «non ci sono cose (le cose sono una nostra finzione)», afferma Nietzsche19. Finzione necessaria, utile e funzionale al nostro bisogno di impadronirci del reale, di rendere vivibile la vita e da ciò trarre quella sicurezza neces saria alla riproduzione della specie. Questa e non altra è la volontà di potenza: logicizzare il reale secondo le nostre esi genze, creando verità fittizie ma tanto utili da aver comincia to a crederle naturali, oggetto di una fede apparentemente indistruttibile. Il carattere di oggettualità, proprio quello che Malevic voleva superare, cioè l’aspetto “cosale” assunto dalla nostra percezione e di conseguenza dal nostro intellet
to, è l’esito di una pratica, è qualcosa di posto, creato, volu to poiché —afferma un Nietzsche “semperiano-riegliano”— quello che ci spinge verso la «volontà formatrice» (fonte e ragione del nostro amore per il bello) è indubbiamente «un piacere primordiale. Noi possiamo capire solamente un mondo che noi stessi abbiamo fatto», dal momento che già «“pensare” è imporre forme»20. Secondo tale impostazione genealogica, ciò che chiamiamo ‘realtà’ è ciò che costruiamo allo scopo di chiamare con questo nome il risultato della no stra costruzione. Bene. Se, com’è indubitabile, è con questa densità filosofìco-concettuale che Malevic più o meno esplicitamente si confronta, se è a questa altezza che si pone il problema della grande astrazione novecentesca che nella sua opera trova la sua più risoluta e pensante figura, allora essa rimette in gio
co perfino le nostre certezze circa la verità pretesa naturale e autoevidente di un essere percepito “figurativamente” come aggregazione di oggetti. L’astrazione pittorica revoca in dub bio la nostra “fede” nel fatto che un oggetto abbia un carat tere originario, presupposto e irrisalibile. Se percepire è an che interpretare, se il «valore del mondo» consiste nell’inter pretazione che ne forniamo o -più precisamente e più signi
19 20
E Nietzsche, La volontà di potenza, cit., p. 545. Op. àt., pp. 211 e 278.
59
ficativamente — attraverso la quale lo costruiamo, allora «for se in qualche altro luogo sono possibili altre interpretazioni, diverse da quelle semplicemente umane»21. In fondo, niente
di diverso dichiara Wittgenstein nella proposizione 5.634 del Tractatus iogico-philosophicus: «tutto ciò che vediamo potrebbe anche essere altrimenti». Ma appunto: se produce senso-significato solo la cosalità, e se il denotatum-designatum è inteso-interpretato unicamente come ente circoscritto e identificabile in quanto evidenza frontale-fontale della
cosa; se si pensa che il mondo apparente sia non solo artico lato ma anche articolabile soltanto in senso oggettuale-“raf figurativo"; se siamo definitiva preda di questo automatismo
“naturale", allora non solo la grande astrazione novecente sca da Malevic in poi, ma anche tutti gli altri fondamentali esiti delle arti del xx secolo rischiano di perdere ogni possi bilità o proiezione interpretativa diventando perfettamente incomprensibili, letteralmente insensati. Bisogna dunque pensare la grande astrazione pittorica come quella pratica che mette in questione e alla prova, esercitandovi una scepsi spietata e radicale, l’estensione definitoria, categoriale e on tologica pretesa ir risalibile della nozione di “oggetto”. Qui sta la valenza filosofica dell’astrazione (in particolare quel la di Malevic) e deH’arte moderno-contemporanea nel suo complesso: assistiamo a un gigantesco processo di autorife
rimento, articolato in vari linguaggi e differenti dialetti, che problematizza, revoca in dubbio la rappresentazione stessa come dato originario e non ulteriormente risalibile. La rap presentazione —collocata a metà strada tra l’intuizione e il pensiero concettuale— è la forma e insieme lo strumento con cui l’atto conoscitivo si rapporta ai dati della percezione conservandone iconicamente —nella ri-presentazione che ne produce— una certa analogia omomorfa. Sotto questo aspet to, la rappresentazione pertiene sempre a un che di materia le, di presentativo-mostrativo, poiché quell’analogia non si riscontra o quantomeno risulta estremamente meno visibile
21
60
Qp.flZ,p.537.
o evidente allorché l’atto conoscitivo è di natura meramente intellettuale e dunque i livelli di astrazione sono maggiori. Mettere in gioco, esercitare un radicale scetticismo sull’atto rappresentativo in quanto tale (gesto tipico di tutte le avan guardie, sia pittoriche sia teatrali, sia letterarie sia musicali) significa mettere in gioco la struttura metafìsica del segno. L’interrogazione operativa non è condotta su “che cosa” rappresentare ma —con ferrea coerenza logica— sull’intero sistema di rappresentazione dell’ente, sull’atto stesso del rappresentare intenzionale. Proprio la categoria dell’intenzionalità, soprattutto per quanto riguarda il suo carattere rigidamente teleonomico-oggettuale, è sottoposta da Malevic a una critica estrema. Trasceso l’orizzonte categoriale dei valori e degli obbiettivi, nella sua opera (questo è il suo versante davvero “orientale”)
la distruzione dell’oggetto va di pari passo con l’eliminazio ne dell’intenzionalità soggettiva. Noi, in prima istanza, intenzioniamo oggetti: è questa l’organizzazione, la struttura del nostro vedere apprensivo. Come abbiamo visto, sembra non soltanto inerente ma intrinseco all’atto rappresentativo il carattere figurale di messa in immagine del mondo. Ma è questa Tunica forma logica dell'intenzionalità? Quella delle forme è una semantica originaria? A più riprese e sulla scor ta dello stesso Husserl, Merleau-Ponty parla già nella Pre messa alla Fenomenologia della percezione di una “intenzio nalità fungente” che si sviluppa scorrendo sotto la trama ri gida degli atti oggettivanti. Si tratta di «una nozione allarga ta dell’intenzionalità»22*, più profonda, fluida e proteiforme, che ne supera la clausola monotematica di indole prioritaria mente se non esclusivamente tetico-posizionale. Una nozio ne che in certo modo richiama e anticipa (nel caso di Hus serl) quella heideggeriana di Dasein come apertura esisten ziale che precede la separazione intellettualistica e derivata tra intentio e intentum. A questo proposito, Merleau-Ponty
22 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione (1945); trad. it. il Sag giatore, Milano 1965, p. 27.
61
esprime l’esigenza di una vera e propria «riforma della co scienza» (il Suprematismo per Malevic non vorrebbe essere altro che questo!)25 che superi il mero “star di fronte” — ob
jectum, il Gegen-stand— dell'oggetto rispetto al soggetto e vi ceversa, per inoltrarsi in uno spazio ove possa avvertirsi, sot to l’oggetto, una pulsazione inoggettiva, una corrente, un’in tensità (un' emozione, avrebbe aggiunto Malevic) che non può più ricondursi o sintetizzarsi negli schemi della coscien za costituente, irrigiditi nella cornice oggettivante degli atti che sono all’origine della nietzscheana “cosalità”. L’astrazio ne pittorica, e in particolare quella di Malevic, scopre, da questo punto di vista, una sorta di Ubera spazialità senza cose (vedremo in seguito quanto sia essenziale qui la nozio ne di campo}, in cui si trova abolito -esattamente come nel la prospettiva inaugurata dalla fìsica moderna— il mondo de gli oggetti distinti, stabili, identificabili. Può perfettamente interpretarsi come uno sviluppo coerente delle riflessioni dell’ultimo Nietzsche genalogista, l’osservazione di Merle au-Ponty secondo la quale —stabilito che «la percezione non è in primo luogo percezione di «w»24- il compito filosofico necessario è quello di «mostrare che 1’ontico [...] gli objecta, i “rappresentati" [...] tutta la congerie di queste “real tà” psichiche positive [...] è in realtà ritaglio astratto nella stoffa ontologica, nel “corpo della spirito"»2’. Ciò che è in
gioco, insomma, è un tipo di intenzionalità non oggettivisti ca, che non fa riferimento a niente che sia necessariamente concettualizzabile-afferrabile-manipolabile sub specie di objectum definito, pensabile come contorno “figurativo”, cosalità iconico-semantica dunque nominabile. Per l’ultimo Merleau-Ponty come per l’ultimo Nietzsche, «l’errore filo sofico totale» consiste precisamente «nel credere che il visi bile sia presenza oggettiva (o idea di questa presenza) (qua
25 24 25
62
M. Merleau-Ponty, Il inabile e Pinviabile, rii., p. 272. Op. di., p. 251. Op. ài., pp. 286-7.
dro visivo)»26, come se davvero occorresse definitivamente ritirare —così, abbiamo visto, si esprime Bachelard- quell’eccesso di immagine che automaticamente attribuiamo al con
cetto di “cosa". E infatti per Malevic il fenomeno, ciò che si porta all’evidenza, è in quanto tale già da sempre integrato e recuperato nella piattezza e nella triviale e utilitaristica insi gnificanza dell’oggettività. Bisogna insomma indebolire la cogenza e la “naturale” complicità mimetico-raffigurativa dell’atto costituente, bisogna assumere, sostiene MerleauPonty, «ciò che, relativo al visibile, non potrebbe pierò esse re visto come cosa», vale a dire «la sua membratura non figu rativa» (corsivo ns.)27. Quello che Merleau-Ponty chiama il «mondo estetico» è il mondo prima di essere filtrato, “svol to", “tradotto” nelle oggettivazioni, o per meglio dire che si dà inoggettivato in esse. È fuori di dubbio che l’intera avven tura artistica moderno-contemporanea, e in particolare quella che riguarda Malevic e la grande astrazione novecen tesca, può essere interpretata anche in questa chiave gnoseo logica, o per meglio dire di “gnoseologia operativa”: cioè come la dimensione eminente e per certi aspetti modellizzante in cui si esprime questo tipo di intenzionalità latente
che, al modo dell’irriflesso e dell’inoggettivo, si nutre di quell’immediatezza precategoriale in base alla quale sentia mo esteticamente X emozione cui Malevic fa costante riferi
mento) che la nostra inerenza originaria alla Lebenswelt, al mondo della vita, non è del tutto necessitata a svolgersi in senso “figurativo"-oggettivo. In particolar modo e con estre
ma coerenza nell’opera teorica e pittorica di Malevic, la pra tica creativa dell’astrazione fa segno verso una linea di fuga e di eccedenza nei confronti dell'attività schematica dell’in
telletto intesa come capacità logico-referenziale; limitando ne, indebolendone la funzione rigidamente denotativa, la clausola o l’ipoteca strettamente designativa. Abbiamo visto che vi è una fortissima, irresistibile, organica connessione tra
26 27
Op. at., p. 291. /m.
63
figuratività e percetto, intenzionalità d’atto e semanticità, connessione che riposa sul presupposto archeologico secon do il quale il fenomeno sensibile che appare visivamente
produce senso-significato (cioè autenticamente appare alla coscienza) solo se selezionato, filtrato e modellato in termini e sotto clausole oggettuali. La pratica dell’astrazione pittori ca indica, anzi incarna esemplarmente l’esercizio della liber tà soggettiva neW.'immaginare produttivamente e applicare inventivamente gli schemi, come “rammemorandone” il ca rattere fondamentalmente convenzionale, pattizio. È come se attraverso di essa si rinegoziassero estensione e articola zione della capacità deH’attività schematica di riferirsi al con tinuum-, per il suo tramite si riconverte l’attenzione sul carat tere intrinsecamente, strutturalmente aperto della possibili tà che il continuum percettivo-esperienziale sia ancora dispo nibile a un diverso ritaglio, a una diversa pertinentizzazione. Con un’azione anti-reifìcante, “decontratturante”, la pratica dell’astrazione mette in campo un costante rimodellamento che risveglia la nostra possibilità, dunque la nostra facol tà-capacità immaginativa, di segmentare e costruire il senso in modi altri rispetto a quelli iconico-raffigurativi e analogi co-associativi, postulati da un tipo di intenzionalità interes sata soltanto a reperire teleonomicamente catene di oggetti {quindi parole, frasi, proposizioni).
Tutto questo fascio di temi e motivi attraversa profonda mente e “organizza” l’intera opera teorica e pittorica di Ma levic. La coscienza di quella che chiamerà Inumanità bian ca» è priva di oggetto, non è più coscienza-di. Viene qui messo in questione il fondamento classico di ogni fenome nologia. Egli punta dritto al cuore del teleologismo finalisti
co sigillato nell’idea di intenzionalità-volontà mettendo in campo un parallelismo con il “fare” della natura. Bisogna
definitivamente liquidare ogni assunzione psicologistica che cerca, come scrive Nietzsche, «una volontà (ossia un’inten zione) dietro ogni fare» {Frammenti Postumi 1888-1889, 14
[29]). Sembrerebbe a prima vista paradossale, ma proprio in ragione di questa radicale “pulizia” ontologica e psicologica,
64
si afferma ripetutamente che l’astrazione suprematista deve avere come unico modello proprio la natura. La sua forza paradigmatica non si esercita però -è del tutto evidente— sul piano trivialmente empirico-mimetico della riproduzione del visibile oggettuale, delle apparenze esteriori, ma su quel lo delle leggi della produzione e della generazione operativa che associano arte e natura. Non, quindi, la natura già con gelata, fissata, morta negli oggetti, ma la natura naturane, animata dall’intrinseca vis che presiede alla sua spontaneità autogenerativa, che governa quel sorgivo venire alla presen za che trova in sé e non in altro la ragione della sua legittimi tà. Il proprio della natura consiste nel produrre, disfare, nuo
vamente produrre et sic in infinitum, in modo del tutto e ori ginariamente indipendente dal bene e dal male, libero da si gnificati e da leggi orientate verso scopi. Insensato è imma ginarne condizioni finalistiche, poiché la vita stessa non ne ha ed è da esse “irraggiungibile”. «Se il globo terrestre va in pezzi, se il sole si spegne», scrive Malevic, «per la natura come tale non cambia nulla»28, poiché in essa non è riscon trabile —se non per una deformazione di carattere antropo morfico— alcuna forza indirizzata a perseguire uno scopo. È
la prospettiva del grande disincanto lucreziano che scende fino a Spinoza, Leopardi, Darwin e Nietzsche. Pochi anni prima, precisamente all’inizio del secolo, Georg Simmel ave va già riaffermato la stessa posizione, denunciando l'ingenui tà del comune atteggiamento che consiste nel credere che la tecnica “domini” la natura, che le “imponga” i suoi principi di prestazione e di efficienza, presupponendo in tal modo nella natura stessa una resistenza, un rifiuto a piegarsi all’u mana costrizione che invece, in realtà, essa non esercita af fatto né potrebbe esercitare proprio perché perfettamente gratuita, indifferente, avulsa da ogni volontà, da ogni inten
zionalità, da ogni dover-essere29. Troviamo in Malevic, quasi
28 K. Malevic, Suprematismo. lì mondo della non-oggeftività, cit., p.77. 29 Cfr. G. Simmel, Filosofia del denaro (1900); trad. it. utet, Torino 1984, pp. 678-80.
65
letteralmente, la stessa affermazione: «La natura non lotta con nessuno e perciò non subisce nessun danno nel suo mo vimento vorticoso senza inizio, senza fine, libero da intellet to, riflessione, senso, scopo e dovere. Vive e agisce nel trion fo della luce che illumina, nell’oscurità infinita, il suo movi mento insensato»50. Costruire un mulino ad acqua o a vento non significa affatto —questa la grande illusione di una ma lintesa “filosofia della tecnica”- imbrigliare, im-piegare la forza dell’acqua o del vento: in realtà esse non soltanto non oppongono alcuna resistenza, ma rimangono del tutto libe re e imperturbate, dal momento che, dichiara Malevic, «non può essere libero ciò che tende a un fine»51. Ma su questi
motivi —cosa che non è mai stata a sufficienza sottolineata52* — 55 egli ha anche pagine del tutto “orientali”, di ispirazione taoista, di “memoria” zen. La natura non sopporta nomi, non ha alcun fine-oggetto da “compiere”, raggiungere, soddisfare, perché qualcosa come un oggetto e come un fine esistono soltanto nella nostra rappresentazione: perfettamente aliena da scopi, ignora ragione, senso e coscienza. Nella natura cer to tutto si trasforma perpetuamente, ma niente in essa dimi nuisce o si accresce: è in sé assoluta inazione, totale inattivi tà, nirvanica inoperosità. E così dovrà essere il Suprematismo “compiuto”. «Ci stiamo preparando a ridurre tutto a nulla. In seguito andremo oltre lo zero», scrive Malevic all’a mico Matjusin nel maggio del 19155 5 Nella non-oggettività non esistono domande né risposte, e in essa si perviene, di-
50 K. Malevié, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, eie, p. 234. 51 Op. cit., p. 179. 52 Vedi però il saggio di Charlotte Douglas, Beyond Reason: Malevil, Matiushin and Their Circles, nel mirabile libro-catalogo The Spiritual in Art: Ab stract Painting 1890-1985, Los Angeles-New York 1987. Maleviè aveva fami liarità con la disciplina, e forse anche con la pratica, dello yoga della scuola Vedanta. Per raggiungere lo stato supremo del samadhi, la meditazione deve escludere via via ogni oggetto fino a diventare perfettamente senza-oggetto. 55 Cfr. Kazimir Malevich 1878-1915, Stedelijk Museum, Amsterdam 1989, p. 157. Si tratta del catalogo della prima grande retrospettiva di Maleviè nell’Europa Occidentale (non a caso organizsata durante la glasnost di Mikhail Gorbaciov). La traduzione dall’inglese è nostra.
66
rebbe Meister Eckhart, «ad abbandonare il questo e il quel lo»5-’, giacché tutti i problemi si risolvono nel nulla. A ★ ★
Malevic ha sempre dichiarato e rivendicato che il Suprematismo è nato nel 1913. Per questo ha datato a quell’anno il Quadrato nero, sebbene si sia ormai raggiunta la certezza storico-filologica che non può risalire a una data anteriore al 1915. E il 1913 è l’anno di Vittoria sul sole (Pobeda nad solncem), l’opera teatrale frutto della collaborazione tra Michail Matjusin che compose la musica, Aleksej Krucènych che scrisse il testo e Malevic che disegnò le scene e i costumi. Il Prologo —recitato dallo stesso Krucènych— era di Velimir Chlebnikov. Lo spettacolo era uno specie di music-hall in chiave dada-futurista e, finanziato dall’Unione della Gio ventù di Pietroburgo, ebbe luogo in un teatrino secondario della città, il “Luna Park”, il 3 e il 5 dicembre, alternandosi con Tragedia di Vladimir Majakovskij, messa in scena il 2 e il 4. Gli attori furono reclutati attraverso annunci sui giornali, così non si presentò nessun professionista ma unicamente studenti universitari. H coro, assunto due giorni prima, era composto da sette persone delle quali soltanto tre sapevano accettabilmente cantare, e un piano malamente accordato sostituiva l’inesistente orchestra. Le serate si svolsero in per fetto stile futurista, in un miscuglio di fischi e applausi, pro teste e approvazioni, ilarità e lanci di oggetti vari in palco
scenico54 55. 54 Meister Eckhart, Moyses orabai dominum deum suum, in Sermoni tede schi, trad. it. Adelphi, Milano 1985, p. 69. 55 II poeta futurista Benedikt LivSic -l’autore dello scrino teorico Liberazio ne della parola— era tra gli spettatori di Vittoria sul sole e ha lasciato della rap presentazione un vivido ricordo, dal quale qui attingiamo, nel suo L’arciere da un occhio e mezzo (193 5), trad. it. Hopefulmonster, Torino 1989, pp. 196-201. Per un panorama completo sul futurismo russo, autentico momento-chiave dell'intera cultura europea del Novecento, resta insostituibile V. Markov, Sto ria delfuturismo russo ( 1968), trad. it. Einaudi, Torino 1973. Con le scenogra fie della sua allieva Vera Ermolaeva, nel 1920 Vittoria sul sole lu replicata in
67
L’eliomachia, la lotta contro il sole —simbolo della bellez za passatista e del vecchio ordine delle cose (ma, vedremo, non solo di questo)— è un motivo ricorrente nella produzio
ne poetica e artistica del futurismo russo. Ad esempio pro prio in Majakovskij e proprio in Tragedia (intitolata anche con il nome stesso del suo autore): «Io intrepido/porto nei secoli il mio odio per i raggi del giorno». Ne La blusa del bel limbusto il poeta dichiara: «sfiderò il sole con un sogghigno arrogante». E in Qualche parola su me stesso: «Sole!/Padre mio!/Abbi tu almeno pietà, non tormentarmi». Tutti e tre i componimenti risalgono al 1913, annus mirabilis del futuri smo russo. E Chlebnikov esclamerà: «il Sole — trascinatelo a un guinzaglio per cani»56. D’altra parte la scritta zat’menje, ‘eclissi parziale’, compare su due celebri tele “alogiche’’ di Malevic del 1914, Un inglese a Mosca e Composizione con la Gioconda. Di lì a poco avverrà l’eclissi totale del Quadrato nero. D tema dell’opera è nel Primo Atto il combattimento contro il sole («Sole tu generasti tormenti [...] ti avvolgere mo in una coltre polverosa»; «H Sole si è nascosto/La tene bra ci ha invaso [...] Salve tenebra!») fino alla sua sconfitta definitiva («D Sole giace ai nostri piedi trafitto»; «Noi abbia mo estirpato il Sole con le radici vive/Grasse che puzzavano di aritmetica/Ecco guardate»)5’ da parte dei budetl’jane
sede didattica durante i corsi che Malevié teneva a Vitebsk. Questa edizione fu presentata a Berlino nel 1922. Recentemente, l’opera è stata messa in scena dal Los Angeles County Museum of Art nel 1980, dal California Institute for the Arts al Festival di Berlino del 198?, dallo Stas Namin di Mosca a Basilea nel 2015. Della prima rappresentazione del 1915 restano due foto, pubblica te su un giornale locale, il “Ranneye Utro" il 12 dicembre e riportate nel cata logo della mostra dedicata a Maleviè dal Centre Pompidou di Parigi nel 1978, p. 12. 56 Cfr. A.M. Ripellino, Tentativo dì esploratone del continente Chlebnikov. in V. Chlebnikov, Poesie, trad. it. Einaudi, Torino 1968, p. Lxxxiv. ’7 Seguiamo la traduzione di Marina Di Filippo che si trova nel catalogo della mostra Katmir Malevii. Una retrospettiva, Artificio, Firenze 1993. Cfr. anche La Vietoire sur le Soleil, a cura di J.-C. Marcadé, L’Age d’Homme, Lau sanne 1976 (con testo a fronte), che contiene il saggio di Marcadé, "La Vieta ne sur le Soleil" ou le merveilleux futuriste cornine nouvelle sensibilité, e C.
68
(qualcosa come ‘aweniriani’), il neologismo con cui Chlebnikov —respingendo la radice latina per quella slava (da budu, futuro di byt‘, ‘essere’)— ribattezzò se stesso e i suoi amici poeti e artisti18. Il Secondo Atto, una volta messianica mente vinto il sole, si svolge nel 35° secolo sul “Decimo ter rò” (sic), dove soltanto esseri eccezionali dotati di una ferrea volontà e una straordinaria forza d’animo («i deboli sono impazziti») possono sopravvivere, finalmente —proprio come le superfìci-piano di Malevic— «liberi dal peso della gravitazione universale». Questi esseri sono una remine scenza, forse più che dell’Oltreuomo nietzscheano, di quel la nuova stirpe di puri ed eletti ai quali dovrebbe essere per messo ciò che al “gregge” è proibito, e di cui agogna far par te senza riuscirvi il Raskol’nikov di Delitto e castigo. Distrut ti sono i vecchi immutabili idola con la loro illusoria aura di fissità e permanenza, edificati secondo l’«antica misura» che non ha più corso. In una sorta di “trasvalutazione di tutti i valori", niente più sta, tutto è in perpetuo movimento: «ieri qui c’era un palo telegrafico oggi c’è un buffet o domani, magari, vedremo mattoni. Qui succede tutti i giorni che nes suno sappia dov’è la fermata e dove mangeranno». Sovverti
mento dei ruoli, rovesciamento delle consuetudini, rifluire dell’effetto sulla causa secondo la tradizionale figura utopica ben presente nella cultura occidentale (si pensi solo all’EZo-
gio della follia di Erasmo da Rotterdam) del “mondo alla ro vescia”: e proprio questo era il titolo, Mirskonca, di un libro “artigianale” di Chlebnikov e Krucènych del 1912. H Chleb-
nikov per il quale «la vita può essere vissuta al contrario, scappando dai funerali all’infanzia»59. Il tempo granulare e
Douglas, Birth of a Royal Infant-.Maleviich and “Victory over the Sun", in “Art in America”. March-April. 1974. 18 Ripellino sceglie la letterale quanto impervia traduzione di «Banditori del “Budu”, del “Sarò”», cit., p. XL 59 Cfr. A.M. Ripellino, Tentativo di esplorazione, cit., p. lxxxviu. Ma il «mondo capovolto» e il tempo alla rovescia che scorre incontro al presente è anche quello del sogno che “introduce" alla temporalità metafìsica dell'icona, sul quale si aprono le pagine di Le porte regalici Florenskij.
69
“disgiunto”che passa «goccia a goccia» (kapleovraznaja} come diceva Matjusin, il tempo lineare, entropico e punti forme che attimo dopo attimo si e ci avvicina “meccanica mente” alla fine, non esiste più. Chronos è finalmente scon fìtto e le lancette degli orologi non si sa più in quale verso gi rino. Se davvero l’universo è infinito, allora non esiste più il tempo e «non differisce il giorno dalla ora, il giorno dalla notte», come già aveva detto Giordano Bruno in De la cau sa, principio et uno. Del passato, secondo questa ispirazione
profetica di totale messianico azzeramento, non è rimasta al cuna traccia («com’è insolita la vita senza passato - Con pe ricoli ma senza pentimenti e ricordi»). Rimane il vuoto che
«ventila tutta la città» così che «tutti cominciano a respirare meglio». L’“ illusione necessaria” della irreversibilità tempo rale, questo velo di Maya secondo cui non può esservi alcu na risposta che segue se non v’è una domanda che precede, non ha più ragione di essere né di costringere nella sua gab bia d’acciaio, e dunque si potrà andare «di traverso nel xvi secolo tra virgolette da qui», viaggiando liberamente «per tutti i secoli». Esattamente come anche Chlebnikov spinge va a muoversi «in una regione trasversale del tempo», movi mento «così familiare allo spirito d’ogni profeta»40. Il “racconto” di Vittoria sul sole è chiaramente impronta to a un messianismo apocalittico e alla radicale inversione dei valori che segnerà la fine dei tempi. Quello che si richia ma al libro neotestamentario è un tema centrale e ossessiva mente ricorrente nell’intera cultura russa, soprattutto lette
raria e filosofica ma non solo, tra Otto e Novecento. Ne L'i diota di Dostoevskij, prima di piombare nella bruta e imme more incoscienza della malattia, l’attimo immediatamente precedente l’attacco epilettico del principe Myskin è felice mente colmo di estatica armonia, di pacificante bellezza, di trepidante fusione con il Tutto. È un attimo apocalittico per ché esso «dilata il tempo aH’infinito e lo fissa al suo compi
40
70
Cfr. Op. cit., p.
lxxix.
mento, alla sua perfetta pienezza»41: per questi momenti, dice tra sé e sé lo stesso protagonista, «si può dare tutta la vita». E Lébedev, uno dei personaggi che attorniano il puro, innocente principe, non si esercita forse da quindici anni a interpretare YApocalisse? «Non esisterà più il tempo», an nuncia l’angelo possente che poggia il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra (Apocalisse, 10, 6). Rivelazione nem meno poi tanto “secolarizzata” del tempo compiuto, del tempo dell’ejrótf/ow e deìYapokatastasis, cioè della salvifica restaurazione finale del primevo ordine divino, è quello di Vittoria sul sole. Azzeramento di ogni rapporto preteso “na turale”, palingenesi di ogni funzione ontologicamente cre
duta immutabile, che coincidono con la morte del “tempo solare” e l’ingresso nella dimensione apocalittica emancipa ta dalla meccanomorfa irreversibilità, dal tempo come soffo cante onmtudo di cui siamo sudditi per conquistare final mente un tempo proprio di cui essere sovrani. Scrive Nikolaj Berdjaev in un saggio del 1917-18 che «il russo è apocalitti co al polo positivo e nichilista al polo negativo», ed è impos sibile distinguere questi due poli solo apparentemente op posti, giacché «nell’intelligencija russa» —ma anche nel po
polo, preciserà poco oltre— «l’apocalisse s’intreccia e mesco la con il nichilismo»42. Lo stesso Berdjaev per il quale l’im manenza del divino significava che in questo mondo deve fare irruzione un mondo diverso. E Ivan Fèdorovic Karama zov non è forse anch’egli pervaso dalla coscienza apocalitti ca che vuole la fine e il compimento della storia come unica
41 S. Givone, Dostoevskij e la filosofia, Laterza, Rotna-Bari 1984, p. 82 (citia mo dall’ed. del 2006). 42 N. Berdjaev, Gli spiriti della rivoluzione russa, in AA.W, Dal profondo. 1918.- la rivoluzione vista dalla Russia, trad. it. Jaca Book, Milana 1971, pp46-7 (citiamo dall’ed. del 2017). Il Tertiunt Organurn di Uspenskij —intera mente dedicato alle implicaazioni scientifico-filosofiche di un mondo inacces sibile alla normale percezione- si apre in epigrafe e si conclude proprio sull’annuncio dell'angelo apocalittico appena citato. Ricordiamo inoltre che Apocalisse della letteratura russa è il titolo di un libro di Krucènych uscito a Mosca nel 1923, e che Michail Bulgakov pone in epigrafe a La guardia bianca un passo dell’Apoca/wre.
71
condizione perché possa finalmente re-instaurarsi la beatitu dine, la felicità e l’eguaglianza sulla Terra (Yapokaiastasis, appunto)? D’altra parte è sempre stato presente nella tradi
zione della cultura russa l’impulso ad assegnare all’arte un compito rigeneratore, terapeutico, salvifico. In Vladimir So lov’ev, il maestro di Berdjaev, ad esempio, l’arte è una poten za teurgica che plasma direttamente la vita, poiché l’artista è la figura eminente in cui si alimenta l’attesa della catastrofe liberatrice e palingenetica, e nella sua opera già vive e si esprime quell'armonia segreta del Tutto che si rivelerà defi nitivamente, secondo la prospettiva apocalittica, alla fine dei tempi. Lo stesso Malevic -il “maestro messianico", come lo
chiamavano alcuni critici del tempo— ha sempre interpreta to la sua figura di artista come quella di un demiurgo, primo edificatore di una nuova epoca gnostica del mondo e porta tore di una suprema conoscenza. Ma se la nuova esistenza dei budetl’jane di Vittoria sul sole è già in atto proprio perché descritta, se il futuro escato logico è qui “narrato" -e si può narrare soltanto ciò che già trascorso- significa che in qualche modo questo segno dei tempi già si dà, già si dipana ria via: è dunque a ben vedere un futuro anteriore che contiene misteriosamente quanto paradossalmente in sé una dimensione pretèrita. È l’enigma
temporale di ciò che si dà hic et nunc e dunque s’inoltra pro gressivamente nel passato, ma solo in quanto sarà. Ora, tut to il futurismo russo è attraversato da un motivo analogo, e in particolare l’opera di Chlebnikov, poetico fautore di un
avveniristico ritorno a un’arcadia slava e comunque orienta le da contrapporre alla cultura razionalistico-illuminista eu ropeo-occidentale. Il futuro, in questa sorta di riarticolazio
ne temporale, coincide con la restaurazione di un'edenica età dell’innocenza; l’antevedere è memoria di una paradisia ca immemoriale incolumità; utopia e regressione arrivano a indistinguersi; lacerante modernità e arcaica primordialità coestistono. In questa specie di anagennesis, di ‘rigenerazio ne’, il tempo futuro rifluisce verso la propria scaturigine, così come la luce dell’icona nera di Malevic, lo vedremo, risale sé
12
stessa fino alla propria arche. Causa ed effetto sovvertono ri baltandola la loro relazione meccanica. Il Prologo di Chlebnikov e —soprattutto nel finale— il te
sto di Krucènych contengono brani zaum , il linguaggio alo gico e asemantico, “trans-mentale" o “trans-razionale” dei futuristi, fatto di slogature lessicali e fratture scomposte del la sintassi, invenzioni onomatopeiche e inserzioni di etimo logia slava, lallismi infantili e balbuzie fonetiche, linguaggio del quale Malevic contemporaneamente cercava di fornire dirette, immediate forme visive. L’“alogismo” dei futuristi, questa presa di distanza dagli schemi del logos, è una trascri zione “artistico-creativa” dei postulati teosofici del Tertium Organum di Uspenskij: nella quarta dimensione (coglibile solo da una visione superiore indipendente da quella fìsica, e ove i piani penetrano nello spazio tridimensionale), A è A e al contempo non-A perché il principio di non contraddi zione della logica aristotelica è superato; la parte non è più piccola del tutto; il fenomeno diventa irreale-inafferrabile e il noumeno percepibile; destra e sinistra, alto e basso, gran de e piccolo sono distinzioni “umane troppo umane” che non hanno più corso né senso. Dunque, secondo gli “inizia ti" zjium’, avrebbe dovuto essere la nuova forma verbale, nel suo funambolico e clownesco istrionismo linguistico —mai dimenticare la dimensione comica che percorre tutte le avan
guardie!45- a creare il nuovo contenuto. «Noi siamo stati i primi», dichiara Krucènych, «ad affermare che per rappre sentare il nuovo e l’avvenire occorrono parole del tutto nuo ve e rapporti del tutto nuovi tra queste parole [...] I quadri di Malevic sono il risultato di questa in transigenza tipica mente russa»44. Nel celebre manifesto del 1913, Schiaffo al gusto del pubblico, i futuristi invitano i poeti -e, trasponen do da parola a immagine, i pittori (e Malevic aderirà)— ad
45 Cfr. su questo motivo imprescindibile per una valutazione complessiva delle avanguardie artistiche, il ns. La mosca di Dreyer Jaca Book, Milano 2007, pp. 146-59. 44 Cfr. A.B. Nakov, Il nuovo Laocoonte, in K. Malevic, Scritti, cit., p. 85.
73
aumentare il volume del vocabolario con neologismi, termi ni inventati, accostamenti arbitrari, e a odiare senza remis sione la lingua esistita prima di loro. Per poter non soltanto rappresentare ma incarnare l’avvenire, occorrono parole completamente inedite, mai prodotte né ascoltate, la cui as sociazione avviene in base a leggi interne e autoassegnate. Il lavorìo sulla lingua si rivolge all’alchimia profonda della pa rola sganciata da ogni significato precostituito. Spezzato è dunque il legame tra sostantivo, verbo e predicato; scompo sta è la connessione “aristotelica” tra nome, concetto e cosa; esploso il rapporto tra mondo e linguaggio4’. La poesia —au mentando esponenzialmente il suo quoziente di materiata fonica— riduce la distanza dal puro oggetto acustico e si tra sforma -seguendo le linee di una lucida, filologica follia ver bale— nella chlebnilcoviana «voce mutola della scrittura». E gli zaum'mk.1, secondo Krucènych, armati di questa neolin gua come della «freccia avvelenata di un selvaggio»46, po tranno allora «passeggiare allegramente nel labirinto»47. I personaggi dell’opera non hanno assolutamente nulla di psicologico; rappresentano categorie, sono puri archetipi: gli Sportsmen, il Becchino, l’Operaio, il Malintenzionato
(interpretato nelle prime due rappresentazioni dallo stesso Majakovskij). I costumi disegnati da Malevic sono indossati dagli attori come scafandri multicolori che ne nascondono o
ne falsano totalmente l’anatomia naturale. La meccanica tu-
•*’ È probabile che la particolare plasticità della lingua russa abbia rappre sentato una condizione favorevole. Scrive Iosif Brodskij in un saggio su Mandel 'stam che «il russo è una lingua molto duttile [..accade facilmente che il sostantivo si trovi proprio alla fine della frase, e la desinenza di questo sostan tivo (o aggettivo o verbo) cambia secondo il genere, il numero e il caso. Tutto questo conferisce a ogni discorso il carattere stereoscopico della percezione stessa e (talvolta) acuisce e arricchisce la percezione», in Fuga da Bisanzio (1986), trad. it. Adelphi, Milano 1987, p. 72. 46 Cit. in A.M. Ri pellino. Tentativo di esplorazione del continente Chlebmkov, cit., in ordine alle pp. uà e lx. 47 Cfr. A.B. Nakov, Il nuovo Laooconfe, cit., p.68. Sulla diversa concezione della lingua zaum' in Chlebnikov e in Krucènych, cfr. Markov, Storia del futu rismo russo, cit. p. 557 sgg.
74
bolare e geometrizzante, con l’incastro forzato dei volumi l’uno nell’altro che produce un gioco di cilindri, coni e altre figure spezzate, è identica —d’altronde gli anni sono gli stes si— a quella in opera nella sua fase cubofuturista (ad esempio Raccolta della segale. Taglialegna oppure Donna con sec chio)**. L’unica testimonianza diretta della rappresentazione al Teatro “Luna Park” di Pietroburgo, come abbiamo già ri cordato, è quella di Benedikt Livsic, che fu colpito soprat tutto dalla messinscena di Malevic, avvicinata al dinamismo
scultuale di Boccioni, e dal gioco delle luci, progettato anch’esso dall’artista, per l’epoca molto innovativo, con i fasci luminosi dei fari che facevano improvvisamente emergere dall'oscurità ora le braccia ora le gambe ora la testa dei corpi-fantoccio, come frammentandone la massa per scompor la e ridistribuirla volumetricamente nello spazio tridimen
sionale della scatola scenica. Ma il sole, sulla sconfìtta del quale si levano nell’opera canti di vittoria, non è soltanto quello che simboleggia la vecchia cultura dominante arretrata e tradizionalista che i futuristi, i budetl‘jane vogliono abbattere per edificare con l’afflato del loro millenarismo cosmico il nuovo secolo che «non avrà fine». H sole è anche e soprattutto la prima condi zione perché il sensibile fenomenico possa manifestarsi; è l’apriori perché gli oggetti possano rivelarsi-apparire nella luce e così venire duplicati raffigurandoli: proprio quegli og getti che Malevic vuole abolire, superare, “detronizzare” perché resti unicamente lo spazio infinito della sensazione pura che si apre e si offre dal Quadrato nero in poi-”. H sole è proprio ciò che con la sua luce onnipervadente vela, na sconde il vero, realissimo continuum quadridimensionale —
48 Malevic disegnerà anche i costumi per Mistero buffo di Majakovskij, an dato in scena con la regia di Mejer’chold il 7 novembre del 1918 a Pietrogrado nel primo anniversario della Rivoluzione, ma tutti i bozzetti originali sono andati perduti. 49 II sole, scrive Cacciati in Icone della legge, è «da condizione trascendenta le di ogni sensibile rappresentazione, presupposto del meramente visibile e delle sue imitazioni», cit., p. 207.
75
impercepibile sì, ma solo dall’interno e nell’ambito della no stra “povera" percezione tridimensionale— che occorre (al perfetto contrario di ogni pretesa semplicemente iconocla sta!) figurare nella nuova icona del Quadrato nero. Il sole va sconfitto perché è la conditio sine qua non dell’apparire ma nifesto di questo mondo composto di meri oggetti distinti, numerabili, separati (quelli che la nuova fìsica ha revocato in questione), che l’arte della pittura ha sempre pensato come suo compito elettivo dover imitare, riprodurre, “raddoppia re”. Ma il mondo continua a esistere, al di là dei nostri sen si. Ben lo sapeva Nietsche, abbiamo visto. Non è un caso, allora, se Vittoria sul sole si rivelerà negli anni immediatamente seguenti la vera fucina dalla quale na sce il Suprematismo. L’opera si apre con una scenografìa composta da pareti bianche e pavimento nero. Ma soprat
tutto il disegno per il primo quadro del secondo atto mostra, all’interno di un quadrato, un altro quadrato diviso diago nalmente, con la parte nera in alto e quella bianca in bassow. Sul disegno (conservato al Museo di Stato per la musica e il teatro di Pietroburgo) compare inoltre la scritta (presumi bilmente non posteriore) kvadrat, e a destra la scritta glupo, “sciocco’, ‘stupido’, che potrebbe riferirsi a uno dei perso naggi, che però nel testo non troviamo con questo appellati vo. Ma c’è di più, sul piano documentale. Quando due anni
dopo, nel 1915, Matjusin si propone di pubblicare una se conda edizione più articolata e completa del libretto di Vit toria sul sole, Malevic gli scrive numerose lettere in cui cal deggia l’inclusione di quel bozzetto tra le illustrazioni. «Krucènych mi ha informato che è vostra intenzione pubbli care Vittoria sul sole e includere i miei disegni per le sceno-
E stata Camilla Gray che per prima ha messo in relazione il bozzetto di Vittoria sul sole con il Quadrato nero, cfr. The Russian Experiment in Art. 1863-1922, Thames and Hudson, London 1962; pp. 158-9 della nuova ed. del 1986. Non sono note le ragioni per le quali il bozzetto non fu poi utilizzato per la realizzazione delle scene, e dal momento che non esistono testimonian ze né materiali né fotografiche della messa in scena del 1920 a Vitebsk, non sappiamo nemmeno se fu utilizzato in quella seconda occasione.
76
grafie», scrive Malevic, «Vi sarei molto grato se pubblicaste imo dei miei disegni, in particolare quello del sipario in cui ha luogo la vittoria. Ho appena ritrovato uno di quei bozzet ti e credo che attualmente sia molto importante includerlo nella vostra pubblicazione. Quel disegno avrà una grande importanza per la pittura. Ciò che è stato creato inconscia mente produce attualmente frutti straordinari». E ancora: «Tutto quanto ho realizzato nel 1913 per Vittoria sul sole mi ha condotto a numerose innovazioni. Purtroppo nessuno l’ha notato [...] Il sipario rappresenta un quadrato nero, embrione di tutte le possibilità»’1. La vittoria sul sole, il suo totale, cusaniano (vedremo tra poco) oscuramento, significa allora la possibilità prelimina re, il presupposto inaggirabile per immaginare-costruire (e non “comporre") la vera icona, foss'anche, o forse proprio
per questo, l’ultima, che di conseguenza non potrà essere al tro che nera. Spegnere la luce del sole che rivela gli oggetti significa abolire la logica semantico-discorsiva con la quale essi ci “parlano”, così come per Nietzsche non credere più nella grammatica era il presupposto per non credere più in Dio. A-logico è appunto lo zaum’ poetico e pittorico dei fu turisti russi: linguaggio sciolto, liberato, emancipato da ogni logos che raccoglie-discorre-rapporta (tra) i diversi, da ogni principio razionale che sistema e riflette qualcosa di ontolo gicamente precedente, l’ente “iniziale” che si pre-suppone. L’oggetto deve scomparire, deve diventare invisibile affin-
Cfr. A.B. Nakov II nuovo Laooconfe, eh., pp. 59-40. E ancora: «Con l’o pera Vittoria sul sole», dichiara Maleviò, «il Supremati&mo ha presentato la non-oggertività sulla scena teatrale», in Suprematismo: il mondo della non-oggettfvifà, di, p. 258. Lo stesso Nakov (p.58) dà notizia dell’esistenza di un al tro progetto di scenario «nel quale si vede distintamente e per intero il Qua drato nero». Probabilmente il disegno avrebbe dovuto far parte delle illustra zioni dell'edizione progettata da Matju&n, però mai apparsa. In effetti nella lettera Maleviò non fa menzione di un quadrato diviso da una diagonale ma di un quadrato foul court. Nella versione dell'opera presentata a Basilea che ab biamo già citato e visibile in rete, il fondale scenico è costituito dall’inizio alla fine da un grande quadrato nero su fondo bianco. Dubitiamo molto che tale scelta registica sia filologicamente corretta.
77
che il vero reale si renda visibile. Ma ciò appunto può com piersi soltanto escatologicamente, cioè dal punto di vista della fine, quando tutto cessa incessantemente, quando ri suona il non più tempo dell’Angelo apocalittico. * **
Allo spazio prospettico che nemmeno il cubismo aveva superato definitivamente, Malevic sostituisce lo spazio gene rativo. Abolito il punto unico di fuga, liquidata ogni ossatura spaziale predecisa, egli non considererà mai il piano di posa originario alla stregua di una superfìcie vuota destinata ad ac cogliere gli elementi —le forme non oggettive— come fosse un contenitore (la “scatola prospettica”) che preceda ciò che soltanto in un secondo tempo vi si collochi. Questo significa che non è più possibile definire le superfìci-piano in relazio ne ai bordi del quadro, alla cornice della tela. Il loro riferi mento è ora lo spazio aperto e tendenzialmente infinito in cui non hanno più alcun senso le fondamentali direzioni antro pologiche, “umane troppo umane” dell’alto e del basso, del la destra e della sinistra, quindi tantomeno ne ereditano il loro carattere oppositivo. Di conseguenza le superfìci-piano —ognuna carica di una propria autonoma, indipendente po tenza proiettiva e produttiva— erano distribuite, nell’allesti mento delle mostre, appese agli angoli oppure al soffitto per ché portatrici di un dinamismo che coinvolgeva tutto lo spa zio ospitante, ma che precisamente perciò non poteva più considerarsi come un neutro, semplice contenitore. Se le di rezioni orientative basate sulla forza di gravità terrestre non hanno più senso né potere coercitivo, allora anche la singola
tela non ha più un unico verso e può essere collocata in vari modi a seconda della qualità e delle dimensioni dello spazio che l’accoglie o del dialogo che intrattiene con le altre. Per fare un solo esempio, Suprematismo. Realismo pittorico di un giocatore di calcio, del 1915, fu esposto alla mostra “0,10” con il grande parallelepipedo nero in alto. In seguito, nelle mo stre del 1919-1920 e alla mostra di Varsavia del 1927, la for
78
ma era collocata in basso, e due settimane dopo questa, a Berlino, di nuovo in alto. Emerge in Malevic una nozione di spazio non referenziale Dovremmo dunque parlare piutto sto —esattamente come nella fisica moderna, soprattutto dal le ricerche sull’elettromagnetismo di Faraday e Maxwell in poi— di campo suprematista, che non è un’evidenza immedia tamente, empiricamente osservabile, non è un oggetto che semplicemente ci si presenta “davanti”, ma è piuttosto un’en tità deducibile dalle proiezioni cinetiche e dalle linee di forze magnetiche che lo attraversano e che così facendo lo creano. Nella teoria dei campi, infatti, ogni fenomeno fìsico (ad esem pio una carica elettromagnetica) si propaga nello spazio con velocità finita, in tal modo “modificando” lo spazio stesso in cui si manifesta, e assegnandogli specifiche proprietà52* . Come la metafora originaria della libertà potrebbe essere quella aperta dalla possibilità di muoversi in uno spazio che non è preliminare al movimento e che non ne prefigura le direzio ni, le intensità o le traiettorie55, allo stesso modo nelle opere suprematiste si apre un campo di tensioni dinamiche che non si innervano e si ramificano secondo schemi preordinati o gabbie geometriche, ma in cui, al contrario, sono gli stessi elementi tensili —le superfìci-piano— che danno origine a quello spazio che non le precede anche se percettivamente sembra accoglierle. Ed è qui che più potente si fa sentire la forza produttiva e generatrice del suprematismo. * **
Singolare contraddizione del Quadrato nero. Ma contrad dizione o antinomia del tutto intrinseca alla sua stessa conce zione, indissociabile dal suo significato filosofico. Nel suo mi stico azzeramento di ogni imprestito oggettivo e psicologico,
52 Cfr. sulla nozione dì campo nella rappresentazione iconica P. Florenskij, Le porte regali, dt., pp. 141-5, e come nozione-base nell’opera di Malevic, A.B. Nakov, Il nuovo Laoeoonte, dt., pp. 118-20. 5i Cfr. J.-L. Nancy, Lesperienza della libertà ( 1988); trad. it. Einaudi, Torino 2000, p. 77.
79
nella sua asseverativa e solenne concisione, nella sua potente, abissale “semplicità”, il Quadrato nero si rivela per l’osserva tore fonte di meditazione, di concentrazione spirituale, di ele vazione metafìsica. Queste innegabili qualità non possono non collocarlo in una eminente, auratica, solitaria unicità. Ep pure, nello stesso tempo, per esplicita e dichiarata volontà
programmatica del suo stesso autore, il Quadrato nero diven ta una sigla riproducibile, un contrassegno votato alla ripeti bilità seriale, un’immagine pronta a tradursi in cliché. Prima
di tutto, come noto, ne esistono tre versioni dipinte su tela. La prima —conservata alla Tret’jakov di Mosca e ormai in condizioni così precarie da non poter essere più esibita- è quella esposta alla “Ultima mostra futurista: 0,10” del di cembre 1915, organizzata da Ivan Pimi nàX'atelier di Na dezda Dobytcina al Campo di Marte di Pietrogrado5455 . È da
tata di pugno dall’autore 1913, ma nel 1970 fu postdatata allo stesso anno della mostra dallo storico dell’arte danese Troels Andersen con una scelta filologica, già abbiamo ricor dato, ormai accreditata da tutti gli studiosi5?. La seconda versione —conservata al Museo Russo di Pietroburgo— fu re alizzata (assieme alla Croce e al Cerchio, tutti e tre i dipinti di nuovo antedatati al 1913) sotto la supervisione e con l’assi stenza di Malevic da tre suoi allievi nel 1923, e la tema di opere fu esposta alla Biennale di Venezia dell’anno successi-
54 Nella letteratura storico-critica, il titolo della mostra è il più delle volte ri portato con il punto tra le due cifre: 0.10; ma basta vedere il volantino che fu distribuito all’inaugurazione per accorgersi che in realtà compare la virgola. Cfr. la riproduzione fotografica in Kazimir Malevich 1878-1915, cit., p. 156. 55 Si veda però quanto scrive Camilla Gray: «At what point the actual Black Square painting was executed it is difficult to ascertain precisely. The fact that it was not exhibited until late 1915 would in no way indicate that it dates from that year [...] Malevic did not always, or even usually, exhibit his most revo lutionary works immediately. His Cubo-Futurist works were exhibited a year, if not two, after their completion»... p. 160. «Quando il Quadrata nera fu ese guito è difficile da accertare. Il fatto che non fu esposto fino alla fine del 1915 non indica che risalga a quell’anno [... ] Non sempre Maleviè esponeva imme diatamente le sue opere più rivoluzionarie. I suoi lavori cubofuturisti furono esposti circa un anno, se non due, dopo il loro completamento», traduzione nostra, p. 160.
80
vow. La terza versione risale al 1929 e fu dipinta da Malevic su sollecitazione di Alexander Fedorov Davydov, l’organiz zatore della sua retrospettiva tenuta nel novembre dello stes so anno presso la Tret’jakov ove tuttora è conservata. Il Qua drato nero fu poi replicato (celebri foto ce lo testimoniano) da Nikolaj Suetin, allievo e collaboratore, in occasione dei funerali di Malevic. Uno compare affisso alla parete inclina to in avanti nella stanza del suo appartamento situato nell'ex edifìcio del GiN’chuK (Istituto nazionale di Cultura artistica) di Leningrado trasformata in camera ardente, ove la salma dell’artista è composta su un catafalco bianco adornato di fiori anch’essi bianchi e circondata dai suoi quadri. Un altro è dipinto, assieme alla replica del Cerchio Nero, sul coper chio della bara che compare nella stessa foto. Un altro anco ra è montato sul radiatore dell’automezzo che accompagna il feretro alla stazione Moskovskaja per il trasferimento a Mosca. E di nuovo un altro, dipinto a olio su gesso, decora va il cubo di cemento collocato sulla tomba (poi distrutta durante la guerra) a Nemcinkovka presso la capitale. Ma un quadrato nero era cucito anche sulle maniche degli studenti dell’uNOVis (acronimo di utversderje novichform iskusstvo,
’nascita di nuove forme nell’arte’) come segno collettivo di riconoscimento e “simbolo di fede" di quella piccola comu nità paramonastica che si era formata presso la Scuola d’Ar te di Vitebsk attorno alla figura carismatica di Malevic. E che il quadrato fosse l’emblema iterabile del Suprematismo come modello totalizzante di vita e non soltanto “stile” arti stico, lo conferma —se ce ne fosse ancora bisogno— il ricordo dello scultore Anton Pevsner secondo il quale Malevic se guiva il feretro della sua allieva prediletta prematuramente
scomparsa stringendo uno stendardo nero su cui aveva cuci to un quadrato bianco. D’altra parte, la riproduzione del Quadrato nero sul frontespizio della terza edizione, uscita
56 U commissario del Padiglione sovietico, Boris Temovec, dichiara esplici tamente nel catalogo la sua disapprovazione della corrente suprematista, pre sente in mostra, fa capire, soltanto per ragioni di obiettività.
81
nel 1916, dell’opuscolo Dal cubismo e dalfuturismo al supre matismo ne mostra chiaramente l’aspetto grafico sottoline andone già il carattere tipizzante di per sé disposto alla ri
producibilità. Enigmatica, ieratica sfìnge e insieme vessillo occasional mente utilizzabile, unicum fonte di meditazione spirituale, simbolo protrettico e al contempo sigla, distintivo come tale destinato alla ripetizione, il Quadrato nero è antinomico nel suo stesso animus, vive di questo conflitto forse solo appa rente, è solcato e sorretto da questa tensione. Ma questo è il medesimo paradosso dell’icona: inseparabile dalla vita spiri tuale e dalla profonda meditazione sul mistero che essa indi ca, e nello stesso tempo —in ragione della sua struttura ico nografica tipizzante- perfettamente adeguata e suscettibile sia alla falsificazione sia alla produzione meccanica e indu
striale realizzata in serie. ★ ★ ♦
Malevic mostra l’inscrizione iconica nella propria opera attraverso un gesto che produce una delle immagini più ce lebri dell’arte del xx secolo. Ma su quale terreno eminente mente dialettico, su quale "divergente accordo” va inqua drato il suo rapporto con l’eredità iconica ortodossa? Quali sono i presupposti concettuali e filosofici all’interno dei qua li diventa possibile rendere conto di quella concordia discors, di quel paradossale dialogo a distanza? In che senso e in quale misura Malevic strappò «le corde della memoria», come disse il poeta Daniil Charms nella sua orazione in ver si alla cerimonia funebre dell’artista?
Per circoscrivere la questione, il lessico dell’ermeneutica dispone del termine forse più adatto, del concetto più ineren te: quello di Verwindung, che significa tramandamento-trasformazione dei contenuti esistenziali e storico-culturali57. Si
57 II riferimento d’obbligo è a H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960); trad, it. Fabbri, Milano 1972.
82
tratta di un processo di appropriazione innovativa del passa to in cui ricordo che vincola e libertà che scioglie trovano un terreno comune, tradizione e modificazione si co-appartengono. L’oblìo si nutre di memoria, straniamento e familiari tà germinano insieme. Dobbiamo collocare la potenza aporetica di questo intreccio tra contesto e decisione all’interno e nell’essenza stessa della modernità artistica, nella sua idea filosofica e nella sua pratica operativa, abbandonando defi nitivamente l’autorappresentazione ideologica delle avan
guardie in termini soltanto di tabula rasa, soltanto di radica le novìtas. In Malevic vive una modernità più segreta, più complessa, più articolata di quella che si può designare con l’espressione “avanguardia russa”. Se è vero che nella sua opera paradossalmente assume nuova vita il problema arti stico e teologico-fìlosofico dell’icona, allora ciò significa che
quell’intreccio, quella Verwindung si anima anche in quei casi ove più enigmaticamente evidente ci si offre il tratto dell’azzeramento radicale; significa che quella connessione
trascendentale “sovrintende” anche a quegli esiti ove viene esibita la rottura più innovativa, la discontinuità più dichia rata. In questo senso davvero il Quadrato nero è ultima ico na. Esso riesce a porsi come rottura irreversibile con la sto ria che ha alle spalle e insieme potente actio in distans pro prio in rapporto ad essa. «Lo spirito della distruzione è lo stesso che lo spirito della creazione»: era il motto di Baku nin, e Malevic era notoriamente di fede anarchica. Ma tutto ciò possiamo intuire e sviluppare soltanto se sia mo in grado di cogliere neH'opera moderno-contemporanea in generale il luogo eminente, il campo privilegiato di una tensione irrisolta e asintotica tra persistenza e mutamento
che la rielabora e la trascrive; se riusciamo a vedervi lo spa zio aperto in cui possono confrontarsi e dialogare interro gandosi reciprocamente le dialettiche dell’appartenenza e della decisione che quell’appartenenza modificano. Al pari del logos polemos eraclitèo, l’opera rende percepibile -quin di trasformabile— questa tensione produttiva proprio perché irrisolta e in costante fermentazione; l’opera fa spazio per
si
che questa possa esprimersi “a giorno”, porta alla luce del presente —una luce che trattiene in sé l’ombra del passato— quell’indiroccabile vincolo dei diversi, quell’inaggirabile le
game degli opposti: attesa e insieme allarme. L'arte moder no-contemporanea, per parafrasare Simone Weil, è radicata sì nell’assenza di luogo; ma per l’appunto vi è radicata, con fìtta ma non sconfìtta. In essa non vive un primo, isolato mo mento costituito dal corpus di regole, codici, norme passiva mente ereditate da un passato prescrittivo, al quale contrap porre un secondo momento scisso dal primo e inteso come antitesi frontale e negazione di quelle regulae attuata nel pre sente che si infutura, come scarto assoluto e azzeramento ol
tranzista. Nonostante, per così dire, ciò che essa pensa di sé stessa, indipendentemente dalla qualità della sua autoconsa pevolezza, nell’arte moderno-contemporanea vive piuttosto —di nuovo esattamente come il logos polemos di Eraclito— l’indecidibile “Unoduità” della loro reciproca, intima, dia lettica co-appartenenza che si esplica via separazione, che si esprime al modo della difformità, che si manifesta e si fenomenizza attraverso lo scarto reciproco. Nell’evento che l’o pera è, i tempi si congiungono nella differenza. Come se l’o pera fosse il differimento di una connessione trascendentale, l’espressione in sé divergente di un’archiunità inesprimibile perché essa stessa rende possibile esprimere. Proprio custo dendo la memoria, proprio curando la tradizione come tale, si produce la modificazione, irrompe la decisione: come se la regola apparisse nella (sua) violazione, come se nella tradi zione stessa, nell’estrema varietà di diversi che però la com pongono, crescesse proprio per questo la radice della diffe renza che libera, si trovasse l’alimento di cui si nutre l’inno
vazione arrischiarne, il novum più radicale. La tradizione stessa è il tramandamento delle sue stesse modificazioni; la tradizione è sempre e per statuto “corrotta”. Forse niente come la costellazione filosofica in cui si inserisce l’arte mo derno-contemporanea e che questa contribuisce certo a for
mare, può meglio farcelo comprendere, disponendoci a per cepire il presente come polifonia e stratificazione di tempi in
84
cui passato e futuro convivono, operano e costruiscono. Nel contesto che abbiamo qui delineato, lo ripetiamo, davvero il Quadrato nero rappresenta nel senso letterale sia dell’agget
tivo che del sostantivo V ultima icona. È precisamente attraverso questo cono prospettico che dobbiamo inquadrare il rapporto tra Malevic e la tradizione delle sacre icone russe. Le prime icone furono portate da Bi sanzio nella Rus’ medievale dal principe Vladimir nel x seco lo, quando si compie la definitiva cristianizzazione di quella terra, e con essa si fa sempre più forte e diffusa l’influenza artistica e spirituale della pittura bizantina. I centri principa li della straordinaria fioritura iconografica della Russia orto dossa furono Kiev, Pskov, Vladimir, Novgorod e più tardi, intorno al xv secolo, anche Mosca. Bisogna sottolineare e ri cordare prima di tutto che l’icona non è un’opera d’arte; piuttosto è un’opera di lode, preghiera e testimonianza cui è necessaria l’arte. L’iconografo non è un artista nel senso mo derno del termine ma il prefìguratore del mondo che verrà. Nella purezza della sua definizione dogmatica originale, dunque, essa non lascia alcun spazio né all’espressione o alla fantasia soggettiva di chi la realizza né a una ricezione di tipo estetico da parte di chi la osserva. L’icona non ha nulla a che fare con il soggettivismo laico e secolarizzato tipico della de finizione moderna e occidentale dell’arte e dell’attività arti stica. La nostra intentio videndi al cospetto di essa non può né deve essere estetistica ma metafìsica. Il Concilio n di Nicea stabilì con estrema chiarezza che al
pittore spetta esclusivamente l’aspetto tecnico -elaborato fino all’ascesi— dell’opera, mentre la dialaxis, cioè la disposi zione e la composizione dell’immagine, spetta ai Santi Padri. Nel Consiglio dei Cento Capitoli del 1551 si ingiunge che «gli iconografi si astengano da fantasie e seguano la tradizio ne». È la Chiesa dunque che nell’esercizio del suo insindaca bile magistero deve riconoscere e certificare la conformità dottrinale e dogmatica dell’immagine prodotta rispetto alla
protoimmagine evocata. Gli iconografi devono seguire e ap plicare i podlinniki, i manuali che dettano le norme tecniche
85
e le procedure pratiche, e a loro stessi -ove non siano veri e propri monaci- è prescritta una condotta di carattere para monastico: sono controllati dal Metropolita, devono mante nersi puri, osservare i digiuni rituali e confessarsi regolar mente al loro padre spirituale. Se l’icona è opera testimoniale e non l’espressione di uno stile autonomo e individuale, attraverso il rispetto del cano ne formale, essa fonda la propria ragione di esistere e acqui sta il suo significato più completo all’intemo del culto collet tivo e della comunità che quel culto pratica come traditio ve ntati;, instaurando così un rapporto fecondo con la cultura che quel canone ha generato58. L’esigenza della forma cano nico-ecclesiale, che, ripetiamo, si trova all’opposto del nostrio modello culturale moderno di tipo soggettivistico -e per la cui comprensione profonda, si afferma, non basta ima vita— viene considerata dai teorici dell’icona una forma di li bertà e non di limitazione o di coercizione. Non c’è una pre supposta quanto presunta libera creatività che sarebbe in se guito conculcata dal canone, dalla regola, dalla norma. Il ta lento è certo indispensabile ma a nulla vale se non è accom pagnato dalla santità di una vita ascetica, da una metabolè,
cioè da una vera e propria trasformazione dell’esistenza per sonale operata attraverso l’ascolto e la preghiera. Se nella tradizione iconografica il passato eterno è radice portante del presente, allora essa, rispettandone i dettami, non soltanto è aliena da ogni sensibilismo emotivo, ma non esprime né si conforma a una lex esterna intesa come vincolo pattizio e convenzionale, arbitrario e contingente, bensì entra in pro
58 Scrive Pavel Florenskij: «Quanto più il canone è fermo e reiterato, tanto più profondamente e puramente si esprime un bisogno spirituale universal mente umano: la cononicità è ecdesialità, l’ecclesialità è conciliare-collettiva, il conciliare-collettivo è universalmente umano», (Le porte regali, cit., p.90). Florenskij ha sempre esplicitamente avversato le avanguardie del suo tempo, che chiama le «correnti più recenti e sinistre» (p. 159), impegnate nel «malato e ambizioso ripudio delle forme umane comuni» (p.81 ). Cfr. su questo punto cruciale e delicato la Poitfazione di N. Misler a P. Florenskij, Lo tpazio e il tem po nell’arte, cit.
86
fonda sintonia con un ethos comune e condiviso fatto di re gole e norme cui deve prestarsi una cura e un’attenzione particolari. Cura e attenzione evidenti in tutte le fasi del pro cedimento tecnico della creazione dell’icona, ognuna con un proprio significato metafisico, dalla scelta della qualità del legno per la tavola fino alla stesura dei colori e all’impasto
della colla. I veri liberi vengono dunque ritenuti non coloro che esercitano ad libitum il proprio peccaminoso e capric cioso arbitrio soggettivistico, ma coloro che sono vincolati alla comunità etico-religiosa cui appartengono, che hanno perfettamente interiorizzato i suoi precetti provenienti da una dimensione non storica ma carismatico-trascendente e che precisamente in essi, e non nell’esprimere gli alterni, im pressionistici, fugaci moti del proprio io individuale, trova no la loro più autentica libertà. I principi stilistici dell’icona tradizionale sono noti e li ab biamo già rapidamente richiamati nella prima parte della no stra ricerca. I chiaroscuri naturali non vengono modellati; grande rilievo viene assegnato al contorno, alla perigraphè delle figure; il colore è piatto, tendenzialmente uniforme, in tenso, dal timbro luminoso, ed è sempre usato in senso sim bolico, ultraterreno; in assenza di qualsivoglia allusione a profondità spaziali-volumetriche, non esiste né davanti né dietro poiché l’intera compagine visiva si sviluppa su di un unico piano di posa. Le proporzioni sono ignorate e i rappor ti di grandezza hanno caratteri simbolico-metafìsici e non mi metico-realistici. Sappiamo d’altronde che le espressioni vi
suali delle prime comunità cristiane -soprattutto per ragioni anti-idolatriche in rapporto al paganesimo- rinunciano all'immagine descrittivo-naturalistica preferendo simboli
astratti e quasi pittogrammatici come la colomba e il pesce, la nave o la lira musicale59. La prospettiva rovesciata -il codice visivo che sovrintende all’impianto strutturale dell’icona— crea uno spazio autonomo con sue proprie norme, concluso
59 Lo stesso Agostino, ad esempio nel De alitate dei (cfr. tv, 31,2), conside ra più puro il culto divino privo di immagini.
87
nei confini dell’immagine, ove le leggi di gravità non hanno più corso né valore, e l'astrazione dalle apparenze fenomeni che è completa e definitiva quanto lo è la rinuncia ad ogni ge
nere di arsenale illusionistico per fìngere la tridimensionalità spaziale60. L’icona è l’immagine dell’eone futuro, dunque essa è festa, tempo liberato da ananke, cioè non più necessi
tato dalla catena che in continuità si svolge da un prima a un dopo; è tempo contratto e sospeso dell’evo venturo in cui prende figura il prototipo di quella che sarà l’umanità trasfi gurata, resa diafana dallo spirito che finalmente assoggetta la carne. A tutto questo consegue, sul piano stilistico-visivo, che è ignorata ogni unità o congruenza diacronico-narrativa di tempo e luogo: tutti i tempi e tutti i luoghi possono essere convocati insieme nella stessa immagine. La prima esposizione a carattere artistico delle icone an
tiche avvenne a Mosca nel 1890, durante il Settimo Congres so della Società Panrussa di Archeologia. Del 1904 è il re stauro della Trinità di Rublèv ad opera dei monaci della Lau ra di San Sergio. Del 1913 -anno cruciale, sappiamo, per Malevic- è la Mostra di Archeologia Cristiana organizzata in occasione del trecentesimo giubileo dei Romanov, in cui furono esposte 147 icone restaurate e liberate dai rifacimen ti posteriori. La riscoperta di questo straordinario patrimo nio partecipò e dette nuovo e ulteriore impulso alla fioritura
artistico-letteraria e filosofica, spirituale e scientifica della Russia tra Otto e Novecento. Malevic, che aspirava a edificare un nuovo sistema pitto rico rigoroso e affidabile, non poteva non rimanere affasci
60 Cfr. P. Florenskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Mi ster, trad. it. Gangemi, Roma 2005, e B.A. Uspenskij, Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe, in AA.W., Ricerche semiotiche. Nuove tendenze del le scienze umane nelLviiss. a cura di J. Lotman e A.B. Uspenskij; trad. it. Ei naudi, Torino 1973. Per quanto attiene agli studi iconologici nella cultura rus sa dell'epoca, cfr. anche E. Trubeckoi, Contemplazione nel colore. Tre studi sull'icona russa, che contiene scritti dal 1915 al 1918, trad. it. La Casa di Matriona, Milano 1977. Cfr. anche L. Uspenskij, V. Losskij, Il senso delle icone (2003); trad. it. Jaca Book, Milano 2007.
88
nato dai principi strutturali che sovrintendono alla tradizio ne iconografica e al suo significato metafisico, principi dei quali non è difficile ritrovare nella sua opera la Verwindung, la trasmissione-trasformazione. Solo apparentemente, solo “a prima vista", ripetiamo, essa può considerarsi iconoclasti ca; in realtà, si trova all’interno della questione (intesa come problema e come domanda) dell’icona, ne sviluppa fino in fondo la logica, ne porta fino all’estremo limite la dialettica. In vari modi e sotto diversi aspetti, questa logica e questa
dialettica si trovano trascritte e inscritte nella sua opera come dispiegamento “immaginale” di ciò che precedentemente è privo di immagine61. Nel suo “saggio autobiografico”, come lui stesso lo chia mava, che non portò mai a termine, Malevic rammenta l’in flusso che ricevette dalla «Mosca delle icone»: gli iconogra fi, scrive, «raggiunta una grande maestria tecnica, riprodu cevano il contenuto in ima verità antianatomica, fuori dalla prospettiva spaziale e lineare. Il colore e la forma erano da essi creati in base alla percezione puramente emotiva del te ma»62. Già in queste parole si riconoscono in nuce alcuni dei principi stilistici e di poetica adottati nella sua opera. Nell'i cona segno e colore si danno “in sé”, non devono fìngere al cuna profondità naturalisticamente illusiva; ogni descrittivi smo è definitivamente superato; ombre e chiaroscuri vengo
no tota caelo liquidati; i piani e le superfici devono davvero im-porsi come tali nella loro immediata realtà, senza alcuna illusione-allusione tridimensionale; l’immagine, sempre fron
tale, proprio perché delineata nella sua rigorosa e icastica chiarezza, sa rinviare a ciò di cui immagine non si dà. Questi sono anche i principi essenziali del Suprematismo, ma già nella fase cubofuturista (ad esempio nei già citati Raccolta
61 «L’immagine deve scoprire in sé un’iconoclastia: la sua origine», scrive Andrea Emo nelle sue mirabili, solitarie riflessioni filosofiche sull’arte. E an cora: «L’iconoclastia crea Fimmagine, e l’immagine è il ricordo, la memoria della sua iconoclastia» (Le voci delle Muse. Scritti sulla religione e tuli’arte 1918-1981, a cura di M. Dona e R. Gasparotti, Marsilio, Venezia 1992, p. 109. 62 K. Maleviè, Autobiografia, in Scritti, cit., p. 37L
89
della segale, Taglialegna del 1912-13) all’insieme cromatico —arancio, scarlatto, blu oltremarino, vinaccia, verde inten so— manca solo il diapason dell’oro per ricordare ancor più da vicino i colori dell’icona. Il medesimo genere di innesto e inscrizione delle immagini sacre lo troviamo più che eviden te anche nelle cromìe timbriche e squillanti della fase del Su-
prematismo dinamico (1915-16) e nelle forme a croce osses sivamente ripetute nei dipinti e nei disegni dal 1915 in poi, che riprendono le croci nere sulle vesti candide dei santi, la cui piatta omamentalità è confermata dal fatto che non ven gono modificate in senso plastico delle pieghe del panneggio su cui sono impresse. E infine negli ultimi anni post-supre-
matisti quando, oltre ai colori accesi e piatti, la ieraticità frontale delle figure intere in sequenza paratattica e dei vol ti senza volto dei contadini, si rivelano straordinarie trascri zioni dei canoni plastici e delle soluzioni compositive dell’i conografìa devota russa. Come noto, Malevic appendeva il Quadrato nero legger mente inclinato verso l’osservatore, in alto nell’angolo for mato dall’incontro della parete con il soffitto, lo stesso dove nelle dimore ortodosse tradizionali si collocava in forma de vozionale e protettiva l’icona verso la quale, entrando, d si rivolgeva facendosi il segno della croce. E nella nona delle ventidue tavole didattiche utilizzate per le sue lezioni di ana lisi formale all’iNchuK negli anni Venti, compare la riprodu zione del Quadrato nero accostata a quella dell’immagine di una Theotokos^. Ma ecco perché il Quadrato nero è icona di nulla: anche la salvezza finale, fino a che è pensata come un oggetto, non è la vera salvezza, che si può trovare soltanto nella grazia,
come tale inintenzionale, della non-oggettività6*. I santi raf-
Le tavole furono presentate per la prima volta in occasione della mostra curata da Troels Andersen allo Stedelijk dove sono conservate; cfr. la riprodu zione nel catalogo, Stedelijk Museum Amsterdam, 1970, p. 121. 64 Cfr. su questo motivo assolutamente decisivo della grazia e dell’inintenzionalità nelle arti moderno-contemporanee il ns. La mosca di Dreyer. L’opera della contingenza nelle arti, Jaca Book, Milano 2007.
90
figurati sulle icone predicano la salvezza, «ma su nessuna icona», scrive Malevic, «il santo compare come un nulla. Pure, l’essenza divina è la salvazione nel nulla. E questa sal
vazione è posta nel ciclo delle metamorfosi di tutto ciò che è oggettivo nel non-oggettivo»6’. È in questo nulla che dimora la nostra salvezza. ***
«Sfinge egizia della nuova sensibilità»: così Nikolaj Sue-
tin, prima allievo poi fido collaboratore di Malevic, definì il Quadrato nero. Opera enigmatica, certo: eppure che cosa c’è di più semplicemente comprensibile di una forma quadrata, che cosa c’è di più “didascalicamente” evidente? Che cosa di più iconograficamente chiaro tanto da far pensare alla didaké di una nuova alfabetizzazione visiva ai suoi primi rudi menti? Ma un mistero rimane mistero anche se mostrato, anzi proprio perché mostrato. La persona sovraessenziale del Cristo, assunta la carne umana, si è rivelata a noi a misu ra delle nostre capacità di comprensione, tuttavia Egli rima ne celato —come scrive lo Pseudo Dionigi l’Areopagita, già sappiamo— nella sua stessa apparizione. Allo stesso modo, il Quadrato nero “resta nascosto nella sua apparizione”, o me glio è la presentazione semplice, chiara, “didascalica” del mistero, l’esibizione del fatto che c’è mistero: è l’e-videnza dell’enigma. Certo: la verità della bespred’mctnost. dell 'inoggettività’ non consiste, come già abbiamo visto, nel cor rispondere o nell’adeguarsi alla cosa ma all’opposto nel ne garla mostrandola come nulla, contrapponendosi incessan temente all’inerzia e alla gravità dell’universo fenomenico, poiché per Malevic il fenomeno è appunto già da sempre in
tegrato e assorbito nella piattezza oggettiva che appare sen sibilmente. Ma ciò non ha niente a che fare con un triviale nichilismo immediatamente liquidatorio. Nel percepire ope rativamente la non-oggettività, egli in qualche modo costrui-
K. Maleviè, Suprematismo. Il mondo della non-oggellività, cit., p. 67.
91
see una iconologia dell’ascesi aniconica, rende immagine ciò che va oltre la rappresentazione immaginale: tramite il visi bile ci dispone —esattamente come fa l’icona tradizionale at traverso la raffigurazione dei misteri della fede— all’invisibi le. È precisamente questo il suo Sublime, ed è per questo che il Quadrato nero è la «messa in opera della presenza del niente»66* : segno artistico-fìlosofico non della mera negazio ne ma dell’assenza. Di un’assenza o meglio di un astensione che cerca di cogliere con una traccia “in levare" quell’ele mento germinale, fontale, posto al di qua del linguaggio —la sensibilità pura, inoggettiva- che rende «manifesta la laten za della poesis»hl. Il Quadrato nero (la cui forma geometrica non ha alcuna attinenza simbolico-simbologica) ha un ruolo attivo, costruttivo: deve agire —di nuovo un segno dell’ar/zo in distans tra Malevic e la filosofia dell’icona- in funzione,
come già accennato, protrettica: così come l’icona asseconda nel fedele lo sforzo di realizzare la somiglianza con il Proto tipo, il Quadrato nero prepara, induce, awia-verso l’espe rienza di ciò che non appare, l’esperienza della sovraessenzialità dell’essere come Niente, non-ente; e nello stesso tem po fa nascere e alimenta nell’osservatore l’interrogativo on
tologico fondamentale circa la natura stessa dell’arte. Svela re il nulla in un’icona astratta da ogni sensibile rappresenta bilità: proprio questo significa non sottomettersi, non cede re alla sua potenza annichilatrice, ma “liberarlo", liberarne la capacità produttiva. Il mondo senza oggetti rimane un mondo. Non si tratta di esprimere —nonostante le apparen
ze (ma proprio queste sono in questione!) possano testimo niare del contrario— il senso di una perdita, di un vuoto, di una dissoluzione: questa è la lettura più immediata, sempli cemente, “ingenuamente” nichilista. L’Inattingibile non è affatto “soltanto” l’assolutamente Altro, ma l’assolutamente
Altro che si rivela appunto come inattingibile nella visio “in
66
G. Di Giacomo, Icona e arte astratta. Aesthetics Preprint, Palermo 1999,
p. 56. 6? E Menna, La linea analitica dell"arte moderna, Einaudi, Torino 1975, p. 66.
92
nominale” del Quadrato nero, e che prelude all’apertura illi mitata del Possibile, alla sconfinata, libera, luminosa naviga zione nell’infinito che Malevic ha lasciato in eredità a tanta parte delle arti moderno-contemporanee: a Yves Klein e a Fontana, a Rothko e a Lo Savio, a Rvman e a Reinhardt. id uhi consistam aporetico, il fondamento diacritico della grande astrazione di Malevic quale icona dell’infigurabile insiste su questo motivo, quasi un filosofema: se non operas si —se non dipingessi— mi comporterei per l’appunto mime ticamente, raffìgurativamente nei suoi confronti, tradirei il suo stesso statuto e soprattutto non saprei coglierne l’ewergheia sprigionante, considererei nulla il Nulla, volgarmente passivo il pathos. Questo sarebbe il vero nichilismo. Identi co motivo si trova nella tradizione estremo-orientale. Per evocare esteticamente la visione della vacuità taoista o del
sunyata del buddhismo Mahayana è necessario accedere al Campo fenomenico68. C’è si un altrove ma lampeggia (come vuole Plotino) nell’/w et nunc del sensibile intuito, pensato e “lavorato” come icona non raffigurativa dell’infinito inap propriabile. Il Quadrato nero non fa “apparire" il Nulla, bensì, manifestandolo, appartiene al Nulla, perché l’ipseità dell’essere non può essere altro che il Nulla e l’ente “Qwadrato nero" non è che l’ek-sistere del Nulla.
Il nuovo deserto; nuove arti per sopportarlo, noi anfibi ...
Friedrich Nietzsche, La volontà di potenza
Dopo la prima comparsa pubblica del Quadrato nero, il critico conservatore Aleksandr Benois scrisse un articolo in cui attaccava violentemente il punctum saliens di quella che
68 Cfr. su questo punto T. Izutsu, La filosofia del Buddhismo zen (1977); trad. h. Astrolahio-Ubaldini, Roma 1984, in pan. pp. 221 sgg.
93
avrebbe dovuto affermarsi come la nuova pittura che va al di là di sé stessa, accusando la persona dello stesso Malevic di propagare uno spirito distruttivo e colpevolmente nichilista che avrebbe potuto minacciare le basi morali della società russa. «Davanti a noi», scrive, «c’è adesso la nuova icona del quadrato. Tutto il santo e il sacro, tutto ciò che amavamo e di cui vivevamo è scomparso. Dove prendere le maledizioni perché questa infamia entri nel branco dei maiali e scompa ia nel vile abisso?»69. Assoluto è lo spaesamento di fronte
all’inaccessibile e inviolabile chiarezza del Quadrato nero, al mistero della sua impenetrabile evidenza. Malevic risponde a Benois con una lettera personale («Poiché le porte della stampa mi sono chiuse») che non è soltanto una difesa della propria opera ma anche il Grundriss, la traccia profonda sul la quale si svilupperà tutto il suo percorso artistico e filoso
fico futuro. «La vostra arte è un’arte che illustra la storia de gli aneddoti, un manuale per gli studenti, ma in nessun modo una creazione», scrive Malevic, ed ecco perché «per voi è difficile scaldarsi davanti al volto di un quadrato, abi tuati come siete al calore di un bel musetto» (corsivo no stro); ma si può stare certi che «nel mio quadrato non vedre te mai il sorriso della dolce Psiche»70. Ma al di là delle parti più accesamente polemiche (e del tutto scontate nel clima del tempo) troviamo nella lettera ima dichiarazione straordi
nariamente significativa: «Io ho soltanto l’icona nuda e sen za cornice della mia epoca, ed è difficile lottare», ma, nono stante ciò, il compito è quello di «andare sempre avanti nel vuoto del deserto. Perché là è la trasformazione» (corsivo no-
69 Cfr. K. Maleviè, Scritti, dt., p. 318. Un analogo, ma per molti versi ben più grave e ‘definitivo’ fraintendimento è mostrato da Pavel Evdokimov in tempi più recenti, quando chiede retoricamente: «si può sentire il desiderio di pregare davanti al quadrato di Maleviè?», in Teologia della bellezza (1972); trad. ìl Ed. Paoline, Roma 1982, p. 102. D’altra parte, poche pagine prima (p.99), aveva affermato: «se si vuole immaginare la decorazione murale dell’in ferno, certa arte contemporanea risponde al compito» (! ). 70 Op. dt., p. 167.
94
stro)7172 . D Quadrato nero è l’icona del xx secolo, l’icona dell’a pocalisse distruttrice e rigeneratrice, della restaurazione fi nale che salva dalla rovina, dalla catastrofe degli oggetti. Ed
è un’icona, abbiamo visto, “pre-adamitica”, senza nome proprio, priva di un nome che non sia la propria tautologica autodesignazione; un’icona priva di una protezione storica, simbolica, perfino fìsica («nuda e senza cornice») che possa difenderne la legittimità. Ma è l’icona di un tempo che si di schiude al futuro, un tempo che il suo autore sente intensa mente come proprio, e per il quale deve, pur tra difficoltà di ogni genere, lottare, combattere aspramente sia sul piano estetico-artistico che su quello morale e politico. Per andare dove? Per indirizzarsi in quale direzione? La risposta è di una straordinaria potenza metafisica: per andare là dove non c’è nessun “dove”, perché nel deserto, in quella astratta lo
calità senza luoghi che si rimodella perpetuamente, che non fa che crescere indefinitamente su sé stessa, ogni possibile punto di riferimento nasce e muore in un attimo trasfigura to dal vento. Bisogna avviarsi in direzione di ciò che fa smar rire ogni direzione, perché dove lo spazio sembra soltanto fare spazio allo spazio, orientarsi e perdersi si alternano con tinuamente fino a coincidere, fino a perdere il loro valore oppositivo. Procedendo nel vuoto del deserto, Malevic si di spone all’esperienza del nulla che azzera ogni esperienza, e il nulla —scrive Meister Eckhart nel sermone Ego elegi vos de mundo— «è lontananza e deserto, è senza nome piuttosto di avere un nome»’2. In una delle prediche del Cusano im Geistes Eckhartr, 'nello spirito di Eckhart’, Ubi est qui natus rex ludaeorum?, il dove diventa la categoria cruciale della rifles sione, e dopo aver affermato che Dio non ha un “dove” poi ché non può essere contenuto in alcun luogo, conclude che Dio stesso «è il luogo»71. H deserto è allora 1’exemplum sen-
71 Op. cit., p. 166. Maleviè utilizza la metafora del deserto anche in Suprematismo, cit., p. 138: «la liberazione non oggettiva» lo ha trascinato «nel deseno dove la sola realtà esistente è la sensazione». 72 M. Eckhart, Sermoni tedetcbi, trad. it. Adelphi, Milano 1985, p. 93. 7J N. Cusano, Il Dio nascosto, cit. p. 74.
95
sitile, la metafora concreta di questa immanenza ubiquita ria, di questo aver-luogo del luogo. Anche Uspenskij, certa mente una delle “fonti" di Malevic, parla a lungo del deser
to dell’infinito che si apre davanti a chi supera il mondo del le apparenze sensibili grazie alla sua superiore intuizione. Eppure, nello stesso spaziotempo di questa disperata spe ranza, Malevic comprende che disporsi all’esperienza del nulla può significare disporsi all’esperienza inaugurale dell’inizio, alla scelta non per i possibili ma per il Possibile in quanto tale. Cioè all’esperienza della libertà come apertu ra preliminare ad ogni esperire. Nel deserto il nomade non soltanto erra ma anche soggiorna: ed è pazientemente sog giornando che avviene la trasformazione-trasfigurazione di cui parla Malevic, per il quale la libertà ha senso se prima di ogni altra cosa significa poter non rappresentare-raffigura-
re-riprodurre alcunché. Mentre l’imitazione è limitazione, mancanza di libertà o forse peggio libertà vigilata, la libertà vera è essenzialmente non imitativa, inoggettiva, non rasso miglia a nulla di già dato, non riflette alcuna istanza antece dente né mima alcuna precedenza7-1. Così come ogni espe rienza di libertà è anche un’esperienza di liberazione, così per Malevic procedere nel vuoto del deserto significa colpi re strutture chiuse e ordinamenti sovrani, liquidare principi e valori acquisiti, gerarchie stabilite e assetti congelati. Un’e sperienza fondamentalmente, letteralmente an-archica, quella della liberazione, in ogni modo indipendente, si badi bene, da ogni successivo, eventuale possibile fallimento (Kant aveva già detto tutto il necessario su questo punto nel lo scritto Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, del 1798, seconda parte del Conflitto delle facoltà).
Pena la sua assoluta incomprensione (“astrattismo formale-geometrico”, “minimalismo concettuale” e via etichet tando), occorre individuare con precisione la dialettica in trinseca e immanente che sostiene il Quadrato nero. Da una parte, vive in esso un tempo interno che è memoria di sé e
7-1
96
Cfr. J.-L. Nancy, L'espertenza delia libertà, dt., p. 154.
del percorso che ha fatto per arrivare alla sua attuale confi gurazione: non esiste nessuna mitologica libertà dell’arte o dell'artista al di fuori del suo contatto con la storia come ele mento di attrito. Dall’altra, ma in uno, con il Quadrato nero, Malevic, per parafrasare Rimbaud, “rende Ubera la libertà”: catastrofe, trasformazione-trasfigurazione, discontinuità, metanoia operata nel vuoto disorientante ma inaugurale del deserto. Da questo punto di vista, occorre sottolineare con forza che il Suprematismo non significa affatto un accesso immediato a un supposto, sconfinato regno della libertà ove ogni fare è indifferente perché dissociato dall’oggetto e dal la mimetologia raffigurativa che esso implica. In uno schizzo esplicativo di E1 Lissitskij tratto dagli ap punti che stese per una conferenza tenuta a Berlino nel 1922, si vede disegnato un quadrato nero contrassegnato dallo 0; alla sua sinistra gli si avvicina la serie decrescente ...4,3,2,1 proveniente dal simbolo matematico dell’infinito seguito dal segno del meno; alla sua destra, si allontana la serie crescen
te 1, 2, 3, 4...diretta verso il simbolo matematico deU’infìnito con il segno del più75. E1 Lissitskij spiega:
«Nel 1913 Malevic dipinse un quadrato nero. L’artista ebbe il coraggio di gettarsi allo sbaraglio. Fu creata così una forma che faceva a pugni con tutto ciò che veniva inteso come quadro, pit tura, arte. Lo stesso autore intendeva portare allo 0 le forme, la pittura. Noi dicevamo: sì, è lo 0 della serie decrescente, ma è an che l’inizio di una nuova serie ascendente. In altri termini, se è vero che esiste una serie che pane dall’infinito - ...6,5, 4,3,2, 1,0- una volta giunti allo 0 comincia però una linea ascenden te, 1,2, 3...: 6, 5, 4, 3,2, 1, 0, 1, 2, 3...Una nuova serie ascen dente, ma secondo un’altra concezione della pittura come tale. È stato detto che i secoli hanno portato la loro pittura fino al quadrato perché qui perisse; noi abbiamo obiettato: se la pietra del quadrato ha ostruito lo stretto canale della civiltà pittorica,
75 Una riproduzione fotografica dello schizzo di E1 Lissitskij si può trovare nel catalogo della mostra Kazimir Malevic e le sacre icone russe. Electa, Mila no 2000, p. 21.
97
il suo rovescio forma la possente pietra che fa da base alla nuo va costruzione volumetrica del mondo reale»76. Che cos’è il “rovescio” della “possente pietra” se non la
visione invisibile costruita una volta passati “al di là dello specchio”, nel buco-quadrato nero in cui tutta la materia viene dissolta in energia e tutti gli oggetti vengono risucchia ti scomparendo in un istantaneo processo di infinita implo sione? Malevic intuisce perfettamente che anche in questa
sorta di oltremondo, anche nel «vuoto del deserto» devono potersi dare leggi e misure “in linea ascendente”, finalmente -questo è il punto decisivo— non imposte da alcuna gram matica autoritativa, da nessuna sintassi pretesa naturale, bensì costruite dal soggetto operante che inventa e trasforma-trasfigura causa sui all’interno del grande Gioco del lin guaggio, un Gioco in cui il rischio può diventare mortale. Lo spazio visionario di Malevic viene edificato sulla spin ta automotivata impressa da un’energia seminale che si rap porta alla vita, alla radicale apertura dell’essere. Ma consen tire a questa spinta significa appunto anche scoprire che, come afferma Nietzsche nei frammenti postumi della Volon tà di potenza, «ogni arte matura ha alla sua base una moltitu dine di convenzioni: in quanto è linguaggio. La convenzione — la condizione della grande arte, non ne è l’ostacolo»77. Ed è così che, allo stesso modo e secondo la medesima esigenza, nell’assenza indicata da quel vuoto desertico nel quale Malevie —con la sua severa, iperbolica ricerca dell’assoluto, con la sua maestosa, ieratica purezza spiritualista- si fa avanti, può rivelarsi un incessante pullulare di possibili da inventare. Non è forse a causa della sparizione, dell’assenza di un cor po che si crede nel Cristo risorto? Non è forse proprio il vuoto del sepolcro all’intemo del quale non c’è niente da ve dere se non il vuoto stesso, ciò che inaugura, fonda e sostie-
76
El Lissitskij, Il Proun, trad. it. in V. Quilici, Larchtiettura del costruttivi
smo, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 99. 77 F. Nietzsche, La volontà di potenza, cit., p. 439.
98
ne il cammino storico della fede cristiana, mostrando così che quel niente è tutto (cfr. 1 Corinzi 15, 12-6)? Il cristiane simo non è forse la fede nel fatto che quel sepolcro sia vera mente vuoto? In ima lettera dell’estate del 1913 indirizzata all’amico Matiusin quando lavoravano insieme alla Vittoria sul sole, Malevic rivela tota caelo questa coscienza straordinariamen te lucida del dovere assoluto di costruire “secondo legge” anche nel vuoto del deserto: «Siamo giunti a rigettare la ragione, ma lo abbiamo fatto per ché un altro genere di ragione è cresciuto in noi, che a parago ne con ciò che abbiamo respinto può chiamarsi oltre-ragione (zaum’ny), che possiede anch’essa legge, costruzione e senso, e soltanto imparando questo potremo fare un lavoro basato sul la legge della nuova, veritiera oltre-ragione [...] sto comincian do a capire che in questa oltre-ragione vige anche una dura, se vera legge che fornisce alle immagini il loro diritto ad esistere. E neanche una linea deve essere tirata senza la coscienza di questa legge; soltanto così saremo vivi»7* (corsivo nostro).
«Neanche una linea...». Malevic, teso verso un più alto ordine del reale, pone con grande, “definitiva” forza etica l’esigenza della costruzione e del controllo, della possibilità che può emergere soltanto dal vincolo più stretto, fa dell’ar bitrio l’estrema norma, accetta la legge ma perché resa final mente propria, interiorizzata in coscienza trasformatrice che parla una lingua pura, redenta, pronta a diventare il nulla in risposta alla totalità diventata domanda. A i i
Ma è indubbio che il miglior commento del Quadrato
nero risale a cinque secoli prima, al 1453. In quell’anno Nic colò Cusano scrive il De visione dei (o De icona): un testo
78 Cfr. C. Douglas, Beyond Reason: Maleviè, Maltushin and Their Circles, di. p. 188. La traduzione dall’inglese è nostra.
99
vertiginoso, mirabilmente teso e intenso, che bisognerebbe leggere in dialogo con l’altro grande scritto cusaniano, il De possest, di sette anni dopo. È nell’esigenza genealogica che abbiamo richiamato all'inizio e in direzione di uno statuto critico-aporetico dell’immagine, che si inscrive un dialogo a distanza —ma di una distanza che rivela l’archiunità di pen siero e poesis— tra l’“arte filosofica” suprematista di Malevic e la speculazione teologico-negativa. Le circostanze che hanno originato il De icona riguarda no l’invio da parte del suo autore di una tavola che raffigu rava il volto del Cristo dalle caratteristiche percettive parti colari ai monaci benedettini del Tegernsee, ai quali lo scrit to è dedicato e che il Cusano spera di introdurre sperimen talmente, tramite questa sollecitazione esterna, nelle sacre oscurità della teologia mistica e della docta ignoranza. H volto di Cristo vi è dipinto in modo tale che il suo sguardo sembra seguire gli osservatori qualunque siano i loro movi menti. Il libellus iconae propone questa immagine ad esem pio sensibile dell’onnivedente ma mai veduto sguardo di Dio: Cusano ragiona dunque attorno all’impossibilità di concepire il Volto divino. Lo stesso Mosè, come noto, potè vedere iiywh solo «di spalle» (Esodo 33, 20-3). Nemmeno con il più raffinato esercizio dell’intelletto —che pure in sé comprende e supera le innumerevoli contrazioni della sfera
sensibile— potremmo mai concepire il Volto incontraibile, astratto da ogni contrazione, cioè liberato da ogni limitazio ne. Questo Volto dimora nell’oscurità, nella tenebra, nella
caligine. Le immagini della nube e della tenebra, dell’oscurità e della caligine caratterizzano molte delle teofanie dell’Antico Testamento. «Il Signore disse a Mosè: “Ecco io sto per veni re verso di te in una densa nube”» (Esodo 19, 9); HYWll «si avvolgeva di tenebre come di un velo» (Salmi 18,12). Abbia mo già visto che anche la luce taborica emanata dalla trasfi gurazione di Cristo davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo, sarà seguita dalla tenebra: «Venne una nube che fi copri con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio
100
mio, l’amato: ascoltatelo!» (Marco 9,7). Da queste immagini bibliche —metafore che esprimono appunto l’inconoscibilità divina— prende origine nella tradizione esegetica (prima in Filone di Alessandria poi, soprattutto, in Gregorio di Nissa) lo schema della lettura allegorizzante del problema costitui to dalla visione di Dio conseguente all’ascesa mistica. Esse quindi conducono alle tipiche, paradossali, deliberatamente autocontraddittorie formulazioni della teologia negativo-apofatica. I temi dello skotos e dello gnophos, delT’oscuro’ e della ‘tenebra’—diventati un locus classicas della speculazio ne patristica— arrivano al Cusano dall'elaborazione che ne ha sviluppato lo Pseudo Dionigi l’Areopagita, che insieme a
Agostino, Scoto Eriugena (che tradusse gli scritti dello Pseu do Dionigi) e Meister Eckhart, rappresenta l’autore che ha maggiormente influenzato il suo pensiero teologico. Sulla scorta di Filone e dei passi biblici, Gregorio di Nis sa aveva già parlato, nella Vita diMosè, della «tenebra lumi nosa» come unica possibile manifestazione teofanica dell’in conoscibile. Afferma lo Pseudo Dionigi nella Teologia misti ca che, mediante la preghiera, la speranza del cristiano è quella di raggiungere la «tenebra luminosissima, per vedere tramite la cecità e l’ignoranza, e per conoscere il principio superiore alla visione e alla conoscenza proprio perché non vediamo e non conosciamo; in questo consistono infatti la reale visione e la reale conoscenza»79. In questo brano è sin tetizzata l’essenza stessa della teologia apofatica —proceden te non per affermazioni ma per negazioni— e della sua luci dissima, “spietata” dialettica mistica: essa va còlta nell’espe rienza vivente, ma questa esperienza si confronta con ciò che non può cogliere. Dio è conosciuto unicamente nell’atto di
non poterlo conoscere. Dall’inconoscibilità-incomprensibil ità di Dio da parte dell’intelletto umano consegue l’identità
paradossale tra conoscenza e agnosia, Pinconoscenza’ che è odos, \ia' alla enosis, alPunione’ con il Supremo. Trascen
79 Pseudo Dionigi l’Areopagita, Gerarchia celeste. Teologia mistica. Lettere, di., p. 108.
101
dere il visibile e il conoscibile significa penetrare nella «tene bra luminosissima e veramente mistica dell’rzgwowa» e così addivenire alT'unione’ sovrarazionale80: non conoscere più
nulla significa conoscere al di là del semplice intelligere, poi ché l’essenza sfugge al metodo della logica deduttiva. Que sto motivo apofatico percorre tutta la Teologia mistica e le prime cinque Lettere che ne sono il commento. La tenebra che simboleggia l’impossibilità di vedere-conoscere non ri manda, però, a una pura e semplice privazione, Yagnosia non è sterile e inconcludente negatività. Significa invece esperire, sperimentare (tutti i mistici sono grandi, lucidissimi sperimentatori di sé stessi) la docta ignoranza, la profonda inalterabile consapevolezza dei limiti immanenti all’atto umano del conoscere, di cui il primo rappresentante nel mondo pagano fu ovviamente Socrate. Nelle tenebre in quanto Luce inaccessibile (epperò internamente illuminata e percorsa da bagliori come la Nube di Deuteronomio 4, 11) si trovano tutti coloro, scrive lo Pseudo Dionigi nella Lette
ra v, «che sono ritenuti degni di vedere e conoscere Dio: proprio perché non vedono e non conoscono, si trovano ve ramente al di sopra della visione e della conoscenza»81. Pe
80 Op. cit., p. 107. Bisogna ricordare, tuttavia, che nemmeno la visto beatifi ca potrà essere assoluta, potrà godere davvero direttamente della quintessen za divina, poiclié rimane pur sempre un modo dell’intelletto che coglie una teo-fania, cioè non la Gloria in sé ma una delle modalità attraverso le quali essa si concede all’apparire. É opportuno ricordare anche ciò che scrive JeanLuc Marion e die non ci sembra limitato al recupero più o meno filologica mente corretto di un’occorrenza lessicale: «Dionigi non usa nulla che si possa tradurre con ‘teologia negativa’. Se parla di ‘teologie negative’, al plurale, non le separa dalle ‘teologie affermative’ con le quali hanno i rapporti che qui [nel capitolo ut della Teologia mistica, ndr.J vengono sono descritti», in L'idolo e la distanza, cit., p. 192, nota 6. Vedi anche -in stretto dialogo con il libro di Ma rion e a proposito di Dionigi- intorno alla possibilità semantico-concettuale e alle stesse condizioni linguistiche di quella che si è dùamata una teologia ne gativa, J. Derrida, Come non parlare. Denegazioni, in Psyché. Invenzioni dell'altro, voi. 2 (1987-2003); trad. it. Jaca Book, Milano 2009. Per quanto ri guarda la complessità sia storica sia teologica deU'apofatismo, cfr. E. Jiingel, Dio mistero del mondo ( 1977); trad. it. Queriniana, Brescia 1982, pp. 297-390. 81 Op. cit.. p. 123.
102
netrare nella Tenebra è quindi il modus dell’apprensione mi stica, entrare nella Caligine è la modalità attraverso cui si manifesta a noi la Luce divina, ed è l’unico mezzo di cui di sponiamo per accedere —nella misura del possibile— al con tatto con una Presenza della quale -pur perpetuamente sottraentesi- godiamo una volta pervenuti alla enosis estatica,
all'«abbandono incondizionato assoluto e puro al raggio sovraessenziale della tenebra divina»42. Si tratta di una ricerca perpetua, incompiuta e incompibile; eppure fonte di beati tudine perché unica viva esperienza che ci sia concessa. Rimane che l’inaccessibilità e la conseguente invisibilità causate dalla divina Caligine procedono dall’eccesso sovraesponenziale di splendore, dalla voragine di luce eccezional mente diafana alla quale non si può accedere a causa dello straordinario bagliore che rende Dio atheatos, ‘incontempla bile’ tenebra perché posta al di là dell’opposizione tra luce e oscurità, fuse in un impensabile-impredicabile Uno plotiniano, oggetto paradossalmente inoggettivo della sublime agno sìa del soggetto mistico. Ed è proprio in virtù di questa sovraessenziale archiunità che dissolvendoli raccoglie in sé i contrari, che lo Pseudo Dionigi arriva alla ultimativa indiffe
renza di Luce e Oscurità, in cui ha termine anche la subida che lo aveva condotto fino a quell’estremo confine, a quel punto-limite. Il movimento immanente della dialettica apofatica porta a negare la negazione stessa, e Dio, dopo essersi posto oltre ogni luce, trascende anche l’opposizione tra Luce e Oscurità. La Luce inaccessibile è Caligine divina e la
Tenebra è il modus dell’apprensione mistica. Il De visione dei cusaniano riprende (talora letteralmen te) e sviluppa con mirabile nitidezza questa tradizione esegetico-speculativa che procede più per immagini che per concetti. Scrive dunque Cusano che per concepire il Volto divino:
42
Op. dt., p. 106.
103
«bisognerebbe andare oltre le forme di tutti i volti formabili, oltre tutte le figure [...] in tutti i volti appare il volto dei volti in modo velato ed enigmatico. Esso non si rivela finché non penetriamo, al di sopra di tutti i volti, in un segreto e occulto silenzio [...] questa è la caligine e la nebbia, la tenebra [...] e questa caligine rivela che qui si trova il volto al di sopra di tut ti i veli [...] ma poiché cerca di vedere la luce che non può ve dere, il nostro occhio sa che, fintanto che vede qualcosa, que sto non è ciò che cerca: deve, dunque, trascendere tutta la luce visibile. Chi deve trascendere ogni luce, deve sapere che ciò in cui penetra è privo di luce visibile [...] quanto più l’occhio sa che la caligine è grande, con tanta maggiore verità coglie nella caligine la luce invisibile [...] perciò esperisco che è necessario che entri nella caligine e ammetta la coincidenza degli opposti oltre ogni capacità della ragione, e cerchi la verità ove mi im batto nella impossibilità, oltre la ragione [...] e quanto più oscura e impossibile è riconosciuta una tale impossibilità tene brosa, con tanta maggiore verità la sua necessità risplende. Perciò, Dio mio, ti ringrazio per avermi rivelato che non c’è al tra via per accedere a te fuorché quella che è sembrata comple tamente inaccessibile e impossibile [...] perché hai mostrato che puoi essere visto solo dove l’impossibilità sopraggiunge e d viene incontro»8*. Fin qui Cusano. È evidente e straordinaria 1’“ affinità elet
tiva" con Malevic. E certamente con Vittoria sul sole e il suo «Salve tenebra!». Se il volto di Dio è invisibile perché non è un oggetto, allora quando nulla vedo sono ad esso più pros simo. La verità è tale, è autenticamente verità, già lo sappia mo, solo se non teme la propria negazione, se assume il pro prio contrario, solo se contiene già in sé il limite che la può abolire, solo se in re è già “relativa”. Proprio il velo enigma tico del Quadrato nero è lo stato estetico della Luce che evo
ca l’impossibile e l’inaccessibile, è la rivelazione iconica del la quinta essenza, ri-velazione che appare, insieme, il movi mento di togliere e di aggiungere il velo, movimento in cui
N. Cusano, La visione di Dio, in Opere filosòfiche, LTET, Torino 1972, pp. 554-5 e 562.
104
permane l’arcano che consiste nel donare visibilità all’invisi bile. Rivelazione, dunque, che permane carica di mistero. Lo sappiamo: «Tutto ciò che è manifestato è luce», scrive Paolo agli Efesini (5, 14). Ma il Quadrato nero è luce implo sa perché richiamata alla propria fonte, ricondotta alla pro pria origine: origine di inaudita, insopportabile concentra zione dove la massa immane degli oggetti è risucchiata nel buco-quadrato nero di pura energia. La luce “esplosa” non soltanto “mette alla luce”, mette a giorno gli oggetti, li porta aH’apparire, ma così facendo ne sovrintende la distinzione, la separazione, la parcellizzazione che ne permette l’analisi. È l’apriori del loro utilizzo più o meno proprietario, del loro
consumo. La luce non è un fenomeno tra gli altri; è piutto sto ciò che rivela i fenomeni, è Parchi-immagine perfetta del la pura gratuità. Tuttavia, non può dirsi un semplice, preli minare medium, un mero veicolo; può considerarsi, invece e prima di ogni altra cosa, informazione allo stato puro, mes saggio senza contenuto, pura medialità, esser-mezzo del mezzo. Dio, secondo Agostino, è lumen de lumine, luce in creata e originaria, spontaneità sorgiva, protocreativa, pro toproduttiva. Ma ove la luce rimanesse a questo stato archetìpale, se l'En Sof —l’infinito divino della mistica ebraica— cioè il nulla senza luce non propagasse luce, se permanesse in se ipse, ‘in sé stessa’, rinserrata nel mistero della propria insondabile fonte, allora la sua vista non sarebbe sostenibile perché nella sua potenza inarginabile annichilirebbe, in ghiottirebbe ogni possibilità di visione, e nessun oggetto po trebbe distinguersi-percepirsi-enumerarsi. Perché qualcow si manifesti, perché possiamo vedere-apprendere oggetti, immagini, figure, è necessario che quella Luce si affiochi, si indebolisca, incorpori la propria ombra, l’ombra che le è fin da sempre intrinseca, immanente84. Luce nascosta che na sconde: «Le immagini sono manifestate all’uomo e la luce che è in esse è nascosta nell’immagine della luce del Padre», recita il logion 83 del Vangelo secondo Tommaso, uno dei più
84
Cfr. M. Cacàari, Generare Dio, il Mulino, Bologna 2017, pp. 33-40.
105
importanti scritti gnostici copti. E prosegue: «Egli si rive lerà, e la sua immagine è nascosta dalla sua luce»85. Il Qua dralo nero è la cusaniana “impossibile-inaccessibile" icona della Luce che si identifica loto cacio con la propria Ombra, l’Ombra assoluta dalla quale non può riemergere alcun og getto: «Sei dunque, Dio mio, così ombra da essere verità»86. Pura medialità “prima” (se la dimensione temporale valesse qui qualcosa) che essa illumini e riveli gli oggetti, “prima” di affiochirsi in medium. «Il cuore della luce è nero», diceva Bachelard. H Quadrato nero è questo cuore e non altro. Po tremmo anche dire: come lo splendore pneumatico del lo gos- Verbo si fa ancora più rilucente proprio nella sua kenosis, nel suo più profondo svuotamento, fino all’opacità del sensibile umano, così il Quadrato nero esprime l’apice del lu minoso, che non può che apparire altro che come luce im plosa, che (si) trattiene (in) sé stessa. E se vedere è vedere qualcosa che è per definizione già-là e rispetto al quale la mia visione non può che essere derivata, se nel Quadrato nero non si esprime questa o quella fenomenologia della luce ma la catastrofe ontologica cui è destinata, allora è del tutto evidente che in quel cuore nessun oggetto può ancora venire ricordato, nessuna figura può ancora designare alcun ché. Certo il Quadrato nero stabilisce i nuovi rapporti che si producono da quella ri-velazione, ma essi non sono imme diatamente visibili-concepibili: «nella nebbia dei nuovi rap porti», scrive di nuovo “cusanianamente” Malevic, «svani scono vista e intelletto»87. Soltanto l’oblìo in cui ogni figura,
ogni oggetto deve cadere, attesta che l’inoggettività è appun to il Nulla che (è all’)opera e che trascende tutta la luce visi bile. Ecco allora che andare al di là della rappresentazione oggettiva significa aprire uno spazio puro, significa cercare di accordarsi alla dynamis che innerva il Tutto, aderire per
85 Insostituibile su questo motivo gnostico e sull’analisi del Vangelo di Tom maso, è la raccolta degli studi di Henri-Charles Puech, Sulle tracce della Gno si (1959, 1978); trad. it. Adelphi, Milano 1985. 86 N. Cusano, La visione di Dio, cit., p. 577. 87 K. Malevic, Suprematismo, cit., p. 87.
106
quanto possibile intimamente, “eroticamente” alla insedabi le energia di ciò che Cusano chiama il possest come inscindi bile unità e co-incidenza in Dio di atto e potenza: «potere-è, cioè che lo stesso potere è. E poiché ciò che è, è in atto, po tere-essere è lo stesso che potere-essere-in-atto [...] è l’atto di ogni potenza»4*. Soltanto in Dio ogni poter essere è in atto, e a quest’altezza solo l’ascesi —e la sua iconologia anico nica— può condurre: ascesi dagli oggetti, dai volti “contrat ti", dalle forme formabili, soltanto superando e “dimenti cando” ogni contrazione fenomenica, ogni limitazione sensi bile si potrà arrivare aìl’osvoboz’dennoie nicto, al ‘nulla libe rato’, ‘riconquistato’. Non di altro si tratta se non della abla
tio terminatorum, della liquidazione di ogni confine, cioè della «via che cancella ogni cosa che sia delimitata» di cui parla il Cusano nel De quaerendo deunr. ma che si trova «dentro di te»89, nel fondo senza fondo dell’anima. ★ ★ ★
L’altro motivo che avvicina la speculazione iconico-teolo gica cusaniana alla poetica suprematista di Malevic fino a
costituirne quasi un “commento anticipato", è quello del volto. Che qui dobbiamo intrecciare ai motivi dello sguardo e dello specchio in una sorta di triangolazione interpretativa. Il volto è nell’icona il luogo epifanico in cui si rivela il nesso con l’invisibile che trasfigura lo sguardo spiritualizzandone la fisicità, e gli occhi dei santi, ai quali non a caso gli icono grafi riservano una cura particolare, sono la manifestazione fenomenica del noumeno, il riflesso riconoscibile dell’imma gine di Dio. L’icona su tavola del volto di Cristo che Cusano ha donato ai monaci, e il cui sguardo segue in tutti i suoi mo vimenti chi lo contempla, è la metafora contratta, Vexem-
88 N. Cusano, Il possest, in Seriffi filosofia, voi 1, a cura di G. Santinello, Za nichelli, Bologna 1965, p. 251. 89 N. Cusano, La ricerca di Dio, cit., p. 52. «La nastra luce è dentro», canta no di budetl'farse della Vittoria sul solei
107
plum “umbratile”, del luminosissimo divino Volto incontrai bile che contempla e com-prende in sé tutti i volti umani: Dio guarda simultaneamente tutti e ognuno come lo sguar do di Cristo del dipinto. Bisognerà intanto ricordare che l’occhio divino dell’archetipo iconografico, l’occhio onnivedente, viene “trascritto” già nel Ritratto perfezionato di Ivan
Kljun del 1913, dove esso è spezzato in due parti riaccostate in modo asimmetrico e sfalsato come se l’occhio fosse impe gnato in una visione multipla. Se vogliamo, però, intendere bene questo passaggio in tutte le sue implicazioni, dobbia mo fare una diversione. Ma solo apparente. Il prototipo acheropìta della Veronica -il Sacro Volto di Gesù, “concorrente” del mandylion bizantino— era conser vato in un’edicola con altare posta davanti all’oratorio della Vergine all’inizio dell’ultima navatella destra della Basilica Vaticana. Veniva mostrato ai pellegrini per l’occasione giun ti a Roma da una postazione probabilmente così lontana che essi riuscivano a scorgere soltanto il riflesso abbagliante dei cristalli, dell’oro e delle pietre preziose che incorniciavano l’icona90. Questa cerimonia liturgica di ostensione pubblica della sacra imago, che lascia impercepito e fuori portata l’og
getto stesso che ne costituisce la ragione, e che dunque, in vece di placare, ravviva il desiderio di visibilità e la pulsione scopica proprio al cospetto della vera icona, viene utilizzata
da Dante come termine di comparazione al momento in cui il poeta è introdotto da San Bernardo alla visione dello splen dore della gloria celeste di Maria: «Qual è colui che forse di Croazia/viene a vedere la Veronica nostra/che per l’antica fame non sen sazia/ma dice nel pensier, fin che si mostra ^Si gnor mio Gesù Cristo, Dio verace/or fu sì fatta la sembianza vostra?» (Paradiso xxxi, 103-8). L’aspetto riconoscibile, l’e
90 Impossibile qui rendere conto della copiosissima letteratura sulle imma gini acheropite. Ci limitiamo a segnalare H. Belting, Il culto delle immagini. Storia dell'icona dall'età imperiale al tardo Medioevo (1990); trad. ir. Carocci, Roma 2001, in particolare pp. 71-104 e 255-77, e G. Didi-Huberman, La so miglianza per contatto. Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta (2008); trad. ir. Bollati Boringhieri, Torino 2009, in particolare pp. 66-86.
108
videnza mimetica, il tratteggiarsi fìgurale-associativo dell’ico na miracolosa (cioè, come già sappiamo, il charakter della car ne divina nell’accezione greca di 'impronta’, ‘indice’, ‘trac cia’ impressa per contatto diretto, nel caso dell’acheropìta, sulla superfìcie, e non segno convenzionale che rinvia a un assente) sembrano ritrarsi (di nuovo compare questo moti vo) nel momento stesso in cui si espongono alla massima vi sibilità del rituale pubblico, lasciando così inappagato il de siderio del fedele. Come interpretare questa contraddizione, questo paradosso? In realtà, {’«antica fame» deve rimanere insaziata e insaziabile per lasciare spazio a quello che nella speculazione teologica sull’icona (nel Cusano ciò risulta as
solutamente evidente) è chiamato a essere il vero, autentico joggefto dell’immagine, cioè proprio chi contempla, l’osser vatore, il fedele che -in operosa attesa della tbeasis, della vi sione intuitiva “faccia a faccia”— ha come preciso compito cristiano nella vita terrena (abbiamo già diffusamente analiz zato questo punto) quello di impegnare tutte le sue forze aiutato e indotto dalla visione dell’icona- ndl'imitatio Chri sti. L’impegno dunque è quello di vedere sulla superfìcie del Santo Volto null’altro che il proprio volto riflesso come in uno specchio, perché tramite Cristo il fedele viene trasfor mato in un’immagine sempre più perfetta di Dio: il deside rio dell’unione completa rimane sì insaziato e inappagato, la distanza, la lontananza restano sì i fattori dirimenti, ma pre cisamente in virtù di questa tensione spirituale dinamica e asintotica, il fedele contemplante viene spronato, stimolato a
meritare di corrispondere per quanto possibile, in una sorta di paradossale contatto a distanza, a quell’immagine “non fatta da mano d’uomo". Ecco perché Cusano scrive che Dio è «occhio e specchio vivente», uno specchio da contemplare «nell’icona, nell’enigma»91. Spesso Malevic, lo abbiamo già visto, parla del suo Qwadrato nero come di un volto-, «sono felice che il volto del mio Quadrato non possa confondersi con nessun artista e nessu
91
N. Cusano, La vistone di Dio, di., pp. 560 e 550.
109
na epoca»92*95 . Lo spettatore del Quadrato nero è coinvolto in una sorta di scenodramma ispettivo. L’atto del vedere, non trovando sulla superfìcie alcun oggetto determinato o punto d’attacco cui riferirsi, è come se si specchiasse (Lo specchio suprematista è il titolo di un enigmatico testo di Malevic) ri tornando su sé stesso. «Ogni volto che può intuire il tuo vol to non vede niente d’altro o di diverso da sé, perché vede la sua verità», scrive Cusano nel De iconiP\ Se Dio ci ha desti nati a essere «conformi all’immagine del Figlio suo» CRowmni 8,29), scrive Paolo, allora noi tutti «a viso scoperto, riflet tendo come in imo specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2 Corfwzz 3,18). L’Invisibile appare nella visibilità stessa, come il nulla-da-vedere del Quadrato nero si rivela alla vista: «Che cos’è il mon do», si afferma nel Possest, « se non l’apparizione del Dio in visibile? E che cos’è Dio se non l’invisibilità delle cose visi bili?»91. Come se in quel bagliore oscuro, in quella gloria nera, in quella tenebra che ha risucchiato tutta la luce, in quello che abbiamo chiamato il dramma del visibile, la con dizione di ogni possibile sguardo, di per sé inesperibile per ché presupposto dell’esperire, si offrisse eccezionalmente, essa stessa, all’esperienza. Un’esperienza dello sguardo che in quel fissarsi sul nulla, in quel vedere che sembra eccedere
la propria misura, si libera dalla disperazione del rinvio in terminabile e sfibrante da un segno all’altro, da un oggetto all’altro. Ma tutto ciò è un traguardo, non un dato; è un pun-
92 K. Malevic, Scritti, cit., p. 165. La frase si trova nella citata lettera a Benois. Se teniamo presente la ieratica frontalità del Quadrato nero e il fatto che il suo autore, come già abbiamo ricordato, lo chiamava il suo “infante regale", non può essere senza interesse sottolineare che Florenskij, nelle sue riflessio ni sul volto nelle icone, assieme agli Dei e ai santi, ai Giusti e ai Saggi, mette va anche «gli Infanti» tra gli oggetti autenticamente degni della rappresenta zione frontale, l'unica che manifesti in loto il senso sacrale dell’immagine, cfr. Lo spazio e il tempo nell’arte, cit., p. 106 sgg. 95 N. Cusano, La visione di Dio, cit., p. 553. 91 N. Cusano, Ilpossest, cit., p. 509. Abbiamo già visto questo motivo apofatico evocato daU’Eriugena.
110
to di tensione, non un presupposto. «Fuori della dimensio ne viveva il Volto», scrive Chlebnikov in una sua poesia95. Proprio questa, infatti, è la funzione “propedeutica”, pro prio questo è l’elemento asintotico, protrettico (e gnostico) “liberato” dal volto-specchio dell'icona del Quadrato nero: lo spettatore deve adeguarsi a quella “tenebra luminosa”, deve corrispondere al nulla che esso rivela-manifesta e rico noscervi il suo vero volto (il suo vero sé), che è al di là di ogni latitudine puramente terrena-terrestre. Ma il primo a dover si riconoscere è naturalmente lo stesso Malevic. Che nel 1913 scrive: «Io cerco Dio, mi cerco in me stesso. Dio onni veggente onnisciente onnipotente [...] Io cerco Dio, cerco il
mio volto, ne ho già tracciato il profilo e sto lottando per in
carnare me stesso»95 96. ***
Nei suoi scritti dal carattere più speculativo, Malevic fa continuamente riferimento al dato dell’emozione. Che, tut tavia, non è per l’appunto affatto un “dato” ma, per così dire, una pre-datità assoluta e inderogabile. Il reale raggiun ge la sua verità ultima soltanto nell’emozione: che non ha né scopo né senso, né tempo né spazio, non ha coscienza né nu mero, è illimitata e inafferrabile. Solo l’arte inoggettiva del
Suprematismo può in qualche modo, dandole un corpo, in tuire ed esprimere -ma non, a rigore, “rappresentare", come fosse un dato esterno— la sua potenza originaria, poiché già l’emozione stessa è metallo allo stato fluido, pre-oggettivo, pre-rappresentativo. Ma tutto ciò possiamo meglio com prenderlo soltanto se ricordiamo il modo in cui Malevic de finisce il Suprematismo: sensazione pura, sensibilità pura. Che cosa significa precisamente? Significa forse sensazione
95 V. Chlebnikov, Poesie, eie, p. 11. 96 Cfr. K.S. Malevich. The Artist, Infinity, Suprematism. Unpublished Writ ings 191.Ì-33, a cura di T. Andersen, Borgens Forlag, Copenhagen 1978, pp. 29 e 12. La traduzione dall’inglese è nostra. Un’altra traduzione del brano si trova in A.B. Nakov, Uh nuovo Laooconte, cit., p. 14.
Ili
di niente, di nessun ente definito o configurato oggettualmente? Sensazione priva per l’appunto di quel substratum, di quell 'objectum, di quel referente esterno del quale risulte
rebbe la sensazione? La possibilità che si produca una situazione sensoria di questo particolare genere è a tutti gli effetti e senza appello esclusa da Aristotele in un passo della Metafisica-. «Invero la sensazione non è affatto sensazione di sé stessa, ma esiste an che qualcosa di diverso al di fuori della sensazione stessa, ed
è indispensabile presupporre resistenza di questo qualcosa come anteriore alla sensazione, giacché ciò che muove è, per natura, anteriore a ciò che è mosso» (1010b). Noi possiamo
percepire unicamente il referente esterno del nostro atto percettivo, non possiamo percepire il mezzo tramite il quale quell’atto si produce: io non vedo la vista, vedo il tavolo; io non tocco il tatto, tocco il legno. Consegnandomi in imma gine l’oggetto, la visione, che è sempre visione di qualcosa, cela a sé stessa il proprio operare: la percezione induce la co scienza a farsi assumere come mera passività di fronte al per cepito, percezione impercepita in quanto tale. Secondo que sto cono prospettico, la percezione senza oggetti di cui par la Malevic è un’ossimorica sfida alle leggi della logica che soltanto un artista poteva lanciare. È precisamente e soltan to quello che Aristotele chiama il to on -dò che c’è, che esi ste—, è l’esistenza empirico-fattuale dell’oggetto sul quale si esercita (che, per l’appunto, cade sotto i nostri sensi) a legit timare, a istituire qualcosa come la sensazione in quanto tale. E quindi, proprio per questo, a segnalare e sanzionare l’inammissibilità logica di una sensibilità a carattere autore ferenziale e l’impossibilità ontologica di un sensorium che in un moto di pura autoaffezione avrebbe a oggetto sé stesso. Perché questo tipo di particolare, “anomala” sensibilità po tesse attivarsi, potesse prendere vita, occorrerebbe oltrepas sare il tempo e Io spazio, che sono però le condizioni a prio ri (le forme della sensibilità) che permettono ai nostri sensi di poter percepire ed esibire (e certo anche pensare) un og getto percepito ed esibito (e pensato) nello spazio e nel tem
112
po. Occorrerebbe paradossalmente “sentire" i propri sensi, avere sensazione dei sensi stessi: cioè una sensazione o un’e mozione assolutamente pure, letteralmente sciolte da ogni referente, per l’appunto inoggettive. Di analoga, impossibile torsione autoreferenziale scrive Cusano nel De possest: «Dio non può essere concepito; a meno che non si riesca a conce pire in atto la stessa concepibilità»97: a meno che non si rie sca, cioè, a concepire in atto la potenza stessa (è in termini si mili, si ricorderà, che abbiamo cercato di interpretare la vi sione gloriosa dei discepoli sul monte Tabor). Qualunque tipo di intenzionalità —che è strutturalmente e non inciden talmente connessa a un principio di volontà— resta impiglia
ta (lo abbiamo già precisato) nella relazione a un oggetto, e per estensione a un’immagine associativa, analogica, mime tica. In Malevic, si potrebbe dire, non vi è intentio ma inten sion accrescimento esponenziale di intensità della sensazione pura, dell’emozione pura, che si libera in maniera del tutto indipendente da situazioni, schemi e protocolli categorizzabili come teleonomici, finalistici. Nell’opera dipinta e nell’opera scritta di Malevic, l’arte moderno-contemporanea raggiunge l’apice, il vertice della kantiana assenza di scopi del suo fare, si dirige verso l’inuti lizzabile più puro. Quella evocata, anzi esplicitamente lan ciata dall’artista alla ricerca della necessaria costruibilità del “mondo senza oggetti”, è appunto una sfida consapevole e programmatica all’impossibilità di una sensazione pura, di una percezione senza oggetto, di un’emozione senza refe
rente. Giacché bisogna arrivare al luogo, scrive Cusano nel De icona, «ove l’impossibilità coincide con la necessità»98. Per un artista l’impossibile non è mai un freno, non rappre
senta mai un limite aprioristicamente insuperabile, ma un elemento di confronto, di sfida, di dialogo operativo, non di “soluzione”. Proprio dei possibili (possibili opere, possibili pensieri) ai quali, per così dire, quella costitutiva impossibi
97 98
N. Cusano, Ilpossest, cit., p. 211. N. Cusano, La vistone di Dio, cit., p. 563.
113
lità dà luogo, è profondamente, drammaticamente segnata l’intera esperienza artistico-filosofìca di Malevic. Un’espe rienza aporetica, o meglio un’esperienza dell’aporia —in Ari stotele l’aporema è il sillogismo che conduce a due proposi zioni contraddittorie ma di uguale valore- cioè un’esperien za della mancanza di un passaggio, dell’assenza di un odos, di una strada, di un percorso. Un’esperienza che è diffìcile non avvertire misteriosamente, sotterraneamente evocata nello straordinario, enigmatico primo frammento degli Ora coli caldaici'.
«C’è un intuibile che devi cogliere con il fiore delTintuire, per ché se inclini verso di esso il tuo intuire, e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai: E il pote re di una forza irradiante, che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza, quell’intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misu ra, fuorché quell’intuibile, e non devi intuirlo con intensità ma —recando il puro sguardo della tua anima distolto— tendere verso l’intuibile, per intenderlo, un vuoto intuire, ché al di fuo ri dell’intuire esso dimora»99. Intuire come un intuibile l’atto medesimo dell’intuizione, dunque come dismisura che irradia e abbaglia e prorompe nel misurare, intuirlo come pienezza del nulla riconquistato, come vuoto che si dà in uno con la presenza. L’“oggetto" di Malevic è un non-oggetto senza contorni, astratto, in(de)fìni-
to e indeterminato: aperigraphè. In un mondo in cui, come scrive benjaminianamente Malevic, «la rovina è diventata una condizione normale»100101 , costruire è certo necessario: ma costruire, finalmente, per nulla. Di nuovo, davvero in Malevie raggiunge il suo vertice l’arte propriamente intesa come techne che si volge verso l’inutilizzabile, verso Vinoperositàmi. In fondo la sua sfida suprematista era già in campo
99 Oracoli caldaici, a cura di A. Tonelli, Coliseum, Milano 1990, p. 25. 100 K. Maleviò, Suprematismo. Il mondo della non-oggettiuità, eh., p. 147. 101 Sul motivo dell'inoperosità nelle arti moderno-contemporanee riman -
114
nell’esperienza orientale: «Come posso vedere la natura del Buddha?», domanda il monaco. «Stolto, non sai forse che il vedere stesso è la natura del Buddha?». Abissalmente sem
plice, perché è in questa semplicità che si celano abissi.
Cubo tutto luce bianco assoluto facce senza tracce nessun ricordo
Samuel Beckett, Senza
Il superamento definitivo del colore naturale-creaturale conduce verso la luce originaria del Quadrato bianco. Nulla
da “vedere”. Surrexit autem Saulus de terra apertisque oculis nihil vedebat, ‘Paolo si alzò da terra e, con gli occhi aperti, vide il nulla’. E la traduzione di Meister Eckhart del passo degli Atti degli apostoli (9,8). Disegnare uno spazio bianco in cui non sia raffigurato assolutamente nulla era per Dee no Taiga, il pittore giapponese del periodo Edo, la cosa più dif
fìcile e l’obbiettivo da raggiungere nell’arte della pittura. Si sbagliano quei pittori, dice ripetutamente Malevic, che cre dono che i nostri occhi possano davvero vedere (rammentia mo il Cusano: finché il nostro occhio vede qualcosa, signifi ca che questo qualcosa non è ciò che cerca). Vera, Ubera, rea lissima percezione (altro che “astrattismo”!) si dà, si offre
soltanto laddove non vi è alcun oggetto da percepire né vo lontà-intenzionalità di percepire alcunché. Siamo di nuovo agU antipodi di ogni fenomenologia della coscienza leti co-posizionale, ma forse vicini agh attributi che Kant nella Prefazione alla Critica della ragion pratica assegnava alla hbertà: necessaria e nello stesso tempo incomprensibile. Nel
1919, alla Decima Mostra di Stato allestita a Mosca e intito lata “Creazione non oggettiva e Suprematismo”, Malevic presenta una serie di dipinti bianco su bianco, apparente mente monocromi. «L’azzurro del cielo è stato vinto dal si-
diamo al ns. Il genio è senza opera. Filosofie antiche e arti contemporanee. Jaca Book, Milano 2017.
115
sterna suprematista», scrive con gli accenti di quel millenari smo cosmico che caratterizza tutto il suo enorme lascito let terario, «si è lacerato ed è penetrato nel bianco come auten tica e reale rappresentazione dell’infinito, e con ciò si è libe rato dal fondo colorato del cielo [...] Ho lacerato abat-jour azzurro delle limitazioni del colore e sono uscito nel bianco; dietro di me, compagni aviatori, navigate nell’abisso [...] ho vinto l’involucro colorato del cielo [...] Navigate! Il bianco abisso libero, l’infinito sono davanti a noi»102* . Bisogna libe rarsi e librarsi in ciò che non ha punti di appoggio, nell’djrsenza dìfondamenta in cui siamo destinati a vivere. La pittu ra giunge così al virtuale bianco, allo stato bianco, come dice ripetutamente lo stesso Malevic. La forma non allusiva, non associativa, conquista la sua definizione estrema e più radi cale nell'identità di luce e colore, e si afferma in quanto vera
e propria dissolvenza al tempo stesso pittorico-percettiva e filosofica nel nulla assoluto come ultima verità-realtà: «Nel palazzo del nulla risiede il tutto», scrive un cabalista spagno lo del xvi secolo. Lo abbiamo già visto: non si può, nulla disegnando-dipingendo, evocare il nulla. Questo sì sarebbe autentico nichilismo: non pensare il Nulla come problema, passare accanto al Nulla come fosse cosa da nulla. Malevic si trova all’opposto: opponendo il colore a sé stesso in un pro cesso di radicale acromatizzazione, costruisce il piano-super fìcie in cui tutta la materia, tutti gli oggetti vengono come
102 K.S. Malevic, Il Suprematismo, in Scritti, cit. pp. 192-5. Un analogo ane lito messianico-apocalittico verso la “fuoriuscita' nel Bianco lo troviamo in Ornamento e delitto di Loos: «Presto le vie delle città risplenderanno come bianche muraglie' Come Sion, la città santa, la capitale del cielo. Allora sarà il compimento», in A. Loos, Parole nel vuoto, trad. it. Adelphi, Milano 1980, p. 219. Non può non venire alla mente, però, anche {’aforisma 575 con cui Nietz sche chiude liricamente Aurora, dal titolo Noi, aerei naviganti dello spirito. «E dove dunque vogliamo arrivare? Al di là dei mare? Dove ci trascina questa possente avidità, che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella direzione, laggiù dove sono fino a oggi tramontati tutti i soli dell'uma nità? Un giorno si dirà forse di noi che, volgendo la prua a occidente, anche noi speravamo di raggiungere un’india, ma che fu il nostro destino naufragare nell’infinito? Oppure, fratelli miei? Oppure?».
116
aspirati in una inaudita e inudibile implosione. Il bianco dice origine, fonte, potenzialità iniziale. La totalità dei colo ri dello spettro solare si cancella inghiottita nel bianco. Il mi niaturista islamico lascia, al posto dell’infìgurabile viso del profeta, uno spazio vuoto simboleggiato da una macchia bianca. Nel bianco è certamente nascosto un arcano, ma Varcano è appunto che tutti i colori continuano a vivere vir tualmente e in stato latente “dentro" la sua visibile parvenza fenomenica. U bianco di Malevic non ha nulla del carattere
spettrale e della qualità “stregata” che talvolta accompagna no questo colore105 nella percezione storico-culturale con i suoi rimandi simbolici, non si acquatta nella sua fenomeno logia alcun genio maligno, quello che ad esempio Melville vedeva affiorare nella Balena10*. Bisogna pensare piuttosto al bianco che si identifica con la luce, la cui proprietà è di dif fondersi e solcare lo spazio: il colore puro e abbagliante del la veste degli angeli e dei santi raffigurati nelle icone (esem pio straordinario, gli affreschi di San Salvatore in Chora a Istanbul), dei monaci del deserto e delle guardie imperiali bizantine, il colore della teofania e della grazia, della purez za che si afferma, come dice lo stesso Malevic, «senza incon trare limiti»10’. In fondo il suo Bianco, questo alfa privativo, radicalizza fino all’estremo quella figura dell’intervallo e dell’interruzione che nel Moderno e nelle avanguardie frat tura e buca il corpo del linguaggio: gli spazi bianchi della pa gina di Mallarmé, le zone non dipinte di Cézanne, i silenzi di Webem portati ai limiti dell'udibilità. In totale assenza di peso, il quadrato bianco bascula asim metrico non “sul” fondo ma nel fondo bianco. Vi è una mi rabile, stupefacente forza trascendentale e contemplativa in
105 Del tutto improprio è chiamare il bianco “non colore* (lo fa sovente lo stesso Malevii) dal momento che incontrovertibilmente tutto è colore; cfr. il ns. Arte e colore. Vn’intraduzione, in AA.W, Il colore nell'arte, Jaca Book, Milano 2006. 104 Cfr. A. Boario, Di tutti i colon, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 2Ì-3. 10’ K. Malevic, Introduzione all’album di litografie ‘Suprematiimo - 34 diìegni”, in Scritti, cit., p. 197.
117
questo equilibrio meditante che non è più tra Bianco e Nero, belji e cèrnji, ma tra Bianco e Nulla, che nel ritmo del loro darsi-donarsi reciproco si bilanciano perfettamente indeter minandosi a vicenda. Soltanto un’impercettibile, lieve infles sione, una piega bianca nel bianco fa la differenza («nicchia visibile per differenza di bianco», scrive Beckett in Ring). Soltanto un solco di nulla, un’increspatura neutra (le onde gravitazionali non sono forse increspature dell’universo?) ne distingue la forma oltre tutte le forme visibili. Nel senso for
te e letterale dell’espressione: niente da vedere. Lo stesso niente-da-vedere che —come abbiamo già evocato— dà origi ne alla fede in Cristo risorto, poiché se qualcosa si fosse pre sentato alla vista nel sepolcro, il cristianesimo non sarebbe esistito. La luce del Quadrato bianco rammenta la luce taborica che si propaga nell’assenza di ogni contrapposizione cromatica che permetterebbe l’identificazione della forma, e nella quale già abbiamo visto l’estrema, liminare possibilità di circoscrivere l’incircoscrivibile. La luce taborica potrebbe dirsi caligo massimamente, supremamente trasparente: Gesù il Cristo appare come luce diafana nella gloria della luce dia fana “come” il quadrato bianco appare nel bianco. Certo esso —e non potrebbe essere altrimenti— è un’estensione sen sibilmente intuibile di materia compatta e ultraconcentrata, che è però in via di trasformarsi in pura energia che naviga
nello spazio astrale: sospesa e illocalizzabile tra il movimen to e la quiete come Yexaìphnes del Parmenide platonico, come Yenergheia akinesias di Aristotele, l'attività consisten te nell’immobilità {Etica nicontachea, 1154b, 27). Nella tec nica del movimento alla base della danza nel teatro nò, l’at tore è perfettamente immobile, danza senza danzare. Sullo
sfondo di questa attività non agente (il wei wu wei del taoi smo), il più impercettibile movimento del corpo -l’incre spatura bianca nel bianco— acquista una potenza letteral mente inaudita, una forza insorpassabile. La vita e l'infinito, per il Malevic “cusaniano" stanno non nella scelta tra i pos sibili, ma nella scelta per il Possibile, un Possibile accennato (come il dio che sta a Delfi) da un’astensione, da una dile
118
guante traccia di neutro. Il Quadrato bianco conduce la ridu zione dei mezzi, del linguaggio e delle apparenze pittori co-percettive ai limiti di un dire che nulla dice, di una volon tà che nulla vuole. E una pura istanza di discorso, che in quanto tale nulla proferisce ma che apre al tutto proferibile; è il puro Possibile esibito in un ictus di 78,7 centimetri per ogni lato106. Sotto questa prospettiva, il Quadrato bianco — che rappresenta l’inizio, diceva Malevic, «di una nuova for ma classica»107— è come se risalisse al punctum caecum della vista. «Perché possa cogliere liberamente il colore, il centro della vista è privo di colore», afferma il Cristiano in dialogo con il Gentile nel De deo abscondito, dunque, prosegue Cu
sano, «la vista è nulla piuttosto che qualcosa»108. Così che «non cogliendo nulla di colorato, tutto il mondo del colore ignora la vista [...] anzi non è neppure in grado di cogliere che essa sia qualcosa, poiché, non afferrando altro che il co lore, ritiene che tutto il non-colorato non esista affatto»109. Mentre in realtà la vista non contratta da alcun colore si ri vela la condizione di possibilità perché ogni ente colorato ex-sista, si offra effettivamente alla percezione. È esattamen
te in questo senso che in un testo (sorta di “poesia in prosa”) databile agli anni 1918-19 —quelli appunto della scoperta o della “conquista” dello stato bianco— Malevic può scrivere: «la mia idea del colore cessa di essere colorata»110. Nessun colore può adeguarsi alla vista inoggettiva e incontraibile, nessun colore creaturale può esprimere la vista “non veden
106 Non è passibile non pensare alla tradizione dell’arte pittorica orientale. Gli Antichi, osserva Francois Jullien, «hanno posto la massima cura per svi luppare “l'inchiostro senza inchiostro’ e il “pennello senza pennello’ [...] L’attenuazione, a questo punto, è estrema, si è al limite della cancellazione [...] si pittura tra la forma e il senza-forma e si rende l’evanescenza del fonda mento») (corsivo ns.), in La grande immagine non ha forma (2005); trad. it. An gelo Colla, Costabissara (Vicenza) 2004, p. 66. 107 K. Malevic, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività. cit., p. 215. 108 N. Cusano, Il Dio nascosto, cit., p. 9 109 N. Cusano, La ricerca di Dio, in II Dio nascosto, cit., p. 16. 110 K. Malevic, In natura esistono il volume e il colore..., in K. Malevic. Una retrospettiva, cit., p. 68.
119
te” e “non colorata” che è condizione e orizzonte di tutti i colori. Il Bianco di Malevic -come compossibilità di tutti i colori dati solo in potenza- è l’unica espressione possibile a sua disposizione per ricordare sensibilmente quel nulla-piuttosto-che-qualcosa che è la vista inoggettiva. «Nessun ogget to è già “essere”», scrive Malevic, «ma è solo un fantasma
dell’essere, perché l’essere si è sempre nascosto e non è co noscibile come forma [...] L’intero mondo visibile non è an cora l’“essere”»in. L’icona del Quadrato bianco, il suo volto, si rivela come la forma della presenza di ciò che non si dà se non ritraendosi, ma che proprio perciò in questo ritrarsi si manifesta come osvobozdennoie nicto, come, già sappiamo, il nulla liberato, affrancato, riconquistato del Supremati smo. Un Bianco che si rivela non ex nibilo ma in rubilo-, non qualcosa che proviene dal nulla ma qualcosa che, manife standolo in levare, come per astensione appartiene al nulla. ★ ★ *
Come molti artisti dell’epoca, Malevic era affascinato dalle nuove tecniche di volo, che probabilmente, quantome no sul piano empirico, hanno rappresentato una fonte di ispirazione per le sue superfici-piano che si librano nell’a perto dello spazio, simboli di emozione cinetica, di fluttua zione e caduta libera, ascensione ed espansione delle possi bilità oltre i confini terrestri. La sorgente sia concettuale sia plastica del Suprematismo, infatti, non è stata tanto la figura del quadrato presa in sé, quanto il piano che l’ha costituito manifestandovisi geometricamente. «Un piano pittorico, so speso sull’abisso della tela bianca, dà alla coscienza ima sen
sazione dello spazio immediata e fortissima», scrive Malevic in una lettera del 1916 a Matjusin112. Assistiamo alla purifì-
111 K. Malevic, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, dt., p.204. Fa cile ma non perdo improprio l’accostamento all’essere hddeggeriano che si ritrae per dar luogo agli essenti. 112 Cfr. A.B. Nakov, Il nuovo Laocoonte, in K. Malevic, Serìtti, cit., p. 114.
120
cazione estrema e radicale dell’immagine e della sintassi cubofuturista praticate fino ad allora, ma giudicate esaurite e soprattutto ormai insufficienti per affrontare i nuovi compi ti. All’interno dei dipinti cubofuturisti compaiono superfìci quadrate e rettangolari monocrome che —nonostante condi vidano lo stesso ambitus con altri elementi come le lettere dell’alfabeto, i frammenti di fotografìe, le forme geometriz zanti colorate, i lacerti di scomposizioni volumetriche— vivo no in un loro spazio indipendente, autonomo, e sono del
tutto sconnesse (non soltanto in termini di significato “logi co’’, ma anche volumetricamente) dagli altri elementi pre senti nella composizione. Le superfici-piano della fase su prematista -che niente possono imitare, che a niente posso no alludere— vengono letteralmente liberate, districate e prelevate dai dipinti di quella precedente fase alogica: ad
esempio Mucca e violino del 1913, Donna accanto a una co lonna d’affissione e la stessa Composizione con la Gioconda del 1914, oppure Guardia del medesimo anno. Proprio da quest’ultimo dipinto viene “liberato" il trapezoide giallo (impropriamente chiamato Quadrato giallo) del 1917-18, sorta di monolite planare davvero “sospeso sull’abisso”, che attraversa diagonalmente lo spazio bianco. L’angolo vivo in basso tocca appena il margine della tela, quello più in alto a sinistra vi si accosta; tutto il lato destro, invece, si disfa, sfu
ma, si polverizza nell’infinito dove si congiungeranno le pa rallele. È uno stupefacente vettore di energia, o meglio: una massa-colore che da un momento all’altro (come già il Qua drato bianco) sembra poter roteare liberamente su sé stessa in assenza di gravità (o che già lo sta facendo, come un’istan tanea scattata in corsa che ferma per un attimo un movimen
to continuo) e che soprattutto -transitando nel vuoto crea tore del nulla— si dissolve e si trasforma in pura energia co smica, riacquistando così il suo stato quintessenziale. Certa mente questo passaggio della superfìcie-piano dalle compo sizioni cubofuturiste alle costruzioni suprematiste segna uno sviluppo formale dalle opere precedenti a quelle seguenti. Ciò è vero, però, se rimaniamo all’inerenza stilistica, alla
121
mera congruenza cronologica. In realtà, in Malevic l’astra zione non è un dis-cursus, un processo, un itinerario che ac coglie e abolisce via via le fasi intermedie sempre più dena
turalizzate e sempre meno descrittive; non è una sintesi-sele zione progressiva delle apparenze sensibili (come la celebre sequenza delTAlbero in Mondrian). Al pari dei mistici che parlano delle loro visioni in termini di rottura improvvisa e di catastrofe del quotidiano, così in Malevic l’astrazione inoggettiva verso l’infinito appare come un salto, un’intui
zione indeducibile, una metanoia vera e propria. Pur considerando le improprietà e gli slittamenti seman tici che possono verificarsi nella traduzione dalla lingua rus
sa, è vero però che bisogna osservare una particolare caute la nel parlare di “infinito” a proposito del Suptematismo. Scrive Malevic, con accenti che ricordano la plotiniana abo lizione delle differenze sensibili per raggiungere l’indiffe renziato: «La non-oggettività non ha nulla a che fare neppu re con 1’“infinità”, poiché anche questo concetto è collega to a qualche cosa di “finito”; il “finito” come contrapposto dell’“infinito”. La non-oggettività non ammette dimensioni»,1J. H concetto di “infinito” è dialetticamente connesso a quello di “finito”; si determina e non può non determinarsi insieme ad esso e con esso si compone: posto l’infinito si pone il finito e viceversa. Se in ogni ente è “contenuto” come in levare anche ciò che esso non è, allora non può dar si infinito senza finito. Ma nei termini radicali in cui Malevie pensa la non-oggettività -e in cui la pensa pittoricamen te— non sopravvive nessuna dialettica; essa non è un compo sto, non è un’armonia di differenti, non è un congiungersi “sinfonico" dei diversi —anche «la sua struttura cromatica è ben altro che una mescolanza di colori integrati pittoricamente»114. Una volta arrivata allo stato bianco, la non-ogget tività, la gegestandlose Welt, il ‘mondo senza oggetti’ si rive la ancor più chiaramente come Veklàmpon, l’istantaneo ba-115
115 114
122
K. Maleviè, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività., rii. p. 85. Op. al., p. 95.
leno di semplicissimo incomposto splendore di cui parla Plotino nelle Enneadi. È in questo senso e sotto questa pro
spettiva misticamente intuizionista che dovremmo “legge re” l’Uno sovraessenziale dell’infinito suprematista, perché nell’«aureo nulla» non può esservi né misurarvi «né grande né piccolo»115. L’intelletto e la ragione analizzano, scom
pongono, distinguono, procedono e dis-corrono dalle pre messe alle conclusioni, ma «l’uomo non può penetrare con intelletto e ragione là ove non c’è né intelletto né ragio ne»115 116. Ed è proprio là, invece, che bisogna, ripetiamo, non tanto “andare” —il che presuppone un itinerario, una pro gressione di tappe distinte (che in ogni caso, certo, pittori camente Malevic percorre in senso diacronico)— quanto in vece bisogna immediatamente trovarsi. Ciò non significa che nelle opere del Suprematismo bianco -ognuna così ica sticamente unitaria, raccolta su sé stessa al limite del mono cromo assoluto ma non semplicemente monocroma— non viva un rhythmos, quel particolare inusitato Ritmo —mille
piedi al di là di ogni sua triviale lettura come inflessibile leg ge normativa— che permane anche nel silenzio suprematista ove pure non sono differenze117. Ritmo quindi aphanes, ‘inapparente’, puro e assolutamente irrintracciabile nella percezione empirica —«sulla superfìcie pittorica spariscono tutte le differenze percepite»118119 — poiché lo stato bianco, su periore a ogni misura e a ogni qualità, è la condizione «in cui niente è più distinguibile, neppure il ritmo non oggetti vo»1 Si capisce qui come il ritmo non è inteso alla stregua di un elemento -componente atomica, struttura ultima o
115 Op. cit., pp. 79 e 78. L’infinito per il Cusano è «la contraddizione senza contraddizione, come il fine senza fine», dunque è plotinianamente «la sem plicità stessa» (La m/bire di Dio, cit. p. 571): l’opposizione che toglie ogni op posizione. 116 Op. dt.,p. 147. 117 Cfr. op. cit., pp. 125-6. Cfr. il classico studio di E. Benveniste La nozione di ‘ritmo' nella sua espressione linguistica, in Problemi di linguistica generale (1966); trad. it. il Saggiatore, Milano 1971. 118 K. Malevic, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, cit., p. 154. 119 Op. dt.,p. 180.
123
quantum minimo— che fa a sua volta parte dell’insieme che è supposto ordinare, governare. Il ritmo quale qui lo pensa Malevic appare piuttosto in quanto causa formale aristoteli ca, eidos, ciò che, astenendosi dall’oggettività e quindi ap partenendo a una dimensione radicalmente altra da quella empiricamente esistente, fa sì che l’oggetto semplicemente
sia quel che è; appare in quanto ousìa, l’essenza in mancan za della quale l’ente non potrebbe mantenersi nella presen za120. La risposta tradizionale che si fornisce riguardo all’o rigine di rhythmos è che sia l’astratto del verbo rhein, ‘scor rere’, come il movimento regolare delle onde. La questione etimologica, però, non è ancora completamente chiarita.
Ma siccome quell’essenza inappercepibile si esprime e si la scia percepire nell’esperienza umana sotto forma di arhythmos, cioè ‘numero’ calcolabile che fornisce un metron, una ‘misura’ —in Platone infatti il rhythmos è ciò che «si realizza dal rapido e dal lento, in origine discordanti ma poi accor dati» (Simposio, 187b-c) ed è anche «il nome del movimen to ordinato del corpo» (Leggi, 665a)- ecco che il ritmo è an che qualcosa che articola trattenendo, che organizza e “do mina” sospendendo, appunto ritmando, quel flusso conti nuo altrimenti indistinguibile. Le superfici-piano di Malevic che attraversano lo spazio bianco aprospettico proprio in tal modo debbono intendersi: còlte, abbiamo già accennato,
come “fotogrammi”, istantanee forme del movimento, mo mentanei arresti del transito, provvisorie sospensioni “ritmiche”del flusso. In un altro dipinto bianco del 1918, il pia
no che fluttua ascendendo diagonalmente verso sinistra è attraversato da tre elementi curvilinei che vi si sovrappon gono quasi a formare una doppia croce ortodossa. Non sol tanto il colore è usato in modo ultraterreno, “astrale”, ma colore luce e forma si danno in uno, e questa identità di di
120 Porrebbe qui venire a mente anche la chora del Timeo di Platone, il ricet tacolo originario in primevo ed eternamente uritmico”-oscillante movimento, né sensibile né intelligibile ma appartenente a un «terzo genere» (cfr. 48e, 52a).
124
versi che permangono tali plana staccata a volo dal mondo terrestre, sublunare, in una regione dove, eliminato l’ogget to, può essere alfine percepito l’indifferenziato suono bian
co delle forze cosmiche. Differenza come e in quanto unità: ecco di nuovo comparire —in questo delicato, fragilissimo equilibrio— quel solco di nulla che attraversa il Quadrato
bianco, ma anche le altre opere dello stesso periodo. Se è ne cessario visivamente intuire le forme nel bianco, «deve esi stere una differenza tra esse, ma solo in forma di bianco pu ro»121, così come soltanto con l’eliminazione radicale dell'oggetto può attingersi nel vuoto che brulica di possibi lità la purezza del Ritmo. È la lezione dei Maestri cinesi: «Quando la pittura giunge al punto in cui è senza traccia», dice Hua Lin, «sulla carta sembra un’emanazione naturale e necessaria di quella carta che è il Vuoto stesso». Huang PinHung: «Quando dipingevano, gli Antichi concentravano gli sforzi sullo spazio in cui è assente il Pennello-Inchiostro». E Wang-Yu: «Il Vuoto puro, ecco lo stadio ultimo al quale tende ogni artista»122*. La pittura di Malevic, dunque, non appartiene più alla terra. La terra è stata abbandonata. Que sta è la rivelazione, e nei suoi scritti egli usa proprio il verbo ob’javljat, ‘rivelare’125, perché è esattamente di un’apocalissi che si tratta, nel senso letterale ed etimologico del termine. Ma siccome il bianco è pur sempre qualcosa (anche se condotto fino ai limiti di sé stesso) piuttosto che niente, la logica spietata e intransigente seguendo la quale Malevic ha sempre “destinalmente" scandito il proprio itinerario creati vo, lo spinge fino a un’ulteriore, estrema decisione; una de cisione che, precisamente perché scaturita da un’interna fer rea coerenza, sarebbe del tutto improprio confinare e ridur re a mera pròvocazione di natura semplicemente “avanguar dista”. In una mostra collettiva nel maggio del 1923 all’Ac-
121 K. Malevic, In natura esistono il volume e il colore..., cìl, p. 68. 122 Cfr. E Cheng, Il Vuoto e il Pieno (1979), trad. it. Guida, Napoli 1989, p.71. 125 Clr. A.B. Nakov, Il nuovo Laoeoonte, in K. Malevic, Serifti, cit., p. 128.
125
cademia di Belle Arti di Pietrogrado, presenta con il suo gruppo unovis alcune tele vuote, non dipinte, su cui nean che il bianco si sovrappone. Non è nota alcuna fotografìa dell’allestimento, ma sembra che le tele fossero “aeree”, col locate in alto sotto il soffitto, quasi fuori vista, ai limiti della capacità fisiologica di presa ottica. Il principio della “libera navigazione" nello spazio secondo cui si dispongono le superfici-piano diventa anche quello dello sguardo dell’osser vatore, non predeterminato ortogonalmente o assialmente ma calibrato secondo i ritmi di una libera fluttuazione ispet tiva. Secondo un’ulteriore direttrice di lettura, potremmo ri chiamare anche le condizioni di precaria visibilità nell’osten-
sione cerimoniale della Veronica evocate nei versi danteschi su cui d eravamo soffermati. E a tale proposito può essere significativo ricordare che la mostra era accompagnata da quell’enigmatico, breve testo —che si scioglie in un formula matematica risolta nello zero— dal titolo Lo specchio supre matista. Il rimando concettuale, dunque, va a quell’econo mia dello sguardo teologico, a quel riconoscimento del pro prio volto riflesso nell’immagine dell’icona che già abbiamo richiamato come a uno sforzo vocazionale di compartecipa zione al trascendente: «Dio mio [...] chi ti guarda», scrive il Cusano, «vede se stesso in te»1-2,1. Nella pura esibizione del supporto, più che “superata”, potremmo forse dire che l’ar
te della pittura è trasfigurata nello stesso presupposto mate riale che è condizione del suo apparire sensibile-fenomeni co, e che ora, affrancato e riconquistato, vola libero nello spazio. È come se la pittura, il suo “sistema" venisse mostra ta nel suo stadio precategoriale, quando è ancora nella fase potenziale di mera ricevibilità-inscrivibilità di un segno, di
una traccia, di ima macchia di colore. In un celebre luogo del De anima (429b, 30 - 430a, 3), Aristotele afferma che «l’intelletto è in potenza gli intellegibili, ma in atto nessuno prima di pensarli. Dev’essere di esso come di una tavoletta, in cui non c’è niente scritto attualmente. Proprio questo si
124 N. Cusano, La visione di Dio, dt., p. 576.
126
verifica per l’intelletto»125. Proprio come la tabula di cera o di altro materiale alla quale Aristotele equipara l'intelletto come potenza di non pensare, e la cui superfìcie non è anco ra stata scalfita dallo stilo, la tela vuota esprime la potenza di non essere dipinta. Se la tela non è ciò che come supporto retrocede per far posto all’immagine, ma ciò che si offre in proprio alla visione, allora 1’“attesa” della scrittura sulla ta bula e della pittura sulla tela è già, essa stessa, una forma di scrittura-pittura in levare', è, per così dire (e incontriamo di
nuovo questa figura), l’atto medesimo della potenza, poten za che pone sé stessa. È come se la rappresentazione esteti
co-sensibile divenisse in qualche modo, ora, superflua. E fosse possibile unicamente la “presentazione” giustappunto di questo suo essere superflua, in eccesso. “Presentazione”, dunque, massimamente critica. Malevic perciò de-dipinge. «La pittura è scomparsa», scrive, «e il pittore è un pregiudi zio del passato»126. È probabile che questa sia la prima volta
in cui la pittura oltrepassa sé stessa trasformandosi in perfor mance, gesto, azione pura. Perfettamente comprensibile ap pare allora il passaggio “teurgico” all’occupazione reale del lo spazio attraverso l’ulteriore fase suprematista tridimen sionale degli architektony o planiti, costruzioni plastiche bianche che aggregano componendole a varie altezze forme non oggettive la cui matrice è il cubo, slanciate sulla vertica le oppure distese in orizzontale. Questi corpi tridimensiona li sono i plastici ideali delle abitazioni che gli zemljaniti —i futuri ‘inquilini della Terra’ nel conio zaum' di Malevic— po tranno utilizzare una volta che ne adeguino la struttura alle loro specifiche, contingenti necessità vitali. La forma plasti ca del planita — non oggetto, diceva Lissitsky, ma vuoto tra sformato in spazio- infatti non ha uno scopo preciso, non de-finisce la propria funzione, non pre-figura né pre-giudica
125 Cfr. su questo filosofema aristotelico G. Agamben, La comunità che vie ne, Einaudi, Torino 1990, pp. 26-7. 126 K. Malevic, Introduzione all’album di litografie ‘Suprematismo - 34 dise gni’, in Sentii, cit., p. 198.
127
l’esperienza che se ne vorrà fare, piuttosto di questa espe rienza rappresenta e valorizza l’apertura, vale a dire il nucleo di libertà. Per Malevic l’arte è un modello di comportamen to e un progetto di esistenza, è tensione costruttiva e fare au tentico indirizzati verso una vita altra poiché la rivoluzione, prima di ogni altra cosa, è l’apertura di un campo di possibi
lità, è Valter mundus qui e ora. ■A ★ ★
Abbiamo visto che con Malevic si raggiunge uno dei più alti esiti dell’arte di un tempo che è ancora il nostro in ciò
che essa ha di più essenziale: l’interrogazione portata sull’in tero sistema di rappresentazione dell’ente. Nella sua gran diosa rinuncia a ogni presupposto che la spinge a un perpe tuo esodo da sé stessa e che la sollecita a immaginare la pro pria verità nel continuo, “hegeliano” dileguare di ogni con tenuto identificante, in equilibrio sul nulla fino a possedersi
nella propria estrema alienazione, l’arte modemo-contemporanea mostra eminentemente un carattere intellettuale-autoriflessivo. Nelle sue lezioni di estetica, Hegel parla di una denkende Hetrachtung, di una ‘considerazione pensante’ che non si limita a caratterizzare l’analisi o il giudizio critico sull’opera d’arte, ma che nel Moderno appartiene alla sua stessa intrinseca verità costitutiva. L’opera d’arte -investita da un potente, destinale processo di intellettualizzazio ne-concettualizzazione- non può non prendere definitivo congedo da ogni immediatezza lirico-espressiva per riacqui sirsi come procedimento autoconsapevole. Nello Zibaldone leopardiano (e sono gli stessi anni di Hegel) vi sono frequen ti considerazioni sul progressivo, moderno disincanto del fare artistico, e di questo processo parlerà a più riprese an
che Nietzsche: «le nostre arti stesse divengono sempre più intellettuali, i nostri sensi divengono sempre più spirituali» (Umano, troppo umano, l, af. 3). Le avanguardie russe e in primo luogo Malevic sono un perfetto esempio di questa in tenzionale, programmatica riflessione sui fondamenti dell’ar
128
te in generale e del pittorico in particolare, che legittimano con il pensiero e con l’elaborazione di concetti teorico-este tici la ragione che sottofonda la propria condotta operativa. «Oggi non fare teoria della pittura equivale al rifiuto di com prenderla», dichiara nel 1912 il poeta e pittore futurista Da vid Burljuk. Quattro anni dopo, lo storico dell’arte Nikolaj Tarabukin comincerà a lavorare al suo trattato pubblicato nel 1923, Per una teoria della pittura, in cui la produttività artistica viene tendenzialmente assimilata a una teoria della conoscenza127. La teoreticnost, la ‘teorizzazione’ vale già come parte componente del processo creativo, e la preoccu pazione speculativa, la mediazione concettuale, l’autoriflessione sistematica si integrano direttamente all 'operari artisti co. In Malevic tutto questo è assolutamente evidente. Egli diventa il pensatore dell’emozione creatrice. Il suo itinerario
—nella spietata coerenza logico-programmatica che lo carat terizza— incarna al massimo livello sia di forza intellettuale sia di scelta esistenziale la crucialità di tutti questi motivi, te stimoniando il punto forse più alto che può raggiungere la fede di un artista nella propria opera128. Già nel suo primo importante testo teorico egli scrive che il pittore, che prima «viveva di stati d’animo», adesso «deve sapere che cosa suc cede nei suoi quadri e perché»129. Se le leggi del materiale inerente all’opera devono stabilire, dettare le forme che essa
127 N. Tarabukin, Per una teoria della pittura, trad. ir. Officina, Roma 1979. 128 Nel suo Malevitch et la philophie (L’Age d’Homme, Lausanne 1977), Emmanuel Martineau, chiedendosi se si può leggere Malevic come qualsiasi altro filosofo, accetta la sfida di non partire dalle immagini ma dalle parole dell'artista, e assegna pari importanza agli scritti e ai dipinti. I primi sarebbe ro testimonianza di una meditazione tanto profonda da entrare in competizio ne -da ingaggiare, dice l’autore, una “lune amoureuse" (p. 181)- con i secon di Riferendosi soprattutto alla collazione di testi postumi raccolti in Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, Martineau parla di un’efficacia di for mule che ricordano il giovane Marx, di un abbandono alla potenza del lin guaggio come in Heidegger, di un ribollire di temi equiparabile al Nachlass di Nietzsche (cfr. p. 7?). 129 K. Maleviè, Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo, in Scritti, cit., p. 185. Il testo die però inaugura decisamente la stagione ‘‘teorico-filosofica" è Nuovi sistemi dell’arte, dell’estate del 1919.
129
ha da assumere indipendentemente da qualsivoglia impre stito letterario o comunque extra-pittorico, e se di conse guenza occorre criticare, respingere e superare il retaggio oggettuale che persiste sia nel Cubismo sia nel Futurismo, allora ciò non può avvenire che all’interno di un coerente processo di acquisizione razionale dei fondamenti teorici e più ampiamente filosofici del proprio operare creativo. Arri vato al confine definito dalla fase bianca del Suprematismo (ma definire un confine, diceva Hegel, significa già averlo superato), Malevic attua una sorta di emancipazione ontolo gica della pittura non-oggettiva, diventata fino in fondo con sapevole delle proprie condizioni e dei propri destini. Fon dandosi unicamente su di sé, essa prepara le basi per un pro cesso di autoabolizione, per il proprio oltrepassamento. H Suprematismo non poteva non condurre al di là dei confini
dell’arte puramente, “semplicemente” pittorica. Il mondo senza oggetti, cioè la visione del Nulla come realtà ultima e liminare di tutte le cose, doveva far cessare qualsiasi attività “artistica", doveva dissolvere l’immagine e lo stesso fare pit tura nella teoresi speculativa, doveva preludere all’inoperosi tà1™. Soltanto ora, arrivata a questo vertice, l’astrazione non-oggettiva si rivela letteralmente come tale assumendo fino in fondo il suo destino, diventando davvero liberazione da ogni dato. Bisogna saper tramontare, raccomandava
Nietzsche. L’astrazione deve essere portata all’estremo limi te in cui diventa anche astrazione di-da sé stessa: i dipinti bianco su bianco fanno pur sempre parte del sistema pitto rico e non riescono a rompere con la condizione essenziale e fondativa di qualsivoglia immagine, che è quella di presenta re, di esibire qualcosa, di rinviare evocativamente o simboli camente a un’ulteriorità che al momento di per sé non si of fre, non si palesa in quanto tale. E anche il passo successivo -Veliminazione della stesura cromatica, l’esibizione della tela vuota— fuoriesce dal pittorico come rappresentazione
lì0 Su questo tenta nel Malevic autore dell'opuscolo L'inattività come verità effettiva dell'uomo, cfr. il ns. Il genio è senza opera, dt., pp. 170-3.
130
ma, pur nella sua liminare radicalità performativa, lascia sempre e in ogni caso dietro di sé l’oggetto e non liquida fino in fondo e del tutto i presupposti e il paradigma del fare pit tura, o meglio del fare arte come poiesis, come produzione di sensihilia anche se non a carattere mimetico-raffìgurativo 111. (Riprenderemo tra poco, per svilupparlo in tutt’altra ma complementare direzione, questo punto “quintessenziale” non soltanto per l’itinerario creativo e filosofico di Malevic ma per tutta l’arte moderno-contemporanea). Si profila cioè
la necessità logica di una presa di congedo dall’arte classicamente-tradizionalmente intesa come fare produttivo. Singo larmente attuando una hegeliana Aufhebung dell’arte nella
filosofìa e comunque nel puro concetto-pensiero (e, allo stesso tempo, soggettivamente richiamandosi alla figura dell’artista-fìlosofo rinascimentale), tra il 1918 e il 1919 Ma levic considera conclusa la sua esperienza pittorica e passa alla speculazione puramente teorica, alla stesura di testi scritti, all’attività pedagogica e didattica. Non è un caso se nel 1922 Malevic entra al GiNchouK, l’istituto Nazionale di Cultura Artistica appena creato a Pietrogrado, e l'anno se guente prende la direzione del dipartimento di analisi for mali e teoriche (f.t.o.). Dopo la “perfezione bianca” non poteva che seguire l’azione filosofica e l’impegno esistenzia le, dal momento che, appunto, «il pittore stesso è un pregiu dizio del passato». Inoltre, permane appunto anche nella pittura non-oggettiva un residuo materiale e materialista non completamente spiritualizzato; persiste in essa la neces sità di un presupposto di natura concreta, di un medium
151 «Eapparenza estetica non può essere eliminata dall'opera», scrive Ador no con parole straordinariamente congruenti con l’ètimo filosofico delle arti moderno-contemporanee oltre che con la loro fenomenologia espressiva, «Anche quella che rigettasse ogni apparenza non si identificherebbe imme diatamente con la realtà empirica; l'apparenza sopravvive anche se l’opera non vuole somigliare a null'altro che a ciò che è (...] detto in altri termini, an che il senso negato è senso. L’arte non è traducibile in fatti; ogni suo momen to è sempre quello che è», ( Vers une musique inform elle, in Immagini dialetti che. Scritti musicali ì()55-65, trad. it. Einaudi, Torino 2004, p. 275).
131
sensibile che esibisce comunque la struttura e la logica del rinvio-ad-altro, deWaliquid pro aliquo. Insomnia, raggiunta quest’altezza, per certi versi il problema si presenta a Malevie sotto le vesti dell’esigenza di uscire dal segno. «Questo è il mio lavoro principale, non già di pennello, ma di penna», dichiara, «Risulta che con il pennello non si ottiene quello che può la penna. L’uno è arruffato e non può estrarre dalle anse del cervello quel che riesce alla penna, più aguzza»152*. In una progressione visionaria di una chiarezza, lucidità, for
za di penetrazione sorprendenti, Malevic non solo svela i li miti dell’astrazione ma rende visibili anche i confini della pittura in quanto modello, paradigma, disciplina. Come se l’icono-ZogM dovesse diventare più degna della sua radice, più pensante. Soltanto la speculazione filosofica attuata con il medium “insostanziale” della scrittura sembra poter ecce dere i limiti segnico-rappresentativi intrinseci alla modalità espressiva tradizionalmente intesa e classificata come pitto rica o artistica. Allora ecco perché «nel suo ulteriore svilup po fino al confine della non-oggettività, il termine “arte” deve essere sostituito da nuove denominazioni»155. Scrivere non era dunque per Malevic un’attività con funzioni soltan to didattiche, tecniche o polemiche, ma una scelta eminente mente filosofica. Qui egli tocca un fondamentum apparente mente inconcussum. Viene messa in questione, cioè, la taxis,
il rango, la distribuzione più o meno gerarchicamente ordi nata che nella cultura occidentale si è costituita delle prati che umane e dei saperi istituzionalmente suddivisi e artico lati; sono in gioco i confini —mobili si, ma di una mobilità governata, vigilata— che tra di essi si sono storicamente con
152 K. Malevic, Introduzione all'album di litografie “Supremai rimo —34 dile gni’, in Scritti, cit., p.198. Ricordiamo che Florenskij recupera e sottolinea la tradizione secondo la quale l’iconografo è considerato a tutti gli effetti un fi losofo: i pittori di icone, scrive, «Testimoniarono del Verbo incarnato con le dita delle mani e veracemente filosofarono con i colori [...] i veri teologi e i veri pittori d’icone si chiamano ugualmente filosofi», in Le porte regali, cit., pp. 174-5. 15 5 K. Malevié, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, cit., p. 125.
132
solidati nel tempo. Perché, in questo modo, dell’arte viene revocata in dubbio la categoria, la qualifica, il concetto e ad dirittura il nome stesso, la sua estensione semantica, la sua capacità referenziale, la sua tenuta lessicale. Ricordiamo che già il Quadrato nero fu considerato come qualcosa di molto diverso da ciò che si intendeva allora come arte, come pittu
ra. Su questo punto davvero decisivo, Malevic si dispone da protagonista all'interno di quella tensione estrema e insieme asintotica che segna indelebilmente essenza e percorso di tutte le “avanguardie” radicali del xx secolo. Ed è forse pro prio in questo punto che incontriamo il vertice di quella “af finità elettiva” che, a distanza e nella differenza, unisce Ma
levic e Duchamp in un’unica costellazione artistica e fìlosofica15-’.
*** Nell’itinerario di Malevic vi sono, come noto, due episo di enigmatici (anche se non sono i soli) che hanno alimenta to, nell’ambito della letteratura specialistica sulla sua opera, una messe di ipotesi storico-critiche. Ma che sostanzialmen te sono rimasti irrisolti. Si tratta della sistematica retrodata zione —una sorta di deliberato scompaginamento cronologi co— che egli fece di molte sue opere, e del ritorno a qualco sa che può comunque chiamarsi figurazione dopo la fase su prematista. Entrambi gli episodi sono profondamente se gnati a nostro parere da una inoltrepassabile, davvero “su prema” ironia. Ed entrambi possono raccogliersi sotto un unico plesso interpretativo, che privilegia su ogni altro sia
i!4 Abbiamo a lungo e a più riprese riflettuto sul motivo eminentemente fi losofico dei confini “linguistici" delle arti moderno-contemporanee, del loro statuto istituzionale e della loro stessa riconoscibilità in Non vedi niente li? Sentieri tra arti e filosofie del Novecento, Castel vecchi, Roma 1999, ai capp. Hans-Georg Gadamer. Il Bello contemporaneo e Arnold Gebien. Quadri d’og gi; nella terza parte de La motta di Dreyer. L'opera della contingenza nelle arti, cit., e in II genio è senza opera. Filosofie antiche e arti contemporanee, cit., al cap. Il genio inoperoso. Duchamp e oltre.
133
pur legittimo fattore esterno, la dialettica intrinseca, lo svi luppo immanente dell’opera. Sarebbe estremamente riduttivo ascrivere la retrodata zione di molte tele—in primis lo stesso Quadrato nero— a una furbesca volontà di mostrare precognizioni e precedenze creative, comunque oggettivamente comprensibile quanto corrente e diffusa nel concorrenziale mondo dell’arte, so prattutto in quello delle avanguardie del primo Novecento, dove l’irruzione del novum era il lasciapassare per la storia. Dobbiamo invece interpretare quella pratica di deraglia mento del buon senso cronologico (non per nobilitarla ma per proiettarla sullo sfondo di quella totalità arte-vita co
stantemente perseguita dall’artista) in stretta connessione con la ripulsa “apocalittica” —e certo provocatoria, beffarda, anti-boghese— della temporalità consequenziale all’opera: quella, come abbiamo visto per Vittoria sul sole, che scorre “goccia a goccia” in una successione apparentemente logi co-deduttiva che ci fa credere, illudendoci, che l’attimo se guente sia l’effetto del precedente che lo avrebbe “causato”. Liberarsi dalla “contabilità” del tempo come ordinata, cata stale consecutùr, affrancarsi dalla storia come sviluppo linea re e progressivo, come accumulo diacronico di momenti che intenzionalmente tenderebbereo a un risultato, a un senso compiuto, è il compito “trans-razionale” che tutti gli adepti zanni’ si erano prefìssati. Non è un caso che questa indiffe renza per la precisione temporale, per la “fissazione” nel tempo dell’opera, fosse comune anche a Chlebnikov, anche lui come sappiamo partecipe di Vittoria sul sole1’5. Per Ma levic conta l’idea, l’intuizione creativa; che l’idea e l’intuizio ne del Quadrato nero le avesse avute nel 1913 è per lui mol
to più importante del fatto che le avesse realizzate, rese sen sibili in un oggetto due anni dopo. È la vis concettuale, è la
1)5 Datare le sue poesie, scrive Ribellino, «è impresa diffìcile, perché egli non si dava briga di apporvi la data o ve ne affìggeva di erronee, e spesso i pro seliti spostavano indietro i termini della stesura per accrescergli credito di precorritore». Tentativo di esplorazione del continente Chlebntkov, cit., XV1U.
134
potenza della mente intuitiva che si riconosce autonoma dal le contingenti parzialità delle vicissitudini reali, che fa astra zione dalle limitazioni della datità fenomenica. Una riflessione in certo modo analoga occorre fare per il “ritorno” all’immagine figurativa (e non “realistica”, perché proprio un “nuovo realismo" era da Malevic considerata la sua fase suprematista) che si sviluppa tra i tardi anni Venti e gli anni Trenta fino alla morte dell'artista. È noto che questa ultima, copiosa fase è colma di continui, insistiti e più o meno espliciti rimandi (oltre che, attraverso modalità più fi gurativamente evidenti, alla tradizione iconica russo-orto dossa) al periodo suprematista. I piani-superfìcie di cui si
compone Testa di contadino del 1930 circa, le forme non-oggettive del corpetto delle figure femminili nel Ritratto della moglie e della Lavoratrice, lo stesso Quadrato nero che com pare appeso alla parete sullo sfondo del Ritratto di V.A. Pa vlov, o che a mo’ di firma affiora quasi invisibile e commo vente in proporzioni ridottissime nell’angolo in basso a de
stra nell’Autoritratto (tutte opere del 1933), sono soltanto al cuni esempi. Sul piano storico sarebbe insensato e del tutto incongruo respingere l’ipotesi secondo cui il ritorno a una pittura più “comprensibile” dalle masse è profondamente implicato con le conseguenze liberticide che sulle arti e sul la cultura ebbe il terrorismo staliniano di Stato. Lo prova la disposizione testamentaria che Malevic redasse e lasciò a Berlino il 30 maggio del 1927: «Nel caso della mia morte o della totale privazione della mia libertà, il possessore di que sti manoscritti, ove voglia pubblicarli, deve studiarli a fondo e poi tradurli in un’altra lingua. Ciò perché mi trovai, a suo tempo, soggetto a influenze rivoluzionarie e potrebbero
quindi sorgere rilevanti opposizioni alla forma con cui di fendo l’arte che ora (1927) rappresento. Questo è quanto si deve osservare»156. Lo prova il totale isolamento artistico ed esistenziale in cui l’artista fu tenuto dal 1930 in poi. Lo pro vano i due arresti: il primo al suo ritorno dal viaggio in Ger-
156
Cfr. H. von Riesen, Prefazione a K. Malevil, Suprematismo, cit., p. 8.
135
mania e Polonia, il secondo quando fu incarcerato per due mesi nella “Grande Casa” —come i leningradesi chiamavano la sede dell’allora NKVD— nell’autunno del 1930.
Qui però, rispettando l’asse direttivo della nostra ricerca, l’interpretazione, come abbiamo anticipato, deve trovare le sue ragioni nel decorso interno dell’opera. Sarebbe erroneo e in qualche modo ingenuo vedere nel recupero della pittura “figurativa” una sorta di “tradimento” (così da molti fu giudi cato all’epoca, ad esempio da E1 Lissitskij), quando invece esso è del tutto conseguente alla fase suprematista. Insistere su questa anche dopo il suo sbocco plastico nei planiti, avrebbe inevitabilmente significato “istituzionalizzarne” la potenza di rompente, sfibrandola e impoverendola in accademismo: cosa che è accaduta per tutte le avanguardie ma non, appun to, per il Suprematismo di Malevic, che ha saputo per così dire “limitarsi” alla sua sorgente originaria e inscrivere la pro pria opera nella sua dimensione fontale e ascetica più pura. Proprio perché era giunto fino a dipingere un quadrato nero, poi un quadrato bianco, poi alla tela vuota, poteva con ogni legittimità sul piano artistico e creativo permettersi di com piere il “falso movimento” di dipingere ritratti “figurativi”,
che soltanto una considerazione dell’avanguardia in termini unicamente evoluzionistico-progressivi poteva giudicare un “passo indietro”. Raggiunto lo zenith, toccato il punto-limite,
il percorso fatto per raggiungerlo può rovesciarsi acronica mente su sé stesso, proprio come leggiamo in questo straordi nario passo di Kleist: «come l’intersezione di due linee, vista da un punto dato, dopo aver traversato l’infinito, d’improvvi so si ritrova dall’altra parte di quel punto, o l’immagine dello specchio concavo, dopo essersi allontanata all’infinito, ci ri
compare vicinissima davanti; così si ritrova anche la grazia, dopo che la conoscenza, per così dire, ha traversato l’infinito [...] questo è l’ultimo capitolo della storia del mondo»1’7. ***
157 H. von Kleist, Della nflessone, in Opere, trad, it Sansoni, Firenze 1959, p. 88«.
136
Non riusciremmo a comprendere nulla dell’intero per corso artistico e filosofico di Malevic se non lo vedessimo at traversato da una “ploriniana" aspirazione verso Vaneidon, il ‘senza forma’ dell’esperienza puramente teoretico-contempla tiva, mentale, veicolata dal medium il più possibile smate rializzato. Come se il Suprematismo reclamasse, pretendesse
—lo abbiamo già visto— una visione noetica e non più empi rica. Questa, d’altronde, è una delle spinte più potenti, delle tensioni più profonde e cruciali di tutta l’arte novecentesca, sia essa “figurativa” o meno. Può darsi un'estetica ascetica? Un’estetica che si rivolge contro i propri stessi fondamenti? Oppure l’evidente ossimoro ne blocca sul nascere, ne para
lizza a priori l’esperienza? Come la percezione senza oggetti poteva riconoscibilmente comunicarsi-materializzarsi in pit tura? Come può darsi uno stato estetico dell’inoggettività?
Quali apparenze assumerà? Tutta l’opera di Malevic è un te nace, inesausto corpo a corpo con questi interrogativi, una lotta incessante condotta all’interno di queste aporie. In essa, l’ineludibile necessità della produzione dell’apparenza, della manifestazione sensibile dell’opera, 1’dpophaìnestai kala erga platonico, il ‘trarre al giorno belle opere’, diventa
davvero problema nei suoi aspetti più contraddittori e dispe ranti. Non è una caso se egli parla spesso dell'angoscia che lo attanaglia nell’abbandonare “il mondo della volontà e della rappresentazione” dove aveva fino ad allora vissuto e creato138. Da questo punto di vista, non soltanto Duchamp, ma anche Malevic è la fonte irrinunciabile, seppure più na scosta, più implicita, dell’arte concettuale degli anni Sessanta-Settanta. L’attitudine più profonda della sua intera opera si dispone su di una soglia, come tutte le soglie paradossale
e antinomica, posta sul fragile delicatissimo discrimine tra ipseità e manifestazione, ritenzione “quintessenziale” e ne-
138 Malevid conosceva Schopenhauer e il suo profondo interesse per l’asce si nirvanica del buddhismo, cfr. T. Andersen, Prefazione a K. Malevich, The World of Non-Objeetivily. Unpublished Writings 1922-25, Borgens Forlag, Co penhagen 1976, pp. 7-10.
137
cessila espressiva. Egli è in aperto, dichiarato e soprattutto teorizzato conflitto con l’àpophaìnestai kala erga, ma nello stesso tempo, ma davvero nello stesso tempo, deve con quel
principio scendere a patti. Nel suo itinerario suprematista — operativo e filosofico— la pittura necessariamente viene mes sa in perpetua e sempre rinnovantesi contraddizione con sé stessa, con la propria ratio, cioè con il suo inaggirabile porsi come cosa sensibile, fenomeno circoscrivibile. Dunque come illusione, fantasma: l’ultimo, sia pur sottilissimo velo di Maya. Malevic sa bene, come uomo e come artista, e talo ra con disperata speranza, di dover venire a patti con la mon danità del mondo come coacervo di irricomponibili diffe renze, come regio dissimilitudinis, dunque ha da confrontar si continuamente con la necessità della contingenza, e questo confronto non cessa di solcarne ma anche di costruirne, di fondarne l’opera. Per chiarire, o meglio per interrogare an cora più a fondo questo snodo cruciale dobbiamo estendere la nostra prospettiva a quella dimensione teologico-fìlosofì-
ca con cui abbiamo iniziato al nostra ricerca. Non v’è alcuna ombra di dubbio che, se confrontata all’i nesprimibile, ineffabile, insostenibile bellezza della visio fa cialis garantita dall’escatologia cristiana, che è immediato, puro vedere inoggettivo quindi libero da ogni necessità di es sere interpretato, se paragonata cioè alla futura visione fac cia a faccia con Dio che ci attende (quando saremo, precisa ancor più intensamente, “eroticamente’’ Meister Eckhart, con Lui «bocca a bocca»), allora «ogni bellezza di forme vi sibili, varietà di colori, proporzione gradevole, splendore di carbonchio, verde dei prati», scrive il Cusano nel De quaerendo deum, «è davvero nulla alla corte del grande re, né più
né meno che se si trattasse dell’infimo strame della reg gia»159. In quanto creature, siamo condannati —in questo mondo terreno del quale ci troviamo temporanei ospiti («Siate di passaggio» ricorda Cristo nel logion 42 del Vange lo secondo Tommaso)- a servirci di figure, similitudini, me
159
138
N. Cusano, La ricerca di Dio, in II Dio nascosto, cit., p. 19.
tafore, congetture. Le stesse cose sensibili, d’altronde, non possono essere intese se non attraverso similitudini: come posso conoscere la ragione propria e indelegabile, la quidditas di questa singola pietra? Quando l’essere umano tenta di attribuire un volto a Dio, non può cercarlo al di fuori dei modi in cui la specie umana è contratta. «Non siamo in gra do», afferma paolinianamente Cusano nel De filiarione dei, «di andare oltre i modi dell’enigma»1441. Ogni proposizione o congettura, ogni immagine o affermazione concernente le cose divine è fatta muovendo dalla realtà finita che appunto de-finisce ontologicamente chi la propone. Noi esseri confit ti nella finitezza non abbiamo allora alcun altro modo di as sociarci all’intelligibile puro e di intraprendere la mistica subida al divino, se non quella di servirci del sensibile e dell’e speribile come di uno strumento. Questo motivo dello “strame*’ proviene al Cusano da Origene. Nel grande adattamento del platonismo al cristia nesimo operato dal Padre alessandrino. Fincato azione kenotica del Logos, il suo volontario abbassamento alle propor zioni umane, non è altro che un mezzo necessario, il medium indispensabile del quale il Primo Principio si deve servire
per farsi conoscere e comprendere dagli uomini, incapaci appunto di accedere allo spirituale senza passare attraverso il sensibile. In qualche misteriosa maniera, il trascendente si
dà consistenza, si solidifica, assume peso mondano. P punto assolutamente decisivo, però, sta nel fatto, come scrive Urs von Balthasar, che questo «diventar sensibile di Dio in Cri sto è un’espressione positiva del suo amore: noi dobbiamo riconoscere l’amore spirituale di Dio attraverso il sensibi le»1-”. Ed è così che Dio, dal fondo insondabile della sua di-
1441 N. Cusano. La filiazione di Dio, in li Dio nascosto, eie, p. 40. E nel Pos sest: «[Dio] non può essere veduto per forza naturale altrimenti cite in enig ma», (cit., p.269) e «per quel tanto che l’invisibile stesso si manifesterà» (p. 253). 141 H. Urs von Balthasar, Gloria. Una estetica teologica, vol. I (1961); trad. it. Jaca Book, Milano 1971, p. 249. La dottrina origenista che vedeva nell’incar nazione soltanto un mezzo pedagogico e di conseguenza il corpo di Cristo al
139
stanza, si dona all’uomo, è così che l’essere si abbandona all’ente, poiché l’umano, come già sappiamo, da sempre e fin dall’inizio è intrinseco, immanente al divino. È per que sto motivo che la libera scelta dell’incarnazione non è una concessione “pedagogico-didattica” alla debolezza umana: il logos-Verbo non ha transitoriamente “dimorato” in un corpo ma è diventato uomo, anche se né Dio si è dissolto neh’umano né questo in Dio. Ciò è perfettamente espresso nella formula di Cirillo di Alessandria (370-444): «H Logos
deve possedere ciò che è nostro per dare a noi ciò che è
suo». Dunque, nonostante la consapevolezza della sua insuffi cienza, dobbiamo tuttavìa servirci del cusaniano strame per farne emergere, svelandone l’essenza simbolica, la facies che lo trascende, poiché esso stesso è già frammento, scintilla
dello spirito. (Tra l’altro, è precisamente il metodo espositi vo seguito dal Cusano stesso nei suoi testi, quello di propor re continui e concreti esempi “didattici" di contrazioni per avvicinare e “spiegare” l’incontraibile). Il Padre divino, se condo lo Pseudo Dionigi, apre alla rivelazione mediante simboli figurati, giacché le nostre misere facoltà non ci per
mettono di ascendere direttamente alla contemplazione im materiale delle intelligenze celesti; ma proprio «attraverso le immagini sensibili», a noi adeguate, il Padre «ci eleva verso l’intelligibile, e, facendoci partire dai simboli che raffigura no le cose sacre, ci fa raggiungere le semplici altezze delle gararchie celesti»1'’2. H sensibile cui siamo assegnati in questo mondo -e le congetture che “sperimentiamo” intorno ad esso— non è dunque sorda, ottusa, indischiudibile resisten za, non è mera opacità, ma in qualche modo è emanazione e
riflesso del Vero. Immagini, congetture, metafore, in attesa di «un cibo più sostanzioso» -quello di cui godremo nella
puri di un fantasma, fu al termine di molte controversie condannata nel con cilio ecumenico del 553, il secondo costantinopolitano. 142 Pseudo Dionigi FAreopagiia, Gerarchia celeste. Teologia Mistica. Lettere, cit., p. 22.
140
visto beatifica— sono per il De icona addirittura «latte che nu tre»141. Proprio lo strame, allora, si rivela essere il nostro ne cessario alimento. Perché questi mezzi sensibili con i quali significhiamo -e nei quali in modo eminente rientra anche l’arte della pittura— pur nella loro miseria e insufficienza, pur contratti nei loro limiti tutti terreni, ci sono comunque donati da Colui che essi tentano imperfettamente di designare-evocare. Lo stesso Dio ignoto ci offre tutto ciò che ci occorre per muovere verso di lui e ascendere alla sua infini ta quiete, poiché Egli stesso vuole essere cercato, e noi pos siamo coglierlo a condizione che sia Egli stesso a manifestar si a noi. «Dio ama infinitamente le cose finite in quanto infi
nite», scrive Simone Weil144. Come già sappiamo dal nostro percorso attraverso la teologia dell’icona, è la manifestazio ne espansiva e radiante dell’amore divino che non rimane in fecondo in sé stesso ma “trabocca’’ dalla sua ipseità permet tendoci così di creare similitudini, immagini, congetture: il segno si apre in virtù dell’amore che —pur restando ine
sprimibile— consente che noi comprendiamo-“incamiamo” questa stessa inesprimibilità e infìgurabilità, consente cioè che nella moltitudine di volti contratti dimori celato il Volto incontraibile. Lungi dal disprezzarli, dunque, quei mezzi sensibili “troppo umani”, occorre usarne mille piedi oltre ogni feticismo, oltre ogni idolatria, cioè nella disincantata consapevolezza del loro intrascendibile limite, che consiste nel restare soltanto immagine, phainomena oggettivi del mondo inoggettivo, ombre proiettate dalTArmonia perfetta ma inapparente, non manifesta. Questo è il destino dell’arti sta: può solamente com-porre in immagine, trans-porre in una iconografia, letteralmente in una ‘scrittura di immagini’ il Ritmo che rimane in sé inudibile-invisibile. È questo l’uni-145 *
145 N. Cusano, La visione di Dio, dt., p. 566. La metafora cusaniana riecheg gia il «latte spirituale» della Lettera Prima di Pietro (2,2). «L’itiattingibile non è (’assolutamente Altro e basta, ma l'assolutamente Altro che si ri-vela in atte ntate mniedurali», scrive Cacciati, «in quell’altro da sé che è la congettura», in Geo-filosofia dell'Europa, Adelphi, Milano 1994, p. 153. 144 S. Weil, Quaderni, voi. ili (1974); trad. it. Adelphi, Milano 1988, p. 179.
141
co rapporto che gli è dato intrattenere con quel luogo iperuranio del quale platonicamente non riconosciamo altro che rammemorazioni (da qui, l’alta speculazione patristica sull’i cona come reminescenza di ciò che mai abbiamo visto-vissu to). Eppure, nello stesso tempo, afferma Cusano —ben pri ma di Wittgenstein e con una sorta di parafrasi anticipata: «Tutte le cose che si possono dire non esprimono l’ineffabi le, tuttavia ogni espressione manifesta l’ineffabile»147. “Ma nifestare” è movimento iconico-teofanico. L’espressione non esprime come suo contenuto l’ineffabile, ma lo manife sta con il suo semplice accadere. L’Uno inattingibile viene còlto in tutto ciò che riusciamo ad attingere, viene «traccia
to in ogni segno»146 indifferentemente da ciò che con quel segno si traccia. È l’istanza stessa del linguaggio, è il darsi
stesso del sensibile che, sebbene «infimo strame», riesce a evocare, convocare e manifestare quell’Uno ineffabile-inattingibile che con la sua virtù abbraccia tutto il dicibile. Già lo stesso Pseudo Dionigi nella Lettera ix aveva affermato che «l’ineffabile appare intrecciato con ciò che si può profferi re»147. Secondo il movimento che abbiamo già visto decisivo all’interno della dimensione teologica dell’icona, l’inattingi-
bile non resta ìdiotes, chiuso, sigillato in sé stesso. H Dio cri stiano (qui radicalmente diverso da quello ebraico e da quel lo islamico) che è amore irradiante (cfr. Ebrei 1,3), ci viene incontro, non d lascia soli nella nostra miseria, nella nostra insufficienza. A quell’Armonia inapparente, a quel Ritmo inudibile appartiene per essenza un conato, un’insopprimi bile esigenza espansiva all’autotrascendimento, così come l’inoggettività di Malevic è sì il nulla, ma è il nulla all'opera. Ci confrontiamo quindi con un Inattingibile che è per esse re attinto restando inattingibile, con una pura Qualità che ri manendo tale è ab origo disposta e aperta alla significazione,
147 146 147 cit.,
142
N. Cusano, La filiazione di Dio, cit., p. 51. Ivi. Pseudo Dionigi l’Areopagita, Gerarchia celeste. Teologia Mistica. Lettere, p. 149.
alla trasposizione in altro da sé: energia irradiante, intesa come continua abolizione dei propri stessi confini —Vablatio terminatorum cusaniana— e della propria latenza148. La co
stellazione nella quale dobbiamo inserire e interpretare que sto passaggio è però di natura eminentemente filosofica. L’essenza per definizione non appare, sta in sé irrivelata. Tuttavia nel fare dell’arte come manifestazione sensibile, il momento negativo, l’opposto dell’essenza, cioè l’apparire manifesto, si mostra paradossalmente come movimento im manente e intrinseco all’essenza, momento interno e inelu dibile. Questo e non altro è il filosofema centrale e decisivo dell’estetica di Hegel che “presiede” al Vergangenheitscharakter der Kunst, al ‘carattere di passato proprio dell’arte’ che lì si annuncia, volgarmente interpretato come “morte dell’arte”. Questo e non altro significa in Hegel poi in Hei
degger lo storicizzarsi evenemenziale della verità, il fatto cioè che la verità si fa evento', significa che essa neanche sa rebbe pensabile se non si trasponesse, se non si manifestasse (ma seguendo, questo il punto, la sua intima, dialettica ne cessità) nelle forme dell’apparenza sensibile come suo pro prio momento negativo -un momento in cui certo permane una dimensione originaria di nascondimento e di latenza— senza il quale resterebbe improduttivamente, nichilisticamente “autistica”. Il vero, al contrario, consiste precisamen te nel poter prodursi, nel poter essere tratto-fuori (su questo Heidegger ne L’origine dell’opera d’arte è chiarissimo fino alla lettera) dalla insondabile identità con sé stessa per stori
cizzarsi in quanto evento, per ac-cadere nell’esistente. Uno dei modi e dei luoghi esemplari della storidzzazione evene menziale della verità è l’arte. Tutto questo Malevic lo sa. Lo sa da pittore e da pensato re. Sa perfettamente di dover inventare lo “stato estetico”
148 E questo il versante “positivo" del linguaggio e del fare, è questa la para dossale dicibilità-visibilità dell'indicibile-invisibile declinata nei polimorfi dialetti artistici modemo-contemporanei, cfr. il ns. Il Sublime è Ora, Castelvecchi, Roma 1993.
143
dell’inoggettività. Di nuovo: sa perfettamente, al pari dell’ar tista zen, che non si può evocare il nulla semplicemente nul la dipingendo. Tutte le opere suprematiste Io testimoniano. Il Quadrato, il Cerchio, la Croce. Forme regolari, geometri che, primarie, “noetiche”. Forme “mentali”, certo. E tutta via dipinte, raffigurate: incarnate. E che, proprio per questo, possono mantenere-mostrare solo il ricordo della loro astrat ta, categoriale normatività, della loro deducibilità ideale, pu ramente logico-geometrica. E lo mantengono proprio attra verso l’imprecisione fenomenica dell’immagine concreta mente intuibile, costruita -e non “composta”- nella contin genza della materia pittorica. Nessun algido geometrismo. La geometria è semmai restituita sotto forma di permanente squilibrio, di catastrofe perpetuamente imminente. La co struzione pittorica non è mai automatica estrinsecazione-de duzione da una legge trascendente, non è garantita da alcun assioma. È una processualità che accetta lo scarto e l’imprevedibilità all’interno di una dimensione di controllo, di vigi lanza razionale. I bracci della Croce sono diversi per gran dezza l’uno dall'altro; il Cerchio è “attratto” dall’angolo in alto a destra. Malevic chiamava Quadrangolo (chetyreuvol’nik} il Quadrato nero proprio allo scopo di sottolineare che in realtà non si tratta di una figura geometrica regolare poiché non presenta parallele né angoli retti né lati di ugua
le lunghezza. Nella sua prima versione, la forma è legger mente divergente-asimmetrica rispetto ai bordi della tela; il colore (con il quale, come già sappiamo, Malevic coprì un quadro precedente) non è steso in maniera perfettamente uniforme e il ductus pittorico lascia percepibili i movimenti della mano. Nella seconda versione del Quadrato nero i bor
di bianchi ai lati sono più stretti, il quadrangolo è più rigido rispetto alla prima versione e si avvicina maggiormente all’ortogonalità della figura geometrica “ideale”. Nella terza versione l’angolo sinistro in alto si allunga in una leggera cu spide. In nessuna delle tre versioni si riscontra la medesima proporzione tra le aree occupare dal bianco e dal nero. Il Quadrato rosso (realismo pittorico di una contadina a due di
144
menzioni) non è affatto un quadrato ma un quadrilatero con una vistosa cuspide a destra in alto, e nella straordinaria co stellazione degli Otto rettangoli rossi, il più lungo è netta mente in disasse rispetto agli altri più piccoli, che peraltro si sviluppano sì tutti in diagonale ma non parallelamente tra loro. In tutte le opere suprematiste l’equilibrio delle masse di colore puro risulta estremamente rigoroso sebbene non sia mai statico ma cinetico-dinamico, e si costruisce autonoma mente, in modo indipendente, da una norma compositiva aprioristica che ne ordinerebbe la complessità. Evidente è l’imperfetta stabilizzazione della forma: geometricamente imprecisa, oscillante, asimmetrica, sbilenca nei contorni, in decisa negli assi direzionali che, paralleli o perpendicolari, non sono mai perfettamente ortogonali gli uni rispetto agli
altri. H colore non è mai steso in modo piatto e meccanico, il valore cromatico viene variato attraverso un ductus pittorico sottilmente cangiante, la testura è vibratile, intensamente pittorica. Spesso sono visibili i tocchi di colore sovrapposti (dei quali la riproduzione fotografica solitamente non resti tuisce quasi nulla) contrariamente a quanto potrebbe pen sarsi dato l’apparente minimalismo geometrico delle opere. Qual è il senso e la condizione di questo stato estetico con il quale l’invisibile si offre nel visibile, se non il passaggio ne cessario attraverso lo “strame” cusaniano che però è “latte che nutre”, attraverso le forme sensibilmente intuibili come unico rapporto possibile con l’inoggettivo, con il nulla da ri conquistare, liberare e svelare? Passaggio che è condanna e dramma, ma insieme unica risorsa, ombra che è via alla tene bra luminosa.
145
TAVOLE A COLORI
Attraverso un intreccio tra appartenenza e discontinuità, memoria e oblìo, conte sto e modificazione, il Quadrato nero, 1’“infante regale”, segna una rottura irrever sibile con la storia della pittura e insieme un “commento” alla secolare tradizione dell’icona, che viene trascritta e inscritta nella sua stessa concezione originaria. Esso indica quella presenza del niente rivelata dalla luce nera -luce risalente cioè verso la propria fonte- che occorre figurare, al di là di ogni malintesa iconoclastia che scompone l’antinomia su cui si fonda l’icona. Il formato quadrangolare è onni presente nella pittura sacra del cristianesimo orientale, e néWAccoglienza dell'icona della Madre di Dio di Vladimir compare nella sua letteralità visiva un “identico” quadrato nero. Come l’icona ha la funzione protrettica di assecondare e stimolare nel fedele lo sforzo aSCimitatio Christi incarnando con la propria condotta di vita la somiglianza con il Prototipo, a farsi insomma, per quanto possibile, “icona di Cristo”, così l'ultima icona del Quadrato nero —nella sua solenne e asseverativa con cisione fonte di meditazione spirituale- prepara, induce, avvia verso l’esperienza di ciò che non appare. Nell’identità di forma, luce e colore, il piano-superficie del Quadrato bianco bascula asimmetrico nel bianco, e soltanto una piega bianca nel bianco fa la differenza; soltanto un solco di nulla, un’inflessione neutra sospesa e illocalizzabile tra il movimento e la quiete conferisce visibilità all’invisibile. Al di là del Quadrato bianco non poteva esserci che la conquista dello spazio reale con gli architektony o planiti, costruzioni plastiche bianche che aggregano componendole a varie altezze forme non oggettive la cui matrice è il cubo, slanciate sulla verticale oppure distese in orizzontale: plastici ideali delle abitazioni che gli zemljaniti —i futuri ‘inquilini della Terra’ nel conio zaunt di Malevic- potranno utilizzare una volta che ne adeguino la struttura alle loro specifiche necessità vitali.
1. Quadrangolo nero, 1915 (datato sul retro 1913)
2.
Accoglienza dellicona della Madre di Dio di Vladimir
i. 0,10 Ultima mostra futurista, 1915
4.
Trittico di Seti
5.
Van Teodoro straniate con scene iella vita
6.
Quadrangolo nero (versione del 192 3, datato sul retro 1913)
7- Quadrato bianco, 1918
8.
Architekion. anni Venti
9.
K.M. composto nella camera ardente con Quadrangolo nero e bara suprematista, 1955
La vis architettonica spesso presente nelle icone esprime la prevalenza dell’univer sale sull’individuale e del necessario sul contingente. I motivi geometrici -e certo altamente simbolici nella pittura sacra— del cerchio e soprattutto della croce sono costantemente presenti nell’iconografia ortodossa e ossessivamente ricorrenti nei dipinti e nei disegni di Malevic dal 1915 in poi. L’ascendenza iconologica del secon do motivo si ritrova nelle croci nere sulle stole candide dei santi e dei Padri teologi, la cui natura ornamentale è confermata dal fatto che non seguono plasticamente le pieghe del panneggio su cui sono impresse. Il Cerchio di Malevic è come attratto dall’angolo in alto a destra, esattamente come il medaglione circolare con l’angelo della Madre di Dio Grande Panagija. Talvolta, come nel Giovanni Crisostomo o nel Salvatore acheropita (e anche se in modo diverso nella stupenda composizione qua si en ahimè di rombi e ovali del Salvatore tra le potenze) croce e cerchio formano un unico insieme geometrico. Così, in un dipinto del 1921 la croce rossa si distende allungandosi sul cerchio nero, e in un altro precedente della fase bianca, il piano che fluttua ascendendo in diagonale è attraversato da tre elementi curvilinei -di cui due raggiungono quasi la forma a semicerchio- che si sovrappongono a evocare quasi la doppia croce ortodossa.
10. San Basilio, San Gregorio Teologo, San Cirillo d"Alexandria
11.
Suprematismo, 1915-1916
12.
La glorificazione delia Croce
13.
Suprematismo, 1921-1927
14.
Croccinone
15.
Parasceve Pjotnia e i Santi Gregprio il Teologo, Giovanni Crisostomo, Basilio il Grande
16.
Croce nera
17.
Giovanni Crisostomo
18.
Suprrmatismo, 1921
19.
falciatore acheropita
20.
Deem: Salvatore tra le poterne
21.
Suprematismo, 1918
22.
MuJrediDio Grande Panagija Orante di Jaroslav!’, particolare
23.
Cerchio nero, 1915
Solo con i restauri dei primi anni del Novecento, il mito della “tenebrosa icona” si è dissolto, la fuliggine e il nerofumo che ricoprivano le opere furono eliminati e si scoprì quella straordinaria vivacità e brillantezza cromatica vicina a una sorta di mistica solare (l’ombra e il chiaroscuro sono ignorati) che non è in contraddizione con l’ascetismo cui l’icona richiama, poiché non c’è resurrezione senza la morte del corpo: l’evento pasquale è uno con lo strazio della croce. Nel periodo del primi tivismo cubofuturista e in quello del suprematismo dinamico, all’insieme croma tico -soprattutto giallo, verde e rosso, ma anche arancio, scarlatto, vinaccia, blu oltremarino- manca soltanto il diapason dell’oro (che non è un colore ma un me tallo di luce pura che può riferirsi unicamente alla divinità) per ricordare da vicino il ritmo musicale dei colori (molti iconografi erano anche cantori di chiesa), che nell’icona sono sempre utilizzati in modo simbolico per indirizzarli allo spirituale, all’ultraterreno. Il rosso, perla sua forza irradiante generatrice di energia, è talvolta usato per lo sfondo dell’icona in sostituzione dell’oro. Il Quadrato rosso, con la sua cuspide che si appuntisce salendo a destra, sembra “trascrivere” sia il moto ascen sionale dei bulbi dorati delle chiese ortodosse, sia, soprattutto, la fiamma ardente dentro la quale Elia, su «un carro di fuoco con cavalli di fuoco» (2Re2,ll), viene rapito in cielo. Il giallo vivido, acceso, intensamente luminoso che pervade molte icone (straordinario quello della Theotokos di Vladimir) viene “ricordato” nello supefacente trapezoide sospeso sull’abisso bianco che, nel suo percorso astrale li bero dalla gravità, sembra dissolversi per trasformare la sua massa di nuovo in pura energia, tornando così al suo stato quintessenziale.
24. Presentazione al Tempio
25. Taglialegna, 1912-1913
>>■
fir
26. Suprematismo, 1915
11. Ascensione
■ X '* ' •
28.
Salvatore in trono am Santi
29.
Ascensione del profeta Elia sul carro di fuoco
30.
Quadrato rosa. Realismo pittorico di contadina a due dimeniioni
31.
Kirill di &dooiero
Ì2. Crocifissione con medaglioni di santi e angeli nella camice
33. Tbeotokoi £ Vladimir
54. Pittura suprematista (Quadrato gjalio), 1917-1918
La diagonale simboleggia una dinamica di ascensione. Il sarcofago presso il quale sostano le pie donne ha una forma rettangolare obliqua proprio come le superfici-piano di Malevic. Forma che è echeggiata in parte nei costoni della montagna (che si ritrovano molto simili nelle rocce della Natività di Cristo con Santi scelti) alle spalle dell’angelo seduto sul sepolcro vuoto in cui restano solo le fasce funebri La composizione de Le ntirofore al Sepolcro è impostata su una diagonale che sale verso destra come la Scala del Paradiso, con una studiata ed equilibratissima ascen sione che si ritrova negli Otto rettangoli rossi e in Aereo in volo, “costellazioni” di straordinaria, potente icasticità. Nel primo, il rettangolo più grande è nettamente in disasse rispetto agli altri di minori dimensioni, che si dispongono sì tutti in dia gonale ma non parallelamente tra loro. Nel secondo -con il titolo che incoraggia l’evocazione mimetica sia pure limitata ad una larvale stenografia- la composizione è più complessa in ragione delle due sbarre rosse orizzontali in alto che fanno da contrappunto al vettore diagonale dell’insieme. Le linee oblique e angolari -simili agli spigoli vivi della voragine infernale che si spalanca sotto i piedi del Redentore nella Discesa agli inferi- si ripresentano nella loro durezza cristalliforme e nella loro asperità stalagmitica sulle pieghe della veste del Cristo della Deesis.
35. Mirofore al Sepolcro
36.
Discesa agli inferi
ÌÌ7. Otto rettangoli misi, 1915
58. Natività Ji Cristo
39.
La scala del Paradiso
40.
Deens
41.
Aerro in volo, 1915
Nella fase post-suprematista dell’opera di Malevic, le “trascrizioni” dalla tradizio ne iconica russo-ortodossa si presentano più figurativamente evidenti. La sagoma morbida del velo sul capo di Maria -l’unico essere umano deificato— e dell’aureola che ne ripete la curvatura nella Madre di Dio della Tenerezza (del tipo iconografico deD’OdigZtotf Eleousa) si vede riecheggiata quasi letteralmente nella forma sinuosa del pettine e del colletto della casacca nella Fanciulla con pettine tra i capelli. Le due figure femminili di Malevic (l’una dalle sembianze riconoscibili, l’altra al limite del pittogramma) -così come numerose altre dello stesso periodo post-suprematista- sono com posizioni a figurazione binaria di ieratica ma solo apparente sempli cità, esattamente come i loro “modelli” iconografici. In questi ritratti, le due metà dell’intero diviso longitudinalmente si interconnettono attraverso echi e richiami grafici, lineari e cromatici in un mirabile ritmo contrappuntistico che fissa l’asim metrico equilibrio tra le due parti. Analogo sviluppo armonico nella Madre di Dio della Tolga, dove le campiture di colore (il porpora, il rosso, il verde) corrisponden ti al manto di Maria e alla veste del Bambino —che sembrano fondersi l’un l’altro in un intreccio insieme genitoriale e spirituale- si alternano richiamandosi a vicenda in un sontuoso, cadenzato ritmo sia cromatico sia lineare.
42. Madre di Dio della Tenerezza
43.
Fanciulla con petiine tra i capelli, 1932-1933
44.
Granile icona della Madre di Dio della Tolga
45.
Busto femminile, 1928 circa
46.
Busta femminile (Figura am volto rosa), 1928 circa
Apparentemente, in questo accostamento, il vuoto si confronta con il pieno, l’as senza con la presenza. In realtà, da una parte, si manifesta la presenza del nulla, la capacità produttiva dell’invisibile che si rivela sensibilmente nel Nero e nel Bianco; dall’altra, assistiamo alla ripetizione simulacrale di un originale assente, alla ripro duzione di un prototipo fantasmatico dimentica perfino di aver dimenticato la dif ferenza tra apparenza e reale. Da una parte l’assenza che si fa presente; dall’altra, l’eccesso di presenza che annichila sé stesso. In Malevic, la dissoluzione dell’imma gine produce l’icona dell’infigurabile e dell’inapparenza che si rivela; in Warhol, l’immagine seriale dissolve svuotandola di senso l’icona creata dal corpo-merce. Il primo allestisce una vera e propria iconologìa dell’ascesi aniconica-, il secondo esemplifica perfettamente il paradosso secondo cui l’immagine non è altro che la memoria dell'iconoclastia come sua origine.
47. Malevic, Quadrato nero — Warhol, Marilyn