Le sonate per pianoforte di Beethoven 8834015320, 9788834015322
Composte sia per l'esecuzione privata, sia per le sale da concerto, le trentadue sonate per pianoforte costituiscon
123 113 18MB
Italian Pages 332 [284] Year 2008
Polecaj historie
Citation preview
ADAGIO
«Adagio» COLLANA DI STUDI MUSICALI
LE SONATE PER PIANOFORTE
DI BEETHOVEN
di Charles Rosen
Titolo originale dell’opera: BEETHOVEN’S PIANO SONATAS A SHORT COMPANION
(Yale University Press, New Haven and London)
Traduzione e cura di Enrico Maria Polimanti
© 2002, Charles Rosen © 2008, Casa Editrice Astrolabio - Ubaldini Editore, Roma Questo libro è staro pubblicato con il contributo del
Campus Internazionale di Musica di Latina
«Adagio» COLLANA DI STUDI MUSICALI
Charles Rosen
LE
SONATE PER
PIANOFORTE DI
BEETHOVEN a cura di
Enrico Maria Polimanti
ROMA
ASTROLABIO MMVIII
Agli studenti di pianoforte della scuola estiva del Festival Fontino a Sermoneta
Prefazione
Questo libro nasce dall’invito del Festival Pontino a eseguire tutte le sonate per pianoforte di Beethoven e a tenere dei seminari su di esse per i corsi estivi che si svolgono al castello Caetani di Sermoneta. Dover parlare, o scrivere, di argomenti musicalmente rilevanti, come ad esempio le questioni di tempo, sen za avere la possibilità di effettuare delle dimostrazioni pratiche è piuttosto fru strante. Per questa ragione la direzione del Festival Pontino e quella dell’istitu to di Studi Musicali “Goffredo Petrassi” mi hanno proposto di registrare degli esempi musicali utilizzando il bel pianoforte che si trova ancora presso la villa Caetani negli splendidi giardini di Ninfa. E un Bechstein del 1879, ammirato da Liszt, la cui cassa armonica produce ancora un magnifico suono con un tempo di decadenza considerevolmente lungo, quello che idealmente ogni pia noforte dovrebbe avere. Rispetto alla maggior parte degli strumenti moderni la sua sonorità è più simile a quella di un pianoforte del 1810, e io son sempre stato convinto che per eseguire una musica la quale, introducendo un nuovo stile, abbia dato impulso alla costruzione di nuovi strumenti, tali strumenti spesso funzionino molto meglio degli strumenti, meno adeguati, di cui dispo neva l’autore. (Ciò non significa che io abbia mai trovato uno strumento per fettamente adeguato alla musica di Beethoven). E un libro eminentemente pratico, vuole essere una guida per ascoltatori e per esecutori a diversi aspetti delle sonate per pianoforte di Beethoven oggi non sempre ben compresi. Non è il tentativo di dire a chicchessia come queste sonate vadano eseguite. Ho sempre sottolineato, e lo faccio qui nuovamente, che la libertà è indispensabile perché ci sia interpretazione, una libertà che lo stesso Beethoven prevedeva, anche se probabilmente sarebbe molto sorpreso da alcune sue manifestazioni odierne, così come lo fu per certe esecuzioni di suoi contemporanei. Ci sono spesso buone ragioni per disattendere le intenzio ni di un compositore, ma non ce n’è alcuna per non cercare di scoprire quali fossero, o per non accertare cosa i segni sulla carta significassero per lui, anche laddove non li usasse in modo del tutto coerente, e anche quando egli, come chiunque, manifestasse in certi casi una propensione all’errore. Comunque suppongo sia inevitabile che i miei pregiudizi personali influiscano su questa trattazione. Soprattutto, questo libro non vuole cercare di costringere pubblico ed ese cutori a quel tipo di apprezzamento delle sonate che dovrebbe piuttosto nasce-
8 Prefazione
re direttamente dall’ascolto. Ho sempre disprezzato i testi di critica musicale che cercano di mettere al posto della musica una specie di pseudopoesia o, peggio, un tipo di speculazione filosofica dozzinale che induca nel lettore la convinzione che ascoltando Beethoven sarà coinvolto in un’attività esaltante (se addirittura non è già abbastanza esaltante la mera lettura del testo). Certo, è indubbio che con la sua musica Beethoven spesso intendesse raggiungere le vette del sublime e che secondo lui la grande musica trascendesse le esperien ze quotidiane della nostra semplice esistenza. Tradurre in parole questa tra scendenza, però, non la rende più accessibile, ma solo più prosaica. L’estasi prodotta dalla musica arriva soprattutto tramite quell’attenzione decentrata a ciò che ascoltiamo o suoniamo che per un momento ci fa uscire da noi stessi e ci fa perdere nell’opera. La musica di Beethoven richiedeva imperiosamente, e tuttora richiede, un livello di attenzione più intenso di quello che qualsiasi al tro compositore avesse mai osato chiedere, anche se poi tutti i musicisti che lo hanno preceduto o seguito hanno goduto i frutti della sua intransigenza. Es senzialmente, con queste pagine ho cercato di rendere più agevole raggiungere quel tipo di attenzione. La maggioranza degli esempi musicali riprodotti provengono da edizioni pubblicate mentre Beethoven era in vita, dunque il loro impianto tipografico è necessariamente disuguale. *
Sono grato anzitutto per il loro aiuto al professor Raffaele Pozzi, dell’istituto di Studi Musicali “Goffredo Petrassi” di Latina, e all’architetto Riccardo Cerocchi, presidente e coordinatore artistico del Campus Internazionale di Musi ca; per l’aiuto e l’incoraggiamento, a Robert Baldock, Malcolm Gerrat e Kevin Brown della Yale University Press. Anche il signor Giulio Cesare Ricci della Fonò, che ha curato la registrazione del cd, è stato di grande ausilio. Sono moltissimi gli amici e colleghi, troppi per essere elencati qui, che nel corso de gli anni mi hanno aiutato a comprendere le sonate per pianoforte di Beetho ven, ma se non altro devo fare menzione delle preziosissime conversazioni che ho avuto con sir Charles Mackerras intorno alla prassi esecutiva della musica del diciottesimo secolo. Devo anche ringraziare la professoressa Pristina Muxfeldt della Yale University per tutto il suo aiuto, il professor Walter Frisch del la Columbia University e il professor Lewis Lockwood di Havard per i suoi preziosi consigli e la sua gentilezza.
Parte prima
La tradizione
Introduzione
La nonna di Proust era una donna di modi estremamente modesti e semplici, che non avrebbe mai osato contraddire chicchessia in fatto di letteratura: Mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sena tes de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d’avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s’en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d’ailleurs, la perfection était presque la méme: c’était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu’on mìt des épices dans les plats qui n’en exigent pas absolument, qu’on jouàt avec affecta tion et abus de pedales, qu’en ‘recevant’ on sortir d’un naturel parfait et parlar de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, a un vrai musicien, à une femme bien élevée. “Elle peut avoir beacoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goùt en jouant avec tant d’emphase cet andante si simple”. [...] “Ce peut étre une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le bifteck aux pommes”. Le bifteck aux pommes! Morceau de concours idéal diffi cile par sa simplicité méme, sorte de sonate “Pathétique” de la cuisine.1
1 “Ma su quelle cose le cui regole e i cui principi le erano stati insegnati dalla madre, sul modo di cucinare certi piatti, di suonare le sonate di Beethoven e di ricevere con amabili tà, era sicura di avere un’idea corretta della perfezione e di saper discernere quanto gli altri vi si avvicinassero o no. Del resto, per tutte e tre le cose la perfezione era quasi la stessa: una sorta di semplicità dei mezzi, di sobrietà e di charme. Rifiutava con orrore che si aggiun gessero spezie in un cibo che non ne richiedeva alcuna, che si suonasse con affettazione e con troppo pedale, che nel ricevere ospiti si abbandonasse la perfetta naturalezza e si par lasse troppo di sé. Aveva la pretesa di sapere, già dal primo boccone, dalla prima nota, da un solo biglietto, se aveva davanti una buona cuoca, un vero musicista o una donna ben educata. «Avrà pure le dita molto migliori delle mie, ma se suona con tanta enfasi un andan te così semplice manca di gusto». [...] «Sarà anche una cuoca molto raffinata, ma non sa fare una bistecca con patate». Bistecca con patate! La pietra di paragone ideale, difficile in virtù della sua semplicità, una sorta di sonata ‘Pathetique’ della gastronomia”. “Journées de Lecture”, pp. 162-163, *n Cantre Sainte-Beuve (précédé de Pastiches et mélanges), Gallimard, Paris 1970.
12 Parte prima: la tradizione
La commedia di Proust colloca le sonate per pianoforte di Beethoven al posto che spetta loro, in quanto profondamente rappresentantive della cultura occi dentale nell’ambito familiare dell’alta borghesia, dal 1850 fin quasi ai nostri giorni, e in quanto parte della vita sociale civilizzata insieme all’intrattenimen to degli ospiti e ai pasti familiari. La grande pittura veniva ammirata nei musei. La lettura della poesia e dei romanzi era generalmente un’attività individuale più che essere svolta con gli altri membri della famiglia; il teatro e la danza esi stevano solo al di fuori delle abitazioni e così pure la musica sinfonica e l’ope ra lirica. Per i bambini appartenenti a una classe sociale agiata, però, lo studio del pianoforte era secondo, anche se a volte a grande distanza, solo all’appren dimento della lettura. In special modo per le fanciulle, saper suonare il piano forte era essenziale per la loro autostima, era un’affermazione del loro posto nella società. Per quanto riguarda il far musica in casa, le sonate di Beethoven erano il più prestigioso esempio di musica colta. A eccezione del Clavicembalo ben tempe rato, le opere di tutti gli altri compositori apparivano leggere al confronto, e Bach era troppo accademico e dotto per rivaleggiare con la drammaticità e il pathos della sonata beethoveniana. Ancor più che il quartetto d’archi, la sona ta costituiva, con poche eccezioni, la sfera d’interesse del musicista dilettante. Potremmo dunque invertire la metafora di Proust: le sonate per pianoforte di Beethoven erano la ‘bistecca con patate’ della musica colta, la dimostrazione che si poteva accedere in casa propria ai più grandi capolavori della musica. Esse erano anche un ponte tra la musica suonata in casa e quella eseguita nelle sale da concerto; erano parte essenziale di un programma di recital che volesse essere considerato serio, un modo, per il pianista professionista, di mostrare che ambiva ai massimi livelli della cultura musicale. Non c’era trac cia di ruffianeria nel mettere in programma sonate di Beethoven; non veniva no usate, o per lo meno si pensava che non avrebbero dovuto essere usate, per stupire l’ascoltatore con uno sfoggio di tecnica esecutiva, e non tradivano nulla di quel carattere deplorevolmente morboso ed effeminato presente nelle opere dei grandi compositori romantici: Chopin, Schubert, Mendelsshon e Schu mann. Esprimevano al tempo stesso gravità, passione e umorismo. Garantiva no il contatto col sublime. Inoltre erano opere che si proiettavano verso il futuro. Con tutta la loro ‘classicità’, mantenevano qualcosa del carattere controverso che aveva inaugu rato il loro primo apparire al pubblico. Ancora all’inizio del ventesimo secolo, il più famoso insegnante di pianoforte di Vienna, Theodor Leschetizky (tra i cui allievi si annoverano Artur Schnabel, Ignaz Paderewski e Ossip Gabri lovich) sconsigliava ai suoi studenti di eseguire le ultime sonate. Tra tutti i lavo ri di Beethoven solo gli ultimi quartetti erano altrettanto sconcertanti per gli ascoltatori. Paradossalmente queste sonate restarono un modello per i compo sitori d’avanguardia anche quando erano diventate un modello per i critici conservatori. Ancora oggi possono tanto stimolare la sperimentazione e l’ori ginalità creativa quanto incoraggiare l’intransigenza.
Introduzione
13
La doppia natura, pubblica e privata, di queste sonate è l’essenza del loro ruolo nella storia della musica. Esse non solo ubbidirono ai radicali cambia menti delle relazioni tra musica e società, ma contribuirono a produrli. Quasi nessuno di questi lavori venne eseguito pubblicamente a Vienna mentre Beethoven era in vita. La tradizione musicale viennese può anche aver creato il primo stile di musica puramente strumentale destinato a sopravvivere nella storia dell’occidente, ma la città era ancora molto arretrata nell’istituzione di concerti pubblici; non dico concerti per bande o performance libere all’aper to, ma concerti di musica strumentale con biglietti a pagamento, un’istituzio ne commerciale fondamentale per lo sviluppo della pratica musicale come la conosciamo noi oggi, che sostituì il patrocinio della corte e della chiesa nel modo di guadagnarsi da vivere dei musicisti. All’inizio del diciottesimo secolo, ben prima di Vienna, Londra e Parigi avevano già un florido e ben sviluppato sistema di concerti pubblici. Perfino New York era più avanti della città asbur gica. E come gli acquedotti più antichi si trovano nei paesi che sono stati tra i primi a dotarsene, mentre quelli dei paesi meno avanzati, che non poterono permetterseli se non molto più tardi, sono i più moderni e aggiornati, così Vienna, dove il concerto pubblico tardava ad affermarsi rispetto ad altre capi tali europee, con l’arrivo di Haydn produsse i più efficienti, moderni ed effica ci esempi di composizioni create per questa nuova forma di fruizione della musica strumentale. Ciò che rese possibile questo risultato, però, fu una ricca tradizione nel far musica in forma privata o semiprivata. La Ylausmusik, o musica da suonarsi in casa, era molto diffusa e lo erano anche i concerti privati in cui si eseguivano quartetti, sonate e lieder per piccoli gruppi (da dodici a venti persone) di amici e di ospiti, sia nelle famiglie aristocratiche che in quelle della borghesia bene stante. Questa fu la culla in cui dovevano nascere e giungere a maturità i lieder romantici di Schubert. Le principesse Esterhàzy studiavano le sonate e i trii di Haydn e l’arciduca Rodolfo d’Austria fu uno degli allievi più famosi di Beethoven. La vendita di spartiti musicali al pubblico generico era un cespite sempre più significativo per il tentativo (solo in parte riuscito) dei composito ri di affrancarsi dal patrocinio e dalla dipendenza dall’aristocrazia. Le sonate per piano di Beethoven potrebbero essere state concepite sostan zialmente come lavori destinati all’esecuzione privata o semiprivata, pur se il compositore stesso era un virtuoso del pianoforte e godeva di considerevole reputazione. Seguendo l’esempio di Mozart, egli introdusse in quella che era essenzialmente musica privata le difficoltà e lo sfoggio di virtuosismo che appartenevano alla musica pubblica: i quartetti con pianoforte di Mozart, che assomigliano a tratti a veri e propri concerti solistici, insieme ad alcune delle sonate pianistiche, come quella in do minore, ne sono il più fulgido esempio (l’editore annullò la commissione originaria di un gruppo di sei perché i primi due erano troppo difficili per i dilettanti e quindi non si vendevano). La sona ta in si bemolle maggiore k. 333 ha addirittura un finale in forma di rondò di concerto e imita l’alternanza di passaggi tra solista e tutti. Beethoven mostrò
14 Parte prima: la tradizione
una considerazione ancora minore per i dilettanti, oltreché, come è noto, per l’agio e la comodità dei professionisti. Le sue sonate ‘facili’, come l’op. 79 in sol maggiore, spesso sono una sfida anche per l’esecutore più preparato, e nella prima sonata matura che pubblicò prescriveva espressamente una diteggiatu ra che, rispetto a quella che ancor oggi la maggior parte dei pianisti adotta e gli editori suggeriscono, rende la musica più difficile da eseguire, ma molto più efficace (si vedano le battute 84-85 del primo movimento dell’op. 2 n. 2 in la maggiore: perfino il suo allievo Czerny consigliava una diteggiatura più agevo le). Ben presto ci si accorse di quanto la sua musica per pianoforte fosse adat ta all’esecuzione in pubblico. Le sonate di Beethoven costituirono il primo cospicuo corpo di lavori importanti per piano che si prestavano a essere suo nati in grandi sale da concerto con centinaia di posti a sedere. Dopo che Liszt ebbe inventato, dieci anni dopo la morte di Beethoven, il recital pianistico, queste sonate gradualmente divennero la base del repertorio di ogni pianista che ambisse a un certo rango professionale. Nonostante ciò, per tutto il diciannovesùno secolo le fondamenta della cul tura musicale restarono nella sfera privata. In un articolo del 1802 sulla Allgemeine musikalische Zeitung, “I virtuosi in tournée” (Uber reisende Virtuosen), il critico Johann Karl Friederich Triest sottolineava che un concer to pubblico di un provetto esecutore era utile soprattutto come stimolo e ispi razione per molti dilettanti a elevarsi al di sopra della loro pigrizia e mediocri tà. Triest era il critico musicale più interessante e brillante dell’epoca, e le sue osservazioni sulle difficoltà che un virtuoso doveva sopportare nei suoi viaggi in tournée sono esattamente contemporanee alla composizione delle sonate di Beethoven dell’op. 31. In esse è implicita l’importanza preponderante dei musicisti dilettanti, che costituivano la maggioranza degli ascoltatori in un con certo pubblico. All’inizio del diciottesimo secolo, il concerto del professioni sta in grandi sale era relativamente raro, era un modo fuori dal comune di fare musica; di regola, la musica era eseguita in residenze private o a casa. Anche il virtuoso in tournée, secondo Triest, doveva essere munito di una lista di indi rizzi e raccomandazioni varie per poter essere invitato a esibirsi in quelle matinées e soirées così importanti nella vita musicale. Il repertorio pianistico fornito da Beethoven con le sue sonate fu una delle principali cause dello spostamento dell’attività musicale dalle abitazioni alle sale pubbliche. Sebbene create per circostanze più intime, molte di queste sembravano meravigliosamente adatte all’esecuzione dei virtuosi nei grandi ambienti. Alcune di quelle giovanili presentavano già difficoltà problematiche per il dilettante medio, ma gli ostacoli tecnici divennero ancora più ardui da superare con la “Waldstein”, 1’“Appassionata” e “Les adieux”. Più tardi la “Hammerklavier”, l’op. 106, sembrò escludere completamente i non profes sionisti. “A Vienna c’è una signora” raccontava Czerny a Beethoven “che stu dia da un mese la vostra sonata in si bemolle e ancora non riesce a suonarne neanche l’inizio”. Tuttavia molte delle sonate rimanevano alla portata dei dilet tanti che potevano comunque cavarne qualcosa; anzi, proprio la loro difficol
Introduzione
15
tà procurava un senso di contatto, per esile che fosse, col mondo del profes sionismo che non si poteva ricavare da nessun altro gruppo di opere colte. Esse erano una sfida da accettare, un ideale a cui aspirare, anche se alla fine poteva no rivelarsi impossibili da padroneggiare pienamente perfino, come rimarcava Artur Schnabel, per il professionista consumato: “Non c’è esecuzione di una sonata di Beethoven”, dichiarava, “che possa essere all’altezza dell’opera stes sa”. La musica per pianoforte dei maggiori compositori romantici, Chopin e Schumann, non assurse mai alla gloria del sublime elevato toccata a quella di Beethoven. Fino alla seconda metà del ventesimo secolo, essendo divenuti sempre più frequenti i recital pianistici, l’appassionato di musica medio si familiarizzava a casa con molte delle sonate, stimolato dall’ascolto occasionale di (più o meno) grandi esecuzioni pubbliche. Solo quando la grande diffusio ne della musica registrata spodestò la pratica tradizionale di fare musica in famiglia le sonate di Beethoven persero quel loro status speciale nel quale gli interessi dei dilettanti e dei professionisti erano stati uniti.
Principi formali
Quasi tutti i possibili lettori di questo libro penseranno di sapere cosa sia una forma sonata, e a ragione (un minimo di cultura musicale o di semplice interes se per la musica comprenderà quest’informazione). È dubbio, però, che Bee thoven avrebbe fatto un’affermazione del genere, o addirittura che l’avrebbe compresa. Non è solo che a quell’epoca si poteva scrivere una composizione chiamandola ‘sonata’ senza che nessuno dei suoi movimenti fosse costruito se condo quella che più tardi avremmo definito appunto forma sonata. È anche che Beethoven non possedeva la definizione di forma sonata standard general mente accettata,1 bensì una serie di modelli che poteva seguire o da cui poteva discostarsi: le deviazioni ovviamente erano limitate da quelle che si potrebbero chiamare le regole della grammatica musicale, più o meno consapevolmente comprese dai musicisti dell’epoca, regole che Beethoven avrebbe allargato e forzato considerevolmente per il disappunto, e più tardi per l’ammirazione, dei suoi contemporanei. Elencherò adesso brevemente alcune caratteristiche dei modelli con cui il compositore lavorava, che in gran parte caddero nell’oblio durante il dicianno vesimo secolo. Per l’esposizione di una sonata c’erano due modelli: i) Un modello bipartito con una semicadenza sul quinto grado della domi nante prima della seconda parte, che è interamente alla dominante, con diversi temi nuovi e passaggi decorativi di natura cadenzale alla fine. Questo era il mo dello che Mozart preferiva. 1 Alcuni teorici a lui contemporanei, fra i quali principalmente Heinrich Christoph Koch, descrivevano quella che secondo loro era la maniera migliore di comporre un movimento sinfonico; in generale basavano il loro giudizio sui modelli che ritenevano più adatti a esse re imitati. Questi teorici non indicavano, però, né i principi che plasmavano la forma né, soprattutto, quelli che permettevano di introdurre elementi sorprendenti fuori dal comune. Perfino un compositore di modesto talento avrebbe sperato di stupire grazie alla sua origi nalità, ma le più estreme deviazioni dai modelli comunemente accettati erano guidate, quan do ciò era fatto con competenza (nella storia e nell’estetica dobbiamo sempre contemplare la possibilità dell’incompetenza), da qualcosa che era ritenuto inerente alla natura della musica: il linguaggio musicale, come concepito alla fine del diciottesimo secolo. E. T. A. Hoffmann sosteneva che la superiorità di Beethoven derivasse dal fatto che qualsiasi cosa egli facesse, scaturiva dalla natura stessa della musica: alla parola ‘musica’ dovremmo sosti tuire l’espressione ‘tonalità basata sugli accordi di triade’.
Principiformali
17
2) Una forma tripartita, impiegata soprattutto da Haydn, come ha messo in luce Jens Peter Larsen. La sezione iniziale alla tonica, che presenta il tema principale, è relativamente breve. Il movimento verso il quinto grado viene compiuto in una sezione più lunga dallo sviluppo motivico considerevole; vi può apparire, alla dominante, il tema principale o una sua variante. Una breve terza sezione conclude l’esposizione con un tema cadenzale. Beethoven fa uso di entrambi questi schemi. Per l’apertura di una sezione di sviluppo c’erano diversi modelli. Dato che nell’esposizione la tensione era stata aumentata con il movimento alla domi nante, e poiché lo sviluppo l’avrebbe alimentata ulteriormente grazie a un più rapido ritmo armonico, talvolta si trovava utile, all’inizio di questa nuova sezio ne, fare un passo indietro per ridurre momentaneamente la tensione. Ciò si po teva ottenere con un breve ritorno alla tonica, una procedura antiquata, larga mente messa da parte dopo il 1770, di cui Beethoven, però, creò una variante nelle sonate n. 1 e 3 dell’op. 31. Un altro metodo era di virare verso la sottodo minante, sistema utilizzato da Beethoven nella sonata in re maggiore op. 28 e nella “Waldstein”, sebbene quest’ultimo caso sia più complicato in quanto l’esposizione termina non sulla dominante ma sul terzo grado. Per concludere la sezione di sviluppo di un movimento di sonata in modo maggiore c’erano almeno due modelli: 1) Lo sviluppo poteva finire con una cadenza nella tonalità relativa minore (vi grado), seguita da una transizione che riportava alla tonica. Quando questo procedimento divenne troppo scontato, la cadenza alla relativa minore fu spes so sostituita da una semicadenza sulla sua dominante (v del vi grado), che pro duceva un effetto più drammatico e inconsueto. Il ritorno alla tonica poteva poi giungere improvviso. A volte Mozart usava alcune versioni di questo pro cedimento; Haydn quasi sempre. 2) Il modello più sovente impiegato da Mozart conclude lo sviluppo alla to nica minore, con una transizione che riporta in modo maggiore. Beethoven preferiva lo schema di Mozart, ma usò la forma haydniana in al cune importanti opere, per esempio l’op. 28 e Top. 81a “Les adieux”. La ripresa richiedeva generalmente un qualche uso della sottodominante per neutralizzare la precedente polarizzazione dominante-tonica. L’uso regola re della sottodominante come parte essenziale del concetto di ripresa sparì quasi completamente nel diciannovesimo secolo e non fu riconosciuto dai teo rici, mentre, al contrario, nel Settecento faceva parte della teoria. Di norma la sottodominante ha un ruolo importante nella seconda parte delle fughe di Bach, e a quell’epoca la sua comparsa in quel punto della composizione era chiaramente intesa come un requisito della grammatica musicale. Nelle sonate c’erano due schemi per questo impiego della sottodominante: 1) Si introduce brevemente un’armonia sottodominante dopo il ritorno del tema principale alla tonica. In questo caso si evita una vera e propria cadenza al quarto grado. La nuova armonia può dare occasione a un momento dal ca rattere più espressivo o lirico.
18 Parte prima: la tradizione
2) La sottodominante può apparire subito prima dell’inizio della ripresa nel corso della transizione che riconduce alla tonica (per esempio nella sonata in la bemolle maggiore Hob. xvi/46 di Haydn, battute 75-76); oppure la ripresa può esser preceduta dal tema principale esposto sul quarto grado (per esempio nel quartetto di Haydn in mi bemolle maggiore op. 50 n. 3, battuta 62, dove si presenta come una falsa ripresa con intenti umoristici). Una variante a questo secondo sistema consiste semplicemente nell’iniziare la ripresa direttamente al la sottodominante, evitando in un primo momento la tonica, dato che questa ritorna da sé naturalmente se l’esposizione viene ripetuta tal quale trasposta una quinta sotto. D. F. Tovey considerava questa una forma ‘pigra’, e sicura mente fa risparmiare il tempo di ripensare l’esposizione. Mozart impiegò una volta questo metodo nella sonata facile in do maggiore k. 545, e Schubert varie volte, quando era molto giovane. Beethoven impiega di regola la prima soluzione. Si hanno eccezioni soprat tutto quando il primo tema inizia su un’armonia sottodominante. In questi ca si (op. 31 n. 3 e op. 8la), la comparsa della sottodominante è posticipata fino al la coda, dove assume un ruolo preminente: evidentemente per Beethoven l’im piego della sottodominante era parte essenziale del linguaggio musicale (nell’op. 10 n. 3 la colloca addirittura dopo la coda). I lavori in modo minore sono meno frequenti e più eccentrici di quelli in maggiore. Gli schemi dell’esposizione sono gli stessi, con il relativo maggiore al posto della dominante. Nelle sezioni di sviluppo, un arrivo alla dominante mi nore tramite una cadenza forte compare abbastanza spesso da poterlo conside rare un modello seguito da Beethoven. Spesso lo sviluppo inizia con la sotto dominante minore mentre alla fine l’interesse è concentrato sulla dominante minore: per esempio nella sonata in do minore Hob. xvi/20 di Haydn, e nella sinfonia in re minore op. 125. In ogni caso il cromatismo proprio del modo mi nore offre una più vasta varietà di procedimenti rispetto al più diatonico modo maggiore. *
La forma di minuetto è molto più rigida delle varie forme del primo movimen to, ma proprio giocando sulla sua rigidità il compositore può ottenere grandi effetti: ogni deviazione dalla struttura prestabilita risulta infatti di gran lunga più evidente. La parte principale di un minuetto, senza considerare il trio, è tradizional mente costituita da tre frasi: la prima è ripetuta e così anche, raggruppate in sieme, la seconda e terza frase. Che la prima termini sulla tonica o sulla domi nante dovrebbe fare una grande differenza, ma di fatto ciò non influisce sulla forma dell’intera struttura. Le tre frasi in genere sono di lunghezza uguale. Quando non lo sono, di solito è chiaro che il compositore ha interpolato qual cosa, e l’interpolazione opera come una plateale interruzione della forma atte sa. Haydn è un maestro nel manipolare in tal modo lo schema prestabilito;
Principiformali
19
spesso usa lunghe sospensioni armoniche che servono solo a far sì che l’ascol tatore stia in attesa del ritorno al modello noto. Nelle sue prime sonate Beetho ven adotta la tecnica di Haydn con grande abilità, e vi ritorna anche più tardi nell’ottava sinfonia, dove la struttura del minuetto è di semplice descrizione:
- frase i, battute 1-10, ripetute; - frase 2, battute 11-20; sospensione del movimento sulla sottodominante, batt. 20-24; - frase 3, (ripresa che partendo sul iv grado giunge al 1), batt. 25-36; coda, battute 36-44; ripetizione delle frasi 2 e 3 fino alla fine della coda. La forma base qui è quella tradizionale con tre frasi di uguale lunghezza, dove le battute in più sono percepibili come un’interruzione o come un prolunga mento. Questo è quanto si trova anche nei minuetti delle prime sonate di Bee thoven.
In un movimento lento ternario la prima parte si chiude con una cadenza sulla tonica. Almeno fino alla fine dell’op. 106, anche in un tempo lento non terna rio Beethoven spesso conclude il primo tema con una decisa cadenza sulla to nica, per cui ci si aspetterebbe una forma ternaria: questo tipo di conclusione è essenziale per ottenere un lirismo disteso. La tipologia dei tempi lenti di Bee thoven è molto ampia e varia: ci sono forme di cavatina (cioè con esposizione e ripresa, ma senza sviluppo), forme ternarie, forme sonata, serie di variazioni e semplici ma emozionanti introduzioni a un finale. La combinazione di tempo lento e finale che si trova nell’op. ito, invece, non è classificabile.
I finali di Beethoven sono quasi sempre costruiti a sezioni e sono meno strettamente organizzati dei primi movimenti; per questo aspetto egli ha seguito in tutto il suo arco creativo il gusto settecentesco. Non solo i finali in forma di rondò ripetono il tema d’apertura varie volte, ma i temi stessi sono quasi sem pre poco coesi e presentano elementi ripetuti al loro interno. Anche i tempi conclusivi che non sono in forma di rondò tendono ad avere temi che però li richiamano (op. 31 n. 3 e op. 81a). La tradizione tardo settecentesca, che preve deva per un finale l’uso di una forma meno strutturata di quella di un movi mento d’apertura, influenzò quindi largamente anche le sonate di Beethoven. E chiaro però che egli cercò di trovare il modo di dare a queste strutture più deboli un’importanza analoga a quella assegnata ai tempi iniziali. Nonostante i finali scritti agli esordi della carriera siano già dei movimenti riusciti, per molti anni ancora il problema di conferir loro un peso maggiore non trovò una solu zione adeguata.
20 Parte prima: la tradizione
La varietà delle forme sonata in Beethoven è impressionante. E come se in ogni sonata avesse cercato di trovare una struttura unica, con un suo impianto drammatico peculiare, diverso da ogni lavoro precedente. A livello puramente formale, lo spettro delle possibilità è sorprendente: per esempio una sezione iniziale alla tonica può dispiegarsi con grande ampiezza, come nell’op. 2 n. 3 e nell’op. 111,0 può essere compressa laconicamente in sette secondi, come nell’op. 109. Nessun altro compositore di sonate si è mai avvicinato a una gamma così vasta di caratteri, stili e forme.
Fraseggio Linee curve e punti: legato, staccato e forma della frase
Un tempo si pensava che le indicazioni di fraseggio di Beethoven fossero tal mente sporadiche che non si poteva dargli gran peso. Lo sostenevano curatori delle sue edizioni del calibro di Artur Schnabel e Donald Francis Tovey. Gra zie a Dio oggi i curatori sono diventati più pedanti. Eppure circola ancora la pervicace convinzione che laddove Beethoven abbia indicato fraseggi diversi nelle varie ricorrenze di un medesimo tema il testo vada normalizzato. Normalizzare vuol dire esser convinti che quando capita di trovare indica zioni di fraseggio o legature differenti sullo stesso tema ciò è dovuto a un erro re del compositore o dell’incisore. I musicisti possono commettere sbagli nel fermare sulla carta il frutto della loro ispirazione e Beethoven certamente non costituisce un’eccezione: poteva essere estremamente preciso, addirittura pi gnolo per certi dettagli, ma anche incredibilmente trascurato per altri. È vero anche che, come molti altri suoi colleghi, le volte in cui tornava un tema già presentato poteva essere un po’ sbrigativo nelle indicazioni: spesso i composi tori, forse poco saggiamente, si affidano all’intelligenza, alla memoria e al buon senso degli esecutori. Tuttavia, un assioma ingiustificato di molta editoria musicale odierna è che ci sia un solo modo giusto o ideale di fraseggiare un tema. Legature diverse possono mettere in luce differenti aspetti e caratteri in una stessa musica, e Beethoven fa ricorso a questa possibilità molto più spesso di quanto non si pensi. Lunghe legature di frase sottolineano l’unità di una linea melodica, lega ture corte invece indicano gli accenti al suo interno: entrambi i tipi possono coesistere tranquillamente e il compositore può decidere di mettere in rilievo l’uno o l’altro.
ATTACCO E RILASCIO
La difficoltà che possiamo incontrare con le indicazioni di fraseggio di Beetho ven, sta nel fatto che per un musicista della fine del diciottesimo secolo le lega ture non avevano lo stesso significato che hanno per noi oggi. Nel Settecento e all’inizio dell’Ottocento le regole basilari che concerneva no le legature erano molto semplici: i) La prima nota posta sotto una legatura deve essere lievemente sottolinea ta (si può considerare la forma minima di accentuazione).
22 Parte prima: la tradizione
2) L’ultima nota posta sotto una legatura non deve essere enfatizzata o ac centata, ma va suonata più delicatamente. Di fatto, dovrebbe essere eseguita spesso, ma non sempre, un po’ più corta di come è scritta. Oggi gli strumentisti ad arco, e sovente i direttori d’orchestra, continuano a fraintendere le legature settecentesche come indicazioni di arcata, come sono usate attualmente. Una volta mentre provavo il concerto in mi bemolle mag giore k. 271 di Mozart, chiesi se i violini potevano fraseggiare le battute 7-11 come le avrei suonate io più avanti, quando si ripresentano nella parte del soli sta. In queste misure
l’ultima nota sotto la legatura dovrebbe essere accorciata, dando così al passo maggiore eleganza e meno eloquenza:
j
> u. mrw
>
Quando il direttore obiettò che si trattava di segni indicanti le arcate feci no tare che nella mia parte c’erano le stesse legature, anche se io non potevo fare arcate ma solo fraseggio. Il più delle volte questo tipo di errore non fa danno, perché spesso l’arcata coincide col fraseggio (l’inizio di una legatura indica un leggero accento e il cambio di direzione dell’arco è la maniera più facile, ge neralmente l’unica, di ottenere questo effetto sul violino); ma non sempre è così, e in ogni caso non viene fuori il senso fondamentale della notazione mu sicale settecentesca. Persino il fraseggio sulla tastiera sovente è basato sul l’analogia con quello degli archi, e più ancora con quello vocale: per molti se coli (incluso quello passato) l’imitazione del canto è stata il fondamento della musica strumentale. Certo, una legatura ci può dire dove l’esecutore alza l’ar co, o il cantante respira o intona più note su una stessa sillaba, ma tradizional mente è soprattutto un sistema per dirigere l’accentuazione ritmica e l’artico lazione di un motivo.1 La maniera di eseguire legature come quelle del concerto di Mozart è spie gata esplicitamente nella Klavierschule pubblicata da Daniel Gottlob Turk nel 1789:21 2 1 Un’eccellente discussione delle indicazioni di fraseggio di Beethoven si trova nel volume di William S. Newman Beethoven on Beethoven, New York 1988, che affronta quasi tutti i temi più importanti; l’unica pecca è l’assunzione che per ogni passo debba esserci un solo fraseggio corretto. 2 Tradotto in inglese come School of Clavier Playing e corredato di un’introduzione e note da Raymond H. Haggh, University of Nebraska Press, Lincoln and London 1982, p. 345.
Fraseggio
23
A volte alcuni suoni dovrebbero essere legati e altri staccati. È abitudine scrivere questo tipo di articolazione come mostrato in a. Ne ho fornito però una più esatta notazione in b.
^LÙ2j
'g
i
IpO
Resta solo da aggiungere che la prima di due note legate, non solo dovrebbe es sere leggermente più lunga della seconda, ma anche avere un po’ più di peso. Quando Beethoven modifica le indicazioni di fraseggio in successive appari zioni di un tema, egli trasforma il senso della melodia. Un buon esempio è il tema principale del movimento finale della sonata “Pathétique” op. 13. All’ini zio della seconda battuta del tema, il do è una nota ben sostenuta che necessi ta di una certa accentuazione cantabile. Per questa ragione la legatura arriva solo fino alla croma che precede il do:
Proprio alla fine del movimento, invece, l’autore altera radicalmente il carattere del tema: la prima nota della seconda battuta del tema non è più una minima, ma una semiminima seguita da una pausa, e qui va suonata con delicatezza e ri lasciata senza accento, un momento di tenera distensione prima della frase fina le. Per questo la legatura si estende fino all’ultima nota, che non va assolutamente tenuta più a lungo di come è scritta (semmai, va leggermente abbreviata):
Questo altera il carattere non solo del motivo ma dell’intero tema principa le, che non viene più accentato sulla seconda e quarta battuta come prima, ma
24 Parte prima: la tradizione
sulla prima e sulla terza. Eliminare l’accento sulla seconda battuta rende il mo tivo esitante, frammentario e temporaneamente indeciso, giustificando in pie no la violenza della cadenza finale. E vero, però, che a volte, quando Beetho ven scrive molto in fretta, è difficile stabilire esaminando i manoscritti dove le legature inizino o terminino. Ma quando è importante egli sa essere molto sen sibile al posizionamento della legatura. Per esempio, nel tema principale dello scherzo della sonata in la bemolle op. 26, le due note della seconda battuta, do e re bequadro, sono chiaramente riunite sotto una legatura e separate dalla no ta che segue. Ciò stabilisce che il do sia accentato, che il re bequadro non lo sia, e che il mi bemolle della misura successiva, che è tenuto per quattro quarti, venga anch’esso accentato. Lo schema è ripetuto quattro battute dopo con le note fa, sol e la bemolle, ma il manoscritto è impreciso e l’incisore ha erronea mente considerato la legatura come se comprendesse tre note.
Ma otto misure dopo, all’inizio della seconda parte, quando torna il motivo, l’ultima delle tre note non dura più quattro tempi, ma solo uno. Nell’autogra fo si può vedere come la penna dell’autore avesse cominciato a scrivere una le gatura lunga due note, come in precedenza, per poi cambiare improvvisamen te direzione, scendendo per evitare di terminare sulla seconda nota e risalendo poi per arrivare fino al suono successivo, che in tal modo non è più accentato:
Fraseggio
25
Ora il motivo si affusola con grazia invece di muovere decisamente verso un accento e uno sviluppo ulteriore. Il nuovo fraseggio indica una trasformazione fondamentale del carattere: le due battute d’apertura non sono più un’afferma zione seguita da un commento scherzando, bensì una domanda a cui risponde un nuovo motivo fortemente accentuato. Non sempre gli editori han compreso appieno il significato delle legature come erano impiegate intorno al 1800, e spesso han cercato di uniformare i differenti fraseggi di Beethoven, i quali stanno a significare un mutamento nel carattere del tema, o proiettano su di esso un tipo di accentuazione diverso. Per esempio, anche i curatori della cosiddetta edizione Urtext pubblicata dalla Henle hanno ridotto, nelle successive revisioni dei testi, la cospicua varietà del le legature nella prima pagina della sonata in do minore op. 10 n. 1. All’inizio della composizione, le legature sul ritmo puntato (battute 1-7) terminano su una semiminima:
Questo ci dice che la prima semiminima sul terzo tempo, in levare, dev’essere suonata leggermente: è la semiminima successiva, sul battere, che riceve l’ac cento. Poche misure dopo, però, l’accentuazione del motivo cambia. La semimini ma sul terzo tempo viene ora accentuata in modo spettacolare con un effetto di sincope, quindi la legatura termina sull’ultimo sedicesimo del motivo, prima dell’ultimo quarto della misura (battute 22-27).
Così si legge nella prima edizione (il manoscritto non esiste più), ma in alcune recenti edizioni la legatura è stata prolungata fino alla semiminima, come in pre cedenza, forse ritenendo che sia impossibile fermarsi tra il sedicesimo e la nota da un quarto seguente. La fine di una legatura, però, non comporta necessaria mente una cesura, ma può significare solo di rilasciare la nota senza accento. Tutto questo rivela l’ambiguità del segno di legatura, che era impiegato per in
26 Parte prima: la tradizione
dicare sia una determinata continuità di suono, sia l’accentazione della frase. Normalmente nel diciottesimo secolo ciò non dava adito a fraintendimenti, in quanto le due funzioni generalmente coincidevano: spesso il compositore inizia va un singolo elemento motivico di una frase con una nota accentata, lo prose guiva in legato e lo concludeva abbandonando la nota finale senza accento. Le partiture di Mozart sono piene di brevi legature che articolano la frase in questa maniera e così pure le prime partiture di Beethoven. Questi allungò sempre di più le legature, nella preoccupazione di non spezzettare la frase in tanti piccoli elementi. Nei compositori successivi, specialmente in Chopin, i segni di legatu ra si fanno immensamente lunghi, arrivando a coprire dozzine di battute e per sino più pagine; esecuzione e interpretazione evolvevano verso una maggiore continuità. Ciò non voleva dire necessariamente più legato, ma stava a significa re l’esigenza di pensare in termini di unità strutturali più ampie. La fine di una legatura può sì indicare uno stacco, cioè che l’ultima nota va suonata più corta di quanto è scritta e seguita da un piccolo respiro, ma non sempre, come si vede nell’op. io n. i, dove una pausa non è possibile e neanche pensabile in quanto la legatura finisce su un sedicesimo. Nella sonata di Mozart in si bemolle maggiore k. 570, il tema d’apertura è fraseggiato come segue:
Più avanti riappare con un fraseggio più unitario:
no
Fraseggio
27
Nel primo caso viene messo in rilievo il ritmo della battuta. Si può suonare con una minima pausa dopo il terzo tempo di ogni misura, ma ciò è comunque me no importante della graziosa inflessione data dai minuscoli accenti che le lega ture impongono. L’ultima nota, un fa, nella prima versione di questo motivo di quattro misure, è una minima ed è posta al di fuori della legatura; questo sta a significare che deve avere, quanto meno, una certa pienezza di suono. Il secon do tipo di fraseggio invece mette in rilievo l’unità del motivo, che termina ora in maniera più aggraziata, sfumando su una nota da un quarto compresa nella legatura, il che richiede un rilascio senza accento. Ma quanto diverse dovevano suonare le due notazioni di fraseggio? È chia ro che la chiusa delle due versioni, quella con la minima e quella con la semi minima, doveva contrastare fortemente, ma è dubbio che si dovesse marcare il contrasto tra la separazione di ogni battuta con legature e la continuità della le gatura su quattro battute: né l’autografo né la prima edizione, in cui potrebbe ro esser state accolte modifiche dell’autore, si dimostrano coerenti a tal propo sito. È chiaro, però, che la prima apparizione del tema, all’unisono non accom pagnato, esige maggiore articolazione che non più avanti, quando esso ricorre in combinazione con un nuovo motivo affidato a un’altra voce. Nell’esposizione della sonata in do minore op. ili, Beethoven colloca una legatura sulle prime cinque note di un motivo di sette:
Solamente le ultime due note sono staccate, per cui non bisogna interrompere il legato prima del sesto suono. Oggi avremmo scritto la legatura fino alla sesta, ma per Beethoven questo avrebbe indicato che va suonata senza accento. La sua notazione, al contrario, ci dice che il sesto suono va attaccato con decisio ne, cosa che produce un grande spicco delle due ultime note, trasformando il carattere della frase in modo spettacolare. L’ambiguità del segno di legatura (che può indicare semplicemente una mancanza di accento nel punto in cui finisce, con o senza accorciamento del suono) poneva problemi al compositore solo quando egli desiderava estende-
28 Parte prima: la tradizione
re il legato pieno fino a una nota finale accentata. Nel movimento iniziale del la sonata in la bemolle maggiore op. i io, le legature a due nelle misure 27-31 indicano che il primo suono, anche se è in posizione debole, è accentato men tre il secondo va alleggerito, e se si vuole può essere seguito da una pausa in finitesimale: . . ____ _
Ma Beethoven in due punti indica uno sforzando sul secondo suono di una le gatura a due. Qui omettere la legatura condurrebbe a un’esecuzione staccata della prima nota. E importante capire che lo sforzando inverte l’accentuazione delle due note implicata dalla legatura, ma anche che tale inversione arriva co me una sorpresa. Il motivo che sale lungo un intervallo di sesta è accentato co sì: forte/debole, forte/debole, forte/più forte (con i primi due accenti forti in posizione debole). Nel diciottesimo secolo questo modo di accentuare le note in tempo debole era uno dei significati del termine rubato. E in effetti, per es sere eseguito con sensibilità, esige una certa libertà ritmica: si dovrebbe indu giare un attimo sulla nota accentata, ma non tanto da provocare una vera e propria distorsione dell’andamento ritmico più ampio.
GLI ACCENTI E IL RUBATO
Nel diciottesimo secolo c’era una confusione analoga, e altrettanto carica di conseguenze, tra nota accentata e nota staccata, un’ambiguità che si protrae fi no al diciannovesimo secolo inoltrato. In realtà, eseguire una nota leggermente staccata era un modo semplice per metterla in rilievo. Quest’imitazione della tecnica degli archi era adatta al basso volume sonoro dei primi strumenti a ta stiera, ma era specialmente utile per il clavicembalo e l’organo, sui quali gli ac centi dinamici non erano realizzabili; sui primi pianoforti essa permetteva una grande varietà espressiva, dal semplice staccato a una leggera accentuazione, per arrivare allo sforzando. Si veda per esempio l’inizio della seconda parte del la variazione lenta dalla sonata in la maggiore k. 331 di Mozart:
Fraseggio
29
Le note col punto sopra a fine frase (sol, la, si, do diesis e re) non sono uno staccato, ma un portamento espressivo, quindi non vanno staccate con nettezza ma devono solo ricevere un po’ di peso in più. Generalmente questo effetto era accompagnato da un rubato discreto, e in effetti la notazione musicale sug gerisce un graduale rilassamento del ritmo. Nel Settecento i due modi di mettere in evidenza la nota, staccato deciso o accento più forte, talvolta venivano differenziati scrivendo il primo con dei punti e il secondo con dei trattini verticali. Nel primo movimento della sona ta in la bemolle maggiore op. no di Beethoven, i segni che compaiono ogni quattro note nel passo di biscrome della mano destra devono essere conside rati come delicati accenti, dato che lo staccato è manifestamente impossibile e assurdo:
Beethoven poteva insistere molto fermamente, con gli editori, sulla distinzione tra punto e tratto allungato. Tuttavia, uno sguardo a uno qualsiasi (o quasi) dei suoi manoscritti mostra che spesso è praticamente impossibile distinguerli: nel
30 Parte prima: la tradizione
la sua calligrafia impaziente, i punti sono grandi quanto i trattini verticali. La necessaria distinzione si può fare solamente in base ad argomentazioni musicali Scrivere i segni di staccato sotto una legatura era un modo comune di indi care un’accentuazione espressiva da suonare in rubato (in questo caso, un leg gero ritenuto}. Se ne possono trovare svariati esempi in Mozart come in Cho pin, e in questi passi suonare le note staccate strettamente in tempo sarebbe intollerabile:
Si noti come nella battuta 57 dello studio op. 25 n. 2 di Chopin tutte e sei le note con sopra il punto vadano eseguite col pedale abbassato. Pertanto, ciò che il compositore qui chiede non è uno staccato ma un ritenuto. Quest’indicazione è stata utilizzata da Beethoven, ma il tipo di rallentando da lui voluto forse era meno estremo di quello di Chopin, anzi è a volte discre to e quasi impercettibile, come nella seconda battuta del tema del movimento finale della sonata in mi minore op. 90:
o anche nella terza e nella decima misura, all’inizio della sonata in la bemolle maggiore op. 110:
Fraseggio
31
Nella sonata in do minore op. in, invece, il rallentamento richiesto dev’essere più marcato rispetto agli esempi precedenti, perciò è indicato espressamente:
CHIUSE CORTE
Che talvolta una frase o anche un movimento vengano conclusi con una nota molto breve è uno degli aspetti della musica di Beethoven che gli esecutori di oggi stentano ad accettare. In effetti, quando troviamo casi del genere in altri autori del diciottesimo secolo, e capita spesso, ci sembra una stranezza. La fine
32
Parte prima: la tradizione
della fuga dalla Toccata, adagio e fuga WXN 564 di Johann Sebastian Bach og gi può apparire bizzarra:
Se sembra strana è perché dopo l’ultimo accordo ci vuole qualche secondo per capire che il pezzo è proprio terminato; gli esecutori moderni preferisco no dei finali più chiaramente e immediatamente percepibili da parte del l’ascoltatore, così l’applauso segue senza incertezze. È raro, perciò, che oggi un pianista resista alla tentazione di indugiare un poco sull’ultima nota della sonata in re maggiore op. 10 n. 3, sebbene sia evidente che Beethoven non vo leva far finire la musica con una conclusione regolare, bensì farla dissolvere vaporizzandosi:
Similmente, l’ultima battuta del movimento finale della sonata in la maggiore op. 2 n. 2 può essere eseguita con un delicato ritardando, ma non c’è ragione di allungare l’ultimo accordo:
Queste conclusioni non retoriche, oggi sgradite a tanti pianisti, erano tipiche di quel periodo. Un ulteriore esempio ci viene fornito dalla fine dello scherzo della sonata “Al chiaro di luna”:
Fraseggio
33
Suonare l’ultimo accordo più lungo di quanto scritto è un errore di stile che si sente spesso nei concerti: l’accordo va eseguito non solo corto, ma anche privo di qualsiasi accento. Però (e questo è proprio ciò che per l’esecuzione moder na è contro natura) se si suona come è scritto l’ascoltatore medio non si rende rà conto che la composizione è finita se non dopo qualche secondo. Perfino concludere una singola frase con un suono corto, con una nota bre ve e leggera non sempre è accettabile per il gusto moderno. Nella melodia di transizione che segue l’inizio dell’esposizione della sonata in re maggiore op. io n. 3, pochi esecutori abbandoneranno il fa diesis della battuta 30 con la ra pidità prescritta da Beethoven:
Dovrebbe essere chiaro che il compositore desiderava qui una nota molto bre ve, visto che si è preso la briga di scrivere una semiminima e due pause da un quarto, invece di una semplice minima puntata, che è la maniera in cui la suo na la maggior parte degli esecutori. Il fa diesis finale non è incluso nella legatu ra che lo precede; questo implica che la nota può ricevere un certo peso, senza però venire allungata.3 3 Le indicazioni di fraseggio richiedono un leggero accento sul primo tempo della prima, seconda e quarta misura di ogni frase (battute 23, 24, 26 e 27, 28, 30), e un altro sulla secon da metà della terza misura (battute 25 e 29), dando in questo modo slancio al levare della quarta battuta e aumentando il suo peso espressivo. Ciò significa che la seconda e la quar ta sono le misure forti. Nella frase seguente (battute 31-36), il peso si sposta sulla prima misura.
34 Parte prima: la tradizione
Due battute dopo (31-32), Beethoven scrive nella parte della mano sinistra un motivo con un breve accordo finale di semiminima senza accento seguito da una pausa da tre quarti, ma l’asciuttezza di tanto spazio vuoto sembra intol lerabile per la sensibilità odierna. L’accordo finale (battuta 32) rientra sotto la legatura; ciò vuol dire che va lasciato immediatamente e non va accentato. Il peso espressivo poggia interamente sullo sforzando della misura precedente, e l’accordo va abbandonato con grazia, creando un contrasto col carattere umo ristico delle due battute successive. La resa del tono affettivo di questo passag gio esige che si presti un’attenzione minuziosa, addirittura letterale, alle indica zioni di fraseggio. Sfortunatamente l’indicazione dei valori delle note praticata tradizionalmen te nel Settecento, per i criteri moderni, è piuttosto approssimativa. A volte sembra che Beethoven, come pure Mozart, vada in cerca di una scrittura più precisa, ma i suoi tentativi sono discontinui. La principale convenzione che è diventata la pietra d’inciampo per tante esecuzioni ed edizioni odierne, di fat to, è molto semplice: ogni nota o accordo che preceda una pausa va suonato più corto di come è scritto. Nella seconda frase (battuta 9) di una delle prime sonate di Beethoven, in la maggiore op. 2 n. 2, troviamo un buon esempio dei suoi tentativi di dare indicazioni più precise e del suo incoerente ritorno alla vecchia e (per noi) inadeguata convenzione. Alla fine della frase egli scrive una nota da un ottavo seguita da una pausa di croma più una di semiminima:
Una dozzina di battute dopo l’autore riformula questa frase alterando il rap porto tra le due mani; questa volta egli chiude il motivo con minor precisione scrivendo una nota da un quarto e una pausa da un quarto:
Si potrebbe pensare che Beethoven non si stia solo risparmiando la fatica di scrivere una pausa in più, e che, essendo le due frasi quasi identiche, qui voglia che la nota sia tenuta un po’ più a lungo. Ma se si va a vedere la ripresa, dove la frase ricompare senza alcuna modifica, ci accorgiamo di essere di nuovo di fronte alla notazione meno precisa:
Fraseggio
35
Qui è tutto identico, salvo la durata dell’ultimo suono della mano destra, che è un’indicazione meno precisa. Ogni volta che il motivo ritorna non c’è alcuna ragione musicale per far durare la nota finale più di un ottavo, ma solo la pri ma volta Beethoven lo scrive precisamente come una croma seguita da due pause, rispettivamente da un ottavo e da un quarto: altrove (la frase torna alle battute 165 e 176 dello sviluppo) scrive sempre semiminima e pausa da un quarto, tranne alle misure 169 e 180 dove un nuovo accordo sul secondo tem po della battuta lo costringe a scrivere una croma più una pausa da un ottavo.
Quando Beethoven ripete un passaggio ma cambia il valore di una nota che precede una pausa, c’è un criterio empirico per decidere se stia indicando con precisione il ritmo o stia tornando a una vecchia convenzione: se la nuova no tazione è più rapida da scrivere, è un’abbreviazione; se è più complessa, vuole dare un valore diverso per la nota allo scopo di alterare il carattere del motivo. E stato proposto che la convenzione di abbreviare le note prima di una pau sa possa spiegare la strana notazione del tema principale della Grande fuga per quartetto d’archi:
36 Parte prima: la tradizione
Se Beethoven avesse scritto qui delle semiminime seguite da pause di un quar to, tutti i musicisti dell’epoca avrebbero suonato l’equivalente di una croma se guita da una pausa da tre ottavi (l’uso del trattino orizzontale per indicare che una nota va tenuta per tutto il suo valore non era ancora diffuso). Perciò le due crome legate servono per dire all’esecutore che la nota va sostenuta fino alla pausa; in tal modo, nel peggiore dei casi Beethoven avrebbe ottenuto una du rata di tre sedicesimi. L’unica altra soluzione possibile sarebbe stata quella di scrivere tenuto su ognuna delle note. Per le stesse ragioni, le differenze di notazione dei seguenti passaggi (battute 252 0312) dalla sonata in la maggiore op. 2 n. 2 non comportano di fatto nessu na differenza d’esecuzione:
La croma della battuta 312 non deve essere tenuta più a lungo della nota corri spondente alla battuta 252. Alla 312 il passo è un’ottava sopra e Beethoven lo rende meno scomodo da suonare dividendolo fra le due mani. Però non perde tempo a scrivere l’ultima nota della mano sinistra come una semicroma seguita da due pause corrispondenti: sarebbe stata un’inutile pignoleria. La convenzione settecentesca di attribuire a una nota seguita da una pausa solo la metà del suo valore effettivamente scritto era particolarmente impor tante per le note del basso. Sir Charles Mackerras ha fatto notare che la famosa lunghissima nota di violoncelli e contrabbassi nella prima battuta del P)on Gio vanni non compare negli incipit che Mozart stilò per il catalogo delle sue ope
Fraseggio
37
re, ed è un effetto sonoro troppo sorprendente perché possa averlo omesso o dimenticato. A quell’epoca gli strumenti dal registro grave ovviamente erano più deboli rispetto a quelli di oggi, e forse la tradizione di scrivere le note nel basso più lunghe della loro durata reale nacque per assicurarsi una sonorità ef ficace. Ad ogni modo, curiosamente sembra che oggi si preferisca tenere le no te nel basso più a lungo di quanto sia scritto. Infatti molti pianisti lasciano la mano sinistra sulla tastiera, indugiando sull’ultima nota suonata prima di una pausa, come se in tal modo fosse più facile ritrovare il tasto nel momento in cui serve. A cominciare dalla generazione di Chopin i compositori di musica per tastiera preferivano una generale continuità di suono rispetto allo stile mag giormente articolato dei decenni precedenti, uno stile che, secondo Czerny, Beethoven stesso, parlando del modo di suonare il piano di Mozart, deplorava perché troppo ‘spezzettato’ (zu gehacktes), e che nel corso degli anni egli cercò di stemperare, senza però mai rinunciare completamente al suo sistema di articolazione. La sua musica e il suo fraseggio contribuirono largamente a prepa rare una nuova era, ma continuando sempre a sfruttare il vecchio stile al quale Beethoven era stato educato. Per cogliere la sua concezione del fraseggio dob biamo imparare ad apprezzare quel suono più articolato che talvolta usava an cora, e la conseguente ariosità e trasparenza che aveva ereditato dallo stile dei suoi primi anni.
RIMODELLARE LA FRASE
A partire dalla nona battuta del finale della sonata in do maggiore op. 2 n. 3, si incontra un motivo quasi identico al motivo di tre note per la mano sinistra già citato sopra a p. 33 (battute 31-32 del primo movimento dell’op. 10 n. 3), un motivo piuttosto comune nella musica di quel periodo:
3 8 Parte prima: la tradizione
Come nell’esempio dall’op. io n. 3, l’ultimo accordo dell’inciso è più corto dei primi due e deve essere lasciato con leggerezza e rapidamente. È lecito suonarlo più corto di un quarto, che è il valore scritto, ma non più lungo, al trimenti il contrasto con la terza apparizione del motivo, dove è scritto come una minima puntata, non sarebbe efficace. Ciò che è essenziale è lasciare im mediatamente e senza accentarlo il suono che precede una pausa: la grazia ti pica dello stile classico dipende da questo, ed è importante per ottenere nel l’articolazione un contrasto con le chiuse accentate, come nell’ultimo esem pio. In questa progressione ascendente, il motivo dovrebbe diventare più ur gente, più pressante via via che procede. Nella mano destra, gli accenti sono chiaramente determinati da due legature per battuta fino alla misura 16, e successivamente da una per battuta: ciò fa decrescere gli accenti e accrescere continuità; qui non è possibile, e neppure necessaria, alcuna interruzione del legato. All’inizio della sonata in mi bemolle maggiore op. 7, alle battute da 5 a 10, incontriamo lo stesso motivo di tre suoni invertito, anche qui suonato due vol te con l’ultimo accordo più corto dei primi due ma tenuto alla terza ripetizio ne. Nelle prime due sortite (battute 5-6, e 7-8), tutte e tre le note sono poste sotto una legatura che impone di lasciare l’ultimo accordo sfumandolo, e ciò implica che la figurazione sia eseguita con un grazioso diminuendo. La terza volta invece (battute 10-11) l’accordo finale è tenuto, anzi, è indicato un cre scendo, subito ribadito da uno sforzando che ripete l’ultimo accordo del moti vo trasformandolo in una settima di dominante:
Dopo due misure in cui il tessuto musicale è più leggero (battute 11-12) il mo tivo della sinistra passa alla destra, e non ha più legatura (ciò comporta che ogni singolo accordo sia leggermente più accentuato), conserva l’indicazione di crescendo e il terzo accordo qui dura il doppio, con lo sforzando sull’accor do seguente, che risolve tornando alla tonica. Questa pagina amplifica un gra zioso motivo di due battute con chiusa femminile fino a farne una più dram matica cadenza maschile di cinque battute (13-17). Questo cambiamento di carattere risulterà ben reso nell’esecuzione se si rispettano le indicazioni di fraseggio e si lasciano quasi immediatamente i suoni che precedono le pause,
Fraseggio
39
senza indugiarvi né cercare di rendere la sonorità più ricca, più omogenea o più gradevole. Quando queste battute ritornano nella ripresa, la versione della mano de stra è ampliata con la consueta introduzione (tradizionale nella musica sette centesca) di un movimento verso la sottodominante subito dopo il ritorno del tema principale e della tonalità d’impianto, ma ora è modificata da una lega tura che si estende per tre battute e da un crescendo più lungo che serve a in dicare una maggiore intensità (misure 201-205). La legatura di tre battute vie ne erroneamente estesa a quattro da molti revisori, ma se le ultime due note ne restano fuori ciascuna deve ricevere una sua accentuazione che è musicalmente efficace. Si noti poi il cambiamento di fraseggio nella mano sinistra, con due legature di due misure al posto di una di quattro: ciò suggerisce un’accentuazione extra, che mette in rilievo una rielaborazione maggiormen te drammatica.
Dal modo in cui è trattato il tema d’apertura della sonata “Pastorale” op. 28 in re maggiore lungo tutto il primo tempo si può vedere il fraseggio beethoveniano in tutta la sua sottigliezza:
In questo tema di nove battute, più una di introduzione, la notazione del fra seggio ci dice che sul primo tempo delle misure 3, 5 e 6 cadono dei delicati ac
40 Parte prima: la tradizione
centi e che le ultime quattro battute costituiscono un’unità a se stante che con clude con una clausola femminile, un suono corto e [ripiano. Nell’immediata ripetizione, o rienunciazione, del tema all’ottava superiore, il fraseggio rivela che la prima battuta, dopotutto, non era un’introduzione, bensì parte integran te della melodia di dieci battute. Qui la parte del tenore è messa in rilievo, con discrezione, da una legatura insolitamente lunga, che comprende tutte e dieci le battute, e questo vuol dire che deve essere percepita come un sommesso contrappunto alla parte del soprano. L’ultima legatura di quattro battute, nella mano destra, è quella cruciale. Da essa dipende la percezione del carattere pastorale dell’intera frase: la prima nota sotto legatura, un la, ha maggior peso, mentre le successive tre battute muovono senza interruzioni verso la chiusura del tema che svanisce in piano, con una nota che va lasciata rapidamente, seguita da due pause da un quarto. Più i suoni salgono più l’intensità dinamica scema, concludendosi liricamente col silenzio. Quando, però, all’inizio dello sviluppo il tema principale ritorna alla sotto dominante, Beethoven comincia a trasformarne il fraseggio:
159
Fraseggio
41
In principio tutto sembra essere uguale, eccezion fatta per la parte del tenore che ora si presenta a partire dalla seconda delle dieci battute che formano il te ma. Giunti all’enunciazione successiva, però, il fraseggio comincia a cambiare in coincidenza con l’introduzione di segni dinamici radicalmente nuovi. Il crescen do e lo sforzando in levare nella terza battuta della frase, assieme al piano im provviso nella quinta (battute 179 e 181) eliminano la legatura unificante sulla terza e quarta misura. Soprattutto, con la seconda indicazione di crescendo (bat tuta 183) scompare il segno di frase che univa le quattro battute finali di que st’idea: solo la terza battuta rimane legata. Ora le prime due misure del motivo conclusivo hanno un peso individuale separato, confermato dallo sforzando sul la seconda (battuta 188), che arriva dopo un forte sulla prima, il che le conferi sce un’articolazione ancor più pronunciata della precedente. Ma ancora più im portante è il fatto che l’ultima nota di questo motivo di quattro battute non è più sotto legatura e quindi non va più lasciata morbidamente. Ora richiede un attacco più pronunciato; ciò non solo produce maggiore vitalità ritmica, ma è anche in linea con la nuova funzione svolta da queste battute, ossia di prepara re la graduale frammentazione del motivo, che sfocia in una serie di incisi a par tire dalla battuta 209, ognuno dei quali reca una propria legatura e uno sforzan do, il tutto seguito dal motivo nella mano destra abbreviato a due tempi (battu ta 219) e con accento sincopato. La violenza drammatica sostituisce l’originario lirismo pastorale. La macrostruttura progressiva dello sviluppo, con la sua gra duale costruzione, è centrata sulla seconda metà del motivo di quattro misure, e ciò impone tutta questa serie di cambiamenti di fraseggio e di accento.4 Le legature separate battuta per battuta, continuano (anche nella mano sini stra, a cominciare dalla 219) fino alla 239. In questo climax sontuosamente di 4 Per l’esposizione e la ripresa possediamo il manoscritto autografo, in cui il fraseggio è abbastanza 1 anche se non del tutto) coerente. Purtroppo manca il manoscritto della sezione di sviluppo: l’autore lo tolse quando rivide la sezione, e il nuovo manoscritto non fu inserito.
42
Parte prima: la tradizione
riamico che tiene, ininterrottamente per trentotto misure, un pedale sulla do minante della tonalità relativa minore, è importante marcare sottilmente il rit mo, dato che quel che resta è una semplice ripetizione dell’armonia di fa diesis maggiore per diciotto battute. La legatura è la forma minima di accento. Tra l’altro si noterà come Beethoven introduca il pedale di risonanza solamente al la battuta 252: ciò significa che voleva per le battute 252-256 una sonorità nuo va e speciale. Torna a proposito qui citare un ultimo caso in cui Beethoven rimodella il fraseggio di un tema importante. Le due versioni del tema provengono dal l’esposizione (a) e dalla ripresa (b) del secondo movimento, Prestissimo, della sonata in mi maggiore op. 109:
Fraseggio
43
A partire dal piano improvviso a battuta 43, Beethoven impiega una progres sione armonica semplice che scende lungo il circolo diatonico delle quinte: dal v grado di fa diesis al fa diesis minore, dal v grado di mi al mi minore, dal v grado di re al re minore, dal v grado di do al do minore. Si tratta di una comu ne progressione che molti compositori, compresi Bach e Mozart, e più tardi anche Chopin e Schumann, trovavano utile per esprimere dei momenti dal ca rattere appassionato. Questa sequenza, una volta innescata, sviluppa una gran de forza propulsiva, ma la sua stessa convenzionalità sposta l’interesse e l’at tenzione dall’armonia alla melodia, che a questo punto del Prestissimo risulta di grande bellezza e molto espressiva. Il fraseggio che il compositore sceglie per la prima versione è veramente ori ginale: per comprenderne appieno il significato, bisogna, come al solito, imma ginarsi la linea del soprano cantata. In generale per i cantanti è facile e molto naturale cantare la nota più acuta più forte del resto: cantare piano un suono acuto è un effetto coltivato in quel tipo di cantabile che in ambito operistico è chiamato ‘spianato’, ed è quello che Beethoven richiede qui ponendo le note acute fa diesis e mi, raggiunte attraverso un salto di sesta, alla fine delle legatu re. (C’è una piccola discrepanza tra il manoscritto e la prima edizione: nel ma noscritto alla battuta 45 la legatura comincia sul do bequadro e non sul fa die sis. La versione del manoscritto ha una maggiore coerenza con il resto della frase e risulta più espressiva). Nella terza parte della progressione (battuta 48) il salto al fa naturale è di ottava, e questa nota acuta si trova nel mezzo di una lunga legatura che copre tre misure. Suonare le note acute di questo disegno senza accentarle richiede al pianista un tipo di esecuzione speciale, un rubato quasi impercettibile su ogni suono, che consente di ottenere una morbida cantabilità. Il vantaggio di questa tecnica è non solo la resa della grazia arabescata della linea melodica, ma anche l’accentuazione che ricevono i suoni armonicamente più espressivi. Le legature partono da re, do e si bemolle e creano tutte con il basso un accordo di nona di dominante e una serie di appoggiature di grande intensità. Dunque la scelta di fraseggio indicata da Beethoven mette in rilievo sia i suoni più acuti della melodia sia quelli più dissonanti. Quando però il passaggio ritorna nella ripresa, egli sceglie diversamente, ri scrivendolo in maniera che le note acute dei primi due elementi della progres sione vengano trasposte, con un effetto straordinario, da un salto di sesta a uno di decima, per raggiungere il fa naturale e il mi bemolle. Ne consegue che esse non sono più sotto la legatura alla fine della frase, ma isolate e separate dalle altre note, dunque non sono più note finali, da lasciare delicatamente, ma de vono ricevere un peso maggiore e una più netta articolazione, un effetto rinfor zato dal fatto che esse ora raddoppiano la linea del basso. L’ultima parte della progressione torna al salto di ottava che porta al si bemolle: come le prime due note acute precedenti, anche questa è separata tramite la collocazione al prin cipio di una legatura, cosa che implica un attacco appropriato. Entrambe le versioni di questo passaggio hanno un loro stile espressivo peculiare e caratte ristico. Quando si esegue questo movimento è bene non suonare le due versio
44 Parte prima: la tradizione
ni allo stesso modo (sarebbe solo pigrizia mentale) bensì seguire le indicazioni di fraseggio di Beethoven in modo da far emergere il contrasto. A meno che non vi venga in mente un’idea migliore (cosa non facile).
LEGATO, NON LEGATO, STACCATO
Sempre nel Prestissimo dell’op. 109, si trovano diversi passaggi in cui si alter nano battute con legature a battute senza legature:
I raggruppamenti di due misure 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 33-34 e 37-38 non presentano legature; mentre le troviamo a 11-12, 15-16, 19-20, 23-24 e 35-36 (le legature riprendono poi a 39-41); in aggiunta le battute 19 e 23 recano l’indica zione specifica legato. (Nella ripresa il passo da 33 a 38 viene ripetuto con l’ag giunta di una coppia supplementare di battute con legatura, dopo di che con tinua come prima). Dovrebbe essere evidente che, se si segnala ripetutamente legato, probabilmente c’è qualcos’altro che non andrebbe legato, anche se de vo ammettere, non senza vergogna, di aver eseguito questo movimento per an ni senza arrivare a tale ovvia conclusione. Per queste coppie di battute, l’autore richiede due tipi di tocco: il legato e un altro, non proprio staccato, che Beetho ven avrebbe altrove chiamato non ligato. Questo è il termine e la grafia impie gati nella fuga della sonata in si bemolle maggiore op. 106, “Hammerklavier”, alla battuta 184, specificato in entrambe le mani:
Fraseggio
45
Nell’edizione critica delle opere di Beethoven pubblicata nell’Ottocento da Breitkopf & Hàrtel c’è un comico refuso che trasforma l’indicazione non ligato in ben ligato. (In genere l’Ottocento non apprezzava molto la tecnica sette centesca del non legato-, nella prima edizione critica dei concerti di Mozart, i curatori dell’epoca aggiunsero indicazioni di legato assolutamente non autenti che a svariate dozzine di passaggi). Secondo Tiirk, che era abbastanza conservatore, il ‘non ligato’ era il tocco normale al tempo in cui scriveva (1789). Egli scrive:5
Per le note che vanno suonate al modo abituale [che non è né legato né staccato} il dito viene sollevato dal tasto un po’ prima di quanto richiesto dalla durata della nota.
Nell’edizione del 1802 del suo trattato aggiunse: Bach [cioè Cari Philip Emanuel] sostiene a pagina 112:6 “Per le note che non sono né staccate né legate, né vanno sostenute, il tasto va tenuto ab bassato la metà di quanto scritto". Ma, preso in generale, non mi sembra che questo modo di suonare sia il migliore. Infatti, 1) il carattere della composizione impone un certo numero di restrizioni sotto questo aspet to; 2) la distinzione tra la nota che è effettivamente in staccato e quella che va suonata nel modo abituale è praticamente scomparsa; e 3) se ogni nota legata fosse tenuta solo la metà del suo valore, l’esecuzione probabilmen te sarebbe troppo corta [spezzettata].
5 Die Klavierscbule, vedi nota 2 a p. 22. 6 Del Versuch uber die wabre Art das Clavier zu spielen del 1753 (“Saggio sulla vera maniera di suonare su tastiera”), [n. d. T.]
46 Parte prima: la tradizione
Quest’aggiunta probabilmente è l’espressione del nuovo interesse, a partire dal 1800, per uno stile più sostenuto. Tuttavia, quanto a volte vada ancora presa sul serio quest’indicazione ‘non ligato’ in Beethoven si può capire dal contrasto col seguente passo dell’op. 106, dove egli scrive per esteso, nella mano destra, un super legato in cui il pia nista è indotto letteralmente a confondere le note tra loro:
Nel Prestissimo dell’op. 109, il tocco non legato rende il legato successivo molto più espressivo, ed è cosa quanto mai appropriata visto che le due battu te legate delineano sempre un tritono o quarta aumentata: l’intervallo più dis sonante, e quindi più espressivo, nello stile tonale. (Ovviamente, a un tempo prestissimo non si percepisce differenza tra non legato e staccato). Beethoven stesso, in generale, non aveva alcuna predilezione per lo stile ese cutivo non legato, anzi fu uno dei compositori ed esecutori più responsabili del la svolta verso una tecnica esecutiva più sostenuta. Nel 1817, il nipote del com positore, Karl, prendeva lezioni di pianoforte da Carl Czerny, e Beethoven scris se al maestro sui tipi di tocco che avrebbe voluto che il ragazzo apprendesse: In certi passaggi vorrei che usasse qualche volta tutte le dita e anche nei passaggi come
in modo che si possano effettuare i legati; certo in questi passaggi si ottie ne un suono, come si dice, ‘periato’ (solo con alcune dita) o ‘come una perla’, soltanto che qualche volta uno desidera anche altri gioielli.7 ' Ludwig van Beethoven, Epistolario, lettera 912, traduzione di Luigi Della Croce, voi. in, Skira, Milano 2001, p. 273.
Fraseggio
47
Il 'periato' era il tocco leggermente staccato, lo stile non legato, e Beethoven preferiva una sonorità più moderna, più sostenuta. Come abbiamo visto, nonostante la sua avversione al suono staccato vecchia maniera, Beethoven spesso trovò utile tornare a usarlo: arrivò a prescrivere l’esecuzione di un passaggio solo con due dita (la diteggiatura che deplorava nella lettera a Czerny) in maniera da ottenere il cosiddetto jeu perlé. Il passaggio si trova nel movimento lento della sonata in sol maggiore op. 31 n. 1 e, parados salmente, contiene proprio la figurazione che il nipote doveva imparare a suona re con tutte le dita, anziché solo due o tre. Nel 1803 furono pubblicate due edi zioni di questa sonata. Beethoven si lamentava che la prima, stampata da Nàgeli a Zurigo, conteneva molti errori. Non si può certo dire che la seconda, quella di Simrock di Bonn, sia migliore. Riporto qui di seguito le prime sedici battute di entrambe. La notazione e il fraseggio nell’edizione Nàgeli sono più accurate, ma quella di Simrock contiene l’importante indicazione sulla diteggiatura:
48 Parte prima: la tradizione
Il passaggio di coloratura a battuta io, e ovviamente anche quello alla 12, deve essere eseguito come indicato, impiegando solo due dita, in modo da ottenere un suono appena staccato e realizzare quel leggieramente che il compositore qui richiede. (Nella scala discendente che chiude ognuna delle due misure si possono impiegare tre dita, ma già quattro produrrebbe quasi certamente un effetto di maggior legato, difficilmente evitabile se non a costo di un grande e inutile sforzo.) L’intero movimento è un’imitazione deliziosa, solo in parte umoristica, ma soprattutto affettuosa, dello stile con cui nel canto operistico tradizionale, e ormai datato, si eseguivano lunghi passaggi decorativi.8 (Quan to segue agli elaborati arabeschi delle misure 10 e 12 è segnato quasi tutto stac cato-, chiaramente non uno staccato netto, piuttosto quella sorta di portamento leggero, tipico dello stile di Mozart.) In questa composizione, un po’ per parodia e un po’ come pittura di caratte re, Beethoven usa un tocco vecchio stile che però non ha mai smesso di ritenere utile a dare spicco, per contrasto, a quel legato più cantabile a cui assegnava tanta importanza. Le varie gradazioni dal legato al non legato allo staccato erano più facili da ottenere sugli strumenti antichi perché il suono era meno spesso e si estingueva prima. Va osservato che c’è più di un tipo di legato, da quello per ottenere quasi una fusione dei suoni, come indicato da Beethoven in un esem pio precedente (p. 46), a quello in cui ogni nota è articolata anche se non sepa rata. Beethoven usava la sonorità così come usava i procedimenti compositivi. Non abbandonò mai nulla della tradizione musicale in cui era cresciuto, ma l’ampliò e la rese più varia nei modi più inaspettati. Anche le sue ultime com posizioni pianistiche hanno passaggi in cui il suono ricorda le sfumature e la trasparenza di Haydn e di Mozart. Allo stesso modo, gli ultimi quartetti hanno passaggi che richiamano l’eleganza di scrittura dei quartetti degli anni ’80. 8 Per quel che riguarda il fraseggio tipico dello stile classico, si noti che alla fine della bat tuta 6 la legatura si interrompe prima dell’inizio della 7, e che la legatura successiva termina su un trentaduesimo che è certamente legato alla nota seguente. In entrambi i casi il suono successivo è accentato e proprio per questo non è incluso nella legatura. Nel resto della bat tuta 7, però, l'edizione Nàgeli fa proseguire la legatura che iniziava sul sol fino al fa al termi ne del motivo decorativo, perché questa nota non va accentata e deve essere lasciata subito e in piano.
Fraseggio
49
VARIETÀ DEL TESSUTO MUSICALE E DRAMMATURGIA
Tranne che in opere di bonaria ironia come l’op. 31 n. 1, non c’è mai in Bee thoven un uso protratto della tecnica esecutiva antiquata dello staccato o non legato di per sé, ma solo come mezzo per ottenere una varietà più interessante di trame sonore. La sonorità con le note separate di solito è subito seguita da un tipo di tocco differente. Il tema principale della sonata in do minore op. 111 (citato a p. 31) è enunciato prima in staccato, e poi con un tipo di suono sem pre staccato, ma più pesante e più espressivo. Quando lo riespone, Beethoven
Dovrebbe essere evidente che all’inizio il motivo suona ancora tutto staccato, poi con un portamento più pesante e rallentato, e infine, per la prima volta, completamente legato-, esso attraversa l’intera gamma dei modi di tocco possi bili. Il motivo diventa ogni volta più espressivo. La gerarchia del tocco è im portante. Il tema principale del finale della sonata in mi bemolle maggiore op. 27 n. 1 è variamente fraseggiato in modo da rinforzare, ogni volta che ricorre, la nuo va funzione del tema. Questo si vede subito nelle prime otto battute osservan do i vari motivi tra le due mani:
50 Parte prima: la tradizione
18
Le semicrome della mano sinistra nelle prime due misure non sono legate; è particolarmente difficile ottenere questo suono staccato al basso sui pianoforti gran coda attuali, perché oggi il registro spesso è così denso che il suono non decade abbastanza velocemente; per eseguire questa sonata bisogna scegliere uno strumento con un registro grave relativamente chiaro e brillante, con una sonorità leggera. Il suono leggero e distaccato delle prime due battute contra sta meravigliosamente col più pesante legato in crescendo delle due mani che si impennano verso l’alto. Lo schema è ripetuto nelle quattro battute successive, ma questa volta tutto quanto in forte (nella misura otto, la chiusa corta e priva di accento subito prima della pausa richiede un diminuendo del precedente sforzando). Il fraseggio del motivo iniziale alla mano destra viene alterato a battuta 5 eli minando la prima legatura per adeguarlo alla nuova dinamica più forte. All’ini zio del movimento la qualità di suono della mano destra contrasta con i sedice simi separati della sinistra: il motivo comincia con una delicata inflessione pro dotta dalle due note della prima misura, una legata e l’altra alleggerita. Quan do però si ripresentano in forte alla battuta 5, non c’è legatura e fi secondo suo no non è, al contrario di prima, un elemento più debole. Sedici battute dopo, al tema principale viene assegnata una nuova funzione e le due note divengono fortemente accentate, separate ma non in staccato, mentre il resto del tema ora è modificato da un tocco staccato subito ripropo sto delicatamente in eco, con un effetto di scherzando:
Il motivo ritorna nello sviluppo per inserirsi in un fugato. Qui è in staccato sia nel forte che nel piano:
Nelle battute da 121 a 129 (con preannuncio dalla 108) si incontra il motivo di due suoni in diminuzione, dapprima staccato e in forte, poi con un piano im provviso che trasforma il tocco in un legato uniforme che si protrae per tre mi-
Fraseggio
51
sure. A ogni comparsa del tema corrisponde un nuovo stile di esecuzione che ne fa emergere il carattere. L’ultima trasformazione del motivo di due note si trova proprio alla fine della composizione, nella coda, marcata Presto: 266
Nella battuta iniziale di questo movimento, la seconda nota era lasciata delica tamente, ma qui nella coda le due note strutturano una progressione ascenden te e alle battute 268 e 272 è la seconda nota che riceve l’accento, con uno sfor zando che risponde in maniera grottesca e decisa al basso sincopato.9 Il significato del motivo di due note è reinterpretato a ogni passo, e ogni vol ta richiede una nuova forma di esecuzione: 1) legato, piano e concluso senza accento, 2) non legato, forte e con due note dello stesso peso, 3) entrambe le note decisamente accentate, 4) entrambe le note molto staccate, 5) staccato e le gato misti a improvvisi cambiamenti di dinamica, e infine 6) legato con crescen do continuo e la seconda nota più forte della prima con uno sforzando sincopa to. Dovrebbe esser chiaro che in questa progressione il motivo guadagna con tinuamente forza e veemenza. I cambiamenti di fraseggio e di tocco sono quin di parte integrante della ‘drammaturgia’, cioè della concezione dello sviluppo drammaturgico. Questi procedimenti di Beethoven hanno dei precedenti, so prattutto nelle opere di Haydn,10 ma mai prima di lui si erano viste delle tra sformazioni su così larga scala di un’idea musicale per tocco, dinamica e fra seggio. E neppure se ne vedranno più. Ecco una delle tante ragioni per cui è così affascinante eseguire queste sonate.
9 L’inizio della coda prima suddivide il nuovo tema di quattro misure in gruppi di due bat tute, poi ripete la frase riunendo tutte e quattro le battute sotto una legatura. Siccome il manoscritto autografo è andato perduto, non possiamo sapere con certezza se questa era l’in tenzione di Beethoven o quella dell’incisore. 10 Vedi i commenti di James Webster in “The Significance of Haydn’s Quartet Auto graphs for Performance Practice” (“L’importanza degli autografi dei Quartetti di Haydn, nella prassi esecutiva”), soprattutto alle pp. 76-78 e 80-82, contenuto nel volume The String Quartets of Haydn, Mozart and Beethoven, a cura di Christoph Wolff, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1980.
Tempo
Suonare un pezzo di musica a un tempo sbagliato non è un crimine: non si rischia la prigione e neanche di essere multati. Secondo certe correnti di este tica, contravvenire alle intenzioni dell’autore è immorale, ma talvolta può anche rivelarsi una buona idea. A tutti sarà capitato di ascoltare esecuzioni che presentavano scelte di tempo arbitrarie e perfino assurde, che però finivano col rivelarsi istruttive, toccanti o molto efficaci. Il tempo sbagliato potrebbe esse re più efficace di quello corretto. Ciò porta alcuni musicisti a concludere che il tempo giusto non esiste e questo potrebbe esser vero per certi stili musicali in certi periodi. Non di meno, evidentemente Beethoven pensava che ci fosse un tempo giusto per ognuna delle sue composizioni, anche se non è del tutto chiaro se lui stesso lo conoscesse o lo stabilisse correttamente. I compositori spesso scrivono note sbagliate (ce ne sono abbastanza nei manoscritti di Beethoven, ma non quante se ne trovano in quelli di Debussy o di Schonberg, il quale detiene il record in questo campo), e quindi possono anche scrivere un tempo sbagliato o mal valutare un’indicazione metronomica. Comunque, an che se decidiamo di suonare a un tempo non autentico o sbagliato (per motivi di efficacia, o anche solo per essere originali), è bene sapere quale sarebbe il tempo giusto e come fare per individuarlo. E fondamentalmente errato ritenere che un tempo con cui oggi ci sentiamo a nostro agio debba essere quello corretto. Gli strumenti sono cambiati, le sale da concerto sono differenti e le abitudini di ascolto si sono modificate. Anche la nostra sensibilità è diversa oggi. È vero che la maggior parte dei tempi a cui oggi si esegue Beethoven pongono pochi problemi. Tuttavia, se andiamo a stu diare il modo in cui usava le indicazioni agogiche, vengono fuori diverse sor prese. Noi abbiamo la cattiva abitudine di scartare un tempo che non ci è con geniale, che ci mette a disagio, dicendo che Beethoven deve essersi sbagliato, o che il copista o l’incisore han fatto un errore. In alcuni rari casi Beethoven, come tutti i compositori, può anche aver sbagliato, ma per poterlo sostenere dobbiamo sempre fornire qualche prova; una reazione istintiva non basta. Appiattire quegli aspetti di Beethoven che ci prendono alla sprovvista può risultare comodo, ma rischia di cancellare qualcosa della sua straordinaria individualità. Dobbiamo esser sempre preparati a una nostra eventuale diffi denza iniziale verso le indicazioni di Beethoven, e in qualche caso saremo obbligati a trovare, anche per i brani a noi più familiari, modi diversi di esecu-
Tempo
53
zione che diano spazio all’originalità e alla specificità del compositore. Ovviamente, alla fine dobbiamo adottare un tempo che renda l’esecuzione possibile e agevole, o che quanto meno si avvicini a questo. Ma le cose impor tanti sono evitare il rifiuto immediato di un tempo che sentiamo estraneo o scomodo, ed esser capaci, quando necessario, di rifiutare un’interpretazione che si presenti ingannevolmente facile.
I ‘TEMPI ORDINARI’ E IL METRONOMO
Il 18 dicembre 1826, Beethoven scrisse alla casa editrice di Bernhard Schott & Figli di Magonza: Quanto prima Le saranno inviate le indicazioni metronomiche. Le aspet ti. Nel nostro secolo queste indicazioni sono assolutamente necessarie; ho pure ricevuto lettere da Berlino in cui mi si informa che la prima esecu zione della Sinfonia [numero 9] è stata accolta con applausi entusiastici, e credo che il merito sia in gran parte da attribuire alle indicazioni metro nomiche. Non possiamo quasi più andare avanti con i tempi ordinari, se seguiamo le idee del libero genio S In questa lettera affiorano alcuni dei problemi connessi con le indicazioni di tempo in Beethoven. I ‘tempi ordinari’ sono tempi standard, cioè, in questo caso, sono indicazioni semplici e convenzionali come allegro, allegretto, an dante, e così via. Il New Grove Dictionary (alla voce ‘tempo ordinario’) cita questa lettera fraintendendo il plurale ‘tempi ordinari’ come se fosse un sin golare, e in base a questo sostiene che Beethoven stesse descrivendo “quel tempo ordinario generico che non richiede alcuna indicazione agogica espli cita”. Ma i tempi standard della fine del diciottesimo secolo non sono la stes sa cosa del tempo standard, o ‘tempo ordinario’, all’epoca di Hàndel, il quale è basato grossomodo sul ritmo del polso.1 2 I ‘tempi ordinari’ della seconda metà del diciottesimo scolo sono più d’uno, stabiliti per convenzione e più rigidamente definiti. Ciò che Beethoven dice nella lettera è che i tempi standard del diciottesimo secolo non sono più accettabili “nel nostro secolo”; in altre parole il genio del diciannovesimo secolo necessita di tempi meno convenzionali e di sfumature più sottili. A noi può sembrare paradossale che delle indicazioni metronomi1 Ludwig van Beethoven, Epistolario, lettera 2244, trad, di Luigi della Croce, voi. vi, Skira, Milano 2007, p. 351. 2 La descrizione più convincente del significato del termine nella prima metà del diciotte simo secolo si trova nel saggio di Robert L. Marshall, “Bach’s tempo ordinario'. A Piaine and Easy Introduction to the System” (“fi tempo ordinario in Bach: una chiara e semplice intro duzione al sistema”), contenuto in Critica Musica: Essays in Honor of Paul Brainard, a cura di John Knowles, New York 1996, pp. 249-278.
54 Parte prima: la tradizione che possano generare maggiore libertà, però fu proprio grazie al metronomo che si poterono indicare. Ovviamente, Beethoven era consapevole del perico lo che comportava la costrizione imposta dal metronomo. Nel manoscritto del suo Lied Nord oder Siid scriveva:
100 secondo Màlzel, ma questo tempo può valere solo per le prime bat tute, in quanto anche il sentimento ha un suo tempo, che non può essere completamente espresso in questo numero.3 Qui entra in questione come vadano interpretate le indicazioni metronomiche di Beethoven, e su questo dovremo tornare. Altrettanto cruciale è che Beethoven asserisca implicitamente che prima i tempi standard erano accettabili. Se “nel nostro secolo” non sono più tollera bili, ciò significa che prima erano utili e validi. Questo ci pone il problema di capire cosa si intendeva a quell’epoca con ‘tempi ordinari’, un tema che aveva già occupato Beethoven alcuni anni addietro. Nel 1817 scriveva al musicista viennese Ignaz Franz Edler von Mosel, in una lettera molto citata:
Mi fa veramente piacere che Lei condivida le mie opinioni circa le indi cazioni di tempo che risalgono ancora alla barbarie della musica, infatti, tanto per fare un esempio, che cosa può esserci di meno ragionevole di un’indicazione come allegro, il cui significato denota qualcosa di lieto, di festoso, e simili, mentre spesso siamo lontani da tale idea al punto che il brano in questione può esprimere addirittura il contrario [...]. Diverso è il caso delle parole che definiscono il carattere della composizione e alle quali non possiamo rinunciare perché, se il tempo è propriamente il corpo, esse si riferiscono allo spirito della composizione - Quanto a me, già da molto tempo ho pensato di abbandonare queste assurde denomi nazioni di allegro, andante, adagio, presto-, il metronomo di Màlzel ci offre la migliore opportunità di farlo. Le do qui la mia parola che non le userò più in nessuna delle mie nuove composizioni.4 Come sappiamo, Beethoven non mantenne la parola e non abbandonò i vec chi termini standard allegro, andante, adagio, presto. In generale continuò a servirsi della terminologia italiana, sostituita da quella tedesca solamente per un breve periodo intorno al 1815. Risulta però chiaro il disagio provocato da un significato confuso, ambiguo: i termini standard esprimevano il carattere del brano oppure una certa veloci tà di esecuzione? È chiaro che per un musicista della fine del Settecento alle gro non aveva un significato letterale. Il termine era usato come oggi, ossia solo come una indicazione neutrale di tempo, anche se in seguito si sviluppò gra5 Alexander Wheelock Thayer, Ludwig van Beethovens Leben, vol 4, Breitkopf & Hàrtel, Leipzig 1907, p. 66. Ibidem, pp. 66-67.
Tempo
55
dualmente un collegamento secondario con un movimento di un certo peso e di una certa ampiezza. Lo stesso avvenne per adagio, che passò non semplicemente a significare lento, ma anche genericamente a connotare un brano dal carattere serio e meditativo (a metà del diciottesimo secolo designava anche un movimento che richiede ornamentazione, sia essa scritta o da improvvisare). Le confusioni nacquero dal fatto che certi tempi cominciarono a essere asso ciati a certi caratteri e forme di sentimento, o tropi, per usare un vocabolo di moda oggi. Tuttavia non possiamo ignorare che Beethoven dà chiaramente per sconta to che il termine ‘tempi ordinari’, come indicazione di velocità, a quell’epoca fosse ben compreso dai musicisti (ossia, era generalmente accettato ed effica cemente applicato); e neppure che, per quanto possa aver alterato e piegato ad altri usi le pratiche che aveva appreso in gioventù, egli rimase sempre radicato in quella tradizione, anche nell’ultima parte della sua vita. Questo significa che all’inizio della sua carriera dei termini standard come allegro, allegretto e andante erano considerati come indicatori più o meno precisi di velocità, una sorta, potremmo dire, di proto-indicazioni metronomiche prima dell’invenzio ne del metronomo. Uno studio sulla musica tra il 1780 e il 1800, infatti, rive lerebbe degli usi relativamente coerenti di alcuni di quei termini, anche se si incontrerebbero inevitabilmente anche usi anomali. Ora è necessaria un’ulteriore precisazione: la comprensione dei ‘tempi ordi nari’ non aveva dimensione internazionale, e neanche nazionale, ma solo muni cipale. Come nel diciottesimo secolo ogni città poteva avere un diapason diver so, così ogni cultura musicale intendeva le indicazioni di tempo come parte del suo idioma locale. Quando Mozart era in viaggio in Italia scrisse al padre che gli italiani nelle loro partiture scrivevano presto ma suonavano allegro-, eviden temente il presto viennese era più rapido di quello italiano. Alla fine del Settecento, Vienna era una città piccola in base ai criteri moderni, e il numero di musicisti professionisti e di dilettanti entusiasti era relativamente modesto e compatto; formavano un sottogruppo sociale in cui probabilmente tutti cono scevano tutti. Non solo le indicazioni di tempo di Haydn e Mozart sono più coerenti di quanto si creda, ma anche l’uso beethoveniano dei termini standard resta in larga misura in linea con quello dei suoi predecessori. Per esempio, il famigerato 138 alla minima dell’Allegro dell’op. 106 di fatto corrisponde a un allegro mozartiano perfettamente normale; la difficoltà nasce qui dal fatto che, rispetto a Mozart, Beethoven è sia più difficile da suonare sia più complesso da ascoltare. Sappiamo comunque che egli non si preoccupava spesso dell’agio dell’esecutore o dell’ascoltatore. D’altra parte determinare oggi esattamente cosa significhino i termini standard in un’epoca in cui non esistevano né il metronomo né le registrazio ni è una questione molto delicata (il metronomo entrò nell’uso generale nel 1813, sebbene già in precedenza esistessero strumenti simili ma rudimentali). Di segni metronomici (come quelli di Hummel e di Czerny per le sinfonie di Mozart) apposti a una partitura venti o trent’anni dopo la sua creazione non
56 Parte prima: la tradizione
sempre ci si può fidare, anche se sicuramente in parte rappresentano la pras si coeva; lo stile d esecuzione, però, può conoscere cambiamenti radicali anche nell arco di una sola generazione, quando i figli si rivoltano contro i padri. Ci sono stati tentativi di illustri studiosi di stabilire il significato delle indicazioni agogiche come erano usate negli ultimi decenni del diciottesimo secolo. I più famosi e quelli che hanno avuto maggior influenza sono gli studi di Rudolf Kolisch? Ciò che è particolarmente valido nel lavoro di Kolisch è che prende in considerazione opere con carattere affettivo e tessitura ritmi ca simili. Alla fine, però, le sue raccomandazioni di tempo derivano molto più dalla tradizione esecutiva sviluppatasi nell’Europa centrale al termine del diciannovesimo secolo e all’inizio del ventesimo, che non da un riesame delle testimonianze contemporanee sulla pratica durante la vita di Beethoven. Per esempio, il 30 alla minima da lui suggerito per il movimento d’apertura del quartetto in do diesis minore op. 131 ha più a che fare con l’aura di sublime che circonda questo lavoro che con l’indicazione adagio ma non troppo e molto espressivo data dall’autore: neppure un semplice adagio, togliendo il ma non troppo, sarebbe stato eseguito così lentamente mentre l’autore era in vita. Il lavoro di Kolisch è una guida di inestimabile valore alla storia della rice zione delle opere di Beethoven come emerge dal carattere delle esecuzioni. L importanza di questo aspetto, però, potrebbe essere sottovalutata. Per molte composizioni potremmo anche sostenere che una tradizione interpre tativa elaborata in decenni di esperienza potrebbe essere in grado di cattura re i valori più significativi della musica di Beethoven meglio che non un mero tentativo di recuperare la prassi esecutiva dei suoi contemporanei. In breve, potrebbe essere una buona idea suonare il primo movimento dell’op. 131 a un tempo impensabile negli anni venti dell’ottocento, ma dobbiamo esser consapevoli che la nostra esecuzione è una radicale revisione delle intenzio ni dell autore, come testimonia, in modo inequivocabile, l’espressione ma non troppo. In genere ancora oggi la metodologia di queste ricerche, anche di alcuni dei più dotti tentativi di recuperare ‘l’autenticità’, purtroppo è guidata, almeno in una certa misura, dal metodo che usiamo per determinare il tempo di un’ope ra del diciannovesimo o del ventesimo secolo: il sistema normale e in apparen za più ragionevole è di prendere in considerazione prima il testo musicale, e solo successivamente l’indicazione di tempo (poniamo, un andante) cercando di adattare la musica a un ritmo che suoni come un andante. Ma se andante è già in qualche misura un tempo standard predefinito grosso modo equivalen te per i contemporanei del giovane Beethoven a un’indicazione di metronomo, allora il modo di procedere moderno andrebbe ribaltato. In altre parole, se nei primi anni di attività di Beethoven per un compositore andante aveva qualco5 Rudolf Kolisch, “Tempo and Character in Beethoven’s Music”, Musical Quarterly voi 77, n. 1 e 2, 1993.
Tempo
57
sa come un significato standard, allora la velocità del brano era già decisa: non era un’incognita da risolvere ma era un dato. Non bisognava andare alla ricer ca di un tempo che facesse suonare il brano come un andante-, l’indicazione 'andante’ era il tempo. Quello che bisognava cercare, invece, era come suona re la musica al tempo dato in modo efficace. Ciò che rendeva il procedimento più complesso è che a volte il significato di andante poteva variare un poco a seconda della forma e del tipo di composizione in questione. Ma anche questa varia tipologia era, in larga misura, fissata per convenzione. Benché nel diciannovesimo secolo l’indicazione di tempo sia generalmente un’indicazione di carattere più che una notazione precisa della velocità neces saria, per la musica del periodo precedente è più spesso vero il contrario. Nonostante la confusione tra carattere e tempo, che in parte già esisteva nel diciottesimo secolo, è chiaro che Beethoven pensava i termini allegro, adagio, e così via, sostanzialmente come indicazioni di velocità standard, anche se ave vano connotazioni affettive. In esse, però, gli mancavano le gradazioni più sot tili di cui aveva bisogno per la sua musica innovativa, sicché il metronomo risultava utile per comunicare all’esecutore sfumature più sottili, sebbene anch’esso, alla fine, fosse una misura troppo rigida per consentire l’elasticità di tempo che il ‘sentimento’ richiedeva. Pertanto dobbiamo iniziare a presumere una relativa coerenza di significato nelle indicazioni di tempo tra il 1770 e il 1800, ed è sorprendente verificare quanto questa assunzione si dimostrerà vali da se non applicata in maniera irragionevolmente rigida. È significativo che Beethoven, nella sua lettera all’editore Schott, affermi che il metronomo serve per fissare i tempi non convenzionali, non standard, che per la loro particola rità permettono al genio di creare opere con un andamento peculiare, e al di fuori dei cosiddetti tempi ordinari. Questi erano ampiamente intesi per comu ne consenso nell’ambito della piccola e omogenea società musicale viennese, che non avrebbe avuto bisogno di uno strumento meccanico come il metrono mo per trovare l’accordo su questioni significative che erano accettate colletti vamente. Fu anche il desiderio di tempi non convenzionali a stimolare l’impie go del metronomo. Certamente, oltre a questa funzione lo strumento di Màlzel servì anche a comunicare agli stranieri (barbari quali inglesi e russi) quale fosse il movimen to standard corretto. Haydn ebbe personalmente l’opportunità di recarsi a Londra a insegnare agli inglesi come eseguire le sue sinfonie, ma né Mozart (dopo i suoi viaggi da bambino e adolescente) né Beethoven si mossero da Vienna (a parte il famoso soggiorno di Mozart a Praga). Fu nel primo decen nio dell’ottocento che gradualmente la reputazione di Mozart e di Beethoven si consolidò al di fuori dell’Austria e nei paesi limitrofi; essa si impose soprat tutto a Parigi e Londra, dove nel 1810 erano considerati i massimi composito ri moderni di musica strumentale. L’invenzione del metronomo avvenne subi to dopo questi eventi e Beethoven ne fu un promotore entusiasta. Lo strumen to di Màlzel fu un motore utile nella campagna viennese di colonizzazione della vita musicale europea.
58 Parte prima: la tradizione UN ESEMPIO: L’ALLEGRETTO CLASSICO
Beethoven spesso, ma non sempre, voleva tempi che non coincidevano con quelli standard, ‘ordinari’, nella cultura musicale viennese, perciò la prima cosa da fare è cercare di capire come funzionassero questi tempi ordinari: è questa la tradizione esecutiva, il contesto dal quale la sua musica derivava il suo significato.6 Forse l’indicazione di tempo più semplice da investigare è l’alle gretto in tempo binario, che presenta una maggiore omogeneità rispetto alla più varia tipologia dell’allegro. Soprattutto possiamo guardare a un genere convenzionale, l’allegretto finale, anche se in parte coincide con {’allegretto come movimento lento; questo genere di finale si presenta anche in due tipi di forma: il rondò e la serie di variazioni, ma il tempo rimane abbastanza costan te se applicato a quelle forme. Nel caso deW?allegretto finale, abbiamo la fortuna di avere un brano che ci consente di stabilire una velocità con considerevole precisione, perché presen ta un certo numero di ritmi differenti disposti in una successione controllata di accelerando e c’è solo un tempo che permetta di realizzare questa progres sione agevolmente. Il brano è il finale del concerto in sol maggiore K. 453 di Mozart, una serie di variazioni tutte in tempo alla breve. Questo lo schema su cui si basa: 1) 2) 3) 4)
Tema in semiminime Prima variazione in crome Seconda variazione in terzine di crome Terza variazione in semicrome
6 Nel saggio The Tempo Indications of Mozart (Yale University Press, New Haven, London 1988), Jean-Pierre Marty ha utilmente compilato un elenco delle indicazioni di tempo in Mozart, e alcune sue classificazioni in categorie sono persuasive. Quello che non convince, invece, sono le enormi differenze di interpretazione di termini quali, per esempio, andante o altre indicazioni agogiche standard. Un segnale pericoloso appare già a pagina x della Prefazione, dove parlando del movimento lento del concerto in do maggiore K. 503, Marty arriva alla conclusione che sia quasi impossibile eseguire “le semibiscrome della bat tuta 98 a una velocità superiore a 44 [alla semiminima]”. Ma il termine andante va applica to alfe note da un quarto, quindi i sessantaquattresimi devono effettivamente risultare molto veloci. Il 44 proposto da Marty non si distingue da un largo, ed è dubbio che un’indicazio ne come andante potesse variare da 44 a 96, come egli crede. La maggior parte delle valutazioni di Marty si basa su registrazioni moderne più che sulle indicazioni di metronomo fornite da Hummel e da Czerny: è vero che queste risalgono a molti anni dopo la morte di Mozart e contengono già alcune interpretazioni chiaramente distorte, e dunque non possono essere accolte acriticamente, ma comunque esse ci danno un’idea migliore di Quanto non possa fare una prassi esecutiva sviluppatasi gradualmente nell’arco di due secoli semplicemente scegliendo volta per volta la velocità più comoda. È vero che non possiamo ignorare la tradizione esecutiva più tarda, ma questa in alcuni casi ha prodotto clamorosi fraintendimenti che oggi gli studiosi stanno a poco a poco cercando di correggere.
Tempo
59
60 Parte prima: la tradizione
Tempo
61
62
Vlc.e Cb.
Parte prima: la tradizione
Tempo
(£>
64 Parte prima: la tradizione
L’allegretto ottocentesco comporta un tempo più rapido di quello settecente sco, perciò molti pianisti lo attaccano un po’ troppo velocemente e sono poi costretti a rallentare a mano a mano che le variazioni procedono. Ma se Mozart passa dalle semiminime alle crome, poi alle terzine di crome e infine alle semi crome sembra evidente che egli ha in mente un incremento del .moto per passi discreti entro un quadro unitario (ci sono una serie di variazioni in cui vanno introdotti dei cambiamenti di tempo, come le Variazioni Diabelli dì Beethoven, ma molte altre richiedono una pulsazione costante, e qui la notazione di Mozart di accelerando controllato ovviamente richiede un tempo unitario). La velocità massima a cui l’oboe e il pianoforte possono eseguire la terza variazione senza che essa risulti caotica corrisponde a 76 all’unità di tempo di pulsazione, che, trattandosi di C tagliato alla breve, è la minima. Per il tema que sto è un tempo piuttosto moderato, all’inizio, ma alla terza variazione i sedice simi saranno suonati a 152 alla semiminima, che è già abbastanza brillante. Cominciare con un andamento più rapido e poi rallentare le variazioni, come si ascolta in alcune esecuzioni, distrugge uno dei più notevoli effetti mozartiani: l’accrescimento simultaneo dell’eccitazione ritmica e del lirismo. L’inizio di ogni frase della terza variazione richiede un cantabile più intenso di tutto quel che si è sentito prima, e al tempo stesso la fine di ogni sezione introduce un vir tuosismo più brillante di quello richiesto negli abbellimenti della seconda varia zione. Non attenersi strettamente al tempo nel passare dalla seconda alla terza variazione significa vanificare una delle più riuscite ispirazioni di Mozart. E importante notare che il movimento termina con una coda in presto nello stile di una ouverture di opera buffa, in cui il tema principale viene suonato al doppio della velocità. A quell’epoca l’aumento del tempo in una composizio ne spesso seguiva il rapporto di uno a due, così ora nel presto il 76 del metro nomo si riferisce alla semibreve (il doppio di 76 alla minima àeWallegretto), e l’intero movimento è dunque concepito in un’unica pulsazione:
Tempo
65
Capita raramente di poter stabilire con una qualche certezza la velocità di una composizione del passato; nel caso del concerto in sol maggiore di Mozart possiamo riuscirci solo perché la logica dello schema mozartiano esige che, per avere un senso, il tema e le prime tre variazioni vengano suonate tutte allo stesso tempo, e solo 76 si adatta alla sequenza così meravigliosamente conge gnata. Quando nel 1815 Beethoven appose le indicazioni di metronomo alle sue sinfonie, l’unico movimento marcato semplicemente Allegretto senza ulteriori specificazioni fu il secondo tempo in 2/4 della settima sinfonia. È indicato 76 alla semiminima, e corrisponde esattamente al 76 alla minima di Mozart per il C tagliato alla breve (dovrebbe esserci una differenza tra 2/4 e 4/4 alla breve, e forse c’è, da un punto di vista teorico e talvolta psicologico, ma in pratica, come vedremo, i due di solito coincidono): Allegretto. J=?6 Rliiacr
Nell’ottava sinfonia, invece, il secondo movimento è un allegretto vivace, e viene conseguentemente segnato poco più veloce da Beethoven: croma = 88. È in tempo binario 2/4, ma il tipo di notazione impiegata rende gli ottavi equi
66 Parte prima: la tradizione
valenti ai quarti della settima sinfonia (e ovviamente alle minime del finale alla breve del concerto k. 453 di Mozart). E chiaro che il significato di allegretto non sempre è alterato dal carattere o dalla funzione del movimento, e neppure da una notazione alla breve. Il movimento lento della settima sinfonia di Beethoven e il finale del concerto di Mozart recano la stessa indicazione di tempo anche se il loro significato espressivo e il loro posto all’interno, rispettivamente, della sinfonia e del con certo sono molto diversi. Dobbiamo nuovamente sottolineare però che, per Beethoven come per Mozart, allegretto è un tempo molto più lento di quan to non diventerà più avanti nell’ottocento. Nel terzo quarto del diciottesimo secolo allegretto aveva una connotazione affettiva, ossia si applicava, come scrisse Leopold Mozart, a una composizione artig, tàndelnd und scberzhaft1^amabile, giocosa e scherzosa”); esso, però, per lo più perse questo significato, come mostrano il movimento lento della settima sinfonia di Beethoven e molti esempi di Mozart. Come anche allegro, intorno al 1790, non ebbe più la funzione di connotare un affetto, e divenne fondamentalmen te un’indicazione di velocità. Successivamente, nel diciannovesimo secolo, l’indicazione allegretto recuperò in parte la sua accezione di ‘allegro spensie rato e aggraziato’, ma fu un processo che richiese vari decenni (il Dona nobis pacem della Missa solemnis di Beethoven, per esempio, è segnato allegretto vivace, ma non è affatto ‘amabile, giocoso o scherzoso’). In seguito divenne non solo più leggero ma anche considerevolmente più veloce: l’allegretto fina le del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Brahms è segnato 104 alla semiminima, cioè il 30% più rapido di un allegretto dell’epoca preceden te, per il quale il valore medio era all’incirca 76. L’unico altro movimento sin fonico che Beethoven chiama semplicemente allegretto, senza ulteriori speci ficazioni, è il finale della sesta sinfonia, che però è in 6/8 ed è indicato 60 alla semiminima puntata, un tempo molto tranquillo, certo più lento di come non venga eseguito da molti direttori. Per comprendere ^allegretto di Beethoven bisogna anzitutto collocarlo all’interno della tradizione in cui il compositore crebbe, e rendersi conto che ebbe un uso relativamente coerente. Il termine venne spesso impiegato da Mozart per certe tipologie di movimento, la più importante delle quali era il finale. Siccome anche Beethoven continuò a produrre finali di questo tipo, seb bene meno spesso di Mozart, è opportuno qui un breve panorama della prati ca mozartiana. Gli esempi sono molti e risulta evidente che una pulsazione di circa 76 all’unità di base della battuta (sia essa in 2/4 o in 4/4 alla breve} può essere accettata come un tempo ordinario. Non voglio dire che ogni allegretto di Mozart vada staccato precisamente a 76, ma solo che come valore medio può fornire uno standard che poi può essere adattato dall’esecutore. Il rondò finale alla breve della sonata per pianoforte e violino forse più eseguita, quella in si bemolle maggiore K. 454, rientra nella suddetta categoria: ' Vedi la voce “Allegretto” nel New Grove Dictionary.
Tempo
67
Qui il 76 alla minima, relativamente lento, è imposto dall’ultima pagina, dove l'abituale brillantezza richiesta viene messa in luce dalle semiminime corri spondenti a 152:
La serie di variazioni che conclude la sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore K. 481, composta un anno dopo, nel 1785, è scritta in 2/4.
68 Parte prima: la tradizione
THEMA
Qui il tempo di 76 alla semiminima si impone, come avveniva nel finale del concerto in sol maggiore e nella sonata per violino in si bemolle maggiore. La quinta variazione introduce delle terzine di sedicesimi (a) e poi quartine di trentaduesimi (b):
VAR.V
Tempo
69
La variazione finale, un allegro in 6/8, risulterà quasi il doppio più rapida se suonata a 66 alla minima puntata, cosa molto efficace e non troppo difficile. L’apertura in allegretto dell’ultimo movimento della sonata per pianoforte e violino K. 306 va eseguita a una velocità simile:
mentre la qualificazione di grazioso per Vallegretto del rondò finale nella sona ta per violino e pianoforte k. 376 potrebbe implicare una tacca circa di metro nomo in meno. Il movimento finale della grande sonata per violino e pianofor te in sol maggiore K. 379 è una serie di variazioni in 2/4 il cui tema è marcato andantino cantabile, ma al termine della composizione il tema riappare come un allegretto:
e le biscrome della coda di nuovo esigono una velocità di circa 76 alla semimi nima. Qui il cambiamento da andantino ad allegretto significa che il ritorno del tema non è inteso a produrre un contrasto marcato, ma solo un’esecuzione più energizzante. Sebbene per noi oggi Vallegretto sia piuttosto vicino a un allegro, magari po’ più lento e con un carattere più leggero, per i compositori tra il 1780 e il 1820 era molto più vicino -àWandante. Due lavori di Mozart ce lo provano: anzitutto il grande sestetto dal terzo atto delle Nozze di Figaro, originariamen te indicato come allegretto nel manoscritto, fu mutato in andante (riporto le misure da 1 a 24 perché più avanti tratteremo il motivo diviso tra oboe e fagotto colla parte di Marcellina e di Bartolo, che intona le parole “figlio amato” nelle battute da 17 a 24):
70 Parte prima: la tradizione
Flauti
Oboi
Fagotti
Corni in F
Violino I
Violino II
Viola
Susanna „
Marcellina
(umarmt Figaro)
(abbracciando Figaro)
r-|
. .......... ir j r
Teu-rer Sohn, o welch’ Ent-ziik-ken,lafi an’s Mut-ter-herz dich Ri-co - no-sci in que-sto amplesso
Don Curzio Der Graf Il Conte
Figaro
Bartolo
Violoncello e Contrabasso
u-na
madre,asta - to
Tempo
FIff.
Bart,
Vc. e Cb.
71
12 Parte prima: la tradizione
Tempo
73
Fl.
Ob.
Fff-
Cor. (F)
VI.
Via.
Mar.
Her
-
zens
-
jun-ge!
fi
- gito a
-
ma - to!
D.Cu.
l'i_ me - neo
ma - dre!
non pnb
ae -
or. nc.
im-mer tol-ler! im-mcr
tol -
aonamar-ri - io, son ator - di
Figaro
-
ler! to,
Fig.
Ge Pa
lieb -
El-tern!
te
ren - ti a
-
ma- til
-i—T-
Bart.
Vc. e Cb.
-
Il
f
jun-ge!
Her
ma-to!
fi
-
zens glio a-
74 Parte prima: la tradizione
FI.
Ob.
Br.
Cor. (F)
VI.
VI*.
(Susanna tritt aarf mtt etner Bórse)
(Susanna entra con una Mar.
ft
-
glioa-ma-to!
D.Cu.
l'i-me-neononpuo se - guir. t________________
no


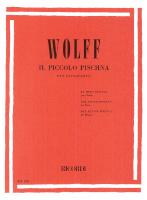





![Appunti di biochimica per le Lauree triennali [1]
9788829919079](https://dokumen.pub/img/200x200/appunti-di-biochimica-per-le-lauree-triennali-1-9788829919079.jpg)

