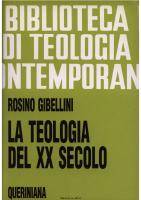La città del ventesimo secolo 8842077100
199 19 11MB
Italian Pages 220 Year 2005
Polecaj historie
Citation preview
Storia
della città
Bernardo Secchi
La città del ventesimo secolo
@D EditoriLaterza
Individuo e costruzione materiale dello spazio abitato: la città europea del ventesimo secolo è il risultato del loro continuo mescolarsi e incrociarsi in rappresentazioni diverse. In questo volume, la straordinaria stratificazione di storie e di idee che compone l’universo urbano contemporaneo.
In copertina: Frank Lloyd Wright, // cittadino dov’è?. Fotografia tratta da EL. Wright, The living city, New York 1958.
i
oe
Sd
gi
Storia della città 6
STORIA DELLA CITTÀ collana diretta da Donatella Calabi
I volumi di questa collana prendono in esame la storia della morfologia urbana dalla Grecia antica alla contemporaneità. Ciascun testo ha come tema principale
la relazione tra le destinazioni d’uso degli spazi urbani e le loro forme architettoniche e illustra le ragioni economiche, istituzionali e culturali che spiegano i più importanti processi di trasformazione degli insediamenti.
GIÀ PUBBLICATI
La città del primo Rinascimento di Donatella Calabi La città dell'Ottocento di Guido Zucconi
La città medievale di Alberto Grobmann
La città greca di Paolo Morachiello
La città bizantina di Ennio Concina
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
La città del tardo Rinascimento di Claudia Conforti La città romana di Paul Zanker
La città barocca di Joseph Connors La città del Settecento di Giovanna Curcio
Bernardo Secchi
La città del ventesimo secolo
zioni Laterza
© 2005, Gius. Laterza & Figli Prima edizione 2005
I’Editore è a disposizione di tutti gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte, là dove non è stato possibile rintracciarli per chiedere la debita autorizzazione.
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa Roma-Bari
Finito di stampare nel luglio 2005 Poligrafico Dehoniano Stabilimento di Bari per conto della Gius. Laterza & Figli Spa
CL 20-7710-8 ISBN 88-420-7710-0
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo
effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l'autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce
questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.
Ringraziamenti
Mentre stava scrivendo Notre-Dame de Paris Victor Hugo smarrì uno
dei suoi quaderni d’appunti e chiese all’editore di poter rinviare la consegna del manoscritto. Molto tempo dopo, durante la stesura di queste pagine, ho chiesto all’editore un analogo rinvio perché vittima del furto di un laptop nel quale il libro era quasi ultimato. Ho così imparato a fare più frequenti back up, ma soprattutto ho scoperto che un libro non si può ri-scrivere e ho dovuto impostare nuovamente e in modo diverso il mio lavoro. Ma le difficoltà che ho dovuto affrontare per scrivere queste poche pagine sono state più serie. Delle maggiori, dico nel capitolo conclusivo; tra le minori, ma non trascurabili, c’era il fatto che avevo di recente
pubblicato, sempre con Laterza, un piccolo libro, Prizza lezione di urbanistica, nel quale molte delle questioni qui prese in esame erano già trattate ad un analogo livello di sintesi. Negli ultimi anni ero poi ritornato su alcuni di quei temi in alcuni saggi. Non sta bene ripetersi, ma neppure è probabile che si possa ritornare sui propri passi tanto di frequente. Mi hanno aiutato ad uscire da queste difficoltà, e per questo li ringrazio, i miei studenti, cui quanto qui esposto è stato sottoposto in forV
ma di lezioni; discutere i loro progetti è stata spesso l’occasione per ripercorrere la storia della città europea e del suo progetto nel ventesimo secolo. ] miei assistenti Laura Mascino, Paola Pellegrini e Matteo D'Ambros con i loro studi, i loro commenti e le loro correzioni mi hanno insegna-
to molto più di quanto essi stessi credano. Le curiosità e le ricerche degli studiosi che frequentano il dottorato in Urbanistica presso l’omonimo dipartimento dell’Università IUAV di Venezia mi hanno spesso stimolato ad inseguire i sentieri che durante il secolo avrebbero potuto essere percorsi e che sono stati invece abbandonati. Matteo Ballarin ha riletto attentamente il manoscritto, evitandomi molti errori e dandomi
molti utili suggerimenti. Un ringraziamento diverso e più profondo debbo a Paola Viganò con la quale ho discusso, non sempre trovando il suo totale accordo, quasi ogni frase di questo testo; un ringraziamento debbo anche alla mia biblioteca, che ogni tanto penso sia la cosa migliore che sono riuscito a fare:
La città del ventesimo secolo
Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from Kahle/Austin Foundation
https://archive.org/details/lacittadelventes0000secc
Capitolo primo
Tre racconti
Un secolo non inizia mai il primo giorno del suo calendario e non termina l’ultimo. A seconda di come il suo tempo interno viene diviso, può essere raccontato in modi diversi. Separare il fluire della storia in periodi, dire quando ciascuno inizia e come e quando termina e perché, raccontandone i caratteri principali, è un modo di pensare il tempo, di ri-costruirlo cercando il senso del suo fluire. Un'operazione mai innocente, tanto più quando il tempo che ricostruiamo è talmente vicino a noi da essere ancora carico delle nostre passioni. Sul ventesimo secolo europeo da qualche tempo si confrontano due ipotesi, racchiudendone il senso in un periodo più corto, facendolo divenire un secolo breve (Hobsbawm, 1994), oppure, come è più abituale | per ogni periodo storico, riconoscendo che i suoi principali caratteri emergono lentamente e in un tempo più esteso, facendolo divenire un secolo lungo. L'utilità di riflettere entro questi due termini è resa a prima vista evidente dal fatto che ancora non riusciamo ad indicare il ventesimo secolo o una sua parte rilevante con parole che, mettendone in evidenza i principali connotati, ne propongano anche il centro tematico. Rinasci-
3
mento, barocco, neoclassico; gli storici futuri faranno forse ricorso a ter-
mini di questo genere, ma non ne sono del tutto certo. Le interpretazioni del secolo giungono ancora a noi come le onde sul bagnasciuga: dominano per un po’ il nostro campo visivo e immediatamente si ritraggono per lasciar posto ad altre e poi forse ritornare con nuova forma, in una continua oscillazione che impedisce di racchiudere definitivamente in una parola il senso di questi anni. Non è solo la loro vicinanza che lo rende difficile; le nostre difficoltà hanno forse a che fare
con i principali caratteri del secolo e con quelli più profondi della città. Ciò di cui ci stiamo accorgendo è che molti fenomeni sono fondamentalmente sovra-determinati, esito cioè di un numero sovrabbon-
dante di cause concorrenti. Tra questi le trasformazioni della città e del territorio. Per dire cosa intendo non trovo miglior riferimento dell’Uomo senza qualità. Come tutti sanno, il problema che Musil affronta è quello delle ragioni del primo conflitto mondiale. Esito di un numero di cause superiore a quelle necessarie, tra le quali diviene difficile stabilire ordini d'importanza e di priorità, il conflitto appare, agli occhi di Musil, un fenomeno appunto sovra-determinato, come lo sono, ad esempio, molti fenomeni meteorologici non a caso richiamati nell’ir2c:pit del romanzo. Analogamente sovra-determinate appaiono oggi le trasformazioni della città e dei territori europei. Il modo più onesto per affrontare questo problema mi sembra allora quello di proporre del ventesimo secolo diversi racconti tra loro non contradditori, ma ciascuno dei quali divide l’asse del tempo in modi diversi e ne coglie un diverso senso. Il racconto è però una forma discorsiva ambigua e di ciò occorre essere consapevoli: fa apparire ciò che viene dopo come conseguenza già inscritta in ciò che viene prima. La sto-
ria del ventesimo secolo mi appare invece ricca di biforcazioni, di percorsi prescelti, ma anche di sentieri abbandonati e d’improvvise rotture. Moltiplicare i racconti ha anche lo scopo di mostrare che lungo il secolo e nelle sue rappresentazioni avrebbero potuto essere intraprese strade diverse. 1. Primo racconto: espansione e dissoluzione della città
Negli immaginari collettivi europei, come agli occhi degli studiosi di molte discipline, il secolo ventesimo, dominato da un’aspettativa che 4
lentamente si stempera in timore, appare collocato tra due estremi: l’attesa angosciosa di una crescita indefinita e smisurata della città e il timore della sua scomparsa, della sua dissoluzione o trasformazione in forme di insediamento delle quali diviene difficile divinare i caratteri, il senso e il destino. L'inquietudine sembra percorrere il secolo e la città non sembra ad essa estranea. La crescita della città europea appare fenomeno inarrestabile sino ad almeno tutti gli anni Sessanta, sino alla fine di un periodo di forte sviluppo e modernizzazione durante il quale tutti i paesi europei e occidentali hanno potuto attingere alla grande riserva demografica del mondo rurale trasferendo verso l’industria, la città e la cultura urbana parti
rilevanti di popolazioni da secoli dedite ad attività agricole ed immerse in culture più arcaiche. Il timore della dissoluzione della città, dell’Auflosung der Stidte,
prende invece corpo e diviene preoccupazione condivisa soprattutto negli ultimi decenni del secolo, quando più elevati livelli di benessere, nuove tecniche e nuove modalità organizzative della produzione, nuovi comportamenti individuali e collettivi concorrono ad attenuare fortemente i trasferimenti di popolazione verso il nord del continente e verso le aree urbane e danno luogo ad evidenti fenomeni di dispersione insediativa. Attesa e timore non costruiscono però due periodi demarcati da una netta frontiera. I sintomi di ciò che connoterà gli anni finali del secolo, il timore della dissoluzione della città, sono già evidenti al passaggio tra Ottocento e Novecento e l'espansione urbana che ha marcato in Europa la prima parte del secolo, seguendo tendenze già chiare nel secolo precedente, prosegue amplificata nella sua parte finale in altre zone del pianeta. Se osservato da questo punto di vista, il secolo ventesimo inizia ben prima del suo primo giorno di calendario e termina, con ogni probabilità, ben oltre il suo ultimo giorno, divenendo un secolo lungo. 2. Secondo racconto: la fine della città moderna Se osservato da un altro punto di vista, il secolo appare però dominato, in una sua parte più breve e centrale, da un’idea principale: l’idea, tipicamente moderna e fatta propria da «una grande generazione» di intellettuali (Godard, 2003) — tra i quali molti architetti e urbanisti —, che la costruzione della città possa far parte di un più vasto progetto di edificazione di una nuova società, se non di un «uomo nuovo». Un'idea che
5
affonda le proprie radici nelle diverse utopie che da sempre accompagnano la cultura occidentale, ma che nei decenni centrali del secolo è declinata, con differenti gradi di chiarezza, in diversi contesti sociali e politici: nei paesi europei occidentali piuttosto che in Unione Sovietica o negli Stati Uniti d'America. La città e il territorio divengono oggetto di proposte radicali, attraverso le quali il secolo afferma la propria alterità rispetto ad epoche precedenti. Mai totalmente condivisa, quest'idea informa di sé gran parte della cultura occidentale e fa dell'urbanistica e dell’architettura la rappresentazione del sistema di valori di una società protesa al cambiamento, nonché il concreto strumento di una più ampia politica di suo rinnovamento, progresso e liberazione. Osservato da una certa distanza temporale e critica, il senso del secolo ventesimo appare allora concentrarsi in un breve periodo, cinque decenni a cavallo dell’ultimo conflitto mondiale durante i quali, pur dando luogo ad alcune delle più alte espressioni dell’architettura e dell'urbanistica europea ed occidentale, si esaurisce e giunge forse al termine un fascio di idee, di aspirazioni, di tecniche nelle quali si era rappresentata la modernità. 3. Terzo racconto: città, individuo e società Ma questo stesso periodo è stato anche interpretato, dai suoi protago-
nisti e da molti dei suoi critici, come quello di una ricerca paziente delle dimensioni fisiche e concrete del benessere individuale e collettivo; una ricerca che, pur appoggiandosi sulle esperienze del diciannovesimo secolo, ma in parziale opposizione all'ideologia che le aveva ispirate, costruisce una chiara rottura con il passato e anticipa la costruzione del Welfare State. Il che contraddirebbe l’idea secondo la quale il progetto della città sia «perennemente in ritardo, rispetto agli avvenimenti che dovrebbe controllare» (Benevolo, 1963). Se osservato da questo punto di vista, il ventesimo secolo appare costituito da tre periodi, tra loro largamente sovrapposti, ma con differenti centri tematici. Un primo periodo nel quale si esaurisce l’esperienza della società disciplinare e durante il quale la critica alla città del diciannovesimo secolo spinge verso una sua «moralizzazione». Essa si rappresenta soprattutto nelle grandi esperienze di Amsterdam e Vienna, alle
quali non è estraneo il tema del secondo periodo, dominato dalla ricer6
ca delle concrete dimensioni del welfare: una ricerca sperimentale, fat-
ta di tentativi ed errori, di avanzamenti lungo alcuni percorsi e di continui ripensamenti, che lascia però nella città europea un deposito duraturo e condiviso. Nel terzo periodo infine, per ora forse solo ai suoi inizi, i risultati faticosamente raggiunti sono sempre più frequentemen-
te contraddetti da una progressiva estetizzazione della vita individuale e collettiva, da ciò che Jacques Gubler indica con i termini di «edonismo democratico», il solo concetto veramente operativo per tutti i governi europei all’inizio del ventunesimo secolo (Gubler, 2003).
Le politiche del welfare sono così poste al centro di un secolo lungo, ma discontinuo, cui danno forse il contributo più originale. Che esse abbiano profondamente inciso sulla città fisica e sulla sua immagine non può essere messo in dubbio: i programmi di edilizia economica e popolare, ad esempio, cercano ovunque, in questo periodo, di costruire una «città pubblica» che anche ostensivamente si opponga alla città privata; attrezzature urbane, asili, scuole, ospedali, parchi e giardini, terreni e attrezzature per lo sport costruiscono una nuova geografia della città; le nuove infrastrutture della mobilità modificano gli idioritmi, le
temporalità di ciascun gruppo e individuo, danno luogo ad una nuova percezione e concezione del tempo e dello spazio e trasformano radicalmente le domande che ciascuno pone alle politiche della città. 4. Il senso dei tre racconti
Questi tre racconti dividono dunque l’asse del tempo in modi diversi e pongono l’accento su questioni differenti. Su alcuni aspetti fenomenici il primo: il crescere e il dissolversi della città. Apparentemente più semplice, il primo racconto si scontra con una questione quasi insolubile: riusciamo a conoscere la realtà solo attraverso le sue rappresentazioni, da quelle che ci appaiono ad essa più vicine, come le descrizioni, le rilevazioni cartografiche o statistiche di
volta in volta proposte, a quelle che ce ne appaiono più distanti, come le diverse teorie che di volta in volta hanno cercato di interpretare il mondo che dalle prime veniva restituito. Il primo racconto tenta di mostrare come la città si è trasformata servendosi soprattutto di studi e ricerche che hanno cercato, appunto, di descriverne, rappresentarne ed interpretarne il cambiamento.
Sul ruolo del progetto il secondo: si è soliti ritenere che, soprattutto 7
nelle economie e nelle società dei paesi occidentali, siano stati all’opera, durante tutto il secolo, fenomeni attinenti i fondamentali rapporti di produzione che politiche e progetti urbani non sono stati in grado di dominare o condizionare. Crescita, sviluppo e trasformazione della città sarebbero, in questo caso, largamente indipendenti dalla riflessione e soprattutto dall’azione di architetti, di urbanisti e delle amministrazio-
ni che ai loro progetti e piani si sono affidate per costruire un più ampio progetto sociale. Crescita, sviluppo e trasformazione della città sarebbero cioè fenomeni che, con modalità sostanzialmente identiche, si sarebbero prodotti anche senza di loro. Il secondo racconto cerca di mostrare che, all'opposto, la città del ventesimo secolo si è trasformata anche perché immaginari e pratiche costruttive sono mutati e che, in questo cambiamento, il ruolo del progetto urbanistico e di architettura, come parte di un più vasto progetto sociale, non è stato irrilevante. Sul ruolo dell’individuo e delle sue aspirazioni il terzo: l'emergere, nella cultura e nella società europea, dell'autonomia del soggetto è fenomeno lento, che si rende inizialmente visibile nel Rinascimento italiano e
ancor più in alcune parti del Nord Europa (Elias, 1987). La pittura fiamminga del sedicesimo secolo ne è una delle prime espressioni (Alpers, 1983; Todorov, 2000). Essa porta con sé una maggior attenzione alle dimensioni del quotidiano e alle dimensioni corporali della città, in una continua ricerca delle dimensioni fisiche del benessere individuale e collettivo. In Europa e nel mondo occidentale durante il secolo ventesimo questa ricerca ha praticamente investito, seppur in diversa misura e in pe-
riodi differenti, tutti gli strati sociali e tutti i paesi. Il terzo è il racconto di come questa ricerca abbia influito sulle trasformazioni dello spazio abitabile europeo e, in particolare, sulle trasformazioni della città.
Le linee di demarcazione tra i diversi periodi ritagliati dai tre racconti non coincidono con i grandi eventi che hanno segnato la storia economica, sociale, politica e istituzionale del secolo, anche se questi
hanno evidentemente avuto conseguenze profonde per la città e il territorio dei diversi paesi. La città non cambia immediatamente a seguito di questi eventi che, situati su piani differenti, scivolano l’uno sull’altro con differenti gradi di attrito e con differente capacità di trascinamento. La città cambia soprattutto come conseguenza di movimenti più
profondi delle strutture sociali e di potere, degli immaginari e delle rappresentazioni, della cultura politica e istituzionale; cambiamenti che ov-
viamente sono legati a quegli eventi, ma in modo mediato. 8
La città è sempre costruita da concreti attori portatori di specifici interessi, culture e immaginari. Essi di volta in volta incontrano specifiche condizioni locali e specifiche congiunture storiche. Il merito degli studi di casi particolari, il ruolo delle tante microstorie che accompagnano le vicende di una qualsivoglia città, il ruolo dei romanzi, del cinema, delle
poesie e della musica, delle rappresentazioni che costruiscono le tante immagini di ogni città, è quello di renderci cauti nei confronti di eccessive generalizzazioni. Il che non evita di riconoscere lungo il secolo alcune tendenze che, come onde sonore, si sono propagate, riflesse e rifratte nelle situazioni locali e nelle diverse congiunture. I tre racconti cui faccio riferimento cercano cautamente di mettere in luce alcune di queste tendenze costruendo un impalcato entro il quale possano essere inseriti le idee ed i fatti che hanno segnato il secolo ventesimo e che, non solo per ragioni di spazio, non posso permettermi di richiamare in modo esaustivo. Ma per restituire in modi più completi la storia della città europea nel ventesimo secolo ogni racconto dovrebbe essere accompagnato da tante storie che, come variazioni, ne articolino i temi principali mostrando eventualmente come essi possano generare racconti differenti.
I cambiamenti della città che di volta in volta i tre racconti mettono in luce, l'emergere, ad esempio, del frammento, dell’eterogeneità e del-
la dispersione come aspetti fondamentali della città di fine secolo opposti ai caratteri di inizio secolo, illuminano forse di una diversa luce
racconti più abituali, concentrati sul contesto geografico e istituzionale o sui grandi exerzpla e i loro protagonisti. Ciò che è però davvero rilevante è che i tre racconti che propongo costruiscono tre differenti bacini semantici nei quali il futuro della città è disegnato rispettivamente dalla paura, dall’immaginazione o dal continuo confronto con il quotidiano, mentre il passato è disegnato dalla nostalgia, dalla critica severa o dalla volontà di separarsene. AI cuore dei tre racconti, come al centro del secolo, c'è, a mio parere, il problema della libertà individuale e collettiva; vi sono, cioè, diffe-
renti idee dei rapporti tra individuo e società e, per ciò che concerne la città, modi diversi di esprimere concretamente tali idee attraverso la costruzione materiale dello spazio abitato: assicurando più elevati livelli di benessere, un quadro di vita radicalmente differente dal passato, una città che per le sue dimensioni e per le relazioni spaziali che instaura faciliti la coesione e le relazioni sociali. >
In altri termini il progetto della città diviene, lungo tutto il secolo, una parte fondamentale della costruzione della nostra idea di welfare e della nostra idea di libertà. Ciò che diviene specifico del progetto della città e che costruisce la sua identità nei confronti di altre politiche e di altre discipline sociali, è che esso cerca lungo tutto il secolo di dare una dimensione fisica, concreta, visibile alla ricerca di benessere e di libertà
con ipotesi che trovano il loro senso più profondo se collocate entro i bacini semantici costruiti dai tre racconti che propongo. Da questi bacini derivano alcune correnti di idee che si mescolano tra loro, si incro-
ciano o corrono parallele, avanzano e indietreggiano costruendo «figure» che danno senso a diversi progetti di modificazione della città (Secchi, 2000). Il risultato di questo continuo incrociarsi, sovrapporsi e mescolarsi è la straordinaria stratificazione di storie e di idee che si rappresenta nella città europea. 5. Esempi
Ho inserito tra i diversi racconti alcune schede. Esse fanno riferimento ad alcune parti di città, ad intere città o territori dei quali ho fatto concreta esperienza; nei quali ho a lungo camminato, il futuro dei quali è stato per me un concreto interrogativo, per i quali ho cercato di costruire e discutere possibili scenari e progetti. Queste città e questi territori come molti altri propongono problemi che, lungo tutto il secolo o per suoi tratti rilevanti, sono stati al centro del dibattito sulla città. Ai miei occhi almeno assumono un'importanza più generale della mia singola esperienza. Siena, ad esempio, come ogni altra città di antico regime, propone il tema del rapporto conla città antica, con la grande allegoria costruita dal patrimonio di architetture, di spazi urbani e di significati che il passato ci ha trasmesso (Choay, 1992); un tema che, differentemente declinato, per-
corre tutto il secolo: mito di una città e di una comunità perduta, analisi tecnicamente pertinente di un sapere progettuale accumulato nel tempo, complesso di colpa nei confronti di una città, quale la città contemporanea, poco amata dai suoi abitanti. Il confronto con la città antica diviene a Siena confronto tra due diversi programmi di ricerca: quello di una continua interpretazione individuale di una stessa struttura dello spazio collettivo, come nella città antica, e quello che cerca di dare un’interpreta-
10
zione collettiva ad esigenze individuali, come in gran parte della città moderna sino, almeno, agli ultimi decenni del secolo ventesimo.
Les Hauts de Rouen propongono un tema diverso: quello della distanza che intercorre tra le riflessioni, i progetti e le realizzazioni della «grande generazione», tra i grandi esempi dell’architettura e dell’urbanistica moderna nella parte centrale del secolo e la folla oscura delle realizzazioni che, specie nel secondo dopoguerra, cercano di seguirne e interpretarne i risultati; della loro riduzione e banalizzazione e delle loro ragioni. A queste realizzazioni si deve la cattiva reputazione della quale gode la città moderna nell’opinione di molti; il frequente, spesso insincero rifiuto dei risultati acquisiti durante il ventesimo secolo; il ritorno paradossale ai modelli compositivi dello spazio urbano tipici dell’ultimo Ottocento. Ma queste stesse realizzazioni, spesso criticate in modi
non corretti e ingiusti, ci invitano piuttosto a riflettere, fuori da ogni moralismo e snobismo, sulle ragioni che hanno portato ad accettare o a rifiutare alcuni dei principali aspetti della città moderna o, in termini ancora più generali, ci portano a riflettere sui processi di riduzione e banalizzazione dei grandi exerzpla che ciascuna epoca propone. Milton Keynes propone una riflessione sull'intera politica delle New Towns, su uno sforzo non solo inglese di imprimere una diversa direzione alla storia delle città; uno sforzo analogo a quello della «grande generazione» anche se condotto su un terreno diverso. Città costruita per una società che ha raggiunto ragguardevoli livelli di welfare individuale e collettivo, Milton Keynes è anche rappresentazione delle sue derive estetizzanti e vuole essere rappresentazione concreta di una pro-
gettazione ecologicamente corretta che re-interpreti una tradizione progettuale maturata durante quasi un secolo di esperimenti. La NWMA (North-Western Metropolitan Area), infine, propone un interrogativo. Nella parte di Europa che alcuni indicano con il nome di Delta Region, tra Amsterdam, Rotterdam, Anversa e Bruxelles, si è ve-
nuta formando da lungo tempo e senza che ve ne fosse l'esatta percezione una nuova forma di città; una città dispersa, priva di un unico centro, ma che, nel suo complesso, ha la stessa importanza e forza delle
maggiori metropoli e rzegacities europee. Questa forma di città potrebbe essere la prefigurazione di quanto di molto diverso dal passato potrà avvenire in molte parti del continente europeo e del mondo nel prossimo futuro. 11
Alle schede ho aggiunto alcune pagine di illustrazioni. Per qualche verso esse costituiscono un testo a sé. Limiti di spazio mi hanno spinto
a selezionarle in modi assai severi. Ma le difficoltà maggiori nascevano altrove: scegliere tra l'enorme quantità di temi e problemi offerti dal ventesimo secolo, proponendone almeno implicitamente un ordinamento per importanza, è impresa ardua; scegliere tra l’immenso ed eterogeneo materiale iconografico prodotto durante questo stesso periodo, gran parte del quale non del tutto noto e non ancora debitamente esplorato, diviene impresa quasi impossibile e ciò soprattutto quando, con l'occhio alla città e alla sua storia, si vorrebbe mettere in luce la folla
oscura degli attori che ne hanno promosso il cambiamento, che è appunto quanto le più importanti storie della città, dell’urbanistica e dell’architettura, che pur rimangono fonti primarie e indispensabili, inevitabilmente non riescono a fare. Ho utilizzato questi racconti, questi esempi e queste illustrazioni per
richiamare l’attenzione su alcuni temi rilevanti. Essi non offrono un panorama completo delle questioni sollevate dalla crescita e dalla trasformazione della città durante il ventesimo secolo. La città, come ho detto, è sempre esito di processi sovradeterminati e sarebbe un errore attribuirne i cambiamenti, in un secolo tanto conflittuale quale il ventesimo — nel quale si distruggono e ricostruiscono nuovi ordini sociali e nuove geografie politiche che a loro volta vengono distrutte e provvisoriamente sostituite da altre —, ad una sola causa, sia pure attiva nel
profondo di una cultura come quella europea che, nonostante le grandi differenze che la percorrono, mantiene ancora caratteri comuni ed è attraversata da temi altrettanto comuni.
Capitolo secondo
Crescita e dissoluzione della città
«Uno degli avvenimenti più importanti per l’intero sviluppo della nostra Kultur — scriveva Werner Sombart all’inizio del secolo — è il rapido aumento demografico di tutta una serie di città a partire dal sedicesimo secolo e la nascita con ciò di un nuovo tipo di città, la città di molte centinaia di migliaia di abitanti, la ‘Metropoli’, che, verso la fine del dicias-
settesimo secolo si avvicina, come Londra e Parigi, alla moderna forma di città con milioni di abitanti» (Sombart, 1912). Alla fine del secolo ventesimo, nel 1987, Pietro Rossi si chiedeva se non fossimo «giunti al termine del ciclo storico della città, di un ciclo
che ha preso le mosse, tra il quarto e il terzo millennio a.C., nelle pianure fluviali del Vicino Oriente, dell'India e della Cina con quella che è stata definita la rivoluzione urbana»; se non fossimo «cioè prossimi alla
scomparsa della città come forma caratteristica di insediamento e di organizzazione sociale» (Rossi, 1987). 1. Un secolo dominato dall’angoscia Ad un primo sguardo il ventesimo secolo è racchiuso tra due angosce: tra l’aspettativa di una crescita inarrestabile della città e il timore della sua 13
dissoluzione in forme di insediamento disperse delle quali è difficile comprendere il ruolo e il senso futuri; tra l'incubo di una metropoli che diviene megalopoli, luogo della concentrazione di masse di popolazione sempre più imponenti, che perde la propria misura, che diviene smisurata, estranea all'esperienza individuale e collettiva dei suoi abitanti, che
non è più possibile conoscere e dominare nei suoi aspetti tecnici e funzionali, e il timore, per molti versi opposto, della dissoluzione dello stesso concetto di città, della sparizione entro territori dagli incerti confini di questo luogo magico, sede di ogni innovazione politica, culturale e tecnica che tanto in profondità ha segnato la storia europea ed occidentale. L’angoscia accompagna il secolo e la città appare come uno dei luoghi ove essa si rappresenta nei modi più evidenti. Urbanistica e architettura svolgono a lungo, in questo racconto, il ruolo salvifico di chi libera società e città dai loro fantasmi e dai loro malanni assicurando più elevati livelli di benessere e di libertà (Secchi, 1984). Esse svolgono o cercano di svolgere questo compito lungo due principali direzioni: quella della «moralizzazione» del lascito dei secoli precedenti, di una modifica degli aspetti meno condivisibili della città, e quella della costruzione di un’alternativa radicale alla città del passato. Le numerose inchieste sulle condizioni di vita nelle città europee ed americane del diciannovesimo secolo avevano messo in luce situazioni e comportamenti nei confronti dei quali era difficile evitare giudizi di carattere etico. La macchina urbana per gran parte della sua popolazione si era rivelata strumento di esclusione, segregazione e impoverimento di ogni esperienza. E da queste inchieste, dalla denuncia delle situazioni che rivelavano e dai giudizi che sollecitavano che sono nati e si sono sviluppati i due atteggiamenti cui ho fatto riferimento. Essi hanno portato amministrazioni locali, architetti, urbanisti, piani, progetti e po-
litiche urbane ad esplorare temi che esorbitavano dai loro tradizionali ambiti di studio e intervento. Lungo tutto il secolo la città è divenuta non solo occasione di denuncia, come nel secolo diciannovesimo, ma
anche e soprattutto metafora del destino della società e dell’individuo, terreno di indagine e di ricerca, luogo privilegiato per lo studio della società e dei suoi movimenti, costruendo un legame molto forte tra l’architettura, l'urbanistica e le altre scienze sociali, la sociologia e l’economia in primo luogo; quasi una soggezione nei loro confronti entro una
nuova geografia delle discipline, delle loro relazioni reciproche, del loro ordinamento gerarchico.
14
Negli ultimi decenni del secolo architettura, urbanistica e politiche urbane, sopraffatte dal diluvio di immagini proposto dalla società della comunicazione, sembrano però perdere il proprio oggetto di ricerca, non appaiono in grado di concettualizzare adeguatamente la nuova situazione della città e del territorio e, come la città, sembrano dissolver-
si in un nomadismo comunicativo che diviene ostacolo all’accumulo progressivo di risultati in grado di dare risposte efficaci alle domande che emergono dalla società, dall'economia e dal territorio. Crescita e dissoluzione della città costruiscono un racconto noto, che
riempie di sé gran parte della letteratura e dà la propria impronta alla maggior parte dei progetti di città del secolo ventesimo assegnando loro il compito, almeno nei paesi occidentali, di dare un ordine a ciò che appare come incomprensibile disordine, ritrovando la misura di una possibile esperienza individuale e collettiva. Dominato dall’angoscia, il secolo sembra aver paura dell’infinito e del baratro che esso apre nella società e nelle coscienze degli individui, paura di una società ridotta a massa continua, di uno spazio illimitato, di un tempo sempre più accelerato e privo di riconoscibili sequenze che ne scandiscano il fluire in modo comprensibile. Gli stessi straordinari sviluppi della scienza divengono, lungo il secolo, fonte di inquietudini più che di certezze di un futuro migliore. Come ci si poteva aspettare, questo racconto implica due sequenze: la
prima costruita sull’esperienza della progressiva concentrazione urbana, la seconda su quella della frammentazione e dispersione della megalopoli entro territori di sorprendente dimensione. Se ci si limita ad osservare la città europea, le due sequenze sembrano dividere l’asse del tempo in un prima e un dopo, implicando quindi un punto di passaggio tra l’uno e l’altro generalmente collocato tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo, anni che assumono, da questo punto di vista, un'importanza del tutto eccezionale. Ma ad uno sguardo più attento che investa tutti i continenti le due stesse sequenze appaiono correre parallele, affondando entrambe le proprie radici in tempi che precedono il ventesimo secolo. Tutto fa prevedere che siano destinate ad un importante percorso nel secolo successivo. 2. Concentrazione
La concentrazione di attività e popolazioni tra loro in competizione per
l'occupazione di uno spazio limitato dalle tecniche della mobilità, una ten15
denza già chiara nel diciannovesimo secolo (Weber, 1890), ha cambiato,
lungo tutto il ventesimo secolo, fisionomia e modi di funzionamento della grande città. Alcune sue parti, solitamente le più centrali, sono state sottoposte ad un’enorme pressione che ha prodotto, come in un gas, un altrettanto spettacolare aumento della loro «temperatura». Questa si è di volta in volta espressa in una più intensa utilizzazione dello spazio urbano, nella sostituzione di funzioni e ruoli da tempo consolidati con ruoli e funzioni nuovi e in una straordinaria accelerazione di ogni movimento. L’architettura della città ha cercato di rappresentare la nuova situazione. Movimenti di persone e di cose, di idee ed informazioni, di tendenze artistiche e politiche, inseguendosi con propri differenti ritmi, hanno espulso, da intere parti della città e dei territori ad essa contermini, individui e gruppi sociali, attività, funzioni e immagini meno competitivi so-
stituendoli con soggetti, attività, funzioni, ruoli e immagini nuovi. Rispetto al passato la città è divenuta un’ancor più imponente macchina produttrice allo stesso tempo di integrazione, ma anche di esclusione e segregazione. La sua immagine fisica è cambiata: in un accelerato processo di selezione cumulativa parti importanti della città preesistente sono state demolite e trasformate; entro una più minuta divisione del lavoro e una
più rigida definizione dello statuto di ogni parte della società come della città, l’uso e la frequentazione multiforme di molti importanti spazi della sociabilità sono andati persi o sono stati modificati in modi irreversibili. Manhattan, e prima ancora Chicago, con i loro grattacieli e la loro straordinaria densità, sono divenute le principali icone della città del «secolo americano», così come la Parigi haussmanniana lo era stata di quella del diciannovesimo secolo. Interpretata come rappresentazione della modernità ed espressione degli attori che la sospingevano (Schleier, 1986; Ward, Zunz, 1992), l’icona della città verticale alla fine del secolo
segnala, a Tokyo o ad Hong Kong, a San Paolo o a Seoul come nella nuova Pechino o a Shanghai, lo spostamento del centro di gravità dell’economia mondiale, anche se, specie in Europa, altre immagini, espressione di un potere più diffuso e articolato, le sono state a lungo contrapposte con successo. Mano a mano che le tecniche del trasporto, la costruzione di ferrovie, di tranvie e, poi, la diffusione dell’automobile lo consentivano, la pressione sulle aree centrali è stata temperata dall’espansione di una vasta pe-
riferia spesso identificata come il più evidente prodotto della crescita ur16
bana del ventesimo secolo, il terreno nel quale il secolo ha prodotto forme insediative che hanno cambiato la fisionomia di interi territori costruendo nuove geografie sociali, funzionali e simboliche. Ma le ragioni stesse che consentivano e sospingevano l’espandersi delle periferie e dei suburbs,la diffusione dell’automobile in particolare, producevano anche
congestione e inquinamento nelle parti più dense della città. Le infrastrutture della mobilità assumono una presenza visiva sempre più importante. Lungo tutta la prima metà del secolo suggeriscono ad architetti e urbanisti immagini, piani e progetti che invitano a dilatare dimensione e scala dello spazio urbano, che le trasformano in mega-strutture, che le monumentalizzano: i disegni di Eugène Hénard per Parigi all’inizio del secolo o quelli di poco posteriori di Harvey Wiley Corbett per New York e soprattutto quelli di Auguste Perret, Le Corbusier e Ludwig Hilberseimer negli anni Venti, il piano di Filadelfia di Louis I. Kahn (1956), quello di Kenzo Tange per Tokyo (1961), quello di Bakema e Van den Broek per l'espansione di Amsterdam (1965) cui fanno seguito molte autostrade urbane di attraversamento e circonvallazione che divengono le vetrine di spazi commerciali e imprese. Viadotti e svincoli si inseriscono in modi aggressivi nella città, la stringono entro cinture troppo strette e ne modificano immagine e modi di funzionare costruendo paesaggi che raramente riescono ad essere significativi e che fanno spesso rimpiangere le analoghe opere del diciannovesimo secolo, a Boston, a Marsiglia piuttosto che a Lione, a Genova o Napoli. Alla metà del secolo, negli anni di massima diffusione dell’automobile, il rapporto Buchanan (Buchanan, 1963), dopo un accurato studio della questione in alcune città inglesi assunte come rilevanti casi di studio e delle politiche intraprese in diverse parti del mondo occidentale per limitare la congestione delle aree centrali, giunge alla conclusione che la soluzione dei problemi generati dalla congestione del traffico impone un radicale ridisegno della città. Il sempre maggior spazio richiesto dalle infrastrutture della mobilità e da ciò che ad esse è indissolubilmente legato, in particolare le sempre più vaste aree di parcheggio, modifica i termini della competizione per lo spazio nelle aree urbane centrali. Molte attività, a cominciare da quelle commerciali, seguite da diverse grandi attrezzature ospedaliere, sportive, scolastiche e congressuali, dai mercati, dai servizi tecnici, dai depositi e dalle sedi di consistenti burocra-
zie pubbliche e private, ristrutturano radicalmente i propri processi produttivi e i propri rapporti con il contesto urbano; alla ricerca di spa17
zi più ampi e di una maggiore accessibilità si disperdono ai margini delle aree metropolitane ed urbane; moltiplicano luoghi centrali ed eterotopie (Foucault, 1984a) e ri-configurano, entro territori sempre più vasti, mappe e tempi degli spostamenti. Concentrazione e dispersione nelle grandi periferie metropolitane, nei suburbs, nella «città regione», divengono fenomeni auto-contraddittori, ciascuno causa del suo opposto. Essi fanno sì che la città sia costantemente alla ricerca di un equilibrio spaziale e temporale tra il proprio ruolo e l'infrastruttura che ne consente un completo svolgimento, che la città sia perennemente instabile. L'instabilità, l'impossibilità di darsi un assetto duraturo nel tempo sembra divenire uno dei connotati fondamentali della città del ventesimo secolo. I problemi della mobilità divengono, per molte città e territori, un incubo.
È anche per queste ragioni che nella seconda metà del secolo, quando la dispersione diventerà fenomeno evidente, si farà strada una concezione più articolata dell’infrastruttura della mobilità. Entro un campo metaforico largamente debitore nei confronti delle scienze ambientali saranno abbandonate le grandi metafore idrauliche del periodo di progressiva ingegnerizzazione del territorio; le reti della mobilità non saranno più concettualizzate unicamente come composte da tubi e canali di sempre maggiore portata, ma anche come insieme di vasi capillari entro tessuti spugnosi; il problema del traffico non sarà più concettualizzato solo come problema di adduzione ed evacuazione, ma anche come problema di percolazione entro città e territori dei quali sempre più frequentemente viene riconosciuto il carattere eminentemente poroso.
3. Città, metropoli, megalopoli Sin dalla fine del diciannovesimo secolo, crescita e concentrazione ur-
bana hanno dato luogo ad una importante riflessione sulla città e sulla società della grande metropoli, una società che appare ora chiaramente distinta da quella di antico regime: relazioni impersonali, anomiche, instabili e una straordinaria accelerazione del movimento di persone, di cose, di idee, notizie ed informazioni. Letteratura, arti visive e musicali anticipano questa riflessione, che si fissa in alcuni testi fondativi della sociologia moderna (T6nnies, 1887; Simmel, 1903; Sombart, 1912; We-
ber, 1922) o di una storiografia ispirata da una prospettiva evoluzionista (Pirenne, 1927) o comparativa (Bloch, 1939). 18
Poste in una lunga prospettiva storica, crescita e concentrazione me-
tropolitana, appannaggio ora delle scienze sociali, danno luogo ad estese ricerche sul campo, ad esempio quelle compiute tra il 1915 e il 1940 dalla Scuola di Chicago, o a quelle svolte all’inizio degli anni Cinquanta da Chombart de Lauwe per Parigi. Esse hanno come conseguenza l'abbandono delle inchieste sociali ottocentesche cariche di moralismo e la formulazione di più generali metodi di indagine e concettualizzazione del fenomeno urbano e delle sue articolazioni (Park, Burgess, McKenzie, 1925; Chombart de Lauwe, 1952, 1960).
L'organizzazione spaziale della grande città moderna — luogo per eccellenza di una divisione del lavoro cui dal diciottesimo secolo appaiono legati la crescita economica, il progresso tecnologico e il miglioramento delle condizioni materiali delle popolazioni che vi abitano — appare però in ritardo rispetto all’organizzazione dei luoghi della produzione o dello scambio (Hilberseimer, 1927). Chiarire, definire, separare
e allontanare, connettere e sincronizzare luoghi e ritmi della vita metropolitana, attraverso un razionale sistema di regole di utilizzo dei suoli e un altrettanto razionale sistema di infrastrutture, appare, per tutta la prima metà del secolo e sino agli anni Sessanta, il modo per dominare l’angoscia che si accompagna alla crescita metropolitana. Ineludibilmente associati alla concentrazione urbana sono ovviamente gli intensi flussi migratori che, a partire dal diciottesimo secolo, l'hanno alimentata. Intere parti del continente europeo hanno continuato a svolgere, durante più di tre quarti del ventesimo secolo, il ruolo di bacino dal quale attingere forza lavoro e popolazione. I trasferimenti di popolazione dalla campagna alla città, dall’agricoltura all'industria, dal Sud al Nord, dal mondo e dalle tradizioni rurali al mondo e alla cultura
urbani, hanno dato luogo a nuove esigenze e a nuove domande radicali e, al contempo, ad importanti cambiamenti nelle relazioni tra le diverse città, le diverse regioni del continente e del pianeta, modificandone l’ordinamento gerarchico e i ritmi di crescita. Alla fine del ventesimo secolo le maggiori città del mondo non sono più quelle che Adna F. Weber studiava cento anni prima. Londra, la Monster City del diciannovesimo secolo e la più popolosa città del mondo nel 1900 (prima di New York, Parigi, Berlino, Chicago e Vienna), era divenuta nel 1950, in un ordine per dimensione della popolazione, la seconda città mondiale (dopo New York e prima di Tokyo, Parigi, Shanghai e Mosca) e alla fine del secolo è scesa al sedicesimo posto, prece19
duta da Tokyo, New York, Seoul, Mexico City, Bombay e da diverse al-
tre città in gran parte appartenenti a paesi di altri continenti (Chandler, 1987). La popolazione di Tokyo è cresciuta, durante il secolo, di ventitré volte, mentre quella di Londra non è arrivata a raddoppiarsi. Il centro di gravità della popolazione urbana si è radicalmente spostato, mentre la concentrazione urbana sembra essersi arrestata laddove si era inizialmente prodotta, cioè in Europa, e ciò ha portato con sé nuove in-
terpretazioni e nuovi atteggiamenti nei confronti del fenomeno urbano. La concentrazione urbana nei paesi in via di sviluppo, d’altra parte, in una prospettiva storica di lunghissimo periodo, non sembra più suscitare, nella maggior parte degli studiosi e dei governi, gli incubi che dal diciottesimo secolo in poi aveva evocato nel vecchio continente. Essa è anzi spesso interpretata, alla metà del secolo, come fattore d’inte-
grazione sociale ed economica, indicatore e propulsore di accelerati fenomeni di modernizzazione e mobilità sociale, occasione d’importanti
riforme politiche (Beyer, 1967). E invece la dispersione della città europea ed occidentale, via via interpretata come forma degradata della città moderna e delle forme urbane che l'hanno preceduta, o come un loro necessario stadio evolutivo 0, infine, come anticipazione di un diverso
modo di abitare, che suscita nuove inquietudini e angosce e che costruisce la seconda sequenza del racconto. Ciò è in parte anche la conseguenza della gran mole di rilievi, di studi e d’ipotesi interpretative che la città sollecita durante tutto il secolo. Mai come nel ventesimo secolo il fenomeno urbano è stato tanto estensivamente studiato. Con un sensibile spostamento rispetto al diciottesimo e diciannovesimo secolo, quando della città si occupavano soprattutto medici, igienisti, ingegneri o studiosi delle cosiddette scienze di polizia, nuove discipline, distaccandosi da un tronco principale, in una
progressiva divisione e specializzazione del lavoro, la assumono come proprio specifico oggetto di ricerca, ciascuna suddividendosi ulteriormente in aree più particolari: la geografia urbana, la storia urbana, la sociologia urbana, l'economia urbana e le scienze regionali, ad esempio. Mala città diviene anche oggetto di studio di psicologi, psichiatri e, naturalmente, di studiosi di scienze politiche ed amministrative. Per un breve momento, nei primi anni Sessanta, agli studiosi di queste diverse discipline sembra di aver consolidato il proprio statuto disciplinare, il proprio oggetto e i propri metodi di ricerca, di poter formulare 20
alcune ipotesi teoriche che aspirano ad una certa generalità e stabilità nel tempo e di poter ricostruire le proprie origini, spesso retrodatandole oltre misura. Alcune grandi opere collettive segnano questo momento di grande ottimismo scientifico (Hatt, Reiss Jr., 1959; Burgess, Bogue, 1964; Hauser, Schnore, 1965; American Economic Association-Royal Econo-
mic Society, 1966). L’irruzione, ad esempio, in questi anni di una nuova formazione discorsiva, quella delle scienze regionali, che si propone come fronte avanzato della ricerca territoriale, corrisponde non solo e non tanto ad una nuova configurazione delle discipline che si occupano della città e del territorio, ad un tentativo di ricomprenderle entro un unico frame stabilendo tra loro nuove gerarchie, quanto ad un diverso e più razionale ordinamento delle politiche che hanno la città e il territorio come proprio oggetto; tra queste le parti più astratte, di derivazione neoclassica, delle discipline economiche assumono il sopravvento. Un atteggiamento che verrà sottoposto a dura critica dal gran numero di descrizioni di concrete situazioni urbane e territoriali degli anni successivi e dal ritorno all'esperienza che esse segnalano. Un ritorno che mette in evidenza il carattere frammentario della città, l'impossibilità di riferirla ad una sola immagine, ad una sola spiegazione, ad una società racchiudibile in una visione comprehensive e che porta ad enfatizzare il ruolo dell’interazione sociale, ad adottare politiche fondamentalmente ispirate all’agire comunicativo (Habermas, 1967) o ad un'idea incrementale della costruzione della città e delle sue politiche (Lindblom, 1975). Alla fine del secolo saranno frequenti gli studi che, cercando di ricostruire la storia di tutte queste discipline, si chiederanno se l'oggetto di ricerca che appariva tanto chiaro qualche decennio prima non si sia per caso dissolto sotto la pressione degli innumerevoli casi di studio esplorati nel frattempo e delle ipotesi interpretative cui di volta in volta si è fatto ricorso 0, ancor più radicalmente, se non si sia prossimi alla scomparsa della città come forma caratteristica di insediamento e di organizzazione sociale (Rossi, 1987; Tosi, 1987). Non sono pochi gli studiosi che ritengono che tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, con gli inevitabili ritardi e anticipi dei singoli casi, la città europea esca definitivamente dalla modernità per entrare in un periodo nuovo, i lineamenti del quale non sono ancora totalmente definiti. La storia forse è sempre interpretabile come segnata da cesure o da
continuità. Alcuni fili che ci tengono legati al passato di quando in quando si rompono, mentre altri rimangono ben visibili e forti o hanno il loro inizio. Per questo diviene importante dire quale si rompe e quale per21
mane e in cosa il dopo differisce dal prima, come e perché si è passati dall’uno all’altro. Cercare le cause e le origini è, invece, come nota Musil, un po’ come cercare i propri genitori e poi i loro genitori e così di seguito all'infinito. Risalendo nel tempo ci si accorge che sarebbe stata necessaria un’infinità di uomini per produrne uno solo oggi (Bouveresse, 1995). Non mi posso permettere tanto. 4. Dispersione
Alla metà del secolo, negli stessi anni nei quali lo statuto disciplinare di molte aree di ricerca appariva consolidarsi e mentre vengono predisposti alcuni importanti progetti e politiche che tentano di confrontarsi con la nuova dimensione della città, un altro gruppo di studiosi cerca però di riconcettualizzare la storia e la situazione della città occidentale (Gregotti, 1966; Rossi, 1966; Venturi, 1966). I/ territorio dell’architettura di
Gregotti mette in evidenza come la dilatazione del fenomeno urbano su territori di inusitata dimensione induca a nuovi rapporti con i caratteri topografici di ciascuna parte di territorio investita dal progetto urbano e di architettura. L'Architettura della città di Rossi interpreta la storia della città europea come continua costruzione e definizione dei caratteri topologici dello spazio urbano. Complessità e contraddizione nell’architettura apre la strada all'accettazione di un’esperienza urbana ove, come nelle città italiane di antico regime da Venturi studiate assiduamente, l’«adattamento» e la stratificazione prevalgono sull’affermazione rigida di un principio. Ad essi faranno seguito altri testi (Tafuri, 1968, 1973, 1974; Banham, 1969; Venturi, Scott Brown, Izenour, 1972; Rowe,
Koetter, 1978; Koolhaas, 1978) nei quali si rappresenta una stagione di studi che invita a deporre sulla città e sulla sua storia sguardi differenti dal passato. Letteratura e immaginari occidentali iniziano infatti a colmarsi in questi anni di immagini ambivalenti e inquietanti: la metropoli di Simmel, Sombart e Benjamin che riempiva gli immaginari di inizio secolo diventa megalopoli (Gottmann, 1961), esplode nello sprazv/ del suburbio americano (Carver, 1962), si trasforma in ciò che in Europa as-
sumerà più tardi le forme della città diffusa (Indovina, 1990) o in ciò che verrà indicato negli Stati Uniti come Edge City (Garreau, 1991). Bardamu, il personaggio principale di Voyage au bout de la nuit, arrivando a New York nei primi anni Trenta vi vede ure ville debout, ab22
solument droite, una città verticale e ritta in piedi (Céline, 1932). Il ter-
mine sprawl, in uso nella letteratura anglosassone dalla metà del diciannovesimo secolo, deriva invece dall’uso sostantivato di un verbo, to
sprawl, il significato del quale è sdraiarsi (Ingersoll, 2004). Queste due immagini, della città ritta in piedi in un ristretto spazio e sdraiata, adagiata su sempre più vasti territori, sembrano segnare un punto di pas-
saggio nella storia urbana europea ed occidentale di volta in volta interpretato come una cesura, come passaggio tra due epoche distinte o come una dissolvenza, quasi il trascolorare di un'immagine nell’altra. Come la concentrazione urbana poteva essere collocata in una lunghissima prospettiva storica, anche la dispersione, le inquietudini che l’accompagnano e le speranze che suscita covavano da lungo tempo in Europa. Da secoli l'Europa è un continente fortemente antropizzato, costituito da una fitta rete di insediamenti dispersi. La costruzione, ancor prima del Cinquecento, di «ville» con propri parchi e giardini disperse nella campagna, ad esempio nell’area veneta o nelle Fiandre, segna una prima fase di appropriazione e densificazione di un territorio disperso (Ackerman, 1990). Le più ricche famiglie londinesi lasciano la città entro le mura disperdendosi nel West End già prima del grande incendio del 1666, ma soprattutto a partire da quell’evento (Thorold, 1999), dando inizio alla tradizione della English Country House (Viganò, 1999). Marcel Roncayolo mostra come, dopo Colbert, le politiche urbane di Parigi e di Marsiglia oscillino tra le esigenze d’allargamento della compagine urbana e il tentativo di frenare la dispersione delle classi più agiate nei territori circostanti (Roncayolo, 2002). Nella Germania di inizio secolo la piccola città, né metropoli, né villaggio, viene ritenuta l’unica situazione in grado di garantire coesione sociale e libertà individuale (Tessenow, 1919). Marcel Smets (Smets, 1977, 1986, 1990a, 1990b) e Bruno De Meulder (De Meulder, Dehaene, 2001) mostrano come la dispersione nelle Fiandre, forse la regione in Europa nella quale il fenomeno ha assunto le dimensioni più importanti e pervasive, sia, dall’inizio del ventesimo secolo, esito in larga misura di esplicite politiche tese ad evitare la formazione di grandi concentrazioni proletarie nelle maggiori città; tra queste politiche la costruzione dei peasant tramways, cioè la densissima infrastrutturazione ferroviaria e tranviaria, è forse la più importante. Ettore Conti, il grande patron dell’industria elettrica italiana, nei primi decenni del secolo portava come argomento a favore di una sempre più spinta elettrificazione le possibilità che essa avrebbe offerto alla disper23
sione della produzione e delle residenze con conseguenze analoghe a quelle che ci si attendeva nelle Fiandre (Conti, 1986). Tra la fine degli anni Dieci e sino alla legge Loucheur del 1928 si sviluppa in Francia una periferia pavillonnatre, spesso abusiva, che darà luogo ai cosiddetti 724/-lotis, famiglie che avendo acquistato un lotto di terreno senza sufficienti conoscenze del luogo si trovano poi a lottare con inondazioni e mancanza di infrastrutture adeguate alla stessa conservazione del loro investimento. Peter Hall interpreta la dispersione come inevitabile conseguenza della più elevata mobilità consentita dalla diffusione delle tranvie prima e dell’automobile poi (Hall, 1997). Come le tranvie, le «gondole del popolo», avevano prodotto negli anni Venti e Trenta le plotlands — lottizzazioni abusive che avevano invaso vaste parti del Sud-Est dell’Inghilterra e le regioni limitrofe alle maggiori città (Hall, Ward, 1998), automobile diviene, secondo Peter Hall, secondo molti studiosi e secondo un’opinio-
ne diffusa, la maggior responsabile della dispersione nell’ultima parte del secolo. Ma come per il telefono alcuni decenni prima occorreva che concreti attori ritenessero utile e conveniente separare gli uffici dalle fabbriche, così l'automobile ha consentito la dispersione perché nella società già operavano tensioni che portavano molti gruppi sociali a preferire l’abitazione dispersa a quella delle più dense aree urbane. Nel 1932 Thomas Sharp e la pubblicistica conservazionista del tempo descrivevano il Bungaloid growth con parole e immagini identiche a quelle utilizzate cinquant’anni dopo per le Fiandre o per l’area veneta (Sharp, 1932). Negli anni Novanta Francesco Indovina prima, Stefano Boeri, Arturo Lanzani e Edoardo Marini poi, descrivono le modifiche della struttura e dell’immagine del Veneto e del territorio metropolitano milanese prodotte dagli intensi fenomeni di decentramento produttivo, di dispersione delle at-
tività e della popolazione prodottisi nei due decenni precedenti (Indovina, 1990; Boeri, Lanzani, Marini, 1993); Stefano Munarin e Chiara Tosi
analizzano in dettaglio storia e caratteri della dispersione nel Veneto, una delle regioni italiane che, a partire dagli anni Settanta, è all’origine dello studio dei nuovi caratteri del fenomeno urbano (Munarin, Tosi, 2001);
Paola Viganò analizza storia, caratteri e opportunità offerte dalla dispersione nel Salento, regione dell’estremo Sud dell’Italia, per la costruzione di una nuova forma di spazio abitabile, di una nuova modernità (Viganò, 2001b).
24
5. Una nuova forma dell'abitare
La dispersione è fenomeno imbarazzante. Difficilmente racchiudibile in poche parole e concetti, essa resiste ad ogni sforzo descrittivo. Negli anni Ottanta una gran parte della letteratura, ricorrendo a tecniche differenti, dall’&@oaotg alla microstoria, all’inventario, al repertorio, al catalogo o al sazpling, cerca di illustrare, attraverso «descrizioni dense», «mappe in profondità» e 775se en abîme, i caratteri della nuova situazione della città e dei territori europei e statunitensi. E un ritorno all’esperienza come fonte primaria della conoscenza; un ritorno antropocentrico che forse connota periodicamente tutta la storia della scienza occidentale (Bloor, 1976). Di volta in volta declinato nella prospettiva ermeneutica, esistenziale o neo-romantica, esso sempre si accompagna alla presa di distanza dal carattere sistematico, decontestualizzato e cumulativo della razionalità tecnica, all’enfasi sulla complessità, all'esigenza di una sua ridu-
zione, mostrando forse la nostra incapacità di usare l’accumulazione della cultura specialistica per l'arricchimento dell’esistenza quotidiana. Ancor più radicalmente esso si accompagna al congedo dall'idea di verità pubblica che ha connotato la parte centrale del secolo. Tutto ciò spinge ad integrare, nella costellazione dei saperi rilevanti per lo studio e il progetto della città, discipline come l’etnologia e l’etnografia, le ricerche, ad esempio, e gli scritti di Ulf Hannerz, piuttosto che di Marc Augé o di Pierre Bourdieu (Hannerz, 1980; Augé, 1986, 1989, 1992; Bourdieu, 1993).
La descrizione appare come un esercizio limite. Sforzandosi di resistere alla linearità delle spiegazioni pre-costituite essa propone di dirigere l’attenzione con mosse elementariste verso i materiali costitutivi
della città e del territorio (Viganò, 1999). Tentativo di organizzare un visibile eminentemente frammentario entro la trama di un sapere asistematico che non necessiti di forti legittimazioni, la descrizione cerca di costituire come ordinabile una vasta gamma di esperienze: «forma degli elementi, quantità di questi elementi, modi nei quali essi si distribuiscono nello spazio gli uni rispetto gli altri e dimensione relativa di ciascuno» (Foucault, 1969). Ben consapevoli dell’impossibilità di costruire una copia esauriente del reale, le ripetute descrizioni della città e del territorio di fine secolo fanno emergere il frammento, lo specifico, il locale, la differenza irriducibile mostrando che lo spazio della dispersione non è omogeneo e isotropo, quanto costituito da costellazioni di ma-
teriali frammentari tra i quali diviene importante stabilire nuove relazioni (Barthes, 1963; Secchi, 1995). 25
Goethe, nelle parole di Peter Behrens, l’ultimo grande spirito sintetico, metteva in guardia contro l’uso del microscopio, perché è uno strumento in grado di impedire la visione d’insieme, la conquista di vasti punti di vista (Dal Co, 1982). In una recente favola apparentemente leggera, ma politicamente impegnata, si racconta di un dittatore che proibisce agli abitanti della città di salire sulle colline che le fanno corona perché dall’alto si riesce appunto ad avere una visione d’assieme, una visione non solo delle cose, ma delle loro reciproche relazioni, della loro coerenza e del loro senso (Orsenna, 2004).
Le ripetute descrizioni della città diffusa e delle sue microscopiche variazioni hanno obbligato a prendere atto di una definitiva e generale trasformazione della società occidentale; una trasformazione in corso da
tempo, ma che solo negli ultimi decenni del secolo produce le proprie conseguenze sul modo di pensare la città e le sue politiche.
Nella prima metà del secolo la società urbana, per non dire l’intera società, è concepita come formata da grandi aggregati, classi o ceti al loro interno fondamentalmente omogenei nei comportamenti e nelle aspi-
razioni. La città è il luogo ove questi aggregati, muovendo specifiche retoriche, si incontrano e scontrano conquistando riconoscibilità, egemonia e potere. La maggior parte delle politiche urbane cerca di costruire pragmaticamente un ponte tra le esigenze dei diversi gruppi tra loro in competizione.
Un punto d’incontro nei fatti condiviso riguarda, ad esempio, in Europa, nella prima metà del secolo e sino a tutti gli anni Sessanta, come negli Stati Uniti negli anni del New Deal, la centralità delle politiche dell'abitazione. La politica della casa, parte di una più ampia politica economica e sociale, darà luogo, lungo tutto il secolo, ad un insieme di stu-
di, di ricerche e di politiche che lentamente modificano il ruolo dello Stato nei confronti della città, ma anche quello della città nei confronti delle politiche pubbliche. La città diviene, in altri termini, il luogo ove, per tutta la prima metà del secolo, si sperimentano alcuni aspetti del Welfare State; ciò darà importanti frutti quando politiche urbane e progetti della città si dovranno confrontare in modi più ravvicinati e diretti con i tre grandi temi proposti dalla società del ventesimo secolo e messi in evidenza dalle sempre più frequenti descrizioni dei caratteri delle città e dei territori europei: l'emergere del soggetto e della sua irriducibile autonomia, della sua richiesta di uno spazio della privacy e dell’iso26
lamento; l'emergere del quotidiano, della dimensione corporale e temporale della città come dimensioni fondamentali del benessere individuale e collettivo e, infine, la progressiva democratizzazione dello spazio entro una profonda redistribuzione di valori e una modificazione degli immaginari individuali e collettivi. Nell'ultima parte del secolo molte ricerche antropologiche, concentrandosi in particolare sulla cultura materiale, sostituiscono al naturalismo del periodo tra le due guerre, quando l'abitazione è considerata in primo luogo un problema biologico (Aymonino, 1971), un’interpretazione culturale dell’emergere di bisogni, desideri e aspirazioni incomprimibili. Il cibo che si mangia, gli abiti che si indossano, l’impiego del proprio tempo e delle proprie risorse, il cinema, i libri, l'automobile e le vacanze, dice Mary Douglas citando peraltro quasi alla lettera una pagina di The Portrait cf a Lady, romanzo che Henry James ha scritto nel 1881, sono opinioni relative alla forma di società che si desidera. Anche se largamente dominate dalle tradizioni, queste opinioni si formano ed esprimono, fatte le debite differenze, nelle società ricche in modi analoghi a
quelli tipici di società arcaiche (Douglas, 1996). In una città quale quella
europea di fine secolo, ciò sposta il centro dell’attenzione dall’essere vivente in quanto tale e dai soli gruppi meno privilegiati situati al di sotto
della linea della poverta, all’identificazione di differenti gruppi culturafi, alle diverse forme con le quali essi si esprimono nei confronti dell’ambiente e della città, ai loro miti e immaginari e alle loro radici, alla storia delle mentalità, alla differenza e alla sua storia, alla lunga durata e alle di-
verse dimensioni del tempo. La società urbana, non più interpretabile come formata da grandi aggregati omogenei, si disperde nell’innumerevole: in una dispersione di gruppi sociali gelosi dei propri stili di vita dei
quali la dispersione della città diffusa diviene concreta rappresentazione. 6. Politiche e progetti Tutto ciò ha dato luogo, lungo il ventesimo secolo, ad una grande varietà di politiche e di progetti per la città. Ad un livello assai generale essi si configurano come «moralizzazione» della città del diciannovesimo secolo, come ricerca del limite dell'espansione urbana o come ricerca di un nuovo ordine spaziale, e assumeranno la forma del decentramento urbano, nelle sue diverse forme di costruzione di Garden Cities, di New
Towns, di città e quartieri satelliti; di spostamento, decentramento e rilo27
calizzazione di impianti produttivi, di attrezzature collettive e di luoghi centrali; della separazione e allontanamento o riavvicinamento e sovrapposizione di ciò che sul piano sociale o funzionale viene ritenuto incompatibile o complementare; della costruzione di unità di vicinato o di quartieri autosufficienti ove sia la dimensione individuale, sia quella collettiva della vita associata abbiano modo di esprimersi e rappresentarsi; della costruzione di green belts e reti verdi che, limitando l’espansione urbana o separando tra loro parti di città differentemente connotate da un punto di vista funzionale e sociale, costruiscano nuovi paesaggi urbani. La critica dei primi decenni del secolo scorso alla città del diciannovesimo secolo e alla società disciplinare che in essa si rappresenta come forma di organizzazione sociale e spaziale mutuata dall’istituzione totale e, in particolare, dalla grande fabbrica, spinge in un primo tempo, come ho detto, in due diverse direzioni: verso la costruzione di un’alter-
nativa alla grande città o verso la sua «moralizzazione». La prima direzione, inaugurata da Ebenezer Howard negli ultimi anni del diciannovesimo secolo (Howard, 1898, 1902), è, ad esempio, quella della costruzione, in tutta Europa come in altri continenti, delle numero-
se città giardino (Hall, Ward, 1998; Ward, 1992), della proposta di Henry Ford e Frank Lloyd Wright della costruzione di tante città di piccole dimensioni disperse nel grande territorio americano, della analoga proposta delle «città del lavoro» in Unione Sovietica, della realizzazione, a partire dagli anni Cinquanta, delle New Towns inglesi e negli anni Sessanta delle Vi/les Nouvelles francesi. Come molte innovazioni questa direzione necessita, contrariamente alle ipotesi e illusioni di Howard, di un potere che la faccia propria: un capitalista filantropo, come, ad esempio, nelle città giardino minerarie del Limburgo (De Meulder, 1991; Loeckx, 1991), una specifica istituzione pubblica, come per le città giardino del sindaco Sellier in Francia, o il potere dello Stato, come nelle «città del lavoro» sovietiche, nelle New Towns inglesi o nelle Vi/les Nouvelles francesi. La seconda direzione, della «moralizzazione» della città esistente, è quella che si rappresenta, ad esempio, nel pensiero di Otto Bauer, importante esponente dell’austromarxismo, per il quale la città non è come una grande fabbrica, quanto piuttosto una grande macchina filantropica e pedagogica che sospinge verso una graduale trasformazione sociale; idea che si rappresenta soprattutto negli anni Venti nelle grandi esperienze della Amsterdam Sud di Berlage e delle Hòfe viennesi sino a «Vienna Rossa» (Tafuri, 1980) e, per alcuni versi, sino ai «quarta28
li» sovietici negli anni Trenta: un’ordinata maglia urbana memore della regolarità e delle gerarchie del secolo dei lumi; fronti stradali continui;
cura nei dettagli dell’edificio, degli ingressi, dei corpi scale; un vocabolario degli spazi aperti che rivisita l’intera storia della città europea dopo il Rinascimento; una dilatazione dell'isolato che ne assicura i requisiti igienici e ne costruisce l'interno come spazio della sociabilità; una monumentalizzazione, infine, dell’abitazione sociale, considerata mate-
riale fondamentale nella composizione di intere parti di città. Apparentemente meno innovatrice, la direzione non è priva di aspet-
ti conflittuali. Negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo Cesare Beruto, anticipando esperienze successive, aveva tentato qualcosa di simile a Milano, ma i proprietari delle aree destinate alla nuova edificazione lo avevano costretto a rinunciare al super-blocco e a limitarsi ad arricchire il vocabolario degli spazi stradali, operazione che Beruto compie peraltro con grande perizia e dignità (Rozzi, Rossari, Boriani, 1992). Le stesse dif-
ficoltà incontra Berlage ad Amsterdam quando il suo piano del 1904 per Amsterdam Sud non viene approvato. Riprendendo una tradizione che rimonta, ad Amsterdam come a Rotterdam, al diciassettesimo secolo e che
sarà interrotta solo nel secondo dopoguerra (Komossa, Meyer, Risselada, Thomaes, Jutten, 2005), Berlage propone una versione «moralizzata» del dutch Baublock. Nel suo piano per Amsterdam Sud il superblocco, concepito come oggetto architettonico unitario, diviene il materiale di base della composizione urbana. Ma gli attori che sarebbero stati coinvolti nella sua realizzazione giudicano troppo dilatati i superblocchi, troppo larghi i viali che ordinano la maglia della nuova parte di città. Nel piano approvato nel 1917 Berlage correggerà questi aspetti senza peraltro abbandonare i riferimenti al dutch Baublock, ai parchi e alle passeggiate parigine della grande regolarizzazione haussmanniana. Berlage l'aveva studiata a lungo; in essa, come nei parchi di Olmsted negli Stati Uniti (Zaitzevsky, 1982), si rappresentava visivamente, in un vero e proprio sistema di elementi gerarchizzati e tipizzati, l’idea dell’articolazione e dell’ordine sociale di fine Ottocento (Choay, 1975) che Berlage «moralizzava».
La costruzione di vasti programmi di edilizia sociale tra le due guerre dà però luogo in Europa anche ad esperienze più radicali. Alla ricerca di un ordine spaziale ove la modernità e un nuovo ordine sociale si rappresentino più chiaramente, esse compiono tre operazioni fondamentali (Panerai, Castex, Depaule, 1977): aprono l’isolato sino a dis-
29
solverlo in un insieme di oggetti tra loro separati e organizzati da differenti principi; eliminano la «strada corridoio», l’idea stessa che lo spazio aperto, solitamente pubblico, sia una sorta di controforma di quello edificato; modificano, infine, in modo sostanziale i rapporti tra spazio coperto dagli edifici e spazio libero. Chi osservi una pianta delle parti di città costruite nel ventesimo secolo e la confronti, esercizio che era
abituale per gli architetti e gli urbanisti del Movimento Moderno, con quella delle parti costruite nei secoli precedenti, chi pratichi la città europea del ventesimo secolo confrontandola con quella dei secoli precedenti, riconosce questi tre punti come i maggiori responsabili della modifica dell'immagine della città. Negli anni tra le due guerre, nella Neue Frankfurt, a Berlino, nei paesi scandinavi, in Unione Sovietica, nella distribuzione interna dell’allog-
gio, concepito come cellula elementare della composizione urbana e sociale, ogni elemento assume ruoli, funzioni, dimensioni e prestazioni definiti in modi il più possibile precisi; nelle versioni estreme l'alloggio cambia di natura facendosi casa comune ove alcuni spazi sono condivisi dai diversi gruppi di abitanti; l’isolato si apre e dissolve entro composizioni urbane nelle quali lo spazio aperto, le attrezzature collettive e le infrastrutture assumono un'identità e una collocazione specifica; l'insieme degli spazi aperti, strade, piazze, giardini e parchi, grazie anche a più generose dimensioni, assume una propria forma coerente ad un ruolo che non è più compensatorio della bassa qualità dell’alloggio, ma è costitutivo della forma urbis e dei suoi rapporti con il territorio e la natura; la città si articola in parti delle quali divengono riconoscibili la funzione e il ruolo; una nuova estetica, come una risonanza dei movimenti artistici che percorrono il secolo, organizza l’esperienza spaziale della grande città. Alcuni fili dunque continuano senza soluzione di continuità con il passato, altri subiscono una forte distorsione senza costruire con il passato una rottura, mentre altri ancora definitivamente si interrompono. Concentrazione e dispersione costruiscono un’opposizione forte, divenendo bandiere ideologiche in un dibattito che non riguarda solo la città fisica, ma nel quale i differenti partiti, cosa solo a prima vista sorprendente (Hirschman, 1991), continuano a cambiare di posizione recipro-
ca. Ciò contribuisce a costruire solitamente una continuità con il passato al livello più generale e a prenderne una grande distanza ad una scala più ravvicinata. 30
7. Continuità/discontinuità
La grande varietà di politiche e di progetti, che ha investito la città europea lungo tutto il secolo, può anzi essere raggruppata sotto le bandiere della continuità con il passato, del tentativo di annodare alcuni dei fili che ad esso ci tengono legati o dell’alterità, dell’affermazione della necessaria rottura di alcuni importanti legami con ciò che è venuto prima. Continuità e discontinuità sembrano inseguirsi lungo tutto il secolo costruendo temi ossessivamente declinati: l'ossessione, ad esempio, della memoria, della fine della storia, di un eterno presente. Ad uno
sguardo più ravvicinato, da una distanza critica e temporale forse non ancora sufficiente, il secolo appare però dominato soprattutto dalla ricerca della continuità, una figura che ha una lunga storia nella città europea (Secchi, 2000). Continuità non è sinonimo di conservazione. Af-
fermare il valore della continuità è riconoscere il ruolo dell’inerzia delle cose e delle idee nella costruzione dell’identità (Sartre, 1936). In mo-
do analogo discontinuità è concetto, termine e fenomeno che non si sovrappone né si identifica necessariamente con l’alterità. Costruire una continuità al livello più generale dell’intera città mentre se ne prende distanza alla scala più ravvicinata dell’alloggio o della parte di città diviene, ad esempio, la linea seguita dalla maggior parte delle città europee nei due dopoguerra. La ricostruzione, con le sue urgenze, con l’invito a colmare, in una specie di damznatio memoriae, i vuoti la-
sciati dal conflitto, con i potenti interessi fondiari e immobiliari che sollecita, agisce come un potente stimolo in questa direzione. Già lo si era visto nella ricostruzione delle città fiamminghe dopo il primo conflitto mondiale (Smets, 1985); «dov'era e com’era» diviene un giustificato imperativo in molte occasioni: a Varsavia come a Saint-Malo. Ma la ricostruzione diviene, dopo il secondo conflitto, anche l’occasione per ripensare criticamente la storia che lo ha preceduto, ad esempio la natura e il ruolo dell’architettura moderna nel ri-configurare la città europea. In questa riflessione la ricerca di una continuità con il passato raggiunge in alcuni casi punte estreme come, ad esempio, nel lungo dibattito inglese sul pittoresco negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale e negli anni immediatamente successivi; dibattito animato da «Architectural Review» cui Nikolaus Pevsner partecipa attivamente. Ma anche la vicenda della lunga ricostruzione di Berlino mostra
quanto la ricerca di una continuità con la città precedente il conflitto sia 31
stata una costante delle politiche per la città negli ultimi decenni del secolo. La vastità delle distruzioni di Berlino alla fine della guerra invitava certo a ripensare interamente la città. Nel 1946 il collettivo berlinese diretto da Hans Scharoun propone la costruzione di una città nel paesaggio. Organizzato da una fluida maglia di tracciati ortogonali che isolano differenti unità paesistiche, il piano di Scharoun, ripreso poi in occasione del concorso Haupstadt Berlin del 1961, è in sintonia con le posizioni del Le Corbusier di Marzère de penser l’urbanisme pubblicato nello stesso anno, ma giudicato troppo costoso perché prevede una rete infrastrutturale quasi totalmente nuova. Ad esso viene preferito lo Zeblendorfer Plan che utilizza in maggior misura la rete esistente, giudizio che ricorda quello espresso nel 1931 dal Comitato Centrale del PC(b)US nei confronti della Réporse à Moscou di Le Corbusier. Anche in quel caso, per ricostruire l'economia urbana, si era ritenuto indispensabile utilizzare al massimo la struttura della città esistente. Ancora nel concorso del 1961 il progetto del gruppo Spengelin è preferito a quelli assai più interessanti di Scharoun ed Ebert, degli Smithson e di Le Corbusier. Le vicende successive sono connotate da una sempre più intensa riflessione sul passato di Berlino; una città frammentaria da due
secoli almeno, nella quale come in poche altre la stratificazione di progetti incompiuti, di architetture non realizzate costruisce una città invisibile «più grande e culturalmente più ricca di quanto sia mai stata la città visibile» (Magnago Lampugnani, 1987). Avviata inizialmente in Germania, nella seconda metà degli anni Cinquanta, dalle Darrzstidter Gespriche, fortemente influenzata da Martin Heidegger e ripresa poi, negli anni Ottanta, dal principale protagonista dell’Iba Josef Paul Kleihues, la riflessione sul passato della città, abbandonati gli anatemi nei confronti dell’architettura e dell’urbanistica moderne ritenute colpevoli del suo assassinio (Siedler, Niggemevyer, 1964), diviene ricostruzione critica, costruzione della città nella città, rivisitazione dei modi compositivi e dei materiali urbani del passato, recupero della trama viaria e dell’isolato della Berlino precedente il conflitto (Kleihues, 1987), modo di opporsi contemporaneamente al-
l’americanismo che aveva invaso Berlino Ovest e alla banalizzazione modernista di Berlino Est. Ancora prima può apparire forse più sorprendente la vicenda del piano di Mosca del 1935. Dopo anni di intenso dibattito sul concetto di 52
città socialista, di una città nuova laboratorio dell’edificazione socialista
e di esperimenti progettuali tra i più interessanti del primo dopoguerra, il piano di Vladimir Semenov resta sospeso tra un passato hausmanniano-viennese e un futuro prossimo che si rappresenterà compiutamente
nei piani studiati nel 1943 e 1944 da Patrick Abercrombie per Londra e dei quali anticipa alcuni fondamentali aspetti come la green belt. Semenov, come Abercrombie, si era formato a Londra e considera-
va Unwin uno dei propri maestri. Nel 1912 aveva scritto un libro assai informato nel quale si diceva convinto che la Russia offrisse le condizioni ideali per l’applicazione dei principi howardiani nella declinazione che avevano assunto a Letchworth e nei suburbs disegnati appunto da Unwin. Come altri raffinati architetti del Moderno che avevano raggiunto posizioni di prestigio prima della rivoluzione, Semenov aveva d’altra parte continuato, durante tutti gli anni Venti, una rilettura analitica delle grandi capitali borghesi europee, Parigi e Vienna soprattutto (Cohen, 1997), ma anche dei principi compositivi di San Pietroburgo, di Ledoux e dell’architettura della Rivoluzione francese. In questo clima molti progetti degli anni Venti, audaci, ma insistenti su parti di città o di territorio limitate, apparivano a Semenov non in grado di dare risposta ad alcuni fondamentali problemi della ricostruzione di Mosca e della città sovietica. Ad esempio, non affrontavano il ruolo della città antica se non per negarne il diritto alla sopravvivenza, o il ruolo di una maglia infrastrutturale esistente nello strutturare fisicamente e simbolicamente la città e il territorio. Ma anche i principi insediativi e i tipi edilizi cui erano ricorse le esperienze degli anni Venti, in Unione Sovietica e nell'Europa continentale, apparivano criticabili; ad essi veniva ideologicamente contrapposto il superblocco quale matrice architettonico-urbanistica della trasformazione urbana nelle condizioni del socialismo. Costruendo uno spazio interno comune il superblocco rendeva possibile una vita quotidiana collettivizzata, tema — quello della vita quotidiana — che aveva ricevuto una grande attenzione sin dall'inizio dell’esperienza della città socialista. Queste considerazioni portarono gli organi politici e amministrativi a compiere quella che è stata giudicata «la grande ritirata» e a costruire politiche urbanistiche nel segno della continuità con un passato sia pur rivisitato (De Magistris, 1995).
Nella seconda metà del secolo ventesimo, nei paesi dell'Europa occidentale, la ricerca della continuità è però sempre più fortemente contra33
stata da due fenomeni tra loro intimamente connessi: la dispersione e la frammentazione dello spazio urbano. Gran parte delle politiche e dei progetti per la città oscilleranno a lungo tra una loro accettazione e il loro rifiuto; tra un’interpretazione, spesso banalizzata, del frammento come espressione e rappresentazione di una società pluralista e la ricerca di una continuità con l’esperienza della città del diciottesimo secolo, considerata la più alta espressione della cultura urbana europea (Benevolo, 1993). 8. Ricostruzione e dismissione della città industriale
Sopraffatte dall’imponente domanda di abitazioni, di attrezzature e di infrastrutture prodotta dalle distruzioni, dagli intensi flussi migratori, da un'intensa quanto prevedibile crescita demografica e dalla conseguente domanda di abitazioni, le amministrazioni delle città europee si sono trovate impreparate a fronteggiare, dopo il secondo conflitto mondiale, fortissime pressioni speculative. Ciò che in quegli anni veniva denunciato con forza era la consistente redistribuzione di ricchezza cui la speculazione sui suoli e sugli edifici dava luogo; una redistribuzione che contrastava quella che faticosamente si cercava di ottenere tramite le istituzioni del nuovo Welfare State. Comela formazione di importanti rendite fondiarie alimentasse il processo di sviluppo economico di alcuni paesi non veniva peraltro esaminato con cura e lucidità (Secchi, 1974). Ma le ondate speculative del secondo dopoguerra hanno avuto conseguenze ancor più durature sulla costituzione fisica della città. L’urgenza dei problemi che occorreva risolvere e l’affollarsi sul mercato di atto-
ri con scarse competenze e tradizioni hanno portato, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, all’oblio se non alla cancellazione di una parte importante dei risultati acquisiti negli anni tra le due guerre. Promotori immobiliari, costruttori e progettisti, funzionari pubblici e organi di controllo hanno prodotto e consentito la costruzione di immense periferie nelle quali quegli stessi risultati erano come orecchiati in una goffa mimesi linguistica. Il prezzo non si è fatto attendere a lungo. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, mentre ivincoli e le retoriche della ricostruzione si allentano, le condizioni di vita della grande città europea appaiono sempre meno sopportabili a parti sempre più
consistenti della sua popolazione. Nasce una «questione urbana» che riecheggia, per qualche verso, la «questione delle abitazioni» di un secolo prima. Vivere in città richiede sforzi che non vengono sempre compen34
sati da ciò che la città offre: impegni monetari dovuti ai più elevati costi dell’abitazione e dei servizi pubblici; impegni del tempo dovuti ai sempre più lunghi tragitti tra casa e lavoro o tra i diversi luoghi della città e alla crescente congestione del traffico urbano; impegni fisici, dovuti alla fatica del vivere e muoversi in uno spazio ove le diverse funzioni sono ubicate secondo logiche estranee allo svolgimento della vita quotidiana della maggior parte della popolazione. Famiglie e fabbriche vengono non solo attratte dalla campagna, ma anche respinte dalla città. La dispersione non nasce per caso. Nelle grandi città europee, specialmente nelle grandi città della rivoluzione industriale, a partire dalla fine degli anni Sessanta, si aprono i vuoti di aree industriali abbandonate. La città europea shrzks, non nella misura di Detroit, ma in modo evidente. Un fenomeno non nuovo: più volte, sin dall’antichità classica, alcune città europee sono state abban-
donate dai loro abitanti e dalle loro attività e poi ricostruite utilizzando in parte i materiali della città precedente. Negli ultimi decenni del secolo ventesimo grandi e piccoli edifici entro vaste zone industriali o immersi, quasi incastrati, in densi tessuti urbani sono dimessi; le attività pro-
duttive che li occupano in parte cessano di esistere, in parte si trasferiscono in territori limitrofi se non in regioni lontane. Come conseguenza
sono abbandonate intere parti del sistema infrastrutturale ad esse funzionalmente collegato. Ciò che era stato lentamente accumulato durante quasi due secoli di crescita e sviluppo, intere parti della città ottocentesca e dell’inizio del secolo si trovano ad essere prive di una funzione e di un ruolo con gravi conseguenze sui livelli occupazionali, sullo sviluppo demografico e sulla geografia sociale, funzionale e simbolica dell’intera città. Né i nuovi equilibri internazionali consentono di sperare che ciò che se ne è andato possa tornare. Alcune «città mondo» (Braudel, 1966) perdono il loro carattere e la loro unicità. La crisi della città industriale sembra a molti segnare una cesura nella storia della città europea ed occidentale, cioè la fine della città moderna.
Limitare la crescita urbana non è più all’ordine del giorno; città che sono state al centro della rivoluzione industriale divengono o aspirano a divenire centri di servizi a scale sempre più vaste e affidano all’architettura il compito di rappresentarne un nuovo possibile ruolo. Esposizioni universali, grandi eventi sportivi, politiche culturali e della mobilità offrono l’occasione di interventi puntuali cui si affida il compito di rinno53)
vare immagine, ruolo e funzionamento della città. Nelle parole di Nan Ellin, Form follows Fiction, Fear, Fitness, Finance (Ellin, 1996): musei, stadi,
palazzi dello sport, aeroporti, centri congressi e grandi shopping malls, occupando spesso i luoghi dell'industria o delle grandi attrezzature della città moderna, costruiscono le attrezzature di base di una nuova società
che si auto-rappresenta come più aperta di quelle del passato. L’aeroporto, luogo ove distrattamente si incontrano persone di diverse origini, culture, occupazioni, stili di vita, livelli di reddito e scopi, diviene una delle
più importanti icone della città e della società di fine secolo. Esso si contrappone all’omogeneità di classe dell’Opéra ottocentesca. Accostandosi e aggiungendosi alle attrezzature di base ottocentesche — più fortemente segnate dalla divisione della società in classi contrapposte, come a quelle della prima metà del secolo, distribuite nella città in una costante ricerca di un’eguaglianza sostanziale tra le condizioni di vita e il benessere dei diversi individui e gruppi sociali — le nuove attrezzature costruiscono nuovi simbolismi e ridistribuiscono entro lo spazio urbano flussi e valori costruendo implicitamente nuove visioni e strategie per la città. Contemporaneamente, nei paesi e nelle regioni più povere, il confronto con le parti di città costruite «abusivamente», bidonvilles, barrios
de lata, favelas, porta a dubitare dell’efficacia delle politiche amministrative, delle tecniche, degli strumenti e dei principi del Welfare State e dell'urbanistica moderna così come, in un lento cammino sperimentale, si
erano venuti configurando dalla fine degli anni Trenta. Nell’un caso come nell’altro essi appaiono inadeguati quando non di ostacolo agli obiettivi che le maggiori città ora perseguono. La grande dimensione assunta da città delle quali si comincia ora a cogliere il carattere smisurato e la complessità di situazioni che si stenta a comprendere appieno modificano l'atteggiamento nei confronti della città, delle politiche destinate ad affrontarne i maggiori problemi e delle discipline che se ne occupano. La costruzione del progetto urbanistico e delle politiche urbane cambia così in modi radicali incontrando le ovvie resistenze di leggi, regolamenti e comportamenti burocratici costruiti in epoche precedenti (Secchi, 1989), ma anche la difficoltà a confrontarsi con la discontinuità, il frammento e la dispersione. E in questo clima che viene posta una sempre maggiore enfasi sul «progetto urbano», una dimensione del progetto di architettura e di urbanistica esplorata da architetti e urbanisti almeno dal Rinascimento in poi e in specie nelle politiche cinquecentesche di rezovatio urbis. Come 36
la renovatio cinquecentesca che alcuni storici dell’architettura consentivano ora di conoscere in modi sempre più approfonditi (Foscari, Tafuri, 1983; Tafuri, 1992), l’idea del progetto urbano si fonda su interventi puntuali, limitati e discreti in luoghi strategici; ad essi si affida il compito di modificare, eventualmente in modi radicali, funzione, ruolo e immagine
di intere parti di città se non dell’intera città. Un atteggiamento che, dopo la grande frammentazione degli interventi del dopoguerra, trova una nuova giustificazione e fortuna. Il problema però di ogni politica di rezovazio urbis, nel secolo sedicesimo come nel ventesimo, è quello della sua legittimità: perché quegli interventi e non altri, perché in quei luoghi e non in altri, perché in quella successione temporale e non in un’altra. Sono pochele città che, negli ultimi decenni del ventesimo secolo, si siano poste questo problema: in generale ha prevalso ancora una volta la pressione dei gruppi di interesse, un pragmatismo acritico nell’ansiosa ricerca di un'immagine che riuscisse a comunicare il nuovo ruolo che la città intendeva assumere. Il recupero delle aree e delle infrastrutture dimesse appare in molti casi come una grande occasione persa. Atteggiamenti ispirati ad un disinvolto vitalismo, coerenti alla società della comunicazione, proponendo di continuo nuove immagini prive di inerzia tendono ad annullare ogni identità e ogni differenza (Perniola, 2004) e trovano, negli ultimi decenni del secolo, un consenso acquiescente. L'immagine della città e dell’architettura aspira a divenire globale e non trova più alcuna resistenza, né nei riferimenti alla specificità dei luoghi, né nella pur importante riflessione sul regionalismo critico (Frampton, 1980; Gregotti, 1991). L'ordinario e l’infra-ordinario, cioè
quanto è più prossimo alla quotidianità della vita della gran parte della popolazione urbana, viene abbandonato ad una versione riduttiva e semplificatrice della partecipazione popolare o trova rifugio nella città diffusa. È in questo clima che trova grande fortuna l’immagine della cosiddetta «città normale». Debitrice più del dutch Baublock e della mzanzana barcellonese di Cerdà che dell’isolato ottocentesco, la città normale as-
sume come suoi materiali costitutivi fondamentali una maglia stradale completamente connessa, sovente identificata in una griglia ortogonale, e l’isolato; più o meno aperto nelle diverse versioni, esso è concepito come un oggetto architettonico unitario. Le possibili numerose variazioni attorno a questo tema possono articolarsi e adattarsi, nonostante le apparenze, nelle diverse situazioni contestuali, qualche volta con finezza,
ST
altre brutalmente. Negli esempi migliori esse appaiono come un richiamo all’ordine neoclassico, come la ricerca, nei termini di Stravinskij, del «contegno» che la città sembra aver perso (Secchi, 2000).
9. Il tempo Di fronte al frammento e alla dispersione urbanistica, architettura e politiche urbane sembrano non essere più in grado di ritrovare un pertinente programma di ricerca comune (Huet, 2003) e assumono caratteri
paradossali: da un lato, debbono dare risposte rapide e immediate ad una società sempre più esigente, mobile sino ai limiti della volatilità delle proprie strutture fondamentali, ivi compresa la struttura del potere; dall’altro, divengono sempre più consapevoli dell’inerzia e della durabilità dei propri prodotti, aspirano anzi alla durabilità delle strutture spaziali e dei loro materiali costitutivi. Il territorio appare loro come un enorme palinsesto (Corboz, 1983) sul quale le differenti generazioni hanno lasciato il deposito del loro passaggio e ciò porta a considerare con nuovi occhi l’intero problema della forma e della dimensione della città. Urbanistica e architettura divengono discipline del tempo in un’accezione forse diversa da quella di altre discipline: del tempo come relazione tra cose che cambiano con ritmi differenti. Le loro difficoltà hanno a che fare con la drammatica separazione dei tempi degli individui e della società, sempre più accelerati, e quelli più lenti degli oggetti che occupano lo spazio abitabile; tra i differenti idioritmi dei soggetti e la differente durabilità degli oggetti. La cittàe i territori più densamente urbanizzati appaiono ora conno-
tati dalla porosità, più che dalla sola dispersione; una figura, quella della porosità, che sin dagli anni Venti insegue la città europea (Benjamin, 1925; Bloch, 1965), per la quale vuoto e pieno, spazio edificato e inedificato non si contrappongono come città e campagna sino al diciannovesimo secolo, ma si compenetrano, sfumano l’uno nell’altro costruendo un
unico sistema di relazioni spaziali. Lentamente si fa strada l’idea che era stata di architetti e urbanisti nel periodo tra le due guerre come Bruno Taut (1920), Frank Lloyd Wright (1932, 1958), come idisurbanisti russi (De Michelis, Pasini, 1976; De Ma-
gistris, 1995) o Erwin A. Gutkind (1962) e per qualche verso di Rudolf Schwartz (Frank, 1990; Mantziaras, 2000, 2004), che era stata del New
Deal o, su un terreno solo apparentemente letterario, dell’economista Aleksandr Cajanov nel Viaggio di mio fratello Aleksej nel paese dell’uto33
pia contadina (Cajanov, 1920): architetti, urbanisti ed economisti che nella dissoluzione o sparizione della città, nella sua dispersione, vedevano la possibilità di costruire una nuova forma urbana e sociale nella quale si rappresentasse l’alterità del ventesimo secolo rispetto al passato. Negli anni Cinquanta alcune di queste idee erano state riprese: Adriano Olivetti, ad esempio, una delle ultime figure della borghesia laica e illuminata italiana, negli anni tra le due guerre aveva studiato negli Stati Uniti e nel secondo dopoguerra riprende ad Ivrea e nel Canavese idee che avevano nel New Deal una delle loro radici. In una regione che si sviluppava grazie ad un'industria, l’Olivetti appunto, tecnicamente assai avanzata, Adriano Olivetti propone insediamenti di piccole dimensioni, in parte radicati in un’antica struttura insediativa; insediamenti nei quali si possa riconoscere lo spirito comunitario della «città dell’uomo», ma nei quali particolare attenzione viene posta anche alla qualità dello spazio del lavoro e dello spazio abitato. «Comunità» è appunto il nome che Olivetti dà al movimento di idee che promuove e al quale collabora una parte della migliore intellighenzia italiana: architetti, ingegneri, designer, sociologi ed economisti (Olivetti, 1960). Un disegno analogo, ma di minor chiarezza e forza, viene proposto in Italia dalla riforma agraria varata in quegli stessi anni in vaste zone del paese; una riforma tardiva, ricca di errori sul piano tecnico, che non riesce a mobilitare i propri destinatari e che, nei fatti, si dimostra non essere in grado di arrestare il flusso emorragico di popolazione dalle campagne. Le proposte di Adriano Olivetti erano forse allo stesso tempo tardive e premature: in quegli anni il sistema economico italiano era troppo proteso verso l’utilizzazione di un'estesa forza lavoro entro le maggiori aree industriali e urbane. E solo alla fine del secolo che una maggiore attenzione per i problemi ambientali, come le più numerose e dettagliate descrizioni dei territori della porosità e della dispersione, portano ad osservare questi fenomeni con occhi nuovi, a concepire porosità e dispersione anche come occasione per costruire una nuova forma urbana e sociale nella quale per molti versi si rappresenti un nuovo rapporto con la natura e l’alterità del ventesimo secolo rispetto al passato. Nel crescente interesse di fine secolo delle politiche urbane, degli urbanisti e degli architetti per le questioni ambientali vi è certamente la curiosità per un tema relativamente nuovo, ma vi è forse anche qualcosa di più importante: il tentativo di inserire, tra un tempo sociale sempre più accelerato e il tempo più lento della città fisica, un tempo intermedio, il 99
tempo della natura, degli alberi, delle piogge, delle stagioni, del sole, del vento e delle maree, un tempo cui si dà il compito di costruire un legame trai ritmi della società e lo spazio abitabile cercando, ancora una volta, di
legare il presente ad un futuro più distante.
È difficile dire quanto le politiche, i piani e i progetti costruiti dal racconto della concentrazione e della dispersione abbiano concretamente cambiato la città europea e le sue principali direzioni evolutive. La storia europea è da questo punto di vista assai diversa da quella di altri continenti. Le esperienze cumulatesi nell’ Europa continentale nel periodo tra le due guerre, o quelle inglesi e scandinave del secondo dopoguerra, come le disordinate spinte speculative dei due dopoguerra o i progetti che, inseguendo ipotesi tra loro assai differenti, hanno cercato di affrontare i problemi incontrati dalle città e dai territori europei dopo gli anni Sessanta, hanno costruito una forte distanza dall’estetica della città di antico regime contribuendo ad una modifica radicale dell’immagine della città europea. Inlinea generale le politiche, ipianie iprogetti cui ho fatto riferimento come quelli che non ho avuto la possibilità di richiamare vengono ritenuti, in parte a ragione, responsabili della frammentazione dello spazio urbano, della sua eterogeneità visiva, della sua eccessiva separatezza fun-
zionale e del suo impoverimento semantico. L'enorme progresso delle tecniche costruttive, progresso per il quale i processi di costruzione della città sono rapidamente passati da una situazione di deficit tecnologico ad una di surplus, l'inflazione normativa e il frantumarsi delle procedure che regolano i processi di costruzione della città, conseguenza in larga misura di una progressiva democratizzazione di una società come quella europea che velocemente si trasforma in una società di minoranze se non di attori isolati, avrebbero accelerato queste derive. Numerosi indizi fanno apparire in Europa gli anni Sessanta del ventesimo secolo come un vero spartiacque. Sino ad allora un programma di ricerca largamente condiviso aveva investito la città e il suo progetto attraverso una serie di esperimenti che, sondando diverse situazioni, avevano costruito un sapere lar-
gamente cumulativo; gran parte dei miglioramenti sostanziali delle condizioni di vita entro le città europee debbono essere ad esso attribuiti. Dopo diallorae sino agli ultimi anni del secolo urbanistica, architettura e politiche urbane si disperdono in una sorta di nomadismo consumatore di immagini e la città appare come l’esito di una miriade di risposte individuali a problemi dei quali si stenta a cogliere il carattere generale. 40
1. EL. Wright, La vecchia città. 2. EL. Wright, Il cittadino dov'è?.
41
3-4.H.P. Berlage, piano d’espansione della zona sud di Amsterdam, 1915. Prospettiva a volo d’uccello.
5. Vienna, mappa del III Bezirk. Planimetrie dello Hanuschhof di R. Oerly, 1923-25, e del Rabenhof di H. Aichinger, 1925-27.
42
6. K. Ehn, Karl Marx-Hof, vedute del blocco centrale.
7.H. Gessner, Reumannhof, veduta del fronte su Margaretengiirtel.
8. Poppovits, Dr. Friedrich Becke-Hof.
43
9. T. Garnier, La Cité industrielle. Planimetria del quartiere residenziale. 10. T. Garnier, La Cité industrielle. Veduta della zona residenziale.
44
11
ns i DI re
ul (iS
ASINI
IULIIS 12
13
IST. SITO Ì
11-13. Suresnes, esempio dei quartieri di Habitation Bon Marché voluti dal sindaco Sellier. Iy a/t0, il piano generale.
45
14. Welwyn Garden City. Woodhall Centre. 15-16. Welwyn Garden City.
46
SII:ò;
rrintitmiiitnt
azz
18
19
17. Waterschei, Genk (Limburgo), pianta della città giardino. 18-19. Città giardino di Waterschei.
47
fa Ùi EESBLE FSE ES ERA
Sp CRERNARCIsmea sa
21
n
‘
da
rg
20. L. Kahn, piano per il centro della città di Filadelfia, 1952-53. 21. L. Kahn, studio per una delle torri di accesso al centro della città di Filadelfia, con 1500 posti auto.
48
22. C. Buchanan, Cellular concept. 23. K. Tange, piano per la baia di Tokyo.
49
24
25.
24-27. Fiandre dell’Ovest: la rete tranviaria nel 1910 ca; la rete ferroviaria, la rete
della mobilità e gli accessi alla rete nel 1995.
50
28-30. La dispersione insediativa a Mallorca.
51
\4)
SES
\wN
vd \v)
31. La dispersione nel Veneto centrale.
32. La dispersione delle attività produttive. 3 . La dispersione delle residenze. 34. In grigio, gli edifici costruiti nell’ultimo ventennio.
\D
52
35. La dispersione nel Salento. 36. La dispersione attorno ai centri urbani. 37. Il ruolo della rete stradale minore. 38. Dispersione e colture agricole di eccellenza.
DI
Siena
Può apparire strano inserire in un
libro dedicato alla città del ventesimo secolo Siena, la città
medievale per eccellenza. Eppure i centri antichi sono parte fondamentale dell’esperienza urbana del secolo ventesimo così come le questioni connesse alla loro conservazione, al loro riuso e risanamento. Valorizzazione e imitazione sono parte
ineliminabile del dibattito sulla città e le politiche urbane che, con accenti ed esiti diversi, dal
romanticismo, attraverso tutto il diciannovesimo secolo e in specie dopo il periodo haussmanniano (Roncayolo, 2002), si estende a tutto il ventesimo secolo. Percepiti dapprima da igienisti ed amministratori come parte della città oscura e malsana, ventre della città ove la povertà può accompagnarsi al vizio e alla criminalità, i centri antichi lungo buona parte del ventesimo secolo sono stati oggetto di sventramenti e demolizioni radicali. Tutte le città europee, compresa Siena,
metropolitana e con le tensioni delle quali è portatrice, la finitudo medioevale e la città nella quale essa si rappresenta è apparsa
anche «specchio vero e fedele di una società», spesso idealizzata,
alla quale si è guardato con nostalgia, una città quindi da salvaguardare, se del caso re-
inventare come nel caso dei «puristi senesi» a cavallo tra i due secoli (Zucconi, 1992). La riflessione del ventesimo secolo sulla città del passato è assai più ricca di quanto l'abbiano fatta igienisti e urbanisti ad essi vicini o testi famosi quali Der Stidtebau nach seinen Kiinstlerischen Grundsdtzen di Camillo Sitte (1889), L’Esthétique des villes di Charles Buls (1893) o Vecchie città ed edilizia nuova di Gustavo Giovannoni (1931); più ricca anche di quanto l’abbiano fatta i quasi centoventi studiosi, tra i quali Victor Horta, Giovannoni, Louis Hautecoeur, convenuti ad Atene
nel 1931, due anni prima dei Ciam, per la Conferenza diAtene sulla
possono raccontare una propria
conservazione artistica e storica dei
storia a questo proposito. Nel confronto però con l’espansione
monumenti (Choay, 2002); conferenza svoltasi sotto il
patrocinio dell’Institut de coopération intellectuelle della Società delle Nazioni, l'Unesco dei tempi, ove per la prima volta i monumenti sono considerati «patrimonio dell'umanità». Siena, una delle prime città in Europa dichiarata monumento integrale, preceduta solo da Capri e San Giminiano, ne è un caso esemplare.
Nel retroterra di questa riflessione sta però anche una schiera assai folta di «antimoderni», arrière-
garde de l’avant-garde, secondo l’espressione di Roland Barthes (Compagnon, 2005), con i quali l’inizio del ventunesimo secolo sembra si trovi ancora a dover fare i conti.
più consapevole forse di quelli che l'hanno preceduto, ha sempre progettato la città con un occhio rivolto a quella del passato, interpretandone in modi banali o sofisticati le principali lezioni. Alla fine del secolo la città antica, Siena, ne propone forse tre maggiori. La prima, apparentemente la più
semplice, ha a che fare con l’esperienza comune: negli ultimi decenni del secolo i centri antichi sono amati e frequentati da folle sempre più numerose; Siena, come Venezia, Toledo, Bruges, Rouen o
Kyoto. Non solo i centri medievali, ma anche quelli costruiti nei secoli a noi più vicini: San Pietroburgo, come Barcellona, Savannah in
Georgia o Charleston nel South Carolina. Non solo le città
Siena da sempre ha fortemente sollecitato l'immaginario: non solo quello individuale, ma soprattutto quello collettivo. Chiunque abbia frequentato con curiosità ed
piccoli centri e luoghi oggetto di stratificate falsificazioni come
attenzione la città, i suoi abitanti e
Carcassonne, San Marino o
la loro storia, non può che cogliere la forza con la quale un fascio di immagini si è depositato sulla città e ha resistito nel tempo. Può osservare anche come queste immagini abbiano trasceso la dimensione locale e siano divenute luogo topico dell'immaginario del ventesimo
autentiche e famose, ma anche
Guérande, come la Gròte Markt di
Bruxelles o di Anversa. Un amore strano, professato da persone e gruppi che risiedono stabilmente altrove, che nel centro antico si
recano per i loro riti di acquisto, come turisti o anche solo per il passeggio, per vedere e farsi vedere e che lentamente
secolo: Siena, come altre città antiche europee, fa parte della coscienza storica di una vasta
trasformano i centri antichi, che
parte del nostro mondo.
o in grandi centri commerciali.
Il ventesimo secolo, storicamente
Perché? Non ci si può
sempre più si svuotano dei loro abitanti, in immensi parchi a tema
VP2YIS |
accontentare della risposta semplicistica: perché sono belli. UEOGOSQuesta espressione deve almeno essere decostruita e articolata. Non tutti gli abitanti dei centri antichi ne sono stati espulsi dalla violenza del mercato o delle politiche di demolizione e risanamento. In molte città, come Siena, essi hanno inizialmente
abbandonato il centro antico alla ricerca di abitazioni più areate e luminose; con migliori caratteri distributivi e materiali più ‘adeguati; con rapporti più mediati con la strada e gli altri edifici; in altri termini alla ricerca del maggior comfort interno ed esterno all’abitazione quale si rappresentava nel programma dell'urbanistica e dell’architettura moderna. Neppure l’abbandono dei centri antichi da parte dei loro abitanti è sempre l’esito di una competizione per lo spazio: di un'occupazione del centro da parte di attività e gruppi migliori pagatori. Gli edifici del centro antico di Maastricht ad esempio, come di diversi centri antichi del Nord Europa, apparentemente ben conservati, sono vuoti ai piani
superiori e utilizzati per attività commerciali al solo piano terra. Il centro antico di Maastricht è divenuto un gradevole scenario, insieme di quinte teatrali tra le quali si svolge la grande rappresentazione dell’acquisto e del passeggio di popolazioni che
vi giungono da una vasta regione
transfrontaliera. Il grande successo di questo scenario ci dice piuttosto che, agli occhi dei più, gli spazi urbani del centro antico sono più
confortevoli di quelli della città moderna e della città contemporanea. Il primo ordine di riflessioni che la città antica solleva riguarda dunque il comfort dello spazio del pubblico: una questione che ha a che fare non solo con le forme, le dimensioni e
l’articolazione di questi spazi, ma anche con le condizioni del microclima costruito dalle dimensioni degli spazi non costruiti, dall’orientamento degli edifici, dai materiali utilizzati per gli uni e per gli altri. Piazza del Campo a Siena, ad esempio: di questa famosa piazza, sulla quale si affacciano edifici di cinque diversi secoli, della sua forma, dei modi nei quali è stata costruita, sono state dette e scritte molte cose importanti. Ma l’esperienza comune ha poco a che fare con tutto ciò. Chi abbia invece provato ad osservare a lungo la piazza, ad osservare come nelle diverse stagioni l’ombra e il sole si spostano e come vengono frequentate le sue diverse parti; chi ha provato a rimanere seduto sul pavimento di questa piazza, riparata dal vento, ad apprezzare il calore morbido dei mattoni e la sua pendenza; chi ha osservato i
39-40. Piazza del Campo.
modi semplici nei quali il disegno della pavimentazione facilita lo scolo dell’acqua da questa immensa superficie nei giorni di pioggia, i modi nei quali lo stesso disegno suggerisce le sue modalità d’uso senza imporle, non può che
convenire che è soprattutto il
grande comfort di questo spazio del pubblico ciò che appartiene all'esperienza comune e lo fa amare. La stessa sensazione di benessere troviamo ad Utrecht,
nelle parti meno frequentate dai
turisti di Venezia o di Amsterdam, città che non si trovano ai margini IC VP? dell’esperienza urbana contemporanea, quanto al loro
centro.
collegati da spazi privi di un chiaro statuto. Lo spazio aperto di Siena, invece, come di molte altre città medievali europee, ha tre principali e chiari statuti (Hunt, 1996; Secchi, 2000;
La seconda lezione, alla prima strettamente legata, riguarda la natura dello spazio aperto: delle strade, delle piazze, delle corti e
dei giardini, dei tratti di campagna racchiusi, a Siena, dalla cinta
muraria. Ciò che lascia stupiti e interdetti in molte città europee .del ventesimo secolo è soprattutto
l'assenza di un’esperienza significativa e sistematica dello spazio aperto. Enormemente dilatatosi, esso sembra essersi
polverizzato in un insieme episodico di frammenti tra loro
41
41. Lo spazio interno del giardino.
Choay, 2003). Ad essi, declinati secondo numerosissime varianti,
corrispondono differenti matericità, disegni ed esperienze spaziali. Il primo è quello dello spazio del pubblico, nel quale si è in pubblico e nel quale si svolgono i principali riti collettivi, dalla festa, al mercato, alla processione, al «passeggio». Spazio collettivo e vago, soggetto alle più svariate
interpretazioni e pratiche, lo spazio del pubblico è un interno della città costretto entro i muri di edifici tra loro assai prossimi che
vi si affacciano. Con improvvisi e rilevanti salti di scala esso si dilata nella piazza e nello slargo, entra, come nella pianta romana del
considerate città medievali per eccellenza, non è fatta solo o tanto di mirabili architetture, ma di questi aspetti. Il secondo è il grande spazio
Nolli, nella chiesa, sotto il palazzo pubblico, sotto le tettoie del mercato o del fondaco, s’incastra
aperto e prossimo della campagna, della laguna, delle
negli edifici attraverso il
colline, dell’esterno, dell’altro dalla città, che si offre alla vista, al percorso e agli usi produttivi più che alle pratiche e ai riti collettivi. Tra queste due esperienze si
chiaroscuro dell’androne, del
sottoportico o di altri specifici luoghi di mediazione, si apre alla vista della campagna circostante. Proust ha splendidamente descritto i rapporti tra la pressione esercitata dallo spazio ristretto delle calli veneziane e del loro susseguirsi e l’improvviso dilatarsi del campo o della vista sul bacino e la laguna. Per giungere a piazza del Campo a Siena si compie un’analoga esperienza spaziale.
situano, nella città medievale,
quelle più intime delle corti, dei chiostri, dei numerosi orti e
giardini parzialmente sottratti alla vista ravvicinata ove i rapporti tra
le persone e le attività possono esprimersi in una serie infinita di
sfumature. Il terzo statuto è quindi quello degli spazi segreti, della più assoluta privacy e del silenzio: spazi del lavoro e dell’ozio, ma anche della vita in comune.
Spazio interconnesso, ma di continuo cangiante, lo spazio
aperto della città medievale stabilisce con l’edificio, attraverso
specifici dispositivi, rapporti di grande varietà e complessità. Nel suo disegno, dettato da una fondamentale economia di mezzi
L'ultima lezione, legata a quella precedente in modi più sottili e di non universale comprensione,
riguarda la grammatica e la sintassi del testo urbano antico.
espressivi, si riconosce una
costante attenzione alla soluzione di problemi tecnici di dettaglio: come far sì che le acque scorrano correttamente, come utilizzare un impercettibile dislivello, come utilizzare materiali adeguati. L'estetica senese, come quella di Bruges, di Ascoli Piceno o di tante altre città europee che, nell’immaginario collettivo, sono
Siena è bella, come lo erano alcune opere letterarie per i
grandi critici nord-europei a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, Georg Brandes, Hermann Hettner o Hans Larsson, per il rigoroso controllo della grammatica e della sintassi compositiva dei suoi materiali.
DD
| ZIE
Ciò che connota lo spazio urbano e il territorio senese è l’intimo vP9IGY9S rapporto che si è stabilito e conservato nel tempo tra segno e suo significato, tra forma della
città e del territorioeruolo e funzione svolti da ciascuno degli elementi che la costituiscono. A Siena, ad esempio, i percorsi più rilevanti dal punto di vista della costituzione morfologica dell’insediamento, quelli di cresta,
sono anche quelli lungo i quali si dispongono le attività principali e | più rappresentative, i luoghi più assiduamente frequentati, i più importanti da un punto di vista commerciale. Questi percorsi
fanno capo e congiungono tra loro luoghi altrettanto rilevanti per la costituzione morfologica della città: le sommità collinari sulle quali sono ubicati grandi complessi edilizi, grandi fabbriche che sono le sole a Siena che abbiano il diritto ad una scala diversa da quella del resto dell’edilizia urbana, palazzi nobiliari compresi; un fuori scala che rappresenta l’eccezionalità del loro ruolo nell’organizzazione della società civile e politica senese: grandi complessi conventuali con le loro chiese, il
grande ospedale di Santa Maria della Scala, il Palazzo Pubblico, la
cattedrale. L'insieme di questi luoghi e di questi percorsi costituisce e delimita lo spazio centrale di Siena: uno spazio
interno che più frequentemente di altri assume il ruolo di spazio collettivo. È peculiare di Siena che questo spazio di grande complessità possa essere riconosciuto osservandone una pianta, tanto più osservando il rapporto tra insediamento urbano e morfologia del terreno, tanto più ancora osservando l’ubicazione dei principali edifici cultuali, sedi delle grandi istituzioni, dei principali palazzi, delle principali attività commerciali e direzionali,
o osservando infine le continue variazioni attorno ad alcuni caratteri tipologici ed architettonici dei singoli edifici. È questa certamente una situazione,
precedente la riduzione quantitativa delle moderne metropoli, che a Siena ha potuto conservarsi a lungo e che fa di Siena, come di molte altre città del
passato, più ed oltre che un monumento integrale oggetto di conservazione, un immenso
serbatoio concettuale in grado di impartire ancora importanti lezioni.
Durante tutto il ventesimo secolo Siena è rimasta al margine della modernità, in particolare dello sviluppo urbano e metropolitano. Sino quasi alla fine del secolo ventesimo si respirava a Siena l’aria di provincia dei romanzi di Federico Tozzi. Per questo soprattutto si è conservata tanto
| UZIE
42-43. Le grandi fabbriche senesi: lo Spedale di Santa Maria della Scala e San Domenico.
integra. Molti altri centri antichi europei sono invece stati investiti violentemente dallo sviluppo
assediati da nuove popolazioni e attività, attraversati da nuovi e più
importanti volumi di traffico e a
moderno, si sono trovati al centro
queste pressioni non hanno saputo
di una città e di una metropoli in
o potuto resistere se non opponendo, in un’estenuante corpo a corpo, deboli e
espansione, immersi entro la
megalopoli o la città diffusa,
61
ALTIS
44. La campagna vista dalle mura.
stessa struttura dello spazio collettivo; all'opposto la città
concettualmente ambigue politiche di conservazione.
moderna si è costituita come tentativo di dare una interpretazione collettiva ad esigenze individuali. Due programmi di ricerca fortemente giustificati, ma profondamente diversi.
Siena, come molte altre città
antiche europee, ci propone una questione di grandissima rilevanza: una città come Siena si è costituita
attraverso una continua
interpretazione individuale di una
62
Capitolo terzo
La fine della città moderna
Il secondo racconto è quello di «una ‘grande generazione’» (Godard, 2003), di una generazione che opera entro diversi campi artistici e di ricerca, tra i quali l'architettura e l'urbanistica, e s'impegna nella storia del proprio tempo cercando di costruire una società differente, un «uomo nuovo» cosciente delle dimensioni della propria libertà e, ancor più, cosciente del fatto che la propria liberazione non può essere trovata altro che all’interno di una più ampia libertà collettiva (Gramsci, 1934a); è il racconto dunque di una generazione che, anche con i mezzi dell’urbanistica e dell’architettura della città, si impegna a costruire una diversa storia. Dopo un secolo di critica alle condizioni sociali prodotte dalla città della rivoluzione industriale la cosa non può apparire sorprendente.
1. Una «grande generazione» La generazione cui Henry Godard si riferisce, testimone della prima guerra mondiale e degli sconvolgimenti che l'hanno seguita, «aveva fatto una delle più mostruose esperienze della storia mondiale» (Benjamin, 1933). Come Céline, Bernanos o Giono, aveva combattuto nelle trincee
63
delle Fiandre e delle Ardenne; come Lurgat e Gropius su fronti opposti, aveva osservato le linee nemiche da un aerostato e da quest’esperienza direttamente o indirettamente vissuta è stata segnata. Questa
stessa generazione ha assistito a movimenti rivoluzionari capaci di sollecitare, per una vasta parte della popolazione europea, la speranza di un mondo migliore; è stata testimone di una profonda crisi delle economie occidentali, dell’improvviso abbattersi della povertà su persone
e ceti che sembravano averla scongiurata per sempre, come di uno straordinario sviluppo della produzione industriale e di una completa riorganizzazione dei metodi produttivi; ha potuto intravedere il passaggio da una società indigente ad una società opulenta. «Quest’epoca ha davvero desiderato che il cielo scendesse sulla terra... desiderando ciò che vi è di meglio, ci siamo ritrovati in guerra, una guerra che assai spesso risulta incomprensibile» (Tessenow, 1919). La prima guerra mondiale ha avuto conseguenze importanti e di lungo periodo in Europa e nel mondo. Nelle parole di Benjamin, «la gente se ne tornava muta dai campi di battaglia; non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile... Poiché mai esperienze sono state smentite più a fondo di quelle strategiche attraverso la guerra di posizione, di quelle economiche attraverso l’inflazione, di quelle fisiche attraverso la fame, di quelle morali attraverso i potenti» (Benjamin, 1933). Non è forse azzardato ritenere, come Godard, che quell’evento abbia indotto al-
cuni a prendere una distanza critica dall'esperienza e a riflettere, individualmente o collettivamente, sulla natura della storia e sulle possibilità di imprimerle, nel proprio campo di studio e d’intervento, una diversa direzione. Solo chi crede nella predestinazione può ritenere fatuo un pensiero del genere. In modo analogo, all’inizio del diciannovesimo secolo, una generazione che aveva vissuto le speranze della Rivoluzione francese e gli orrori del Terrore, i sogni del periodo napoleonico e le frustrazioni della restaurazione elabora, nelle due declinazioni del fourierismo e del saint-
simonismo, un pensiero utopico al centro del quale la città, il territorio e le loro trasformazioni divengono rappresentazione di una possibile diversa direzione della storia. Il secondo conflitto mondiale, che pur ha dato luogo ad importanti conseguenze sul piano sociale e geopolitico, non ha prodotto una reazione analoga. Le esperienze della shoah e di Hiroshima, ma anche le ambiguità di molti comportamenti individuali e collettivi durante il pe64
riodo delle dittature e dell’occupazione tedesca di diversi paesi, i malintesi e icompromessi che ne sono conseguiti sembrano aver gelato in
Europa e nel mondo occidentale ogni forma di pensiero utopico. Qualcosa di simile emerge ancora, ma nelle forme di un pensiero sul futuribile, per un breve periodo negli anni Sessanta; al suo centro troviamo però la protezione della sfera affettiva dell’individuo e la dimensione tecnicizzata della vita in una società che si fa ogni giorno più complessa. 2. «Un mappamondo che non includa Utopia non merita neppure uno sguardo» Che la costruzione della città possa far parte di un più vasto progetto di costruzione sociale non è, all’inizio del ventesimo secolo, un’idea nuova.
Come è del tutto evidente, si tratta di un’idea che ha le proprie radici in epoche precedenti, in particolare nelle differenti utopie che dall’antichità classica accompagnano con continuità la cultura dell’Occidente (Carey, 1999) o, più specificamente, di un fascio di idee che ha il proprio retroterra nel primo Rinascimento, quando tutto lo spazio urbano appare progettabile (Calabi, 2001), nella rezovatio urbis cinquecentesca, quando l’in-
sieme di alcuni interventi puntuali appare in grado di dare nuovo significato e ruolo ad intere parti di città se non a tutta la città (Foscari, Tafuri, 1983), nelle strade rectae et latae nelle quali, a partire dalla fine del Cinquecento, si rappresenta la cattura dell’infinito, cioè di una nuova dimensione del pensiero, della società e dell'economia (Benevolo, 1991) e, naturalmente, nell’architettura dell’illuminismo (Kaufmann, 1933) e nella
progressiva ingegnerizzazione in chiave saint-simoniana della città e del territorio nel diciannovesimo secolo. Con la sua forza critica e la sua capacità immaginativa l'utopia accompagna tutto il secolo ventesimo.
«Un mappamondo che non includa Utopia non merita neppure uno sguardo», scriveva Lewis Mumford (Mumford, 1921) riprendendo le parole di Oscar Wilde (Wilde, 1891), perché l’utopia, ben lungi dal configurarsi come previsione o evasione, impone un confronto critico con
il presente e la sua storia, come nei racconti dei diversi popoli e dei loro costumi fatto da Itlodeo nell’Utopzia di Thomas More e spinge ad immaginare, come nella descrizione dell’isola felice nello stesso testo di More, un suo possibile cambiamento. L’immaginazione non confina con
il sogno o il fantastico. Immaginare è quanto fa lo scalatore di Putnam che, per superare le proprie difficoltà, immagina di percorrere vie di65
verse sino a che, con qualche rischio, ritiene di aver trovato quella che gli consente di superare ciò che, guardando il mondo dal sotto in su, ritiene essergli di ostacolo (Putnam, 1978). L'utopia incontra sempre resistenze, inerzie ed atteggiamenti rivolti verso un passato dal quale si ha
paura ad allontanarsi. Immaginare un futuro possibile è quanto fanno, in un periodo di grandi sconvolgimenti sociali e geopolitici, correndo molti rischi intellettuali, iprotagonisti della «grande generazione». 3. Utopie concrete
La riflessione e le realizzazioni degli architetti e degli urbanisti della «grande generazione» cercano di dare all’utopia dimensioni concrete; ciò è quanto le rende specifiche. Critica del presente ed immaginazione di un futuro possibile e necessario si esprimono sul terreno visivo nella grande generazione delle avanguardie artistiche, sul terreno delle tecniche nell’attenzione per il macchinismo e l’americanismo nelle sue diverse forme, ma in particolare, per il fordismo e il taylorismo (Gramsci, 1934b; Cohen, Damish, 1993) e sul terreno sociale nella convinzione
dell'importanza del supporto socio-spaziale per la costruzione di una nuova società. E su questi terreni che le utopie del secolo ventesimo incontrano gli immaginari individuali e collettivi, il mito, l'ideologia e il sapere. Esse cercano di costruire una prospettiva per il futuro ben sapendo che una parte degli eventi futuri potrebbe trasgredire le regole della rappresentazione prospettica, invertendola, dilatandola, proiettandola fuori del suo contesto, deformandone il significato e il ruolo, trasformando la prospettiva iniziale in un’anamorfosi (BaltruSaitis, 1984) e che ciò potrebbe obbligare a modificare il punto di fuga, a riferire il futuro a più punti di fuga. Al contempo, proponendo una sorta di verità pubblica, le utopie del ventesimo secolo oppongono anche una forte resistenza nei confronti del pragmatismo cieco e opportunista che aveva portato agli orrori del primo conflitto mondiale. Quasi al centro del secolo, negli anni tra le due guerre, in differenti situazioni politico-sociali, quest'idea è declinata con differente chiarez-
za, in modi diversi ed eventualmente tra loro in opposizione, nei paesi europei occidentali, piuttosto che in Unione Sovietica o negli Stati Uniti. Essa non si rappresenta nel solo Movimento Moderno e, in particolare, nei soli Ciam. Città e territorio sono investiti da una molteplicità di progetti radicali attraverso i quali il secolo cerca di mostrare la propria 66
diversità rispetto al passato. La loro natura ideologica, nel senso che al termine dava Roland Barthes (Barthes, 1963), risiede nella convinzione
che la modernità non sia mai conclusa e che i progetti degli architetti e degli urbanisti possano dare un contributo fondamentale al suo compimento purché urbanistica e architettura si facciano non solo rappresentazione dei valori di una società, ma anche strumento della sua tra-
sformazione, del suo progresso, di liberazione ed uguaglianza. La «grande generazione» è all'origine di una numerosa serie di città di fondazione, di una serie ancora più numerosa di parti di città che si sono inserite, sovrapposte, giustapposte come critiche severe alla città
esistente modificandone l’immagine o, ancora, è all’origine di una serie di «progetti dimostrativi» attraverso i quali si è cercato di convincere della necessità e della possibilità di cambiare in modi radicali il quadro di vita consentito dalla città di antico regime e, soprattutto, dalla città del diciannovesimo secolo. Mai totalmente condivisi, soprattutto nelle loro derive più rigorose ed estreme, le idee ed i progetti della «grande generazione» informano di sé, per adesione od opposizione, tutta la riflessione sulle forme dello spazio abitabile nella città occidentale; ridotti e banalizzati diventano, in molte situazioni, la xouvm della costruzio-
ne della città nella seconda parte del secolo, in altre, divengono rappresentazione, anamorfosi se non prospettive depravate, dei valori e delle ideologie dei gruppi dominanti e delle strutture del potere (Miller Lane, 198).
L’architettura del potere è una costante nella storia della città europea come di altri continenti e, occorre riconoscere, è responsabile di alcune tra le più alte espressioni architettoniche ed urbanistiche del passato. Abbiamo la tendenza a dimenticare quale potere si rappresentasse nei castelli, nelle regge, nei parchi e in intere parti di città del passato, quali fossero le ragioni delle torri che disegnavano lo skyline delle città medioevali, di quali relazioni sociali fossero espressione i parchi, i giardini o le grandi scenografie urbane del barocco; abbiamo la tendenza a distaccare le forme architettoniche ed urbane dalle relazioni sociali entro le quali esse sono state costruite e dal significato che assumevano per i contemporanei. Nel secolo ventesimo l’arte e l’architettura del potere, delle dittature fascista, nazista, staliniana, franchista e salazariana, quanto quelle del potere finanziario, hanno assunto volti che ci interrogano e quasi sempre ci inquietano (Ades, Benton, Elliott, White, 67
1995). Con il loro enfatico monumentalismo portano ad interrogarci sul significato di un’analoga ricerca svolta dagli stessi architetti della «grande generazione» a partire dagli anni Quaranta (Giedion, 1956); ci inquietano perché i moniti e la memoria che sollecitano e che sono alla radice non solo della parola, ma del senso proprio del monumento, dovrebbero indurre a non lasciare che la distanza tra le parole e le cose, tra
le architetture ed i loro promotori, si ampli troppo. 4. Sforzi estremi dell’immaginazione Nati per la maggior parte tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del diciannovesimo secolo, gli architetti e gli urbanisti della «grande generazione» hanno, negli anni Venti, tra i trenta e i quarant'anni. La loro storia è stata raccontata più volte seguendo diverse linee espositive che mettono in evidenza questioni differenti. Come storia, ad esempio, di
avanguardie che precedono i tempi; di precursori cui succedono pionieri e maestri: è la linea espositiva forse più frequentata dalle storie della città, dell’architettura e dell’urbanistica moderne. Oppure come succedersi di una molteplicità di contributi limitati e parziali che, pur inseguendo come tanti esperimenti di laboratorio temi e ipotesi differenti, cumulativamente convergono su alcuni punti fondamentali. In questa storia i Ciam hanno solitamente occupato, sino a tempi recenti, un posto
centrale (Mumford, 2002). Ma la stessa storia può ancora essere raccontata mettendo al centro, come più importante contributo di questa gene-
razione al progetto e allo stesso modo di pensare la città, ciò che, per non utilizzare il termine spesso frainteso di utopia, indico con i termini, per me equivalenti, di «sforzi estremi dell’immaginazione», e cioè La Ville Radieuse e Broadacre City. Considerati molto spesso come due progetti piuttosto che come testimanifesto nei quali, come nella coetanea Carta di Atene, converge una serie di riflessioni, di esperienze, di prese di posizione intorno ai caratteri della società e della città maturati in un lungo lavoro collettivo, essi sono stati troppo spesso misinterpretati. Nella Ville Radieuse e in Broadacre City non si rappresenta un disegno nel senso tradizionale del termine, quanto una riflessione su diversi principi insediativi e su opposte maniere di pensare alle relazioni tra individui, società e territorio. Direttamente o indirettamente, entrambi questi sforzi nascono dall’incontro con la prima fase della Rivoluzione sovietica e, in particolare, 68
coni problemi che essa pone al mondo e alla società occidentale. Cronologicamente situata a valle del dibattito che attorno al concetto di città socialista si sviluppa tra gli anni Venti e Trenta, forse uno dei più interessanti dibattiti urbanistici del secolo (De Magistris, 1995), La Ville Radieuse nasce, nel 1930, dall’incontro di Le Corbusier con Mosca (Cohen,
1987). Broadacre City nasce invece quando Wright viene invitato nel 1934, in un clima di crescente anticomunismo — quando lo spettro della grande crisi del 1929 non è stato ancora esorcizzato e quando con il New Deal viene varato un vasto programma di rinnovamento della società e dell'economia statunitense —, a predisporre un progetto di città che si contrapponga, come rappresentazione dei valori della società americana e, più in generale, di una società libera, tanto alle idee di Le Corbusier, «cavallo di Troia del comunismo nel mondo occidentale», quanto alle realizzazioni socialiste (Johnson, 1990). In questi anni, all’indomani di un sofferto dopoguerra, di una profonda crisi dell'economia occidentale e alla vigilia dell’insorgere di alcune terribili dittature, si colloca lo sforzo, frutto e sintesi di un intenso lavoro collettivo, di immaginare un mondo diverso che segua un diverso cammino facendo scendere il cielo in terra. Architetti e urbanisti ne hanno a lungo sperimentato alcuni aspetti e cercano di delinearne i fondamentali caratteri complessivi. 5. «Elementaire»
Vent'anni circa dopo la costruzione di Letchworth, dieci dopo Welwyn Garden City, dei primi tentativi cioè di costruire un’alternativa alla grande città, mentre in Inghilterra Howard e Osborn propugnano la costruzione di altre cento Garden Cities e Unwin e Parker costruiscono alcuni Garden Suburbs, negli anni che per gli Stati Uniti Christine Boyer indica come quelli di una superspeculazione responsabile in parte della crisi del °29 (Galbraith, 1961; Boyer, 1983), Ernst May, direttore dell’attività edilizia municipale e già collaboratore di Unwin ad Hampstead Garden Suburb, cerca, nella Nuova Francoforte, in un clima politico totalmente differente (Richard, 1991), di porsi in continuità con alcune delle idee e dei progetti del maestro. Sviluppando precedenti esperienze condotte a Breslavia, May costruisce una serie di quartieri satelliti separati tra loro e dalla città da corridoi verdi; entro un vasto programma d’edilizia sociale, dà un largo spazio, come Unwin, alle case unifamiliari a schiera, ma, diffe-
rentemente da Unwin che in quegli stessi anni vi si oppone, opta chiara69
mente per il linguaggio dell’architettura del Movimento Moderno (Dreysse, 1988).
Martin Wagner e Bruno Taut a Berlino, nel più vasto programma di edilizia sociale della Germania del primo dopoguerra (Scarpa, 1983), costruiscono delle Stedlungen, non dei quartieri satelliti, nuove parti di città in adiacenza alle grandi fabbriche senza alcunché che le separi dal tessuto urbano preesistente. Bruno Taut e Martin Wagner avevano forse co-
me uno dei loro importanti riferimenti le città giardino e i suburbs di Unwin e Amsterdam Sud di Berlage, ma Walter Gropius, Hugo Haring, Hans Scharoun e gli altri architetti chiamati a progettare le nuove Stedlungen costruiscono ambienti confortevoli quanto Hampstead con edifici in linea multipiani e vasti giardini individuali e collettivi. La Stedlung di Onkel-Toms-Hiitte diviene alla fine del secolo uno dei quartieri più ricercati dai ceti medi berlinesi, Berlin Britz è in via di divenirlo. Ma non si
può sottovalutare il fatto che i quattro più famosi quartieri berlinesi del Movimento Moderno, Siemenstadt, Onkel-Toms-Hiitte, Britz e Weis-
senstadt rappresentano meno del 10% del programma edilizio di Martin Wagner negli anni tra il 1924 e il 1932. Francoforte e Berlino sono solo due importanti esempi di una diffusa sperimentazione che, dai primi decenni del secolo sino all’inizio degli anni Trenta, cerca di mettere a punto i materiali compositivi di una città «altra» rispetto ad ogni precedente storico. Amsterdam, Rotterdam, Dessau, Karlsruhe, Celle, Stoccarda, Vienna, Zurigo, Ginevra, Praga, Breslavia, Brno, Barcellona, Milano sono solo alcune delle città nelle qua-
li questi esperimenti si svolgono. Annegati spesso nello sviluppo urbano del secondo dopoguerra, i quartieri francofortesi e berlinesi, come quelli loro contemporanei nei diversi paesi europei, costituiscono un’importante testimonianza di un sentiero che avrebbe potuto essere più rigoro-
samente percorso fino in fondo, sino a convergere, prima delle progressive riduzioni e banalizzazioni del dopoguerra, nell’immagine complessiva di una città radicalmente diversa da quella del passato, una convergenza che viene diagrammaticamente tentata da Le Corbusier e Wright e sperimentalmente cercata nei pochissimi esempi che le condizioni politiche dell'Europa degli anni Trenta hanno consentito. I risultati di queste esperienze sono stati a lungo discussi nei primi tre congressi dei Ciam (Aymonino, 1971): a La Sarraz nel 1928, a Fran-
coforte nel 1929 e a Bruxelles nel 1930. I congressi dei Ciam non erano luoghi tranquilli come l’oleografia delle foto di gruppo può far pensare. 70
Sin dall'inizio, dall’incontro di La Sarraz, entro i Ciam si forma un gruppo «saint-simoniano», del quale facevano parte Le Corbusier e lo stesso Sigfried Giedion, e una sinistra «fourierista-costruttivista» formata dal gruppo svizzero di ABC con Mart Stam, Hannes Meyer, Hans Schmidt ed Ernst May (Gubler, 1983; E. Mumford, 2002). I due gruppi, pur condividendo molte cose fondamentali, ad esempio l’elementarismo, e pur coltivando entrambi un’idea di razionalità forte, un’idea che non entra in crisi che negli anni Ottanta, divergevano nell’interpreta-
zione del ruolo politico della nuova architettura e dei nuovi metodi di produzione industriale, cioè del fordismo e del taylorismo (Ciucci, 1981). Entrambi i gruppi alla fine degli anni Venti avevano già svolto di-
versi esperimenti nel campo della prefabbricazione edilizia e avevano partecipato ad un intenso dibattito sui rapporti tra tecnica e cultura (Maldonado, 1979). Le Corbusier, in una interpretazione forte dell’au-
tonomia dell’architettura, ne rivendicava un ruolo apolitico: l’architettura della città, migliorando le condizioni di vita di tutti, sta al di sopra delle forme del potere; La Ville Radieuse è genericamente dedicata «all’autorità». Il suo particolare saint-simonismo lo porta peraltro, molto spesso, vicino ad ambienti culturali e politici di destra, come vi aveva
portato nel secolo precedente Michel Chevalier, l’ingegnere uscito, come molti saint-simoniani, dall’Ecole des Ponts et Chaussées, imprigionato perché saint-simoniano e considerato quindi sovversivo, poi liberato da Thiers e da questi inviato, nel 1837, negli Stati Uniti per studiarvi i sistemi di trasporto di quel paese, che se ne torna con in una mano la penna che scriverà, quasi contemporaneamente a Tocqueville, Lettre sur lAmérique du Nord e nell’altra quella che scriverà Des interéts materiels de la France: de l’aménagement des voies navigables à la recherche de métropoles (Roncayolo, 1992). Le nuove tecniche del trasporto o produttive, così come poi il taylorismo e il fordismo, assumono, per Chevalier e
per Le Corbusier, un carattere naturale e ineludibile, indipendente dal significato contingente che possono avere sulla parte di popolazione che ne è coinvolta e, attraverso questa, sull’intera società.
Il gruppo svizzero-tedesco-olandese aveva un differente retroterra: un’interpretazione elementarista della città e del processo di sua costruzione che proveniva da De Stijl e dal costruttivismo russo li portava ad interpretare in modi più originali e approfonditi la questione delle tecniche; taylorismo e fordismo potevano essere interpretati non solo come origine di una maggior produttività del lavoro e sfruttamento delya
la classe operaia, ma anche come opportunità per una diminuzione della fatica, della forza lavoro erogata durante il processo produttivo, come contributo cioè alla liberazione dal lavoro. In un legame più profondo di quanto venisse detto con il fourierismo ciò li portava a collegare i progressi del macchinismo con l’organizzazione del tempo del riposo, a proporre la «città verde», luogo ove la forza lavoro progressivamente liberata potesse ricostituirsi dedicandosi ad altre attività, ad interpretare differentemente la questione delle abitazioni ponendo una forte enfasi sulla «casa comune» e, più in generale, sugli spazi condivisi. Una parte di questo gruppo nel 1930 si trasferisce in Unione Sovietica ove, partecipando con proprie proposte a diversi concorsi per le
«città del lavoro», diventa parte attiva nel dibattito sulla città socialista: Avtostroj, Magnitogorsk, Novokuzneck, Novi Cardzou e Mosca divengono i luoghi ove continuare su una scala più vasta e con un diverso impegno gli esperimenti iniziati nei paesi dell'Europa continentale. Convinti dell'importanza del supporto socio-spaziale per il conseguimento degli obiettivi posti dalla industrializzazione, dirigenti politici e responsabili del primo piano quinquennale sovietico invitano architetti e urbanisti a farsi carico, in una fase di accelerata industrializza-
zione delle campagne, della ricostruzione socialista della struttura insediativa dell'intero paese, ponendo una grande attenzione alla costruzione della vita quotidiana (Strumilin, 1930). Alcuni temi ricorrenti nelle utopie europee dal Rinascimento in poi, chiarissimi nelle utopie ottocentesche, vengono ora ripresi: l’ambientalismo, la convinzione cioè dell’importanza del supporto fisico nel costruire una nuova società; la
dimensione finita della città, sia per gli «urbanisti», sia per i «disurbanisti», come per Franklin Delano Roosevelt ed Henry Ford negli Stati Uniti: alla grande città dovrebbero essere sostituiti tanti nuclei urbani di medie se non di piccole dimensioni distribuiti nel territorio; l’attenzione ai modi di vita e alla quotidianità dei giovani, degli adulti, dei vecchi; il lavoro come regolatore delle temporalità, degli idioritmi dei diversi individui e gruppi; l'educazione collettiva dei bambini; l’egualitarismo, tra i generi e gli individui; l’importanza quantitativa e simbolica degli spazi condivisi e un atteggiamento istituzionale, regolamentare e ordinatore dello svolgimento delle diverse attività individuali e collettive. Il club operaio e la casa comune sono i luoghi sperimentali ove questi principi vengono messi alla prova sino al secondo dopoguerra (Ginzburg, 1922; Quilici, 1974; Cohen, 1980; Kubova, 2004).
72
6. «Equilibrium»
Benché opposte nelle loro intenzioni dimostrative, La Ville Radieuse e Broadacre City fanno in larga parte ricorso ad un analogo schema concettuale. In entrambi i casi alcune attività, la residenza, la produzione ed il commercio, le attrezzature collettive per l’istruzione, lo sport e la cultura, assumono una chiara e visibile identità che si esprime e rappresenta in specifici materiali, principi insediativi e ubicazioni. Separare, stabilire corrette distanze e tra loro connettere le diverse attività e le
architetture nelle quali esse si rappresentano, dare a ciascuna attività corrette dimensioni, costruire la città come un parco è parte essenziale
dell’architettura della città. In entrambi i casi la serialità domina e organizza la residenza, la singolarità le attrezzature collettive. L'intero spazio urbano è strutturato da una maglia infrastrutturale che combina, in entrambi i casi, due griglie ortogonali, l’una ruotata di 45° rispetto l’altra. Accanto alle grandi infrastrutture, che collegano la città e ogni sua parte al mondo esterno, sono ubicate le attività produttive e dello scambio e le grandi attrezzature collettive, le aree della residenza
sono irrigate capillarmente da una rete infrastrutturale minore: «le strade da una parte — dirà Le Corbusier — le case dall’altra... perché sono due fenomeni totalmente indipendenti l’uno dall’altro». Struttura d’ordine per eccellenza la griglia costruisce, in entrambi i casi, uno spazio urbano aperto e flessibile, che può espandersi su vasti territori. In entrambi i casi, infine, vi è il rigetto del peso della storia, l'urgenza di
un’architettura della città esteticamente pura e priva delle influenze del passato. Le differenze tra i due schemi si costruiscono su due terreni di diversa profondità.
Il primo riguarda il rapporto con il terreno: in Le Corbusier l’alloggio è staccato dal terreno, ove possibile l’edificio è posto su pilotis che ne segnano il distacco; in Wright all'opposto l’alloggio si mantiene prossimo alle proprie radici terrestri. Grande parco, totalmente destinato a pratiche collettive ed al movimento, il suolo della Ville Radieuse fa parte di una natura che si offre con un proprio e autonomo disegno alla vista dello spettatore e alle pratiche collettive. Giardino, luogo di pratiche individuali e private, prolungamento e intersezione con lo spazio interno dell’alloggio, il suolo di Broadacre è sede di un rapporto più segreto con la terra e la natura. 79
Ad un livello più profondo, nel retroterra della Ville Radieuse sta una
lunga riflessione degli architetti della «grande generazione» e di Le Corbusier sulla grande città ottocentesca, una riflessione che aveva dato luogo nel 1922-25 ai disegni del Plan Voisin per una Parigi di tre milioni di abitanti e, soprattutto, nel 1930, alle riflessioni sui progetti degli architetti moscoviti per La Vi/le Verte; che aveva dato luogo, in particolare, alla polemica con Mojsei Ginzburg e i «disurbanisti» e infine, nello stesso anno, alla Réporse à Moscou (Cohen, 1987). Ma stanno anche,
nel retroterra di Le Corbusier, le diverse proposte emerse in Unione Sovietica in quegli stessi anni dal gruppo degli «urbanisti», in particolare il principio funzional-sequenziale ed il conseguente schema proposto da Miljutin (Miljutin, 1930), allora presidente della Commissione governativa per la costruzione delle città nuove; sta il piano di Magnitogorsk del gruppo di Ernst May con Mart Stam e, naturalmente, vi sono le diverse sperimentazioni condotte nell'Europa occidentale dagli architetti della «grande generazione» e dallo stesso Le Corbusier; stanno Peter Behrens e Auguste Perret con i quali Le Corbusier aveva lavorato nei suoi primi anni di attività; sta, infine, la centralità che la questione del-
le abitazioni, da Engels in poi, aveva assunto nel pensiero sulla città in Europa (Engels, 1872). Nell’edizione-testamento del 1964 Le Corbusier propone di considerare La Ville Radieuse come punto verso il quale convergono i propri progetti e realizzazioni precedenti. Per tutti gli anni Trenta, del resto, Le Corbusier ha continuato a lavorare sulle proprie proposte. Le tavole della Réporse è Moscou vengono presentate con qualche modifica grafica nello stesso 1930 negli Stati Uniti e al congresso dei Ciam a Bruxelles, ove la proposta assumerà appunto il titolo definitivo di La Ville Radieuse; infine, verranno pubblicate in un volume dallo stesso ti-
tolo (Le Corbusier, 1964). In uno strato ancora più profondo nel retroterra della Vi/le Radieuse sta Saint-Simon, stanno Durand, Ledoux e l’idealismo europeo nella sua versione kantiana (Kaufmann, 1933; Dami-
sh, 1981); sta l’idea forte di buona parte del ventesimo secolo della possibilità di sovrapporre ed anteporre alle esperienze ed agli interessi particolari una verità pubblica come evidenza necessariamente destinata ad essere condivisa. Nel retroterra di Wright sta invece la griglia jeffersoniana che aveva consentito di misurare e colonizzare l’intero territorio degli Stati Uniti
74
(Linklater, 2002) e nella quale mitologicamente si rappresentava una forma di democrazia nata nei grandi territori del nuovo continente; una
democrazia erede, in parte, dell’idea di regolarità propria dell’età dei lumi e in parte del mito della «frontiera»: delle idee di libertà, proprietà e conquista che in essa si condensavano. Nel retroterra di Wright sta cioè l’idea che il ruralismo sia alla base delle democrazia americana: «il ruralismo, distinto dall’urbanesimo, è americano e veramente demo-
cratico» (Wright, 1930); ma stanno anche l’origine gallese della sua famiglia materna, i Lloyd Joneses giunti negli Stati Uniti in cerca di terra e di libertà religiosa sull’onda della grande emigrazione degli anni Quaranta del diciannovesimo secolo; stanno il trascendentalismo di Emer-
son e il pragmatismo di Peirce, i New Englanders, Henry D. Thoreau e Walt Whitman (Huxtable, 2004); sta il discorso con il quale, all’inizio
del 1933, Franklin Delano Roosevelt inizia il suo lungo mandato presidenziale e la sua proposta di redistribuzione della popolazione sull’intero territorio statunitense; sta il rapporto con Henry Ford e con la sua
idea di piccoli centri produttivi dispersi nel territorio; stanno le proposte di Miljutin, illustrate in «The Architectural Review» nel 1932 e sulle quali Wright aveva lavorato con il suo collaboratore Edgar Tafel nel 1934; stanno infine i progetti e le realizzazioni di Frederick Law Olmsted che Wright conosceva bene, anche se non lo cita nell’edizione di Broadacre City del 1943, e molti precedenti progetti dello stesso Wright (Johnson, 1990). Le idee che in Broadacre si rappresentano, nascono e si sviluppano in un periodo di straordinaria creatività di Wright. Sino al 1932 Broadacre era solo un insieme di ipotesi verbalmente espresse: le Kabr Lectures a Princeton nel 1930 non contengono ancora alcuna idea precisa
sulla nuova città, ma solo un critica della città esistente. Qualche prima idea compare in un articolo pubblicato nel 1932 in «American Architect» e il nome Broadacre compare per la prima volta in un articolo, Broadacre City: an Architect's Vision, pubblicato in «The New York Ti-
mes Magazine» nello stesso 1932 come reazione ad un precedente articolo nel quale Le Corbusier illustrava La Ville Radieuse. I primi schizzi e il primo modello, costruito dagli «studenti» di Taliesin West, sono del
1934; l'insieme dei disegni e del modello che illustravano 4 new pattern of living for America furono infine esposti al Rockfeller Center di New York nel 1935, accompagnati da un insieme di negazioni verbali nelle quali era riassunto un programma antiurbano concettualmente analogo
75
a quello di Howard (Johnson, 1990). Come Le Corbusier, Wright continuò a ripensare e dettagliare i disegni di Broadacre per tutti gli anni Trenta e i primi anni Quaranta. Può apparire sorprendente che le proposte di Le Corbusier siano state criticate e di fatto rifiutate perché borghesi da Sergj Gornyj, capo dell’ufficio per la preparazione del piano d’ampliamento della Mosca futura e socialista, e da Vladimir Semenov, che sarà poi il principale autore del piano generale di Mosca del 1935, un piano che ha peraltro le proprie radici nella Parigi di Haussmann e nella Vienna della Rirgstrasse. In modo analogo le idee di Wright sono state interpretate come dirette inesorabilmente verso l’abolizione del capitalismo e verso la creazione di una società socialista (Alexander, 1935).
Nella sua risposta ad Alexander, Wright presenta peraltro le proprie proposte come una prima riflessione circa il decentramento urbano sulla necessità del quale erano concordi, durante tutto il dibattito dei primi anni Trenta, urbanisti e disurbanisti sovietici, Franklin Delano Roosevelt
come Henry Ford. Negli anni successivi al 1933, dopo il quarto congresso dei Ciam sulla Patris II e dopo le difficoltà per raggiungere l’unanimità in ordine al testo della Carta di Atene, la «grande generazione» si disperde: Turchia, Kenia, Brasile, Giappone e, soprattutto, Stati Uniti: Joseph Albers al Black Mountain College, Lionel Feininger, Amédée Ozenfant, Piet Mon-
drian e José Luis Sert a New York, Laszlo Moholy-Nagy a Chicago come Ludwig Mies van der Rohe e Ludwig Hilbersheimer, Walter Gropius e Marcel Breuer ad Harvard, Bruno Taut a Tokyo, Ernst May in Turchia e
Kenia, Alexander Klein in Palestina. Una parte rimane in Europa, un’altra vi ritorna dopo il conflitto, ma la tensione che aveva animato gli anni tra il primo conflitto mondiale e i primi anni Trenta, anche a causa della frustrazione prodotta dall’avvento delle dittature e dal successivo conflitto, è scomparsa: inizia una diaspora fisica ed intellettuale che porta a distinguere sempre più chiaramente, in una serie di interessanti microstorie personali, le posizioni di ciascuno. I convegni dei Ciam del dopoguerra hanno temi più articolati anche se meno chiari di quelli degli anni Venti e Trenta; lo sforzo sembra essere quello di mettere ordine nelle molte idee emerse durante il terribile decennio precedente e che stanno sperimentalmente emergendo du76
rante la ricostruzione dei paesi coinvolti nel conflitto, di costruire frames e griglie entro le quali collocare i nuovi problemi della città e le proposte di una più giovane e numerosa generazione di architetti e urbanisti fortemente sollecitati da nuove posizioni, quali l'architettura organica wrightiana o il neo-empirismo scandinavo, da nuove discipline tra le quali antropologia ed etnografia, da un’interpretazione strutturalista o fenomenologica dello spazio e delle pratiche urbane, probabilmente anche da riflessioni quali quelle di Ortega y Gasset in La ribellione delle masse (Ortega y Gasset, 1930), che collegavano l'emergere delle dittature alla sovra-specializzazione e divisione del lavoro capitalista e alla conseguente riduzione di una consapevole partecipazione cittadina alla storia e alla dimensione collettiva. Nei convegni dei Ciam di Bridgwater nel 1947, Bergamo nel 1949, Hoddeston nel 1951, Sigtuna nel 1952, Aix-enProvence nel 1953, Dubrovnik nel 1956 e, infine, di Otterlo nel 1959,
quando i Ciam si sciolgono, cioè nei quindici anni della ricostruzione, le nuove generazioni di architetti e urbanisti, più che una critica alle posizioni e al lavoro della «grande generazione», richiedono un approfondimento e un’apertura dell’orizzonte di riferimento: un approfondimento nel senso di una nuova riflessione sulla storia e un’apertura che riesca a confrontarsi con più articolate situazioni, esperienze e posizioni (Mum-
ford, 2002). Nella diaspora la «grande generazione» ha forse esaurito il proprio ruolo. 7. «Continutté»
Sarebbe però un errore identificare la «grande generazione» con i soli Le Corbusier e Wright, con i soli protagonisti dei Ciam e della Bauhaus o anche con la schiera assai più numerosa di architetti che hanno visto le proprie opere esposte nelle tre sezioni della mostra Modern Architecture organizzata nel 1932 da Alfred Barr jr., Henry Russell-Hitchcock e Philip Johnson al Museum of Modern Art di New York (Hitchcock, Johnson, 1932; Riley, 1992). Il termine di generazione vuole sottolineare quanto alcune reazioni nei confronti del passato, alcune idee nei confronti del futuro e alcuni temi fossero condivisi da una schiera assai vasta, da una folla anche oscura di architetti, di urbanisti e, più in generale, di intellettuali ed amministratori attivi nel periodo tra le due guerre. 7]
Negli anni Trenta sono numerosi i progetti che cercano di raccogliere i risultati delle ricerche condotte nelle diverse parti dell'Europa dagli architetti della «grande generazione» e continuarne l’impegno. Alcuni di questi progetti sono rimasti nella storia del pensiero sulla città e hanno dato luogo a concrete modifiche di alcune importanti aree urbane. La città lineare, ad esempio, il principio funzional-sequenziale di Miljutin, solleciterà lo stesso Le Corbusier nel 1935 a studiare per Bat’a, l'importante industria delle scarpe cecoslovacca, una città lineare nella valle dello Zlin, progetto che verrà ripreso nel 1946 nei Trozs Etablissements Humains. In Belgio, nel 1932, Gustave Herbosch, allievo e poi col-
laboratore di Raphaél Verwilghen, studia un’espansione lineare di Bruxelles che si rifà chiaramente alle esperienze sovietiche, come alle stesse esperienze si ispira nel 1934 René Braem con il progetto di una città lineare lunga cento chilometri da Liegi ad Anversa (Strauven, 1985; Van Loo, Zampa, 1994).
Nel 1935 Maurice Braillard, allora responsabile dell’urbanistica di Ginevra, dota la città di un nuovo piano urbanistico. Con la sua figurazione astratta il piano mette a prima vista in imbarazzo e appare come un’applicazione rigida ed estrema dei principi e dei materiali dell’urbanistica sperimentata nei quartieri di Francoforte, di Berlino, di Celle, di Zurigo, di Barcellona o della stessa Ginevra. Il piano non ha però uno scopo dimostrativo, non si limita a mostrare una parte di ciò che sarebbe possibile per il tutto, ma ha l’ambizione e in parte riesce a proporre e realizzare una nuova forma di città, di una città contemporanea radicalmente diversa dalla città sino ad allora conosciuta (Cogato Lanza, 2003). Il piano della città del 1935 e quello esteso all'intero Cantone ginevrino di due anni successivo mostrano l’importanza dei concetti di ripetizione, serialità e struttura. L’astrazione geometrica della figurazione s'incontra in modi sofisticati con la topografia del territorio. La ripetizione di una serie di barre — materiale costruttivo fondamentale nel piano di Braillard — s'inserisce nella trama viaria e in quella più ampia delle penetranti verdi, dando luogo a piccoli spostamenti e a piccole e sistematiche modificazioni dei rapporti tra edificio e spazio aperto. Alla loro luce la geometria del piano appare assai più articolata di quanto si sarebbe supposto a prima vista, la topografia diviene l'occasione per affermare il valore dell'esperienza sensibile dei luoghi più che della loro esperienza estetica. Le differenze che il piano dell’architetto socialista 78
costruisce, in uno spazio urbano che rifiuta l’isotropismo della città del
diciannovesimo secolo, non sono differenze tra livelli qualitativi, cioè di valore, che possano tradursi in differenze sociali. La ripetizione e la serialità, come la maglia che organizza sia il piano della città, sia quello del Cantone, hanno tutt’altra origine, tutt'altro valore e significato; esse cercano di costruire una città aperta all’uguaglianza dei soggetti ed è per questo che il piano di Braillard, meno legato di quello di Amsterdam ai caratteri della città del diciannovesimo secolo (Hellinga, 1983), si situa allo stesso livello teorico e qualitativo di altri piani contemporanei: del Pla Macià per Barcellona, del piano di Cornelis Van Eesteren per Amsterdam o del piano di Ludwig Hilberseimer per Dessau e ancora di quello di Luigi Piccinato per Sabaudia, delle città nuove progettate in Unione Sovietica dalla May-Gruppe o da Hannes Meyer. Tra il 1929 e il 1934 Cornelis Van Eesteren, dal 1930 chairzzan dei
Ciam, prepara il piano di espansione di Amsterdam, il piano simbolo di questo periodo e della città funzionale, il primo piano moderno che, per essere costruito a partire da un insieme accurato di analisi, affidate prevalentemente a I.S.P. Scheffer e K.T. Van Lohuizen, e su di una visione complessiva dello sviluppo della città, si propone non solo come mo-
dello esemplare, ma anche come guida metodologica nella costruzione di altri piani (Giedion, 1941; Klusman, Teunissen, 2003). Nel convegno
preparatorio del quarto congresso dei Ciam, che produrrà la Carta di Atene, i metodi di analisi e le rappresentazioni cartografiche del piano di Amsterdam in corso di elaborazione verranno proposte come linee guida cui ogni altro caso proposto per il dibattito è invitato ad adeguarsi (Cohen 1997; Di Biagi, 1998). Nel 1949 Giovanni Astengo, dedicando un numero di «Urbanistica» alla «lezione di Amsterdam», lo ri-
propone come modello per l’urbanistica della seconda metà del secolo (Astengo, 1949). La fiducia degli autori del piano di Amsterdam e dei responsabili politici della città nella propria capacità di interpretare la società a loro contemporanea e nella possibilità di estrapolare le tendenze in atto, fiducia che li porta a fare previsioni di lunghissimo periodo, sino al 2000, può apparire ingenua, ma era la prima volta che un piano era predispo-
sto con un grande apparato di informazioni e di analisi. I rappresentanti politici investiti dai due volumi ricchi di dati e di tavole non poterono che affidarsi all’autorevolezza di chi li presentava (Algemeen Uit19
breidingsplan van Amsterdam, 1934). La fortuna del piano è stata davvero eccezionale, la sua dimensione mitica forse irripetibile. In una lezione dal curioso titolo L’urbarzistica in un'ora, tenuta a Ber-
lino nel gennaio del 1928 — la riunione fondativa dei Ciam nel castello di La Sarraz si terrà nel giugno dello stesso anno — Van Eesteren spiega i principi della città funzionale, principi maturati in un lungo studio critico dell’urbanistica di Berlage e, soprattutto, durante alcune importanti esperienze concorsuali. I motti che Van Eesteren ha utilizzato in queste occasioni sono assai significativi: nel 1924, nella competizione per il Rokin ad Amsterdam, il motto è elerzentazre, in quella per ’Unter den Linden a Berlino l’anno successivo il motto diviene equilibri; nel concorso infine per la riorganizzazione del traffico parigino nel 1926 il motto diviene conzinuité. In questi tre motti è condensato il programma di Van Eesteren: un’interpretazione elementarista della città, già presente nel 7zemzorandum preparato nel 1923 per il Prix de Rome, che lo porta a riconoscere e separare i differenti materiali dei quali la città è composta dando un largo spazio allo z0777g; una concezione analitica del progetto della città come continua ricerca di un equilibrio, tra il passato e il nuovo, tra le diverse funzioni, tra le architetture che le esprimono, tra
lo spazio costruito e lo spazio aperto, che lo porta al tentativo di fissare in rapporti e parametri i risultati via via raggiunti e a dare largo spazio alle analisi che precedono la costruzione del piano; una concezione, infine, della crescita della città come processo dominato dalla figura della continuità, dalla possibilità e necessità cioè di inserire ogni nuova azione entro il frazze offerto da una storia urbana che si estende sulla lunga durata. L’azzonamento, chiaramente espresso nel piano di Amsterdam del 1934 nelle forme che diverranno abituali e tanto criticate nei decenni successivi, ha origine nelle pratiche sociali prima che nei progetti degli urbanisti. A partire dalla fine del diciottesimo secolo, con l'emergere graduale dei ceti medi, si modifica in Inghilterra, e successivamente anche in altri paesi europei, un intero sistema di valori relativi all’abitare. La domesticità comincia ad assumere una sempre maggior importanza per tre ordini di motivi: la pressione, da una parte, dei movimenti evangelici per i quali la casa diviene un microcosmo, nucleo di una società
ideale opposta al mondo esterno; i progressi tecnologici e sanitari con la conseguente diminuzione della mortalità infantile e la maggior pre80
senza di giovani nelle famiglie dei ceti medi e il distacco, infine, dalla fa-
miglia e dalla casa delle attività professionali o impiegatizie delle nuove generazioni. Il mondo borghese e dei ceti medi si separa in due: in una specie di esterno — il mondo del lavoro e la città — e in un interno — il mondo della casa e della famiglia, l’astuccio del compasso e dei suoi accessori immersi nel velluto, evocato da Benjamin nei suoi scritti degli anni Venti (Benjamin, 1982). La narrativa ottocentesca è piena di personaggi che distinguono e separano o aspirano a distinguere e separare nettamente tra di loro i due mondi (Flanders, 2003) ed è nei decenni ini-
ziali dell'Ottocento che si situano le prime realizzazioni di parti di città, come Edgbaston, la Belgravia di Birmingham, nelle quali è interdetta la presenza di negozi e persino di attività professionali svolte entro la propria residenza (Hall, 1990). Anche le proposte di gran parte dei riformatori sociali ottocenteschi seguono il sistema di preferenze dei ceti medi, dai quali essi stessi provengono (Bullock, Read, 1985). All’inizio del ventesimo secolo l’azzonamento è pratica diffusa, specie nel Nord America; alla metà del secolo in Europa è quasi totalmente istituzionalizzata (Mancuso,1978), ma anche ridotta e banalizzata abbandonando percorsi che pure erano stati proposti.
A partire dal 1901 Tony Garnier disegna una cté industrielle, pubblicata finalmente nel 1918, di fatto contemporaneamente all’approvazione, nel 1917, del piano di Berlage per Amsterdam Sud (Garnier, 1918;
Pawlowski, 1967). I disegni di Garnier erano tutt’altro che immaginari e riguardavano, con ogni probabilità, la piccola città di Givor a sud di Lione (Uyttenhove, 2001). Ciò che Garnier fa nel suo progetto di città industriale è mostrare che diverse funzioni, la residenza, l'industria, le attrez-
zature collettive, danno luogo a differenti principi insediativi e a differenti rapporti con la topografia e con le principali infrastrutture. L’azzonamento diviene pratica progettuale dell’architettura della città, non solo tentativo di separare e allontanare tra loro, trovando la giusta distanza, le differenti funzioni a seconda del loro grado di compatibilità o incompatibilità. La stessa operazione faranno Le Corbusier, che infatti apprezzava il lavoro di Garnier, nella Ville Radieuse e Wright in Broadacre. Ciò che Van Eesteren fa, seguendo peraltro una tendenza già assai chiara, è costruire un insieme di argomenti che consentano di costruire
l’azzonamento al di fuori di idiosincrasie o interessi particolari: di dare delle dimensioni alle diverse zone, di ubicarle correttamente rispetto al sistema infrastrutturale e alla topografia, di separarle o unirle in modo lo81
gico. L’interpretazione elementarista della città l'aveva convinto che ogni materiale urbano doveva essere studiato di per sé nel suo funzionamento e nelle sue relazioni con il contesto; l’attenzione per l'equilibrio l’aveva convinto che occorreva ricercare corretti rapporti tra i diversi spazi e
oggetti; l’idea della continuità che il nuovo doveva far i conti con ciò che già esiste mettendovi ordine. Nel 1968 Giovanni Astengo a Bergamo farà un ultimo tentativo di combinare le idee di Garnier e quelle di Van Eesteren proponendo un azzonamento che esprime, nel linguaggio implicito divenuto abituale per gli urbanisti, la complessità di un progetto tridimensionale della città, ma il suo tentativo non verrà più compreso, come se parlasse un’incom-
prensibile lingua straniera (Astengo, 1970; Viganò, 2000). 8. Copenhagen, Stoccolma
Nel secondo dopoguerra Copenhagen e Stoccolma, città di dimensioni molto inferiori a Londra o a Parigi, si dotano, rispettivamente nel 1948 e nel 1952, di piani urbanistici che adottano una politica di espansione incrementale, di crescita della città per aggiunte successive lungo le direttrici segnate dalla storia precedente ed entro un attento controllo della forma urbana in un recupero di immagini che hanno una lunga tradizione nella città europea. L'immagine del piano della Grande Copenhagen, inizialmente proposta in forma di schizzo, la ben nota immagine delle cinque dita della mano che si distendono nella campagna, si ritrova, ad esempio, a Bergamo, nel Cinquecento; quella della stella del piano di Sven Markelius e Goran Sidenbladh per Stoccolma è frequente nei progetti delle città rinascimentali. Steen Eiler Rasmussen, presidente del gruppo di lavoro incaricato dello studio ed elaborazione del piano di Copenhagen e che certamente l’ha ispirato, nel 1936 aveva preparato un piano per le aree verdi libere e da salvaguardare nella Grande Copenhagen, un piano simile a quelli, ispirati da Olmsted, preparati nei primi decenni del secolo da George Kessler per Kansas City e da Charles Eliot per Boston (Scott, 1995). Il rapporto con lo spazio aperto della campagna diviene, nella Grande Copenhagen, elemento fondamentale e duraturo del controllo della forma urbana come la topografia, il paesaggio e le acque lo divengono a Stoccolma (Utarbetad av Stads Stadsplanekontor, 1952). 82
Stoccolma nel 1932, quando il governo socialdemocratico dà inizio ad una consistente politica edilizia e ad una concezione positiva del welfare che segnerà una forte differenza rispetto alla successiva concezione del welfare nell'Europa continentale, era composta da una numerosa serie di piccoli e medi insediamenti dispersi in una natura dominata dalle acque e dai boschi. Da quella data in poi l’espansione della città dà luogo alla densificazione e unificazione di un territorio disperso più che al suo spraz/. Il piano di Markelius e Sidenbladh, in una situazione di quasi totale proprietà pubblica dei suoli, agisce negli interstizi di questa città ristrutturandola in gruppi di quartieri satelliti separati tra loro e dalle aree produttive da ampi parchi connessi da una fitta rete di corridoi verdi. Memore dei piani del 1918 di Eliel Saarinen per Helsinki e per Tallin, il piano di Markelius e Sidenbladh costruisce un arcipelago: i diversi quartieri, dotati di propri centri e gravitanti attorno ai centri maggiori di Vallingby, Farsta e Skarholmen, sono come isole immerse in una natura d’acqua, di boschi e di declivi verdi. Le densità decrescono dal centro di ciascun quartiere, ove si situa la stazione del trasporto pubblico, verso i suoi margini. Molte attrezzature pubbliche, come i porti in un arcipelago, sono situate lungo la linea che separa le parti edificate da quelle lasciate alla natura, il quartiere dal parco (Rudberg, 1989). 9. Questioni ereditarie
I piani di Copenhagen e di Stoccolma e, più in generale, la tradizione del neo-empirismo scandinavo hanno avuto un’influenza enorme nell’Europa continentale proprio perché costruivano una continuità con il passato al livello più generale e astratto della struttura urbana, mentre dallo stesso passato prendevano le distanze alla scala più ravvicinata dei principi insediativi e dell’organizzazione interna di ciascun quartiere e dei suoi principali materiali costitutivi. Il passato con il quale i due piani di Copenhagen e Stoccolma si confrontavano era diverso: quello di una struttura radiocentrica a Copenhagen e il rischio di un suo evolvere in una vasta periferia indifferenziata come avverrà in molte città europee; quello di una città dispersa entro un paesaggio reso assai ricco e complesso dalla geografia delle acque e dalla topografia nel caso di Stoccolma; ciò spiega, in parte almeno, il loro diverso atteggiamento e le piccole polemiche 83
che negli anni Cinquanta intercorrono tra i due gruppi di progettazione e con le politiche londinesi (Rasmussen, 1950). Ma i piani di Copenhagen e Stoccolma sono anche rappresentativi di un insieme di idee maturate negli anni Trenta: la città parco di Le Corbusier, la città foresta di Alvar Aalto, la città verde e le ipotesi di Taut o dei disurbanisti sovietici, gli insediamenti rurali di Wright o le città disseminate nella campagna di Henry Ford, le città del lavoro sovietiche o «la città dell’uomo» di Adriano Olivetti. Essi, in altri termini, sono rappresentativi di un insieme di idee che avrebbero potuto far trovare i diversi paesi europei più preparati sia di fronte ai problemi della ricostruzione sia quando, a partire dagli anni Settanta del ventesimo secolo, la dispersione è esplosa ed è di-
venuta fenomeno pervasivo. Se osservati oggi, da una certa distanza temporale e critica, gli anni nei quali si situano alcune delle più importanti acquisizioni del secolo sul piano dell’architettura e dell’urbanistica appaiono quelli nei quali la modernità si è espressa ad un livello più alto e rigoroso, ma anche quelli nei quali la città moderna ha forse raggiunto il proprio termine. La critica accanita, spesso ingenerosa, della numerosissima serie di progetti realizzati dalla «grande generazione» nei diversi paesi europei e negli Stati Uniti nei decenni immediatamente precedenti e successivi il secondo conflitto mondiale; la critica del tentativo di far convergere i loro risultati in uno sforzo estremo dell’immaginazione quale si rappresenta nella Vi/le Radieuse o in Broadacre City; la critica del tentativo di codificare questi risultati nel linguaggio implicito della Carta di Atere o di Van Eesteren ma, soprattutto, la critica della folla oscura di progetti che hanno investito la città europea del secondo dopoguerra spesso banalizzando, riducendo e distorcendo ciò che la «grande generazione» aveva proposto. Ciò ha preparato il terreno, negli ultimi decenni del secolo, per un loro più severo riesame critico.
Anche se è difficile dire quali siano state le sue conseguenze sul quadro di vita della maggior parte della popolazione occidentale alla fine del secolo ventesimo, la «grande generazione» e i dibattiti che ha suscitato hanno posto con chiarezza il problema delle relazioni concrete tra libertà individuale e libertà collettiva. Quella della «grande generazione» era ancora un’epistemologia spettatoriale che continuava ad osser-
vare il mondo dal di fuori, enfatizzando il valore della continuità e della quantità; affascinata dal macchinismo la «grande generazione» sud-
84
divideva e scomponeva ogni elemento alla ricerca del suo miglior funzionamento; la sua società era ancora una società disciplinare, di masse
entro le quali l'individuo era come annegato e protetto (Deleuze, 1990). Nonostante Vision in Motion (Moholy Nagy, 1947) per trovare, nella prima metà del secolo, il sentore di quanto stava avvenendo e ne dominerà l’ultima parte, il sentore di uno sguardo in movimento, dell’irruzione della discontinuità, del frammento, del souci de soi, della ricerca
della privacy e dell’intimità, di una visione dall'interno, occorre rivolgersi piuttosto al mondo della musica, delle arti figurative e letterarie che, dovendo far meno i conti con l’inerzia dei propri prodotti, spesso anticipano i tempi. Ma la «grande generazione» ha tuttavia posto le basi per affrontare questi nuovi aspetti della società europea ed occidentale. La ricerca degli architetti e degli urbanisti della «grande generazione» non è stata solo ricerca formale, produzione di una nuova estetica urbana (Bullock, Read, 1985). Lungo le due linee della «moralizzazione» e della costruzione di un’alternativa radicale, cercando di dare una dimensione concreta al welfare individuale e collettivo, essa ha in-
vestito strati assai più profondi e rilevanti della storia sociale europea e del mondo occidentale.
85
45
47 LEI
mi E L)
HU Um
45. Schema di sviluppo di Francoforte basato sul Trabartenprinzip. 46-47. E. May, E. Bòhm, pianta e veduta della Stedlurg Westhausen.
86
48-49. M. Wagner, B. Taut, Grofsiedlung Britz, 1925-27.
Planimetria generale e veduta aerea.
87
50
Di
50. E. May, Rozzerstadt. I rapporti tra spazio interno ed esterno. 51. E. May, Praunhein. I rapporti tra spazio interno ed esterno.
88
52
fiv
Fixla IA
53
52-53. Brigata Osa diretta da I. Leonidov, progetto per Magnitogorsk, 1930. Schema generale del piano e pianta della zona residenziale.
89
AI HI
s D
urèa»r:320820C3t
CE | Vu 8
agi
CT
TT NWANIULE CLASSÉE LESVILLES PELE-MÉLE
gi
56
ve: D GAS n
DI
56. Le Corbusier, il tessuto della Ville Radieuse,
paragonato a quelli di Parigi, New York e Buenos Aires.
57. Sezione di uno dei fabbricati della Ville Radieuse. Ogni alloggio si affaccia direttamente sul verde e sul cielo; le strade per le automobili passano sopraelevate, senza disturbare il cammino dei pedoni.
Sai
DOTT
1 wo cena E E fait.
pa Pet ia
È i
1°4
Lala x
\
A
ni3) à
p'
CAN
I]
cali
sd
\
See
SCA
pren ì
vi st
pros
+ sap
DS? }
al
t
Sgneni CS
le,
SR
pill
58. EL. Wright, Broadacre City. Veduta zenitale del modello. 59. FL. Wright, Broadacre City. Planimetria generale, schizzo.
92
60
î
On I
DS WU
Ep YT
esi er
sez
SS
61 62
60. Veduta e planimetria (sorto, a destra) del progetto presentato da Le Corbusier,
in collaborazione con Hoste e Locquet, al concorso di Anversa del 1933. 61. M. Braillard, piano urbanistico per la città di Ginevra, 1935. 62. M. Braillard, sistemazione della rive drotte, seconda versione, 1931.
Prospettiva a volo d’uccello e pianta d’insieme.
93
63. Schema del piano regolatore di Amsterdam del 1935. In tratteggio incrociato i nuovi quartieri, in nero le zone verdi. 64. Il piano regolatore di Amsterdam del 1935. A quadretti i nuovi quartieri, a puntini le zone verdi, a tratteggio incrociato le zone industriali, a tratteggio diagonale le zone degli orti.
94
J SI
7
Eos
do ASS
65. E. Saarinen, piano per la Grande Helsinki e schemi di decentramento
pianificato per Helsinki e Tallin. 66. E. Rasmussen, schema del piano delle cinque dita per Copenhagen, 1926. 67. E. Rasmussen, piano delle cinque dita per Copenhagen: piano settoriale della viabilità, 1926.
95
Les Hauts de Rouen
numerose, tassi di disoccupazione giovanile molto elevati e violenza diffusa sulle cose e le persone. Gli abitanti originari hanno lasciato in gran parte il quartiere alla ricerca di nuove situazioni nelle quali meglio si esprimessero stili di vita e desideri coerenti ai maggiori livelli di benessere raggiunti. Quartieri a questo simili, di dimensioni diverse sino ad
Les Hauts de Rouen sono un grand ensemble, uno dei molti quartieri di iniziativa pubblica costruiti in Francia durante i «trenta gloriosi» (Fourastié, 1979), tra la fine cioè degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta. Ad essi era affidato il compito di risolvere una gravissima crisi degli alloggi, di modernizzare l’industria edilizia e di costruire una nuova città nei modi dell'urbanistica moderna: grandi spazi aperti; attrezzature
assumere quelle di una nuova città, si trovano dispersi in tutta Europa
collettive generosamente dimensionate ed efficienti; rete stradale, aree di sosta e aree verdi
tanto nella sua parte occidentale, quanto in quella orientale; in parti cioè che per lungo tempo hanno
dal disegno curato; edifici ben
vissuto entro sistemi politici e
orientati, torri e barre, una plastica
istituzionali profondamente differenti. Secondo diverse declinazioni essi sono l'esito di rappresentazioni della società del ventesimo secolo che sono state comuni ad una gran parte della cultura europea ed occidentale, ma anche di un forte intento pedagogico e di un’insistita retorica del progresso morale e sociale. Les Hauts de Rouen sono un quartiere onesto, correttamente
della città chiara e forte in un contesto di grande qualità ambientale. Il quartiere è stato inizialmente abitato da famiglie nucleari, due genitori e due figli, operai o impiegati con comportamenti e consumi sostanzialmente omogenei; trent'anni dopo è abitato, in molte sue parti, da una popolazione assai differente: immigrati extra-europei, prevalentemente nord-africani,
disegnato e realizzato, ma è da situazioni come questa che è nata e
redditi bassi e aleatori, famiglie
96
Scheda DDCo) EdÙ (2)
sn) aut s de Rouen, o rto foto.
|
si è consolidata, divenendo un
città come La Duchère a Lione, La
luogo comune nell’ultima parte del Vpaj9gsecolo, una critica ingenerosa dell’architettura della città del Movimento Moderno.
Canadière a Strasburgo, Les Courtilières a Pantin-Bobigny o Sarcelle, forse il più famoso grand ensemble, nella periferia parigina; quartieri legati al tessuto antico della città come La Courneuve a Parigi o, infine, quartieri destinati a rinnovare parti insalubri della città come La Bièvre, sempre a Parigi, o St. Joseph a Marsiglia. Dopo anni di polemiche, in un clima politico mutato, una circolare ministeriale ne arresta nel 1973 la costruzione (Langereau,
In Francia una grave penuria di alloggi e inaccettabili condizioni di vita nei quartieri sovraffollati delle maggiori città, le condizioni che danno luogo nel 1954 alla «insurrezione della bontà» dell’Abbé Pierre, portano, alla metà degli anni Cinquanta, a considerare il problema
dell’alloggio fondamentale problema nazionale e spingono verso una politica delle abitazioni che sia in grado di aumentarne rapidamente l’offerta grazie ad una spinta industrializzazione del settore edilizio. Dalla metà degli anni Cinquanta sino all’inizio degli
2001; «Urbanisme», 2002).
anni Settanta, in quindici anni,
abitativo, circa 1,3 milioni di abitazioni nella ex Repubblica Democratica Tedesca, 2,1 milioni in Cecoslovacchia, 3,7 milioni in Polonia, 1,1 in Ungheria, 2 milioni
circa 7 milioni di alloggi sono costruiti nei gra7.ds ensembles; negli anni Sessanta vengono costruiti 300.000 alloggi all’anno, nei primi anni Settanta circa 450.000.
I grands ensembles entrano a far parte del paesaggio urbano francese: con una dimensione media tra i 2.500 e i 3.000 alloggi essi formano città nuove lontane
da un grande centro urbano, in località mono-industriali come il quartiere di Beauregard a Poissy per gli operai della Simca, quartieri nuovi nella periferia di una grande
Nei paesi dell'Europa centroorientale, circa 30 milioni di
persone abitano alla fine del secolo in alloggi progettati e realizzati tra gli anni Cinquanta e Novanta con metodi industrializzati. Lo stock
in Romania e 1 milione in Bulgaria, tra il 18% e il 36% del totale degli alloggi dei diversi paesi, è costituito per la maggior parte da Grofensiedlungen, quartieri che ospitano più di 2.500 abitazioni, o da Stedlungen di dimensioni relativamente più piccole con 5002.500 abitazioni (Rietdorf, Liebmann, Schmigotzki, 2001).
La distinzione tra Grofensiedlung e Stedlung non è irrilevante: per
AGNE
69-70. Les Hauts de Rouen, vedute aeree.
99
raggiunti prima. Fritz Heckert,
Grofensiedlung si intende un quartiere costruito dopo la | CESSIseconda guerra mondiale, di grandi dimensioni e costituito prevalentemente da abitazioni in affitto secondo un progetto delle infrastrutture e del verde che segue regole unitarie; il carattere delle
costruito tra il 1976 e il 1989 a Karl Marx Stadt (ora Chemnitz), con i
suoi 95.000 abitanti, LeipzigGriinau, costruito tra il 1976 e il 1986 a Lipsia, con 100.000 abitanti, Berlin-Marzahn, costruito a Berlino Est tra il 1976 e il 1988, con 135.000 abitanti, BerlinHellersdorf, costruito ancora a Berlino Est tra il 1979 e il 1991, con
costruzioni è relativamente
omogeneo e da ciò deriva una chiara distinzione rispetto
120.000 abitanti, sono alcuni degli esempi più noti (D’Ambros, 2005).
all’intorno. Ciò riguarda sia i
quartieri della ex Repubblica Democratica Tedesca sia quelli costruiti nella Repubblica Federale. Le minori dimensioni di questi ultimi restituiscono l’importanza della politica dell’abitazione nella ex Repubblica Democratica Tedesca e negli altri paesi socialisti.
Altri paesi, come l’Italia, seguono inizialmente politiche abitative differenti che solo più tardi, alla fine degli anni Sessanta, si avvicinano a quella dei grards ensembles (Di Biagi, 2001). Le politiche abitative hanno del resto sempre avuto, in Italia, un carattere r2ultipurpose e le condizioni del mercato del lavoro o delle tecniche hanno avuto un peso analogo a quello della pressione della domanda nel determinarle (Secchi, 1984). Considerazioni, ad esempio, relative ai livelli di disoccupazione, ai livelli di istruzione dei lavoratori che si intendeva occupare, alla limitazione delle importazioni, hanno fatto sì che in Italia, perlomeno nei piani Ina-casa sino
Tra il 1958 e il 1990, ad esempio,
nella sola Repubblica Democratica Tedesca sono stati costruiti 2,2
milioni di nuove abitazioni secondo metodi di costruzione industrializzati; di queste circa 1,5 milioni sono realizzate con pannelli prefabbricati (Platter, da cui il nome Plattenbausiedlungen): 1.140.000 abitazioni sono nelle Grofensiedlungen, 600.000 fanno parte di Stedlungen di dimensioni più piccole. Il maggiore numero di abitazioni è stato costruito nel decennio 1975-85, durante la mitica Wobnbauserie 70 (\WBS 70),
al 1962, ci si affidasse a tecniche e
materiali tradizionali piuttosto che all’industrializzazione edilizia
con un solo metodo di costruzione industrializzato in serie e con tempi di realizzazione mai
(Poretti, 2001), con evidenti conseguenze sui caratteri tipologici
100
degli edifici e dei quartieri che ne erano l'esito.
tedesche degli anni tra le due guerre e dei grands ensembles francesi del secondo dopoguerra.
Ancora più distanti dai grands ensembles sono alcune parti di città costruite nei paesi scandinavi per far fronte ad urgenze abitative simili a quelle cui cercavano di rispondere igrands ensembles. Tapiola, ad esempio, nella città di Espoo accanto ad Helsinki, costruita come una forest town negli anni Cinquanta, benché fortemente e forse indebitamente criticata negli anni Sessanta, deve essere considerata uno dei più alti esempi di architettura e urbanistica moderna, testimone di «un periodo nel quale il quotidiano aveva assunto una dimensione eroica» (Viganò, 2001). «Città foresta» è espressione usata da Alvar Aalto negli anni Trenta in occasione del piano di Sunila: una città che si adatta alla topografia e che cresce per moduli secondo le mutevoli esigenze degli abitanti. Nel
Alla fine del secolo Les Hauts de Rouen sono divenuti una «zona
sensibile» e, come molti quartieri simili in diverse parti d'Europa, sono investiti, almeno in modo implicito, da proposte tra loro
spesso opposte che, nei loro termini essenziali, possono essere
colte nelle parole degli abitanti e dei loro rappresentanti, degli amministratori, dei vari esperti chiamati al loro capezzale e dei loro commentatori: demolirli,
trasferire gli abitanti altrove come si è fatto per molte parti del centro storico, dal quale peraltro una parte dei suoi abitanti proviene. Oppure gradualmente svuotarli dei loro abitanti attuali; attendere che i caratteri di una massa critica di popolazione cambino, che gli abitanti attuali divengano una sparuta minoranza; una politica di
retroterra di Otto Meurman,
diradamento fisico e sociale quale
progettista di Tapiola, vi era Mumford, in quello di Aalto oltre Mumford vi era Wright, ma vi era anche, se non soprattutto, la
si è spesso praticata nei centri storici. Oppure ancora
connetterne la rete viaria gerarchizzata e ricca di i7passes in modo da costruire un r247/lage più omogeneo che renda il quartiere permeabile in ogni direzione, il più simile possibile ad una parte di «città normale»: isolati impiantati su di una maglia stradale ortogonale e totalmente connessa. O lavorare sull'idea di un quartiere
tradizione scandinava, una
tradizione che non temeva la discontinuità dello spazio urbano, né temeva composizioni più libere che, proprio perché rispettose di una topografia sovente assai articolata, si scostano dalla rigidità degli schemi tipici delle Stedlungen
101
VP9GIS |
Sessanta del ventesimo, con
multi-etnico; rinunciare ad una
qualche anticipo o ritardo nei diversi paesi europei, la città è stata
integrazione diffusa e omogenea, | DpIdIS:rafforzare le identità alla scala del quartiere e pensare all’integrazione
meta, come noto, di intensissimi
come insieme di relazioni tra diversi entro l’area metropolitana o la regione; lasciare, come peraltro già avviene in molte parti della città europea, che modi di vita e attività si sviluppino coerentemente alle culture delle popolazioni che
flussi migratori che hanno provocato una crescita senza precedenti della sua popolazione e della domanda di abitazioni. Le distruzioni belliche, sia
all’indomani del primo conflitto mondiale, sia soprattutto dopo il secondo, quando Les Hauts de Rouen e molte parti di città ad essi
abitano il quartiere; s’infiltrino,
come in un processo di percolazione, entro le geometrie
simili sono state costruite, hanno
del disegno originario, le pieghino
fatto sì che in Europa la questione delle abitazioni fosse, per gran parte del secolo, al centro di quasi tutte le politiche urbane. La città del ventesimo secolo ha preso forma in gran parte grazie a questi
e deformino incrementalmente,
modificando destinazioni d’uso, aggiungendo o togliendo volumi, densificando e rendendo meno rigida la stereometria del quartiere. Oppure ancora modificare l’immagine del
interventi.
Negli ultimi decenni del secolo il tema è cambiato. La crescita urbana in molti paesi ha avuto se non un termine un sensibile rallentamento. Per una serie di ragioni demografiche, sociali, economiche e culturali gli immensi trasferimenti di popolazione dalla campagna alla città, dall’agricoltura all’industria, dal
quartiere inserendovi nuove
attività pulite e tecnologicamente avanzate, ospitate in edifici immersi nel verde e in zone ben allacciate alle maggiori infrastrutture stradali. La forza retorica dell'immagine è spesso associata ad una sua capacità auto-realizzatrice, al potere di far divenire reale ciò che inizialmente è solo
Sud al Nord, dal mondo e dalla
cultura rurale al mondo e alla cultura urbana si sono dapprima
rappresentazione. Tutto ciò pone
seri problemi a chi rifletta sulla storia del ventesimo secolo e sul suo senso.
attenuati e poi praticamente
annullati. Mentre gran parte della popolazione dell'Occidente europeo, protetta da elevati livelli di reddito e da un Welfare State che aveva esteso il proprio intervento a
A partire dal diciottesimo secolo e sino almeno a tutti gli anni
102
È
i
si
ngi
I]
Les tours
«TT
DPS |
rl _
Les équipements
![Atlante del ventesimo secolo. I documenti essenziali. 1969-2000 [Vol. 4]
8842094560, 9788842094562](https://dokumen.pub/img/200x200/atlante-del-ventesimo-secolo-i-documenti-essenziali-1969-2000-vol-4-8842094560-9788842094562.jpg)
![Atlante del ventesimo secolo. I documenti essenziali. 1900-1918 [Vol. 1]
9788842094531, 8842094536](https://dokumen.pub/img/200x200/atlante-del-ventesimo-secolo-i-documenti-essenziali-1900-1918-vol-1-9788842094531-8842094536.jpg)
![Atlante del ventesimo secolo. I documenti essenziali. 1946-1968 [Vol. 3]
8842094552, 9788842094555](https://dokumen.pub/img/200x200/atlante-del-ventesimo-secolo-i-documenti-essenziali-1946-1968-vol-3-8842094552-9788842094555.jpg)
![Mysterium salutis. Lessico dei teologi del secolo ventesimo [Vol. 12]
8839900128, 9788839900128](https://dokumen.pub/img/200x200/mysterium-salutis-lessico-dei-teologi-del-secolo-ventesimo-vol-12-8839900128-9788839900128.jpg)