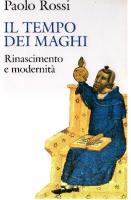I diluvi e il tempo. Aforismi e frammenti filosofici 9788885716216, 9788885716339
Leonardo da Vinci Filosofo presenta molte sorprese per il lettore di oggi: la sua indagine su i principi della Natura si
119 54 7MB
Italian Pages 218 Year 2018
Polecaj historie
Table of contents :
Gli Aforismi filosofici di Leonardo da Vinci
Avvertenza per il lettore
Tavola dei codici
Pittura e Prospettiva
Aforismi e Pensieri
Aforismi sulla Natura
Frammenti del Trattato dell’Acqua
I Diluvi
Tempo
Bibliografia generale
Indice
Citation preview
1
Leonardo da Vinci I diluvi e il tempo Aforismi e frammenti filosofici
2
3
C an o n e e u r op eo
Collana diretta da: Andrea Tagliapietra
Comitato scientifico: Giovanni Bonacina, Catherine Douzou, Nicola Gardini, Helmut Karl Kohlenberger, Leonel Ribeiro dos Santos.
4
Canone europeo | 2
5
Leonardo da Vinci I diluvi e il tempo
Aforismi e frammenti filosofici Introduzione e commento di Paolo Bordonali
6
Pubblicazione del Centro di Ricerca Interdisciplinare in Storia delle Idee (CRISI) e del Centro Europeo di Ricerca di Storia e Teoria dell’Immagine (ICONE)
© 2018, INSCHIBBOLETH EDIZIONI, Roma. Proprietà letteraria riservata di Inschibboleth società cooperativa, via G. Macchi, 94 - 00133 - Roma www.inschibbolethedizioni.com e-mail: [email protected] Canone europeo ISSN 2533-1329 n. 2 - ottobre 2018 ISBN – Edizione cartacea: 9788885716216 ISBN – E-book: 9788885716339 Copertina e Grafica: Ufficio grafico Inschibboleth Immagine di copertina: Leonardo da Vinci © myper – Fotolia.com
7
8
9
Introduzione
Gli Aforismi filosofici di Leonardo da Vinci di Paolo Bordonali
L’immagine di Leonardo da Vinci come pensatore, anticipatore e annunciatore dei tempi moderni, si è affermata fin dall’Ottocento con la pubblicazione dei manoscritti. In particolare è stato considerato come scienziato, per la visione dell’esperienza che fonda la conoscenza umana e l’utilizzo del disegno per studiare i meccanismi e il moto, così del corpo umano come dei fenomeni fisici. L’applicazione positiva della geometria alle macchine ne ha fatto quasi il precursore della convergenza di sapere teorico e tecnica, anche se non erano mancati degli esempi nel secolo precedente e poi nel Quattrocento con Leon Battista Alberti. Noi oggi riteniamo un errore di prospettiva storica fare del pensiero rinascimentale la premessa della filosofia dell’Illuminismo1. Ma potrebbe ancora non sembrare così grave nel caso della personalità di Leonardo da Vinci, vista nella sua eccezionalità, nel suo rifiuto di accettare l’autorità della tradizione e nella rivendicazione dell’autonomia della sua attività di artista, anche rispetto alla nuova cultura umanistica del suo tempo. Tuttavia è proprio il suo caso tanto studiato e celebrato come 1. G.B. Venturi, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci, Paris 1797.
10
“uomo universale”2 che ha portato a sottolineare l’isolamento di Leonardo per la sua eccentricità nella sua epoca storica, la scarsa considerazione da parte dei filosofi delle Università delle sue concezioni, rimaste non pubblicate tra le sue carte e disegni e quasi sconosciute fino a quando Jean Paul Richter ha reso noti gli estratti da tutti i suoi manoscritti3. Il concetto romantico di “genio”, di personalità dalle capacità eccezionali che crea una visione del mondo nuova, che supera il suo tempo e si proietta nel futuro, è a tutt’oggi riferito di preferenza a Leonardo da Vinci. Nell’Ottocento inizia Michelet a vederlo come il Faust italiano e finisce Valéry per considerarlo come il simbolo dello Spirito artistico4. Nonostante il fatto che il mito di Leonardo abbia avuto nel Novecento moltissimi sostenitori ed abbia raggiunto notevoli livelli di esagerazione, spesso con interpretazioni contraddittorie e opposte, non si è arrivati a considerarlo pienamente come filosofo. Infatti Benedetto Croce5 ha negato che la sua concezione potesse essere una filosofia perché non corrispondeva alla svolta 2. J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (1866), trad. italiana di D. Valbusa, Introduzione di E. Garin; Id., La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1980; G. Procacci, Storia degli italiani, Bari 1983, pp. 116-117, parla di un Leonardo isolato nel suo tempo, E. Garin (a cura di), L’uomo del Rinascimento, Bari 1988, critica lo stesso concetto di uomo universale, proposto da Burckhardt in riferimento a Leon Battista Alberti e Leonardo. 3. J.P. Richter, The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Voll., London 1883. 4. P. Valéry, Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci (1894), in “Varietà” a cura di S. Agosti, Milano 1990; S. Migliore, Tra Hermes e Prometeo. Il mito di Leonardo nel Decadentismo europeo, Firenze 1994, pp. 101-119. 5. B. Croce, Leonardo Filosofo? Conferenza Firenze, aprile 1906, ora in Id., “Saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di varia filosofia”, Bari 1948, pp. 207-234. G. Gentile, Leonardo, in “Storia della filosofia italiana”, Vol. I, Firenze 1963, pp. 262-278, riprende il giudizio di Croce sulla mancanza di uno sviluppo logico negli scritti di Leonardo, sostenendo tuttavia che
11
idealistica del pensiero: le annotazioni di Leonardo sarebbero legate all’osservazione naturalistica ed empirica. Croce non trova che sia possibile interpretarlo secondo i temi e problemi del presente, pretendendo che la storia del pensiero sia uno svolgimento di cui la filosofia è il punto d’arrivo, che si distingue nettamente dall’arte e dalla scienza. Pur concedendogli la qualifica di scienziato e di sommo artista, per Croce Leonardo non avrebbe raggiunto la sistematicità necessaria per sviluppare non solo concetti teorici ma nemmeno un’estetica, “disciplina speculativa, che presuppone e compie il sistema”. La ricerca di una continuità nello sviluppo del sapere scientifico, piuttosto che collocare ogni autore rispetto alle domande del suo tempo, ha spinto negli stessi anni di inizio Novecento Pierre Duhem a riportare la concezione naturalistica di Leonardo ad un quadro mentale medioevale, con qualche novità dipendente dalla teologia matematizzante di Niccolò Cusano6. Edmondo Solmi7 lo smentiva e riproponeva la figura dell’artista anticipatore del metodo scientifico, in un’armonia e sintesi di arte e scienza che il mondo moderno avrebbe dovuto cercare di ripetere, in riferimento ad una filosofia positivista. Ernst Cassirer8 tentava di recuperare la dipendenza supposta da Duhem da Cusano all’interno di una storia della filosofia incentrata sulla questione del metodo della conoscenza, per
nell’attività artistica Leonardo esprimerebbe implicitamente una visione filosofica, quella dell’arte come potenza creatrice ed “eternatrice” (p. 268). 6. P. Duhem, Études sur Léonard de Vinci: ceux qu’il a lu, ceux qui l’ont lu, 3 voll., Paris 1906-1913. 7. E. Solmi, Scritti vinciani. Le Fonti dei Manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, (1 ediz. 1908-11) Firenze 1976. 8. E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Voll. I-II, Berlin 1906-1907; Id., Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig 1927, ed. italiana Id., Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, a cura di F. Federici, Firenze 1935.
12
cui le esigenze della pittura rinascimentale si risolverebbero in questioni dell’epistemologia e della metafisica, tesi riproposta con accenti diversi in Italia da Rodolfo Mondolfo9. Infine è stato Karl Jaspers che ha preso in considerazione Leonardo come filosofo10, con un’analisi che riprenderemo più avanti. Di fronte a tesi tanto contrastanti la nostra proposta di considerare il carattere filosofico di molti testi di Leonardo richiede in qualche modo una cautela e persino una chiarificazione preliminare di come si intende interpretarli. Attenersi ai testi dell’autore è il punto di partenza obbligato per qualsiasi lavoro ermeneutico di chiarificazione del contenuto di senso. E già scegliere dall’opera di Leonardo quali siano i testi da prendere in considerazione richiede di basarsi sul lungo e difficile lavoro filologico che generazioni di studiosi ha portato a compimento. Prima ancora di una ricerca sulle fonti filosofiche, potremo motivare come risultato della lettura dei testi e frammenti che lo stesso Leonardo aspirava a formulare una propria filosofia. Questo desiderio o, se si preferisce, sua pretesa, è nato dalla stessa esperienza di pittore prospettico e ingegnere militare. La sua filosofia nasce in un contesto esterno alle Università, in contatto con la corte dei Medici, signori di Firenze, con le pratiche di bottega che la condiziona, e la frammentarietà dei suoi appunti è legata sicuramente al lavoro, ai fogli utilizzati per schizzi e progetti della sua attività artistica. Ne è sorta la domanda inevitabile sul suo riferimento a conoscenze nate all’interno delle botteghe artigiane, influenzate da correnti culturali ai margini delle istituzioni ufficiali, come potevano essere l’Alchimia pratica o l’Ermetismo. Ancora di più si è posta dai critici la questione di come ad un certo pun9. R. Mondolfo, Figure e idee della filosofia del Rinascimento, Firenze 1963. 10. K. Jaspers, Lionardo als Philosoph, Berna 1953, ediz. italiana a cura di F. Masini, Leonardo filosofo, Napoli 1983, ristampa Milano 2001.
13
to, alla corte di Milano, Leonardo abbia sentito l’esigenza di raccogliere le sue osservazioni e di imparare a diventare uno scrittore. Il voler prendere in considerazione i frammenti di Leonardo come una filosofia pone innanzitutto una questione di forma, entrare nel merito di come sia arrivato a fissare i suoi pensieri in aforismi, quando questo stile trovava poco credito in volgare, prima che avesse raggiunto una formulazione convincente e comunque in concomitanza di un recupero degli umanisti delle massime latine e greche. Da dove ha potuto riprendere questo stile? Esisteva ed era conosciuta una tradizione filosofica che si esprimeva in questo modo? Solo in riferimento alla risposta a queste domande potremo valutare se questi scritti frammentari possono costituire una filosofia autonoma, una proposta coerente, che accompagna osservazioni precise dei fenomeni con alcuni principi teorici.
1. Leonardo scrittore di aforismi Leonardo da Vinci lasciò la gran parte dei suoi manoscritti, quando morì ad Amboise in Francia nel 1519, in eredità all’allievo prediletto Francesco Melzi, che li conservò nella sua casa a Vaprio d’Adda, vicino a Milano, e li mise a disposizione di chiunque volesse studiarli. Con il titolo Trattato della pittura11 circolava manoscritta nel Cinquecento tra artisti e pittori l’opera a nome del sommo artista fiorentino, anche se era stata corretta formalmente nella sua stesura finale dallo stesso Melzi. L’effetto di ammasso caotico di appunti e disegni, di
11. Leonardo da Vinci, Libro di pittura. Codice Urbinate lat. 1270 della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, 2 Voll., Firenze 1995.
14
appunti personali e di bottega, senza continuità di argomenti e di nessi, denunciato da molti critici12, doveva apparire già all’epoca di Leonardo pesante per occhi esperti, per il numero esorbitante dei fogli. Ma ciò che comunque va sottolineato è che lo stesso Leonardo aveva raccolto le sue ricerche più avanzate e particolareggiate in quaderni appositi. È la vicenda complicatissima della dispersione di questo lascito, a partire dal disinteresse del figlio di Francesco Melzi alla sua conservazione, che ha determinato l’effetto labirintico, con percorsi che convergono verso un centro nascosto ma che si interrompono improvvisamente, con la fascinazione per molti a voler entrare nei suoi meandri, per ritrovare il filo perduto, per confermare o smentire la continuità presunta e desiderata che li porti verso la contemporaneità. La nascita di un vero e proprio culto degli enigmi legati al nome dell’artista fiorentino ha portato più a favoleggiare di parti mancanti della sua opera, di codici celati e fogli sottratti, piuttosto di indagare su quelli rimasti e arrivando a trascurare i quaderni con temi precisi e argomenti specifici, il Volo degli Uccelli, i fogli di Anatomia, i Codici C e D sull’occhio e la vista, il Codice F sull’acqua, il Codice Leicester sui fossili e la geologia, i diluvi e le teorie cosmologiche. In molte parti dei manoscritti prevale l’interesse alla matematica applicata, fin dall’epoca della sua formazione fiorentina e ancor più a Milano, dove incontra e diventa amico di Donato Bramante, fino all’incontro nel 1496 con il matematico, allievo di Piero della Francesca, Luca Pacioli. Anche altre parti, dominate dai disegni per diversi e non sempre omogenei campi di lavoro, che vanno dalla pittura all’architettura, dalle armi da fuoco alla meccanica, sono comunque in linea con l’educazio-
12. A.M. Brizio, Introduzione a Leonardo da Vinci, Scritti scelti, Torino 1952, p. 7.
15
ne ricevuta nella bottega artigiana di Verrocchio, ed anche con la tendenza degli umanisti ad un recupero degli studi antichi di tipo enciclopedico. La scoperta dei Codici di Madrid, nel 1967, ha evidenziato come Leonardo avesse allargato notevolmente la sua biblioteca13. I tanti manoscritti si presentano, dopo un lungo processo di decifrazione e trascrizione14, come disegni, schizzi e brevi note di lavoro secondo l’usanza di una bottega artigiana, ma anche con appunti di brani letterari, favole, rebus, apologhi e facezie, caratteristiche di un utilizzo per intrattenimenti di una corte signorile, fin dai tempi del suo trasferimento a Milano. Lo stesso Leonardo ne ha raccolto molti in un unico foglio per utilizzarli in altre occasioni, e compongono la parte più consistente del suo lascito letterario. Lo sforzo di dare a storie da presentare a corte una veste ripulita con la scrittura, si giustifica con l’importanza che Ludovico il Moro dava al volgare più utilizzato e famoso, cioè al toscano di Dante, Petrarca, Boccaccio, con la presenza alla sua corte di Bernardo Bellincioni, poeta chiamato espressamente da Firenze, e con le iniziative di lettura e commento della Divina commedia di Dante Alighieri, ad opera di Antonio Grifo15, che si serviva dell’edizione commentata da Cristoforo Landino, considerata già autorevole, dopo l’edizione a stampa del 1481. La sua attività di pittore non era comunque esente, fin dagli anni fiorentini, da necessità di conoscenze più vaste. Un
13. L. Reti (a cura di), Leonardo, Milano 1974, p. 272; Leonardo da Vinci, I Codici di Madrid, a cura di L. Reti, Firenze 1974. 14. P. Galluzzi, La Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci. Un secolo di storia, in “Leonardo da Vinci. La vera immagine”, Firenze 2005, pp. 26-42. 15. V. Calmeta, Prose e lettere edite ed inedite, a cura di C. Greyson, Bologna 1959, p. 71.
16
esempio di come la pittura fosse in stretto collegamento con esigenze di cultura letteraria è l’utilizzo in chiave simbolica delle figure di animali per le rappresentazioni di caratteri di persone, come il ritratto di Cecilia Gallerani, allora amante del Moro, che tiene in braccio un bianco ermellino (in realtà il quadro rappresenta un furetto) simbolo della castità. A tale scopo esistevano manuali e “bestiari” dedicati e il loro conseguente utilizzo era tanto più proficuo quanto l’artista aveva una preparazione letteraria. Nei fogli di Leonardo si trovano anche proverbi e massime, in forma di “imprese”16, cioè accompagnati da disegni esplicativi, da rappresentazioni simboliche, spesso d’animali veri o fantastici; ad esempio nel caso del simbolo della Vittoria si utilizzava il Dragone, della Prudenza il disegno di un ramo o dell’albero di Palma, oppure il Leone per indicare la Fortezza. Questo tipo di attività era simile a ciò che Leonardo aveva appreso a Firenze, lavorando con la bottega del Verrocchio alla preparazione di stendardi e bandiere per feste e manifestazioni pubbliche per Lorenzo il Magnifico. Anche se non sembra abbia partecipato direttamente alla vita di corte, nella sua prima commissione di pittore aveva trascritto sul retro del ritratto di Ginevra Benci, il motto di stampo petrarchesco “Virtus forma decorat”. Il detto era modellato su quello personale dell’ambasciatore veneziano a Firenze, Bernardo Bembo, “Virtus et Honor”. Bembo aveva donato il quadro ad Amerigo de’ Benci, ricco banchiere, come omaggio alla figlia e novella sposa, partecipando così al clima cavalleresco della corte laurenziana17.
16. C. Vecce (a cura di), Scritti di Leonardo da Vinci, Milano 1992, pp. 94-99. 17. D.A. Brown, Leonardo da Vinci. Origini di un genio, Milano 1999, pp. 101-121; si veda anche N. Giannetto, Bernardo Bembo, umanista e politico veneziano, Firenze 1985, pp. 137-8.
17
Giochi e serate a corte richiedevano spiriti arguti e allegri. L’utilizzo di facezie con battute salaci non è così lontano dallo spirito toscano di Leonardo, che possedeva il libro di Poggio Bracciolini delle Facezie in latino, a cui però preferisce ben presto favole, racconti e aneddoti raccolti in giro o di sua invenzione. Un chiaro esempio del periodo milanese di una composizione di massime che dovevano accompagnare un’immagine simbolica, riguarda due imprese: Ostinato rigore. Destinato rigore./ Non si volta chi a stella è fisso.18
Il primo è riferito all’immagine di un aratro nel campo, il secondo a un ago di una bussola che, oltre che indicare il Nord, era rivolto verso le insegne del regno di Francia, i gigli araldici, indicazione di una fedeltà promessa o mantenuta del proprietario. Due frasi molto citate dal decadentismo di fine Ottocento, che le aveva intese come massime morali dell’artista, non tenendo conto dello scopo per cui sono state formulate. Il motto, preso di per sé come se esprimesse un’ideale estetico, assume un significato che non corrisponde all’intenzione dei committenti, e si è finito per travisarne il senso. Tuttavia la comparazione del carattere degli uomini e delle donne con oggetti, “a casse, a scanni, a carri, a candelieri”19 era diffusa nelle corti tanto quanto l’utilizzo allo stesso scopo di animali e piante. Ma nel caso citato si tratterebbe di accostamenti ridicoli, di burle, anche pesanti; invece l’aratro e la bussola non erano oggetti da considerarsi fuori luogo in riferimento a chi 18. Leonardo da Vinci, Windsor 12282 r. Cfr. Vecce (1992), p. 96, che scrive nella nota p. 99: “… imprese, che hanno forse goduto di un’indebita celebrità, in età dannunziana, caricandosi di significati allotrii e inesistenti”. C. Dionisotti, Centenario di Leonardo (1952), aveva parlato della prima metà del Novecento come pervasa da una “religione” leonardesca. 19. B. Castiglione, Il libro del cortegiano, a cura di G. Carnazzi, Milano 1987, p. 177.
18
volesse celebrare un’impresa, per un progetto da compiere con onore, con cui caratterizzarsi, sperando di conseguire gloria e fama. Non è quindi escluso che l’artista, che ha inventato l’emblema in corrispondenza al motto, fosse anche partecipe, almeno emotivamente, del loro significato. L’episodio che avrebbe portato Leonardo a dover utilizzare la scrittura è stato, secondo Carlo Dionisotti20, il volgarizzamento del Landino del De Gestis Francisci Sphortiae di Giovanni Simonetta, opera storica stampata nel 1483 in latino che esaltava il capostipite della casata, lo stesso Francesco Sforza per cui il Moro aveva dato incarico a Leonardo della costruzione del monumento a cavallo, libro che nel 1490 aveva fatto ristampare nella versione in fiorentino, per una maggiore divulgazione in funzione politica autocelebrativa. Leonardo avrebbe visto sminuita la sua opera: infatti nella nuova prefazione il Landino esaltava il ruolo della poesia come capace di tramandare ai posteri la memoria delle grandi imprese, molto più di una quadro o di una statua. Lo stesso Dionisotti ha sostenuto la tesi che la preparazione culturale di Leonardo era per quei tempi ampia e ben caratterizzata secondo uno sviluppo in volgare, che non si limitava ai tre più grandi scrittori, citati e riconosciuti da tutti, ma riprendeva Burchiello e altri minori, i fratelli Luca e Luigi Pulci, autore del Morgante, e anche Angelo Poliziano, di cui prepara le scene per la rappresentazione dell’Orfeo. I suoi interessi, le sue ricerche, erano legate ad una cultura letteraria in volgare molto in voga non solo nella Firenze medicea della sua gioventù, ma che vedeva alla fine del Quattrocento un suo ulteriore sviluppo, quasi in parallelo con la filologia umanistica.
20. C. Dionisotti, Leonardo uomo di lettere, in “Italia medioevale e umanistica”, V, (1962), pp. 183-216, ora in Id., Appunti su arti e lettere, Milano 1995, pp. 21-50, cit., pp. 44-6.
19
Per Leonardo era necessario un uso ampio del volgare, in riferimento non solo ad allietare le serate dei signori con musica, versi improvvisati e raccontini spiritosi, ma anche per lo sviluppo di conoscenze tecniche in vari campi di attività, come è dimostrato dal fatto che si era presentato alla corte milanese con una lettera in cui elencava le sue capacità di ingegnere militare, prima ancora di architetto, scultore in bronzo e pittore21. L’attività di “Vocabolizzare”, cioè crearsi un dizionarietto di termini necessari per l’uso, è attestato nel Codice Trivulziano dai repertori lessicali, ricavati da altri scrittori, e in particolare dalla traduzione volgare del De Rerum militari di Valturio, fatta dal veronese Paolo Ramusio nel 148322. Una propria creazione letteraria è certamente ascrivibile alle “Profezie” di eventi catastrofici, più evidente quando utilizza le sue esperienze tecnologiche e militari in chiave sarcastica e ironicamente moralistica, alcune vere e proprie parodie delle tante voci di segni dell’Apocalisse vicina. Invenzioni legate allo spirito del tempo, e non si può dire che Leonardo ne sia estraneo od esente: “Profezia di Lionardo da Vinci”23 annota di sua mano, quasi a volersi proporre in concorrenza agli astrologi di corte, a cui Ludovico il Moro dava grande ascolto. Troviamo anche un elenco intitolato “Divisione della profezia” (Atl. 393) che propone animali, piante, cerimonie religiose e costumi sociali, casi strani e fantastici, il tutto tra il serio e il faceto, con un tono da favola esopea o di predica morale, che vuole sorprendere e muovere al riso. Infine “Ottava delle
21. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano, trascrizione critica di A. Marinoni, 20 Voll., Firenze-Milano 2006, cit., 1082 r, ex 391 r a; da ora in poi solo Atl. con indicazione del numero del foglio, recto o verso. 22. P.C. Marani - G.M. Piazza (a cura di), Il Codice di Leonardo da Vinci del Castello Sforzesco, Milano 2006, pp. 160-165. 23. Leonardo da Vinci, Atl. 526 a v, ex 194 v a.
20
cose filosofiche”, ed è questa indicazione che ci fa ritenere che Leonardo cominciasse a raccogliere massime e sentenze dei filosofi, in raccolte in volgare o da altri testi che li citavano. Andrè Chastel24, importante critico e storico dell’arte, ha individuato la fonte di molte immagini in Ovidio, Le Metamorfosi, in particolare il libro XV dove viene esposta la concezione di Pitagora di Samo. I versi del poeta latino propongono una perorazione ad abbandonare le uccisioni di animali per i sacrifici e l’adozione di una dieta vegetariana, prima ancora di introdurre il tema fondamentale della filosofia di Pitagora, la reincarnazione dell’anima. Se la condanna dello spargimento del sangue e della guerra, ed anche la tendenza a limitare l’uso della carne, è riscontrabile in alcune affermazioni di Leonardo, non altrettanto si può dire della concezione dell’anima, dal modo come viene messa in ridicolo da una facezia, che dobbiamo perciò considerare filosofica: Uno volendo provare colla alturità di Pittagora come altre volte lui era stato al mondo, e uno non li lasciava finire il suo ragionamento, allor costui disse a quel tale: “E per tale segnale che io altre volte ci fussi stato, io mi ricordo che tu eri mulinaro”. Allora costui, sentendosi mordere colle parole, gli confermò essere vero, che per questo contrassegno lui si ricordava che questo tale era stato l’asino, che li portava la farina.25
24. A. Chastel, Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris 1959, pp. 414 sgg.; ed. italiana Id., Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992. R. Nanni, Ovidio metamorfoseos, in “Letteratura italiana antica”, III, 2002, p. 378 sgg., ha riproposto la tesi di Chastel, perché l’opera ovidiana era disponibile in volgare nella traduzione di Arrigo Semintendi da Prato. 25. Leonardo da Vinci, M 58 v., Manoscritti della Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi, ed. a cura di A. Marinoni, A-M, Firenze 1987-1990; A. Marinoni (a cura di), Leonardo da Vinci, Scritti letterari, nuova ediz. accresciuta con i manoscritti di Madrid, Milano 1974, cit., p. 142.
21
Sicuramente la storiella richiede una conoscenza dell’argomento che va oltre i versi di Ovidio, e la rielaborazione di argomenti filosofici viene sostenuta da un forte scetticismo popolano e un’attitudine alla disputa verbale, che è ben diversa dalle formali “questioni disputate” in latino della Scolastica. Questa raccolta letteraria in volgare è sembrata un’eredità degna, anche se non al livello dei suoi celeberrimi dipinti, di entrare a far parte della storia della letteratura italiana26. Una scarsa preparazione e studio del latino e la tendenza di Leonardo ad attenersi a ciò che era stata tradotto in volgare può essere testimoniato dalla lettura di Plinio il Vecchio, autore del I secolo d.C., la cui opera enciclopedica era fonte unica per molte delle conoscenze tecnico-scientifiche del mondo antico, e quindi al centro degli interessi degli umanisti; infatti Ermolao Barbaro ne discute con Poliziano, ed espone le sue analisi critiche nelle Castigationes Plinianae27, considerato un capolavoro della filologia umanistica. Leonardo possedeva la versione di Plinio in volgare di Cristoforo Landino, esponente dell’Accademia fiorentina con Marsilio Ficino, pubblicata a Venezia nel 147628, che aveva cominciato a studiare a Firenze. È il libro che troviamo tra quelli posseduti all’epoca del trasferimento a Milano, e che lo ha fatto avvicinare allo ambasciatore veneziano, quando questi viveva a Milano nel 1489-90. Sembra infatti che Leonardo sia stato consultato da Ermolao Barbaro per chiarire alcuni passi oscuri del testo di Plinio, in 26. A. Marinoni, L’eredità letteraria, in “Leonardo”, cit., pp. 56-85; C. Scarpati, Leonardo scrittore, Milano 2001. 27. E. Barbaro, Castigationes plinianae, et in Pomponium Melam, ediz. a cura di G. Pozzi, 4 Voll., Padova 1973-1979. 28. Caius Plinius Secundus, Historia naturalis, traduzione di C. Landino, Nicolas Jenson, Venezia 1476. L’elenco del Codice Trivulziano dei libri posseduti da Leonardo al suo arrivo a Milano include solo quattro titoli: Plinio, Luigi Pulci “morgante”, Donato (grammatica latina) e Abaco (matematica).
22
riferimento alla tecnica di costruzione in legno di un teatro semovente che Curio, al tempo di Giulio Cesare, aveva inventato per le onoranze funebri del padre29. Forse in questa occasione è venuto a conoscenza dello scambio di lettere tra il Barbaro e Giovanni Pico della Mirandola30, sul rapporto tra retorica e filosofia. Ma, proprio nel coinvolgimento con le attività letterarie e umanistiche, per le sue ricerche già note di architettura, delle macchine per costruzioni e progetti di canalizzazioni e fortificazioni, basate sull’opera di Vitruvio, nella ripresa che ne ha fatto l’opera di Leon Battista Alberti, Leonardo ha dovuto ricorrere sempre di più all’utilizzo di traduzioni dal latino di amici della corte sforzesca e, nel secondo periodo alla corte milanese (1507-1513), alle buone conoscenze della lingua greca dell’ultimo acquisto tra i suoi discepoli, Fabrizio Melzi. L’incontro con il Barbaro può avere fornito una forte spinta, o anche solo il pretesto, per sviluppare le proprie capacità di scrittore, perché la richiesta di chiarimento sul significato concreto di una frase, un termine tecnico latino, era la concretizzazione dell’ideale filologico professato negli scambi di lettere tra l’umanista veneziano e il Poliziano31, cioè la precisa indica29. S. Ferri (a cura di), Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche, Milano 2000, p. 325. C. Pedretti,, Leonardo. Le macchine, Firenze 1999, pp. 62-66, ha segnalato la soluzione data da Leonardo nel Codice I di Madrid (f. 110 r). 30. E. Barbaro - G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, a cura di F. Bausi, Napoli 1998; Leonardo lo cita solo una volta, negli anni dopo il 1511: “El Pico ne dié le opinioni” in merito ad un’osservazione sul “raggio della luna col simulacro del sole” (G., 20 r). Leonardo intendeva spiegare la luminosità della luna con esperimenti di prospettiva matematica, per cui il riferimento è probabilmente al primo libro delle Disputationes adversus astrologiam divinatricem, dove Pico elenca i filosofi antichi che non hanno preso sul serio l’astrologia e il suo influsso sulle vicende umane. Cfr. F. Frosini (a cura di), Leonardo e Pico. Analogie, contatti, confronti, Firenze 2005. 31. V. Branca, Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino 1983, p. 13; G. Fumagalli, Leonardo e Poliziano, in “Il Poliziano e il suo tempo”, Firenze 1957, pp. 131-160.
23
zione di concordare verba et res, pensiero e parola, senza indulgere in vuote formule retoriche, e questo era molto più facilmente raggiungibile per Leonardo con l’utilizzo della lingua materna, con il volgare. Quando lo stesso Leonardo sembra ammettere di essere “omo sanza lettere”32, possiamo pensare ad uno sfogo di frustrazione in riferimento alla sua scarsa conoscenza del latino, che studiava ancora oltre i quarant’anni, e l’ignoranza del greco, o, al contrario, leggere la sua battuta polemica verso gli umanisti, in quanto non prendevano nella dovuta considerazione chi come lui si rifaceva direttamente all’osservazione della natura, “maestra dei maestri”, come la prima rivendicazione della sua concezione filosofica. Dallo scontro tra due tendenze compresenti nelle corti signorili, l’umanesimo dotto che si rivolgeva all’antico come modello di virtù e un più concreto concetto di virtù come capacità, forza di ben operare nel presente, è nata la rivendicazione di Leonardo che pone la Natura come vera maestra e l’esperienza sensibile come criterio di verità. A testimonianza di questa polemica troviamo, tra altre riprese del tema, un elaborato aforisma: Le buone lettere so’ nate da un bono naturale; e perché si de’ più laldare la cagion che l’effetto, più lalderai un bon naturale sanza lettere, che un bon litterato sanza naturale.33
Preferire un uomo capace ma senza preparazione letteraria, non significa tuttavia che Leonardo auspicasse l’eliminazione della cultura dotta, più probabilmente la compenetrazione tra i due momenti, in collaborazione per un nuovo sapere. E se non lo proponeva apertamente, era in qualche modo la sua
32. Leonardo da Vinci, Atl. f. 327 v, ex 119 r a. Giuseppina Fumagalli aveva caratterizzato l’intera opera dell’artista come Leonardo “omo sanza lettere”, Firenze 1939, sollevando le proteste di Carlo Dionisotti. 33. Leonardo da Vinci, Atl. 207 r, ex 76 r.
24
attività a manifestarne l’esigenza. Infatti, negli stessi anni Leonardo è impegnato anche a organizzare grandi rappresentazioni per la festa che Galeazzo Sanseverino aveva organizzato per il matrimonio del Moro con Beatrice d’Este. Alla giostra interviene il cavaliere, capitano e uomo d’armi del Duca, travestito da uomo selvatico, accompagnato da una turba di soldati vestiti allo stesso modo. Leonardo, ideatore dei costumi annota: Salvatico è quel che si salva.34
Così l’abitante della selva, pronunciato e scritto toscanamente con la “a”, va a formare un gioco di parole, una falsa etimologia, con una ambivalenza semantica che vale la pena sottolineare. Anche le raccolte di vocaboli possono trovare una lettura filosofica, nel momento in cui Leonardo usa questa sentenza come un indovinello che presuppone una soluzione che rinvia alla concezione che Platone35 attribuisce alla più antica sapienza dei sacerdoti egizi: solo gli abitanti delle montagne, dei boschi e luoghi selvaggi, si salvano dai diluvi periodici che colpiscono la terra, mentre le città vengono spazzate via dall’i-
34. Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, f. 1 v; L. Pulci, Vocabulista, CCXVII: “Silvestro:salvatico”, citazione in E. Solmi, Scritti vinciani. Le Fonti dei Manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, Firenze 1976, p. 396. C. Vecce, Scritti, cit., p. 105 riporta le interpretazioni di “salvatico”, inteso come solitario, o rozzo, rustico, abitante della campagna; tutte possibili, tuttavia lontane dallo spiegare il perché e da che cosa il selvatico si salva. 35. Platone, Timeo, 22 E, a cura di G. Reale, Milano 2000, prevede, come conseguenza dei periodici diluvi in diverse zone della Terra, che “coloro che abitano sui monti, i mandriani e i pastori, si salvano, mentre coloro che stanno nelle vostre città, vengono trascinati in mare dai fiumi” (p. 65). L’immagine di superstiti che affollano la cima dei monti, insieme con vari animali durante l’inondazione, è chiaramente delineata in Windsor 12665 v. K. Clark, Leonardo da Vinci. Storia della sua evoluzione artistica, Milano 1983, p. 184, segnalava come le prime note descrittive del progetto per il quadro del Diluvio erano del 1494.
25
nondazione. Uno dei temi più sviluppati nei suoi ultimi anni con una serie di disegni considerati tra i più belli e inquietanti, quello dei Diluvi, è già presente, in riferimento ad un recupero del platonismo dell’Accademia fiorentina, ma con evidenti tentativi di sviluppo autonomo, nella forma di ricerca naturalistica dello scontro tra gli elementi, in particolare del fondamentale ruolo dell’acqua nelle dinamiche della terra. Dunque all’origine della formazione filosofica di Leonardo è la ricerca dei tempi della natura, ed è strettamente legata al tema dei diluvi che hanno trasformato la terra. Infatti uno dei suoi primi tentativi letterari, che Augusto Marinoni ha intitolato “Il mostro marino” presenta già un riferimento alle sue osservazioni giovanili, il riferimento alla vita di un pesce che il tempo ha trasformato in un fossile che giace alle falde di un monte: O tempo, consumatore delle cose in te rivolgendole dai alle tratte vite nuove e varie abitazioni.36
Un tempo ipostatizzato, reso simbolo ed emblema della distruzione di tutti gli esseri è un’immagine topica, ripresa dai “Trionfi” di Petrarca. Facile profezia che ogni cosa sia destinata alla consumazione del tempo! Ma per Leonardo la morte non annulla la vita, la trasforma in nuove condizioni, rimane sempre una traccia, e il fossile diventa uno di quei “segreti” della natura che non va ricercata nei libri ma nella natura stessa. Così l’opzione aforistica comincia a delinearsi come la trasformazione di proverbi, sentenze di autori antichi, da utilizzare nelle occasioni di incontri e dibattiti a corte, ed anche come la ripresa di opere moderne in volgare conosciute da tutti, utilizzate per le proprie invenzioni di profezie filosofiche. Nell’utilizzo di citazioni di autorevoli autori antichi per giustificare la propria opera letteraria, era stato sicuramente 36. A. Marinoni (a cura di), Leonardo da Vinci, Scritti letterari, nuova edizione accresciuta con i manoscritti di Madrid, Milano 1974, p. 186.
26
receduto da Dante Alighieri, che aveva costruito l’intero p commento alle sue poesie giovanili del “Convivio” sulla base di Aristotele, da lui riconosciuto come maestro, il Filosofo per eccellenza. Leonardo ne ha sicuramente ripreso una: Aristotile nel terzo dell’Etica: l’uomo è degno di lode e di vituperio solo in quelle cose che sono in sua potestà di fare e di non fare.37
Possiamo essere sicuri che la citazione di Leonardo non sia stata presa direttamente da Aristotele perché Dante in questo caso non cita letteralmente, la sua è piuttosto una sintesi del contenuto più vicina alla morale cristiana, probabilmente mediata dai commentatori che utilizza, come Alberto Magno o Tommaso d’Aquino. Leonardo deve confrontarsi spesso con le tesi di Aristotele e ne riprende alcuni concetti fondamentali della Fisica. Ma è da notare come, tra le numerosissime citazioni che Dante introduce nel suo testo, Leonardo ne scelga una sola, che diventa quindi un riferimento più che al filosofo antico, alle idee che ritiene valide. Così, quando cita a suo modo l’inizio famosissimo del Primo Libro della Metafisica: Naturalmente li omini boni desiderano sapere,38
non possiamo non notare la precisazione “boni”, che sottintende una categorizzazione dell’umanità in due tipi di uomini, capaci di virtù, e “tristi”, distinzione che non corrisponde al testo aristotelico. Inoltre, se leggiamo i due aforismi accostati, troviamo che ciò che gli uomini hanno in potere di fare è conoscere e, rispetto al fatto che tendano a ciò, che operino 37. Leonardo, Atl. 785b v, ex 289 v.c; Solmi (op. cit., p. 134) ha dimostrato che il testo è preso da Dante Alighieri, Convivio, Trattato terzo, IV, 6., e quindi non da Aristotele, Etica Nicomachea, III; 1-4. 38. Leonardo da Vinci, Atl. 327 v, ex 119 v.a. Aristotele, Metafisica, Libro I (A), 980 a, traduzione di A. Russo, in “Opere”, 6, Bari 1982, p. 3: “Tutti gli uomini sono protesi per natura alla conoscenza”.
27
per acquisire la virtù del sapere, possiamo classificarli capaci o incapaci, e non per quello che non è in loro potere, come nascere patrizi o plebei, legittimi o illegittimi, come nel caso personale di Leonardo, oppure essere sani di corpo o malati, forti o deboli. Una piccola aggiunta forma un’interpretazione personale. La scelta di due citazioni determina una concezione etica che pone al centro la conoscenza come virtù dell’individuo. Sempre nel Codice Trivulziano dei primi anni milanesi, troviamo un aforisma che riassume l’intera questione della elaborazione filosofica di Leonardo: L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, Così il tempo presente.39
Tra il concetto medievale di un tempo di Dio e la nuova concezione di un tempo umano, della gestione economica del buon padre di famiglia, della virtù come saggezza pratica e attività civile, si incunea la concezione naturalistica di uno scorrere del presente in una mutazione continua e perenne, costitutiva dell’esistenza umana. Il brano parte dalla citazione di Platone di Eraclito: “due volte nello stesso fiume non potresti entrare”40 che evidentemente, anche se implicitamente, 39. Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, foglio 34 verso. 40. Platone, Cratilo 402 a, trad. italiana di L. Minio-Paluello in Platone, Opere complete, 2, Bari 1984; Plutarco, De Ei apud Delphos, XVIII, che fornisce la versione del frammento n. 91, Diels-Kranz, in I presocratici. Testimonianze e frammenti, Bari 1983, Tomo I, p. 215, è stato tuttavia stampato da Aldo Manuzio solo nel 1509. Più facilmente Leonardo poteva conoscere la versione latina del Cratilo di Platone di Marsilio Ficino, magari con l’aiuto di qualche amico umanista. S. Toussaint, Leonardo filosofo dei contrari. Appunti sul “Chaos”, in “Leonardo e Pico”, cit., pp. 13-35, non trovando la citazione di Eraclito nei manuali a disposizione all’epoca, accosta il riferimento a Ovidio, Metamorfosi XV, 90. Qualche immagine che utilizza Eraclito in collegamento con il pitagorismo, si trova anche nei vv. 176-185,
28
introduce la questione di tempi diversi, passato presente e futuro, che non permettono di toccare la stessa acqua, mentre il fiume fluisce incessantemente. Leonardo rielabora il tutto nella similitudine tra lo scorrere dell’acqua e il tempo vissuto. C’è forse anche qualche suggestione tratta sempre dal Timeo di Platone, di una temporalità di ogni cosa composta, dell’intero mondo formato dal Demiurgo dall’unione delle idee con la materia informe. Di fatto quest’opera di Platone è un riferimento costante, basti pensare alle illustrazioni dei corpi regolari geometrici che accompagnano l’opera dell’amico Luca Pacioli (1445- 1514)41. E non è sempre da ciò che era scritto all’ingresso dell’Accademia platonica che viene formulato l’imperativo che Leonardo pone a monito dei suoi lettori? “Non mi legga chi non è matematico nelli mia principi”42. Un esempio notevole di riferimento ai postulati matematici, si trova nel Codice Arundel dove un’intero foglio è diviso in due parti, la parte superiore ripete in continuazione come il punto, che non occupa spazio, sia termine della linea che delimita le figure che sono nello spazio; nella seconda metà si riprende esattamente ciò che sta nella prima riformulandolo fino ad arrivare alla formula più breve: “Ciò che non ha termine non ha figura alcuna”43. La massima non sembra avere molto senso
in particolare: “Tutto scorre ed ogni fenomeno ha forme errabonde. Anche il tempo fila via in forma incessante, non diversamente dal fiume”. Ma è inserito nel contesto della teoria della reincarnazione dell’anima, unica sostanza stabile nella continua metamorfosi. 41. L. Pacioli, De divina proportione,(1498), riprod. anastatica dell’edizione a stampa Venezia 1509, Milano 1956. 42. Leonardo da Vinci, Windsor 19188 r. 43. Leonardo da Vinci, Codice Arundel, foglio 132 retto. Si veda anche R. Nanni, La natura tra retorica e scienza: un sondaggio nel Codice Arundel, in “Leonardo da Vinci, l’uomo universale”, Catalogo della Mostra di Venezia 1 settembre-1 dicembre 2013, pp. 64-69.
29
come prescrizione pratica per il pittore, ma ne ha molta per il filosofo: l’infinità spaziale non ha nessuna figura e quindi è inconoscibile. Il fatto che Leonardo tenti ripetutamente di trovare la formula più breve delle sue conclusioni lo porta inevitabilmente a riscrivere lo stesso concetto più e più volte in forme diverse, cosa che ha messo spesso fuori strada i critici, pronti a considerarla un’incapacità di utilizzare correttamente concetti filosofici. Ma non è che l’utilizzo corretto dello stile aforistico! Solo che noi abbiamo solo la “brutta copia” del componimento e dobbiamo scegliere la versione della frase sulla base del contenuto espresso in una formulazione compiuta, in “bella copia”. Infatti troviamo anche delle fissazioni chiarificatrici del paradosso che Leonardo vuole risolvere: Qual è quella cosa che non si dà, e s’ella si dessi non sarebbe: egli è lo infinito, il quale se si potessi dare, e’ sarebbe terminato e finito, perché ciò che si può dare ha termine colla cosa che lo circuisce ne’ sua stremi, e ciò che non si pò dare è quella cosa che non ha termini.44
Quasi un indovinello, che affronta però il tema più arduo per l’artista che vuole rappresentare la forma nella sua inquadratura prospettica, l’impossibilità di adattare il pensiero matematico, il “nulla” del punto geometrico, non solo al singolo corpo ma anche all’universale naturale, sempre finito, qualitativo.
2. Riferimenti alla tradizione aforistica. Se con la nostra ricostruzione della prima attività di scrittore abbiamo risposto alla domanda sul come arrivi a formulare lo stile di scrittura utilizzato, l’aforisma, rimane la questione 44. Leonardo da Vinci, Atl. 362 r, ex 131 r.b. Per Aristotele, Fisica, III, 6-7, l’infinito matematico può esistere in potenza ma non in atto.
30
se esista una filosofia, una scuola antica che con la sua autorità permetta a Leonardo di considerare questo modello, così congeniale per un amante della formulazione mordace e conclusiva, come capace di esprimere una intera concezione del mondo, un atteggiamento filosofico esistenziale. La tradizione di scuola che nel mondo antico ha privilegiato la massima, la locuzione sentenziosa, la chiusura epigrammatica del discorso, è stata la filosofia Stoica45, in particolare Epitteto, Seneca e Marco Aurelio. Se i “Pensieri” di quest’ultimo sono stati tradotti dal greco solo nel 155946, il “Manuale” di Epitteto, composto da 68 sentenze, era già tradotto in latino nel 1479 da Poliziano a Firenze. La brevità di ogni capitolo permette di estrarne singole frasi, perle preziose di una sapienza che ha la caratteristica della fermezza, della lucidità razionale. Il suo inizio è lapidario: “Eorum quae sunt, partim in nobis est, partim non est”47. Tutte le cose si dividono in ciò che è in nostro potere e ciò che non lo è. Se Leonardo avesse conosciuto questo testo prima di trasferirsi a Milano, risulterebbe il punto di partenza della sua scelta nelle citazioni aristoteliche del Convivio di Dante. Seneca era utilizzato ampiamente nel Medioevo, proprio perché l’intera sua opera si presenta con frasi brevi e chiusure dei discorsi che si prestano facilmente ad essere trasformati in massime morali: “la vita bene spesa lunga è”, aforisma di
45. R. Tosi, I Greci: gnomoi, paroimiai, apophthegmata, in G. Ruozzi (a cura di), “Teoria e storia dell’aforisma”, Milano 2004, p. 11. 46. Marco Aurelio, Pensieri, a cura di C. Cassanmagnago, Milano 2008, p. 115. Il primo titolo era “A se stesso” ed è da notare che anche i “Ricordi” di Francesco Guicciardini, considerati il modello di tutta l’aforistica europea successiva, sono stati scritti prima di questa edizione di Marco Aurelio. 47. Epitteto, Manuale, traduzione italiana di G. Leopardi e latina di A. Poliziano, a cura di G. De Ruggero, Milano 1971, p. 69.
31
Leonardo, risulta una quasi traduzione di Seneca, “vita, si uti scias, longa est”(De brevitate vitae, II)48. Lo stoicismo prevedeva che il comportamento etico dell’uomo si collegasse strettamente alla natura, il cui studio era perciò obbligatorio. Il riferimento alla natura è il fondamento stesso della filosofia di Leonardo, e troviamo numerosissimi aforismi al proposito: La sperienzia, interprete in fra l’artifiziosa natura e la umana spezie, ne ‘nsegna ciò che essa natura in fra’ mortali adopra di necessità costretta, non altrimenti oprar si possa che la ragione, suo timone, oprare le ‘nsegni.49
Questo brano è un rapido riassunto del suo pensiero, già indicativo di una concezione che Leonardo ha maturato, della possibilità di rendere intelligibile la realtà attraverso la forma aforistica, convinto che la ragione possa grazie all’esperienza comprendere la necessità naturale e porsi come guida delle opere umane. Infatti alla base delle sue ricerche vi è il riferimento ad una natura capace di produrre effetti, “artifici”, molto più vari e grandiosi di quelli umani, di determinare il destino di ogni vivente e di trasformare ogni cosa in un moto incessante. L’attività umanistica che ha tuttavia aperto l’orizzonte della filosofia scolastica, stimolando l’approccio pluralistico e lo sviluppo individuale delle prospettive su tutti i temi filosofici, è stata la prima traduzione dal greco del 1433 di Ambrogio Traversari50 delle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio, 48. Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, foglio 34 verso. Marani-Piazza (a cura di), Il Codice di Leonardo da Vinci del Castello Sforzesco, cit., p. 143. 49. Leonardo da Vinci, Atl. 86 r a. 50. S. Gentile, Il ritorno delle culture classiche, in C. Vasoli (a cura di), “Le filosofie del Rinascimento”, Milano 2002, pp. 78-80. Più in generale, P.O. Kristeller, La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento, Firenze
32
che ha visto compendi, riprese ed edizioni a stampa anche in volgare, che Leonardo si procura, come risulta dal secondo elenco di libri posseduti intorno al 149551. Fin dall’inizio e per tutti gli autori trattati, oltre alla raccolta di dati biografici, testimonianze e racconti spesso dubbi o lontani dal tempo in cui sono effettivamente vissuti, Diogene Laerzio espone le sentenze (apophthegmata), i detti tramandati con cui si può compendiare la loro posizione sui vari argomenti, gli aforismi che caratterizzano il pensiero di ogni singolo filosofo. Nel caso di Epicuro raccoglie come sintesi delle sue concezioni due lettere, risultando così la principale fonte, con il poema di Lucrezio, della filosofia epicurea e dell’atomismo. Tuttavia Leonardo è molto più interessato alla prima parte dell’opera, che ha determinato la stessa concezione sincretistica del neoplatonismo fiorentino, in quanto parla della nascita della filosofia in Oriente, in stretto collegamento con i sacerdoti delle varie religioni, di Orfeo, dei Magi, a cui Firenze aveva innalzato grandi omaggi pittorici, e degli Egizi. Ma è soprattutto là dove vengono esposte le concezioni dei primi fisiologi, indagatori della natura, che Leonardo viene attirato: Di Talete si tramandano anche queste sentenze: – Il più antico degli esseri è Dio, perché è ingenerato. – Il più bello è il mondo, perché è opera di Dio.– Il più grande è lo spazio perché comprende tutte quante le cose. – il più veloce è l’intelletto, perché passa attraverso ogni cosa. – Il più forte è la necessità,
1987; anche A. Marinoni, La biblioteca di Leonardo, in “Raccolta vinciana”, XXII, Milano 1987, pp. 291-342. 51. Leonardo da Vinci, Atl. 559 r, ex 210 r a. E. Villata (a cura di), La biblioteca, il tempo e gli amici di Leonardo. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, Novara 2009, p. 80. Per un’analisi e confronto con l’elenco di Madrid II, 2v-3r, si veda A. Marinoni, Leonardo da Vinci. Scritti letterari, cit., pp. 239-257.
33 perché domina su tutte le cose. – Il più sapiente è il tempo, perché rivela tutto.52
Un classico esempio di come in poche parole l’aforisma possa esprimere contenuti universali che rimangono impressi nella memoria del lettore, perché la concisione e brevità si accompagna all’incisività dell’espressione, alla profondità del significato. Leonardo deve aver meditato a lungo su questi argomenti, tanto da riproporne l’ultima sentenza, riscritta secondo una tradizione proverbiale consolidata: La verità sola fu figliola del tempo.53
Leonardo non si interessa, come la filologia umanistica, della originalità delle sentenze, se sono attribuibili davvero a Talete, oppure risentano di interpretazioni successive, perché sembrano già stoiche sia l’immagine del Dio Intelletto che della necessità che domina ogni fenomeno. Per lui, che aspira a proporre la sua filosofia, diventano un vero modello di sintesi, che utilizza come sfondo in cui si inseriscono le sue ricerche sull’occhio e la vista, le sue considerazioni sulle bellezze naturali: Come l’occhio e il razzo del sole e la mente sono i più veloce moti che sieno- Il sole, immediate che li appare nell’oriente, subito, discorre co’ li sua radi a l’occidente, i quali sono composti di tre potenzie spirituali: splendore, calore, e la spezie della forma della loro cagione. L’occhio, subito ch’è aperto, vede tutte le stelle del nostro emisperio. La mente salta ‘n uno attimo dall’oriente all’occidente, e tutte l’altre cose spirituali
52. Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di G. Reale, Milano 2005, p. 99. 53. Leonardo da Vinci, M 58 v., Manoscritti della Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Aulio Gellio, Notti Attiche, L.XII, 11,7, indica in un poeta antico, di cui dichiara di non sapere il nome, l’autore della sentenza “veritatem temporis filiam esse”.
34 sono di gran lunga dissimile per velocità a queste. L’occhio riserva in sé le immagine delle cose luminose che se li rappresentano.54
La capacità della visione dell’occhio di cogliere la totalità delle cose, congiunto con la velocità della mente, come nelle sentenze riportate da Diogene Laerzio, rende rappresentabile tutto ciò che cade sotto le potenze spirituali. Leonardo sviluppa una teoria della conoscenza che punta alle forme qualitative di ciò che è oggettivabile, dove vengono utilizzati principi filosofici per affermare la bellezza dei moti naturali, alla ricerca di determinare la causa di ogni vita nel calore del sole. Come ha sottolineato Karl Jaspers, pur nel richiamo continuo all’esperienza Leonardo si appella a principi universali, e quindi la sua filosofia non può essere paragonata all’empirismo dei secoli successivi55 e, aggiungiamo noi, nemmeno all’occamismo medievale, proprio per questo richiamo dei più antichi filosofi. La lettura delle “Vite” dei filosofi deve aver impegnato Leonardo fino alla tarda età e ha lasciato un ricordo duraturo, se il monito per se stesso: non si debbe desiderare lo impossibile56
del tardo Codice E(31 v), sembra ripreso da un detto di Chilone, uno dei Sette sapienti. L’altra fondamentale tradizione che ha spesso adottato la forma aforistica è stata quella medica, a partire dai conosciutissimi “Aforismi” di Ippocrate57 disponibili in varie traduzioni 54. Leonardo da Vinci, Atl. 545 v, ex 204 v.a. 55. K. Jaspers, Leonardo filosofo, cit., pp. 33-36. 56. Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, cit., p. 73: “Non desiderare cose impossibili”. 57. Dante Alighieri, Convivio, Trattato primo, VIII, 5: “quando un medico donasse a uno cavaliere scritti li Aphorismi d’Ippocràs…”. S. Gentile, Pico filologo, in “Giovanni Pico della Mirandola”, a cura di G.C. Garfagnini,
35
manoscritte fin dai tempi più antichi. Si tratta di un testo che tratta questioni specifiche, legate alla professione medica, ed è un esempio molto ripreso di fissazione del sapere sulla base dell’esperienza accumulata in una vita di lavoro. L’influsso sul trattato sulla pittura che Leonardo progetta, nonostante la diversità degli approcci e degli strumenti, è sicuramente documentabile là dove si tratta di fissare tecniche compositive e consigli pratici. Di fatto è l’unico esempio di trattazione sistematica attraverso la formulazione di ricette, di formule prescrittive che, nella loro penetrante brevità, posso essere facilmente apprese e applicate ai casi particolari. Ma Leonardo ha un interesse speciale per il sapere medico, perché gli fornisce gli strumenti per le sue ricerche anatomiche e la fisiologia dell’occhio, che negli ultimi anni estende all’embriologia e alla fonazione. Fin dalle sue prime raccolte di aforismi troviamo il riferimento a Cornelio Celso, enciclopedista romano come Plinio, i cui libri sulla medicina attestano lo stretto legame che si riteneva indispensabile con la filosofia: Il sommo bene è la sapienza, il sommo male è il dolore del corpo. (…) Adunque siccome il sommo male è ’l corporal dolore, così la sapienza è dell’animo il sommo bene, cioè de l’om saggio, e niuna altra cosa è da a questa comparare.58
L’uomo saggio riconosce nella sapienza ciò che, sola, secondo l’eudemonismo antico porta alla felicità dell’animo, al sommo bene. La medicina è per Leonardo un insegnamento filosofico, da cui assume fin dai primi scritti quello che troviamo in tutta la sua concezione, cioè la dottrina dei quattro elementi di Firenze 1997, Vol. 2, p. 475: “tra il 1488 e il ’90 Poliziano colleziona codici del De compositione medicamentorum di Galeno e traduce gli Aforismi di Ippocrate col commento dello stesso Galeno”. Tra le tante edizioni moderne, si veda Ippocrate, Aforismi e giuramento, Introduzione di M. Baldini, trad. italiana di M.T. Malato, Roma 1994. 58. Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, foglio 2 v.
36
Empedocle, travasati e utilizzati come indiscusso fondamento dalla medicina non solo antica ma anche araba ed ebraica, prima di essere insegnata nelle Università europee. In ogni malattia bisogna trovare le cause e procedere ad una terapia che ristabilisca la giusta proporzione che determina la particolare complessione del corpo, così come il carattere dell’animo. Medicina è ripareggiamento de’ disequalati elementi; malattia è discordanza d’elementi infusi nel vitale corpo.59
La definizione stessa di malattia, come squilibrio tra i quattro elementi che compongono il corpo, determina l’intero sapere della medicina, che è appunto l’arte capace della restaurazione dell’armonia, secondo ciò che viene riferito alla medicina più antica fino a Galeno. L’intero approccio dei disegni anatomici di Leonardo parte dalla prospettiva pittorica che ha come presupposto la proporzione delle parti, vuole mettere in evidenza non solo la dissezione e analisi autoptica, ma ricerca la ricostruzione dell’insieme degli organi in una totalità corporea, in un’“Armonia”60 che ne costituisce la bellezza, prima che la funzionalità. Il disegno era per Leonardo il modo più immediato per fissare la realtà delle cose, per apprendere con certezza ciò che gli antichi avevano conosciuto e fissato con le parole nei testi. E non è affatto estraneo alla cultura dell’epoca il passaggio da un sapere all’altro, la possibilità di considerare la pittura in parallelo ad una scienza come la medicina, e la proporzione prospettica come l’equilibrio degli elementi in un corpo sano. Così come era considerata scontata in medicina la similitudine tra l’uomo e l’universo:
59. Leonardo da Vinci, Ibidem, foglio 4 r. 60. D. Laurenza, La ricerca dell’armonia. Rappresentazioni anatomiche nel Rinascimento, Firenze 2003, pp. 31 sgg.
37 L’uomo è detto da li antichi mondo minore, e certo la dizione d’esso nome è bene collocata, impero ché, siccome l’omo è composto di terra, acqua, aria e foco, questo corpo della terra è il simigliante.61
L’analisi anatomica diventa uno studio scientifico del corpo della terra, non solo nelle sue forme che sembrano più evidenti, come la circolazione sanguigna e il ciclo dell’acqua, della struttura ossea e la composizione delle rocce, tra forma dell’articolazione dei movimenti e la meccanica di ogni trasformazione fisica, ma anche instaurando un’analogia tra attività biologiche della terra e la vita cosmica. L’uomo è il Microcosmo che ha in sé, in una misura accertabile, l’intero Macrocosmo, e questo rapporto analogico tiene insieme le leggi inesorabili poste all’interno della natura stessa, il continuo scomporsi e ricomporsi dei quattro elementi tra loro, con le giuste misure che vanno a formare tutte le cose. La proporzione non solamente nelli numeri e misure fia ritrovata, ma etiam nelli suoni, pesi, tempi e siti, e qualunque potenzia si sia.62
Il mondo medievale aveva seguito le indicazioni di Alano di Lilla per cui ogni creatura del mondo funge per l’uomo da specchio delle nostra condizione terrena, simbolo, “signatura”, del destino comune: “omnis mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum”63; la natura è come un libro 61. Leonardo da Vinci, Manoscritto A. 55 v., Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. 62. Leonardo da Vinci, Manoscritto K. 1, 49 r., Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Cfr. per l’importanza delle tecniche Paolo Galluzzi, Gli ingegneri del Rinascimento da Brunelleschi a Leonardo da Vinci, Firenze 1996. 63. Alanus de Insulis, Rhytmus alter quo graphice natura hominis fluxa et caduca depingitur, in Patrologiiae cursus completus. Serie latina, PL. 210, col 579. Sull’argomento cfr. Andrea Tagliapietra, La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Torino 2008, pp. 265-276.
38
o un’immagine dipinta da Dio che l’uomo può solo imitare. Ma Leonardo ha appreso anche la lezione ermetica diffusa da Marsilio Ficino, l’immagine di una sapienza originaria rivelata da Dio nelle sue opere. La creatività dell’artista imita quella divina, come scriveva già Leon Battista Alberti nel De pictura, (1435), riproposto da lui stesso in volgare, di cui un manoscritto64 è utilizzato da Leonardo nel suo primo periodo milanese. L’artista si fa simile a Dio, “per arte possiamo esser detti nipoti a Dio” scrive Leonardo, in quanto conosce la realtà così a fondo per poterla riproporre con l’intensità del particolare e l’universalità di una scienza. Esempio di tale nuova collocazione della prospettiva matematica era stata affermata nella prefazione dell’opera di ottica di John Peckham (1225-1292), la cui traduzione Leonardo copia per sé: La prospettiva dunque è da essere preposta a tutte le traduzioni e discipline umane, nel campo della quale la linia radiosa complicata dà e modi delle dimostrazioni, innella quale si truova la groria non tanto de la matematica quanto della fisica, ornata co’ fiori dell’una e dell’altra, le sententie della quale, distese con gran circuizioni, io le ristringerò in conclusiva brevità, intessendo, secondo il modo della materia, naturale e matematiche dimostrazioni, alcuna volta conchiudendo li effetti per le cagioni, e alcuna volta le cagioni per li effetti.65
64. Leonardo da Vinci, Codice Ashburnham II, 17 v- 24 v. L.B. Alberti, Della pittura, ed. critica a cura di L. Mallè, Firenze 1950; V.P. Zubov, Léon Battista Alberti et Leonard de Vinci, in “Raccolta vinciana”, XVII, 1960, pp. 11-14; P.C. Marani, Leonardo e Leon Battista Alberti, in Id., “Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da Vinci”, Milano 2010, pp. 313-323. 65. Leonardo da Vinci, Atl. 543, ex 207 r.; J. Peckham, Perspectiva communis, f.a. 2: l’edizione era stata curata da Fazio Cardano, matematico milanese, padre del più famoso Girolamo Cardano, intorno al 1482-3. Cfr. Solmi (1976), pp. 226-227.
39
Lo studioso medievale considerava i fenomeni della luce come manifestazione spirituale, come un’emanazione divina di cui il sole era lo strumento per infondere la vita nell’universo. L’ottica era dunque una via scientifica d’accesso al mondo metafisico, che seguiva il metodo scolastico sia induttivo che deduttivo, di cui la prospettiva era l’applicazione concreta nel campo artistico. Leonardo lascia nelle sue carte innumerevoli appunti sull’indagine dei fenomeni ottici, del rapporto luce ed ombra, della fisiologia dell’occhio e cerca anche di porre a fondamento dei suoi risultati dimostrazioni matematiche, e infine fa risaltare le conquiste ottenute con brevi e conclusive sentenze: L’aria, subito che s’allumina, s’empie d’infinite spezie, delle quali l’occhio si fa calamita.66
Va sottolineato il fatto che per Leonardo la pittura “prospettica” deve essere considerata parte della filosofia, come veniva proposto dagli studiosi europei più importanti nel campo dell’ottica. Ma soprattutto bisogna ribadire che Leonardo generalizza questa importanza, al punto da farne la premessa dell’intera sua posizione filosofica. Se tu sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: mare, siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte di ombra e di luci. E veramente questa è scienza e legittima figlia di natura, perché la pittura è partorita da essa natura; ma per dir più corretto, diremo nipote di natura, perché tutte le cose evidenti sono state partorite dalla natura, dalle quali cose è nata la pittura.
66. Leonardo da Vinci, Atl. 303 v, ex 109 v.a.
40 dunque rettamente la chiameremo nipote di essa natura e A parente d’Iddio.67
Così nelle note polemiche che va componendo per il suo Libro di Pittura, la considera persino più importante della poesia, perché si interessa dei moti naturali, dell’anatomia di uomini e animali, della geologia, del vento e delle acque, Ogni ramo del sapere concorre ad una visione generale della natura, ma la pittura, in quanto scienza matematica, ha un primato rispetto alla poesia perché può andare a coglierne proporzioni, misure e forme armoniche, in competizione anche con la Musica. Quest’ultima era considerata fin dall’antichità parte del Quadrivio insieme a Geometria, Aritmetica e Astronomia, ma incapace per Leonardo di fissare la sua arte in forma stabile, al contrario della pittura. Considerazione quest’ultima che ha provocato forti discussioni, probabilmente già all’epoca o nei decenni immediatamente successivi alla sua morte, perché il testo di Leonardo circolava manoscritto presso molti artisti, tra cui Benvenuto Cellini e Annibale Carracci68. Arrivato alla modernità ha avuto l’apprezzamento di Goethe, ma anche la stroncatura di Croce, che faceva rilevare come l’estetica non ha mai scalzato il primato della poesia, della tragedia, e in epoca romantica tutt’al più si era alternata al primo posto la musica. Solo con Jaspers69 è stata riproposta la centralità della matematica e della filosofia naturale in riferimento a questa discussione sul primato della pittura. Il filosofo tedesco si è infatti chiesto quale sia la matematica a cui Leonardo faceva riferimento, perché è sicuramente distante sia dall’utilizzo
67. Leonardo da Vinci, Libro di pittura, I, par. 12. 68. K. Clark, Leonardo da Vinci. Storia della sua evoluzione artistica, Milano 1983, p. 88. 69. K. Jaspers, Leonardo filosofo, cit., p. 50.
41
teologico-metafisico di un Niccolò Cusano, sia dalla sua applicazione alla fisica secondo il metodo galileiano e della rivoluzione scientifica. Le scienze matematiche son dette quelle che mediante i sensi sono in primo grado di certezza.70
L’affermazione di questa sentenza dimostra che la matematica di Leonardo risultava, prima dell’arrivo a Milano di Luca Pacioli, al livello della scuola dell’abbaco delle botteghe fiorentine, del tutto legata all’evidenza sensibile e alla trattazione di questioni tecniche e meccaniche. Se pensiamo che la rivoluzione scientifica è stata una rimessa in discussione della testimonianza dei sensi e che la matematica ha raggiunto un’astrazione via via più accentuata dall’uso pratico, possiamo misurare tutta la distanza che Leonardo avrebbe dovuto superare, non solo senza gli strumenti adeguati, ma anche contro gli stessi presupposti della sua formazione. Per quanto da allora abbia approfondito Euclide e Archimede, non ha potuto che appropriarsi di un sapere teorico già raggiunto dai pensatori greci. Infatti il suo tentativo di quadratura del cerchio, problema teorico estremamente complesso che rinvia al problema dei numeri irrazionali ed alla incommensurabilità di determinate figure, viene risolto da Leonardo in forma intuitiva e approssimata, secondo regole pratiche di composizione delle “lunule”71. Ed è ancora il non risolvibile paradosso della divisibilità infinita della quantità, di contro alla finitezza della forma, della qualità, rivendicata da Leonardo, che lo separa sia dalla mistica neoplatonica che arriva fino alla visione cosmica 70. Leonardo da Vinci, Madrid II 67 r. 71. G.T. Bagni - B. D’Amore, La matematica di Leonardo, Firenze 2006, p. 70; cfr R. Marcolongo, Leonardo da Vinci artista-scienziato, Milano 1939, p. 161, cita come fonte Giorgio Valla, De expetendis et fugiendis rebus, IV, I, Aldo Manuzio editore, Venezia 1501, enciclopedia posseduta da Leonardo che riporta le formule di Ippocrate di Chio.
42
di Giordano Bruno, sia dalla nuova “Mathesis Universalis” di Cartesio. Il concetto teorico sempre ripreso da Leonardo risulta la geometria applicata all’architettura e alla pittura, il modello dell’uomo vitruviano, misura di ogni proporzionalità. L’affermazione che il “frutto matematico” si raccolga in particolare nel “paradiso” della meccanica significa porre lo strumento come riferito non solo ai suoi scopi pratici ma anche alla conoscenza dei meccanismi che Leonardo ritrova analogicamente nel corpo umano e nei fenomeni naturali. Se infatti scrive nei fogli di anatomia: O studianti, studiate le matematiche, e non edificate sanza fondamenti.72
vuole significare che il sistema scheletrico, con i collegamenti dei nervi e dei muscoli, è paragonato ad una macchina, che può essere studiata attraverso leve e meccanismi. La pittura è un’arte meccanica che, tuttavia, “s’estende alla filosofia naturale”73, per cui indaga la statica e la dinamica dei corpi, e in generale ne ricerca le cause. Leonardo ha cercato di riappropriarsi della sapienza dei greci e dei romani a partire dalle sue esperienze nel campo della pittura prospettica, cioè dell’applicazione della geometria all’arte, e infine della meccanica all’anatomia e alla fisica. Ed è sulla base delle sue intuizioni in questi campi che rivaluta l’animazione universale, riconducibile al pensiero naturalistico dei presocratici, al logos nella materia degli Stoici. Alla fine della nostra analisi delle tradizioni filosofiche si può constatare che, vanno tenute in debito conto per le possibili influenze sul pensiero di Leonardo, il recupero dell’Accade72. Leonardo da Vinci, Windsor 19066. 73. Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, I, 16.
43
mia fiorentina dell’Ermetismo e di Platone ma anche gli studi naturalistici di Aristotele; inoltre è partecipe di un recupero umanistico delle sentenze e massime di tutte le scuole filosofiche, comprese le teorie della medicina ellenistica strettamente legate alle Università. Quale ha concorso di più? Alla domanda, per valutare la sua filosofia, Jaspers ha risposto indicando un utilizzo strumentale da parte di Leonardo di tutte le scuole filosofiche ma senza arrivare ad una sintesi. Per il filosofo tedesco la frammentarietà sembra dominare la sua stessa personalità, e ritiene che. la sua opera rimanga sul piano dell’inquietudine della continua osservazione dei fenomeni, tra incanto artistico e ricerca religiosa cosmica74. Ma non è proprio così, e l’immagine di un artista sempre insoddisfatto, che non porta mai a termine le sue opere, viene direttamente dal Vasari, condizionando almeno in parte il mito romantico della continua aspirazione alla perfezione, all’infinita ricerca dell’opera d’arte, quando si potrebbe intendere come un progressivo accantonamento della pratica pittorica in favore della ricerca filosofica e della sperimentazione naturalistica. Se bisogna ammettere in Leonardo un certo eclettismo nell’utilizzo delle fonti filosofiche, abbiamo visto come la scrittura aforistica poteva essere utilizzata all’interno di una visione cosmologica, sulla base del modello dei filosofi presocratici che trovava in Diogene Laerzio. Inoltre non mancano i tentativi di Leonardo di organizzare i suoi scritti in forma si-
74. K. Jaspers, Leonardo filosofo, cit., p. 97. G. Gentile (op. cit., p. 265) aveva già cercato di recuperare come “atteggiamento veramente religioso” la ricerca artistica di Leonardo e lo inseriva nella storia della filosofia come il precursore della concezione immanentistica dell’infinito nella natura di Giordano Bruno. Ciò era in contraddizione sia alla sua adesione alla tesi di Croce, che gli negava la qualifica di filosofo, sia ai testi stessi di Leonardo. In questo errore è stato seguito anche da G. Saitta, Il pensiero italiano nell’Umanesimo e nel Rinascimento, Firenze 1961, p. 18.
44
stematica, raccogliendo i vari frammenti che ha elaborato sulla base di analisi specifiche sui temi che più gli premevano75. Molto significativo, per la continua ripresa di motivi filosofici riproposti in una chiave unitaria, è un piccolo dialogo, che pone al centro la Natura: Contra76: perché la natura non ordinò che l’uno animale non vivessi della morte dell’altro? Pro. La natura essendo vaga e pigliando piacere del creare e fare continue vite e forme, perché cognosce che sono accrescimento della sua terrestre materia, è volonterosa e più presta col suo creare che ‘l tempo col suo consumare, e però ha ordinato che molti animali sieno cibo l’uno dell’altro, e non sodisfacendo a questo simile desidero, ispesso manda fuora certi avvelenati e pestilenti vapori e continua peste sopra le gran moltiplicazioni e congregazioni d’animali, e massime sopra gli uomini che fanno grande accrescimento, perché altri animali non si cibano di loro, e tolte le cagioni mancheranno gli effetti. Contra. Adunque questa terra cerca di mancare di sua vita, desiderando la continua moltiplicazione, per la tua assegnata e mostra ragione. Spesso gli effetti somigliano le loro ragioni. Gli animali sono esemplo de la vita mondiale. Pro. Or vedi, la speranza e ‘l desidero del rimpatriarsi e ritornare nel primo caos77 fa a similitudine della farfalla al lume, dell’uomo, che con continui desideri sem-
75. C. Scarpati, Leonardo scrittore, cit., p. 130: “Il carattere frammentario degli scritti leonardeschi ha lungamente distratto gli interpreti dalla considerazione della coerenza interna dei frammenti. Se la parte non è giunta a comporsi in una totalità, non significa che la porzione non sia in sé organica”. 76. A. Marinoni (op. cit., p. 169) ritiene lo stile adottato quello della “questione disputata” usata nelle Università ed ha premesso il titolo Disputa “Pro” e “Contra” la legge di natura. Ma il senso sembra piuttosto quello di una recita tra due attori che si scambiano le battute, nella forma tipica del dialogo platonico. 77. Al primo caos faceva riferimento Esiodo e Anassimandro, alla materia prima informe il Timeo di Platone e la tradizione neoplatonica fino a Marsilio Ficino e Pico della Mirandola.
45 pre con festa aspetta la nuova primavera, sempre la nuova state, sempre e nuovi mesi e nuovi anni, parendogli che le desiderate cose, venendo, sieno troppo tarde, e non s’avvede che desidera la sua disfazione. Ma questo desidero ène in quella quintessenza spirito degli elementi, che trovandosi rinchiusa per anima dello umano corpo, desidera sempre ritornare al suo mandatario. E vo’ che sappi che questo desiderio è ‘n quella quinta essenza compagna della natura, e l’uomo è modello dello mondo.78
Il dialogo mette in rilievo i contrastanti fenomeni fisici, la variabilità, il processo organico di un universo in cui gli opposti si compenetrano e si compongono in complessi “artificiosi”. La natura si muove in un ciclo continuo di vita e morte, in cui l’uomo è preso e quasi obbligato dal suo stesso desiderio a passare dall’una all’altra. Il tempo trascorso a rincorrere passioni e desideri è tragicamente un avvicinare il momento della propria fine. Ma è la stessa essenza della natura, l’anima infusa in tutte le cose, che tende a ritornare al principio, al caos originario. La condizione animale è l’esempio massimo della ciclicità della natura: l’alimentazione mantiene in vita a spese dell’altrui morte e la stessa generazione di nuova vita è produttrice della necessità di nuova morte. Se questa visione cosmologica richiama il modello della fisica greca, in Leonardo assume maggior significato l’immagine di una natura creatrice di sempre nuove forme, in un eccesso di produzione che deve essere compensato da epidemie, diluvi, distruzioni periodiche. Lo stile del dialogo, la discussione, la ricerca di argomenti che provano o confutano le proposte teoriche, è un metodo filosofico che imita inevitabilmente Platone, modello unico e indiscusso. Ma è una visione complessiva, un condensato teorico, diversamente da una semplice elencazione di tesi contrapposte da risolvere dogmaticamente, come 78. Leonardo da Vinci, Codice Arundel f. 156 v.
46
avveniva nel mondo delle Università medioevali. La preferenza per Platone, il filosofo che l’Accademia fiorentina aveva rimesso al centro delle sue speculazioni, sembra indirizzarsi sempre di più in Leonardo, come si evince dal brano citato, nell’essere fonte di concezioni più antiche; infatti Leonardo intende questo sapere degli “altori”, dei primi autori e maestri, come il più vicino alla verità della Natura, testo originario da cui ricavare ogni insegnamento, e riferimento costante della sua concezione filosofica.
3. I Diluvi e il tempo. Fin dai primi scritti, il tema dell’acqua domina l’interesse di Leonardo, descrizioni dei suoi effetti si ritrovano in moltissime note dei suoi studi sulla grande forza vitale e plasmatrice del mondo di questo elemento. L’acqua è proprio quella che per vitale omore di questa arida terra è dedicata.79
Ancora negli ultimi anni della sua vita, ai visitatori illustri che andavano nel suo studio in Francia, oltre ai quadri, mostrava i suoi studi di anatomia, di macchine, le innumerevoli pagine del sapere acquisito attraverso formule sintetiche, di scritti in volgare, “e ha composto Della natura dell’acqua”80. Esiste dunque un argomento che Leonardo voleva indicare come
79. Leonardo da Vinci, Codice Arundel f. 236 v. Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2004, Vol. 2, Libro XIV, p. 165: “Propriamente la terra è detta arida… Proprietà naturale della terra è, infatti, la secchezza: solo la vicinanza di acqua le conferisce umidità”. 80. K. Clark, Leonardo da Vinci, cit., p. 194. La testimonianza è di Antonio De Beatis, segretario del Cardinale Luigi d’Aragona, che registra l’incontro avvenuto il 10 Ottobre 1517.
47
proprio, in cui possiamo rintracciare almeno l’abbozzo del suo sistema cosmologico, lasciato al Melzi, e mai pubblicato anche se, come vedremo, già conosciuto almeno nelle sue linee essenziali. Per Leonardo l’acqua è l’elemento di maggiore importanza per la vita. La stessa affermazione dell’uomo microcosmo in corrispondenza con il macrocosmo era stata posta come premessa di uno studio sull’acqua. Infatti l’analogia tra circolazione sanguigna del corpo umano e il ciclo delle acque che percorre la terra, con i fiumi a comporre le vene superficiali e il mare come luogo centrale dell’elemento acqua, il suo cuore, viene allargata fino a comporre l’immagine dell’acqua che scende e sale per la terra, in un movimento continuo che la modella e cambia, determinandone le variazioni di forma e di superficie, la vita e la morte degli esseri che l’abitano. Il corpo della terra, a similitudine de’ corpi de li animali, è tessuto di ramificazioni di vene, le quali son tutte insieme congiunte, e son costituite a nutrimento e vivificazione d’essa terra e de’ sua creati, e si partono dalle profondità del mare, e a quelle, dopo molta revoluzione, hanno a tornare per li fiumi creati dalle alte rotture d’esse vene.81
Il ciclo delle acque viene inteso sul modello tramandato dal Fedone di Platone e da Seneca. Mentre l’opera di Platone era stata ripetutamente tradotta e pubblicata, le Naturales quaestiones di Seneca ebbero la loro prima edizione, in latino, a Venezia nel 1490, testo in cui si propone la teoria che l’acqua dei fiumi derivi da grotte sotterranee in collegamento col mare, quasi un circuito venoso che percorre il mondo82.
81. Leonardo da Vinci, Codice Leicester f. 33 v. 82. Lucio Anneo Seneca, Naturales questiones, III, 14-15, a cura di D. Vottero, Torino 1989; la prima edizione a stampa risultava molto scorretta e Leonardo forse ne aveva appreso il contenuto da Alberto Magno, M eteororum
48
La concezione teorica di un ciclo delle acque che prevede un passaggio continuo dalle profondità del mare alle cime dei monti attraverso canali e caverne, dove si depositano i grandi quantitativi d’acqua che permettono alle sorgenti di essere perenni, pone tuttavia una questione da risolvere, cioè se sia possibile, rispetto alla teoria aristotelica dei luoghi naturali, un movimento dell’acqua all’insù: quella causa, che lo move per le sue ramificate vene contro al natural corso delle cose gravi, è proprio quella che move li omori in tutte le spezie de’ corpi animati.83
Un importante esempio è quello della linfa nelle piante, perché la terra stessa ha un’anima vegetativa, di crescita e mutazione morfologica. Il semplice taglio di un tralcio di vite può testimoniare il flusso della linfa dal basso in alto. Così, sempre utilizzando le sue ricerche anatomiche, lo schizzo di un germoglio che ha buttato le radici e punta a formare i cotiledoni è appaiato a quello del fegato84. La plausibilità dell’analogia permette di tenere insieme ciò che può essere osservabile direttamente e fenomeni fisici oscuri ed enigmatici, perché lontani nel tempo o non osservabili direttamente. E che sappiamo noi se la terra ha concavità grandissime con riserbi d’acque? E le innumerabili vene che son piene di tante acque quante si vede nel lor comporre de’ fiumi. Vedesi il mare Ircano grandissimo.85
libri IV, citato anche da Dante, Convivio, II, 13. Vedi anche M. Kemp, Leonardo. Nella mente del genio, Torino 2004, p. 87. 83. Leonardo da Vinci, Codice Arundel f. 236 v. 84. M. Kemp, Leonardo. Nella mente del genio, cit., p. 89. D. Laurenza, Corpus mobile. Tracce di patognomica in Leonardo, in “Raccolta Vinciana” XXVII, Milano 1997, pp. 287 sgg. 85. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 2A, f. 35 v. Il Mar Caspio (Ircano), si credeva alimentato da una fonte sottomarina.
49
La continua erosione dell’acqua non risulterebbe solo superficiale ma anche nelle profondità, arrivando a scavare così tanto da provocare periodicamente dei grandi crolli che farebbero emergere, per la violenta spinta dalla parte opposta, monti e cime, mentre il mare conquisterebbe una parte del globo inabissato86. Il ripetersi ciclico di questo spostamento geologico permetterebbe di spiegare come ci sia anche un rivolgimento delle parti superficiali in strati più profondi: Della terra in sé. L’alzarsi tanto le cime dei monti sopra la spera dell’acqua può esser dirivato, perché il loco grandissimo della terra, il quale era ripieno d’acqua, cioè la grandissima caverna, dovette caderne assai della sua volta inverso il centro del mondo, trovandosi ispiccata mediante il corso delle vene, che al continuo consumano il loco, donde passano,…Ora, questa gran massa potè cadere, essendo il centro del mondo infra l’acqua: essa si fermò con equal pesi oppositi intorno al centro del mondo, e alleggerì la terra, onde essa si divise; la qual si rimosse immediate dal centro del mondo, e s’alzò all’altezza, che si vede le pietre faldate, fatte con l’ordine dell’acque, alle cime delli alti monti.87
Leonardo ritiene fondamentale un moto apparentemente contrario al suo naturale, ma necessario per il continuo opporsi di acqua e terra nell’occupare il centro geometrico dell’universo. Se all’inizio la sua idea della natura è legata alle teorie della terra come un grande organismo dove tutto è collegato, lo scontro tra i quattro elementi, causato dal loro stesso movi-
86. M. Baratta, Leonardo e i problemi della terra, Torino 1903; G. De Lorenzo, Leonardo da Vinci e la geologia, Bologna 1920; G. Ligabue, Leonardo da Vinci e i fossili, Vicenza 1977; S.J. Gould, I fossili di Leonardo e il pony di Sofia, Milano 2004. 87. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 1B, f. 36 r.
50
mento naturale88, diventa il principio che domina la dinamica dei processi, in quanto determina un mutamento violento che provoca l’incessante circolarità di vita e morte. In questo modo la spiegazione prospettica, matematica e meccanicistica, tende a prevalere sull’immagine ovidiana della metamorfosi, il passare continuo in altre forme di ogni cosa. Leonardo usa spesso il disegno per dare un’immediata e intuitiva prova di ciò che sta affermando nel testo, e nel Codice Leicester presenta uno schema esemplificativo per dimostrare sperimentalmente la possibilità che l’acqua salga sulle cime dei monti per ridiscendere dall’alto, e spiegare così il ciclo idrologico, come il peso dell’acqua sul fondo del mare spinga attraverso le caverne e i condotti naturali sotterranei l’acqua verso l’alto: L’acqua s’innalza quando essa discende essendo il suo transito circondato da canna.89
Come nello zampillare di una fontana, l’acqua esce dalla cima del monte e alimenta il ciclo di ritorno al mare. Il riferimento agli studi di uno scienziato tardo-antico, Erone di Alessandria, permette a Leonardo di controbilanciare la critica di Aristotele, che nella Meteorologia90 discute questa teoria già espressa nel Fedone, e infine ritiene assurda la tesi che i fiumi possano scorrere all’insù, sostenuta dal suo maestro Platone, ritenendo che il ciclo delle acque sia determinato dall’evaporazione dell’acqua dal mare per ritornare alla terra con la pioggia.
88. C. Zammattio, Acque e pietre: loro meccanica, in “Leonardo”, cit., pp. 196-7. 89. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 7B, f. 7 v; anche Madrid I, 115 r, cfr. A. Vezzosi, In viaggio con Leonardo. Invenzioni e macchine di un genio umanissimo, Firenze 2003, pp. 7-9. 90. Aristotele, Meteorologia, Libro II, Cap. II, a cura di L. Pepe, Milano 2003, cit., p. 73.
51
Leonardo sembra verso la fine dei suoi anni convincersi della validità delle obiezioni di Aristotele? Forse, se la conclusione delle sue ricerche anatomiche sulla circolazione sanguigna è questa: Contraria è l’origine del mare all’origine del sangue, perché il mare riceve in sé tutti li fiumi, li quali sono sol causati dalli vapori acquei levati infra l’aria; ma il mare del sangue è causa di tutte le vene.91
Il dubbio rimane, dal momento che Leonardo attribuisce al cuore ciò che prima riteneva la funzione del mare per la terra, l’analogia microcosmo-macrocosmo non è eliminata, solo rovesciata, e il cuore viene visto come l’origine della circolazione sanguigna, e il mare ancora come luogo naturale dell’acqua92. D’altra parte non mancavano interpretazioni della meteorologia aristotelica che ponevano un concorso di due cause, una data dalle piogge per i piccoli corsi d’acqua e una marina per i grandi fiumi. Infatti il caso delle piene del Nilo nella stagione più calda aveva creato grande imbarazzo fin dall’antichità, e la teoria dell’origine sotterranea delle sue sorgenti è ripresa anche nel Codice Leicester. Ma ciò che comunque Leonardo concorda con la Fisica aristotelica, è il continuo comporsi e decomporsi delle cose nel perenne conflitto degli elementi. Gli aforismi di Leonardo spesso sono stati giudicati solo intuizioni, prefigurazioni di un sapere più vasto non ancora raggiunto. Ma è una conferma della filosofia naturale il risultato che voleva raggiungere, una visione cosmologica che permet91. Leonardo da Vinci, Windsor 19003. 92. P.C. Marani, Verso nuovi modelli scientifici. Leonardo fra arte, scienza e tecnologia, in C. Vasoli, “Le filosofie del Rinascimento”, Milano 2002, pp. 434-451; dopo aver elencato “un altro paio di assurdità”, ritiene che l’analogia tra circolazione sanguigna e vene della terra venga alla fine abbandonata, “una prova della straordinaria apertura mentale di Leonardo” (p. 450).
52
tesse l’unità di estetica e fisica; non si preoccupava della stesura di un trattato scientifico specialistico, ideale dei secoli successivi, quanto dell’imitazione attraverso la pittura dei più complessi e enigmatici fenomeni. Come per Aristotele, il tempo è misura del movimento, ed ogni cosa è determinata dal moto. Il tema dell’acqua nel suo incessante fluire è quello dell’eternità della natura, principio filosofico fondamentale, contestato dalla visione della Bibbia di una creazione dal “nulla”, e che la Scolastica medioevale aveva faticato a conciliare con la fede. Leonardo ritiene possibile dimostrare sulla base delle sue scoperte dei fossili, non solo il mutamento, lo scambio tra terra ed acqua, ma anche il suo eterno ripetersi. Aveva infatti ipotizzato nei suoi primi scritti, dominati dalla concezione platonica del mondo Grande Animale: Per le 2 linie de’ nichi bisogna dire che la terra per isdegno s’attuffassi sotto ‘l mare, e fè il primo suolo; poi il diluvio fè il secondo.93
Il mare, inteso come il centro dell’elemento acqua, è la causa principale delle trasformazioni della terra, sia nel suo continuo moto delle maree che scopre e allaga la terra, o per inghiottirne una parte a seguito di terremoti (sempre che si possa interpretare così il tuffarsi per isdegno) sia per l’evaporazione che alimenta le nuvole e provoca i diluvi. Le sue successive osservazioni sull’erosione dei fiumi, che in tempi lunghissimi ha portato alla luce una stratificazione orizzontale delle montagne, in cui sono presenti vari livelli fossiliferi di origine marina, gli fanno affermare nei suoi ultimi scritti:
93. Leonardo da Vinci, Codice Arundel f. 156 v.
53 Li nichi ostrighe e altri simili animali che nascono nelli fanghi marini, ci testificano la mutazion delle terre intorno al centro dei nostri elementi.94
Come nelle sue ricerche anatomiche o nei suoi studi di embriologia, il tema di fondo è la ricerca della mutazione nel tempo, così dell’uomo, degli animali e del mondo. Leonardo riferisce dunque le sue descrizioni precise e articolate dei fossili ad una verifica certa delle tesi che si stanno confrontando nella sua epoca, quella creazionistica di un inizio e di una fine del tempo, e la concezione filosofica dell’eternità del mondo. Infatti le analisi della dinamica dei fiumi specificano una granulometria dei depositi di sassi e fanghi, per cui la stratificazione di foglie, cadute nel fiume e sepolte dal fango in posizioni sovrapposte, fa determinare i tempi della loro formazione. I diversi strati fossili stabiliscono il principio che i ritrovamenti nei livelli inferiori sono più antichi95. Così nella descrizione della struttura dei fossili marini, i più comuni “nichi” (lamellibranchi e gasteropodi), Leonardo può stabilire l’accrescimento del guscio nel tempo, perché presenta anelli di crescita che possono essere contati “come nelle corna de’ buoi e de’ castroni”96. Inoltre i muscoli che serrano le due valve lasciano dei segni sul guscio stesso, dimostrando che erano vissuti in quel luogo ed erano ancora vivi quando sono stati sepolti, imprigionati nel fango e pietrificati. Tu hai ora a provare come li nicchi non nascano se non in acque salse, quasi tutte le sorte, come li nicchi di Lombardia
94. Leonardo da Vinci, Manoscritto E, f. 4 v. 95. S.J. Gould, I fossili di Leonardo e il pony di Sofia, cit., pp. 30-32, elenca nove punti di osservazioni geologiche e paleontologiche che vengono utilizzate ancora oggi come valide o comunque come esperienze ritenute corrette. 96. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 1B, f. 36 r.
54 4 livelli, e così è per tutti li quali son fatti in più tempi, e questi sono per tutte le valli che sboccano alli mari.97
Da notare come i livelli studiati sono passati da due a quattro e che questa indicazione stabilisca una cronologia di epoche millenarie, che confermano la teoria di epoche di sconvolgimenti del rapporto tra terra e acqua, con l’intervento di quattro diluvi per seppellire gli animali della zona costiera, a determinarne il processo di fossilizzazione. Dubitatione- Movesi qui un dubbio, e questo è se’l diluvio venuto al tempo di Noè fu universale o no, e qui parrà di no per le ragioni che si assegneranno. Noi nella Bibbia abbiàn che il predetto diluvio fu composto di quaranta dì e quaranta notte di continua e universa pioggia, e che tal pioggia alzò dieci gomiti sopra al più alto monte dell’universo; e se così fu che la pioggia fussi universale, ella vestì di sé la nostra terra di figura sperica, e la superfizie sperica ha ogni sua parte equalmente distante al centro della sua spera; onde la spera dell’acqua trovandosi nel modo della detta condizione, elli è impossivile che l’acqua sopra di lei si mova, perché l’acqua in sé non si move, s’ella non discende; adunque l’acqua di tanto diluvio dove si partì, se qui è provato non avere moto? E s’ella si partì come si mosse, se essa non andava all’insù? E qui mancano le ragioni naturali, onde bisogna per soccorso di tal dobitazione chiamare il miracolo per aiuto, o dire che tale acqua fu vaporata dal calor del sole.98
Leonardo ha posto in dubbio la tesi di un Diluvio Universale, cioè esteso a tutta la terra, sulla base della dimostrazione geo97. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 1B, f. 36. All’epoca del lavoro per il Monumento equestre di Francesco Sforza, furono portati a Leonardo fossili dalla zona di Piacenza. Evidentemente, Leonardo ha allargato le sue ricerche alle Alpi lombarde e alla valle dell’Adige, si informa delle montagne friulane e della valle del Danubio, infine torna alla valle dell’Arno, che conosceva da bambino. 98. Leonardo da Vinci, Atl. 418 b, ex 155 r.c.
55
metrica della sfera, la cui circonferenza è equidistante in tutti i suoi punti dal centro. L’isonomia dei mari, che Leonardo aveva correttamente individuato, deve sempre lasciare scoperta una parte di terra, per cui l’acqua non potrebbe defluire nel momento in cui avesse coperto tutto. Se è vero che l’acqua provoca il disfacimento delle rocce dei monti portando a valle i detriti “e vorrebbe ridurre la terra in perfetta spericità, s’ella potessi”99, rimane il fatto che la vita è possibile solo nella compresenza e nel bilanciamento dei quattro elementi. L’acqua non può logicamente prevalere, perché l’equilibrio attuale è evidente. Nella più grande distruzione delle inondazioni rimane sempre una cima di monte, qualche porzione di selva dove i sopravvissuti possono rifugiarsi. Così scrive per il suo progettato quadro del Diluvio: Gran quantità di popoli, d’uomini e d’animali diversi si vedea scacciare dall’accrescimento del diluvio, inverso le cime de’ monti, vicini alle predette acque.100
Leonardo non nega affatto che vi sia stato un diluvio, come raccontato dalla Bibbia, perché gli stessi fossili stanno a testimoniarne la veridicità. Solo che i fossili si trovano in strati ben precisi, poco sopra la radice dei monti, per tutto a una medesima altezza, a suoli a suoli,101
99. Leonardo da Vinci, Atl. 291 v, ex 105 v.c. 100. Leonardo da Vinci, Windsor 12665 r. Il tono drammatico di queste descrizioni ha portato V.P. Zubov, Leonardo da Vinci, Cambridge (Mass.) 1968, pp. 22-23, e recentemente M. Versiero, “La nota del stato di Firenze” Leonardo e Savonarola: Politica, Profezia, Arte, in “Raccolta vinciana”, XXXV, Milano 2013, pp. 32-42, ad accostarle alle profezie di Savonarola. Ma Leonardo contesta scientificamente proprio l’idea del Diluvio Universale, negando implicitamente ogni profezia di fine del mondo. 101. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta B, f. 8 v.
56
e non sulla cima delle montagne, se valesse il racconto che fissa una altezza delle acque sopra le vette più alte. Inoltre nei 40 giorni previsti dalla narrazione biblica, chiocciole e ostriche non avrebbero potuto percorrere la distanza dal mare Adriatico alla Lombardia, essendo il nichio animale di non più veloce moto che si sia la lumaca fori dall’acqua.102
Nel progettato libro delle acque la questione dei fossili è il banco di prova della validità della teoria dei Diluvi che colpiscono parti consistenti della terra, ma non “universali”, bensì limitati nello spazio e periodici, già prospettata nel mito da Platone e sostenuta anche da Aristotele nella Meteorologia. Ma quest’ultimo non aveva chiarito l’origine marina delle zone fossilifere e la sua scuola, già a partire da Teofrasto riteneva credibile un influsso astrologico, tale da determinare un principio di generazione “spontanea” della terra, a riformare il mondo dopo ogni cataclisma. Quest’ultima posizione era inevitabile se si poneva un’eternità della natura con periodiche distruzioni dovute al fuoco che portavano alla fine di ogni forma di vita, come per l’apocatastasi degli Stoici. La fissità delle specie e la loro rigenerazione continua dalla composizione dei quattro elementi era la teoria più seguita nelle Università dagli scienziati aristotelici. La presenza di fossili sui monti era considerata uno scherzo mostruoso di influssi celesti, una metamorfosi della formazione geologica dei minerali e delle gemme. Leonardo sostiene invece, consapevolmente e dichiaratamente contro di loro, la tesi dell’origine organica dei fossili. L’elencazione dei casi in cui i fossili sono con tutta evidenza resti di animali vissuti, e non semplici em-
102. Ibidem.
57
brioni di organismi in via di formazione, lo porta a criticare e ad escludere la teoria degli influssi astrologici103. Che i suoi contemporanei, studiosi di astronomia, fisica e medicina delle Università non gradissero queste intromissioni è testimoniato dalla valutazione negativa di Baldassar C astiglione: Un altro de’primi pittori del mondo sprezza quell’arte dove è rarissimo ed èssi posto ad imparare filosofia, nella quale ha così strani concetti e nove chimere, che esso con tutta la sua pittura non sapria depingerle.104
E il fatto che si è proposto come filosofo ai suoi contemporanei, trova un’altra conferma proprio nella discussione sull’eternità del mondo, con la principale obiezione che era stata mossa già da Agostino105, e perciò molto ripresa, della mancanza di testimonianze scritte per i tempi più lontani, al di là del racconto biblico della Genesi: Perché molto son più antiche le cose che le lettere, non è meraviglia se alli nostri giorni non apparisce alcuna scriptura delli predetti mari essere occupatori di tanti paesi: e se pure alcuna sciptura apparia le guerre, l’incendi, le mutazioni delle lingue e delle leggi, li diluvi dell’acque hanno consumato ogni anti-
103. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, f. 9 r-c. R. Nanni, Astrologia e prospettiva: per lo studio dell’immagine della scienza nel “Paragone delle arti” di Leonardo. In “Raccolta Vinciana”, XXVII, 1997, pp. 13-81. Sulle teorie della natura dei fossili, considerate scientifiche al tempo di Leonardo, non posso che rinviare al mio Leonardo a Venezia e nel Veneto, VII, Leonardo filosofo: i fossili e i tempi del mondo., Treviso 2007. 104. B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, I, XXXIX, cit., p. 154. Il libro, pubblicato solo nel 1528, è stato scritto per la prima parte nel 1513-15, in cui l’autore si trovava presso la corte di Leone X, negli stessi anni in cui Leonardo era a Roma. 105. Agostino, La città di Dio, XII, 10-11, a cura di L. Alici Milano 2001, pp. 574-5.
58 chità: ma a noi basta le testimonianze delle cose nate nell’acque salse ritrovarsi nelli alti monti lontani dalli mari talor.106
Leonardo mette al centro della sua concezione del tempo la teoria del conflitto tra acqua e terra, con i diluvi che periodicamente cancellano ogni testimonianza di civiltà umana ma non i resti fossili degli animali marini che rappresentano, come abbiamo visto, la prova fisica delle catastrofi periodiche. Grazie a queste distruzioni è possibile il ciclico ripetersi della natura e delle vicende dell’umanità, come era stato pensato dalla cosmologia peripatetica. La somiglianza, tra questa precisa analisi della concezione della mancanza della memoria storica di tempi più antichi dovuta alla morte traumatica di popoli e genti, a causa di eventi provocati dall’uomo come le guerre, cambiamenti di forme di governo e di leggi civili, ma soprattutto determinata dai diluvi periodici, con il quinto capitolo del libro secondo dei “Discorsi” di Machiavelli, è stata segnalata da tempo107. A quegli filosofi che hanno voluto che il mondo sia stato eterno, credo che si potesse replicare che se tanta antichità fusse vera e’ sarebbe ragionevole che ci fussi memoria di più che cinquemila anni; quando e’ non si vedesse come queste memorie de’ tempi per diverse cagioni si spengano, delle quali, parte vengono dagli uomini, parte dal cielo.108
106. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 6 B, f. 31 r. 107. O. Tommasini, La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli in relazione al machiavellismo, 2 Voll. Torino 1883-1911, II, p. 909, nota 1; G. Sasso, Machiavelli e gli antichi e altri saggi, Vol. II, Milano-Napoli 1988, pp. 347-353. 108. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, II, 5. In Id. “Tutte le opere” a cura di Mario Martelli, Firenze 1971, p. 154. Il giovane Niccolò Machiavelli aveva ricopiato e tradotto un manoscritto di Lucrezio, De rerum Natura, per cui conosceva i versi 325-345 del libro V dove, dal punto di vista atomistico i mondi si formano e scompongono continuamente, per cui “il mondo è giovane” e non appaiono testimonianze dei poeti di
59
L’obiezione all’eternità del mondo sarebbe credibile anche per Machiavelli se non si potessero dimostrare le cause della distruzione delle testimonianze dei tempi più antichi di quelli previsti dalla cronologia biblica dei cinquemila anni. Machiavelli analizza ovviamente in maniera articolata le cause storiche, della variazione delle religioni e delle lingue. Ma tra le cause naturali pone le pestilenze, la fame, e i diluvi: Quanto alle cause che vengono dal cielo, sono quelle che spengono la umana generazione, e riducano a pochi gli abitatori di parte del mondo. E questo viene o per peste o per fame o per una inondazione d’acque; e la più importante è questa ultima.
Così, dopo aver riproposto il mito platonico dei pochi “montanari e rozzi” che si salvano, ritiene che non vi siano dubbi sulle conseguenze verificabili dei fenomeni della natura, dubbi invece sempre possibili per le testimonianze degli storici che, come tutti gli altri uomini, sono condizionati dalle casuali variazioni di linguaggi, leggi, stati, o per interessi personali. Anche la concezione della terra “organismo animale” viene ripresentata da Machiavelli, prima ancora di quella dell’analogia tradizionale tra corpo umano e corpo politico dello stato. Infatti, che l’eternità della mondo sia ragionevole, viene espresso da Machiavelli con questa similitudine: perché la natura, come ne’ corpi semplici, quando e’ vi è ragunato assai materia superflua, move per se medesima molte volte, e fa una purgazione, la quale è salute di quel corpo;109
tempi remoti. Ma qui un’eternità della natura e dei suoi processi è pensata in riferimento al nostro sistema solare, è rifiutato il modello atomistico e non si ipotizzano “infiniti mondi”. 109. N. Machiavelli, Discorsi, cit., p. 155. E. Garin, Machiavelli tra politica e storia, Torino 1993, discute il riferimento alla ciclicità delle forme di governo in Polibio e segnala l’apertura del quinto libro delle Istorie fiorentine: “perché non essendo dalla natura conceduto nelle mondane cose il fermarsi, come le arrivano alla loro ultima perfezione, non avendo più da salire, con-
60
Dove l’incremento demografico raggiunge il livello massimo, la natura non può che curare la parte sovrabbondante, malata, purgandosi per eliminarla. È da notare come vi sia un preciso richiamo all’immagine della natura che lo stesso Leonardo aveva delineato la natura sol s’astende alla produzione de’ semplici, ma l’omo con tali semplici produce infiniti composti, ma non ha la podestà di creare nessun semplice, se non un altro sé medesimo, cioè li sua figlioli.110
L’uomo è parte della natura nella sua generazione dei figli, come la natura produce ogni vita sulla base degli elementi semplici di essenze elementari, di particelle qualitative, di semi. Tutte le produzioni artificiali dell’uomo non fanno che comporre in varie combinazioni ciò che già esiste. Anche i linguaggi sono composti che l’uomo crea, sulla base di una capacità fonatoria naturale, articolandone i suoni semplici: Se tutti gli effetti di natura avessino nome, s’astenderebbero inverso lo infinito, insieme colle infinite cose che sono in atto e che sono in potenzia di natura: e queste non isplemerebbe in un solo linguaggio, anzi in moltissimi, li quali ancora lor s’astendano inverso lo infinito, perché al continuo si variano
viene che scendino”. E. Cutinelli-Rendina, Introduzione a Machiavelli, Bari 1999, p. 101-2: “eterno è il mondo stesso, che altro non è che questo eterno consumarsi e ricomporsi di ciò che viene ospitato nel suo ambito”. Di diverso avviso F. Frosini, Umanesimo e immagine dell’uomo, in “Leonardo e Pico”, cit., pp. 206-8, ha parlato di “mera suggestione”, a proposito del collegamento tra Leonardo e Machiavelli; torna poi sulla questione in Id. Vita, tempo e linguaggio (1508-1510), L Lettura vinciana Firenze 2011, pp. 29-32, dove nega che Machiavelli ritenga valida la tesi dell’eternità del mondo (p. 31) e considera quella di Leonardo solo un’ipotesi. 110. Leonardo da Vinci, Windsor 19045 v. Il brano prosegue in polemica con gli alchimisti che pretendevano di poter produrre la quintessenza, o materia prima, supposta base delle trasmutazioni dei metalli in oro; si veda a questo proposito C. Luporini, La mente di Leonardo, Firenze 1953.
61 di seculo in seculo e di paese in paese, mediante le mistion de’ popoli che per guerre o altri accidenti al continuo si mistano; e li medesimi linguaggi son sottoposti alla obblivione e son mortali come l’altre cose create; e se noi concederemo il nostro mondo essere eterno, noi diren tali linguaggi essere stati e ancora dovere essere d’infinita varietà, mediante l’infiniti secoli che nello infinito tempo si contengano, ecc.111
I linguaggi sono soggetti dal continuo uso a modificarsi per la loro stessa composizione casuale e destinati a scomparire per le vicende storiche accidentali, come guerre e migrazioni. La visione della storia di Leonardo si sviluppa coerentemente su questa base, e se non può coincidere con il quadro molto più articolato che ha fatto Machiavelli delle vicende umane e dei linguaggi, è evidentemente simile nel suo contenuto generale. Machiavelli inoltre sembra dipendere dalle tesi di Leonardo per la concezione dei diluvi, vera prova delle mutazioni temporali delle condizioni in cui si inserisce la storia umana. Che possa averne discusso negli anni in cui si sono trovati vicini ed hanno collaborato, a Firenze al tempo della Battaglia di Anghiari, spiegherebbe quel “a noi” basta le testimonianze delle cose nate nell’acque salse112. Esisteva una cerchia di confidenti e amici, di cui è stato partecipe anche il segretario fiorentino. Se Discorsi II,5 non nomina espressamente la fonte, e parla genericamente de “i filosofi che hanno voluto il mondo essere eterno”, di fatto Machiavelli finisce per accostare i filosofi greci al suo conterraneo, di quindici anni più anziano, Leonardo da Vinci. Si tratta della più importante testimonianza della sua
111. Leonardo da Vinci, Windsor 19045 v. L.M. Batkin, Leonardo da Vinci, Bari 1988, pp. 121-126. M. Versiero, Dall’eternità del mondo al governo delle città: Leonardo da Vinci, dopo Machiavelli, in L. Bianchi-A. Postigliola (a cura di), “Dopo Machiavelli/Après Machiavel”, Napoli 2008, pp. 33-52. 112. Leonardo da Vinci, Codice Leicester, Carta 6 B, f. 31 r.
62
filosofia, almeno per quanto riguarda la concezione dei Diluvi, e la sua divulgazione in un ambito pubblico113. Sul perché Leonardo non arrivi alla stampa della sua concezione filosofica non sembra abbia potuto pesare la preoccupazione stilistica, dato che un trattato sistematico è possibile anche in una organizzazione degli argomenti nella forma aforistica. Lo stesso “Principe” del Machiavelli, modello sempre ripreso della scienza politica, è stato definito un sistema di massime, con l’aggiunta di esempi tratti dalle storie antiche e moderne; inoltre la maggior parte delle opere del segretario fiorentino è stata pubblicata postuma. Piuttosto si può pensare che siano sorte delle difficoltà nel momento in cui Leonardo si apprestava a farlo, il sentore di un’ostilità nei confronti delle sue concezioni. Altri motivi probabili sono in primo luogo il bisogno di ulteriori verifiche di anatomia che, dopo Firenze e l’anno di collaborazione con Marcantonio Della Torre a Pavia, cerca di riprendere a Roma; in secondo luogo la reazione negativa rispetto alle sue analisi della luna e la concezione del sole in ambienti universitari114. 113. G. Sasso, Su Machiavelli. Ultimi scritti, Roma 2015, p. 174: “Del resto, non per indulgere ad associazioni estrinseche e per dare spazio, nel migliore dei casi, agli aneddoti, ma perché di quel che si asserisce esiste il documento, non può escludersi che di parti del mondo che sprofondano nella distruzione sotto la furia dei venti e delle acque mentre la sua eterna cornice si sottrae alla vicenda che si contempla nel suo spazio, Machiavelli avesse occasione di parlare con l’artista e scienziato che di quegli spettacoli dette, negli scritti e ancor più nei disegni, rappresentazioni famose. L’artista e scienziato è Leonardo, con il quale Machiavelli ebbe rapporti fra il 1502 e il 1504”. 114. G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, Torino 1992, Vol. II, p. 547: “… continuando et osservando il moto del cielo, il corso de la luna e gli andamenti del sole. Per il che fece ne’ l’animo un concetto sì eretico, che e’ non si accostava a qualsivoglia religione, stimando per avventura assai più lo esser filosofo che cristiano” Questa frase verrà tolta nella seconda edizione del 1568.
63
Nel merito di un dubbio sul piano religioso si può solo congetturare. Forse il timore delle conseguenze, forse Leonardo si rese conto che scalzava l’immagine della conciliazione facile e scontata di fede e ragione, e che poteva rimanere coinvolto in una diatriba teologica sull’immortalità dell’anima, quando scriveva: Essendo dato il mondo etterno, egli è necessario che gli sua popoli sieno ancora loro etterni.115
L’immagine di Leonardo da Vinci a Roma, che Leone X vede come un pittore ormai anziano e sorpassato nella pittura dal giovane Raffaello, che lascia ai suoi allievi le commissioni più importanti per dedicarsi a esperimenti considerati quantomeno curiosi, se non “folli”, ha interessato molti critici. Che fosse ancora alle prese con ricerche anatomiche che gli procurano sospetti e fastidi, è stato ormai appurato dalla sua stessa testimonianza, dalle lettere che invia ai suoi potenti protettori116. Ma un’affermazione della sua filosofia che propone l’eternità del mondo in una considerazione generale sui tempi naturali, scanditi da diluvi e sommovimenti tellurici tali da formare le montagne, non limitandosi a proporre le tesi degli antichi del flusso e riflusso del mare, bensì accumulando prove che hanno al centro il ciclo dell’acqua e il punto fermo dei fossili,
115. Leonardo da Vinci, Manoscritto G, f. 49 rv., Quando poi scrive: “E il resto della definizion dell’anima lascio nella mente de’ frati, padri de popoli, li quali per ispiritata azione san tutti li segreti” (Windsor, 19115, r) sembra accettare con sottile ironia la tesi della doppia verità. Secondo D. Laurenza, Leonardo. L’anatomia, Firenze 2009, pp. 167-168, è stato coinvolto nella stessa questione di Pietro Pomponazzi che, mentre il Concilio Laterano del 1513 aveva sancito il dogma di fede dell’immortalità dell’anima, scriveva contro la sua dimostrabilità scientifica, suscitando la reazione dei teologi. 116. A. Forcellino, Leonardo a Roma, in “Raccolta vinciana” XXXVI, Milano 2015, pp. 133-161. D. Laurenza, Leonardo nella Roma di Leone X, XLIII Lettura Vinciana Firenze 2003.
64
poteva creargli fastidi ancora peggiori. Non si tratta certo di riprendere la notizia esagerata di sue tendenze eretiche di cui parla Vasari, che doveva circolare decenni dopo la morte in ambienti ecclesiastici. Anche il suo riferimento ai Presocratici non lo porta a riconsiderare la credenza nelle divinità pagane, che erano per l’Accademia fiorentina miti poetici sotto i cui veli si nascondeva la rivelazione originaria, per Leonardo solo immagini antropomorfiche delle forze della Natura. E Karl Jaspers, seguendo il percorso interpretativo che va da Goethe a Nietzsche, ripropone l’analisi di Leonardo filosofo dalle vedute più ampie delle dispute teologiche tipiche del periodo della Riforma protestante, e ne fa un indifferente senza interessi chiesastici, credente senza dogmi117. La filosofia per Leonardo deve riguadagnare quella sapienza originaria che gli uomini periodicamente dimenticano, perché la distruzione delle città elimina ogni tecnica, ogni arte, e toglie anche il ricordo del passato e fa ritornare l’umanità ai suoi primordi: Ogni danno lascia dispiacere nella ricordazione salvo che ‘l sommo danno, cioè la morte, che uccide essa ricordazione insieme colla vita.118
Il tempo in Leonardo non si disgiunge, bensì si accompagna al movimento, sia in forma rettilinea e limitata, quantificabile nel moto locale, sia ciclico, in riferimento agli elementi primi e alla eternità dei cieli che vede il sole come unico motore del
117. K. Jaspers, Leonardo filosofo, cit., pp. 129-132, nega che si possa definire anticristiano, perché la sua vastissima apertura di pensiero lo pone di fronte alla trascendenza, e se rimane impassibile, agnostico, e non si pronuncia, è perché sa che l’infinito va al di là delle nostre possibilità conoscitive. 118. Leonardo da Vinci, Manoscritto H f. 33 v.
65
conflitto continuo degli elementi. In questo eterno ritorno119 delle stesse cose l’esistenza dell’umanità non è mai annullata ma altrettanto ciclica nelle sue forme, sviluppo, capacità conoscitive. Per Leonardo la meraviglia di fronte alla natura non è solo l’inizio del filosofare ma anche il suo risultato: questo è il modo di conoscere l’operatore di tanti mirabili cose, e questo il modo di amare un tanto inventore, perché invero il grande amore nasce dalla gran cognizione della cosa che si ama, e se tu non la conoscerai poco o nulla la potrai amare.120
Nella sua filosofia Leonardo ha ritenuto di aver compreso ciò che era nascosto, la “caverna oscura” della Natura che desiderava conoscere, di aver ottenuto il premio finale alla sua attività virtuosa, il grande amore che nasce dalla conoscenza. Ma questo amore intellettuale non porta all’unione mistica con l’Assoluto come in Pico della Mirandola, o al sentirsi parte dell’amore divino come in Leone Ebreo, che usa formulazioni molto simili al testo appena citato di Leonardo nei suoi “Dialoghi d’Amore”, nel porre la conoscenza a fondamento del trasporto amoroso. La sapienza raggiunta, la felicità che ne deriva, trapassano nell’infelicità massima, essendo il filosofo arrivato a quel limite delle capacità conoscitive, al culmine che porta alla discesa verso il suo opposto: la somma filicità sarà somma cagione della infelicità, e la perfezion della sapienza cagion della stoltizia.121
119. R. Mondolfo, L’infinito nel pensiero dei greci, Firenze 1934, pp. 39-40. E. Berti, Tempo ed eternità, in L. Ruggiu (a cura di), “Filosofia del tempo”, Milano 1998, pp. 12-26. Un’analisi dell’interpretazione di Nietzsche di Leonardo artista-filosofo,, non può essere proposta in questa sede, per cui si rinvia ad un’ulteriore lavoro da parte di chi scrive, in via di pubblicazione. 120. Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, 77. 121. Leonardo da Vinci, Atl. 112° rv, ex 39 v.c. G. Fumagalli (1939) ha pubblicato per la prima volta questo aforisma di Leonardo, interpretandolo
66
Nella concisione dell’aforisma Leonardo racchiude la profondità della riflessione sulla sua vita, l’intuizione che ne fa un filosofo, al di là di ogni errore teorico. La stoltizia non ha più a che fare con l’anedottica delle follie e bizzarrie degli uomini della “Nave dei folli” di Sebastian Brant, e nemmeno con l’ironia parodistica dei lunghi discorsi sofistici dell’“Elogio della Follia” del grande umanista Erasmo da Rotterdam, da poco pubblicata e che circolava nella Roma negli anni di Leone X. Leonardo vede il suo destino come filosofo che, avendo posto la sua unica e vera felicità nella conoscenza, deve ammettere che gli uomini non riescono ad accettarne i risultati, e rinunciare ad essere riconosciuto come sapiente gli permette di continuare a vivere nella comune insipienza, ma significa per lui sprofondare nell’infelicità. Forse come consolazione della sua vecchiaia ripeteva tra sé che l’uomo va giudicato per ciò che può fare e non per ciò che non è in suo potere cambiare.
c ome un riconoscimento di incapacità della ragione umana a cogliere la verità; Pedretti e Marani hanno datato il foglio in cui si trova al 1487-90, ben prima dell’opera di Brandt (1497) e di Erasmo (1511) e quindi del tutto originale nella sua formulazione e, secondo l’interpretazione qui esposta, anche nel suo contenuto.
69
Avvertenza per il lettore
L’antologia che qui si presenta cerca di documentare nella maniera più ampia la filosofia di Leonardo che è sparsa nei manoscritti in forma di pensiero frammentario e aforistico. La suddivisione per argomenti, proposta dai titoli dei capitoli, è funzionale a una lettura più semplice, senza però isolare i singoli pensieri dal contesto della ricerca, dei disegni e applicazioni tecniche e artistiche di cui fanno parte, che verranno indicati in nota. L’antologia segue il criterio di porre all’inizio di ogni capitolo sempre i pensieri che sono stati formulati nei manoscritti risalenti cronologicamente all’inizio dell’attività di Leonardo come maestro indipendente, secondo le indicazioni dei vari studiosi che hanno cercato di datarli, e di cui si rende conto nella tavola dei Codici. Purtroppo le più importanti raccolte dei manoscritti non rispettano affatto un ordine in base lo sviluppo nel tempo dell’elaborazione dell’autore e molte possono essere le difficoltà a seguire il principio di mantenere un preciso collegamento temporale, specialmente raggruppando i testi per temi. Va da sé che la scelta è del curatore, e che non è pensabile di arrivare a proporre una collocazione sistematica definitiva, con la vana pretesa di interpretare le intenzioni,
70
o addirittura di sostituirsi all’autore. Il risultato finale, come il lettore constaterà facilmente, è che ci sono collegamenti tra aforismi collocati sotto titoli diversi; in alcuni casi il rinvio dall’uno all’altro è posto in nota, quando lo richiede il senso del ragionamento o l’importanza dell’argomento. Si fornisce di seguito una tavola dei Codici in cui sono raccolte le tantissime pagine di disegni e annotazioni che compongono le Opere di Leonardo, con la sigla con cui vengono citati. Per una descrizione della formazione e storia dei Codici si rinvia alla Bibliografia.
71
Tavola dei codici
Si forniscono le sigle utilizzate nelle citazioni delle opere di Leonardo da Vinci, dei Codici tra parentesi quadre a cui segue il numero del foglio, con l’indicazione della facciata, retto = r, o verso = v.
A = Manoscritti della Biblioteca dell’Istitut de France. Parigi, prima edizione curata da C. Ravaisson-Mollien, Les Manuscripts de Léonard de Vinci, Paris 1881-1892. Nuova edizione a cura di Augusto Marinoni, A-M, Firenze 1987-1990. Data di composizione circa 1492. Arundel = Codice Arundel, British Museum, London; British Library, ms. Arundel 263. Raccolta di fogli da tutta la produzione di Leonardo dal 1478 al 1518. Edizione della Reale Commissione Vinciana, in quattro tomi, Roma 1923-30. Edizione in facsimile a cura di Carlo Pedretti, trascrizione e note critiche di Carlo Vecce, 1998. Ashburnham = Fogli asportati da A e B, rivenduti al Conte di Ashburnham e poi restituiti alla Francia e ricompresi nella prima edizione C. Ravaisson-Mollien, Les Manuscripts de Léonard de Vinci, Paris 1881-1892.
72
Atl. = Codice Atlantico, Biblioteca Ambrosiana di Milano. Trascrizione diplomatica e critica di Augusto Marinoni, Firenze 2000, voll. I-IV. Edizione in facsimile in 20 Voll., Firenze-Milano 2006. Come indica il suo nome è una raccolta di fogli da tutta la produzione dal 1480 al 1518. Il Vol. 20 riporta Indici per materie e alfabetico, a cura di Pietro C. Marani, pp. 103107, con un Ordine cronologico di proposte di datazione di una parte dei fogli; infatti solo 17 fogli (p. 108) su 1119 sono stati datati da Leonardo. B = Manoscritti della Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Edizione a cura di A. Marinoni, Firenze 1987-1990. Data di composizione circa 1484-86: è quindi il primo in ordine cronologico dei quaderni a noi giunti. C = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Oltre all’edizione citata a cura di Marinoni, anche Leonardo da Vinci. Codice C, a cura di Manlio Brusatin e Vittorio Mandelli, Milano 2006. Data posta da Leonardo 23 aprile 1490. D = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit., Data di composizione circa 1508-10. E = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit., Data di composizione circa 1513-14. F = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Oltre all’edizione citata a cura di Marinoni, anche Leonardo da Vinci. Il mondo e le acque. Scritti XI, a cura di Giovanni Majer, Vicenza 2006. Data posta da Leonardo: 12 settembre 1508. Forster I, II, III = Codice Forster, London, Victoria and Albert Museum. Trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze 1992. Data di composizione circa 1487-97. G = Biblioteca dell’Istitut de France. Parigi. Ed. cit., Data di composizione circa 1511-15.
73
H = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit., circa 1494. I = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit., Data di composizione 1498-99. K = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit., Fogli di composizione varia, dal 1484-86 al 1504-1509. L = Biblioteca dell’Istitut de France, Parigi. Ed. cit, circa 1497-1502. Leic.= Codice Leicester, a cura di Girolamo Calvi, Milano 1909; reprint Firenze 1980. Databile circa 1506-1510. Proprietà prima del Conte di Leicester, poi A. Hammer, ora B. Gates, Seattle (USA); unico codice in mani private, è stato riprodotto fotograficamente in Leonardo: il Codice Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo Pedretti, Firenze 1985. Recentemente è stata annunciata l’edizione critica a cura di Martin Kemp. LP. = Codice Urbinate lat. 1270 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 1540 circa, di mano dell’allievo Francesco Melzi, stampato parzialmente da una copia francese per la prima volta nel 1651, pubblicato successivamente nel 1817 da G. Manzi come Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci, tratto da un codice della Biblioteca Vaticana. Dall’edizione rivista e corretta a cura di H. Ludwig, Leonardo da Vinci, Das Buch vom Malerei, Vienna 1882, seguono varie edizioni, ad esempio G. Milanesi (1890), A.M. Brizio (1952) J. Recupero (1966). Più recentemente, la trascrizione critica di C. Vecce, Libro di pittura. a cura di C. Pedretti, 2 Voll., Firenze 1995, da cui si cita il numero di paragrafo. Di seguito si indica la numerazione del Trattato della Pittura (TP) in quanto più reperibile e tuttora diffuso.
74
M = Biblioteca dell’Istitut de France. Ed. cit., Data di composizione circa 1498-99. Madrid, I, II = I Codici di Madrid, a cura di Ladislao Reti, Firenze 1974. Data di composizione circa 1494-95 per il primo volume con studi di meccanica, e 1503-1505, con originali utilizzati da Melzi per il Trattato della Pittura, per il secondo volume. Tri. = Codice Trivulziano. Il Codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, a cura di A. Marinoni, Milano 1980. Riguarda il primo periodo a Milano circa 1484-90. V.U. = Volo degli Uccelli, Biblioteca Reale di Torino. Circa 1505. Il Codice sul Volo degli Uccelli nella Biblioteca Reale di Torino, Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci, a cura della Commissione Vinciana, Firenze 1976. Windsor = Royal Library, Castello di Windsor, Londra. 780 fogli sparsi di diverse datazioni, dal 1480 al 1518. I fogli di anatomia a cura di T. Sabachnikoff, trascritti e annotati da G. Piumati, sono stati pubblicati come Dell’anatomia. Fogli A e B, Parigi 1898. I disegni invece da K. Clark, The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of the Majesty the Queen at Windsor Castle, 3 Voll., Cambridge 1935. Nuova edizione: K. Clark (with the assistance of C. Pedretti), The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of the Majesty the Queen at Windsor Castle, 2 Voll., London 1968.
I diluvi e il tempo
Antologia degli scritti filosofici
77
Pittura e Prospettiva
Prospettiva. Domandasi a te, pittore, perché le figure da te fatte in minuta forma per dimostrazione di prospettiva non paiano in pari dimostrazione di distanzia grandi quanto le naturali levate di pari grandezza alle dipinte sopra la pariete. E perché le cose apparenti in picciola lontanità in pario distanza apparano1 maggiore che ‘l naturale. [Tri. 71] La prospettiva è briglia e timone della pittura. La grandezza della figura dipinta ti debbe mostrare a che distancia ell’è veduta. Se tu vedi una figura grande al naturale, sappi che la si dimostra essere presso all’occhio. [LP. 502; TP., III, par. 497]
1. apparano = appaiono. Si tratta della prospettiva lineare, che deve collocare le figure diminuendone la grandezza a seconda della distanza. Fin dalle sue prime annotazioni, Leonardo si pone domande che cercherà di risolvere con analisi ottiche e con l’anatomia dell’occhio.
78
L’ingegno del pittore vol essere a similitudine dello specchio, il quale sempre si trasmuta nel colore di quella cosa ch’egli ha per obietto2, e di tante similitudini s’empie, quante sono le cose che li sono contraposte. Adunque, conoscendo tu, pittore, no’ poter essere bono se non se’ universale maestro di contraffare co’ la tua arte tutte le qualità delle forme che produce la Natura, le quali no’ saprai fare se no’ le vedi e ritraile3 nella mente. [Ashburnham I, 2 r] Io ho già veduto nelli nuvoli e muri macchie4, che mi hanno desto a belle invenzioni di varie cose. [Ashburnham I, 22 v] Intra li studi5 delle naturali considerazioni la luce diletta più i contemplanti. Intra le cose grandi delle matematiche la 2. obietto = oggetto. La similitudine tra la mente umana e lo specchio esprime la concezione mimetica della conoscenza umana del mondo circostante, talmente diffusa in ogni epoca da essere stata definita “realismo dogmatico”. 3. ritraile = te le rappresenti. L’attività del pittore è mentale e pratica insieme, se vuole essere capace, bono, di riprodurre (contraffare) le forme naturali nel loro insieme, e diventare così universale maestro. 4. Nel Libro di pittura, I, par. 66, viene ripreso e allargato l’esempio delle macchie, insieme all’osservazione di nuvole, ceneri o fanghi, dove troverai invenzioni mirabilissime, che destano l’ingegno del pittore a nuove invenzioni. La creatività dell’artista ha comunque un punto di partenza dai fenomeni naturali, anche banali, quotidiani e brutti, che possano tuttavia stimolare l’immaginazione. 5. L’intero brano è una traduzione (Solmi 1976, pp. 226-227) della prefazione all’opera Perspectiva communis, f.a. 2 di John Peckham (1225-1292), che presenta il metodo scientifico, sia induttivo che deduttivo utilizzato dalle Scuole. La scienza del fenomeno fisico della luce si deduce da dimostrazioni matematiche che devono trovare una verifica. Ma il rapportare cielo e terra
79
c ertezza della dimostrazione innalza più preclaramente l’ingegni dell’investiganti. La prospettiva dunque è da essere preposta a tutte le traduzioni e discipline umane, nel campo della quale la linia radiosa complicata dà e modi delle dimostrazioni, innella quale si truova la groria6 non tanto de la matematica quanto della fisica, ornata co’ fiori dell’una e dell’altra, le sententie della quale, distese con gran circuizioni, io le ristringerò in conclusiva brevità, intessendo, secondo il modo della materia, naturale e matematiche dimostrazioni, alcuna volta conchiudendo li effetti per le cagioni, e alcuna volta le cagioni per li effetti, aggiungendo ancora alle mie conclusioni alcuna che non sono in quelle, non di meno di quelle si traggano, come si degnerà o Signore, luce d’ogni cosa, illustrare me trattatore della luce, el quale partirò la presente opera in tre parti. [Atl. 543, ex 207 r] Il pittore che ritrae per pratica e giudizio d’occhio, sanza ragione, è come lo specchio, che in sé imita tutte le a sé contra poste cose, sanza cognizione7 d’esse. [Atl. 207 r, ex 76 r.a]
doveva innalzare lo studioso al mondo metafisico che era rappresentato proprio dalla luce, considerata come emanazione divina. 6. groria = gloria, vittoria, risultato. Lo scambio delle lettere r e l è un toscanismo, cfr. Marinoni(1974), p. 39. 7. cognizione = conoscenza. Leonardo arriva a distinguere tra riflessione, imitazione passiva da parte del pittore dei fenomeni naturali, e capacità di andare oltre la superficie, di comprenderne la causa o ragione.
80
Proemio8. È da essere giudicati e non altrementi stimati li omini inventori e ‘nterpreti tra la natura e gli uomini, a comparazione de’ recitatori e trombetti9 delle altrui opere, quant’è dall’obbietto fori dello specchio alla similitudine d’esso obbietto apparente nello specchio, che l’uno per sé è qualche cosa, e l’altro è niente. Gente poco obrigate10 alla natura, perché sono sol d’accidental vestiti, e sanza il quale potrei accompagnarli in fra li armenti delle bestie. [Atl. 323 r, ex 117 r.b] Leggimi lettore11, se ti diletti di me, perché son rarissime volte rinata12 al mondo, perché la pazienzia di tale professione si trova in pochi che voglino di novo ricomporre simile cose di 8. Una delle tante introduzioni, o proemi, che Leonardo tenta di premettere retoricamente alle sue analisi e ricerche, nessuna dei quali concluse, come sottolinea Marinoni (1974), pp. 147-154. 9. trombetti = trombettieri (militare), annunciatori, banditori; quindi nel senso di semplici ripetitori. 10. obrigate = obbligate, rispettose. 11. Proemio evidentemente di un testo scritto, mentre in altre presentazioni poteva trattarsi della preparazione di discorsi da tenere in occasioni di dibattiti con dotti e artisti alla corte del Moro. A. Marinoni, La biblioteca di Leonardo, in “Raccolta vinciana”, 1987, p. 321, ritiene, data la collocazione del testo al margine di una pagina con disegni del conflitto tra acqua e terra per il baricentro del mondo e studi di meccanica, che si tratti dell’introduzione ad un progettato trattato di “scientia de ponderibus”, e non del Trattato di pittura. Rimane in ogni caso un chiaro tentativo di dare una forma sistematica alle sue ricerche. 12. Il Rinascimento delle concezioni antiche era un tema presente in molti autori del tempo, prima ancora di diventare una categoria storiografica nell’Ottocento. Ricordiamo innanzitutto la lettera dedicatoria a Filippo Brunelleschi di L.B. Alberti, Della pittura, (a cura di L. Mallè, Firenze 1950), di cui Leonardo possedeva il manoscritto. Alberti parla della professione di pittore come una attività rinata, in quanto erano ben pochi i riferimenti antichi rimasti, e la prospettiva di Masaccio era una conquista recente. La
81
novo. E venite, o omini, a vedere i miracoli13 che per questi tali studi si scopre nella natura. [Madrid I, 6 r] Scienza è detto quel discorso mentale il qual ha origine da’ suoi ultimi principi, de’ quali in natura null’altra cosa si può trovare che sia parte di essa scienza, come nella quantità continua, cioè la scienza di geometria, la quale, cominciando dalla superficie de’ corpi, si trova da avere origine nella linea, termine d’essa superficie. E in questo non restiamo, perché conosciamo la linea aver termine nel punto ed il punto esser quello del quale null’altra cosa può essere minore. [LP. 1; TP. I, par. 1] Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie; e questo è quanto a quello che si finge, cioè esso corpo che si finge, perché invero la pittura non si estende più oltre che la superficie per la quale si finge il corpo figura di qualunque cosa evidente. [LP. 3; TP. I, par. 41] La pittura sol si estende nella superficie de’ corpi, e la sua prospettiva si estende nell’accrescimento e decrescimento de’
conoscenza di come ricomporre la visione in un insieme era perciò nuova, e la pittura attività nobile e rara. 13. miracoli = meraviglie. L.B. Alberti, Della pittura (p. 72) parla dei miracoli che si possono ottenere attraverso la prospettiva artificiale, creando illusioni ottiche. Magia naturale o “scienza dei miracoli” era chiamata l’ottica ancora alla fine del Cinquecento.
82
corpi e de’ loro colori; perché la cosa che si rimuove dall’occhio perde tanto di grandezza e di colore quanto ne acquista di remozione14. Adunque la pittura è filosofia, perché la filosofia tratta del moto aumentativo e diminutivo15, il quale si trova nella sopradetta proposizione; della quale faremo il converso e diremo: la cosa veduta dall’occhio acquista tanto di grandezza e notizia e colore, quanto ella diminuisce lo spazio interposto infra essa e l’occhio che la vede. Chi biasima la pittura biasima la natura, perché le opere del pittore rappresentano le opere di essa natura e per questo il detto biasimatore ha carestia16 di sentimento. Si prova la pittura essere filosofia perché essa tratta del moto dei corpi nella prontitudine17 delle loro azioni, e la filosofia ancora lei si estende nel moto. Tutte le scienze che finiscono in parole hanno sì presto morte come vita, eccetto la sua parte manuale, cioè lo scrivere18, ch’è arte meccanica. [L P. 9; TP. I, par. 5] La pittura rappresenta al senso con più verità e certezza le opere di natura, che non fanno le parole e le lettere, ma le let14. remozione = lontananza, allontanamento. 15. Secondo la gerarchia delle scienze di Aristotele, la filosofia che tratta dell’aumento e diminuizione del movimento è la Fisica, scienza teoretica. La pittura è quindi conoscenza filosofica. Questa rivendicazione della sua posizione di pittore-filosofo caratterizza il trattato di Leonardo, rispetto alle raccolte precedenti, come quelli del Cennini o del Ghiberti, incentrate invece su consigli pratici e di bottega. 16. carestia = mancanza, povertà, miseria. 17. prontitudine = immediatezza. 18. La tecnica della scrittura è meccanica in quanto ha come strumenti penna e calamaio, ed è equiparata al disegno in quanto usa segni grafici. La natura pittografica del linguaggio poteva essere testimoniata dai geroglifici, il cui utilizzo e interpretazione stava diventando una moda diffusa nel Rinascimento, ma anche la stessa notazione musicale, inventata nel Medioevo, così come la nuova geometria proiettiva.
83
tere rappresentano con più verità le parole al senso, che non fa la pittura. Ma dicemmo essere più mirabile quella scienza19 che rappresenta le opere di natura, che quella che rappresenta le opere dell’operatore, cioè le opere degli uomini, che sono le parole, com’è la poesia, e simili, che passano per la umana lingua. [LP. 10; TP. I, par. 6] Se tu sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: mare, siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte di ombra e di luci. E veramente questa è scienza e legittima figlia di natura, perché la pittura è partorita da essa natura; ma per dir più corretto, diremo nipote di natura, perché tutte le cose evidenti sono state partorite dalla natura, dalle quali cose è nata la pittura. Adunque rettamente la chiameremo nipota d’essa natura e parente20 d’Iddio. [LP. 12; TP. I, par. 8]
19. Anche la poesia è scienza produttiva, poietica, secondo Aristotele. Ma Leonardo pone la pittura più in alto, più mirabile, in quanto si riferisce direttamente alla natura e quindi è scienza fisica, cioè filosofia teoretica. 20. In quanto la natura è creazione di Dio, il pittore compie un atto creativo, o meglio ricreativo, a somiglianza con quello divino. Perciò la pittura è una forma di conoscenza che avvicina l’uomo a Dio, secondo diffuse tesi ermetiche, come in Dante, Inferno XI, 103-105. Leonardo cita Ermete filosafo (M. interno di copertina) di cui conosceva la traduzione volgare di Tommaso Benci, Pimander, Treviso 1474. Inoltre poteva aver sentito le discussioni dell’epoca a Firenze, dopo la pubblicazione nel 1471 del Corpus Hermeticum, tradotto da Marsilio Ficino, che riteneva erroneamente Ermete Trimegisto contemporaneo di Platone, e tutti e due allievi di Mosè, dunque una antichissima e originaria sapienza profetica.
84
Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero dell’uomo, perciocché s’egli ha desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è signore di generarle, e se vuol vedere cose mostruose che spaventino, o che sieno buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, ei n’è signore e creatore. E se vuol generare siti deserti, luoghi ombrosi e freschi n’tempi caldi, esso li figura, e così luoghi caldi ne’ tempi freddi. Se vuol valli il simile; se vuole dalle alte cime dei monti scoprire gran campagna, e se vuole dopo quelle vedere l’orizzonte del mare, egli n’è signore; e così pure dalle basse valli vuol vedere gli alti monti, o dagli alti monti le basse valli e spiagge21. Ed in effetto ciò che è nell’universo per essenza, presenza o immaginazione, esso lo ha prima nella mente, e poi nelle mani, e quelle sono di tanta eccellenza, che in pari tempo generano una proporzionata armonia22 in un solo sguardo qual fanno le cose. [LP. 13; TP. I, par. 9] La pittura serve a più degno senso23 che la poesia, e fa con più verità le figure delle opere di natura che il poeta, e sono molto 21. Sembra una ripetizione, ma il traguardare i monti dal basso e le pianure dall’alto era necessario per la cosmografia che Leonardo cita tra le attività prospettiche e che ha applicato per le sue imprese militari, dalla valle dell’Isonzo in Friuli, alla Romagna al servizio di Cesare Borgia, fino ai magnifici disegni della valle dell’Arno. 22. L’immagine mentale viene disegnata dalle mani, e in questa attività la pittura si trasforma in filosofia. L’armonia determinata dalla proporzione delle figure e dell’insieme della rappresentazione è da considerarsi l’ideale della pittura leonardiana, in quanto unifica quantità e forme qualitative, luci ed ombre, ed è l’essenza della bellezza, che dà vita ad una cosa morta come la pittura. 23. È il famoso Paragone delle Arti, che circolava tra gli artisti del Cinquecento. Il paragone tra poesia e pittura precede quello con la scultura e la musica. La superiorità della pittura si fonda sulla vista, che è il senso più
85
più degne le opere di natura che le parole, che sono opere dell’uomo; perché tal proporzione è delle opere degli uomini a quelle della natura, qual è quella ch’è dall’uomo a Dio. Adunque è più degna cosa l’imitar le cose di natura, che sono le vere similitudini in fatto, che con parole imitare i fatti e le parole degli uomini. E se tu, poeta, vuoi descrivere le opere di natura colla tua semplice professione, fingendo siti diversi e forme di varie cose, tu sei superato dal pittore con infinita proporzione di potenza… il pittore per sé senza aiuto di scienza o d’altri mezzi va immediate24 alla imitazione di esse opere di natura. Con questa si move li amanti inverso li simulacri della cosa amata a parlare con le imitate pitture25; con questa si move li populi con infervorati voti a ricercare li simulacri delli iddii; e non a vedere le opere de’ poeti, che con parole figurino i medesimi iddii. Con questa s’ingannano gli animali: già vid’io una pittura che ingannava il cane mediante la similitudine del suo padrone, alla quale esso cane facea grandissima festa; e similmente ho visto i cani abbaiare e voler mordere i cani dipinti; ed una scimmia fare infinite pazzie contro ad un’altra scimmia dipinta. Ho veduto la rondine volare a posarsi sopra
nobile rispetto all’udito, odorato, gusto e tatto; questa gerarchia dei sensi risale ad Aristotele, e si trova in molti riferimenti medievali e umanistici, in particolare Marsilio Ficino, Sopra lo amore (1474), esposizione in volgare del Simposio di Platone. 24. immediate = subito, (lat.) immediatamente, ma qui con il significato di direttamente, senza intermediazioni. Il disegno viene compreso senza bisogno di parole, che fanno da schermo alla mente. 25. Boccaccio, Decamerone, Sesta giornata, Novella Quinta, parla di Giotto, capace di disegnare e dipingere ogni cosa della natura, imitandola al punto che “il visivo senso degli uomini vi prese errore, quello credendo esser vero che era dipinto”. Si veda al proposito anche la nota 27.
86
i ferri dipinti che sportano26 fuori dalle finestre degli edifizi; tutte operazioni del pittore meravigliosissime27. [LP. 14; TP. I, par. 10] Maggior danno ricevono gli animali per la perdita del vedere che dell’udire, per più cagioni; e prima, che mediante il vedere il cibo è ritrovato, donde si deve nutrire, il quale è necessario a tutti gli animali. Il secondo, che per il vedere si comprende il bello delle cose create, massime delle cose che inducono all’amore, nel quale il cieco nato non può pigliare per l’udito, perché mai non ebbe notizia che cosa fosse bellezza di alcuna cosa. Restagli l’udito per il quale solo intende le voci e parlare umano, nel quale sono i nomi di tutte le cose, a cui è dato il proprio nome: senza la saputa di essi nomi, ben si può vivere lieto28, come si vede ne’ sordi nati, cioè i muti, mediante il disegno del quale il più dei muti si dilettano. E se tu dirai che il vedere impedisce la fissa e sottile cognizione mentale, con la quale si penetra nelle divine scienze, e tale impedimento condusse un filosofo a privarsi del vedere29, a 26. sportano = sporgono. 27. Plinio, Naturalis Historia, XXXVI, 65-66, descrive effetti pittorici che ingannano gli uccelli e, soprattutto, racconta di Apelle (XXXVI, 95) che dipinse un cavallo per una gara pittorica e fece passare molti cavalli davanti ai quadri in mostra: davanti al suo tutti i cavalli nitrivano riconoscendo il soggetto dipinto, e vinse così la gara. Leonardo per tutta la vita ha osservato con grande attenzione cavalli e uccelli e altri animali, di cui abbiamo molti disegni e studi. 28. La conoscenza dei nomi non è necessaria al vivere felice, affermazione che mette in evidenza la concezione del linguaggio come opera dell’uomo, una svalutazione dei “discorsi” che si aggiunge alle considerazioni sulla superiorità della pittura sulla poesia. 29. L’aneddoto di un filosofo che giunge ad accecarsi per proteggere il pensiero dalle sensazioni esterne e potersi rivolgere agli intelligibili nella propria interiorità, si riferisce tradizionalmente a Democrito. Anche se Plu-
87
questo rispondo, che tal occhio come signore de’ sensi fa il suo debito a dare impedimento ai confusi e bugiardi, non scienze, ma discorsi, per i quali sempre con gran gridore e menar di mani si disputa; ed il medesimo dovrebbe fare l’udito, il quale ne rimane più offeso, perché egli vorrebbe accordo, del quale tutti i sensi s’intricano. E se tale filosofo si trasse gli occhi per levare l’impedimento a’ suoi discorsi, or pensa che tale atto fu compagno del cervello e de’ discorsi, perché il tutto fu pazzia: or non potea egli serrarsi gli occhi, quando entrava in tale frenesia e tanto tenerli serrati che tal furore si consumasse? Ma pazzo fu l’uomo, e pazzo il discorso, e stoltissimo il trarsi gli occhi. [LP. 16; TP. I, par. 12] Nessuna parte è nell’astrologia30, che non sia uffizio delle linee visuali e della prospettiva, figliola della pittura; perché il pittore è quello che per la necessità della sua arte ha partorito31 essa prospettiva, e non si può fare per sé senza linee, dentro
tarco considerava falso l’aneddoto, il racconto ebbe molte riprese, tra cui Petrarca, Trionfo della fama, vv. 75-78: “e Democrito andar tutto pensoso/ per suo voler di lume e d’oro casso”, aggiungendo la tradizione che il filosofo di Abdera aveva rinunciato alle sue proprietà per poter viaggiare. 30. L’astrologia matematica che misura le distanze e le orbite dei pianeti, cioè l’astronomia. Nel paragrafo 25 del Trattato della Pittura aggiunge non della fallace giudiciale, perdonimi chi per mezzo degli sciocchi ne vive. L’astrologia giudiziaria (giudiciale) era quella dei pronostici individuali e delle previsioni annuali dei grandi cambiamenti di regni, pestilenze, terremoti, nonché di religioni, che sconfinava spesso all’epoca e si confondeva con le ricorrenti profezie apocalittiche di fine del mondo, di distruzioni col fuoco o con un nuovo Diluvio Universale. 31. partorito = generato, creato, inventato (figurativamente). Oltre che una rivendicazione storica della scoperta della prospettiva, è innanzitutto il motivo principale per cui Leonardo pone la pittura tra le scienze, in quanto l’astronomia era compresa nel Quadrivio medievale, assieme alla geometria,
88
alle quali linee s’inchiudono tutte le varie figure de’ corpi generati dalla natura, e senza le quali l’arte del geometra è orba. E se il geometra riduce ogni superficie circondata da linee alla figura del quadrato, ed ogni corpo alla figura del cubo; e se l’aritmetica fa il simile con le sue radici cube e quadrate; queste due scienze non si estendono se non alla notizia della quantità continua e discontinua, ma della qualità32 non si travagliano, la quale è bellezza delle opere di natura ed ornamento del mondo. [LP. 17; TP. I, par. 13] Noi per arte possiamo esser detti nipoti a Dio. Se la poesia s’estende in filosofia morale, e questa33 in filosofia naturale; se quella descrive le operazioni della mente che considera quella, se la mente opera nei movimenti; se quella spaventa i popoli colle infernali finzioni, questa con le medesime cose in atto fa il simile. Pongasi il poeta a figurare una bellezza, una fierezza una cosa nefanda e brutta, una mostruosa, col pittore; faccia a suo modo come vuole trasmutazioni di forme, che il pittore non satisfaccia più. Non s’è egli visto pitture avere avuto tanta conformità con la cosa imitata, che hanno ingannato uomini ed animali? [LP. 19; TP. I, par. 15]
all’aritmetica e alla musica: se l’ottica è parte dell’astronomia (e per gli arabi lo era) la prospettiva può essere equiparata alla geometria e all’aritmetica. 32. La pittura si interessa della qualità e non solo della misura, delle forme che corrispondono alla bellezza, che è la manifestazione dell’anima. 33. Cioè la pittura, di nuovo messa a confronto con la poesia, che rimane sempre su un piano di inferiorità, rispetto alla gerarchia aristotelica tra il grado di certezza e verità della filosofia fisica (teoretica) ed etica (pratica).
89
Il colore che si trova infra la parte ombrosa e alluminata de’ corpi ombrosi, fia di minor bellezza che quello che fu integralmente alluminato. Adunque la prima bellezza de’ colori fia ne’ principali lumi34. [Madrid II, 26 r] I lumi de’ lumi, cioè il lustro35 di qualunque cosa, non sarà situato nel mezzo della parte alluminata, anzi farà tante mutazioni quanto farà l’occhio riguardante di quello. [H 90 v] Nessun corpo si può comprendere sanza lume ed ombra. Lume ed ombra è causata dalla luce36. [Atl. 245 r, ex 90 r.b]
34. Chastel (1974) pp. 222-24, ha evidenziato la corrispondenza con analogo brano del Trattato della pittura, trascritto con altri quattordici passi da Francesco Melzi. 35. lustro = splendore, dovuto al rispecchiamento della luce. E.H. Gombrich, L’eredità di Apelle, Milano 2004, p. 31, ritiene che la distinzione tra lume, o illuminazione, e lustro sia stata introdotta dai fiamminghi e che Leonardo l’abbia applicata dalle prime sue opere, come la “Ginevra Benci” e la “Vergine delle rocce”. In base alle diverse prospettive di chi guarda, il lustro presenta cambiamenti di luce, mutazioni. 36. Dunque il lume dipende dalla luce ma coinvolge l’oggetto illuminato che è parzialmente ombroso. Osservazioni apparentemente banali portano Leonardo a concepire che anche l’ombra abbia un lume parziale e che tra luce e ombra non vi sia uno stacco così netto. È nota la tendenza di Leonardo, nelle opere pittoriche più tarde, ad applicare questo principio fondato sulle esperienze di osservazione naturalistica. Infatti sono anche alla base della sua scoperta astronomica che il lumen cinereum, la mezzombra sulla faccia della luna, è determinato da una luminosità riflessa della terra, che risulta più scuro per la parte vicina alla falce in piena luce solare e più chiara dalla parte oscura del cielo, una illusione ottica annotata nel Codice Leicester, f. 2 r.
90
Ogni corpo fa concorso di razzi, empie la circostante aria d’infinite sue similitudine. Concorso ombroso e luminoso è quella somma de’ razzi che da corpo ombroso e luminoso si partano, scorrendo per l’arie sanza percussione. Percussione ombrosa e luminosa è quel loco che impedisce e sopra sé taglia ilo concorso de’ razzi ombrosi e luminosi37… E quella qualità del corpo meglio fia conosciuta, della quale l’occhio di quella risguardatore sarà contra posto alla divisione delle parti ombrose dalle luminose. Ma se l’occhio sarà al centro del lume primitivo o dell’ombra dirivativa, conoscerà la vera qualità del corpo d’ombra vestito. [Atl. 320 r, ex 116 r.b] L’occhio, vero mezzo infra l’obietto e l’impressiva, il quale immediate conferisce con somma verità le vere superficie e figure di quel che dinanzi se gli rappresenta, dalle quali ne nasce la proporzionalità detta armonia, che con dolce concento38 contenta il senso, non altrimenti che si facciano le proporzionalità di diverse voci al senso dell’udito; il quale ancora è men degno che quello dell’occhio, perché tanto quanto ne nasce, tanto ne muore; ed è sì veloce nel morire quanto nel nascere. [LP. 23; TP. I, par. 19]
37. Il brano è scritto in una colonna centrale mentre il proseguio è nella colonna parallela sinistra, con frasi abbozzate e parole abbreviate, che qui vengono proposte secondo l’integrazione fatta da Marinoni. In basso un elenco di varianti del disegno di lumi sui corpi e Natura de’ termini dell’ombre primitive e dirivative. 38. concento = concerto, insieme piacevole, dolce; con l’esempio successivo, coro di voci, armonioso.
91
Come l’occhio e il razzo del sole e la mente sono i più veloce moti che sieno- Il sole, immediate che li appare nell’oriente, subito, discorre co’ li sua radi39 a l’occidente, i quali sono composti di tre potenzie spirituali: splendore, calore, e la spezie della forma della loro cagione. L’occhio, subito ch’è aperto, vede tutte le stelle del nostro emisperio40. La mente salta ‘n uno attimo dall’oriente all’occidente, e tutte l’altre41 cose spirituali sono di gran lunga dissimile per velocità a queste. L’occhio riserva in sé le immagine delle cose luminose che se li rappresentano. [Atl. 545 v, ex 204 v.a] Dell’occhio. L’occhio, dal quale la bellezza dell’universo è specchiata dai contemplanti, è di tanta eccellenza, che chi consente alla sua perdita si priva della rappresentazione di tutte le opere della natura, per la veduta delle quali l’anima sta contenta nelle umane carceri42, mediante gli occhi, per i quali l’anima si rappresenta tutte le varie cose di natura. (…) la bellezza del mondo, la quale consiste nella superficie dei corpi, sì accidentali come naturali, i quali si riflettono nell’occhio umano. [LP. 24; TP. I, par. 20]
39. radi = raggi. 40. emisperio = emisfero. 41. Marinoni (1974) integra il testo introducendo una [r]: “altre ci convince più che alte del ms.”, nota 1, pag. 64. 42. Il corpo come carcere dell’anima è teoria orfica ripresa da Platone e dal cristianesimo. Ma che la visione delle bellezze naturali faccia accontentare l’anima della vita, sottolinea la funzione dell’occhio, posto retoricamente come solo contrappeso a ciò che nel brano non riportato (…) viene drammaticamente posta come una condizione totalmente negativa, riassunta nel brano che segue con il termine tormento.
92
Or non vedi tu che l’occhio abbraccia la bellezza di tutto il mondo? (…) Questo è finestra dell’umano corpo, per la quale la sua via specula, e fruisce la bellezza del mondo: per questo l’anima si contenta dell’umana carcere43, e senza questo essa umana carcere è suo tormento; e per questo l’industria umana ha trovato il fuoco, mediante il quale l’occhio riacquista quello che prima gli tolsero le tenebre. Questo ha ornato la natura coll’agricoltura e dilettevoli giardini… questo ha trovato la navigazione, ed in questo supera la natura, perché i semplici naturali sono finiti, e le opere che l’occhio comanda alle mani sono infinite, come dimostra il pittore nelle finzioni d’infinite forme di animali ed erbe piante e siti. [LP. 28; TP. I, par. 24] Non po essere bellezza e utilità, come appare nelle fortezze e nelli omini44. Il trotto è quasi di cavallo libero. Dove manca la vivacità naturale, bisogna farne una accidentale. [Atl. 380 r, ex 138 r.b]
43. Vedi la nota precedente. In questo paragrafo il brano soppresso propone un’esaltazione della funzione conoscitiva dell’occhio che consiglia e corregge tutte le arti, e che ha generata la pittura e la prospettiva matematica. 44. Si è proposto di introdurre un punto di domanda, quasi che Leonardo volesse sostenere l’identità di bellezza e utilità. Ma qui si tratta, come evidente dal seguito, del progetto di monumento equestre a Francesco Sforza, e un cavallo al trotto, che evidentemente era il più bello per l’artista, non rappresentava una cavalcatura utile, cioè addestrata e guidata dal cavaliere, per cui riteneva necessario introdurre un artificio per rappresentare la vivacità naturale dell’animale. Tra i disegni preparatori si trovano infatti cavalli impennati, trattenuti per le briglie mentre agitano le zampe anteriori.
93
Prospettiva45. L’aria è piena d’infinite similitudine delle cose, le quali infra quella sono strebuite46, e tutte si rappresentano in tutte e tutte in ciascuna (e tutte in una). Onde accade che se saranno 2 specchi volti in modo che per linia retta si sguardino l’uno l’altro, il primo si specchierà nel secondo e ‘l secondo nel primo. Il primo che si specchia nel secondo, porta con seco la similitudine di sé con tutta le similitudini che dentro vi si rappresentano; infra le quale è la spezie del secondo specchio, e così di similitudine in similitudine se ne vanno in infinito, in modo che ciascuno specchio ha dentro infiniti specchi, l’uno minore dell’altro, e dentro l’uno all’altro. [Atl. 380 r, ex 138 r.b] Ciò che non ha termine47 non ha figura alcuna. I termini di 2 corpi insieme congiunti sono scambievolmente superficie l’uno dell’altro, come l’acqua coll’aria. [Arundel 132 r] L’aria, subito che s’allumina, s’empie d’infinite spezie, delle quali l’occhio si fa calamita. [Atl. 303 v, ex 109 v.a]
45. Titolo posto da Leonardo. Marinoni annota che “in realtà si tratta di ottica”. Il lungo brano prosegue infatti con considerazioni sull’occhio, l’aria, la luce del sole e ripropone anche l’esperimento, nel brano qui riportato in riferimento a due specchi contrapposti, con molti specchi posti in circolo, visti da un punto centrale. 46. strebuite = distribuite. 47. termine = limite. L’infinità spaziale non dà nessuna figura e quindi è inconoscibile. E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Firenze 1935, p. 248: “Leonardo anche come investigatore, non si diparte da questa visibilità e concepibilità della forma… I limiti del vedere sono quindi, per lui, necessariamente anche i limiti del concepire”.
94
Il corpo dell’aria è pieno d’infinite piramide radiose, causate da la cosa posta in essa, le quali intersegate e intessute sanza occupazione l’una dell’altra, con disgregante concorso s’infondano per tutta la circostante aria, e sono d’equale potenza e tutte possano quanto ciascuna, e ciascuna quanto tutte; e per esse la similitudine del corpo è portato tutto per tutto e tutto in ne la parte, e ciascuna per sé riceve in ogni minima parte tutta la sua cagione. [Atl. 278 r, ex 101 v b] Tutte le spezie delle cose all’occhio antiposte concorrano per linie radiose alla superficie di tale occhio, le quali si tagliano nella superficie di tale occhio infra equali angoli. L’aria è tutta per tutto e tutta in ogni parte di quella, piena delle similitudine de’ corpi che in lei s’includano48. [Atl. 331 r, ex 120 r.d] Adunque l’occhio manda infra l’aria la sua similitudine a tutti li obietti che li sono opposti e in sé li riceve, cioè in su la sua superficie, donde il senso comune le piglia e le considera, e quelle che piacciono le manda a memoria. Onde io giudico che la virtù spirituale delle spezie degli occhi si faccino incontro all’obbietto come le spezie dell’obietto all’occhio. [Atl. 380 r, ex 138 r.b] Sommo difetto è ne’ maestri, i quali usano replicare i medesimi moti nelle medesime istorie vicini l’uno all’altro, e simil48. La visione di ogni corpo nella sua similitudine, o spezie, in ogni direzione e prospettiva fa pensare a Leonardo alla concezione di Anassagora, piuttosto che alla tradizione che risaliva ad Empedocle del simile col simile.
95
mente le bellezze de’ visi essere sempre una medesima, le quali in natura mai si trova essere replicate, in modo che, se tutte le bellezze di eguale eccellenza ritornassero vive, esse sarebbero maggior numero di popolo che quello che al nostro secolo si trova, e siccome in esso secolo nessuno precisamente si somiglia, il medesimo interverrebbe nelle dette bellezze. [LP. 107; TP. II, par. 104] Sommo difetto è de’ pittori replicare li medesimi moti e medesimi volti e maniere di panni in una medesima istoria, e fare la maggiore parte de’ volti che somigliano al loro maestro49, la qual cosa m’ha molte volte dato admirazione50 perché n’ho conosciuti alcuni che in tutte le sue figure pare avervisi ritratto al naturale; et in quelle si vede li atti e li moti del loro fattore, e s’egli è pronto nel parlare e ne’ moti, le sue figure sono il simile in prontitudine; e se ‘l maestro è da poco, le sue figure paiono la pigrizia ritratta al naturale; e se ‘l maestro è sproporzionato, le figure sue son simili; e s’egli è pazzo, nelle sue istorie si dimostra largamente, le quali sono nimiche di conclusione, e non stanno attente alle loro operazioni, anzi, chi guarda in qua, e chi in là come se sognassino; e così segueno ciascun accidente in pittura il proprio accidente del pittore. E avendo io più volte considerato la causa di tal difetto, mi pare che sia da giudicare che quell’anima che regge e governa ciascun corpo si è quella che fa il nostro giudizio inanti sia il proprio giudizio nostro. Adonque ella ha condotto tutta la
49. Alla critica dei pittori che sanno dipingere bene solo poche figure, che replicano in tutti i dipinti, segue una più articolata critica alla soggettività dell’artista che reputa bello ciò che è somigliante a se stesso, e perciò riprodotto continuamente, quasi vicino all’idea stessa di Bellezza, mentre la natura presenta una enorme varietà di bellezze. 50. admirazione = ammirazione, stupore.
96
figura de l’omo, com’ella ha giudicato quello stare bene, o col naso longo, o corto, o camuso, e così li affermò la sua altezza e figura. Et è di tanta potenzia questo tal giudizio, ch’egli move le braccia la pittore e fagli replicare sé medesimo, parendo a essa anima che quello sia il vero modo di figurare l’omo, e chi non fa come lei faccia errore. E s’ella trova alcuno che simigli al suo corpo, ch’ella ha composto, ella l’ama, e s’innamora spesso di quello. E per questo molti se innamorano e toglian51 moglie che simiglia a lui, e spesso li figlioli che nascono di tali somigliano ai loro genitori. [LP. 108; TP. II, par. 105] Il buon pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l’uomo ed il concetto della mente sua. Il primo è facile, il secondo difficile, perché si ha a figurare con gesti e movimenti delle membra: e questo è da essere imparato dai muti, che meglio li fanno che alcun’altra sorta d’uomini52. [LP. 179; TP. II, par. 176] Quel movimento ch’è finto essere appropriato all’accidente mentale, ch’è nella figura, dev’esser fatto di gran prontitudine, e che mostri in essa grande affezione e fervore; altrimenti tal figura sarà detta due volte morta, com’è morta perché essa è 51. toglian = tolgono, prendono. Proverbiale: prendere moglie. 52. Aforisma riferibile al Cenacolo di Santa Maria delle Grazie di Milano, alle figure degli apostoli con atteggiamenti tutti diversi, non solo del viso ma anche delle mani e della postura, per rappresentare il concetto mentale, ciò che vogliono esprimere con il movimento più semplice, come fanno i muti. Come suggerisce la Poetica di Aristotele a proposito dell’azione tragica, il dramma si rivela nell’esatto momento in cui gli Apostoli, colpiti dalle parole terribili di Gesù sul prossimo tradimento, entrano in agitazione, irati, sorpresi, amareggiati o pronti a giurare la propria innocenza.
97
finta53, e morta un’altra volta quando essa non dimostra moto né di mente né di corpo. [LP. 297; TP. III, par. 293] Tutte le membra di qualunche animale sien corrispondenti alla sua età, cioè che il giovane non mostri vene o nervi, come li più fan per mostrare acume d’arte, guastando il tutto mediante le scambiate membra. Li moti delli omini sieno qual richiede la sua degnità o viltà. [Atl. 949 v, ex 345 v b] Li omeni e le parole sono fatti e tu, pittore, non sapiendo operare le tue figure, tu se’ come l’oratore che non sa adoperare le parole sue. [K 110 v] Ecci un’altra prospettiva, la quale chiamo aerea54 imperò che per la varietà dell’aria si può conoscere le diverse distanzie di vari edifici terminati ne’ loro nascimenti da una sola linea, come sarebbe il vedere molti edifici di là da un muro che tutti appariscono sopra alla stremità di detto muro d’una medesima
53. La pittura è finzione perché allo spazio prospettico si aggiungono figure che imitano la realtà, ma sono morte, e solo la prontezza, l’immediatezza del moto, le fa apparire vive. La figura deve essere colta nell’attimo in cui manifesta il sentimento che le è proprio. 54. Ecci = c’è. Ai tre tipi di prospettiva, lineare, di colore e di “spedizione” (quanto più gli oggetti sono lontani tanto meno sono definiti) Leonardo aggiunge la prospettiva aerea, cioè determinata da una maggiore o minore limpidità dell’aria.
98
grandezza, e che tu volessi in pittura fare parere più lontano l’uno che l’altro; è da figurare un’aria un poco grossa. [LP. 262; TP. II, par. 258] Esperienza mostra come l’aria à dopo sé tenebre, e però pare azzurra. [Leic. Carta 1B, f. 36 r] Dico l’azzurro in che si mostra l’aria non essere suo proprio colore, ma è causato da umidità calda55, vaporata in minutissimi e insensibili attimi, la quale piglia dopo sé la percussion de’ razzi solari e fassi luminosa sotto la oscurità delle immense tenebre della regione del fuoco, che di sopra le fa coperchio. E questo vedrà, come vidi io, chi andrà sopra Mon Boso56, giogo delle Alpi che dividano la Francia dalla Italia, la qual montagnia ha la sua basa che partorisce li 4 fiumi che riga per 55. Il colore dipende dalla rifrazione della luce. La prospettiva che rende agli oggetti lontani una colorazione azzurrina, in riferimento alla maggiore o minore lontananza, viene fondata sull’osservazione che l’azzurro del cielo è dato dal mescolamento con le particelle d’acqua in sospensione. La concezione della tenebrosità dell’aria a grandi altezze andava a confermare la concezione aristotelica dei luoghi naturali dei quattro elementi per cui, più ci si avvicinava alla sfera del fuoco, più aumentavano le tenebre, dove si manifestavano i fenomeni degli incendi celesti e delle comete. 56. Mon Boso era la denominazione del Monte Rosa (m. 4600). Leandro Alberti, Descritione di tutta Italia, Venezia 1588, sostiene che li 4 fiumi comprendono Rodano, Reno, Danubio e Po; cfr. Solmi (2006, p. 300-1). Le sorgenti del gruppo montuoso del San Gottardo, in Svizzera, riguardano in realtà il Ticino e l’Inn, affluente del Danubio, oltre al Rodano e al Reno. La notizia sul ghiacciaio perenne del Rosa come dovuto a grandine ha fatto ritenere che Leonardo sia salito oltre i 3000 metri, per una verifica basata su fatti di ipotesi naturalistiche. La regione del fuoco che sta sopra il cielo, era concezione presocratica ed è alla base della famosa lode (lalda) del sole (F. 5 r).
99
4 aspetti contrari tutta l’Europa, e nessuna montagnia ha sue base in simile altezza. Questa si leva in tanta altura che quasi passa tutti li nuvoli e rare volte vi cade la neve, ma sol grandine di state, quando li nuvoli sono nella maggiore altezza. [Leic. Carta 4A, f. 4 r] Ordine del libro57. Questa mia figurazione del corpo umano ti sarà dimostra non altrementi che se tu avessi l’omo naturale innanzi. E la ragione sie che se tu vuoi bene conoscere le parti dell’omo natomizzato tu lo volti, o lui o l’occhio tuo, per diverso aspetto, quello considerando di sotto e di sopra e dalli lati voltandolo cercando l’origine di ciascun membro. E in tal modo la notomia naturale t’ha soddisfatto alla tua notizia. Ma tu hai a intendere che tal notizia non ti lascia soddisfatto. Con ciò sia che la grandissima confusione che resulta della mistione di panniculi misti con vene, arterie, nervi, corde, muscoli, ossi, sangue, il quale tigne di sé ogni parte d’un medesimo colore, e le vene che di tal sangue si vòtano non sono conosciute per la lor diminuzione; e la integrità delli panniculi nel cercare le parte che dentro a loro s’includano, si vengono a rompere e la lor trasparenza tinta di sangue non ti lascia conoscere le parte coperte da loro per la similitudine del lor colore insanguinato, e non poi avere notizia dell’un che tu non confonda e destrugga l’altro. Adunque è necessario fare più natomie, delle quali tre te ne bisogna per avere piena notizia delle vene e arterie, destruggendo con somma diligenza tutto il rimanente; e altre tre per avere la notizia delli panniculi; e tre per le corde e muscoli e legamenti; e tre per la notomia delle ossa… E tre te ne bisogna fare per la donna, nella quale è gran misterio mediante la matrice e suo feto. Adunque per il mio disegno ti fia 57. Il testo accompagnava i disegni anatomici conservati a Windsor; è dunque un libro illustrato.
100
noto ogni parte e ogni tutto mediante la dimostrazione di tre diversi aspetti di ciascuna parte… Adunque qui, con quindici figure58 intere, ti sarà mostro la cosmografia del minor mondo, col medesimo ordine che innanzi a me fu fatto da Tolomeo nella sua Cosmogrofia59. E così, dividerò poi quelle membra, come lui divise il tutto in province. E poi, dirò l’uffizio delle parti per ciascun verso, mettendoti dinanzi alli occhi la notizia di tutta la figura e valetitudine dell’omo in quanto a moto locale, mediante le sue parte. E così piacessi al nostro altore che io potessi dimostrare la natura degli omini e loro costumi nel modo che io descrivo la sua figura. [Windsor 19061 r]
58. Le importantissime tavole anatomiche sono presentate secondo la tecnica prospettica: prima si scompone il corpo nelle sue parti, con una dissezione particolareggiata e ripetuta, per poi ricomporle architettonicamente nel disegno (avanti, dietro, di lato). Qui Leonardo ci dà anche notizia sull’apparato riproduttivo femminile e quindi in una fase molto avanzata delle sue ricerche, comunque dopo la sua collaborazione a Pavia con Marcantonio Della Torre (1509-1510). Si veda a questo proposito D. Laurenza, Leonardo. L’anatomia, cap. 5, Firenze 2009. 59. Cosmogrofia = Cosmografia. L’opera di Tolomeo, Geografia, era stata edita a stampa nella traduzione latina a Vicenza nel 1475 e poi a Bologna e Roma nel 1478 con le tavole della Cosmografia. Infine nel 1482 era uscita anche la traduzione in volgare di Francesco Berlinghieri con la dedica al Duca di Urbino. Definita come la “bibbia” della geografia del Rinascimento (N. Broc 1989) era stata la base cartografica delle ricerche del Portogallo per circumnavigare l’Africa, ed anche dei calcoli di Toscanelli su cui Cristoforo Colombo ha ipotizzato il viaggio oceanico che gli ha fatto scoprire il nuovo continente, chiamato America dal fiorentino Amerigo Vespucci che ne dà per primo la notizia. Sembra impossibile che Leonardo non ne fosse a conoscenza. Ma qui cita l’antico scienziato alessandrino solo per ribadire che la conoscenza dell’uomo microcosmo è preliminare per poter conoscere l’intero macrocosmo. Conclude persino con la speranza di potere esporre un quadro complessivo delle genti e dei costumi, cioè una intera opera geografica, di cui l’anatomia del corpo umano è la premessa.
101
Aforismi e Pensieri
Fuggi e precetti di quelli speculatori che le loro ragioni non son confermate dalla isperienzia1. [B 4 v] Da Cornelio Celso2. Il sommo bene è la sapienza, il sommo male è il dolore del corpo. Imperoché3 essendo noi composti di due cose, cioè d’anima e di corpo, delle quali la prima è migliore, la peggiore è il corpo, la sapienza è della miglior parte, il sommo male è della peggior parte e pessima. Ottima cosa è nell’animo la sapienza. Così è pessima cosa nel corpo il dolore. Adunque siccome il sommo male è ‘l corporal dolore, così la
1. L’aforisma conclude una polemica con chi sostiene l’esistenza dei fantasmi o spiriti incorporei: Non po’ essere voce, dove non è movimento e percussione d’aria. Cfr. Marinoni (1974) p. 161. 2. Aulo Cornelio Celso (I secolo d.C.), enciclopedista romano di cui sono giunti a noi solo gli otto libri De medicina. 3. Imperoché= poiché.
102
sapienza è dell’animo il sommo bene, cioè de l’om saggio4, e niuna altra cosa è da a questa comparare. [Tri. 2 v] Medicina è ripareggiamento de’ disequalati5 elementi; malattia è discordanza d’elementi infusi nel vitale corpo. [Tri. 4 r] Sì come il mangiare sanza voglia fia dannoso alla salute, così lo studio sanza desiderio guasta la memoria e non ritien cosa ch’ella pigli. [Ashburnham 34 r] Movesi l’amante per la cos’ amata come il senso alla sensibile, e con seco s’unisce e fassi una cosa medesima. L’opera è la prima cosa che nasce dall’unione. Se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile. Quando la cosa unita è conveniente al suo unitore, li seguita dilettazione e piacere e sadisfazione. Quando l’amante è giunto all’amato, lì si riposa. Quando il peso è posato, lì si riposa. La cosa conosciuta col nostro intelletto6. [Tri. 6 r] 4. L’uomo saggio riconosce nella sapienza il sommo bene, che porta alla felicità dell’animo. Questa massima riassume la concezione razionalistica delle scuole filosofiche. Leonardo aggiungerà presto la specificazione non superflua che la sapienza deriva dall’esperienza. Ma, evidentemente da quest’ultima premessa ricava più tardi un paradosso che smentisce la facile conquista del sapere, che condurrebbe non alla felicità ma alla follia. 5. disequalati = non equilibrati, non proporzionati o eguali. 6. L’intelletto conosce, a partire dai sensi, allo stesso modo che il desiderio amoroso, che vuole congiungersi con l’amata. La qualità della cosa amata determina il grado di conoscenza, come teorizzato dai neoplatonici.
103
Quattro sono le potenzie: memoria e intelletto, lascibili7 e concupiscibili. Le prime due son ragionevoli e l’altre sensuali. [Tri. 7 v] De’ 5 sensi, vedere, uldir8, odorato sono di poca proibizione, tatto e gusto no. [Tri. 7 v] Ogni nostra cognizione prencipia da sentimenti. [Tri. 20 v] I sensi sono terrestri, la ragione sta for di quelli quando contempla9. [Tri. 33 r] Lo corpo nostro è sottoposto al cielo, e lo cielo è sottoposto allo spirito. [Tri. 36 v] 7. lascibili = volubili, cioè irascibili, secondo la tripartizione dell’anima di Platone. 8. uldir = udire, udito. Insieme a vista e odorato considerato meno peccaminoso, di poca proibizione, dalla morale cristiana, rispetto al tatto, che innesca la lussuria, e il gusto al peccato di gola. Si veda ovviamente Dante, Inferno, a cui sembra opporsi l’aforisma di Leonardo in H 32 r. 9. L’uscir fuori della ragione, il distacco dai sensi, è un lascito di Platone, probabilmente attraverso l’influenza di Marsilio Ficino. Tuttavia la contemplazione della ragione nel neoplatonismo non è riferita solo alle idee ma anche alla bellezza che è riscontrabile nei corpi e nel mondo. Leonardo non sembra indirizzare la ragione verso il mondo delle idee, bensì alle cose sensibili quando fa cominciare ogni conoscenza “dai sentimenti”, cioè dai sensi.
104
La sapienza è figliola della sperienzia. [Forster III, 14 r] L’anima mai si può corrompere nella corruzion del corpo, ma fa nel corpo a similitudine del vento che causa il suono dell’organo, che guastandosi una canna, non resultava, per quella, del vento buono effetto. [Tri. 40 v] Amor onni cosa vince. [Atl. 945 r, ex 344 r.b] Lussuria è causa della generazione. Gola è mantenimento della vita. [H 32 r] L’omo ha desiderio di intendere se la femmina è cedibile alla domandata lussuria, e intendendo di sì e come ell’ha desiderio dell’omo, elli la richiede e mette in opera il suo desiderio, e intender nol po’ se non confessa, e confessando fotte. [Arundel 191] Chi non raffrena la volontà con le bestie si accompagni. Non si po’ avere maggior né minor signoria che quella di se medesimo10. [H 119 r] 10. Una serie di proverbi tratti da Fiore di Virtù, XXXI., segnalato da Solmi come fonte. Cfr. Vecce (1992) pp. 102-106.
105
Nessuna cosa è da temere quanto la sozza11 fama. Questa sozza fama è nata da’ vizi. [H 40 r] La fama vola e si leva al cielo, perché le cose vertudiose12 sono amiche a Dio. [H 61 r] Chi non punisce il male, comanda che si facci. [H 118 v] Ostinato rigore. Destinato rigore. [Windsor 12701] No’ si volta chi a la stella è fisso. [Windsor 12282 r] La passione dell’animo caccia via la lussuria. [Atl. 994 v, ex 358 v.a]
11. sozza = sporca, negativa. Può essere un riferimento alle proprie esperienze personali, quando a Firenze venne accusato, con una denuncia anonima, di sodomia. L’inchiesta si concluse con un nulla di fatto, ma l’episodio può aver pesato anche nella decisione di lasciare la città per Milano. Vecce (1992) p. 159, segnala che il testo accompagna disegni allegorici della Fama. 12. vertudiose = virtuose, piene di virtù. Il termine si trova in Luigi Pulci, Morgante, XVII, 29, 4.
106
E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, raggiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all’entrata d’una gran caverna; dinanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante di tal cosa, piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, e colla destra mi feci tenebre alle abbassate e chiuse ciglia; e spesso piegandomi in qua e in là per vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa; e questo vietatomi per la grande oscurità che là dentro era. E stato alquanto, subito salse in me due cose, paura e desidero: paura per la minacciante e scura spilonca, desidero per vedere se là entro fosse alcuna miracolosa cosa. [Arundel 155 r] La idea, over imaginativa, è e timone e briglia de’ sensi, in però che13 la cosa immaginata move il senso. [Windsor 19019 v] Il senso comune è quello che giudica le cose a lui date da li altri sensi. [Atl. 245 r, ex 90 v.b] L’acquisto di qualunche cognizione è sempre utile all’intelletto, perché potrà scacciare da sé le cose inutili e riservare le buone. Perché nessuna cosa si può amare né odiare se prima non si ha cognizion di quella. [Atl. 616 v, ex 226 v.b]
13. in però che = tuttavia, però.
107
E questo omo ha una somma pazzia, cioè che sempre stenta per non istentare, e la vita se li fugge sotto speranza di godere i beni con somma fatica acquistati. [Forster III, 17 v] La somma filicità14 sarà somma cagione della infilicità, e la perfezion della sapienza cagion della stoltizia. [Atl. 112 a r, ex 39 v.c] Ecco alcuni che non altramente che transito di cibo, e aumentatori di sterco e riempitori di destri15 chiamarsi debono, perché per loro non altro nel mondo apare, alcuna virtù in opera si mette, perché di loro altro che pieni destri non resta. [Forster III, 66 v]
14. filicità = felicità, e al contrario, infelicità. Che la presunzione della sapienza sia stoltizia, è un tema che si diffonde in Europa alla fine del secolo, basti ricordare la Stultifera navis (Basilea 1497) di Sebastian Brant, che Leonardo cita tra i suoi libri come Galea de’ matti (n. 38, Vecce 1992 p. 258) e Erasmo da Rotterdam, Morias Encomion id est Stultitiae laus, (Parigi 1511), il famosissimo Elogio della Follia. Il testo tuttavia, scritto in un foglio datato 1487-90, parla di perfezione della sapienza che trapassa nella stoltizia, quindi non nega la possibilità del raggiungimento della verità, non giudica la ragione presuntuosa e l’orgoglio smisurato, come nella tradizione religiosa. Per lui l’infelicità non deriverebbe dal dover ammettere l’incapacità umana, bensì il paradossale rovesciamento nel suo contrario della felicità, una volta raggiunto l’apice del sapere, come se la follia fosse l’inevitabile destino del filosofo, nel momento in cui entra in contrasto con la presunzione dogmatica del mondo di sapere già. 15. destri = latrine, buche profonde, fosse adibite a comuni bisogni fisiologici.
108
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll’operante d’essa. [Forster III, 55 r] Tristo16 è quel discepolo che non avanza il suo maestro. [Forster III, 60 v] Le buone lettere so’ nate da un bono naturale; e perché si de’ più laldare la cagion che l’effetto, più lalderai un bon naturale sanza lettere, che un bon litterato sanza naturale. [Atl. 207 r, ex 76 r.a] Quando Fortuna17 viene, prendil’a man salva; dinanzi dico, perché dirieto è calva. [Atl. 207 v, ex 76 v a] 16. Tristo = incapace, non virtuoso, contrapposto a bono. 17. La dea Fortuna era rappresentata assisa su una nave mentre teneva la vela gonfiata dal vento (A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico, Firenze 1980, fig. 67) Oppure in una miniatura di Pietro Birago del 1490, è posta con la vela in piedi sul dorso di un delfino, in riferimento a Ludovico il Moro che amava presentarsi come “figlio della Fortuna”. Infine sopra una palla rotolante in terra con le ali con cui fa vento e spinge lei stessa la vela. (E. Wind, Misteri pagani nel Rinascimento, Milano 1985, fig. 48). Invece l’immagine dei capelli solo nel ciuffo frontale, mentre dietro (dirieto) è calva, risale ad Ausonio, Epigrammata, 33, che vuole rappresentare l’Occasione, per rimarcare la variabilità e l’instabilità con cui gli uomini hanno a che fare, nel momento in cui volessero affidarsi al momento propizio. Il foglio del Codice Atlantico presenta la data A dì 23 d’aprile 1490, ed è probabile che Leonardo stesse lavorando ad un’allegoria, come appare nel disegno del British Museum, (1886.0609.42). Tuttavia nel foglio Atl. 785 b-v (ex 289 v.c) l’aforisma è ricopiato, o riscritto a memoria per le piccole varianti, all’epoca dei suoi studi sull’Arno 1504-1506, quando ha varie occasioni di incontro e collaborazione con Niccolò Machiavelli, per la commissione per il grande affresco della Battaglia di Anghiari, e per la guerra contro Pisa.
109
Aristotile nel terzo dell’Etica18: l’uomo è degno di lode e di vituperio solo in quelle cose che sono in sua potestà di fare e di non fare. [Atl. 785b v, ex 289 v.c] Aristotile e Alessandro furon precettori l’un de l’altro. Alessandro fu ricco di stato, il qual li fu mezzo a osurpe19 il mondo; Aristotile ebbe grande scienzia, le quale li furon mezzo a osurparsi tutto il rimanente delle scienzie composte dalla somma de’ filosofi. [Madrid II, 24 r] Li abbreviatori20 delle opere fanno ingiuria alla cognizione e allo amore, con ciò sia che l’amore di qualunche21 cosa è figliol
18. Aristotele, Etica Nicomachea, III; 1-4. In realtà non è una citazione, piuttosto una sintesi del contenuto. Solmi (1976 p. 134) ha dimostrato che è presa letteralmente da Dante Alighieri, Convivio, Trattato terzo, IV, 6. 19. osurpe = usurpare, il manoscritto presenta una lacuna tra la p e la e; anche il successivo osurparsi. Il termine utilizzato sembra indicare una nota polemica contro Aristotele che, secondo tutta la tradizione (Plutarco, Vita di Alessandro) era stato precettore del giovane principe macedone. Il senso del brano è che Alessandro Magno si è imposto al mondo conquistando un impero, così come Aristotele ha imposto il suo sapere a tutti gli altri filosofi. La fonte è Plinio, Storia naturale, Libro VIII, 44-45, dove si attribuisce al comando di Alessandro di fare la raccolta di tutte le notizie sugli animali del suo vasto Impero la circostanza in base alla quale Aristotele ha potuto, usufruendo di centinaia di informazioni da ogni parte del mondo conosciuto, organizzare la più completa enciclopedia zoologica del suo tempo, un sapere su cui lo stesso Plinio dichiara di basare la gran parte delle notizie riportate, perché ancora valide. 20. Coloro che sintetizzano, riducono l’opera a compendi superficiali. Leonardo fa l’esempio di Giustino, storico romano del III secolo d.C. verso l’opera di Pompeo Trogo, ridotta ad un elenco di fatti. Si veda la nota 209. 21. qualunche = qualunque.
110
d’essa cognizione, e l’amore è tanto più fervente quanto la cognizione è più certa; la qual certezza nasce dalla cognizione integrale di tutte quelle parte, le quali, essendo insieme unite, compongano il tutto22 di quelle cose che debbono essere amate. Che vale a quel che per abbreviare le parte di quelle cose che lui fa professione di darne integral notizia, che lui lasci indirieto23 la maggior parte delle cose di che il tutto è composto? Gli è vero che la impazienzia, madre della stoltizia, è quella che lalda24 la brevità: come se questi tali non avessino tanto di vita, che li servissi a potere avere una intera notizia d’un sol particolare, come è un corpo umano; e poi vogliano abbracciare la mente di Dio, nella quale s’include l’universo, caratando e sminuzzando quella in infinite parte, come l’avessino notomizzate. [Windsor 19084] Sono infra il numero degli stolti una certa setta, detti ipocriti, che al continuo studiano d’ingannare sé ed altri, ma più altri che sé; ma in vero ingannano più loro stessi che gli altri. E questi sono quelli che riprendono i pittori, i quali studiano i giorni delle feste25 nelle cose appartenenti alla vera cognizione di tutte le figure che hanno le opere di natura, e con sollecitudine s’ingegnano di acquistare la cognizione di quelle, quanto
22. La visione d’insieme è il risultato che la Pittura raggiunge e che perciò dà più certezza e amore per la cosa conosciuta che non i discorsi sintetizzati, abbreviati. Qui il testo accompagna i suoi disegni anatomici. 23. indirieto = indietro (letterale), nel senso di lasciato fuori dal riassunto. 24. lalda = lode, lodare. 25. Polemica contro i preti ipocriti, ingannatori di sé e degli altri, che forse hanno rimproverato Leonardo perché durante le festività religiose continua nei suoi studi naturalistici, per cui la sua difesa riguarda l’amore per Dio, tanto inventore della natura, che si può amare solo conoscendone le opere.
111
a loro sia possibile. Ma tacciano tali riprensori, ché questo è il modo di conoscere l’operatore di tanti mirabili cose, e questo il modo di amare un tanto inventore, perché invero il grande amore nasce dalla gran cognizione della cosa che si ama, e se tu non la conoscerai poco o nulla la potrai amare26. E se tu l’ami per il bene che t’aspetti da lei, e non per la somma sua virtù, tu fai come il cane che mena la coda e fa festa alzandosi verso colui che gli può dare un osso, ma se conoscesse la virtù di tale uomo l’amerebbe assai più, se tal virtù fosse al suo proposito. [LP. 77; TP. I, par. 74] Molti mi crederanno ragionevolmente potere riprendere allegando le mie prove per esser contro all’alturità d’alquanti omini di gran riverenza apresso de’ loro inesperti iudizi, non considerando le mie cose essere nate sotto la semplice e mera sperienzia, la quale è maestra vera. [Atl. 327 v, ex 119 v.a] La esperienza non falla, ma sol fallano i vostri giudizi promettendosi di quella effetto che in e nostri experimenti causati non sono27. Perché, dato un principio, è necessario che ciò che siguita di quello, è vera conseguenza di tal principio, se 26. L’amore nasce dalla conoscenza completa e certa, così solo lo studio della natura permette il grande amore verso Dio. Una concezione razionalistica della fede che si distacca nettamente da ogni mistica teologica, in particolare quella di Marsilio Ficino che, seguendo Agostino, considerava l’amore per Dio un atto della volontà, indipendente e superiore alla conoscenza razionale. 27. Marinoni (1974) p. 65, preferisce scrivere “nostri”, invece che il testo manoscritto vostri; poi però riporta anche l’altra versione del frammento che prosegue, invece che nella discussione dell’esperimento, in accesa pole-
112
già non fossi impedito; e se pur seguita alcuno impedimento, l’effetto che doveva seguire del predetto principio, partecipa tanto più o meno del detto impedimento, quanto esso impedimento è più o men potente del già detto principio. [Atl. 417 r, ex 154 r. b-c] Naturalmente li omini boni desiderano sapere28. So che molti diranno questa essere opra inutile, e questi fieno quelli de’ quali Demetrio disse non faceva conto più del vento, il quale nella lor bocca causava le parole, che del vento ch’usciva dalla parte di sotto; uomini i quali hanno solamente desiderio di corporal ricchezze, diletto, e interamente privati di quello della sapienza, cibo e veramente sicura ricchezza dell’anima; perché quant’è più degna l’anima che ‘l corpo, tanto più degni fien le ricchezze dell’anima che del corpo. E spesso quando vedo alcun di questi pigliare essa opra in mano, dubito non si come la scimia sel mettino al naso, o che mi domandi ‘se è cosa mangiativa. [Atl. 327 v, ex 119 v a] Dicono quella cognizione esser meccanica la quale è partorita dall’esperienza, e quella esser scientifica che nasce e finisce nella mente, e quella essere semimeccanica che nasce dalla mica con chi si ripromette dall’esperienza ciò che non è in suo potere… co’ vostri vani e instolti desideri. 28. Aristotele, Metafisica, I, ma la precisazione “boni” sottintende una categorizzazione dell’umanità in due tipi di uomini, capaci di virtù, e tristi, che non corrisponde al testo aristotelico. Sembra invece di derivazione stoica, perché gli uomini del numero degli stolti sono considerati incapaci di comprendere il valore della sapienza, come è evidente dal proseguio in tono spregiativo dell’aforisma, interessati solo all’interesse immediato, a ciò che si può toccare e mangiare, paragonati a scimmie.
113
scienza e finisce nella operazione manuale. Ma a me pare che quelle scienze sieno vane e piene di errori le quali non sono nate dall’esperienza, madre di ogni certezza e che non terminano in nota esperienza, cioè che la loro origine, o mezzo o fine, non passa per nessuno de’ cinque sensi. E se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per i sensi, quanto maggiormente dobbiamo noi dubitare delle cose ribelli ad essi sensi, come dell’essenza di Dio e dell’anima e simili, per le quali sempre si disputa e si contende. [LP. 33; TP. I, par. 29] Chi nega la ragion delle cose, pubblica la sua ignoranza. [Madrid I, foglio di guardia] O speculatori del continuo moto29, quanti vani disegni in simile cerca ave’ creati! Accompagnatevi colli cercator dell’oro! [Forster II, 92 v] Al cimento30 si conosce il vero oro. [H 109 v]
29. La critica della possibilità del moto perpetuo conclude un esperimento con una ruota a cui sono stati agganciati una serie di pesi, che avrebbero dovuto trascinarla continuamente intorno al suo centro. Il disegno si trova anche in Atl. 760 ex 279 v b, e la confutazione in Madrid I, 147 v- 148 r. La polemica coinvolge anche i cercatori di trasmutazione del piombo in oro, cioè gli alchimisti. Si veda la continuazione della polemica con questi ultimi alle note 96-98. 30. cimento = prova, in senso traslato indica pericolo, rischio; l’orafo fin dall’antichità utilizzava una mistura di sali (caementum) per staccare l’oro dalle impurità, o per saggiare nella fusione la qualità del minerale.
114
Chi poco pensa molto erra. [H 119 r] Chi non stima la vita, non la merita. [I 15 r] La scienza è il capitano e la pratica sono i soldati. [I 130 r] L’ordinare è opra signorile, l’operare è atto servile. [Atl. 303 v, ex 109 r a] Sì come ogni regno in sé diviso è disfatto, così ogni ingegno diviso in diversi studi si confonde e indebolisce. [Arundel 180 v] Vita del pittore ne’ paesi. Al pittore è necessario le matematiche appartenente ad essa pittura e la privazione di compagnie che son alieni dalli loro studi; e cervello mutabile secondo la direzione delli obbietti che dinanzi se li oppongano, e remoti da altre cure. E se nella contemplazione31 e definizione di un caso se ne interpone un secondo caso, come accade quando l’obbietto muove il senso, allora di tal casi si debbe giudicare quale è di più faticosa difinizione e quel seguitare insino alla sua ultima chiarezza e poi seguitare la difinizione dell’altro. E sopra tutto essere di mente equale alla natura che ha la su31. La contemplazione era considerata l’attività filosofica per eccellenza, che Leonardo accosta alla pittura.
115
perficie dello specchio, la quale si trasmuta in tanti vari colori, quanto sono li colori delli sua obbiecti. E le sue compagnie abbino similitudine co’ lui in tali studi e, non le trovando, usi con se medesimo32 nelle sue contemplazione, che infine non troverà più utile compagnia. [Atl. 505 v, ex 184 v c] I’ho tanti vocavoli nella mia lingua materna33, ch’io m’ho più tosto da doler del bene intendere le cose, che del mancamento delle parole, colle quali io possa bene espriemere il concetto della mente mia. [Windsor f. 19086] La proporzione non solamente nelli numeri e misure fia ritrovata, ma etiam34 nelli suoni, pesi, tempi e siti, e qualunque potenzia si sia. [K 1, 49 r]
32. Da solo, solitario; dice in un altro brano: E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo, (LP. 50, TP., par. 48). 33. Ovviamente la lingua natia, toscana, il volgare che le corti d’Italia stavano sempre più utilizzando, e che trova un convinto sostegno nell’opera di Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, (1525). Il personaggio del dialogo che più esalta il fiorentino è Giuliano de’Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e fratello di Leone X, protettore di Leonardo negli anni 1513-16, a cui Bembo fa dire con grande enfasi “la volgar lingua non solamente vicina si dee dire che ella sia, ma natia e propria, e la latina straniera”(Libro primo, III, Milano 1989, p. 80). 34. etiam = anche (latinismo). L’aforisma richiama la teoria esposta da Luca Pacioli, De divina Proportione.
116
A ciascuno strumento si richiede esser fatto colla esperienza. Ciascuno strumento per sé debbe essere operato colla esperienza dond’esso è nato. [Arundel 191 r] Chi biasima la somma certezza delle matematiche si pasce di confusione, e mai porrà silenzio alle contradizioni delle sofistiche scienzie, colle quali s’impara uno eterno gridore. [Windsor 19118 r] Sanza dubbio tal proporzione è dalla verità alla bugia qual è da la luce alle tenebre. Ed essa verità in sé di tanta eccellenza che, ancora ch’ella s’astenda sopra umili e basse materie, sanza comparazione ella eccede le incertezze e bugie estese sopra li magni e altissimi discorsi. Perché la mente nostra, ancora ch’ell’abbia la bugia pel quinto elemento35, non resta però che la verità delle cose non sia di sommo nutrimento degli elementi fini, ma non di vagabondi ingegni. [V.U. 11 r]
35. Il quinto elemento è riferito da Aristotele al mondo dei cieli, che risultano così diversi nei loro movimenti circolari perfetti rispetto al mondo sublunare, terrestre, dominato dal conflitto dei quattro elementi. Leonardo ne contesta la validità perché non verificabile dai sensi. Il brano è inserito nel codice che parla del volo degli uccelli ed è apparso a Chastel (1995, p. 21), come estraneo al contesto. Ma Leonardo sta appunto esponendo i moti umili degli animali e non di quelle che considera bugie o, come ripete in una nota al margine ragion soffistiche e barerie de’ parlari nelle cose grandi e incerte, che anche se volessero esaltare Dio, toglierebbero gratia a sua deità.
117
L’uomo ha grande discorso del quale la più parte è vano e falso, li animali l’hanno piccolo ma è utile e vero36; e meglio è la piccola certezza che la gran bugia. [F 96 b.] O studianti, studiate le matematiche, e non edificate sanza fondamenti. [Windsor 19066] Non mi legga chi non è matematico nelli mia principi. [Windsor 19188 r] La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché in quella si viene al frutto matematico. [E 8 v] Le cose mentali che non son passate per il senso son vane e nulla verità partoriscono se non dannosa. E perché tal discorsi nascan da povertà d’ingegno, poveri son sempre tali discorso-
36. La parola come caratteristica propria dell’uomo, il linguaggio come ciò che lo differenzia dagli animali, era un luogo comune, che l’umanesimo aveva esaltato. “Gli uomini in questa parte sono dagli altri animali differenti, che essi parlano” (Prose della volgar lingua, Libro primo, I, Milano 1989, p. 75) scriveva Pietro Bembo nel 1515-16 a Roma, alla corte di Leone X, negli stessi anni in cui vi si trovava Leonardo. La diversa e polemica posizione di Leonardo vuole colpire l’uso retorico del linguaggio; il suo “animalismo” si collega alle osservazioni di tutta una vita sulla natura, e che proprio negli anni della vecchiaia lo distaccano dalla grande attività artistica promossa a Roma dal Papa di casa Medici. Va precisato che la polemica non si riferisce specificatamente all’ambiente romano perché il quaderno F è datato da Leonardo 1508, e Pietro Bembo pubblica la sua opera nel 1525.
118
ri; e se saran nati ricchi, e’ moriran poveri nella lor vecchiezza, perché pare che la natura si vendichi con quelli che voglian far miraculi abbin men che li altri omini più quieti, e quelli che vogliano arricchire ‘n un dì, vivon lungo tempo in gran povertà, come interviene e interverrà in eterno alli archimisti37, cercatori di creare oro e argento, e all’ingegneri che voglian che l’acqua morta dia vita motiva a sé medesima con continuo moto, e la sommo stolto negromante e incantatore. [Windsor 19070] Perché la natura sol s’astende38 alla produzione de’ semplici, ma l’omo con tali semplici produce infiniti composti, ma non ha la podestà di creare nessun semplice, se non un altro sé medesimo, cioè li sua figlioli; e di questo mi saran testimoni li vecchi archimisti, li quali mai, o a caso o con volontaria sperienzia, s’abbatteron39 a creare la minima cosa che crear si possa da essa natura. [Windsor 19045 v]
37. archimisti = alchimisti. Polemica contro coloro che cercano di applicare formule per trasmutazioni dei metalli, basate sull’idea di una essenza comune o materia prima. Alla condanna di concezioni di magie incantatorie e negromantiche Leonardo aggiunge anche gli ingegneri che avevano dedicato tempo e fatica alla ricerca del moto perpetuo della ruota del mulino in acqua morta, cioè stagnante e paludosa, attraverso l’applicazione della vite di Archimede. 38. s’astende = si estende, è capace di… Solo la natura può produrre gli elementi semplici, mentre l’uomo può naturalmente solo riprodursi, generare figli. Tutte le produzioni artificiali dell’uomo non fanno che comporre in varie combinazioni ciò che già esiste. 39. s’abbatteron = si imbatterono, riuscirono; gli alchimisti non trovarono mai il modo di creare quei semplici che la natura può fare. Anche se non lo dice, Leonardo doveva aver praticato l’Arte, o almeno eseguito qualche esperimento alchemico legato alle attività di bottega del Verrocchio (fusione, levigatura e doratura dei metalli).
119
Esemplo degli elementi. La definizione di nessuna quiddità40 delli elementi non è in podestà dell’omo, ma gran parte de’ loro effetti son noti. E porreno a nostro beneplacito li gradi di lor gravità e levità, benché si po dare la verità, ma non de’ semplici elementi, perché infra noi non si trovano. [Atl. 214 a v, ex 79 r b] Del calore e del colore del foco41 non se ne dà scienzia, né di sua natura, né de’ colori de’ vetri e d’altre cose che in lui s’ingenerano, ma di sua moti e altri accidenti sì, e del farlo aumentare e diminuire di potenzia e trasmutazion di colori nella sua fiamme in tanti diversi modi, quante son le varietà delle materie che lo nutriscono o che in lui s’infondano. [Atl. 728 r, ex 270 r.a] Comparazione della pazienzia. La pazienzia fa contra alle ‘ngiurie non altrementi che si faccino i panni contra del freddo; imperò che, se ti moltiplicherai di panni secondo la moltiplicazione del freddo, esso freddo nocere non ti potrà, similmente alle grandi ingiurie cresci la pazienzia, esse ingiurie offendere non ti potranno la tua mente. [Atl. 323 v, ex 117 v.b] 40. quiddità = essenza, sostanza. 41. Il fuoco è sempre stato considerato uno dei quattro elementi fondamentali dell’universo, tanto che il Timeo di Platone lo rappresentava con la figura geometrica della piramide, fondata dal triangolo, posto come base di tutte le forme composte. Ora il brano citato è la conclusione di una lunga analisi che parte dal disegno di tre candele accostate, poi due e una candela, tutte con fiamme piramidali. Marinoni (2006, Vol. 13, p. 193) nota che Leonardo ribadisce il concetto che della natura o essenza dei quattro elementi “non si dà scienza”, come affermato in Atl. 214 a v, citato sopra. Ma il limitare la conoscenza certa ai movimenti e alla quantificazione del calore è una critica implicita non solo a Platone ma anche alla fisica aristotelica.
120
Alli ambiziosi, che non si contentano del benefizio della vita né della bellezza del mondo, è dato per penitenza che lor medesimi strazino essa vita, e che non possegghino la utilità e bellezza del mondo. [Atl. 249 r, ex 91 v.a] Quelli che s’innamorino di pratica42 sanza scienza son come il nocchiere che entra in naviglio sanza timone e bussola, che mai ha certezza dove si vada. [G 8 r] Delle scienze – Nessuna certezza è dove non si po applicare una delle scienze matematiche, ovver che non sono unite con esse matematiche. [G. 96 v] O speculatore delle cose, non ti laldare di conoscere le cose che ordinariamente per sé la natura conduce, ma rallegrati di
42. pratica = sottinteso attività, che viene distinta da scienza, cioè la parte teorica. In questo aforisma degli anni 1510-15 sembra che Leonardo sia molto più preoccupato di trarre conclusioni teoriche ai suoi tanti esperimenti che di precisare il ruolo dell’esperienza. Ribadito fin dai suoi primi appunti, il primato dell’esperienza ha comunque bisogno di teorie capaci di renderne conto in una sintesi. A proposito dei tentativi di costruire la macchina volante, negli anni che vanno dal 1509 alla morte in Francia, Domenico Laurenza, Leonardo. Il volo, Firenze 2004, p. 92 parla di un “Primato della teoria” nei suoi studi sull’aria e il vento, che vengono comparati con ciò che ha osservato per l’acqua. L’analogia dei moti spiega il paragone con la navigazione: anche per volare ci vuole un timone e una bussola, c’è il bisogno di artifici che sostituiscano ciò che gli uccelli e i pesci hanno per natura.
121
conoscere il fine di quelle cose che son disegnate dalla mente tua. [G. 47 r] Per dare vera scienza del moto delli uccelli in fra l’aria è necessario dare prima la scienza de’ venti, la qual proverem mediante li moti dell’acqua in sé medesima. [E 54 r] Non si debba43 desiderare lo impossibile. [E 31 v]
43. debba = deve. È un monito per se stesso, negli ultimi anni della sua vita?
123
Aforismi sulla Natura
Il moto è causa di ogni vita. [Tri. 36 v] Il moto nasce da superchio o mancamento. [Arundel 82 r] Molte volte una medesima cosa è tirata da due violenzie, cioè necessità e potenzia: l’acqua piove, la terra la sorbisce per necessità d’omore, el sole l’asciuga non per necessità ma per potenzia. [Tri. 39 r] Nessuna cosa nasce in loco dove non sia vita sensitiva, vigitativa e razionale. Nasce le penne sopra gli uccelli e si mutano ogni anno; li peli sopra gli animali e ogni anno si mutano, salvo alcuna parte come i peli delle barbe de’ lioni e gatte e simili; nasce l’erbe sopra i prati, e le foglie sopra gli alberi, e ogni anno in gran parte si rinnovano. Adunque potrem dire la terra aver anima vigitativa, e che la sua carne sia la terra, li suoi ossi
124
siano li ordini delle col legazioni de’ sassi di che si compongano le montagnie, il suo tenerume sono li tufi, il suo sangue sono le vene delle acque, il lago del sangue, che sta dintorno al core, è il mare oceano, il suo alitare è il crescere e il decrescere del sangue pelli polsi e così nella terra è il frusso e refrusso del mare e ‘l caldo dell’anima del mondo è il foco, ch’è infuso per la terra, e la residenza dell’anima vigitativa sono li fochi per diversi lochi della terra spirano in bagni e miniere di zolfi e in vulcano, e Mongibello di Cicilia1 e altri lochi assai. [Leic. Carta 3B, f. 34 r] Si come la pietra gittata nell’acqua si fa centro e causa di vari circuli, el sono fatto in nell’aria circularmente si sparge. Così ogni corpo posto in fra l’aria luminosa circularmente sparge e empie le circostanti parti d’infinite sue similitudine e appare tutto per tutto e tutto in ogni parte. [A 9 v] Il moto, per essere fatto di varie potenzie è detto essere di due nature e però in due parti si divide delle quali l’una è spirituale e l’altra è materiale. Spirituale in fra noi è detto quello che è fatto dalla potenzia della immaginazione, materiale è quel fatto dai corpi materiali. [Madrid I, 122 v] Come è più difficile a ‘ntendere l’opere di natura che un libro d’un poeta. [Madrid I, 87 v]
1. Etna, in Sicilia.
125
Quella cosa che contiene in sé più universalità e varietà di cose, quella sarà detta di più eccellenza. Adunque la pittura è da essere preposta a tutte le operazioni, perché è contenitrice di tutte le forme che sono, e di quelle che non sono in natura. [LP. 31; TP. I, par. 27] La natura pare qui in molti o di molti animali stata più presto crudele matrigna che madre, e d’alcuni non matrigna, ma piatosa2 madre. [Forster III. 29] Delli asini bastonati3. O natura instaccurata4, perché ti se’ fatta parziale, facendo ai tua figli d’alcuni pietosa e benigna madre, ad altri crudelissima e dispietata matrigna? Io veggo i tua figlioli esser dati in altrui servitù sanza mai benefizio alcuno, e in loco di remunerazione de’ fatti benefizi, esser pagati di grandissimi martiri; e spender sempre la lor vita in benefizio del suo malefattore. [Atl. 393 a v, ex 145 r a]
2. piatosa = pietosa. Il riferimento alla natura, madre benigna e pietosa, o crudele e maligna riconduce a Plinio, Naturalis Historia, VII, Pref., nel volgarizzamento di Cristoforo Landino, Venezia 1476 (Marinoni 1974., p. 248). 3. Titolo che indica l’intenzione di Leonardo di usare la storia come indovinello o profezia; il brano si trova in una pagina che ne raccoglie di vari tipi. A conclusione un promemoria intitolato “Divisione della profezia” elenca otto diverse categorie di cui l’ottava delle cose filosofiche. Vecce (1992, p. 123). In un altro foglio del Codice Atlantico, foglio 526 a, una frase a margine di esercizi di geometria: Profezia di Leonardo da Vinci. 4. Instaccurata = poco accurata.
126
Due sono le qualità degli elementi, cioè raro e denso; raro è detto come il foco, l’aria e l’acqua; denso si pò dire alla terra. [Arundel 189 r] La gravità, la forza e moto accidentale insieme colla percussione son le quattro accidentali potenzie colle quali tutte l’evidenti opere de’ mortali ànno loro essere e loro morte. [Forster II, 16 v] La forza da carestia o dovizia è gienerata: questa è figliola del moto materiale e nepote del moto spirituale e madre e origine del peso; e esso peso è finito nell’elemento dell’acqua e terra, e essa forza è infinita, perché con essa infiniti mondi si moverebbe, se strumenti far si potessi dove essa forza gienerare si potessi5. [Arundel 151 r] Gravità è una potenzia creata dal moto, il quale mediante la forza transporta l’uno elemento nell’altro; e essa gravità ha tanto di vita quanto esso elemento pena a ripatriarsi…La gravità, la forza insieme col moto materiale e la percussione sono le quattro potenzie accidentali colle quali l’umana spezie nelle sue mirabili e varie operazioni pare in questo mondo dimo-
5. La frase è ipotetica, gli infiniti mondi non sono un riferimento alla teoria atomistica ma più semplicemente a una quantità indefinita che Leonardo, seguendo il racconto proverbiale sulla leva di Archimede, capace di sollevare il mondo se avesse un punto di appoggio e una leva enorme, dichiara retoricamente di poter spostare, se solo avesse strumenti capaci di generare una tale forza. Si veda la nota successiva.
127
strarsi una seconda natura. Imperochè con tali potenzie tutte l’evidenti opere de’ mortali hanno loro essere e loro morte6. [Arundel 151 v] Dice Aristotele che ogni cosa desidera mantenere la sua natura. La gravità per essere rescacciata dalle cose lievi, desidera tal sito che essa più non pesi, che la sua densità rimanga senza peso; il qual trovato, più non pesa e più per sé non si move. La gravità e la forza desidera non essere e però ciascuno con violenza mantiene suo essere. [Atl. 340 r, ex 123 r. a] La necessità è maestra e tutrice della natura. La necessità è tema e inventrice della natura, e freno e regola eterna. [Forster III, 55 r] La natura è costretta dalla ragione della sua legge, che in lei infusivamente7 vive. [C 23 v]
6. Viene ripreso il brano di Forster II, 16 v, posto qui a concludere il ragionamento: gli uomini, per quanto grandi e meravigliose possano apparire le loro operazioni, possono operare solo con forze naturali e con mezzi finiti, non in grado di generare forze infinite e moti perpetui (si vedano le critiche a tal proposito al cap. 2). 7. infusamente = diffusamente, internamente. La necessità è la legge che vive in ogni cosa e può essere intesa come legge divina immanente, dando all’aforisma un sapore stoico-panteistico.
128
Ogni azione fatta dalla natura non si po’ fare con più brieve modo co’ medesimi mezzi. Date le cause la natura partorisce li effetti per più brievi modi che far si possa. [Arundel 175 v] Facciàno nostra vita coll’altrui morte. [H 89 v] L’uomo e gli animali sono proprio transito e condotto di cibo, sepoltura d’animali, albergo de’ morti, facendo a sé vita dell’altrui morte, guaina di corruzione. [Atl. 207 v, ex 76 v.a] Per le 2 linie de’ nichi bisogna dire che la terra per isdegno s’attuffassi sotto ‘l mare, e fè il primo suolo; poi il diluvio fè il secondo. Contra8: perché la natura non ordinò che l’uno animale non vivessi della morte dell’altro? Pro. La natura essendo vaga e pigliando piacere del creare e fare continue vite e forme, perché cognosce che sono accrescimento della sua terrestre materia, è volonterosa e più presta col suo creare che ‘l tempo col suo consumare, e però ha ordinato che molti animali sieno cibo l’uno dell’altro, e non sodisfacendo a questo simile desidero, ispesso manda fuora certi avvelenati e pestilenti vapori e continua peste sopra le gran moltiplicazioni e 8. Marinoni (1974) ha omesso la frase “Per le 2 linie de’ nichi…” ed ha premesso il titolo Disputa “Pro” e “Contra” la legge di natura, inserimento che vuole dare il senso dello stile adottato, simile alla “questione disputata” usata nelle Università. Ma la frase iniziale lascia intender che il seguito doveva affrontare direttamente la problematica della mutazione continua di tutta la natura, in particolare del contrasto acqua-terra di cui i resti fossili (nichi) sono testimonianza. Di ciò ai capitoli successivi.
129
congregazioni d’animali, e massime sopra gli uomini che fanno grande accrescimento, perché altri animali non si cibano di loro, e tolte le cagioni mancheranno gli effetti. Contra. Adunque questa terra cerca di mancare di sua vita, desiderando la continua moltiplicazione, per la tua assegnata e mostra ragione. Spesso gli effetti somigliano le loro ragioni. Gli animali sono esemplo de la vita mondiale. Pro. Or vedi, la speranza e ‘l desidero del rimpatriarsi e ritornare nel primo caos9 fa a similitudine della farfalla al lume, dell’uomo, che con continui desideri sempre con festa aspetta la nuova primavera, sempre la nuova state, sempre e nuovi mesi e nuovi anni, parendogli che le desiderate cose, venendo, sieno troppo tarde, e non s’avvede che desidera la sua disfazione. Ma questo desidero ène in quella quintessenza spirito degli elementi, che trovandosi rinchiusa per anima dello umano corpo, desidera sempre ritornare al suo mandatario. E vo’ che sappi che questo desiderio è ‘n quella quinta essenza compagna della natura, e l’uomo è modello dello mondo. [Arundel 156 v] La quinta essenzia10 è infusa per l’aria, sì come è il foco elemento, benché ciascun di questi abbia in sé ovvero per sé la
9. Al primo Caos faceva riferimento Esiodo e Anassimandro ma anche Platone nel Timeo, concezione variamente ripresa anche nell’interpretazione biblica della Genesi, e dalla tradizione neoplatonica fino a Marsilio Ficino, Theologia platonica, 10, VII, con il riferimento ai “prisci theologi” che lo chiamavano “chaos antiquum”. 10. La quinta essenza veniva riferita al De caelo di Aristotele, dove il quinto elemento, o etere, caratterizzava le sfere celesti in eterno movimento circolare perfetto, mentre il mondo sublunare era nettamente separato, caratterizzato dal conflitto dei quattro elementi. Ma il fatto che qui venga indicata come mescolata all’aria esclude che si tratti della visione aristotelica, ed è piuttosto da riferirsi alle ricerche degli alchimisti. O meglio, in riferimento
130
sua regione; e mediante che a ciascuna lor particula è dato materia notritiva, essa piglia forma accrescitiva e aumentativa; e se il nutrimento fia tolto loro, essi subito abbandonano tal corpo e tornano alla sua prima natura. [Atl. 1090 r, ex 393 r a] Dove non vive la fiamma, non vive animal che aliti11. Il superchio vento uccide la fiamma e’l temperato la nutrica. Quella fiamma fa maggiore sonito coll’aria che la penetra, nella qual l’aria entra con maggior furore. La fiamma dispone prima la materia che la de’ nutrire, e poi si nutrica di quella. L’umido si fa più lieve che più si dilata, e si fa più grave che più si riscalda. [Atl. 728 r, ex 270 r.a] Come il corpo dell’animale al continuo more e rinasce. Il corpo di qualunque cosa la qual si nutrica al continuo muore e al continuo rinasce, perché entrare non può nutrimento se non in quelli lochi dove il passato nutrimento è spirato, e s’elli è spirato, elli più non ha vita, e s e tu non li rendi nutrimento equale al nutrimento partito, allora la vita manca di sua vale-
al testo precedente, Leonardo può intendere per quintessenza la materia prima infusa in tutta la natura delle concezioni neoplatoniche ed ermetiche, che erano riprese d’altra parte dagli stessi alchimisti. Ma in altri frammenti critica questa impostazione. 11. Dove manca l’aria non si accende il fuoco ma nemmeno un essere vivente può respirare. L’aforisma si trova inserito in vari testi che elaborano le osservazioni sul fuoco di una candela, come è evidente da quel che segue. Solmi, nel ricercare anticipazioni del pensiero scientifico, considera queste pagine un precedente di Lavoisier, cioè della scoperta della funzione dell’ossigeno nella respirazione dei viventi. Ma la concezione dei quattro elementi li poneva come elementi semplici e non, come la scienza che Lavoisier inizia, dei composti chimici.
131
tudine; e se tu levi esso nutrimento, la vita in tutto resta destrutta. Ma se tu ne rendi tanto quanto se ne distrugge alla giornata, allora tanto rinasce di vita quanto se ne consuma, a similitudine del lume fatto dalla candela col nutrimento datoli dall’omore d’essa candela, il quale lume ancora lui al continuo con velocissimo soccorso restaura di sotto quanto di sopra se ne consuma morendo, e di splendida luce si converte, morendo, in tenebroso fumo; la qual morte è continua, si com’è continuo esso fumo; e la continuità di tal fumo è equale al continuato nutrimento, e in istante tutto il lume è morto e tutto rigenerato, insieme col moto del nutrimento suo. E la sua vita ancora lei riceve il flusso e reflusso, come ci mostra la ventilazione della sua cima. E il medesimo accade nelli corpi delli animali, mediante il battimento del core che genera l’onda del sangue per tutte le vene, le quali al continuo si dilatano e constringono; e la dilatazione è nel ricevere il superchio sangue e la diminuzione è nel lasciare soprabondanzia del ricevuto sangue (…) Ma per ritornare al nostro intento, dico che la carne delli animali è rifatta dal sangue che al continuo si genera del lor nutrimento, e che essa carne si disfa e ritorna per le arterie miseraiche e si rende alle intestine, dove si putrefa di putrida e fetente morte, come ci mostran nelle loro espulsioni, e caligine, come fa il fumo e foco dato per comparazione. [Windsor 19045 r] I bugiardi interpreti di natura affermano lo argento vivo12 essere comune semenza a tutti i metalli non si ricordando che la 12. argento vivo = mercurio. Per gli alchimisti era base o semenza degli altri metalli, nei procedimenti di trasmutazione; ad esempio, Bartolomeo l’Inglese, Sulla proprietà delle cose (1397): “L’argento vivo è la sostanza di tutti i metalli e perciò, rispetto ad essi, un semplice elemento”. Secondo E.J. Holmyard, Storia dell’Alchimia, Bologna 2009, che cita ampiamente Bartolomeo, la concezione risale agli arabi Geber e Avicenna (pp. 115-117).
132
natura varia le semenze13 secondo le diversità delle cose che essa vole produrre al mondo14. [ Atl. 207 v, ex 76 v.a] La sperienzia interprete in fra l’artifiziosa15 natura e la umana spezie, ne’nsegna16 ciò che essa natura in fra’ mortali adopra da necessità constretta, non altrimenti oprar si possa che la ragione, suo timone, oprare le ‘nsegni17. [Atl. 234 r, ex 86 r. a] Data la causa la natura opera l’effetto nel più breve modo che operar si possa. [Arundel 174 v]
13. semenze = particelle che mantengono anche in maniera infinitesimale la qualità della cosa. Sono le omeomerie che, secondo Aristotele in Della generazione e della corruzione, I (A), 1, 314, erano state proposte da Anassagora di Clazomene. Si veda anche il volgarizzamento dell’opera di Diogene Laerzio, stampato a Venezia nel 1480: nell’elenco dei suoi libri (Atl. 559), al numero 27 come “Vita de’ filosofi”, Marinoni (1974) p. 251. 14. Il foglio presenta la data A dì 23 d’aprile 1490. 15. artifiziosa = capace di artifici, di meccanismi. Il brano accompagna il disegno della ricerca del centro di gravità di alcuni pesi. Il rapporto proporzionale delle misure vale sia per la meccanica sia per l’apparato locomotore degli animali, e quindi “artificiale” come si intenderebbe per un prodotto dell’uomo, che non fa che imitare la natura. 16. ne’nsegna = ci insegna, riferito all’esperienza, la sperienzia. 17. La ragione guida l’esperienza ad operare secondo quella necessità che l’esperienza stessa ha ricavato da una natura piena di tante meraviglie, che spesso sfuggono a sensi poco attenti.
133
Delle macchine. Perché la natura non può dare moto alli animali sanza strumenti macchinali, come per me si dimostra in questo libro nell’opere motive da essa natura fatta nelli animali, e per questo io ho composto le regole nelle 4 potenzie di natura, sanza le quali niente per essa po’ dare moto locale a essi animali. Adunque descriveren prima d’esso moto locale, e come lui partorisce ed è partorito da ciascuna dell’altre tre potenzie; di poi descriveren del peso naturale, ancora che non si possa nessun peso dire altrementi che accidentale; ma così è piaciuto nominarlo per separarlo dalla forza, che è di natura di peso in tutte sua operazioni, e per questo è nominata peso accidentale; e questa tal forza è posta per la 3 potenza, over naturata. La quarta ed ultima potenzia fia detta percussione, cioè termine o impedimento di moto. E diren prima che ogni moto locale insensibile è generato dal motore sensibile, come nell’orilogio il contrappeso tirato in alto dall’omo suo motore. Ancora li elementi scacciano o tiran l’un l’altro, come si vede l’acqua scacciar di sé l’aria, e ‘l foco, entrato per calore nei fondi delle caldare, e se ne fugge per li bollori superficiali dell’acqua bollente; e ancora la fiamma tira a sé l’aria, e il caldo del sole tira in alto l’acqua in forma d’umido vapore, il quale poi ricade in ispessa e grave pioggia. Ma la percussione è la immensa potenzia delle cose che si generi dentro alli elementi. [Windsor 19060] Se la perfezion dell’effetto è nella causa, la perfezion dell’impeto è nella forza che lo genera. Ogni parte desidera essere nel suo tutto nel quale meglio si conserva… Ogni parte ha inclinazion di ricongiungersi al suo tutto per fuggire dalla sua imperfezione. L’anima desidera stare col suo corpo, perché sanza li strumenti organici di tal corpo nulla può operare né sentire. [Atl. 166 r, ex 59 r.b]
134
De anima- Il moto della terra contro alla terra ricalcando quella, poco si move le parte percosse. L’acqua percossa dall’acqua fa circuli dintorno al loco percosso. Per lunga distanzia la voce infra l’aria. Più lunga infra ‘l foco. Più la mente infra l’universo. Ma perché l’è finita18 non s’astende infra lo ‘nfinito. [H 87 r] La natura è piena d’infinite ragioni, che non furon mai in esperienza19. [I 18 r] D’ogni cosa la parte ritiene in sé della natura del tutto. [I 90 r]
18. Si riferisce alla mente, capace di muoversi per intendere l’Universo, ma non di arrivare, in quanto finita, a comprendere l’infinito. 19. Solmi (2006, p. 103) pone questo aforisma quasi all’inizio dei “Pensieri sulla Natura” della sua scelta antologica, per voler sottolineare che lo scienziato Leonardo ha abbandonato il piano dell’esperienza, della pratica per rivolgersi ai principi e alle leggi dei fenomeni naturali. Tuttavia il riferirsi alle concezioni dei presocratici è stata un’acquisizione tarda e che non lo ha portato a rompere con il piano della ricerca empirica, né con l’idea che il microcosmo è immagine e specchio del macrocosmo.
135
Anassagora20: Ogni cosa vien da ogni cosa, e d’ogni cosa si fa ogni cosa, e ogni cosa torna in ogni cosa, perché ciò ch’è nelli elementi è fatto da essi elementi21. [Atl. 385 v c, ex 376 v] Perché le spezie degli obbietti son tutte in tutta la loro antiposta aria e son tutte in ogni punto di quella, egli è necessario che le spezie del nostro emisperio entrino e passino con tutti li corpi celesti per il punto naturale – e s’impremino nella pariete antiposta al predetto punto preforato22 in sottil pariete. E per questo la parte orientale s’impremerà nella parte occidentale di tal pariete e la occidentale nella orientale e de converso, eccetera… O mirabile necessità, tu con somma ragione costrigni tutti li effetti a partecipare delle lor cause e con somma irrevocabile legge ogni azione naturale colla brevissima operazione a te obbedisce. Chi crederebbe che sì brevissimo spazio fussi capace delle spezie di tutto l’universo? O magna azione, quale ingegno potrà penetrare tale natura? Qual lingua fia quella
20. Anassagora di Clazomene, si trasferì ad Atene nel 463 a.C., e fu amico e consigliere di Pericle. Venne poi ostracizzato per empietà, come riferisce anche Platone, Apologia di Socrate. Garin (1961, p. 391) ritiene più probabile come fonte, possibile per la citazione successiva della sua filosofia, Aristotele, Fisica, VIII, I, 250 b. 21. Leonardo mette insieme le particelle infinitesimali di Anassagora, che vanno a comporre ogni cosa per poi ritornare alla loro essenza, con la teoria dei quattro elementi di Empedocle, ripresa da Aristotele per il mondo sublunare. 22. preforato = perforato. Il punto naturale, cioè non matematico, può occupare uno spazio fisico, rappresentato evidentemente da un foro in una carta, o come quello usato in pittura per traguardare gli oggetti da rappresentare usando la camera ottica, per cui la spiegazione riferisce di come le immagini si dispongano specularmente.
136
che esplicare possa tal meraviglia? Certo nessuna. Questo dirizza l’umano discorso alla contemplazione divina23, eccetera. [Atl. 949 v, ex 345 v b] Nessun effetto è in natura sanza ragione; intendi la ragione e non ti bisogna sperienzia. [Atl. 398 v, ex 147 v.a] La scienzia strumentale over machinale è nobilissima e sopra tutte l’altre utilissima, con ciò sia che mediante quella tutti li corpi animati che hanno moto fanno tutte le loro operazioni. [V. U. 3 r] Ogni moto attende al suo mantenimento, ovvero ogni corpo mosso sempre si move, in mentre che la impressione della potenzia del suo motore in lui si reserva24. [V. U. 13 r] Due debolezze insieme appoggiandosi fanno una fortezza. [Atl. 663 v, ex 244 v a]
23. La meraviglia del fenomeno ottico, per cui da un foro passano i simulacri di ogni cosa visibile, testimonia della legge di natura e indirizza il ragionamento (dirizza l’umano discorso) verso il piano metafisico e teologico. L’eccetera indica forse che Leonardo intendeva rinviare a Luca Pacioli, De divina proporzione, per la parte teologica. Ma ciò che effettivamente riprende e sviluppa è l’analisi della visione attraverso la camera ottica o ispiraculo (in particolare in Atl. 955 r v). 24. reserva = rimane, si conserva.
137
La forza è tutta se medesima ed è tutta in ogni parte di sé… Forza non è altro che una virtù spirituale25, una potenza invisibile, la quale è creata e infusa per accidental violenza, da corpi sensibili nelli insensibili, dando a essi corpi similitudine di vita; la qual vita è di meravigliosa operazione, costrignendo e stramutando di sito e di forma tutte le create cose, corre con furia a sua disfazione, e vassi diversificando mediante le cagioni. Tardità la fa grande e prestezza la fa debole. Vive per violenza e more per libertà. Trasmuta e costrigne ogni corpo a mutazione di sito e di forma. Gran potenza le dà gran desiderio di morte. Scaccia con furia ciò che si oppone a sua rovina. [Atl. 826 r, ex 302 v b] More gravità e levità e così insieme nascano e insieme si consuman l’un l’altra. [Atl. 214 a v, ex 79 r b] Gravità e levità sono accidenti creati nell’uno elemento tirato nell’altro elemento. Se ‘l grave è tirato nell’elemento lieve, esso non fugge di quello per sua elezione o desiderio che in lui si truovi, ma sol perché li lieve nollo po sostenere. Provasi. Sia tirata l’acqua infra l’aria… [Atl. 663 v, ex 244 v a] Il moto libero del foco, quanto più si muove allo in su, più si fa veloce, sì come far si vede al grave allo in giù. Ed è piegabile per qualunche tortuoso condotto sanza perdimento o diminuzione di velocità equale, e se così non fussi, e’ seguite-
25. A sinistra del foglio si trova: Il peso è materiale e la forza spirituale.
138
rebbe che dov’ella avessi continuo ritardamento, la quantità antecedente si separerebbe dalla quantità succedente, e così si genererebbe il vacuo infra esse separazioni, la qual cosa è impossibile. [Atl. 728 r, ex 270 r.a] Il caldo e ‘l freddo vien dalla propinquità e remozione26 del sole - Il caldo e ‘l freddo genera il moto nelli elementi- Nessun elemento ha in sé gravità e levità- Gravità e levità sanza aumentazione nasce dal moto dello elemento in sé medesimo, nella sua rarefazione e condensazione; come far si vede nella generazione de’ nuvoli mediante l’umido che in lei è infuso. [Arundel 204 r] Il moto degli elementi nasce dal sole – Il caldo dell’universo è generato dal sole – Il lume e ‘l caldo dell’universo viene dal sole, e ‘l freddo e le tenebre dalla privazione del sole. [Arundel 205 v] Quel ch’è detto della supefitie dell’acqua che confina coll’aria s’intende essere detto della superfitie dell’aria che confina col focho, la qual potrebbe essere che spesso vaporassi a uso di nuvoli tirata dal caldo del sole, sì come fa l’acqua tirata infra l’aria dal medesimo caldo in forma di nugoli, e ‘l simile il focho tirato da maggior caldo di lui, cioè dal sole, come provato nel sesto lui essere caldo per essentia e non per virtù come vogliano molti. [F 26 v]
26. propinquità e remozione = vicinanza e lontananza.
139
Se guarderai le stelle sanza razzi (come si fa a vederle per un piccholo foro fatto colla strema punta d’una sottile acucchia27, ecque’ posto quasi a toccare l’occhio), tu vedrai esse stelle essere tanto minime che nulla pare essere minore, e veramente la lungha distanzia dà loro ragionevole diminuitione, ancora che molte vi sono che son moltissime volte maggiore che la stella, cioè la terra coll’acqua. Ora pensa quel che parrebbe essa nostra stella in tanta distantia, e considera poi quante stelle si metterebbe e per longitudine e latitudine infra esse stelle, le quali son seminate per esso spatio tenebroso. Ma i’ non posso fare che non si biasimi molti di quelli antichi li quali dissono che ’l sole non avea altra grandezza che quella mostra, fra’ quali Epicuro, e credo che cavassi tale ragione da un lume posto in questa nostra aria equidistante al centro (chi lo vede, nol vede mai diminuito di grandezza i’ nessuna distantia). E le ragioni della sua grandezza e virtù le riservo nel quarto libro; ma ben mi meraviglio che Socrate28 biasimassi questo tal corpo, e che dicessi quello essere a similitudine di pietra infocata, e certo chi lo ponì di tal errore poco peccò. Ma io vorrei avere vocaboli che mi servissimo abbiasimare quelli che vollon laldare più lo adorare li omini che tal sole, non vedendo nell’universo corpo di maggiore magnitudine e virtù di quello, e ‘l suo lume allumina tutti i corpi celesti che per l’universo si compartano; tutte l’anime discendan da lui, perché il caldo ch’è i’nelli animali vivi vien dall’anime, e nessuno altro caldo né lume è nell’universo, come mostrerò nel quarto libro. E cierto costoro che àn voluto adorare homeni per iddei, come Giove, Saturno, Marte essimili, àn fatto grandissimo errore, vedendo che ancora che l’omo fussi grande quanto il nostro mondo, ch’è parrebbe simile a una minima stella, la qual pare un punto nell’universo; e ancora vedendo essi omini mortali e 27. acucchia = ago. 28. Platone, Apologia di Socrate, 26 d.
140
pitridi e corruttibili nelle lor sepolture. La Spera29 e Marullo30 lalda con molti altri esso sole. [F 5 r] Se ‘l sole fussi minore della terra, le stelle di gran parte del nostro emisperio sarebbon sanza lume, contro a Epicuro31 che dice: “tanto è grande il sole quanto e’ pare”. [F 6 r] Del sole. Dicano che ‘l sole non è caldo, perché non è di colore di foco ma è molto più biancho e più chiaro. E a questi si po’ rispondere che quando il bronzo liquefatto è più caldo, elli è più simile al color del sole, e quand’è men caldo, à più color di foco. [F 34 v] Tutto tuo discorso à a concludere la terra essere una stella quasi simile alla luna; e così proverai la nobiltà del nostro mondo. E così farai un discorso delle grandezze di molte stelle secondo li altori. [F 56 r]
29. Goro Dati, La Spera, Firenze 1482. La lode del sole, si trova alle stanze 16-22. Cfr. Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, 2006, p. 83. 30. Marullo (Michele Tarcaniota), Hymni naturalis,(1497), in Michele Marullo, Poliziano, Iacopo Sannazzaro. “Poesie latine, Tomo Primo”, Torino 1976. Il Sole come immagine-simbolo del Bene è di origine platonica. 31. Epicuro di Samo. La citazione è basata su Lucrezio, De rerum natura, V 565-6.
141
Libro mio s’astende a mostrare come l’ocean, con li altri mari, fa mediante il sole splendere il nostro mondo a modo di luna, e a’ più remoti pare stella. E questo provo. [F 94 v] Della figura degli elementi e prima contro a chi niega l’opennione di Platone32, che dicano che se essi elementi vestissin l’un l’altro cholle figure che mette Platone che si causerebbe vacuo33 infra l’uno e l’altro; il che non è vero, e qui lo provo. Ma prima bisogna proporre alcuna conclusione. Non è necessario che nessun elemento che veste l’un l’altro sia d’equal grossezza in tutta la sua quantità infra la parte che veste e quella ch’è vestita. Noi vediamo la spera dell’acqua manifestamente essere di varie grossezze dalla sua superficie al fondo, e che nonché essa vestissi la terra quand’è fussi di figura cuba (che è di 8 angoli, come vole Platone), essa veste la terra che à innumerabili angoli di scogli coperti dall’acqua e varie globosità e concavità, e non si genera vacuo infra l’acqua e la terra. Ancora l’aria che veste la spera dell’acqua insieme choli monti e valli che superano essa spera, e non rimane vacuo infra la terra ellaria, sì che chi disse generarsi vacuo ebbe tristo discorso34. A Platone si risponde che la supeficie delle
32. Platone, Timeo, 54A-55C. 33. vacuo = vuoto. Chi criticava Platone sosteneva che le figure degli elementi non potevano stare insieme senza determinare dei vuoti, contraddicendo al principio di pienezza. 34. Gli atomisti che ponevano il vuoto hanno portato cattivi argomenti alla loro tesi. Kemp (1982, pp. 294-5) ritiene che la frase successiva introduca una critica allo stesso Platone, perché nella realtà i corpi fluidi tendono ad assumere una configurazione sferica. Ma non ci sembra che questo sia in contrasto con la difesa che Leonardo ne fa contro i sostenitori del vuoto, semmai con il testo successivo in cui pone il triangolo come riferito all’elemento terra e non al fuoco, come riteneva Platone.
142
figure che arebbon li elementi chellui pone non potrebbero stare. [F 27 r] De 5 corpi regolari, contro alcun commentatori che biasiman li antichi inventori donde nasceron le grammatiche e lle scientie e fansi cavalieri contro alli morti inventori per la pigritia, e come di tanto libri attendano al continuo con falsi argumenti a riprendere i lor maestri35. Dicano la terra essere tetracedronica, cioè cubica, cioè corpo di 6 base, e questo provano dicendo non essere infra i corpi regulari corpo di men movimento né più stabile che ‘l cubo. E al foco attribuirono il thetracedron, cioè corpo piramidale, la quale è più mobile (secondo questi filosafi) che non è la terra, però attrebuirono essa piramide al foco e ‘l cubo alla terra; il che s’avessi a ricercare la istabilità del corpo piramidale e compararla al corpo cubo, sanza comparazione è più mobile esso cubo che lla piramide. E così si prova… Adunque i’voglio inferire che’l triangolo è di più tardo moto che ‘l cubo, e per conseguenza era da mettere essa piramide e non il cubo per la terra. [F 27 v]
35. Il corsivo faceva da titolo a una lunga dimostrazione accompagnata da disegni esplicativi delle figure dei corpi geometrici regolari, posti da Platone nel Timeo alla base dei quattro elementi fisici. Solmi (1908, p. 72) ritiene che il riferimento agli antichi inventori riguardi Aristotele, forse per il verso dantesco che lo indica come il “maestro di color che sanno” (Inferno, IV, 131), mentre Platone e Socrate sono posti vicino a lui e subordinati al suo magistero. Ma non risulta che qui Leonardo segua l’ordine di preferenza di Dante, che ha fatto di Aristotele il Filosofo per antonomasia. Piuttosto c’è un salto tra il corsivo e la critica che Leonardo stesso muove a Platone, che deve ritenere fondata, mentre altre, di ignoti “commentatori che biasiman”, non ricevono il suo consenso.
143
Della confregatione de’ cieli, s’ella fa sòno o no. Ogni sòno si causa dall’aria ripercossa in corpo denso e s’ella sarà fatta da due corpi gravi infra loro, ell’è mediante l’aria, che li circonda, e questa tal confregatione consuma li corpi confregati. Adunque seguiterebbe chelli celi36, nella lor confregatione, per non aver aria infra loro non generassimo sòno. [F 56 v] Ma prima farò alcuna esperienza avanti ch’io più oltre proceda, perché mia intenzione è allegare prima l’esperienzia e poi colla ragione dimostrare perché tale esperienza è costretta in tal modo a operare. E questa è la vera regola come li speculatori delli effetti naturali hanno a procedere, e ancora che la natura cominci dalla ragione e termini nella sperienzia, a noi bisogna seguitare il contrario, cioè cominciando, come di sopra dissi, dalla sperienzia, e con quella investigare la ragione. [E 55 r] Ancora che lo ingegno umano in invenzioni varie rispondendo con vari strumenti ad un medesimo fine, mai esso troverà invenzione più bella né più facile né più breve della natura, perché nelle sue invenzioni nulla manca e nulla è superfluo e va con contrappesi quando essa fa li membri atti al moto negli animali, ma vi mette dentro l’anima d’esso corpo componitore, cioè l’anima della madre che, prima, compone nella matri-
36. celi = cieli, sfere celesti che, secondo la teoria pitagorica dovrebbero col loro movimento determinare una musica, sòno, un’armonia celeste. Leonardo aggiunge a questa considerazione una “prova” meccanica: infatti il brano prosegue col negare che ciò sia possibile in riferimento alla rotazione eterna degli astri, che porterebbe inevitabilmente a una consumazione (confregatione) tale da non far più combaciare le sfere.
144
ce la figura dell’omo e, al tempo debito, desta l’anima di quel debbe essere l’abitatore. La qual prima resta addormentata e in tutela dell’anima della madre, la qual nutrisce, vivifica per la vena ombelicale con tutti li sua membra spirituali. E così seguita insin che tale umbilico li è giunto con la secondina e i cotiledoni, per la quale il figliolo si unisce colla madre e questi son causa che una volontà, un sommo desiderio una paura che abbia la madre o altro dolore mentale, ha potenzia più nel figliolo che nella madre, perché spesse son le volte che il figliolo ne perde la vita ecc. E il resto della definizion dell’anima lascio nella mente de’ frati, padri de popoli, li quali per ispiritata37 azione san tutti li segreti. Lascio star le lettere incoronate38 perché son somma verità. [Windsor 19115, r]
37. ispiritata azione = ispirata, rivelata; la fede religiosa fa conoscere tutti li segreti, senza una dimostrazione razionale. Battuta che non nasconde un certo sarcasmo, subito moderato dalle frasi successive (si veda la nota successiva). 38. Lettere incoronate, cioè capilettera con il disegno di una corona, erano tipiche delle Bibbie miniate. Leggendo la prima parola della frase come un imperativo, Lascia, risulterebbe un ammonimento fatto a se stesso per non farsi coinvolgere in polemiche religiose. Domenico Laurenza, Leonardo nella Roma di Leone X, (1513-16), Lettura vinciana, Biblioteca Leonardiana, Città di Vinci Firenze 2003, riporta la battuta sui frati alla polemica sull’immortalità dell’anima che aveva coinvolto in quegli anni Pietro Pomponazzi, e il forte sospetto della Chiesa su chiunque non accettasse il proclamato dogma di fede cristiana nel Concilio del 1513. Seguendo questa indicazione e leggendo invece Lascio stare, come aveva già proposto Richter (1883), diventa una dichiarazione di salvaguardia di chi all’epoca si appellava alla “doppia verità”: Leonardo intende dire che, fatta salva l’adesione alla verità di fede, espone i risultati della sua ricerca attenendosi all’esperienza fatta, che dimostra il passaggio di generazione in generazione, dal corpo della madre al nascituro, dell’anima naturale.
145
E tu omo che consideri in questa mia fatica le opere mirabili della natura, se giudicherai esser cosa nefanda il distruggerla, ora pensa esser cosa nefandissima il torre la vita all’omo, del quale, se questa sua composizione ti pare di meraviglioso artifizio, pensa questa essere nulla rispetto all’anima che in tale architettura abita e veramente quale essa si sia39 ella è cosa divina sicché lasciala abitare nella sua opera a suo beneplacito e non volere che la tua ira e malignità destrugga una tanta vita che, veramente, chi nolla stima nolla merita, poiché così mal volentieri si parte dal corpo e ben credo che ‘l suo pianto e dolore non sia sanza cagione. [Windsor 19001, r]
39. quale essa si sia = qualunque sia la sua essenza. Di nuovo una dichiarazione che tiene insieme l’idea religiosa della divinità dell’anima e l’impossibilità di determinarne l’essenza, cioè la sua mortalità o immortalità, dal punto di vista scientifico.
147
Frammenti del Trattato dell’Acqua
Cominciamento del trattato de l’acqua. L’uomo è detto da li antichi mondo minore1, e certo la dizione d’esso nome è bene collocata, impero ché, siccome l’omo è composto di terra, acqua, aria e foco, questo corpo della terra è il simigliante. Se l’omo ha in sé osso, sostenitori e armadura della carne, il mondo ha i sassi, sostenitori della terra; se l’omo ha in sé il laco del sangue, dove cresce e discresce il polmone nello alitare, il corpo della terra ha il suo oceano mare, il quale ancora lui cresce e decresce ogni sei ore per lo alitare del mondo; se dal detto lago di sangue diriva vene, che si vanno ramificando per lo corpo umano, similmente il mare oceano empie il corpo della terra d’infinite vene d’acqua. Manca al corpo della terra i nervi, i quali non vi sono, perché i nervi sono fatti al proposito del movimento, e il mondo ‘sendo di perpetua stabilità, no’ v’accade movimento e, non v’accadendo movimento, i nervi non vi sono necesari. Ma in tutte l’altre cose sono molto simili. [A 55 v]
1. mondo minore = microcosmo, secondo una teoria antica, presente negli scritti di Platone e Seneca, sempre in riferimento al Macrocosmo o Universo.
148
Perché i fiumi mutano letto e spesso levano e pongono in diversi lochi. Il movimento dell’acqua sempre attende a consumare il suo sostegno, e quella parte chè più tenera li fa men resistenzia, e e’ partesi del suo loco lasciando diverse concavità, dove l’acqua, raggirandosi con vari retrosi2, consuma e cava allargando detto vacuo; e percuotendo nelle nuove argini, risalta percotendo nelle rive, consumando e rodendo, con ruine dell’opposizione, muta corso per mezzo delle ruine, accompagnando con esso corso la terra più lieve, la quale poi scarica nei lochi più quieti; alzando i fondi, diminuisce la quantità e la forza dell’acqua, mandando il suo furore dall’opposita parte; e se truova ripa, quella rode e scalza i sua fondamenti, finché co’ gran ruine scopre i novi terreni. E se truova pianura, quella occupa, lavando e cavando si fa novo letto; e se truova i sotterrati sassi quelli scopre e po’ discalza, i quali spesse volte per la loro grandezza fanno resistenzia a l’impetuoso corso, il quale, ripercosso ne’ contrastanti sassi, ribalza in opposita parte, rompendo e dannificando l’oposite rive. [A 59 r v] Vuolsi torre fiume che corra, aciò che non corrompessi3 l’aria della città. [B 38 r] Che cosa causa i sua retrosi. Il vento è in tutto simile nel suo movimento a quello dell’acqua. Universalmente tutte le cose desiderano mantenersi in sua natura, onde il corso dell’acqua che si move cerca mantenere la potenzia della sua cagione, e 2. retrosi = vortici, mulinelli. 3. L’acqua ferma corrompe l’aria, teoria medica molto diffusa a partire dai testi di Ippocrate, ed era considerata causa di pestilenze. Leonardo sta progettando una città-porto sul Ticino, collegata attraverso i navigli a Milano.
149
se trova contrastante oposizione, finisce la lunghezza del cominciato corso per movimento circolare e retorto. [A 60 r] L’acqua nel suo moto si tira con seco l’aria che con lei confina. [H 55 r] Dell’onde dell’acqua. L’onda dell’acqua, creata dal vento, è più tarda che ‘l vento, che la move, e più veloce che ‘l corso dell’acqua, che genera l’onda: dassi l’esempio dell’onde de’ prati. [Leic. Carta 1A, f. 36 v] L’aria, ancor che si muti di loco, reserva più la impressione de’ sua retrosi che non fa l’acqua, per essere più agile e più sottile. [Leic. Carta 7A, f. 30 v] E come il sole che percote sopra li specchi cavi, e for di quel risalta con piramidal concorso, che quella parte della piramide sarà proporzionalmente tanto più calda che la sua basa, quanto ell’è di minor grossezza, così fa quando essa umidità si restrigne quel caldo vapore che con quella era misto, si fa tanto più potente quanto più s’unisce, e’n quanto minor loco si reduce, tanto maggior calore quella genera. Onde spesso quel s’accende e moltiplica, facendosi del nùolo una bombarda; e così con ruinose folgore e tuoni la nùole rompe4. Le piccole
4. La descrizione della formazione dei fulmini a seguito della condensazione dell’umidità in nuvole, nùole, dove il calore si scontra con la massa più fredda, restretto, precede una lunga descrizione dei cambiamenti che l’acqua
150
granicule dell’acqua, quando il nùolo dal freddo è restretto, insieme s’appiccano, e pel peso cascano. E in questo modo i nùoli si disfano, e così in pioggia al basso sito tornano. Questa l’alte cime de’ monti consuma. Questa scaccia il mare de li antichi liti, perché col portato terreno l’inalza il fondo. Questa l’alte ripe conquassa e ruina; nessuna fermezza in lei giammai se vede, che subito non corrompa sua natura. Questa co’ sua fiumi cerca delle valli ogni pendice, e dove leva e dove pone nuovo terreno: Onde molti fiumi direno essere quegli donde tutto lo elemento sia passato, e molte volte il mare al mare abbin reduto, e nessuna parte di terra sia sì alta, che già il mare non fussi già ai sua fondamenti; e nessuna profondità di mare esser sì bassa, dove già non fussi fondate altissime montagne. E così quando acra e quando forte, quando prusca5 e quando amara, quando dolce e quando grossa o sottile, quando dannosa o pestifera si vede, quando salutifera o tosculente6. Onde diren che’n tante nature si trasmuta, quanto so’ vari i lochi donde passa. E come lo specchio si trasmuta nel colore del suo obietto, così questa si trasmuta nella natura del loco donde passa. Salutifera, solutiva, stitia7, sulfurea, salsa, sanguigna,
produce. Il brano termina con il riferimento ai diluvi e al tempo, di cui si veda ai capitoli successivi. 5. prusca = Schneider legge “acre”(2001, p. 309). Ma sarebbe una ripetizione di acra, della riga precedente. Recupero (1966, p. 733) invece legge “brusca, di sapore che tira all’aspro”, per analogia con il vino aspro detto brusco o bruschetto. Ma non troviamo altro esempio di uno scambio tra p e b mentre Marinoni (1974, p. 39) indica uno scambio abituale di entrambe le lettere con v, come in ave per ape o possivile per possibile. Forse non è un errore di Leonardo, prusca sarebbe l’acqua frizzante, perché in vernacolo fiorentino si dice che pruzzica, cioé pizzica. 6. tosculente = tossica, velenosa. 7. stitia = astringente, il contrario di solutiva, cioè purgativa; è un elenco delle diverse acque minerali che venivano prescritte in medicina, in base al colore corrispondente alla caratteristica fisica prevista dalla teoria degli umori (sanguigna, malinconica, flemmatica, collerica).
151
malinconica, flemmatica, collerica, rossa, gialla, verde, azzurra, untuosa, grassa, magra. Quando apprende il foco, quando lo spegne, calda fredda; quando leva o pone, quando cava o alza, quando ruina o stabilisce, quando riempie o vota, quando corre o si quieta, quando di vita o di morte è causa, quando di generazione o privazione, quando notrica8 e quando il contrario, quando salata o discipita, quando con gran diluvi le ampie valli sommerge. [Arundel 57 r] Pruova9 come la superficie del mare è equidistante al centro della terra ed è la più bassa superficie del mondo. [A 57 r] Nessuna parte dello acquatico elemento si leverà o si farà più distante dal comun centro, se non per violenzia. Nessuna violenzia è durabile. [C 15 r] Che cosa è acqua. Acqua è infra i quattro elementi il secondo men grieve10 e di seconda volubilità. Questa non ha mai requie insini che si congiugne11 al suo marittimo elemento, 8. notrica = nutrisce. 9. L’isonomia dei mari, concezione scientificamente corretta, è affermata da Leonardo in polemica con teorie proposte dalla scienza medioevale e araba, che trovava esposte in Restoro d’Arezzo. La prova, pruova, è geometrica, ponendo la terra come una sfera, non perfetta per la presenza delle cime montuose, ma di cui il mare rappresenta la circonferenza. 10. grieve = greve, pesante. 11. insini che si congiugne = fino a che non si congiunge. La quiete è data solo dal ritornare al centro del suo elemento che è il mare.
152
dove, non essendo molestata dai venti, si stabilisce e riposa con la sua superficie equidistante al centro del mondo. Questa è l’aumento12 e omore di tutti i vitali corpi; nessuna cosa sanza lei ritiene di sé la prima forma. Lei collega ed aumenta i corpi ad accrescimento. Nessuna cosa, più lieve di lei, la può senza violenza, penetrare. Volentieri si leva per il caldo in sottile vapore per l’aria. Il freddo la congela, stabilità la corrompe. Piglia ogni odore e sapore e da sé non ha niente. Penetra tutti i porosi corpi. Al suo furore non vale alcuno umano riparo, e se non vale non sarà permanente. [C 26 v] L’acqua è proprio quella che per vitale omore di questa arida terra è dedicata, e quella causa, che lo move per le sue ramificate vene contro al natural corso delle cose gravi, è proprio quella che move li omori in tutte le spezie de’ corpi animati. [Arundel 236 v] Questi libri13 contengano: in ne’ primi la natura dell’acqua in sé ne’ sua moti, li altri contengano delle cose fatte da e’ sua corsi, che mutano il mondo di centro e di figura. [ Leic. Carta 5A, f. 5 r]
12. aumento = crescita, sviluppo grazie all’acqua, intesa come umore, principio vitale. 13. Si tratta del Codice Leicester, composto negli anni 1506-1510, che cerca di ricomporre le tantissime note, dai quaderni A, H, e soprattutto F. (1508) che sono dedicate al tema dell’acqua come elemento determinante della vita della terra, pur in continuo contrasto con la terra, in una visione cosmologica che ritroviamo solo tra i presocratici e che Platone, Fedone 112 a, fa risalire ad Omero.
153
Il moto del centro della gravità della terra è nato dal moto della terra portata dalle acque dov’ella non era, e quivi ha aggravato, e alleggerito dond’ella si remosse. Questo si vede manifesto, che sempre i fiumi portano con seco la terra, che li intorbida, insino al mare, dov’ella poi, posando la terra, che manca alle valli de’ maìonti e corsi de’ fiumi. Quella parte della terra s’è più alienata dal centro del mondo, la qual s’è fatta più lieve. E quella parte della terra s’è fatta più lieve, per la quale è passato maggior concorso d’acque. Essi dunque fatta più lieve quella parte, donde scola più numero di fiumi, come l’Alpi, che dividano la Magna e la Francia dalla Italia; delle quali esce Rodano a mezzodì, e il Reno a tramontana, il Danubio over. [Leic. Carta 10A, f. 10 r] Se tu mi concedi per la prova di tali vesciche d’acqua14 che l’acqua abbia tenacità in sì piccola sua sottilità, tu mi concedi che quel che fa la parte mi farà il suo tutto. [Leic. Carta 12B, f. 25 r] Che l’acqua abbia tenacità e colleganza insieme, assai chiara mente si manifesta nelle piccole quantità d’acqua, dove la gocciola di quella, nella separazione, che essa fa dal suo rimanente, prima che caggia, si dilunga quanto può, insino che ‘l peso della gocciola assottiglia in modo la tenacità, che la sospende, che essa tenacità, vinta dal soperchio peso, subito cede, e si spezza e separa dalla predetta gocciola, e, contro al natural
14. Vesciche d’acqua = palloncini fatti con visceri d’animali e riempiti d’acqua. Qui Leonardo descrive un esperimento, ed enuncia il principio metodico che ne è alla base: il comportamento riscontrabile nella parte, è vero anche per l’elemento nella sua totalità.
154
corso della sua gravezza, ritorna in su, donde più non si move, insin che di nuovo è risospinta in basso dal già rifatto peso. Questa proposizione è in sé dua conclusioni, delle quali la prima è che la col legazione della gocciola à col legazione e nerbosità coll’acqua, con che essa si congiunge; 2°, che l’acqua, per forza tirata, si rompe la sua col legazione, la qual rottura è tirata insù dal suo rimanente, non altrimenti che ‘l ferro dalla calamita15. [Leic. Carta 10B, f. 27 r] La ramificazione delle vene dell’acqua sono tutte congiunte insieme in questa terra come son quelle del sangue nelli altri animali, e stanno in continua revolutione per la vivificazion di quella, sempre consumando i lochi onde si movano, così dentro alla terra come di fuori, e molta più acqua universalmente versano li fiumi che versare non soleano. Per la qual cosa la superficie del mare alquanto è declinata inverso il centro del mondo, avendo avuto a riempire il vacuo di tale accrescimento d’esse vene, per la qual cosa diremo poi. [Leic. Carta 9B, f. 28 r] Il corpo della terra, a similitudine de’ corpi de li animali, è tessuto di ramificazione di vene, le quali son tutte insieme congiunte, e son costituite a nutrimenti e vivificazione d’essa terra e de’ sua creati. Essi partono dalle profondità del mare e a quelle, dopo molta revolutione, hanno a tornare per li fiumi creati dalle alte rotture d’esse vene, e se tu volessi dire, le piove, il verno, o la resoluzione della neve, la state, essere la causa
15. Accompagna il disegno di una goccia con piccole goccioline tutto intorno la scritta come l’acqua si fa calamita dell’altra acqua (Leic. Carta 14A, f. 23 v).
155
del nascimento de’ fiumi, e’ si potrebbe allegare li fiumi, che ànno origine ne’ paesi focosi dell’Africa, nella quale non piove, e non nevica, perché il superchio caldo sempre risolve in aria tutti li nuvoli, che da’ venti in là son sospinti. E se tu dicessi, che tali fiumi, che vengono grossi il luglio e l’agosto, son delle nevi, che si risolvono il maggio e il giugno, per l’apprezzamento del sole alle nevi delle montagnie di Scizia, e che tali resoluzioni si riducano in certe valli, e fanno laghi, dove poi entrano per le vene e cave sotterranee, le quali riescano poi all’origine del Nilo; questo è falso, imperò ch’ell’è più bassa la Scizia che l’origine del Nilo, con ciò sia che la Scizia è presso al mar di Ponto, a 400 miglia, e l’origine del Nilo è remoto 3000 miglia dal mare d’Egitto, ove versa le sue acque. [Leic. Carta 4A, f. 33 v] La causa16 che move l’acqua per le vene contr’al natural corso della sua gravezza, è quella che fa il simile a tutti gli omori, in tutte le de’ corpi animati. E come il basso sangue in alto surge, e per le rotture della fronte ricade, tal spezie dell’intima profondità del mare l’acqua s’inalza alle sommità de’monti, dove, trovando le sue vene rotte, per quelle versa, e al basso mare ritorna. Vedestù17 mai l’acqua che discende da’ tagliati rami della vite, e ricadere sulle sue radice, che quelle penetrando di nuovo resurge? Tal fa l’acqua che nel mar ricade, che per i meati della terra penetra, e ritornata nella potenzia del suo mo-
16. La causa è indicata analogicamente con i movimenti degli umori di animali e piante. La questione è centrale per la teoria meccanicistica di Leonardo: l’acqua si muove all’insù in un ciclo continuo che sembra andare contro la fisica aristotelica dei luoghi naturali, per cui l’elemento acqua dovrebbe tendere sempre verso il basso, e il movimento all’insù solo innaturale e violento. 17. Vedestù = hai tu veduto.
156
tore, onde con violenzia18 di nuovo resurge e al solito discenso discende, po’ ritorna. Così insieme appiccata e congiunta con continua rivoluzione19 tra dentro e fuori si va raggirando. [Arundel 58 v] L’acqua s’innalza quando essa discende essendo il suo transito circondato da canna20. [Leic. Carta 7B, f. 7 v] E che sappiamo noi se la terra ha concavita grandissime con riserbi d’acque? E le innumerabili vene che son piene di tante acque quante si vede nel lor comporre de’ fiumi. Vedesi il mare Ircano21 grandissimo… necessità fa la macchina della terra vota di terra e piena d’acqua, a uso del vaso pieno d’acqua. [Leic. Carta 2A, f. 35 v]
18. Il moto violento all’insù è accidentale e meccanico, mentre il corso all’ingiù è naturale determinato dalla gravezza dell’elemento. La circolarità del fenomeno sta ad indicare una costante della natura, il conflitto perenne degli elementi. 19. Il termine astronomico indica il ciclo annuale intorno al centro delle sfere celesti, nel sistema tolemaico il mondo terrestre. 20. La spiegazione accompagna il disegno di un condotto artificiale che raccoglie l’acqua di una fonte e la porta in alto, con aperture a vari livelli per dimostrare sperimentalmente la possibilità che l’acqua salga per le vene, o condotti naturali della terra, sulle falde montuose per ridiscendere dall’alto. 21. Mar Caspio, un mare chiuso, che si credeva alimentato da una fonte sottomarina.
157
Quella causa che move li omori in tutte le spezie de’ corpi animati22… Così di qua, di là di su, di giù scorrendo, nulla quiete la riposa mai, non che nel corso ma nella sua natura. Nessuna cosa ha da sé ma tutto piglia, e ‘n tante varie nature si trasmuta, quanto son vari i lochi donde passa. Facendo proprio come fa lo specchio23 che tante similitudini in sé piglia, quanto son le cose che dinanzi li passano, così questa sempre si varia, quando di sito e quando di colore, quando novi odori o sapori dentr’a sé include, quando nuove sustanzie o qualità ritiene, quando mortale o salutifera si pruova. Alcuna volta coll’aria si mista o da caldo in alto si lascia tirare, e quando giugne alla fredda regione, dove il caldo sua guida con quella si restrigne. [Atl. 468 r, ex 171 r a] Il continuo corso che fa il sangue per le vene, fa che tali vene s’ingrossano e fansi callose in tal modo che alfine si riserrano e proibiscano il corso del sangue. Lo spazio ovver concavità delle vene de li animali col lungo corso dell’omore che li nutrica, s’incalliscano e al fine si riserrano24. La concavità delle vene 22. Leonardo riscrive in una forma più elaborata il brano di Arundel 58 v, aggiungendovi il testo qui riprodotto dopo i puntini. Infine conclude con un esempio di come il freddo stringa le nuvole come spugne, costrette a espellere il loro contenuto. 23. L’acqua è l’elemento fondamentale della natura, perché si può mutare in ogni altra cosa, attraverso il meccanismo del caldo e del freddo, come era stato teorizzato per la prima volta dalla filosofia ionica. Leonardo la ripropone a partire dalle sue conoscenze pittoriche, e l’esempio dello specchio è alla base della sua concezione, come si è visto nella prima parte. 24. Le osservazioni anatomiche di cadaveri di vecchi, porta a considerare che le loro vene sono occluse dalla continua circolazione di sostanze nutritive, mentre al contrario l’acqua per lo stesso continuo scorrere all’interno della terra allarga lo spazio delle vene. L’analogia tra corpo umano e moti naturali, tra microcosmo e macrocosmo, viene qui precisato e riaffermato, anche se vi sono dei risultati opposti del processo circolatorio. Kemp (1982,
158
della terra pel lungo e continuo corso dell’acqua si vengono allargando. [F 1 r] L’acqua delli fiumi non dal mare ma dalli nuvoli ha origine25. La confregazione de’sassi l’un con l’altro nelli corsi fatti dalli fiumi consumano li angoli delle pietre… Tutti li mari mediterrani e li golfi d’essi mari son fatti da fiumi che versano in mare. Li monti son fatti dalli corsi de’ fiumi. Li monti son disfatti dalle piogge e dalli fiumi. Li monti son più etterni e più premanenti nelle loro altezze, li quali si coprano di neve per tutta la vernata… Li mari mediterranei al continuo diminuiscano. [Atl. 160 v a, ex 433 r]
p. 298) ritiene che la discrepanza diventi “imbarazzante constatazione” in Windsor 19003 r dove Leonardo scrive contraria è l’origine del mare da quella del sangue, intendendo la direzione del processo circolatorio determinato dal cuore: il mare riceverebbe l’acqua di tutti i fiumi senza esserne l’origine, se le loro sorgenti nascessero solo dall’evaporazione provocata dal sole. L’analogia finora sostenuta sarebbe smentita nelle ultime sue analisi anatomiche? 25. La tesi qui esposta coincide per la prima parte con Aristotele, Metereologica, II, cap. II, 355 b, mentre l’ultima parte sulla diminuzione del mare è una teoria contrastata dallo stesso Aristotele e attribuita a Democrito. Leonardo ha un ultimo ripensamento, oppure elenca le tesi contrarie alle sue per cercare delle risposte convincenti? La tesi di un ciclo delle acque dal mare al cielo e la pioggia a determinare i fiumi, stabilirebbe un tempo lineare di consumazione della terra e di diminuzione del mediterraneo che non spiega i livelli diversi di fossili sui monti né l’ipotesi dell’eternità del mondo basata su un continuo bilanciamento di terra e acqua, come si può evincere dai frammenti del capitolo quinto. Difficile perciò credere che negli ultimi anni della sua vita Leonardo avesse completamente cambiato idea, piuttosto sembra costringerlo ad evidenziare, con una serie di disegni spettacolari, il ruolo determinante dei diluvi.
159
Contraria è l’origine del mare all’origine del sangue, perché il mare riceve in sé tutti li fiumi, li quali sono sol causati dalli vapori acquei levati infra l’aria; ma il mare del sangue è causa di tutte le vene. [Windsor 19003 r] Moltissime volte il Nilo e gli altri fiumi di gran magnitudine hanno versato tutto l’elemento dell’acqua e renduto al mare; e vanno le vene scorrendo con infinita ramificazione pel corpo della terra: Diventan l’acque di tante varie nature quanto son vari i lochi onde passano. [Leic. Carta 16 A, f. 21 v] Come li fiumi si possa degnamente chiamare la fortuna avversa o prospera di tutti i sua vicini. [Leic. Carta 15B, f. 22 r] Come il fiume del Po in brieve tempo secca il Mare Adriano nel medesimo modo ch’elli seccò gran parte di Lombardia. [Leic. Carta 10 A, f. 27 v] Rinchiudesi il mare infra la gran valle della terra, la qual terra fa ofizio di vaso al mare, e li labbri del vaso son le rive delli mari, le quali chi le togliessi via, il mare coprirebbe tutta la terra, ma perché ogni parte di terra scoperta è più alta che la maggiore altezza del mare, esso mare non può discorrere sopra di lei, ma solo si contenta di coprire quella terra che se li fa fondo. Benchè molti, ignorando tal cosa, hanno presuntuosamente scritto come la superficie dell’acqua marina è più alta
160
che il maggior monte che si truova26: la qual cosa, ancor che lor veddano l’argine più alto che l’acqua, son tanto accecati che dicano per miracolo essere l’acqua alta in mezzo del pelago più che la sua riva o che li promontori che sopra tali mari si tagliano. Ma tal fallacia è nata perché costoro immaginano una linea retta indefinita protratta sopra del mezzo del pelago, la quale sanza dubbio sarà più alta che le dette rive perché l’acqua è sperica e la sua superficie s’incurva. [Leic. Carta 6B, f. 31 r] Ogni elemento flessibile o liquido per necessità à lla sua superficie sperica. [F. 27 r] Come le valli furon coperte in gran parte da laghi, no perché sempre il suo terreno fece argine a’ fiumi, e da mari, i quali poi, colla perseverazione de’ fiumi che creava l’acque, ch’è nelli m… segorono li monti e li fiumi, co’ loro vagabondi corsi, portorono via le alte pianure incluse dalli monti; e le segature de’ monti sono note per le falde delle pietre, che si conrispondano nelle lor tagliature fatte dalli detti corsi dei fiumi. [Leic. Carta 1B, f. 1 v] L’acqua disfa li monti e riempie la valle e vorrebbe ridurre la terra in perfetta spericità, s’ella potessi. [Atl. 291 v, ex 105 v-c]
26. Restoro d’Arezzo, La Composizione del Mondo, II, 7, a cura di Alberto Morino, Parma 1997, p. 193.
161
Può il centro della gravità dell’acqua e della terra essere concentrici con il centro del mondo: quando la terra fussi perfettamente sperica allora il centro del mondo sarebbe centro della spera della terra come della spera dell’acqua. Ma non si produrrebbe animali terrestri. [Leic. Carta 2A, f. 35 v] Se ‘l frusso e refrusso è vario nascie dalla luna, o sole, o vero è l’alitare di questa terrestre macchina. Come il frusso e refrusso è vario in diversi paesi e mari. Come le bocche de’ mediterranei versan più acqua nell’oceano, ne’ loro frussi e refrussi, che non fa l’oceano in detti mediterranei. [Leic. Carta 17B, f. 17 v] Il flusso e reflusso del mare non nasce dalla luna né dal sole, ma dall’onda massima incidente e refressa27. [Atl. 762 r, ex 281 r a] Ordine del primo libro delle acque. Difinisci prima che cosa è altezza e bassezza, anzi come son situati li elementi l’un dentro all’altro. Di poi che cosa è gravità densa e che è gravità liquida, ma prima che cosa è gravità e levità. Di poi descrivi perché l’acqua si move e perché termina il moto suo; poi per27. refressa = riflessa. Sintesi di una pagina di annotazioni sulla base di notizie ricevute da qualche amico mercante, che accompagnano un disegno della foce di un fiume con la scritta sulla riva Anversa, città delle Fiandre in cui Leonardo non è mai stato. L’esperienza del Mare del Nord, dove la marea risulta molto più sostenuta che nel Mediterraneo, dovrebbe confermare che il moto ondoso è determinato da movimenti meccanici dell’acqua che i fiumi portano al mare, creando un’onda sostenuta dal vento, l’alitare della terrestre macchina.
162
ché si fa più tarda o veloce; oltre a di questo, com’ella sempre discende, essendo in confino d’aria più bassa di lei. E come l’acqua si leva in aria mediante il calore del sole, e poi ricade in pioggia. Ancora, perché l’acqua surge dalle cime de’ monti, e se l’acqua di nessuna vena, più alta che l’oceano mare, può versare acqua più alta che la superfizie d’esso oceano. E come tutta l’acqua che torna all’oceano è più alta della sfera dell’acqua; [E 12 r]
163
I Diluvi
Salvatico è quel che si salva1. [Tri. 1 v]
1. Durante la giostra di Galeazzo da Sanseverino 26 gennaio 1491, organizzata in onore del matrimonio di Ludovico il Moro con Beatrice d’Este, c’erano anche figuranti in costume d’omini salvatici (C 15 v). Il significato della figura è stato variamente interpretato, nel senso di solitario o di rustico. Boccaccio, Decamerone, Quarta giornata, Novella seconda, testimonia che era usanza a Venezia l’intervento durante le feste mascherate (caccie) in Piazza San Marco del travestimento “a guisa d’uom salvatico”. Dal latino tardo salvaticum che ha sostituito il classico silvaticum da silva(m) = bosco. Leonardo stesso annota dal Vocabulista di Luigi Pulci, silvestre = salvatico, cioè uomo dei boschi; cfr. Vecce (1992) p. 105, Marani-Piazza (2006), p. 178. Come mai l’aforisma affermi che l’uomo della foresta, con un accostamento che ripete il suono, ma non il significato, si “salva”, non sembra possa essere spiegato solo come un gioco di parole. Piuttosto va messo in riferimento alla teoria antica, esposta in Platone, Timeo 22 E, che prevede come conseguenza dei periodici Diluvi in diverse zone della Terra, che “coloro che abitano sui monti, i mandriani e i pastori, si salvano, mentre coloro che stanno nelle vostre città, vengono trascinati in mare dai fiumi”.
164
Lucrezio nel terzo delle cose naturale: le mani unghie e denti furono le armi de li antichi2. [B 18 v] Il corso della minor somma dell’acqua obbedisce alla maggiore de’ gran diluvi e muta corso e accompagnasi con quella e manca del suo cavare sotto all’argini. [A 23 v] La deità ch’ha la scienzia del pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in una similitudine di mente divina; imperò che con libera potestà discorre alla generazione di diverse essenzie di vari animali, piante, frutti paesi, campagne, ruine di monti, loghi paurosi e spaventevoli, che danno terrore alli loro risguardatori, et ancora lochi piacevoli, suavi e dilettevoli di fioriti prati con varii colori, piegati da suave onde, dalli suavi moti di venti, riguardando dietro al vento che da loro si fugge; fiumi discendenti con li empiti de’ gran diluvi dalli alti monti, che si cacciano inanti le deradicate piante, miste co’ sassi, radici, terra e schiuma, cacciandosi inanzi ciò che si contrapone alla sua ruina; et il mare con le sue procelle contende essa zuffa co’ li venti, che con quella combatteno, levandosi in alto co’ le superbe onde, onde e’ cade, e di quelle ruinando sopra del vento che percote le sue base; e loro richiudendo e incarcerando sotto di sé, quello straccia e divide, mischiandolo con le sue turbide schiume, co’ quello sfoga l’arrabbiata sua ira, et alcuna volta superata dai venti si fugge dal mare scorrendo
2. Il manoscritto presenta un numero 163 che Calvi (1925) considera un rinvio di Leonardo ad un repertorio, probabilmente tratto da Valturio De rerum militari, da cui è presa anche la citazione da Lucrezio, De rerum Natura, V 1283. Vecce (1992) p. 234 cita anche Virgilio, Eneide, IX, 548.
165
per l’alte ripe delli vicini promontorii, dove, superate le cime de’ monti, discende nelle opposite valli, e parte se ne mischia in ischiuma predata dal furore de’ venti, e parte ne fugge dalli venti ricadendo in pioggia sopra del mare, e parte ne discende ruinosamente delli alti promotori, cacciandosi inanzi ciò che s’oppone alla sua ruina, e spesso si scontra nella sopravegnente onda, e con quella urtandosi si leva ‘l cielo, empiendo l’aria di confusa e schiumosa nebbia, la quale ripercossa dai venti nelle sponde de’ promontori genera oscuri nuvoli, li quali si fan preda del vento suo vincitore. [LP. 68, TP. I, par. 65] A similitudine di un arritrosito vento che scorra ‘n una renosa e cavata valle, che pel suo veloce corso scaccia al centro tutte quelle cose che s’oppongono al suo furioso corso… Non altrimenti il settentrionale aquilone ripercuote colla sua tempesta… Non fa sì gran muglia il tempestoso mare, quando il settentrionale aquilone lo ripercuote, colle schiumose onde fra Scilla e Cariddi; né Stromboli o Mongibello quando le solfure fiamme, essendo rinchiuse, per forza rompendo e aprendo il gran monte, fuminando per l’aria pietra, terra, insieme con l’uscita e vomitata fiamma; né quando le ‘nfocate caverne di Mongibello renda mal tenuto elemento, rivomitandolo e spingendolo alla sua regione con furia, cacciando innanzi qualunche ostacolo l’interpone alla sua impetuosa furia…. E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, raggiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all’entrata di una gran caverna; dinanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante di tal cosa, piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, e colla destra mi feci tenebre alle abbassate e chiuse ciglia; e spesso piegatomi in qua e in là per vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa; e questo
166
vietatomi la grande oscurità che là entro era. E stato alquanto, subito salse in me due cose, paura e desiderio; paura per la minacciante e scura spelonca, desidero per vedere se là entro fusse alcuna miracolosa cosa. [Arundel 155 r] Infra li inriparabili e dannosi furori certo la inondazione de’ ruinosi fiumi de’ essere preposta a ogni altro orribile e spaventevole movimento, e non come alcuno ha voluto3, che lo incendio del foco superi essa inondazione. In contrario trovo, imperò che ‘l foco consuma chi lo nutrisce e si consuma insieme col notrimento. Il movimento dell’acqua ch’è mantenuto dalle declinate valli, ancora lui termina e more insieme co’ l’ultima bassezza della valle; ma il foco è causato dal nutrimento e ‘l moto dell’acqua dalla bassezza. Il nutrimento del foco è disunito e disunito e separato fa il danno, e ‘l foco more dove manca il nutrimento. E la declinazione delle valli è unita, e unito fia il danno, e unito fia il danno col ruinoso corso del fiume, finché in compagnia delle sue valli, finirà nel mare, universale bassezza e unico riposo delle peregrinanti acque de’ fiumi. Ma con quali vocaboli potrò io discrivere li nefandi e spaventosi mali contro alli quali non vale alcuno umano riparo? Ma colle gonfiate e superbe onde ruina li alti monti, deripa le fortissime argine, disvelle le radicate piante, e colle rapaci onde, intorpidato delle cultivate campagne, porta con seco le intollerabili fatiche di miseri e stanchi agrecultori. Lascia le valli denudate e vili per la lasciata povertà. Infra li irreparabili e dannosi furori, certo la inondazione de’ ruinosi fiumi debbe
3. La distruzione periodica attraverso il fuoco era la teoria dell’apokatastasis, sostenuta dagli Stoici. Tuttavia Seneca, Questioni naturali, Torino 1989, propendeva per una concomitanza di cause naturali come terremoti e maremoti.
167
essere preposta a ogni altra orribile e spaventevole dannificazione. Ma con quale lingua o con quali vocaboli potrò io ispriemere4, o dire le nefande ruine, li incredibili deripamenti, le inesorabili rapacità, fatte da’ diluvi de’ rapaci fiumi, contro ai quali non vale alcuno umano riparo? [Atl. 302 r, ex 108 v b] L’accozzamento di queste 3 dette cose sono e sono state cagione di grandissimi diluvi, cioè il refrusso del mare, e li venti occidentali, e la distruzion delle nevi. [Leic. Carta 6B, f. 31 r] Di lieve cosa nascesi gran ruina. [H 100 r] Come l’acque grandi de’ gran diluvi fanno le medesime revolutioni ne’ lor casi che fan l’acque piccole; ma nelle piccole poca acqua s’adopera, e fa poco movimento della sommità della sua onda alla parte inferiore d’essa onda, e quella medesima quantità d’acqua nell’onda di gran magnitudine fa gran movimento, onde non più conserva come prima qualità d’acqua trasparente, ma si converte in fumo, ovver nebbia, o in schiuma per la sua gran revolutione. [Leic. Carta 13B, f. 24 r]
4. ispriemere = esprimere. Introdotta in forma letteraria da una domanda retorica… con quali vocaboli potrò io discrivere…, che ora viene ripetuta, a ribadire l’impossibilità per l’uomo di far fronte al diluvio.
168
Molte volte il vento che si scontra con un altro vento con angolo ottuso fa che essi venti insieme si raggirano e si restringano insieme, in forma di grandissima colonna, e l’aria condensata acquista peso: e già vidi fare concavità di statura d’uomo sopra della rena del mare, dove tali venti infra lor s’aggiravano. E cavar sassi di buona grossezza di tal concavità, e portare la rena e aliga5 infra l’aria per ispazio di un miglio, e questa medesima discorrere infra l’acqua, e quella raggirare e vaporare in forma di spessa colonna di nuvola: la quale nel suo superiore estremo componeva oscure e folte nugole, e queste nugole dopo le cime de’ monti si spargevano e seguitavano il retto corso del vento, dove più non era impedito dalle cime de’ monti. [Leic. Carta 7A, f. 30 v] Io sono già stato a vedere tal moltiplicazione, e già sopra a Milano, inverso lago Maggiore, vidi una nuvola in forma di grandissima montagna, piena di scogli infochati perché i razzi del sole, che già era all’orrizzonte che rosseggiava, la tigneano del suo colore e questa tal nugola attraeva a sé tutti li nugoli piccoli che intorno li stavano e la nugola grande non si movea di suo locho, anzi riservò nella sua sommità il lume del sole insino a una ora e mezo di notte tant’era la sua immensa grandezza, e infra due ore di notte generò si gran vento che fa cosa stupente e inaudita. E questo fece nel risserrarsi, che l’aria che infra quella si rinchiudeva, essendo premuta dalla condensazione del hugolo rompea e fuggia per la parte più debole, scorrendo per l’arie con ispesso tumulto, facendo similitudine della spugna premuta dalla mano sotto l’acqua, della quale acqua che era imbeve rata fuggia infra le dita della man che preme a fuggendo con impeto infra l’altra acqua. [Leic. Carta 9B, f. 28 r] 5. aliga = alghe
169
Come sono vene che, per terremoti o altri accidenti, subito nascano e subito mancano: e questo accade ‘n una montagna in Savoia, dove certi boschi profondono6 e lasciarono uno balatro7 profondissimo e lontano circa 4 miglia di lì s’aperse il terreno in certa spiaggia di monte, e gittò una subita inondazione grossissima d’acqua, la quale nettò tutta una vallata di terren lavorativi, vigne e case, e fece grandissimo danno ovunque discorse. [Leic. Carta 11B, f. 11 v] Dubitazione. Movesi qui un dubbio, e questo è se ‘l diluvio venuto al tempo di Noè fu universale o no; e qui parrà di no per le ragioni che si assegneranno. Noi nella Bibbia abbiàn che il predetto diluvio fu composto di quaranta dì e quaranta notte di continua e universa pioggia, e che tal pioggia alzò dieci gomiti sopra il più alto monte dell’universo; e se così fu che la pioggia fussi universale, ella vestì di sé la nostra terra di figura sperica8, e la superficie sperica ha ogni sua parte equalmente distante al centro della sua spera; onde la spera dell’acqua trovandosi nel modo della detta condizione, elli è impossibile che l’acqua sopra di lei si move, s’ella non discende. Addunque l’acqua di tanto diluvio come si partì, se qui è provato non aver moto? E s’ella si partì, come si mosse, se ella non andava all’insù? E qui mancano le ragioni naturali, onde bisogna per
6. profondono = sprofondarono. 7. balatro = baratro. 8. Sperica, spera = sferica, sfera. La ragione matematica è il fondamento del dubbio sul racconto biblico del Diluvio Universale. La Dubitazione non riguarda il diluvio in quanto tale ma se fu universale, cioè se colpì tutta la terra o, al contrario, fu localizzato in determinate aree geografiche, parziale, limitato a una parte dell’umanità.
170
soccorso di tal dubitazione chiamare il miracolo per aiuto, o dire che tale acqua fu vaporata dal calore del sole9. [Atl. 418 a, ex 155 r b] Confutazione, ch’è contra coloro che dicano i nicchi esser portati per molte giornate distanti dalli mari per causa del Diluvio10. [Leic. Carta 9B, f. 9 v] Quando il Diluvio avesse avuto a portare li nicchi trecento e quattrocento miglia distanti dalli mari elli li avrebbe portati misti con diverse nature, insieme ammontati: e noi vediamo in tal distantie l’ostriche tutti insieme, e li conchili, e li pesci calamai e tutti gli altri nicchi che stanno insieme a parentadi grandissimi, infra quali assai vedi quelle che hanno ancora il coperchio congiunto a significare che qui furono lasciate dal mare che ancora vivevano quando fu tagliato lo stretto di Gibraltar. Vedesi nelle montagne di Parma e Piacentia le moltitudine de’ nicchi e coralli intarlati, ancora appiccati alli sassi: de’ quali, quando io facevo il gran cavallo di Milano, me ne fu
9. Il movimento del sole che si avvicina alla terra provocando siccità incendi e distruzioni, faceva parte della tradizione mitica. Ma la tesi sostenuta da Leonardo vuole essere scientifica ed esclude il miracoloso, che sia biblico o della mitologia greca, perché non permette una spiegazione razionale. 10. Al dubbio segue la confutazione, secondo il metodo espositivo della Scolastica. Leonardo ha proposto le sue tesi a professori dell’Università e ne ha ricevuto risposte tradizionali, che facevano riferimento alla Bibbia e alle tesi fisiche di Aristotele. Nel codice Leicester abbiamo il nome di Andrea da Imola, cioè Andrea Cattani, medico e filosofo, commentatore di Avicenna che, probabilmente nel 1505, aveva pubblicato la sua opera dedicandola a Pier Soderini, Gonfaloniere di Firenze, all’epoca quindi della presenza di Leonardo nella città; cfr. E. Garin (1979), pp. 115-126.
171
portato un gran sacco nella mia fabbrica da certi villani, che in tal loco furon trovati, fra li quali ve n’era assai delli conservati nella prima bontà. [Leic. Carta 9B, f. 9 v] Se tu dirai che li nicchi che per li confini d’Italia, lontani dalli mari, in tanta altezza si veggano alli nostri tempi sia stato per causa del Diluvio che li lasciò, io ti rispondo che, credendo tu che tal Diluvio superassi il più alto monte 7 cubiti, come scrisse ch’l misurò, tali nicchi che sempre stanno vicini alli liti del mare doveano restare sopra tali montagne, e non si poco alla radice dei monti per tutto a una medesima altezza a suoli a suoli. E se tu dirai che essendo tali nicchi vaghi di stare vicini alli liti marini e che crescendo l’acqua in tanta altezza, che li nicchi si partirono da esso lor primo sito e seguitorno l’accrescimento delle acque insino alla lor somma altezza; qui si risponde che essendo il nicchio animale di non più veloce moto che sia lumaca fori dell’acqua, e qualche cosa più tardo perché non nota, anzi si fa un solco per la rena e mediante i lati di tal solco ove s’appoggia camminerà il dì dalle 3 alle 4 braccia, dunque esso con tal moto non sarà camminato dal mare Adriano insino il Monferrato di Lombardia, che v’è 250 miglia di distanza, in 40 giorni, come disse chi tenne conto d’esso tempo! [Leic. Carta 8B, f. 8 v] Come nelle falde11, infra l’una e l’altra, si trova ancora li andamenti delli lombrici, che camminavano infra esse, quando
11. falde = stratificazioni. Continua il discorso precedente sui fiumi e la loro azione che determina un taglio della montagna, una falda, e la pietra scoperta che mostra una serie di strati soprapposti.
172
non era ancora asciutta. Come tutti li fanghi marini ritengano ancora de’ nichi, ed è pietrificato il nichio insieme col fango. Della stoltitia12 e semplicità di quelli che vogliono che tali animali fussi in tali lochi, distanti dai mari, portati dal Diluvio. Come altra setta d’ignoranti affermano la natura o i cieli averli in tali lochi creati per infrussi13 celesti. Come in quelli non si trovassi l’ossa de’ pesci cresciuti con lunghezza di tempo, come nelle scorze de’ nicchi e lumache non si potessi annumerare li anni o i mesi della lor vita come nelle corna de’ buoi e de’ castroni e nella ramificazione delle piante che non furon mai tagliate in alcuna parte. E avendo con tali segni dimostro la lunghezza della lor vita essere manifesta, e’ ci bisogna confessare che tali animali non vivino sanza moto per cercare il lor cibo, e in lor non si vede strumento da penetrare la terra o ‘l sasso ove si trovano rinchiusi. Ma in che modo si potrebbe trovare ‘n una gran lumaca i rottami e parte di molt’altre sorte di nichi di varie nature, se, essa sopra de’ liti marini già morta, non li fussino state gittate dentro dalle onde del mare, come l’altre cose lievi, che esso gitta a terra? Perché si trova tanto rottame e nichi interi fra falda e falda di pietra, se, già quelli sopra del lito, non fussi stat ricoperta da nuova terra rigittata dal mare, la qual poi si venne petrificando? E se ‘l diluvio predetto li avessi in tali siti dal mare portato, tu troveresti essi nichi in el termine di una sola falda, e non al termine di molte, dove si pò annumerare le vernate delli anni, che ‘l mare multiplicava le falde della rena e fango, portatoli da’ fiumi vicini, e ch’elli scaricava in su’ liti sua. E se tu volessi dire che più 12. stoltitia = stoltezza, follia (lat.) 13. infrussi = influssi, condizionamenti. La setta d’ignoranti è riferibile alla gran parte degli aristotelici, averroisti e non, che ritenevano i fossili di origine inorganica, riprendendo le tesi della presenza di semi che una “vis formativa” faceva crescere e che, incontrandosi con gli influssi dei pianeti, convertiva in pietre preziose, metalli o “pietre figurate”, cioè con immagini a somiglianza degli esseri organici.
173
diluvi fussino sttati a produrre tali falde, e nichi infra loro, e’ bisognerebbe che ancora tu affermassi, ogni anno essere un tal diluvio accaduto. Ancora infra li rottami di tal nichi si prosume, in tal sito essere spiaggia di mare, dove tutti li nichi son gittati rotti e divisi, e non mai appaiati, come infra ‘l mare vivi si trovano, con due gusci che fan da coperchio l’uno all’altro. E infra le falde della riviera e de’ liti marittimi son trovati e’ rottami; e dentro alli termini delle pietre son trovati rari e appaiati di gusci, come quelli che furon lasciati dal mare sotterrati vivi dentro al fango, il qual poi si seccò e col tempo pietrificò. [Leic. Carta 10A, f. 10 r] Del mondo. Nessuna parte della terra si scopre dalla consumazione del corso dell’acqua, che già non fussi superficie di terra veduta dal sole. [Atl. 124 v, ex 45 v a] Il taglio d’Abile e Calpe nello stretto Gaditano14 diminuì assai li fiumi che discendan dall’Alpe e corrano a settantrione. E questo si prova perché, inanti15 che tal taglio de’ monti Gadetani fussi creato, il mare Mediterraneo era d’altissima super-
14. Gibilterra. Abile e Calpe sono i nomi antichi dei due punti elevati da una parte e dall’altra, europea e africana, dello stretto; cfr. anche Luigi Pulci, Morgante, XXV, 227. Leonardo ipotizza che il Mediterraneo fosse in epoche lontanissime un grande lago che, scavando la roccia ha creato un taglio, in modo da abbassarsi moltissimo ricongiungendosi con l’Oceano e lasciando scoperte molte terre. Nello stretto si verifica un forte movimento di correnti che seguono il moto delle maree, per cui Leonardo li chiama anche gorghi Gadetani. 15. inanti = innanzi, prima.
174
fizie, la quale passava li tre quarti dell’altezza16 di tale Alpi; e la penetrazione che tal mare facea per li meati e vene della terra era altissima e abondante, dove, dopo il taglio gadetano, il mare Mediterraneo abbassò la superfizie sua, e li alti monti per detti meati rimason vacui delle loro acque e li fiumi perderon l’abondanzia delli loro corsi. [Arundel 168 v] La superficie del mare Rosso è in livello coll’Oceano… Mancato il peso delle diminuite acque mediterranee la terra s’alzò e mutò in sé centro di gravità. L’acque marine che dal mare Mediterraneo nell’Oceano discendeano, per la immensa percussione data sopra il fondo han concavato esso fondo assai sotto la superficie d’esso Oceano, il qual cavamento s’ha tirato dirieto insieme colla sua caduta insino a tanto ch’è pervenuto al fin del canal Gadetano, che oggi ci si mostra17. Può essere caduta una montagna e serrato la bocca del mare Rosso e proibito l’esito al Mediterraneo e così ringorgato tal mare abbia per esito il transito infra li gorghi Gadetani, perché il simile abbian veduto alli nostri tempi cadere un monte di sette miglia e serrare una valle e farne lago18. E così son fatti la mag-
16. La prova di tale altezza è ovviamente la fascia geologica fossilifera, che in alcune zone prende anche una colorazione delle marne “azzurrina”, o verde marino, per la forte presenza nello strato di alghe. 17. Il brano accompagna un disegno del bacino del mediterraneo, con prospettiva a volo d’uccello. 18. La notizia del “diluvio di Bellinzona” riguarderebbe solo la prima fase dell’evento catastrofico perché successivamente, nel 1515, mentre Leonardo era a Roma, l’acqua tracimò in un’alluvione altrettanto disastrosa. L’intera ricostruzione delle notizie storiche è ora in Marino Viganò, Il “Diluvio di Bellinzona”. Leonardo e “la buzza di Biasca” (1513-1515), Raccolta vinciana XXXVI, Milano 2015, pp. 75-131.
175
gior parte de’ laghi de’ monti, come lago di Garda, di Como e Lugano e lago Maggiore. [Atl. 901 r, ex 328 v b] Della terra in sé. L’alzarsi tanto le cime dei monti sopra la spera dell’acqua può esser dirivato, perché il loco grandissimo della terra, il quale era ripieno d’acqua, cioè la grandissima caverna, dovette caderne assai della sua volta inverso il centro del mondo, trovandosi ispiccata mediante il corso delle vene, che al continuo consumano il loco, donde passano,…Ora, questa gran massa potè cadere, essendo il centro del mondo infra l’acqua: essa si fermò con equal pesi oppositi intorno al centro del mondo, e alleggerì la terra, onde essa si divise; la qual si rimosse immediate dal centro del mondo, e s’alzò all’altezza, che si vede le pietre faldate, fatte con l’ordine dell’acque, alle cime delli alti monti. [Leic. Carta 1B, f. 36 r ] Faccia mutazion la terra colla sua gravezza quanto far si voglia, che mai la superfizie della spera dell’acqua no si partirà dalla sua equidistanzia col centro del mondo. Nel seno Mediterraneo, il quale come pelago ricevea l’acque regali de l’Africa, Asia ed Europa, che a esso erano volte, e colle sue acque veniano a le piagge de’ monti che lo circondavano e li facevano argine; e le cime dello Apennino stavano in esso mare in forma d’isole circondate dalle acque salse; e ancora l’Africa dentro al suo monte Attalante non mostrava al cielo scoperta la terra de le sue pianure con circa a 3.000 miglia di lunghezza; e Menfi risiedeva in su’ lito di tal mare; e sopra le pianure della Italia, dove oggi voln li uccelli a torme, solea discorrere i pesci a grandi squadre. [Leic. Carta 10B, f. 10v ]
176
Del mare che muta il peso della terra. Li nichi ostrighe e altri simili animali che nascono nelli fanghi marini, ci testificano la mutazion delle terre intorno al centro dei nostri elementi. Pruovasi così: li fiumi reali sempre corron torbidi mediante la terra che per lor si leva mediante la congregazion delle sue acque sopra il fondo e nelle sue rive; e tal consumazione scuopre le fronti de’ gradi fatti a suoli di quelli nichi che stan nella superficie del fango marino, li quali in tal sito nascerono, quando l’acque salse li coprivano. E questi tali gradi eran ricoperti di tempo in tempo dalli fanghi di varie grossezze, condotti al mare dalli fiumi con diluvi di diverse grandezze; e così tali nichi restavano murati e morti sotto tali fanghi, composti in tanta altezza, che tal fondo si scopriva all’aria. Ora questi tal fondi sono in tanta altezza, che son fatti colli o alti monti; e li fiumi, consumatori de’ lati d’essi monti, scoprano li gradi d’essi nichi; e così il levicato lato della terra al continuo s’inalza, e li antipodi s’accostano più al centro del mondo, e li antichi fondi del mare son fatti gioghi de’ monti. [E 4 v] Figurazion del Diluvio. L’aria era oscura per la spessa pioggia, la qual, con obliquo discenso piegata dal traversal corso dei venti, faceva onde si sé per l’aria, non altrementi che far si vegga alla polvere; ma sol si variava perché tale inondazione era traversata delli liniamenti che fanno le gocciole dell’acqua che discende. Ma il colore suo era tinto del foco generato dalle saette fenditrici e squarciatrici delli nuvoli, el vampo delle quali percotevano e aprivano li gran pelaghi delle rempiute valli, li quali aprimenti mostravano nelli lor ventri le piegate cime delle piante. E nettuno si vedea in mezzo all’acque col tridente, e vedeasi Eulo colli sua venti ravviluppare le notanti piante diradicate, miste colle immense onde. L’orrizzonte, con tutto lo esmisperio, era turbo e focoso per li ricevuti vampi
177
delle continue saette. Vedeasi li omini e uccelli che rempievan di sé li grandi alberi, scoperti dalle dilatate onde, componitrici delli colli, circundatori delli gran balatri. [G 6 v] Vedeasi per li vertiginosi corsi de’ venti venir di lontan paesi gran quantità di torme d’uccelli, e questi si mostravan con quasi insensibili cognizioni, perché, ne’ lor raggiramenti, alcuna volta l’una torma si vedean tutti li uccelli per taglio, cioè per la loro minore grossezza, e alcuna volta per la loro maggior larghezza, cioè in propria faccia; e ‘l principio della loro apparizione erano in forma d’insensibile nuvola, e le seconde e le terze squadre si facean tanto più note, quant’elle più si avvicinavano all’occhio di chi le riguardava. E le più propinque delle predette torme declinavano in basso per moto obliquo, e si posavano sopra li morti corpi portati dall’onde di tal diluvio, e di quelli si cibavano, e questo feciono19 insin che la levità deli infiati corpi morti venne mancando, dove con tardo discenso andaro declinando al fondo delle acque. [Atl. 981 v a, ex 354 v b] Sia in prima figurato la cima d’un aspro monte con alquanta valle circostante alla sua basa, e ne’ lati di questo si veda la scorza del terreno levarsi insieme colle minute radici di piccoli sterpi, e spogliar di sé gran parte delli scogli circostanti; rovinosa discenda da tal dirupamento, con turbolente corso
19. feciono = fecero. L’immagine terribile delle conseguenze del diluvio, con i cadaveri galleggianti, pasto per stormi di uccelli, è stata spesso ritenuta al limite della rappresentabilità per una pittura dell’epoca, e quindi una fantasia proponibile solo al futuro, quasi come una contemporanea inquadratura cinematografica, una scena in movimento.
178
vada percotendo e scalzando le ritorte e gluppolente radici delle gran piante e quelle ruinando sotto sopra. E le montagne, denudandosi, scoprino le profonde fessure fatte in quelle dalli antichi terremoti20; e li piedi delle montagne sieno in gran parte rincalzati e vestiti delle ruine delli albusti precipitati da’ lati delle alte cime de’ monti, e quali sien misti con fango, radici, rami d’alberi, con diverse foglie, infusi infra esso famgo e terra e sassi. E le ruine d’alcuni monti sien discese nella profondità d’alcuna valle e faccisi argine della ringorgata acqua del suo fiume, la quale argine già rotta, scorra con grandissime onde, delle quali le massime percorrino e ruinino le mura delle città e ville di tal valle. E le ruine degli alti edifici delle predette città levino gran polvere; l’acqua si levi in alto in forma di fumo, ed i ravviluppati nuvoli si movino contro alla discendente pioggia. [Windsor 12665 r] L’onde del mare, che percorre l’obliquità de’ monti che con lui confinano, scorrano schiumose con velocità contro al dosso de’ detti colli, e nel tornare indietro si scontrano nell’avvenimento della seconda onda, e dopo il gran loro strepito tornan con grande inondazione al mare, donde si partirono. Gran quantità di popoli, d’uomini e d’animali diversi si vedea scacciare dall’accrescimento del diluvio, inverso le cime de’ monti, vicini alle predette acque. [Windsor 12665 r]
20. Nelle note di pittura per il Diluvio confluiscono le annotazioni geologiche sulla stratificazione dei suoli e anche sulla presenza di antiche frane e fessurazioni della roccia. La questione dei tempi della terra e dei suoi cambiamenti è strettamente legata al ruolo dell’acqua.
179
Ancora aresti potuto vedere, nelle sommità di molti monti, essere ridotte molte varie spezie d’animali, spaventati e ridotti al fin dimesticamente in compagnia de’ fuggiti omini e donne colli lor figlioli21. E le campagne coperte d’acqua mostravan le sue onde in gran parte coperte di tavole, lettiere, barche e altri strumenti fatti dalla necessità e dalla paura della morte, sopra li quali erano donne, omini colli lor figliuoli misti, con diverse lamentazioni e pianti, spaventati dal furor de’ venti, li quali con grandissima fortuna rivolgevan l’acque sottosopra e insieme colli morti da quella annegati. E nessuna cosa più lieve che l’acqua era, che non fossi coperta di diversi animali, e quali, fatta tregua, stavano insieme con paurosa col legazione, infra’ quali era lupi, volpe, serpe e d’ogni sorte, fuggitori della morte. E tutte l’onde percuotitrice lor liti combattevan quelli, colle varie percussioni di diversi corpi annegati, la percussion de’ quali uccidevano quelli alli quali era restata vita. Alcune congregazioni d’uomini aresti potuto vedere, li quali con armata mano difendevano li piccoli siti, che loro eran rimasi, con armata mano da lioni e lupi e animali rapaci, che quivi cercavan lor salute. O quanti romori spaventevoli si sentiva per la scura aria, percossa dal furore de’ tuoni e dalle fulgore da quelli scacciate, che per quella ruinosamente scorrevano, percotendo ciò che s’oppone al su’ corso! O quanti aresti veduti colle proprie mani chiudersi li orecchi per ischifare l’immensi romori22, fatti per la tenebrosa aria dal furore de’ venti misti con pioggia, tuoni celesti e furor di saette! [Windsor 12665 v] 21. Continuano le note per un grande affresco: nella concezione di Leonardo i Diluvi, per quanto periodici, non distruggono l’umanità, perché l’inondazione lascia all’aria le vette dei monti, che fungono da isole su cui sopravvivono uomini e animali. 22. Plinio, Storia naturale XXXVI, 29, aveva caratterizzato Apelle come un pittore capace di gareggiare con la natura, cioè descriverne i fenomeni più incredibili e difficili da rappresentare come fulmini, tuoni e saette.
181
Tempo
Un peso di piombo, spignendo e calcando un sacchetto di cuoio pieno d’aria, nel suo calare ti potrà ancor lui mostrare l’ore1. Non ci manca modi né vie di compartire e misurare questi miseri giorni, i quali ci debba ancor piacere di none spenderli trapassargli indarno e senza alcuna loda e sanza lasciare di sé alcuna memoria nelle menti dei mortali. Acciò che questo nostro misero corso non trapassi indarno. [Atl. 42 v, ex 12 v.a] Esemplo della saetta fra nuvoli2. O potente e già animato strumento della artificiosa natura, a te non valendo le tue gran forze, ti convenne abbandonare la tranquilla vita, obbidire 1. Il testo accompagna un disegno di un rudimentale segnatempo o clessidra, con l’indicazione dei materiali necessari, Piombo-Cuoio. Marinoni (2006, Vol. 1, p. 224) lo indica come uno dei fogli più antichi del Codice Atlantico. 2. Titolo che non sembra corrispondere al contenuto del frammento, che Marinoni (1974) p. 186, cambia in” Il Mostro Marino”, riconoscendo che il foglio è molto tormentato e lacunoso (…). Va comunque inteso come uno dei primi tentativi letterari di Leonardo, ed è già presente il tema del tempo come carattere essenziale della nostra esperienza.
182
alla legge che Dio e ’l tempo diè alla genitrice natura (…) Le ramute e gagliarde schiene, colle quali tu, seguitando la tua pleda, solcavi col petto aprendo con tempesta le salse onde. O quante volte furono vedute le impaurite schiere de’ dalfini e de’ gran tonni fugire da l’impia tua furia, e tu che colle veloci e ramute ali e colla forcelluta coda fulminando generavi nel mare subita tempesta con gran busso e sommersione di navili, con grande ondamento empievi gli scoperti liti degli impauriti e sbigottiti pesci; togliendosi a te, per lasciato mare rimasi in secco, divenivano superchia e abondante preda de’ vicini popoli. O tempo, consumatore delle cose in te rivolgendole dai alle tratte vite nuove e varie abitazioni. O tempo, veloce predatore delle create cose, quanti re, quanti popoli hai tu disfatti, e quante mutazioni di stati e vari casi sono seguiti, po’ che la meravigliosa forma di questo pesce qui morì! (…) Ora, disfatto dal tempo, paziente diaci in questo chiuso loco: colle spolpate, ispogliate e ignude ossa hai fatto armadura3 e sostegno al sopraposto monte. [Arundel 156 r] Scienzia: notizia delle cose che sono possibile presente e preterite. Prescienzia: notizia delle cose ch’è possivine4 che possin venire. [Tri. 17 v]
3. armadura = armatura, fondamenta. Dato che il prosieguo parla di sostegno al sopraposto monte sembra che le ossa del gran pesce siano quelle di un reperto fossile. 4. possivine = possibile.
183
La vita bene spesa lunga è5. [Tri. 34 r] L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente. [Tri. 34 v] La memoria dei beni fatti, appresso l’ingratitudine, è fragile. [H 16 v] O tempo, consumatore delle cose, e o invidiosa antichità, tu distruggi tutte le cose e consummate tutte le cose da duri denti della vecchiezza a poco a poco con lenta morte. Elena quando si specchiava, vedendo le vizze grinze del suo viso, fatte per la vecchiezza, piagne e pensa seco perché fu rapita du’ volte6. [Atl. 195 r, ex 71 r.a] L’età che vola discorre nascostamente e inganna altrui, e niuna cosa è più veloce che gli anni e chi semina virtù fama ricoglie. [Atl. 195 v, ex 71 v.a]
5. Ripresa di un proverbio trascritto nella pagina 27 del codice trivulziano: Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene spesa dà lieto morire. Si noti la sintesi che la rende una massima allo stesso tempo personale e universale. 6. Una rielaborazione di Ovidio, Metamorfosi XV, 1, vv. 232-36 che Vecce (1992) p. 228 pone tra le “Trascrizioni” anche se, nella nota p. 233, la considera come parte di altre annotazioni ancora del periodo fiorentino, probabile risposta ad un sonetto di mano di un amico poi cancellato.
184
Io t’ubbidisco, Signore, prima per l’amore che ragionevolmente portare ti debbo, secondaria7 che tu sai abbreviare o prolungare le vite a li omini. [Forster III, 29] Proemio di prospettiva, cioè dell’uffizio dell’occhio. Or guarda lettore, quello che noi potremo credere ai nostri antichi, i quali hanno voluto difinire che cosa sia anima e vita, cose improvabili, quando quelle che con isperienzia ognora si possano chiaramente conoscere e provare, sono per tanti secoli ignorate e falsamente credute. L’occhio, che così chiaramente fa sperienza del suo ofizio, è insino ai mia tempi per infiniti altori8 stato difinito in un modo: trovo per esperienza esser in un altro. [Atl. 327 v, ex 119 v a] Il giudizio nostro non giudica le cose fatte in varie distanzie di tempo nelle debite e propie lor distanzie, perché molte cose passate di molti anni parranno propinque e vicine al presente, e molte cose vicine parranno antiche, insieme con l’antichità della nostra gioventù, e così fa l’occhio infra le cose distanti, che per essere alluminate dal sole, paiano vicine all’occhio, e molte cose vicine paiano distanti. [Atl. 81 v, ex 29 v.a]
7. secondaria = seconda motivazione, secondariamente. Va notato che la concezione religiosa di Leonardo risulterebbe molto popolana e senza nessuna pretesa teologica, dove il timor di Dio è dovuto alla possibilità che intervenga ad abbreviare o prolungare la vita a seconda del comportamento, se non fosse preceduta dall’amore per Dio dovuto alla conoscenza; cfr, gli aforismi sul tema al capitolo secondo. 8. altori = autori (antichi), altorità= autorità, citazione da antichi autori.
185
A torto si lamentan li omini della fuga del tempo, incolpando quello di troppa velocità, non s’accorgendo quello esser di bastevole transito; ma bona memoria, di che la natura ci ha dotati, ci fa che ogni cosa lungamente passata ci pare essere presente. [Atl. 207 r, ex 76 r a] Chi disputa allegando l’alturità, non adopera lo ‘ngegno ma più tosto la memoria. [Atl. 207 r, ex 76 r a] Come la pittura d’età in età va declinando e perdendosi, quando i pittori non hanno per altore altri che la fatta pittura. Il pittore arà la sua pittura di poca eccellenza, se quello piglia per altore l’altrui pitture; ma s’egli imparerà dalle cose naturali, farà bono frutto, come vedemmo ne’ pittori dopo i Romani, i quali sempre imitorono l’uno dall’altro e di età in età sempre andaro detta arte in declinazione. Dopo questi venne Giotti fiorentino9, il quale (none stando contento a lo imitare l’opere di Cimabue suo maestro…) nato in monti soletari, abitato solo da capre e simil bestie, questo, sendo volto dalla natura e simile arte, cominciò a disegnare su per li sassi li atti delle capre de le quali lui era guardatore, e così cominciò a fare tutti li animali che nel paese si trovava in tal modo che questo, dopo molto studio, avanzò non che li maestri della sua età, ma tutti quelli di molti secoli passati. Dopo questo l’arte ricadde, perché tutti imitavano le fatte pitture, e così di seculo in seculo andò declinando, insino a tanto che Tommaso fiorentino,
9. Giotto (1267-1337) pittore famoso già in vita, viene posto da Dante, Purgatorio, XI, come allievo che supera il maestro Cimabue, tanto da oscurarne la fama.
186
scognominato10 Masaccio, mostrò con opera perfetta come quegli che pigliavano per altore altro che11 la natura, maestra de’ maestri, s’affaticavano invano. Così voglio dire di queste cose matematiche, che quegli che solamente studiano li altori e non l’opere di natura, son per arte nipoti, non figlioli d’essa natura, maestra de’ boni altori. Odi somma stoltizia di quelli i quali biasimano coloro che’nparano da la natura lasciando stare li altori, discepoli d’essa natura! [Atl. 387 r, ex 141 r.b] Ma la bellezza di tale armonia il tempo in pochi anni la distrugge; il che non accade in tal bellezza imitata dal pittore, perché il tempo lungamente la conserva, e l’occhio in quanto al suo ufficio piglia il vero piacere di tal bellezza dipinta, qual si facesse nella bellezza viva. [LP. 23; TP. I, par. 19] Dice il musico12 che la sua scienza è da essere equiparata a quella del pittore, perché essa compone un corpo di molte membra, del quale lo speculatore contempla tutta la grazia in tanti tempi armonici quanti sono i tempi ne’ quali essa nasce e muore, e con quei tempi trastulla con grazia l’anima che risiede nel corpo del suo contemplante. Ma il pittore risponde e dice che il corpo composto delle umane membra non dà di sé piacere a’ tempi armonici, ne’ quali essa bellezza abbia a variarsi dando figurazioni ad un altro, né che in essi tempi abbia a nascere e morire, ma lo fa permanentemente per moltissimi 10. scognominato = soprannominato. 11. altro che = altro da, diverso dalla natura. 12. Il Paragone delle arti, dopo il poeta, continua con il musico, e con lo scultore.
187
anni, ed è di tanta eccellenza ch’ella riserva in vita quell’armonia delle proporzionate membra, le quali natura con tutte le sue forze conservar non potrebbe. Quante pitture hanno conservato il simulacro di una divina bellezza di cui il tempo o morte in breve ha distrutto il naturale esempio, ed è restata più degna l’opera del pittore che della natura sua maestra! [LP. 30; TP. I, par. 26] Quella cosa è più nobile che ha più eternità; dunque la musica, che si va consumando mentre ch’ella nasce, è men degna della pittura, che con vetri si fa eterna… Con questa si fanno i simulacri agli iddii; d’intorno a questa si fa il culto divino, il quale è ornato con la musica a questo servente; con questa si dà copia agli amanti della causa de’ loro amori; con questa si riservano le bellezze, le quali il tempo e la natura fa fuggitive13; con questa noi riserviamo le similitudini degli uomini famosi. E se tu dicessi: la musica s’eterna collo scriverla, il medesimo facciamo noi con le lettere14. [LP. 31; TP. I, par. 27] Dice lo scultore la sua arte essere più degna della pittura, conciosiacchè quella è più eterna per temer meno l’umido, il fuoco, il caldo e il freddo, che la pittura. A costui si risponde 13. fuggitive = di breve durata. La bellezza è destinata a scomparire se la pittura non la fissa, e l’eternità e qui intesa come continuità temporale, persino come permanenza nel ricordo, come nel caso della figura amata, o dell’immagine dei grandi uomini. Leonardo arriva a ritenere che non ci sia un volto bello uguale ad un altro e sembra porre in dubbio l’Idea platonica di Bellezza, che proprio la musica, con la sua armonia, avrebbe dovuto indicare. 14. La scrittura è pittura, forma grafica, allo stesso modo della notazione musicale che, sola, può eternare la musica altrimenti destinata a morire mentre viene suonata.
188
che questa tal cosa non fa più dignità nello scultore, perché tal permanenza nasce dalla materia, e non dall’artefice, la qual dignità può ancora essere nella pittura, dipingendo con colori di vetro sopra i metalli, o terra cotta, e quelli in fornace far discorrere, e poi pulire con diversi strumenti, e fare una superficie piana e lustra, come ai giorni nostri si può fare in diversi luoghi di Francia e d’Italia, e massime in Firenze nel parentado della Robbia15, i quali hanno trovato modo di condurre ogni grande opera in pittura sopra terra cotta coperta di vetro. [LP. 37, TP. I, par. 33] Di quel di Pavia si lalda più il movimento che nessun’altra cosa16. L’imitazione delle cose antiche è più laldabile che le moderne. [Atl. 399 r, ex 147 r.b] I nostri antichi architettori o talenti cominciando in prima dagl’Izi, i quali, secondo che descorre Diodoro Siculo, furon i primi edificatori e componitori di città grandissime e di castella e d’edifizi pubblici e plivati17, di forma, grandezza e qualità,
15. La famiglia dei Della Robbia, produttrice di famose sculture in terracotta invetriata. 16. Il Regisole di Pavia era un monumento equestre di epoca ellenistico- romana (I sec. a.C.) in bronzo dorato, andato perduto nel Settecento. Leonardo lo aveva studiato come modello per il Monumento a Francesco Sforza, che progettava in movimento con il cavallo rampante, in posa dinamica come teorizzava per le sue pitture, che si riferivano a modelli antichi perduti, di cui poteva però leggere la descrizione in Plinio. 17. plivati = privati.
189
per le quali i loro anticedenti riguardevoli con stupefazione e meraviglia le elevate e grandissime macchine parendo loro…18 [Atl. 890 r, ex 325 r.b] Giustino19, abbreviator delle storie scritte da Troco Pompeo, il quale scrisse ornatamente tutti gli eccellenti fatti delli sua antichi, li quali eran pieni di mirabilissimi ornamenti; e così compose una cosa ignuda, ma sol degna d’ingegni impazienti, li quali pare lor perdere tanto di tempo, quant’è quello che è adoperato utilmente, cioè nelli studi delle opere di natura e delle cose umane. [Windsor 19084]
18. Un altro proemio interrotto, in un foglio pieno di annotazioni architettoniche, con disegni, su colonne e capitelli. Il riferimento a Diodoro Siculo (I secolo a.C.) e la sua Bibliothéke istoriké, può essere indiretto, perché largamente citato da L.B.Alberti, De architectura; Solmi (1976) p. 136, elenca varie edizioni latine a cui Leonardo poteva accedere. In riferimento ai libri posseduti da Leonardo, era citato come fonte autorevole da Plinio e la testimonianza di Diodoro sull’antichità degli egizi, Izi, e della loro civiltà andava a confermare ciò che Diogene Laerzio sosteneva nelle Vite dei filosofi, I, Proemio, sulle origini orientali dei primi sapienti, magi e filosofi. 19. Marco Giuniano Giustino, storico romano del III secolo d.C. che ha tramandato l’indice e una breve sintesi dell’opera di Pompeo Trogo. Historiae Philippicae, in 44 libri quasi interamente perduti. Evidentemente una sintesi molto apprezzata dagli umanisti, fonte primaria per Marin Sanudo il Giovane, “chome Justino scrive Hystoriogropho”(Itinerario per la terraferma veneta nel 1483 di Marin Sanuto, Padova 2008, p. 210) che si serviva della traduzione in volgare: Iustino, Epitome, volgarizzamento di Girolamo Squarciafico, Venezia 1477; traduzione letta da Leonardo, ma non apprezzata, tanto che si scaglia contro gli abbreviatori che non hanno la pazienza di esporre l’argomento (nel suo caso l’anatomia del corpo umano) nella sua interezza e complessità. Si veda la nota 79.
190
Col tempo ogni cosa va variando20. [Arundel 57 r] Essempli e pruove dell’accrescimento della terra. Piglia un vaso21 e empilo di schietta terra e pollo sopra un tetto. Vedrai che immediate comincerà a germinare le fronzute erbe e quelle cresciute far vari semi e, ricaduti i figlioli a piè delle loro vecchie madri, vedrai l’erbe, fatti i loro semi, seccarsi e ricadere alla terra, in picciol tempo convertirsi in quella e darle accrescimento. Dopo questo vedrai ai nati semi fare il medesimo corso e sempre le nate cose, fatto il loro naturale corso, vedrai con la loro morte darle accrescimento alla terra. E se tu lascerai passare 10 anni e misurarsi l’accresciuto terreno, potresti vedere quanto la terra universalmente è cresciuta e moltiplicando vedrai in mille anni quanto la mondiale terra è cresciuta. [Atl. 715 r, ex 265 r a] Or non vedi tu negli alti monti i muri delle antiche e disfatte città essere da l’accrescimento della terra22 occupate e nascoste? Or non s’è veduto le sassose cime de’ monti, la viva pietra col suo accrescimento avere inghiottito una appoggiata colonna, e scalzata co’ taglienti ferri e quella trattane, aver lasciato nel vivo sasso la sua accanalata forma? [Atl. 715 r, ex 265 r a]
20. È la conclusione del lungo brano sull’acqua e tutte le sue possibili variazioni, che si può vedere sopra, dalla nota 145 a 149. 21. Un semplice vaso può fornire occasione per una riflessione cosmologica. 22. Il brano è preceduto dall’esempio del vaso di terra che si accresce per la semplice nascita, riproduzione e morte dell’erba.
191
Uno volendo provare colla alturità di Pittagora23 come altre volte lui era stato al mondo, e uno non li lasciava finire il suo ragionamento, allor costui disse a quel tale: “E per tale segnale che io altre volte ci fussi stato, io mi ricordo che tu eri mulinaro”. Allora costui, sentendosi mordere colle parole, gli confermò essere vero, che per questo contrassegno lui si ricordava che questo tale era stato l’asino, che li portava la farina. [M 58 v] La verità sola fu figliola del tempo. [M 58 v] Benché il tempo si possa annumerare infra le quantità continue, esso, per essere invisibile e sanza corpo, non cade integralmente sotto la geometrica potenzia, la quale lo divida per figure e corpi d’infinita varietà, come continuo nelle cose visibili e corporee far si vede; ma sol co’ sua primi principi si conviene, cioè col punto e colla linia. Il punto nel tempo è da essere equiparato al suo istante; e la linea ha similitudine colla lunghezza d’una quantità di un tempo. E sì come i punti son principio e fine della predetta linia, così gli istanti son termine e principio di qualunque dato spazio di tempo. E se la linia è divisibile in infinito, lo spazio d’un tempo da tal divisione non è alieno; e se la parte divise della linia sono proporzionabili, ancora le parti del tempo saranno proporzionabili infra loro. [Arundel 173 v]
23. Pitagora di Samo: “Dicono che costui per primo abbia dichiarato che l’anima, percorrendo un ciclo stabilito da necessità, si vincoli ora ad alcuni viventi, ora ad altri”, Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, VIII, 14.
192
Lo istante non ha tempo. El tempo si fa col moto dello istante, e l’istanti son termine del tempo. Il punto non ha parte. La linia è il transito del punto; e punti son termine della linia. Scrivi la qualità del tempo separata dalla geometrica. Se una potenzia move un corpo un tanto spazio in tanto tempo. [Arundel 176 r] Quello che è detto niente si ritrova sol nel tempo e nelle parole. Nel tempo si trova infra ‘l preterito e ‘l futuro, e nulla ritiene del presente, e così infra le parole che si dicano che non sono, o che sono impossibile. Appresso di natura non si truova il nulla; s’accompagna infra le cose impossibile, onde per questo non ha l’essere. [Arundel 131 r] Domandasi se tutti li infiniti sono equali ovvero maggiori l’un che l’altro. Rispondesi che ogni infinito è eterno e le cose eterne son d’equal premanenzia, ma non di lunghezza d’età, perché quel che in atto fu prima cominciato a dividere, ha passato più età, ma li tempi a venire son equali. [Arundel 204 v] Qual è quella cosa che non si dà, e s’ella si dessi non sarebbe: egli è lo infinito24, il quale se si potessi dare, e’ sarebbe terminato e finito, perché ciò che si può dare ha termine colla
24. La questione dell’infinito determina aporie insolubili. Per Aristotele può esistere in potenza ma non in atto, per cui qualsiasi grandezza sensibile non può che essere finita (Fisica, III, 6-7); come si evince dai suoi aforismi, Leonardo nega ogni possibilità di rappresentazione di ciò che non ha un termine, cioè appunto l’infinito, come Aristotele ne negava la conoscibilità.
193
cosa che lo circuisce ne’ sua stremi, e ciò che non si pò dare è quella cosa che non ha termini. [Atl. 362 r, ex 131 r.b] Io ho trovato infra l’altre superchie e impossibile credulità degli uomini la cerca del moto continuo, la quale per alcuno è detta ‘rota perpetua’. Questa ha tenuto moltissimi seculi, con lunga cerca e sperimentazione e grande spesa, occupati quasi tutti quelli omini che si dilettano di macinamenti d’acqua e di guerre e altri sottili ingegni. E sempre nel fine intervenne a loro come alli archimisti, che per una piccola parte si perdea il tutto. Ora io intendo fare questa limosina a questa setta d’investigatori, cioè di dare loro tanto di quiete in tale cerca quanto durerà questa mia piccola opera. E oltre a di questo, ciò che di sé altri imprometteranno, arà il disiderato lor fine, e none aranno sempre a stare in fughe per le cose impossibile promesse ai principi e reggitori di popoli. Io mi ricordo avere veduti molti e di vari paesi, essere per loro puerile credulità, essersi condotti alla città di Vinegia con grande speranze di provisioni, e fare mulina in acqua morta25, che non potendo dopo molta spesa movere tal machina, eran costretti a movere con gran furia se medesimi di tale aer26. [Madrid I, foglio di guardia r] Truovo la forza essere infinita insieme col tempo, e ’l peso essere finito insieme col peso di tutto il globo della terrestre macchina. [Atl. 324 r, ex 117 r c] 25. Lo stesso Leonardo annota: Cioè levare con istrumenti l’acqua quieta, come di padule, pozzo o di mare. 26. aer = aria, luogo, movere di gran furia se medesimi, cioè non gli rimaneva che scappare. Proverbiale: “meglio cambiare aria”.
194
Modo di sapere quanto un’acqua corre per ora. Questo si fa col tempo armonico, e potrebbe fare col polso27, se’l tempo del suo battere fossi uniforme. Ma più è sicuro in tal caso il tempo musicale, col quale se n’otterrà quanto spatio cammina una cosa portata da essa acqua per 10 o 12 d’essi tempi, e con questo tal modo si farà regola generale in qualunque canale uguale, ma non di fiumi, che quando corran di sotto non par che si movino di sopra. [Leic. Carta 13B, f. 13 v] Ogni impressione si riserva lungamente nello obbietto ove s’imprime. Come si vede ne’ circoli che dentr’alla superficie dell’acqua si creano per la percussione di quella che per lungo spatio infra l’acqua si movano, e ne’ retrosi e onde create in un loco e per l’empito dell’acqua portati in un altro sanza distrution di quelli: el medesimo fa lo splendore nell’occhio e la voce nell’orecchio. [Leic. Carta 8A, f. 29 v] Ogni danno lascia dispiacere nella ricordazione, salvo che ‘l sommo danno, cioè la morte che uccide essa ricordazione insieme colla vita. [H 33 v] Del mare che cigne la terra. Io truovo il sito della terra essere ab antico nelle sue pianure tutto occupato e coperto dall’acque salse, ei monti, ossa della terra, colle loro larghe base penetrare e elevarsi infra l’aria coperti e vestiti di molta 27. Il battito del cuore sentito nella vena della mano all’altezza del polso. Galileo Galilei ha misurato l’oscillazione del pendolo in questo modo.
195
e alta terra. Di poi le molte piogge, accrescimento de’ fiumi, con ispessi lavamenti han dispogliati in parte l’alte cime d’essi monti. Lasciando il loco della terra, il sasso si truova essere circondato dall’aria, e la terra, d’essi lochi partita, è già. E la terra delle spiaggie e dell’alte cime delle montagne è discesa alle sue base e ha alzato i fondi de’ mari, ch’esse base circavano, e fatta discoperta pianura; e di lì in alcun loco, per lontano spazio ha cacciato i mari. [Atl. 350 r, ex 126 v b] Come li fondi de’ fiumi col tempo s’elevano inverso la superficie delle acque, come mostra l’Arno che corre da Monte Lupo in giù, che già vi fu mare, che prima non correa. Come la spera dell’acqua s’innalza per la riacquistata acqua de’ mediterranei mari, scacciata dal terren che li torbidi fiumi dentro vi lasciano. -23m28. [Atl. 201 r, ex 74 r.a] Quando la natura viene alla generazione delle pietre, essa genera una qualità d’omore vischioso, il quale col suo seccarsi congela in sé ciò che dentro allui si rinchiude, e non li converte in pietra, ma li conserva dentro assé nella forma chelli à trovati. E per questo le foglie son trovate intere dentr’alli sassi nati nelle radici de’ monti, con quella mistione di varie 28. I numeri e la sigla stanno ad indicare la collocazione degli argomenti all’interno di un trattato sulle acque che secondo Calvi (1982, p. 223) diventerà il Codice Leicester. L’indicazione geografica della valle dell’Arno al paese di Monte Lupo, tra Firenze ed Empoli, è molto precisa e ben conosciuta da Leonardo, dato che si trova a una decina di chilometri da Vinci. Che in questa zona vi fosse anticamente il mare è ovviamente dedotto dalla presenza di fossili marini, che Leonardo può avere visto e trovato negli anni della sua infanzia e giovinezza.
196
specie sì come lì le lasciano li diluvi de’ fiumi nati alli tempi delli altunni, dove poi li fanghi delle inondazioni succedenti le ricopersono, ecquesti tali fanghi poi si collegoron del sopra detto omore, e convertissi in pietra faldata a gradi secondo li gradi d’esso fangho. [F 80 r] Truovasi sotto terra e sotto li profondi cavamenti de’ lastroni li legnami delle travi lavorati, fatti già neri, li quali furon trovati a mio tempo in quel di Castelfiorentino;(…) in Candia in Lombardia, presso Alessandria della Paglia, facendosi per messer Gualtieri di Candia uno pozzo, fu trovato uno principio di navilio grandissimo sotto terra, circa a 10 braccia, e poiché il legname era nero e bello, parve a esso messer Gualtieri di far allargare tal bocca di pozzo, in forma che i termini di tal navilio si scoprissi. Truovasi nelle mentagne di Verona la sua pietra rossa mista tutta di nicchi convertiti in essa pietra. [Leic. Carta 9B, f. 9 v] Tu hai ora a provare come li nicchi non nascano se non in acque salse, quasi tutte le sorte, come li nicchi di Lombardia 4 livelli29, e così è per tutti li quali son fatti in più tempi, e questi sono per tutte le valli che sboccano alli mari. [Leic. Carta 1B, f. 36 r] 29. La precisa indicazione dei quattro livelli di sedimenti fossili determina la convinzione che il mare abbia coperto la pianura padana a livelli differenti in quattro epoche diverse, confermando la teoria dei diluvi e di un periodico abbassamento del mare o di una successiva inondazione marina, come alternanza fondamentale della vita del mondo, con ere di sconvolgimenti del rapporto tra acqua e terra. All’affermazione generale segue una descrizione dettagliata della stratificazione osservabile in una valle alpina, formata dall’azione dell’acqua del fiume. Il testo successivo estende l’osservazione
197
Come li fiumi à tutti segati e divisi li membri delle grand’alpe l’uno dall’altro; e questo si manifesta per lo ordine delle pietre faldate, che dalla sommità del monte insino al fiume, si vede le corrispondenze delle falde essere così da l’un de’ lati del fiume, come dall’altro. Come le pietre faldate de’ monti son tutti e’ grandi de’ fanghi, posati l’un sopra l’altro per le inondazioni de’ fiumi. [Leic. Carta 10A, f. 10 r] Il Danubio, primo fiume d’Europa per magnitudine… si lascia per mezzo di Austria e Albania, e, per tramontana, Bavaria, Polonia, Ungheria, Valachia e Bosnia. Versava adunque il Danubio, over Danoia, nel mare di Ponto, il quale s’astendea insino vicino all’Austria, e occupava tutta la pianura, che oggi discorre esso Danubio, e‘ l segno di ciò ne mostrano l’ostriche e li nichi e bovoli e cappe e ossa di gran pesci, che ancora in molti lochi si trovano nell’alte coste de’ predetti monti. [Leic. Carta 1B, f. 1 v] Di quelli che dicano ch’e nichi sono per molto spazio nati remoti dalli mari per la natura del sito e de’cieli, che dispone e infruisce tal loco a simile creazione d’animali, a costor si risponderà che, se tale infruenzia d’animali non po’ accadere in una sola linia se non animali di medesima sorte e età, e non il vecchio col giovane, e non alcun col coperchio e l’altro essere con la sua copritura, e non l’un essere rotto e l’altro intero, e non l’uno ripieno di rena marina e rottame minuto e grosso d’altri nichi dentro alli nichi interi che li son rimasti aperti, e non le bocche dei granchi sanza il rimanente del suo tutto, e all’intero corso del Danubio, coperto in tempi remotissimi dal mare, stando alla testimonianza dei fossili presenti sulle montagne.
198
non li nichi d’altre spezie appiccati con loro in forma d’animale che sopra di quelli si movessi, perché ancora resta il vestigio del suo andamento sopra la scorza che lui già, a uso di tarlo sopra il legname, andò consumando. Non si troverrà infra loro ossa e denti di pesce, li quali alcuni dimandano saette e altri lingue di serpenti30, e non si troverrà tanti membri di diversi animali insieme misti, se lì da’ liti marini gittati non fussino. [Leic. Carta 9A, f. 9 r] Ma a dire meglio31, essendo dato il mondo etterno, egli è necessario che li sua popoli sieno ancora loro etterni, onde etternalmente fu e sarebbe la spezie umana consumatrice del sale; e se tutta la massa della terra fussi sale, non basterebbe alli cibi umani. Per la qual cosa ci bisogna confessare o che la spezie del sale sia etterna insieme col mondo, o che quella mora e rinasca insieme cogli uomini d’essa divoratori. Ma se la esperienza c’insegna quel non aver morte, come per il foco si manifesta, il qual nollo consuma, e per l’acqua che di tanto si sala di quanto ella in sè ne risolve, e vaporando l’acqua, sempre il sale resta nella prima quantità, né vale passare per li corpi umani che in orina e sudore o altre superfluità fia ritrovato, e quanto è il sale che ogni anno si porta alle città, dunque direno che le piogge penetratrici della terra sie quella che,
30. Glossopetre erano denominati dagli studiosi i denti fossili di pescecane per la forma a punta di freccia, saette, o per lo stesso motivo lamiarum dentes, lingue di serpenti. Ritenuti a lungo come immagini di pietra e non resti organici di animali marini, come qui fa correttamente Leonardo, sono stati identificati solo nel 1667 da Niccolò Stenone, che analizzò la testa di un grande squalo pescato al largo di Livorno. 31. Il lungo testo era iniziato a G 48 v: Dice Plinio nel secondo suo libro a 103 capitoli che l’acqua del mare è salata perché l’ardore del sole abbronza e secca l’umido. La salinità del mare era una delle questioni che risalivano ai presocratici e ne tratta Plinio, Storia naturale, II, 104, Torino 1982, pp. 347-9.
199
sotto alli fondamenti delle città e popoli, sie quella che per i meati della terra renda la salsedine levata dal mare, e che la mutazione del mare stato sopra li monti, lo lasci per le miniere ritrovate in essi monti, ecc. [G 49 r] Considera bene come, mediante il moto della lingua32, coll’aiuto delli labri e denti, la pronunziazione di tutti i nomi delle cose ci son note, e li vocabuli semplici e composti d’un linguaggio pervengono alli nostri orecchi mediante tale strumento; li quali, se tutti gli effetti di natura avessino nome, s’astenderebbero inverso lo infinito, insieme colle infinite cose che sono in atto e che sono in potenzia di natura: e queste non isplemerebbe33 in un solo linguaggio, anzi in moltissimi, li quali ancora lor s’astendano inverso lo infinito, perché al continuo si variano di seculo in seculo e di paese in paese, mediante le mistion de’ popoli che per guerre o altri accidenti al continuo si mistano; e li medesimi linguaggi son sottoposti alla obblivione e son mortali come l’altre cose create; e se noi concederemo il nostro mondo essere eterno, noi diren tali linguaggi essere stati e ancora dovere essere d’infinità varietà, mediante l’infiniti secoli che nello infinito tempo si contengano, ecc. [Windsor 19045 v] Perché molto son più antiche le cose che le lettere, non è meraviglia se alli nostri giorni non apparisce alcuna scriptura34 32. Si tratta di una descrizione anatomica della bocca e della funzione della lingua, che accompagna i disegni. 33. isplemerebbe = si esprimerebbe. 34. scriptura = scrittura, testimonianza scritta. Analoga riflessione si trova in Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II,5.
200
delli predetti mari essere occupatori di tanti paesi: e se pure alcuna sciptura apparia le guerre, l’incendi, le mutazioni delle lingue e delle leggi, li diluvi dell’acque hanno consumato ogni antichità: ma a noi basta le testimonianze delle cose nate nell’acque salse ritrovarsi nelli alti monti lontani dalli mari talor. [Leic. Carta 6B, f. 31 r] Il sapientissimo Platone philosopho35 approva come in trentasei migliora d’anni questo nostro mondo ritornarà da capo36. [Atl. 790 r, ex 290 v.a] Acquista cosa nella tua gioventù che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù, che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento. [Atl. 310 r, ex 112 r.a] La cognizion del tempo preterito e del sito della terra è ornamento e cibo delle menti umane. [Atl. 1040 v, ex 379 r.a]
35. La calligrafia non è di Leonardo ma dell’allievo Francesco Melzi che lo aveva seguito in Francia. Leonardo nella sua nuova residenza di Cloux, vicino ad Amboise, aveva cominciato a dettargli il Libro di pittura, e anche l’indicazione che Platone calcolava in 36.000 anni il ciclo dell’universo può essere una citazione indicatagli dal maestro da Timeo, XI, 39d, o comunque l’appunto dell’allievo che traduceva per lui passi da Marsilio Ficino, Theologia platonica, Libro IV, cap. II, cit., p. 295. 36. La teoria dell’Eterno Ritorno dell’Eguale, la circolarità del tempo infinito in un universo finito.
201
Quando io crederò imparare a vivere, e io imparerò a morire. [Atl. 680 r, ex 252 r.a] Io continuerò37. [Atl. 673 r, ex 239 r.a]
37. Il foglio presenta la data di mano di Leonardo “A 24 di giugno dì di san Giovanni 1518” nel palazzo di Cloux presso Amboise, messogli a disposizione da Francesco I re di Francia. Pochi mesi dopo iniziava la malattia che lo portò alla morte il 2 maggio 1519, per cui l’incipit di questo appunto interrotto si è caricato di un valore simbolico, “quasi epigrafico (un po’ come il Mehr licht goethiano!)” Villata (2009) p. 154. Per Karl Jaspers (1983) pp. 132-3, è l’indicazione più esatta della sua ambizione alla gloria postuma, per la vicinanza con il mondo antico nella dimenticanza della trascendenza religiosa, con l’implicita affermazione dell’attività umana come unico orizzonte.
203
Bibliografia generale
Opere di Leonardo Da Vinci 1) Biografia. Descrizione e storia dei Codici: Arrighi, V. - Bellinazzi, A. - Villata, E. (a cura di), Leonardo da Vinci. La vera immagine. Documenti e testimonianze sulla vita e sull’opera, Archivio di Stato, Firenze 2005. Brizio, A.M. (a cura di), Leonardo da Vinci, Scritti scelti, Torino 1980 (prima ediz. 1952). Calvi, G., “I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico, Busto Arsizio 1982 (prima ediz. 1925). Marani, P. - Piazza, G.M., Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, Milano 2006. Marcolongo, R., Leonardo da Vinci, Artista-scienziato, Milano 1939.
204
Marinoni, A. (a cura di), Leonardo da Vinci. Scritti letterari, nuova ediz. accresciuta con i manoscritti di Madrid, Milano 1974. Pedretti, C. - Cianchi, M., Leonardo. I codici, Firenze-Milano 1995. Pedretti, C. - Vecce, S., Libro di pittura. Codice Urbinate lat. 1270 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 2 Voll., Firenze 1995. Roberts, J., Catalogo del Codice Hammer, Riproduzione del Codice Hammer, in “Leonardo: il Codice Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo Pedretti. Arte e scienza a Bologna in Emilia Romagna nel primo Cinquecento”, Firenze 1985, pp. 43-138. Solmi, E., Scritti vinciani. Le Fonti dei Manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, (1 ediz. 1908-11) Firenze 1976. Vecce, C., Leonardo, Roma 1998. Zuffi, S., Le acque, la terra e il cielo nella storia universale del mondo, in “Leonardo da Vinci. Della Natura, peso e moto delle acque. Il codice Leicester” Milano 1995.
2) Cronologia delle Edizioni e Antologie: Richter, J.P., The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Voll. London 1883; seconda ed. riveduta 1939, ristampa Edinburgh 1977. Leonardo da Vinci, Scritti scelti. Frammenti letterari e filosofici, a cura di Edmondo Solmi, Firenze 1899 (ristampa Firenze 2006)
205
Leonardo da Vinci, Scritti scelti, a cura di A.M. Brizio, Torino 1952. Leonardo da Vinci, Scritti. Tutte le opere: Trattato della pittura, Scritti letterari, Scritti scientifici a cura di J. Recupero, Roma 1966 (ristampa Milano 2002). Leonardo da Vinci, Scritti letterari, a cura di A. Marinoni, nuova edizione accresciuta con i manoscritti di Madrid, Milano 1974. Leonardo da Vinci, L’uomo e la natura, a cura di M. De Michieli, Milano 1982. Leonardo da Vinci, Scritti, a cura di C. Vecce, Milano 1992. Leonardo da Vinci, Aforismi, novelle e profezie, a cura di M. Baldini, Roma 1993. Leonardo da Vinci, Delle acque, a cura di M. Schneider, Palermo 2001. Leonardo da Vinci, Scritti artistici e tecnici, a cura di B. A gosti, Milano 2002.
Autori antichi. Opere utilizzate e citate AA. VV., I presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di H. Diels -W. Kranz, Bari 1983. Alberti, L.B., Della pittura, edizione critica a cura di L. Mallè, Firenze 1950. Alberti, L.B., L’arte di costruire, a cura di V. Giontella, Torino 2010. Aristotele, Fisica, Del cielo, in “Opere”, 3, Bari 1983.
206
Aristotele, Della generazione e della corruzione, I (A), 1, 314, in “Opere”, 4, Bari 1983. Aristotele, Metafisica, Libro I (A), 980 a, in “Opere”, 6, Bari 1983. Aristotele, Etica Nicomachea, III; 1-4. in “Opere”, 7, Bari 1983. Aristotele, Meteorologia, a cura di L. Pepe, Milano 2003. Barbaro, E., Castigationes plinianae, et in Pomponium Melam, a cura di G. Pozzi, 4 Voll., Padova 1973-1979. Barbaro, E. - Pico della Mirandola, G., Filosofia o eloquenza?, a cura di F. Bausi, Napoli 1998. Boccaccio, G., Decameron, a cura di N. Sapegno, Voll. 2, Torino 1956. Bembo, P., Prose della volgar lingua, Gli Asolani, Rime, a cura di C. Dionisotti, Torino 1966. Bracciolini, P., Facezie, Milano 1995. Brant, S., Stultifera navis, Basilea 1497, ed. italiana Milano 1984. Calmeta, V., Prose e lettere edite ed inedite, a cura di C. Greyson, Bologna 1959. Castiglione, B., Il libro del cortegiano, a cura di G. Carnazzi, Milano 1987. Dante Alighieri, Convivio, Milano 1980. Dante Alighieri, La Divina Commedia, in “Tutte le opere di Dante. Edizione del Centenario”, a cura di Fredi Chiappelli, Milano 1965. Dati, G., La Spera, Firenze 1482.
207
Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di G. Reale, Milano 2005. Epitteto, Manuale, traduzione italiana di G. Leopardi e latina di A. Poliziano, a cura di G. De Ruggero, Milano 1971. Erasmo da Rotterdam. Elogio della Follia, Milano 1985. Ermete Trimegisto, Corpus Hermeticum, a cura di A.D. Nock e A.J. Festugière, Milano 2005. Ficino, M., Sopra lo Amore ovvero il Convito di Platone, Milano 1998. Ficino, M., Teologia platonica, a cura di E. Vitale, Milano 2011. Ippocrate, Aforismi e giuramento, Introduzione di M. Baldini, Roma 1994. Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, 2 Voll., a cura di A. Valastro Canale, Torino 2004. Iustino, Epitome, volgarizzamento di Girolamo Squarciafico, Venezia 1477. Lucrezio, La Natura, Introduzione di L. Canali, testo latino a fronte, Milano 1976. Machiavelli, N., Istorie Fiorentine, in “Tutte le opere”, a cura di M. Martelli, Firenze 1971. Machiavelli, N., Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Seguiti dalle “Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli” di Francesco Guicciardini, a cura di C. Vivanti, Torino 1983. Marullo (Michele Tarcaniota), Hymni naturalis, in Michele Marullo, Poliziano, Iacopo Sannazzaro, Poesie latine, Tomo Primo, Torino 1976. Pulci, L., Morgante, Voll. 2, Milano 1992.
208
Ovidio, P.N., Metamorfosi, Torino 1979. Pacioli, L., De Divina Proportione, Milano 1956. Petrarca, F., Trionfi, Milano 1984. Pico della Mirandola, G., De hominis dignitate Heptaplus De ente et uno e scritti vari, a cura di E. Garin, Firenze 1942. Platone, Apologia di Socrate, in “Opere complete”, Vol. 1, Bari 1984. Platone, Cratilo, in “Opere complete”, Voll. 2, Bari 1984. Platone, Fedone o Sull’Anima, a cura di A. Tagliapietra, saggio critico di E. Tetamo, Milano 1994. Platone, Timeo, a cura di G. Reale, Milano 2000. Plinio, Storia naturale, Voll. I-V, Torino 1982. Poliziano, A., Poesie italiane, a cura di S. Orlando, Milano 1976. Restoro d’Arezzo, La Composizione del mondo, (1282), ediz. critica di A. Morino, Parma 1997. Sanuto, Marin, Itinerario per la terraferma veneta nel 1483, Padova 2008. Seneca, Lucio Anneo, Questioni naturali, a cura di D. Vottero, Torino 1989. Valla, G., De expetendis et fugiendis rebus, Aldo Manuzio editore, Venezia 1501. Vasari, G., Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri, Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, Torino 1992.
209
Letteratura critica AA. VV., Leonardo, a cura di Ladislao Reti, Milano 1974. Bagni, G.T. - D’Amore, B., Leonardo e la matematica, Firenze 2006. Baratta, M., Leonardo e i problemi della terra, Torino 1903. Batkin, L.M., Leonardo da Vinci, Bari 1988, pp. 121-126. Bedini, S.A. - Reti, L., Leonardo e l’orologeria, in “Leonardo”, cit., pp. 240-263. Berti, E., Tempo ed eternità, in Ruggiu, L. (a cura di) “Filosofia del tempo”, Milano 1998, pp. 12-26. Bordonali, P., Leonardo filosofo: i fossili e i tempi del mondo, in Id. “Leonardo a Venezia e nel Veneto”, Silea (TV) 2007, pp. 127-152. Bramly, S., Leonardo da Vinci. Artista, scienziato, filosofo, Milano 1990. Branca, V., Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino 1983. Broc, N., La geografia del Rinascimento, Modena 1989. Brown, D.A., Leonardo da Vinci, origini di un genio, Milano 1999. Brugnoli, M.V., Il monumento Sforza, in “Leonardo”, cit., pp. 86-109. Burckhardt, J., La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1980. Campana, A. Leonardo. La vita, il pensiero, i testi esemplari, Milano 1973.
210
Cassirer, E., Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Firenze 1935 (ristampa 1977). Castelfranco, G., Studi vinciani, Roma 1966. Chastel, A., Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Milano 1992. Chastel, A., Il trattato della pittura, in “Leonardo”, cit., pp. 216-239. Chastel, A., Leonardo da Vinci, a cura di G. Coccioli, Torino 1995. Clark, K., Leonardo da Vinci. Storia della sua evoluzione artistica, Milano 1983. Croce, B., Leonardo Filosofo? (1906), ora in “Saggio sullo Hegel, seguito da altri scritti di varia filosofia”, Bari 1948, pp. 207-234. Cutinelli-Rendina, E., Introduzione a Machiavelli, Bari 1999. De Lorenzo, G., Leonardo da Vinci e la geologia, Bologna 1920. Dionisotti, C., Leonardo uomo di lettere, in “Italia medioevale e umanistica”, V (1962), pp. 183-216, ora in Id., Appunti su arti e lettere, Milano 1995, pp. 21-50. Duhem, P., Études sur Léonard de Vinci: ceux qu’il a lu, ceux qui l’ont lu, 3 Voll., Paris 1906-1913. Ferri, S., (a cura di) Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche, Milano 2000. Forcellino, A., Leonardo a Roma, in “Raccolta vinciana”, XXXVI, Milano 2015, p. 133-161. Frosini, F. (a cura di), Leonardo e Pico. Analogie, contatti, confronti, Firenze 2005.
211
Frosini, F., Vita, tempo e linguaggio (1508-1510), Lettura vinciana, Firenze 2011. Fumagalli, G., Leonardo “omo sanza lettere”, Firenze 1939. Fumagalli, G., Leonardo e Poliziano, in “Il Poliziano e il suo tempo”, Firenze 1957, pp. 131-160. Galluzzi, P., Gli ingegneri del Rinascimento da Brunelleschi a Leonardo da Vinci, Firenze 1996. Galluzzi, P. (a cura di), La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale, Firenze 2006. Garin, E., Il problema delle fonti del pensiero di Leonardo, (1961), ora in Id., La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze 1979. Garin, E. (a cura di), L’uomo del Rinascimento, Bari 1988. Garin, E., Rinascite e rivoluzioni, Milano 1992. Garin, E., Machiavelli tra politica e storia, Torino 1993. Gentile, G., Leonardo, in “Storia della filosofia italiana”, Vol. I, Firenze 1963. Gentile, S., Il ritorno delle culture classiche, in C. Vasoli (a cura di), “Le filosofie del Rinascimento”, Milano 2002, pp. 78-80. Gombrich, E.H., L’eredità di Apelle, Milano 2004. Gould, S.J., I fossili di Leonardo e il pony di Sofia, Milano 2004. Holmyard, E.J., Storia dell’Alchimia, Bologna 2009. Jaspers, K., Leonardo filosofo, a cura di F. Masini, Napoli 1983. Kemp, M., Leonardo da Vinci, le mirabili operazioni della natura e dell’uomo, Milano 1982.
212
Kemp, M., Leonardo. Nella mente del genio, Torino 2004. Koyrè, A., Galileo e Platone, Firenze 1973. Kristeller, P.O., La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento, Firenze 1987. Laurenza, D., Corpus mobile. Tracce di patognomica in Leonardo, in “Raccolta Vinciana”, Fasc. XXVII, Milano 1997, pp. 237-298. Laurenza, D., La ricerca dell’armonia. Rappresentazioni anatomiche nel Rinascimento, Firenze 2003. Laurenza, D., Leonardo nella Roma di Leone X, XLIII, Lettura Vinciana, Firenze 2003. Laurenza, D., Leonardo. Il volo, Firenze 2004. Laurenza, D., Leonardo. L’anatomia, Firenze 2009. Ligabue, G., Leonardo da Vinci e i fossili, Vicenza 1977. Luporini, C., La mente di Leonardo, Firenze 1953. Marani, P.C., Verso nuovi modelli scientifici. Leonardo fra arte, scienza e tecnologia, in C. Vasoli, “Le filosofie del Rinascimento”, cit., pp. 434-451. Marani, P.C., Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da Vinci, Milano 2010. Marinoni, A., L’eredità letteraria, in “Leonardo”, cit., pp. 5685. Marinoni, A., La biblioteca di Leonardo, in “Raccolta v inciana”, XXII, Milano 1987, pp. 291-342. Migliore, S., Tra Hermes e Prometeo. Il mito di Leonardo nel Decadentismo europeo, Firenze 1994.
213
Mondolfo, R., L’infinito nel pensiero dei greci, Firenze 1934; edizione ampliata del 1954, L’infinito nel pensiero dell’antichità classica, ristampa Milano 2012. Mondolfo, R., Figure e idee della filosofia del Rinascimento, Firenze 1963. Nanni, R., Astrologia e prospettiva: per lo studio dell’immagine della scienza nel “Paragone delle arti” di Leonardo, in “Raccolta Vinciana”, XXVII, Milano 1997, p. 13-81. Nanni, R., La natura tra retorica e scienza: un sondaggio nel Codice Arundel, in “Leonardo da Vinci, l’uomo u niversale”, Venezia 2013, pp. 64-69. Pedretti, C., Leonardo architetto, Milano 1989. Pedretti, C., Leonardo. Le macchine, Firenze 1999. Procacci, G., Storia degli italiani, Bari 1983. Ruozzi, G. (a cura di), Teoria e storia dell’aforisma, Milano 2004. Sasso, G., Machiavelli e gli antichi e altri saggi, Vol. II, Milano- Napoli 1988. Sasso, G., Su Machiavelli. Ultimi scritti, Roma 2015. Scarpati, C., Leonardo scrittore, Milano 2001. Tagliapietra, A., La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Torino 2008. Tosi, R., I Greci: gnomoi, paroimiai, apophthegmata, in G. Ruozzi (a cura di), “Teoria e storia dell’aforisma”, cit., pp. 1-16. Tommasini, O., La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli in relazione al machiavellismo, 2 Voll., Torino 1883-1911, II, p. 909.
214
Toussaint, S., Leonardo filosofo dei contrari. Appunti sul “Chaos”, in Frosini (a cura di) “Leonardo e Pico”, cit., pp. 13-35. Valéry, P., Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci (1894), in “Varietà”, a cura di S. Agosti, Milano 1990. Vasoli, C. (a cura di), Le filosofie del Rinascimento, Milano 2002. Vecce, C., La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma 2017. Versiero, M., Dall’eternità del mondo al governo delle città: Leonardo da Vinci, dopo Machiavelli, in “Dopo Machiavelli/Après Machiavel”, Napoli 2008, pp. 33-52. Versiero, M., “La nota del stato di Firenze”. Leonardo e Savonarola: Politica, Profezia, Arte, in “Raccolta vinciana”, XXXV, Milano 2013, pp. 32-42. Vezzosi, A., Leonardo da Vinci. Arte e scienza dell’universo, Milano-Parigi 1996. Vezzosi, A., In viaggio con Leonardo. Invenzioni e macchine di un genio umanissimo, Firenze 2003. Viganò, M., Il “Diluvio di Bellinzona”. Leonardo e “la buzza di Biasca” (1513-1515), Raccolta vinciana, XXXVI, Milano 2015, pp. 75-131. Villata, E. (a cura di), La biblioteca, il tempo e gli amici di Leonardo. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, Novara 2009. Warburg, A., La rinascita del paganesimo antico, Firenze 1980. Wind, E., Misteri pagani nel Rinascimento, Milano 1985.
215
Zammattio, C., Acque e pietre: loro meccanica, in AA. VV. “Leonardo”, cit., pp. 196-7. Zubov, V.P., Leonardo da Vinci, Cambridge (Mass.) 1968.
Indice
Introduzione Gli Aforismi filosofici di Leonardo da Vinci di Paolo Bordonali
p. 9
Avvertenza per il lettore
p. 69
Tavola dei codici
p. 71
I diluvi e il tempo Antologia degli scritti filosofici
Pittura e Prospettiva
p. 77
Aforismi e Pensieri
p. 101
Aforismi sulla Natura
p. 123
Frammenti del Trattato dell’Acqua
p. 147
I Diluvi
p. 163
Tempo
p. 181
Bibliografia generale
p. 203
Canone europeo | 2
Collana diretta da Andrea Tagliapietra
Leonardo da Vinci Filosofo presenta molte sorprese per il lettore di oggi: la sua indagine su i principi della Natura si collega alle origini della filosofia, secondo un atteggiamento tipico del Rinascimento di considerarle più vicine alla verità. Se la sua formazione artistica lo spinge a dare grande importanza all’osservazione dei fenomeni e al disegno, quando vuole fissare l’intuizione ed esprimere le analogie che la mente coglie tra micro e macrocosmo, gli è congeniale l’aforisma. I testi qui raccolti in forma sistematica mostrano la sua intenzione di arrivare a pubblicare la sua filosofia. Inoltre un confronto con il conterraneo Machiavelli mette in evidenza quali erano i contenuti salienti della sua visione cosmologica: diluvi periodici segnano i cicli di distruzione e cambiamento della terra, in cui l’umanità torna allo stato primordiale, nell’eterno ripetersi del mondo.
ISBN E-book 9788885716339
€ 10,00