Critofilm. Cinema che pensa il cinema 9788894189933
Questo ebook è la seconda edizione, ampliata con nuovi saggi e aggiornata nella filmografia, del primo ebook in Italia c
236 32 11MB
Italian Pages [522] Year 2017
Polecaj historie
Table of contents :
Frontespizio
Colophon
Critofilm. Cinema che pensa il cinema
Indice
Nota bene
Nota alla seconda edizione
STORIA
Critofilm. Verso nuove forme di critica e di saggistica
Dal critofilm al video essay: scritture per immagini in rete
Appunti per una storia del critofilm italiano
Piccolo schermo e mitologia del cinema: i programmi sul cinema nella televisione francese
Film sul cinema. Il periodo muto
CRITICA
Critica col cinema
«Look at the way he rides with his legs stretched up!» / Lavorare con fotogrammi, lavorare con inquadrature, lavorare con sequenze
La visione sinottica nel critofilm
I “videosaggi” di Tag Gallagher come paradigma di nuovi modelli di analisi cinematografica
Forme del riuso filmico nel cinema sperimentale. Un inventario personale
VERSIONI ORIGINALI DEI SAGGI STRANIERI
Petit écran et mythologie du cinéma: les émissions sur le cinéma à la télévision française
Films on Filmaking. The Silent Era
Criticism on Film
»Look at the way he rides with his legs stretched up!«
Du tabulaire dans le critofilm
Los “ensayos visuales” de Tag Gallagher como paradigma de nuevos modelos de análisis cinematográfico
APPENDICE
Images sur l’image
Immagini sull’immagine
Una ipotesi cinematografica di linguaggio critico
Critofilm niente eccezioni
APPARATI
Filmografia dei documentari sul cinema
Servizi sul cinema del LUCE, LA SETTIMANA INCOM, Ciac e altri e cortometraggi della Cines, del LUCE e altri
Rubriche periodiche sul cinema della RAI e programmi speciali
Documentari stranieri
Documentari del periodo muto e sul muto
Filmografia di Cinéastes de notre temps (1964-1972) e Cinéma, de notre temps (1989-2016) di Janine Bazin e André S. Labarthe
Webgrafia dei video essays
BIOGRAFIE DEGLI AUTORI
ELENCO DEI FILM PROIETTATI
Citation preview
Critofilm Cinema che pensa il cinema
a cura di Adriano Aprà Seconda edizione aggiornata
Il presente volume viene pubblicato in occasione della 53a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (Pesaro 17- 24 giugno 2017) www.pesarofilmfest.it Festival realizzato con il contributo di: Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino Comune di Pesaro Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale per il Cinema
Critofilm. Cinema che pensa il cinema Seconda edizione aggiornata a cura di Adriano Aprà Pesaro Nuovo Cinema Realizzazione dell’ebook: Eugenio De Angelis © 2017 by Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus Prima edizione: giugno 2016 Seconda edizione aggiornata: giugno 2017 ISBN: 9788894189933
Indice Storia Adriano Aprà, Critofilm. Verso nuove forme di critica e di saggistica Chiara Grizzaffi, Dal critofilm al video essay: scritture per immagini in rete Simone Starace, Appunti per una storia del critofilm italiano Céline Gailleurd, Olivier Bohler, Piccolo schermo e mitologia del cinema: i programmi sul cinema nella televisione francese Kevin Brownlow, Film sul cinema. Il periodo muto Critica Jonathan Rosenbaum, Critica col cinema Michael Baute, Volker Pantenburg, “Look at the way he rides with his legs stretched up!”. Lavorare con fotogrammi, lavorare con inquadrature, lavorare con sequenze Alain Bergala, La visione sinottica nel critofilm Elpidio del Campo Cañizares, I “videosaggi” di Tag Gallagher come paradigma di nuovi modelli di analisi cinematografica Federico Rossin, Forme del riuso filmico nel cinema sperimentale. Un itinerario personale Versioni originali dei saggi stranieri Céline Gailleurd, Olivier Bohler, Petit écran et mythologie du cinéma: les émissions sur le cinéma à la télévision française Kevin Brownlow, Films on Filmmaking. The Silent Era Jonathan Rosenbaum, Criticism on Film Michael Baute, Volker Pantenburg, “Look at the way he rides with his legs stretched up!”. Arbeiten mit Stills, Arbeiten mit Einstellungen, Arbeiten mit Sequenzen Alain Bergala, Du tabulaire dans le critofilm Elpidio del Campo Cañizares, Los “ensayos visuales” de Tag Gallagher como paradigma de nuevos modelos de análisis cinematográfico Appendice
Raymond Bellour, Images sur l’image / Immagini sull’immagine Luigi Faccini, Una ipotesi cinematografica di linguaggio critico Bruno Torri, Critofilm niente eccezioni Apparati Adriano Aprà, Filmografia dei documentari sul cinema Documentari italiani Adriano Aprà, Simone Starace, Servizi sul cinema del LUCE, LA SETTIMANA INCOM, Ciac e altri e cortometraggi della Cines, del LUCE e altri Adriano Aprà, Paolo Luciani, Cristina Torelli, Rubriche periodiche sul cinema della RAI e programmi speciali Documentari stranieri Documentari del periodo muto e sul muto André S. Labarthe, Filmografia di “Cinéastes de notre temps” (1964-1972) e “Cinéma, de notre temps” (1989-2016) di Janine Bazin e André S. Labarthe Chiara Grizzaffi, Webgrafia dei video essays Biografie degli autori Elenco dei film proiettati Edizione 2016 Edizione 2017
Nota bene Questo ebook è provvisto di collegamenti ipertestuali interni ed esterni. Le parole sottolineate e in italics si riferiscono a tutti i collegamenti interni (note, fotogrammi, foto); le parole sottolineate e in grassetto consentono di linkare siti web per avere ulteriori informazioni o per visualizzare video. This e-book is equipped with internal and external hypertext links. Throughout the text underscored words in italics are directly linked to the relevant end note or illustrations (stills or photographs); underscored words in bold link you to websites enabling you to get more information or to watch relevant videos.
Nota alla seconda edizione A parte alcune modifiche al mio saggio di apertura, questa seconda edizione comporta l’aggiunta, in appendice, di tre articoli pionieristici – e purtroppo senza conseguenze – sull’idea di critofilm. Inoltre, sono state aggiunte circa 400 nuove voci alla mia filmografia, equamente divise tra italiani e stranieri. Infine, si è preferito inserire le fotografie all’interno dei testi piuttosto che separatamente. (a.a.)
STORIA
Critofilm. Verso nuove forme di critica e di saggistica Adriano Aprà Il paradosso del cinema “scritto” La critica cinematografica trova un limite nello strumento che sembra costretta a impiegare per esprimersi: la lingua scritto-parlata. Questo limite è dovuto alla non omologia fra l’oggetto della propria analisi (il cinema, o il video) e tale strumento. Si parla di immagini e di suoni servendosi di parole. Non è così per altre arti: la critica letteraria impiega la scrittura per parlare di scrittura. Quella pittorica si serve di parole ma anche di fotografie, meglio se a colori, per parlare di immagini fisse. Quella musicale può citare pagine di spartiti assieme ad analisi verbali. Nel corso della storia del cinema si è peraltro manifestato da tempo il bisogno di utilizzare il cinema per parlare di altre arti. Esistono numerose opere dedicate alle arti visive. Carlo Ludovico Ragghianti ha proposto il termine critofilm d’arte per definire le più esigenti (in Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1952, p. 220), e lui stesso ne ha realizzati 21 (uno però è andato disperso), fra cui Stile di Piero della Francesca (1954) e Cenacolo di Andrea del Castagno(1954).
Possiamo parlarne come di saggi veri e propri, che si servono dei mezzi del cinema, e non solo di una voce fuori campo “illustrata” da immagini, per analizzare o commentare le opere. Sono usciti anche due libri su questi critofilm: Antonio Costa (a cura di), Carlo L. Ragghianti. I critofilm d’arte, Campanotto, Udine 1995, e Caterina La Salvia (a cura di), I critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti. Tutte le sceneggiature desunte, Ed. Fondazione Ragghianti Studi sull’Arte, Lucca 2006. Questi critofilm d’arte sono ancora più preziosi quando riguardano arti dove lo spazio ha un ruolo essenziale, come la scultura e l’architettura. Il film è d’altra parte l’unico mezzo per preservare nel tempo le opere teatrali (comprese le opere liriche) e la danza, anche se non conosco esempi di riflessioni propriamente saggistiche. Lo stesso si può dire della musica (penso tuttavia che un film
come Chronik der Anna Magdalena Bach, 1968, di Danièle Huillet e JeanMarie Straub possa essere considerato come film saggistico sulla musica, e del resto tutta l’opera degli Straub è anche una riflessione saggistica su altre arti). La critica cinematografica pare non porsi il problema, né d’altra parte sembra ambire, come quella letteraria o di altre arti, a una propria autonomia espressiva in quanto letteratura: il critico come artista. Chi sono a livello internazionale i saggisti cinematografici che possano legittimamente far parte di una storia della letteratura? Mi vengono subito in mente alcuni registi, talvolta provenienti dalla letteratura, come Ejzenštejn e Godard, o come Cocteau e Pasolini, ma dovrei invece sforzarmi per pensare a dei critici-critici (che, appunto, restano il più delle volte critici e non saggisti in senso proprio). Indicativo e forse unico in questo senso, e prezioso, è il n. 100, inverno 2016, del trimestrale francese «Trafic» dedicato a “L’écran, l’écrit”, dove si ribadisce con forza la scelta della rivista di concentrarsi su una riflessione saggistica sul cinema che tenga conto della qualtà della scrittura, e dove vengono invitati numerosi critici-saggisti a scrivere su un altro saggista. Al di là della possibilità della saggistica cinematografica di porsi come arte letteraria, cosa che dipende dall’ambizione di colui che scrive, resta un proble- ma molto più semplice di comunicazione: il critico o il saggista cinematografico non può che alludere all’oggetto di cui parla; i film non potranno che essere evocati, più o meno “oggettivamente”. Questo limite accomunava il saggista cinematografico a quello teatrale, perché fino a non molto tempo fa il film, benché tecnicamente arte riprodotta, in pratica era destinato a una visione unica, che permaneva poi nella memoria (certo, si poteva rivedere un film – cosa peraltro non sempre agevole – e con molti sforzi lo si poteva studiare in moviola: ma si trattava di eccezioni). Si è cercato di ovviare al problema della aleatoria riproducibilità tecnica del cinema dotando lo studioso di strumenti che gli consentissero di puntellare la propria memoria con trascrizioni di film, pur sempre ovviamente su carta. Il volume (credo unico nel suo genere) di David Bruni, Il cinema trascritto. Strumenti per l’analisi del film, Bulzoni, Roma 2006, rende ben conto della questione. La pubblicazione di libri con la trascrizione più o meno ben fatta di un film (non quindi la semplice sceneggiatura di lavorazione ma il cosiddetto découpage tecnico ricavato dal film finito, ovvero la sceneggiatura desunta) è comunque relativamente recente, e non diffusissima. Ricordo la pionieristica collana dell’editore milanese Il Poligono che, nell’immediato dopoguerra, propose un modello pressoché insuperato, con descrizioni di film (Entr’acte,
Zuiderzee, Vampyr) inquadratura per inquadratura, compresa la scala dei piani, il numero di fotogrammi di ogni inquadratura, la durata e moltissime riproduzioni di fotogrammi, nonché a volte (Zuiderzee, Vampyr) includendo dei grafici; e quella coeva della milanese Domus, che si “limitava” a riassumere un film con un centinaio di fotogrammi (entrambe dovute all’iniziativa di Aldo Buzzi). C’è poi La corazzata Potiomkin a cura di Pier Luigi Lanza, Fratelli Bocca, Milano 1954, trascrizione altrettanto precisa di quelle de Il Poligono. Il mensile «Bianco e Nero», in vari momenti, ha pubblicato numeri speciali con sceneggiature desunte di alcuni classici, così come la bolognese Cappelli con i volumi “retrospettivi” su Rossellini, Visconti, Antonioni e Fellini. Ricordo anche le (quantitativamente) meritorie schede della rivista francese «Téléciné», che negli anni ‘50-’60 pubblicava in ogni numero la descrizione dettagliata (ma comunque assai semplificata) di un film. E negli anni successivi la serie dell’«Avant-scène Cinéma», con trascrizione integrale dei dialoghi suddivisi in scene, con descrizione dell’azione ma di solito povera di scansioni in inquadrature e priva di fotogrammi. Infine, per tornare in casa nostra, i volumi dei restauri della Philip Morris promossi da Lino Miccichè, il cui modello è poi stato seguito da qualcun altro, nonché la Storia del cinema italiano in più volumi promossa dallo stesso Miccichè per la Scuola Nazionale di Cinema/Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma oggi i libri dedicati a un singolo film (compresi quelli moltiplicati dall’insegnamento universitario) hanno perso molto della loro utilità, come vedremo. I libri di cinema sono di solito illustrati da “foto di scena” (raramente dalle assai più interessanti “foto di set”). Si tratta di un impiego quasi sempre puramente decorativo, tanto per fare “libro di cinema”. Solo di recente (con qualche meritorio caso isolato in passato) si è pensato di introdurre fotogrammi o addirittura di basare le analisi su di essi (Una riflessione stimolante sull’uso di foto di scena e di fotogrammi è quella di Sylvie Pierre, Eléments pour une théorie du photogramme, «Cahiers du Cinéma», n. 226227, gennaio-febbraio 1971, pp. 75-83). Gli esempi non mancano ma non sembrano moltiplicarsi come sarebbe necessario (e va precisato che, a quanto mi risulta, non esistono problemi di “aventi diritto”, semmai solo di accesso alle copie, anche se ormai i fotogrammi si possono facilmente estrarre dai dvd). Pionieristica è l’impresa di Raymond Bellour che in L’analyse du film (Albatros, Paris 1979) basa il suo saggio sulla riproduzione di fotogrammi tratti direttamente dalle pellicole (cosa allora non agevole; e l’edizione italiana – L’analisi del film, Kaplan, Torino 2005 – si arricchisce del colore,
presumibilmente avendo avuto accesso stavolta a dvd). Penso poi ai volumi di Barry Salt Film Style and Technology: History and Analysis, Starword, London 1983 (terza edizione 2009) e Moving Into Pictures: More on Film History, Style, and Analysis, Starword, London 2006 (su cui tornerò), ai tanti volumi di David Bordwell, alla monografia di Tag Gallagher John Ford. The Man and His Films, University of California Press, Berkeley-Los AngelesLondon 1986 (aggiornata nel 2007 sul web con altri fotogrammi), a quella, esemplare per il dettaglio dell’analisi, di Kristin Thompson, Herr Lubitsch Goes to Hollywood. German and American Film After World War I, Amsterdam University Press, Amsterdam 2005; alla Storia del cinema italiano in più volumi promossa dallo stesso Miccichè per la Scuola Nazionale di Cinema/Centro Sperimentale di Cinematografia; e diversi altri meriterebbero di essere ricordati. Ma i capolavori di questo genere di libri fotogrammatici sono italiani, dovuti alla coppia Michele Mancini-Giuseppe Perrella: Pier Paolo Pasolini. Corpi e luoghi, Theorema, Roma 1981, e soprattutto Michelangelo Antonioni. Architetture della visione, Coneditor Consorzio Coop, Roma 1986 (in due lussuosi volumi, con testo anche in inglese sia pure mal tradotto, alla base anche di una mostra). Tuttavia questi libri sono ancora, come dicevo, l’eccezione alla regola. Invece in alcuni siti di riviste on line o di critici, soprattutto anglosassoni – qualcosa di più e di meglio dei cinebloggers –, la pratica del fotogramma sembra essere più diffusa, anche perché la riproduzione, spesso a colori, è “a costo zero” (alcuni esempi di website: riviste come «Senses of Cinema» o «Rouge» ; critici come Jonathan Rosenbaum, David Bordwell o Tag Gallagher; e io stesso ne ho uno www.adrianoapra.it). Il punto è però un altro. Se fino a qualche tempo fa l’accesso problematico alle pellicole poteva giustificare la scarsità di trascrizioni dettagliate e la conseguente generica, o “allusiva”, analisi di film o di gruppi di film, oggi, col digitale, le cose non stanno più così. È ormai possibile studiare il cinema col cinema, o anche col cinema. Il cinema incontra il cinema Dagli anni ‘60 con la televisione e dai secondi anni ‘90 con il digitale e con i dvd si sono moltiplicati i documentari sul cinema, con un incremento esponenziale negli anni 2000, tanto da poterli oggi considerare come un vero e proprio genere. Prima, dal muto agli anni ‘50, solo occasionalmente si registrano esempi analoghi. Si può dire che, aldilà delle occasioni distributive, il bisogno di realizzare documentari sul cinema fosse allora assente perché il cinema non aveva bisogno di pensarsi. Tutte le energie erano concentrate nel crescere. Il cinema veniva semmai promosso e pubblicizzato attraverso i film
di finzione ambientati nel mondo del cinema. Solo quando una generazione ha cominciato ad affacciarsi sulla scena cinematografica essendo cresciuta col cinema ha sentito il bisogno di riflettere su di esso, quasi volesse arrestare il tempo che stava cancallandone la giovinezza. Non è un caso quindi che il primo manifestarsi di tale bisogno nasca, con la serie francese Cinéastes de notre temps e poi con altre a sua imitazione, da una scuola critica, quella dei «Cahiers du Cinéma», che aveva riletto il cinema del passato con passione, e non solo con ideologia, e che aveva fatto dell’intervista ai “vecchi” un suo punto di forza, come a voler fissare, per il momento solo sulla carta, la saggezza dei fondatori. Quella critica innovatrice si era poi rapidamente trasformata in una nuova ondata di cineasti che si è diffusa in tutto il mondo, in grado, forte dell’eredità dei padri, di reinventare dalle fondamenta il cinema. C’è anche un intervento della tecnica. L’intervista filmata ha bisogno di una agevole cinepresa (quasi sempre 16mm insonorizzata) e di una altrettanto agevole registrazione del suono. È ciò che gli esperimenti dei primissimi anni ‘60 col cinema verità hanno consentito. Ecco dunque che l’intervista filmata trova i mezzi tecnici, le possibilità distributive (la televisione) e la ragione di essere (la “scuola critica”) per fiorire. I promotori di Cinéastes de notre temps, dal 1964, sono non a caso André S. Labarthe, ex critico dei «Cahiers du Cinéma», e Janine Bazin, vedova di André, cioè del più influente critico innovatore della stessa rivista (su questo programma si veda André S. Labarthe, La saga “Cinéastes de notre temps”. Une histoire du cinéma en 100 films, Capricci, Paris 2011). Un altro apporto tecnico fondamentale sarà l’arrivo del digitale, che non solo abbassa i costi ma arricchisce il vocabolario espressivo. Un altro pioniere del documentario sul cinema è l’inglese Kevin Brownlow, che non ha una tradizione critica alle spalle ma una passione archeologica per la storia del cinema, specialmente quello muto, e che si cimenta, a cominciare nel 1968 con Abel Gance: the Charm of Dynamite, con una serie di “ritratti” scrupolosamente documentati di cineasti e di periodi della storia del cinema, mentre non rinuncia a scrivere libri sugli stessi argomenti. Più tardi, va ricordato lo storico statunitense Richard Schickel (a cominciare dalla serie The Men Who Made the Movies, 1973). In Italia possiamo considerare pionieri del genere il vecchio Alessandro Blasetti (Gli italiani del cinema italiano, 1964) e il giovane Gianfranco Mingozzi (Michelangelo Antonioni. Storia di un autore, 1966). Luigi Faccini, sulle pagine di «Cinema & Film» (n. 1, inverno 1966-67), teorizza il genere
recensendo il cortometraggio Il cinema di Pasolini (appunti per un critofilm) di Maurizio Ponzi. Prolifici contributi italiani verranno poi da Donatella Baglivo, Mario Canale, Patrizia Pistagnesi, Sergio G. Germani e il gruppo dell’Officina Film Club. Altre tre date sono da menzionare. Del 1966 è il saggio di Raymond Bellour nella «Nouvelle Revue Française» (n. 157, gennaio) Images sur l’image, in cui pone il problema parlando della serie Cinéastes de notre temps. Del 1991 è il saggio del critico statunitense Jonathan Rosenbaum Criticism on Film («Sight and Sound», inverno 1990-1991) – riproposto nel suo saggio per questo ebook – che esplicita la necessità di utilizzare il cinema per parlare di cinema. Del 1995 è la serie promossa in Gran Bretagna bfi Century of Cinema, su singole cinematografie di vari paesi. Sia i saggi di Faccini, Bellour e Rosenbaum sia la serie britannica conferiscono al genere del documentario sul cinema una sorta di statuto ufficiale da parte tanto della critica scritta quanto dell’industria culturale. Negli anni 2000, a conferma di tale statuto, si manifestano rassegne cinematografiche di documentari sul cinema: una riflessione sulla riflessione. Ricordo: Histórias do cinema por si próprio a cura di Ricardo Matos Cabo, 23-27 gennaio 2008, Culturgest, pequeno auditório, Lisbona; Kunst der Vermittlung. Aus den Archiven des Filmvermittelnden Films (Arte della mediazione. Dagli archivi dei film che mediano il cinema) a cura di Michael Baute e Volker Pantenburg, Kino Arsenal, Berlino, ottobre-novembre 2008 e febbraio-luglio 2009 e Österreichischen Filmmuseum, Vienna, 10-13 dicembre 2008; Essay Film Festival, prima edizione, 24-29 marzo 2015, Birkberk Institute for the Moving Image (Londra), seconda edizione, 17-24 marzo 2016 (anche sui documentari sul cinema); Video Essay: Workshop a cura di Chiara Grizzaffi, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Sala Pasolini, Pesaro, 24 giugno 2015 [p. 87]; Double Shadows. Talking About Films That Talks About Films a cura di Tamaki Tsuchida, Yamagata International Documentary Film Festival, 9-13 ottobre 2015; nonché alcuni spazi dedicati al genere in vari festival (p. es. i documentari di Cannes Classics e Venice Classics). Per una critica audiovisiva Ora che il genere dei documentari sul cinema si è consolidato se ne può tentare una descrizione. Da una parte esso può essere suddiviso in sottogeneri: documentari sulla storia del cinema, su singole cinematografie, su singoli autori, su singoli film, su making of. Ci sono poi categorie più particolari: documentari su restauri, su ricostruzione di film perduti, su
ricostruzioni di location, e altre ancora. Dall’altra si possono individuare quattro tipologie: documentari di critica giornalistica (la maggior parte), di critica storica (una buona parte), di critica saggistica (una minoranza) e, sporadicamente, di critica creativa. Quest’ultima tipologia si concentra soprattutto sul riutilizzo di materiale filmico a scopi soggettivamente espressivi, e praticamente si tratta di opere sperimentali autonome rispetto al materiale di base. Come si vede, salvo l’ultimo caso, si ripropongono le tipologie della critica scritta, con lo stesso rapporto quantitativo. Con una differenza importante però: il documentario sul cinema ha uno statuto omologo all’oggetto del suo discorso. Questo è fondamentale. Non più allusioni ma prove. La critica giornalistica, che nei casi peggiori è critica promozionale (specie nei making of), nei casi migliori è una critica informata e documentata, ma senza ambizioni espressive. Ci sono autori di documentari specializzati, il più prolifico dei quali (quasi 300 titoli fra making of e documentari su film) è l’americano, di provenienza francese, Laurent Bouzereau. Ma ricordo anche gli inglesi David Thompson e Paul Joyce e i francesi Claude-Jean Philippe, Nicolas Ripoche, Jonas Rosales (e la casa di produzione Allerton Films). Nei documentari sui film (sempre molto elogiativi, ma con merito) capita spesso di vedere le stesse facce: p. es. negli Stati Uniti, dai registi-cinefili Peter Bogdanovich e Martin Scorsese (a loro volta autori: Directed by John Ford, 1971, 2006; A Personal Journey Through American Movies, 1995, My Voyage to Italy, 1999) ai critici Rudi Behlmer, Leonard Maltin, Richard Schickel. I making of sono di due tipi: quelli realizzati “a caldo”, al momento della lavorazione, e quelli ricostruiti ad anni di distanza, con i testimoni di allora che adesso, invecchiati, ricordano (un caso da segnalare: il mega making of Blade Runner di Charles de Lauzirika, 2007, 214’, cioè più del film stesso di Ridley Scott del 1982). Anche i documentari sugli autori si avvalgono quasi sempre di testimoni (compresi i famigliari), in assenza dell’interessato (se non per qualche materiale d’archivio); ed è a volte imbarazzante vedere attori famosi impietosamente invecchiati. La critica storica si concentra più volentieri sui ritratti d’autore e sui documentari sulla storia del cinema e su singole cinematografie. Qui il lavoro di ricerca e di documentazione è fondamentale. Ma anche in questo caso manca in genere un’ambizione stilistica autonoma, compensata però dalla chiarezza dell’informazione e dalla preziosità dei filmati proposti. Sono gli inglesi in genere a distinguersi in questa tipologia. La critica saggistica è quella che si pone problemi di scrittura, non solo al
livello delle immagini ma anche a quello della voce over che le accompagna, e che spesso è quella dell’autore. L’esempio insuperato sono le Histoire(s) du cinéma di Jean-Luc Godard, iniziate nel 1988, quando c’era solo il video analogico, e terminate dieci anni dopo. In questo campo si distinguono soprattutto i francesi, non a caso data la loro “creativa” tradizione critica: Noël Burch, Bernard Eisenschitz, Alain Bergala, Jean Douchet, Jean-Louis Comolli, Charles Tesson, Serge Toubiana, Noël Simsolo, Céline Gailleurd con Olivier Bohler; ma anche, in Germania: Rainer Gansera, Harun Farocki, Hartmut Bitomsky, Helmut Färber, Manfred Blank e il produttore per la wdr (e occasionalmente regista) Werner Dütsch; in Russia: Oleg Kovalov e Yuri Tsivian; in Spagna: Luciano Berriatúa; in Australia: Adrian Martin con Cristina Álvarez López (con una formula originale, video + testo, visibili sul web; negli Stati Uniti: Thom Andersen, Mark Rappaport, Tag Gallagher, Janet Bergstrom. (Anche io mi sono cimentato con la saggistica audiovisiva, e lascio ad altri giudicare i risultati). È qui che si manifesta veramente un nuovo modo di fare critica, diverso e più incisivo che con la parola scritta, anche se “illustrata”. È questa la nuova frontiera della critica cinematografica, quella che consente, grazie al digitale, di scrivere di cinema col cinema. E, per cominciare, ecco un prezioso sostegno per la didattica, che gli universitari dovrebbero utilizzare. Un solo handicap: il problema dei diritti di citazione, che viene sormontato – salvo opere sontuose come The Pervert’s Guide to Cinema (2006) di Sophie Fiennes con Slavoj Žižek o The Story of Film: an Odyssey (2011) di Mark Cousins – solo quando i saggi visivi (ma anche le altre tipologie) sono prodotti dalla televisione (che può permettersi investimenti altrimenti proibitivi) e, ora, quando sono extra di dvd (il cui editore detiene i diritti del film); e vanno citati fra i più esigenti Criterion negli Stati Uniti (Kim Hendrickson), Eureka in Gran Bretagna (Ron Benson, e ora la figlia Ruth Brukarz-Schofield), Carlotta in Francia (Vincent PaulBoncour), Rarovideo (Stefano e Gianluca Curti) e Ripley’s Home Video (Angelo Draicchio) in Italia. Il problema può essere aggirato quando, più disinvoltamente, i contributi vengono postati sul web. Un passo avanti: per una critica ipermediale Oggi il computer offre la possibilità di affrontare l’analisi critica con un altro strumento espressivo omologo: parlare di immagini in movimento e di suoni con immagini in movimento e con suoni, ma anche con parole scritte o dette, con grafici, e altro ancora; e soprattutto con la possibilità di interrelare gli elementi dell’analisi fra di loro nonché, se necessario, di correlare, tramite il web, ciò che si va dicendo con ciò che altri hanno detto. Su questo terreno è stato fatto sinora, per quanto ne so, troppo poco: ed è
strano. Perché si tratta, per così dire, dell’uovo di Colombo. Perché in altri campi, se non altro come strumento didattico, il computer è largamente impiegato; perché le analisi ipermediali potrebbero diventare un prezioso supplemento dei dvd e dei Blu-ray; perché una nuova generazione di studiosi di cinema, che si suppone abbia più familiarità di uno come me col nuovo strumento, dovrebbe trovare naturale cimentarvisi per la trascrizione del pensiero critico, che inevitabilmente diventerebbe – poiché la materia dell’espressione non può non trasformare il pensiero – una forma nuova di pensiero. Fra i non molti esperimenti a livello internazionale va studiata l’attività promossa da Yuri Tsivian col suo sito lettone (si veda anche il suo Qu’est-ce que le cinéma?: une réponse agnostique, in «Trafic», n. 55, autunno 2005). CineMetrics ha tuttavia il limite, dichiarato, di segmentare il film in inquadrature con un programma manuale che ne calcola la durata in maniera approssimativa e di circoscrivere le rilevazioni ad alcuni elementi soltanto. Esso prosegue di fatto l’analisi statistica introdotta da Barry Salt (misurazione precisa della asl, average shot length, o durata media dell’inquadratura, della scala dei piani e dei movimenti di macchina) nei citati Film Style and Technology e Moving Into Pictures. Si tratta di due volumi riccamente illustrati che estendono il discorso a una storia della tecnologia collegata a quella dello stile, unica nel suo genere, nonché a preziosi esempi di analisi, che hanno non poco influenzato, per esempio, i lavori di David Bordwell. Nonostante i suoi limiti CineMetrics, a cui contribuiscono studiosi di tutto il mondo (spesso poco o per nulla conosciuti), fra cui in modo massiccio Salt, e che periodicamente perfeziona i propri modelli operativi, ha collezionato quasi 18.000 analisi statistiche di film, il che consente di ricavare dati per periodi, per paesi, per nazioni, per autori, ecc.
A CineMetrics aderisce fra l’altro il gruppo dell’Università di Vienna Digital Formalism (i cui studi su L’uomo con la macchina da presa, 1929, di Dziga Vertov possono essere visti nel sito di CineMetrics). Interessanti sono i lavori del gruppo moscovita di Hyperkino, che ha elaborato un sistema di “annotazioni” dei film ora messo in pratica in edizioni DVD di alcuni classici sovietici (si veda anche Natasha Drubek-Mayer, Nikolaj Izvolov, Critical Edition of Films on Digital Formats, in «Cinéma et Cie», fall 2006). Ho potuto vedere le proposte di due studiosi del Dipartimento di Ingegneria Telematica dell’Università Carlos iii di Madrid, Guillermo Ibáñez Fernández e José Jesús García Rueda, che applicano gli strumenti delle concept maps al cinema, in particolare a proposito di Vertigo (1958) di Alfred Hitchcock.
Thomas Elsaesser e Thomas Meder mi hanno parlato di analisi al computer e di videosaggi di film fatti, rispettivamente, con i loro studenti dell’Università di Amsterdam e della Fachhochschule di Mainz; e ho visto quelle egregie realizzate da Amedeo Fago con i suoi studenti di architettura a Valle Giulia a Roma centrate sulle location di film italiani ma non solo. E non dimentico i lavori pionieristici del romano Istituto MetaCultura, in particolare su Rossellini, che hanno costituito lo stimolo iniziale per avventurarmi anch’io in questo campo, assai ostico data la mia formazione. Ricordo infine il dvdStudienfassung (edizione di studio) di Metropolis di Fritz Lang edito nel 2005 dalla Universität der Künste Berlin nel quadro del loro progetto dvd als Medium kritischer Filmeditions (il dvd come mezzo di edizione critica del cinema) e coordinato da Enno Patalas, che propone una navigazione interattiva del film col computer (si veda, anche qui per altri progetti, in tedesco); e la “multimedia edition” di How to Read a Film. Movies, Media, Multimedia (2007) di James Monaco, che è appunto la versione multimediale del suo prezioso libro del 1977 (successivamente aggiornato), edito anche in italiano da Zanichelli nel 2002 col titolo Leggere un film. Cinema, media e multimedia. Ed esiste già una bibliografia sull’argomento curata da Mike Baxter per CineMetrics e una tesi di dottorato di Simone Starace, Per una rilettura di “Madame Bovary” di Jean Renoir (Università degli Studi di Siena, a.a. 2014-2015, tutor Andrea Martini), che analizza il film del 1934 con metodologia digitale. Qualcosa si muove, insomma.
Il problema maggiore, sorto nel mio stesso progetto di analisi ipermediale, è quello della elaborazione automatica dei dati, cioè di un programma informatico dedicato che consenta di calcolare rapidamente tutto ciò che è calcolabile nell’analisi di un film. In altre parole, almeno in una fase iniziale, l’analisi ipermediale avrebbe bisogno della collaborazione fra uno studioso di cinema e un informatico (trovare in una sola persona entrambe le competenze è abbastanza difficile: Yuri Tsivian [Juris Civjans] ha potuto varare CineMetrics grazie alla collaborazione del figlio informatico Gunars Civjans; i due ingegneri madrileni sono anche dei cinefili…). A parte il programma “semplificato” di CineMetrics, conosco solo un altro tentativo in questa direzione, quello (successivamente sospeso) del gruppo francese IRI (Institut de Recherche et d’Innovation) con il suo programma Lignes de temps. Si tratta del programma più vicino a ciò che io ritengo necessario per l’analisi approfondita di un film. Non a caso si chiama “linee di tempo/i”, analogamente alla timeline di programmi di montaggio come Final Cut Pro, Adobe Premiere o Avid. Si tratta in sostanza di fare l’operazione inversa: smontare, sia a livello visivo che sonoro, ciò che è stato montato. Il programma di Lignes de temps consente di acquisire un film da dvd e scomporlo automaticamente in inquadrature. Ogni inquadratura può quindi essere indicizzata in base a determinate variabili formali e contenutistiche: scala dei piani, movimenti di macchina, musica, ambienti, personaggi in scena ecc. In questo modo il film diventa “navigabile” come un vero ipertesto, nel senso che è possibile “saltare” da un primo piano all’altro o da un carrello all’altro, con accostamenti anche inaspettati che ci permettono di cogliere equilibri e relazioni segrete fra le varie parti dell’opera. Il limite principale del programma, almeno per ora, risiede però nella sua scarsa praticità di utilizzo, che non permette agevolmente di lavorare sul film e, inoltre, non consente di esportare con facilità i risultati dell’analisi, salvandoli e mettendoli così a disposizione di un più ampio pubblico di studiosi.
Quanto alla mia proposta di analisi ipermediale, realizzata nel 2009 con Sara Leggi e Simone Starace su Zangiku monogatari (Storia dell’ultimo crisantemo, 1939) di Kenji Mizoguchi – senza un programma dedicato ma creando manualmente i tanti link che la caratterizzano (cosa che ha richiesto mesi di lavoro, quasi impossibili da ripetere per un’altra proposta), e per ragioni di diritti utilizzando solo fotogrammi, ma in abbondanza –, basta collegarsi qui e avere la pazienza di navigare fra le tante opzioni che vi sono contenute.
(Grazie a Raymond Bellour per alcuni suggerimenti. Il primo e l’ultimo paragrafo riprendono parte del mio Per un’analisi ipermediale del film, in Cristina Casero, Michele Guerra, a cura di, Le immagini tradotte. Usi passaggi trasformazioni, Diabasis, Reggio Emilia 2011). Pubblicato, in edizione interattiva, e qui integrato, nell’ebook da me curato Critofilm. Cinema che pensa il cinema, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro 2016
Dal critofilm al video essay: scritture per immagini in rete Chiara Grizzaffi Nell’introduzione al suo The Secret Life of Moving Shadows Mark Rappaport descrive l’inevitabile difficoltà dello scrivere e del parlare di cinema con un tono a metà fra il comico e il malinconico: «You’re trying to pick up sand with a fork, you’re trying to extract the soul from the body with a pair of tongs and tweezers. You’re lunging to embrace shadows that vanish just when you think you’re about to touch them» [1]. Prima dell’avvento di supporti di registrazione e archiviazione di immagini cinematografiche, come VHS e DVD, il critico e lo studioso di cinema erano condannati a cercare di catturare – di imprimere nella propria memoria, talvolta di scarabocchiare su carta – le immagini che si rincorrevano sullo schermo e a tradurle in parole per prolungare il piacere di un’esperienza, quella della visione, rigorosamente limitata da un luogo (la sala) e da un tempo (quello di durata del film) ben precisi [2]. Le tecnologie digitali non solo hanno reso i film fruibili in luoghi e su devices diversi ma consentono anche di intervenire sulle immagini in modi che vanno oltre la rottura della fruizione continua e lineare del film (consentita dalle VHS e, in modo ancora più efficace, dal DVD): si tratta del fare testuale di cui parla Francesco Casetti, «determinato dal fatto che lo spettatore ha sempre più la possibilità di manipolare il film che fruisce, non solo nel senso di “aggiustarlo” alla propria visione […] ma anche nel senso di intervenirci sopra espressamente (è quello che succede con i filmati rimontati e risonorizzati che popolano YouTube […])» [3]. Queste pratiche sono agevolate dagli strumenti di editing digitale, che nella loro versione consumer fanno parte delle dotazioni di ogni computer – si pensi a Movie Maker per Windows o a iMovie per Mac –, e hanno come conseguenza più vistosa la proliferazione in rete di immagini cinematografiche sotto forma di fake trailers, vids, mash-up, GIFs (Graphics Interchange Formats), che vengono incessantemente condivisi, postati e linkati su blog e social network. Prassi di rimontaggio e manipolazione dell’immagine che appartenevano a determinate élites artistiche e culturali diventano oggi una fra le tante declinazioni possibili del rapporto che intratteniamo con il patrimonio cinematografico. E quello che, per critici e studiosi, era “il sogno di una cosa”, cioè riuscire a dire il cinema con il cinema, diventa invece una sfida possibile. Di cosa parliamo quando parliamo di video essay Con il termine video essay [4] sono convenzionalmente indicati quei lavori
che rimontano e remixano immagini cinematografiche per suggerire spunti analitici, per veicolare riflessioni critiche o talvolta, più semplicemente, per mostrare con l’immediatezza delle immagini un’intuizione e condividere una suggestione visiva. Sarebbe impossibile determinare con precisione le tappe di un ipotetico sviluppo cronologico di questa forma di critica e analisi audiovisiva online, che certo esisteva ben prima della sua diffusione in rete: si potrebbe dire che ci sia una sorta di filiazione diretta con gli extra su DVD, a loro volta una declinazione digitale del “critofilm” (cfr. l’intervento di Adriano Aprà in questo volume). Ma andrebbe ricordata almeno, oltre alla tradizione del documentario sul cinema, anche l’influenza di altre pratiche che fanno del (ri)montaggio uno strumento in grado di produrre significato intorno e attraverso il patrimonio cinematografico: il film di found footage sperimentale, da Rose Hobart (1936) di Joseph Cornell fino a The Clock di Christian Marclay (2010), e il film-saggio, forma altrettanto sfuggente (Phillip Lopate lo definisce un “centauro” [5], una creatura mitologica ibrida che appartiene al regno dell’immaginazione) in cui si declina la relazione intima, soggettiva, di un Io con il Mondo [6]. Il video essay, però, è una forma espressiva fortemente ibridata non solo con le altre prassi di rimontaggio appena descritte ma anche con le forme ludiche di remix legate per esempio alla fan culture. Proveremo qui a delineare un percorso a partire dai primi tentativi di studiosi e critici di proporli come forma alternativa o integrativa della riflessione scritta e individuare alcuni luoghi deputati alla condivisione di video essay. Intorno alla metà degli anni Duemila – periodo in cui vengono anche lanciate le principali piattaforme di videosharing, come YouTube e Vimeo – alcuni blogger e studiosi di cinema iniziano a produrre e a condividere in rete, accanto alle più tradizionali recensioni scritte, delle videoanalisi. È il caso del critico e filmmaker statunitense Kevin B. Lee, che nel 2007, nell’ambito del suo progetto online Shooting Down Pictures, pubblica una recensione del film di Fritz Lang While the City Sleeps (Quando la città dorme, 1956), analizzando tramite voice over le tematiche del film e rimontandolo selezionando le scene più rilevanti ai fini della sua argomentazione [7]. Lee chiede ai lettori del blog un’opinione sul potenziale di questo «format of analysis», soffermandosi nei commenti anche sull’aspetto della realizzazione tecnica del video, montato in totale autonomia dal critico utilizzando iMovie. Più o meno nello stesso periodo altri critici si cimentano con il formato audiovisivo. Per esempio, Jim Emerson nel blog “Scanners” su «RogerEbert.com» [8] condivide un video dedicato al volto e al primo piano
nel cinema, o Matt Zoller Seitz, che per “Moving Image Source” realizza la serie The Substance of Style, dedicata agli autori che hanno influenzato il cinema di Wes Anderson [9].
Fra i primi studiosi a condividere in rete i propri lavori audiovisivi ci sono Christian Keathley, che nel 2006 realizza Pass The Salt, analisi dettagliata di una scena di Anatomy of a Murder (Anatomia di un omicidio, Otto Preminger 1958), e Catherine Grant. Attivissima in rete – è curatrice, fra le altre cose, di un blog, “Film Studies For Free”, considerato un punto di riferimento dalla comunità scientifica per il preziosissimo lavoro di selezione e condivisione delle pubblicazioni online su cinema e media – Grant realizza il primo di una lunga serie di video essay nel 2009: si tratta di un’analisi di Les bonnes femmes (Donne facili, Claude Chabrol, 1960) dal titolo Unsentimental Education [10]. Inoltre, dal 2011 gestisce un forum su Vimeo, “Audiovisualcy” [11], che seleziona e archivia i video essay condivisi sulla piattaforma di video sharing. Finora “Audiovisualcy” ha raccolto più di mille video essay. In quasi un decennio il video essay, da vezzo cinefilo di critici e studiosi che sui propri blog personali sperimentavano il potenziale creativo derivante dalla possibilità di catturare, rimontare e condividere immagini cinematografiche, si trasforma in una pratica sempre più diffusa in diversi ambiti. Tra i blog e i siti di critica che raccolgono, insieme a recensioni scritte, anche video essay ricordiamo almeno «Press Play» [12], blog sul sito statunitense “Indiewire” fondato da Matt Zoller Seitz e Ken Cancelosi, e oggi sotto la direzione di Max Winter; il sito della storica rivista britannica «Sight and Sound» [13]; il magazine spagnolo «Transit» [14], diretto da Covadonga G. Lahera e Carles
Matamoros Balasch; «FilmScalpel» [15], nato nell’estate del 2015, sito dedicato solo ai video essay, che pubblica sia video prodotti dai curatori sia da altri autori (esempi di “best practices” secondo il team di «Filmscalpel») accompagnati da una breve descrizione o da un commento critico. Particolarmente utile, poi, il glossario a disposizione sul sito, che offre brevi definizioni di alcuni termini ricorrenti (video essay, mash up, appropriation, supercut ecc.) e i link ad alcuni esempi o ad approfondimenti bibliografici. Un caso molto interessante è costituito da blog e sezioni critiche ospitate su piattaforme di VoD come MUBI [16] o Fandor (fruibile al momento solo in Canada e negli Stati Uniti) [17]. Nel solo 2015 Fandor ha pubblicato più di settanta video essay, imponendosi come uno dei principali luoghi online di diffusione di queste pratiche. Perfino Criterion[18], marchio per eccellenza della distribuzione di film d’autore, ha iniziato a promuovere le proprie uscite anche attraverso la pubblicazione di video essay commissionati ad alcuni dei videosaggisti più noti della rete, come kogonada [19]. Alcune riviste accademiche internazionali online annoverano, fra i propri contributi, dei videosaggi, il più delle volte accompagnati da un saggio scritto: «NECSUS» [20] ha una sezione dedicata agli “audiovisual essays” curata da Adrian Martin e Cristina Álvarez López; riviste come «Frames Cinema Journal» [21] o «The Cine-Files» [22] incoraggiano l’invio di materiali video in alternativa o in aggiunta ai più consueti articoli scritti. A promuovere la legittimazione del video essay come prassi accademica e di ricerca si impegna dal 2014 «[in]Transition», [23] primo journal online espressamente dedicato ai “videographic film and moving image studies”, che ospita solo contributi audiovisivi sottoposti a open peer review, equiparando quindi i propri processi di selezione a quelli delle riviste accademiche che ospitano saggi scritti. Sono sempre più numerosi poi i corsi universitari che utilizzano il video essay come strumento e metodologia didattica [24]. Da questo excursus, estremamente sintetico e senz’altro parziale [25], emerge con chiarezza quanto il termine video essay finisca per designare, in realtà, una complessa varietà di pratiche audiovisive che accomunano tanto il cinefilo di cui a volte si conosce solo il nickname quanto il critico cinematografico professionista, tanto studiosi quanto filmmaker. Dato il complicato intreccio di modelli adottati, di esigenze comunicative e di formazione e profilo professionale degli autori, è quasi impossibile dare una definizione univoca di una forma costitutivamente ibrida, meticcia. Un primo tentativo in direzione di una possibile organizzazione delle forme videosaggistiche è quello di Christian Keathley, che nel suo La caméra-stylo. Notes on Video Criticism and Cinephilia [26] distingue due tipologie (o
meglio due estremi di uno spettro entro i quali ciascun lavoro si può collocare): explanatory, caratterizzato da finalità didattico-argomentative, e caratterizzato principalmente dall’utilizzo del commento in voice over, come certi extra su DVD, e poetic, semanticamente più opaco, indecifrabile, contraddistinto da strategie formali prese in prestito, per esempio, dal film di found footage sperimentale. Ma si tratta di una distinzione che inevitabilmente finisce per risultare riduttiva, in parte inadeguata a restituire la varietà e la complessità di tali pratiche. Ogni tentativo di delimitare un territorio, quello della produzione online di video essay, caratterizzato come tutti i fenomeni in rete da continue evoluzioni, mutamenti, apparizioni e sparizioni, rischia di rivelarsi fallimentare in partenza. Può essere proficuo però interrogarsi sui modi in cui il video essay lavora sulle immagini, su quali strategie retoriche e linguistiche adotta, e sulle relazioni che questa forma audiovisiva intrattiene con la tradizione della critica e degli studi sul cinema. Il rimontaggio nei video essays: strategie formali Gli ultimi lavori di Mark Rappaport, come Debra Paget, For Example (2015) sono stati realizzati nel suo appartamento parigino, utilizzando un Mac e il programma di montaggio Final Cut [27]. Se i supporti come VHS e DVD rendono possibile, perfino banale, un gesto fondamentale come l’arresto sull’immagine, o la cattura di un singolo fotogramma, in un «funzionale addio alla critica e alla spettatorialità della memoria» [28], il montaggio digitale trasforma il film in una materia plastica infinitamente manipolabile. La timeline dei software di editing consente, attraverso le miniature, di abbracciare con lo sguardo il film nella sua interezza, di vederlo dispiegarsi nello spazio. Grazie alla disponibilità e alla semplicità di utilizzo dei software di editing non professionali, per realizzare un video essay «the critic or scholar has no need of a television studio or crew; they alone can be the expert author of the work, as they most often are in the written text, even though, of course, the act of “doing it alone” may require the acquisition of the same specific media skills» [29]. Oltretutto, la dimensione “domestica” e in molti casi amatoriale della produzione videosaggistica non va necessariamente a detrimento della qualità e della ricchezza espressiva delle soluzioni formali adottate per comunicare attraverso le immagini. Lungi dal rinunciare all’impiego del linguaggio verbale, il video essay sfrutta le molteplici combinazioni possibili fra testo scritto o commento sonoro e le immagini [30]. Il commento audio è, come nel documentario sul cinema, uno degli strumenti, se non lo strumento principale, di un lavoro con funzione
argomentativa, che ambisca a far comprendere con chiarezza una tesi. Accanto ai lavori caratterizzati da un registro formale e da un’argomentazione più accademica (Frames of Mind, di Jordan Tynes e Maurizio Viano, 2014, Fembot in a Red Dress, di Alyson de Fren, 2015, solo per citarne alcuni) [31], vi sono video che adottano invece un registro più informale e un tono diretto: è il caso, per esempio, dei video di Tony Zhou, filmmaker di San Francisco il cui Tumblr e canale YouTube Every Frame a Painting sono fra i più seguiti. Zhou usa un linguaggio semplice e chiaro e uno stile informale e brillante particolarmente adatto alla rete.
Molto interessanti sono poi i risultati della contaminazione tra finalità criticoanalitiche e tentativi di finzionalizzazione, o tra il videosaggio e la forma soggettivo-diaristica di uno dei suoi modelli, il film-saggio appunto. In ADAPTATION.’s Anomalies (2016) lo studioso statunitense Jason Mittell analizza il film di Spike Jonze dal titolo omonimo (Il ladro di Orchidee, 2002), ma nel cercare di dipanarne la struttura narrativa, di rivelarne le presunte chiavi interpretative, Mittell finisce per trasformare lo stesso video essay in un testo ambiguo, in cui verità e finzione si confondono: «My own voiceover takes inspiration from the film, purposely leaving it unclear exactly how much I mean what I’m saying—if Kaufman serves, at least in part, as an unreliable narrator, perhaps I stand as an unreliable critic» [32]. In SFR, Christian Keathley rievoca un film visto da bambino, Swiss Family Robinson (Robinson nell’isola dei corsari, Ken Annakin, 1960), e ricorda come, da giovane spettatore, egli tracciasse genealogie imprecise, connessioni inesistenti, biografie tanto fantasiose quanto inesatte di alcuni degli interpreti. Le immagini dei film, dei personaggi e dei luoghi rievocati da Keathley sono
continuamente inframmezzate da un cartello, su fondo nero, che recita «This confused me at an early age»: un riferimento anche alla propria vicenda personale – Keathley viene cresciuto dai nonni, e scopre solo da ragazzo che il padre è in realtà quello che per lungo tempo ha considerato il proprio fratello maggiore [33]. SFR è tanto il racconto di un vissuto personale, la confessione intima di uno spettatore, quanto una riflessione più generale sull’esperienza cinematografica e su «quell’altro cinema ricomposto a tal punto dai nostri ricordi e dalle nostre parole da differire profondamente rispetto a ciò che veniva presentato dallo svolgimento della proiezione» [34]. Altrettanto presente è il testo scritto, sotto forma di sottotitoli, intertitoli, epigrafi e altri inserti grafici. La quantità di testo scritto utilizzata all’interno del videosaggio oscilla da una presenza minima, poco invasiva (per esempio, quando si forniscono brevi indicazioni come i titoli dei film mostrati o alcune parole chiave utili a orientare l’utente rispetto al significato del video o alla lettura che si vuole dare del film), a una sorta di onnipresenza che punteggia continuamente l’immagine, quasi a sostituire la voice over. In Interplay (2015), Catherine Grant adotta una strategia ricorrente nei suoi lavori, limita cioè il testo scritto a una citazione mostrata alla fine del video e tratta in questo caso da un saggio di Annette Kuhn, Cinematic Experience, Film Space, and the Child’s World [35]: le immagini, prive di parole e accompagnate soltanto da due diversi brani musicali, sono chiaramente ispirate dagli studi recenti di Kuhn sul cinema come esperienza che evoca i processi transizionali dell’infanzia, in cui il bambino impara a distinguere fra la propria realtà interiore e il mondo esterno. La suggestiva successione di immagini cinematografiche che rappresentano momenti di intimità familiare, giochi e lacrime infantili, e soprattutto l’attraversamento di diverse soglie (porte, finestre) per scoprire il mondo fuori dallo spazio domestico illustrano con straordinaria chiarezza le parole di Kuhn. La varietà nell’utilizzo della scrittura è soprattutto stilistico-formale: in generale mancano usi poetici e riflessivi della parola scritta, come nelle Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 1988-1997), in cui essa, oltre a essere un segno visivo, plastico, da modellare come l’immagine, “rompe” il meccanismo di immedesimazione e assuefazione all’immagine [36]. L’organizzazione del rimontaggio delle immagini nel video essay può basarsi su due possibili strategie: montaggio sequenziale o montaggio spaziale [37], messa in fila o accostamento tramite split e multiple screen – due strategie che possono anche coesistere nello stesso video. Quando c’è la voice over, e un tipo di procedere argomentativo più didattico, le immagini sono sovente organizzate in sequenza sulla base dello script recitato dalla voce. Ma la
messa in sequenza può anche puntare a far emergere delle contrapposizioni dialettiche: in A Lovely Film About Killing (2016) Ian Magor, dottorando a Birkbeck, contrappone alle immagini realistiche e raccapriccianti dell’omicidio di un uomo in A Short Film About Killing (Krzysztof Kieślowski, 1988) le immagini fortemente stilizzate ed estetizzanti degli omicidi dei personaggi femminili in Topaz (Alfred Hitchcock, 1969). Il montaggio sequenziale è poi il principio di organizzazione di una delle forme più popolari di video essay online, la “compilation” di motivi stilistici o tematici, dalle caratteristiche molto simili a quello che viene chiamato supercut: «a compilation of a large number of (short) film clips, focussing on a common characteristic these clips have. That commonality can be anything: a formal or stylistic aspect, a shared theme or subject matter» [38]. Diventato popolare soprattutto come ironico smascheramento di cliché e frasi fatte in film o programmi televisivi, il supercut nella sua declinazione videosaggistica è invece un utile strumento per mettere in evidenza il ricorrere di determinati motivi figurativi anche in opere cinematografiche profondamente diverse o, più comunemente, la cifra stilistica di un autore. In Hands of Bresson (2014) di kogonada, la forza espressiva delle mani dei personaggi del cinema di Bresson, la loro capacità di esprimere con la stessa forza di un primo piano sentimenti ed emozioni emerge con straordinaria chiarezza attraverso il montaggio, efficace e suggestivo. In quanto forma paradigmatica, questo tipo di video essay non procede secondo nessi causali ma per accumulo di elementi simili, di infinite varianti possibili [39]. Il video essay si serve di split e multiple screen per ricostruire percorsi di relazione fra le immagini, in continuità – più che con il cinema narrativo – con certe installazioni museali che sfruttano la proiezione su più schermi. L’utilizzo dello split screen permette quel tipo di analisi comparativa già praticata, tramite il doppio proiettore, negli studi di storia dell’arte: consente di abbracciare con lo sguardo, in modo immediato, due testi diversi, di rilevarne analogie e differenze, e quindi di verificare in modo molto efficace i nessi intra e intertestuali. Per esempio, diversi video sono stati realizzati per confrontare le due versioni (muta e sonora) di Blackmail (1929) di Alfred Hitchcock: Garden of Forking Paths? Hitchcock’s BLACKMAILs (2012) di Catherine Grant, Sound and Silent: The Murder Sequence in Hitchcock’s Blackmail e Sound and Silent: The “Knife” Sequence in Hitchcock’s Blackmail (2014) di shiro iioka accostano diversi momenti delle due versioni per mostrare con chiarezza quanto la costruzione delle scene sia stata ripensata in funzione dell’introduzione della nuova tecnologia. In What is Neorealism? kogonada
utilizza la voice over insieme a inserti di testo, reverse motion, slow motion, freeze frame, accelerato e split screen per confrontare la versione originale di Stazione Termini (1953) di Vittorio De Sica con quella rieditata per volontà di Selznick (Indiscretion of an American Wife, 1953), cercando così di individuare le differenze fra la sensibilità europea di De Sica e lo stile dello studio system hollywoodiano.
The Spielberg Touchscreen (2016) di Ken Provencher, docente alla Josai International University di Tokyo, cerca di dimostrare quanto nella filmografia di Spielberg sia fondamentale la dimensione tattile. Per Provencher nel cinema del regista statunitense c’è una sorta di “visione tattile”: il toccare superfici, oggetti, schermi è spesso un momento di scoperta dal punto di vista narrativo ma anche di stimolazione sensoriale per lo spettatore. Per provare la sua argomentazione Provencher ricorre allo split screen: mettendo in contrapposizione i film “dell’impegno” e i blockbuster spettacolari della filmografia spielberghiana Provencher fa collassare questa distinzione e fa dialogare momenti simili in film molto diversi e cronologicamente distanti [40], ricorrendo appunto a una strategia comparativa in cui il visivo e il sonoro si richiamano a vicenda oppure creano un’opposizione dialettica. I riquadri possono talvolta moltiplicarsi fino a rendere lo schermo una sorta di mosaico, in cui l’utente sceglie di volta in volta un percorso dello sguardo tra i molteplici possibili: è il caso di Intersection (Catherine Grant, Denise Liège, 2014) [41], che offre la possibilità di vedere in simultanea attraverso i riquadri multipli i nove, differenti momenti di In the Mood For Love (Wong Kar-Wai,
2000) accompagnati dal medesimo leitmotiv musicale.
In quanto forma (ri)nata e diffusasi attraverso la rete, il video essay tiene conto anche delle modalità di fruizione consentite da internet: il video online è pensato per essere visto e rivisto, messo in pausa, riguardato, e proprio per questa ragione, anche tenendo conto della fruizione distratta degli utenti della rete, spesso impegnati in più attività contemporaneamente, si può concedere una velocità e una densità visiva maggiori rispetto al documentario sul cinema, soprattutto quello di impronta più didattica realizzato per altri mezzi, come la televisione. Il video essay tra ripetizione e innovazione «I will NOT be doing a Wes Anderson video essay. The market is saturated and I have nothing to add». [42] Questo post di Tony Zhou rivela quanto il video essay, pur costituendo una forma innovativa di riflessione sul cinema, finisca in realtà per poggiarsi non solo su alcune nozioni collaudate molto care alla critica su carta stampata – in primis, quella di autore cinematografico – ma anche per focalizzarsi soltanto su alcuni registi. I supporti per la visione dei film, come VHS e DVD, hanno certamente reso possibili analisi dettagliate di singoli film in modi in precedenza impensabili; il video essay permette anche, in qualche modo, di raccogliere e di esibire “le prove” di quanto affermato in sede di analisi. Come sottolinea Christian Keathley, la prassi di individuazione di determinate marche stilistiche, di ossessioni visive e tematiche che costituiscono la cifra di un autore risale almeno alla formulazione della politique des auteurs da parte dei giovani
turchi dei «Cahiers du Cinéma», e vede il critico cinematografico procedere in modo non dissimile dal connoisseur, dall’esperto d’arte che procede all’attribuzione di un dipinto analizzandone tutti i particolari, soprattutto quelli meno evidenti [43]. Questo processo di individuazione e di attribuzione trova evidentemente nel video essay uno strumento di dimostrazione efficace. Di conseguenza, si sono moltiplicati in questi anni i video dedicati ad autori noti e dalla cifra visiva particolarmente coerente: Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Wes Anderson, appunto. Le compilation di motivi visivi, senza accompagnamento in voice over, sono fra i contributi più visualizzati e condivisi in rete. Non stupisce, quindi, che Criterion abbia iniziato una collaborazione proprio con kogonada, i cui video sono per la maggior parte brevi e suggestive compilation dedicate a singoli autori che hanno solitamente molto successo online: per la società di distribuzione che ha fatto proprio del cinema d’autore – inteso come cinema “di qualità”, per il quale l’autore funziona quindi anche come nome di richiamo, come garanzia di un prodotto “alto” – i video essay diventano così un’ulteriore, fondamentale forma di promozione. È proprio l’incontro tra distribuzione cinematografica e produzione di videosaggi critico-analitici che determina, nel caso di questi ultimi, la necessità di creare contenuti appetibili, che ricevano tante visualizzazioni: Kevin B Lee ha raccontato la sua esperienza con Fandor all’ultimo Festival di Berlino, sottolineando quanto sia difficile trovare un equilibrio tra contenuti accessibili e accattivanti che siano, allo stesso tempo, in grado di stimolare riflessioni nuove; troppo spesso, per Lee, ci si concentra solo su autori molto noti o sui film che rientrano nel canone delle opere principali della storia del cinema [44]. Il meccanismo di diffusione virale dei remix in rete si basa su un processo di ripetizione e imitazione [45]: non sorprende quindi la continua ripresa di formule di successo, anche nel caso dei video essay. Il video virale dello statunitense Jacob T Swinney, First and Final Frames (2015), accosta tramite split screen i primi e gli ultimi fotogrammi di diversi titoli cinematografici. In poco tempo il video ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni e la sua formula, semplice ma efficace, è stata imitata da diversi lavori (First and Final Frames – Horror Edition, Zach Prewitt, 2015; First and Final Frames of Series, Celia Gómez, 2015 [46]; Valar Morghulis|The First & Last Character Shots in Game of Thrones, Fernando Andres, 2016 [47]). La stessa sorte è toccata a molti video di kogonada: da Wes Anderson // Centered e Kubrick // One Point Perspective derivano, per esempio, Amelie: Simmetry and Camera Movement (2016) di Lessa Räbiger, Peter Greenaway // Centered (2014) di LaurentG e Aronofsky: Spirals and Simmetry (2014) di Studio Little. Certe ripetizioni ossessive, però, corrono il rischio di svuotare
di senso tanto la matrice quanto le varie copie/filiazioni, per le quali diventa sempre più difficile (o perfino irrilevante) innestare elementi di novità. Eppure, al di là della produzione più evidente perché più condivisa sui social, sui blog, sui siti internet dei quotidiani, lo spettro degli argomenti affrontati nei video essay, e delle cornici interpretative, è molto ampio e rispecchia almeno in parte la complessità e la diversità di direzioni che i film studies e la critica hanno percorso nel tempo: i video hanno per oggetto l’opera di un determinato regista ma anche performance attoriali oppure il lavoro di altre figure della produzione e della postproduzione, come direttori della fotografia e montatori; vi sono recensioni di singoli film, analisi debitrici della Feminist Film Theory – il contributo di studiose femministe come Laura Mulvey e Pam Cook [48] è fondamentale, ed entrambe si sono anche dedicate ai videosaggi –, le osservazioni di stampo formalista di David Bordwell, video essay dedicati a ricognizioni storiche, e così via. Anche le questioni di grammatica e sintassi filmica – molto complesse da descrivere con la sola parola scritta e per questo trascurate dalla critica su carta, che tante volte si concentra più su questioni di natura tematica – sono oggetto di numerosi video che, per chiarezza e accuratezza, possono costituire un valido strumento di introduzione al linguaggio filmico: The Dutch Angle (Jacob T. Swinney, 2015), Why Framing Matters in Movies (Chloe Galibert-Laîné, 2016), Paul Thomas Anderson - Every Whip Pan (Kevin B. Lee, 2013), Costructive Editing in Robert Bresson’s Pickpocket (David Bordwell, Erik Gunneson, 2012), solo per citarne alcuni.
Altrettanto interessanti sono gli approcci che combinano il rimontaggio con
l’utilizzo di altri tool digitali: Jason Mittell ha utilizzato di recente il video essay come metodo di “visualizzazione” per analisi quantitative. Sfruttando i calcoli e le misurazioni ottenibili con Cinemetrics [49] ha “deformato” le immagini di alcuni film, come Singin’ in the Rain (Cantando sotto la pioggia, Stanley Donen, 1952) o Raiders of The Lost Ark (Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Steven Spielberg, 1981) rallentando o accelerando la velocità delle singole inquadrature per uniformarle tutte al calcolo della ASL (average shot length, durata media delle inquadrature) e trasformando quindi i dati (presentati su Cinemetrics sotto forma di numeri o di grafici) in un prodotto audiovisivo, che costituisce tanto uno strumento di visualizzazione quanto un curioso esperimento di rimontaggio [50]. Kevin B Lee nel 2014 ha realizzato un lavoro dal titolo Transformers: The Premake: più che un video essay, è quello che Lee definisce desktop documentary. Si tratta di un video in cui, utilizzando una tecnologia che consente di registrare le interazioni di un utente con il desktop del proprio computer (“catturando” quindi tutte le immagini che tale attività produce, dall’apertura di un documento alla digitazione di un indirizzo nel browser fino alla visione di un video su YouTube), Lee realizza una sorta di making of di Transformers: Age of Extinction (Transformers 4 - L’era dell’estinzione, Michael Bay, 2014) utilizzando le riprese amatoriali, disponibili su YouTube, di fan e curiosi che si sono recati nei luoghi in cui il film veniva girato. Ma Transformers: the Premake è molto più di un “dietro le quinte”: come spiega lo stesso Lee è una «critical investigation of the global big budget film industry, amateur video making, and the political economy of images» [51]. A metà strada tra documentario e performance, Transformers: The Premake rispecchia, del resto, la tendenza di Lee a combinare, anche nei video essay, alla riflessione critica la performance recitativa, sia in forma di riflessione soggettivodiaristica che come vera e propria messa in scena. In Siri Says HER Should Win 2014 Oscar for Best Picture – parte di una serie che Lee ha realizzato ogni anno, a partire dal 2013, per “dimostrare” [52] quale, fra i nominati agli Oscar nelle categorie principali, è meritevole della statuetta – il critico mette addirittura in scena un finto dialogo con Siri, l’applicazione di assistenza digitale per iPhone. Anche il meccanismo di imitazione proprio delle forme “virali” della rete, tuttavia, può essere declinato in modi proficui: un esempio su tutti è il gioco online proposto da Catherine Grant, nell’aprile 2014, sulla sua pagina Facebook: una versione in video delle liste di dieci – o più – film selezionati dall’utente secondo il proprio gusto o anche seguendo dei criteri imposti (in questo caso, la scelta di film i cui titoli abbiano la stessa iniziale) che vengono spesso condivise sui social. Contestualmente alla pubblicazione della sua
videolista, TenBMovies, ha lanciato la seguente sfida agli utenti: Announcing the “Ten Favorite Films Beginning with the Letter…” video game! The rules: please request a letter in the comments below, and edit together very short sequences from your ten favorite films beginning with the allocated letter. Feel free to use a soundtrack excerpt from another film beginning with that letter. Keep the whole thing well under 5 minutes. Credit all your sources. Share a link to your video in the comments. The Fair Use/Dealing context is that of experimental compilationism. Some scholars/critics say they don’t make film studies video essays because of the pressure of having to “argue something discursively” in audiovisual forms. Film scholars, why not just create an “audiovisual argument” in favor of associative connection by joining up movie sequences you already know and love? In this way, you might get to explore, indeed to *feel*, if you haven’t before, one of the biggest advantages, and tools, of videographic film studies: compilation [53]. La proposta di realizzare una creazione audiovisiva che proceda per associazioni di immagini a partire da una rosa di titoli già selezionati sulla base di un parametro puramente formale (l’iniziale del titolo) si avvale della dimensione ludica della compilation per avvicinare, in modo familiare e piacevole, gli studiosi di cinema presenti fra i contatti di Catherine Grant ai videographic film studies (ma chi scrive l’ha proposto anche come forma di “introduzione al videosaggio” per studenti universitari). I video essay in rete coesistono, del resto, con altre pratiche puramente ludiche – come i recut trailer che trasformano Shining (Stanley Kubrick, 1980) in un film per famiglie o Jaws (Lo squalo, Steven Spielberg, 1975) [54] in un musical della Disney, o i mash up che sovrascrivono il sonoro de La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013) su scene tratte dalla saga di Fantozzi [55] – e non sono infrequenti forme di incontro e di contaminazione fra i videosaggi e queste forme di remix legate alla fan culture. Béla Tarr’s “Repulsion”: Fragments of a Lost Remake (2015) di Adrian Martin e Cristina Álvarez López richiama proprio la pratica ludico-sovversiva dei recut trailer e reimmagina Repulsion, di Polanski (Repulsione, 1965) come fosse un film di Béla Tarr, eliminando dialoghi, azioni, punti di snodo narrativo per lasciare soltanto i momenti morti, di sospensione del film, invitando a una riflessione sulla «tension between narrative and non-narrative that is inherent to so many (most?) films» [56]. In Murder Husbands: Queerness, Violence & Cinematic History (2016) la studiosa Melanie Kohnen, dell’Università di Coventry, utilizza invece la forma analitica del video essay con commento in voice over insieme al vidding, che consiste nel remixare immagini di serie televisive (più
raramente di film) aggiungendo una traccia musicale accuratamente selezionata [57]. Kohnen nella prima parte del video riflette su Rope (Nodo alla gola, Alfred Hitchcock, 1948) in quanto queer film, nella seconda realizza un vid su Hannibal (NBC, 2013-2015) e nella terza combina i due approcci, dimostrando quanto anche le pratiche ludiche basate sul montaggio possano rivelarsi delle forme critiche e insieme evidenziandone l’affinità (in termini di durata, di ritmo, di metodi compositivi e formali) con il videosaggio in rete. Il video essay, insomma, si sviluppa in continuità con una lunga tradizione critico-analitica che ha cercato di riflettere sul cinema attraverso le immagini: il film d’archivio sperimentale, i documentari sul cinema realizzati per la televisione, certi film-saggio e così via. È una forma meticcia, che guarda al passato ma che si contamina con le forme del presente, siano esse le pratiche ludiche del remix in rete o gli strumenti delle Digital Humanities. Si fa metodo di analisi del film preservandone la natura di immagine in movimento e sonora e allo stesso tempo si apre alla dimensione soggettiva ed esperienziale della relazione col film. La natura ibrida del video essay lo rende un oggetto sfuggente, difficile da definire, da classificare, e per questo la sua legittimazione in ambito critico e accademico non si è ancora pienamente compiuta. Ma è proprio questo margine di indecidibilità, forse, a dimostrare che non solo possiamo, anzi dobbiamo, parlare ancora di Nuovo Cinema ma anche che possiamo ancora immaginare nuovi modi di pensarlo.
Note del capitolo: 1. Mark Rappaport, Introduction, in Id., The Secret Life of Moving Shadows Pt. 1 [corsivo di chi scrive]. Il volume è autoprodotto da Rappaport e distribuito in versione ebook da Amazon. 2. Si vedano, in proposito, almeno i saggi di Raymond Bellour, Di una storia e Il testo introvabile, in Id., L’analisi del film, [L’analyse du film, Editions Albatros, Paris 1979], Kaplan, Torino 2005, pp. 19-37 e 41-46, e Lino Micciché, Fil(m)ologia, in Id., Filmologia e Filologia. Studi sul cinema italiano, Marsilio, Venezia 2002, pp. 11-22. 3. Francesco Casetti, La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene, Bompiani, Milano 2015, p. 192. 4. Il termine non nasce, naturalmente, con questa accezione, ma è stato utilizzato per indicare, come nel caso del film-saggio, una sorta di ulteriore derivazione dell’incontro tra saggio letterario e medium audiovisivo. La parola video serviva a rimandare non solo a un mezzo differente, quello elettronico, ma anche a ulteriori contesti di fruizione, come l’ambito museale. Ricordiamo per esempio che Gianni Toti parla di videosaggi già nel suo Dal film-saggio al video-saggio e oltre… («Filmmaker», 5 aprile 1996, p. 29) e Ursula Biemann ha curato nel 2003, in occasione del Festival del Video Sperimentale Videoex, a Zurigo, un volume dal titolo Stuff It. The Video Essay in the Digital Age (Voldemeer, Zürich 2003), in cui con il termine video essay indica lavori realizzati con tecnologie digitali, di argomento vario e che si innestano nella tradizione del film-saggio. Oggi l’espressione video essay è la più adoperata per indicare queste forme di rimontaggio online; va precisato però che non tutti gli studiosi sono concordi nell’utilizzarla: Adrian Martin e Cristina Álvarez López preferiscono l’espressione audiovisual essay, che pone enfasi anche sulla dimensione sonora; su “[in]Transition” si adottano le espressioni videographic film and moving image studies, o videographic criticism, perché meno legate alla specificità del termine essay, saggio. 5. Phillip Lopate, In Search of The Centaur: The Essay Film, in Charles Warren, Beyond Document: Essays on Nonfiction Film, Wesleyan University Press, Middletown 1998 (originariamente pubblicato su «The Threepenny Review», n. 48, Winter 1992). 6. Riguardo al film-saggio rimandiamo a due testi fondamentali: Laura Rascaroli, The Personal Camera: The Essay Film and Subjective Cinema, Wallflower Press, London 2009; Timothy Corrigan, The Essay Film: From Montaigne, After Marker, Oxford University Press, Oxford 2011. Sull’influenza del found footage e del film-saggio sul video essay si veda anche Cristina Álvarez López, Adrian Martin, Introduction to the audiovisual essay: A child of two mothers, «NECSUS. European Journal of Cinema and Media Studies», War, Autumn 2014 (ultimo accesso il 25.04.2015). 7. While the City Sleeps (Fritz Lang, 1956), “Shooting Down Pictures”, post del 25 Aprile 2007 (ultimo accesso il 20.01.2016). 8. Jim Emerson, Close-Up: The Movie/Essay/Dream, “Rogerebert.com”, post del 18 ottobre 2007 (ultimo accesso il 14.04.2016). 9. Matt Zoller Seitz, The Substance of Style, “Moving Image Source” (ultimo accesso il 15.04.2016). 10.Catherine Grant, Unsentimental Education: on Claude Chabrol’s “Les Bonnes femmes” (1960), «Filmanalytical» 22 giugno 2010 (ultimo accesso il 24.04.2016). 11. «Audiovisualcy» (ultimo accesso il 24.04.2016). 12. «Press Play» (ultimo accesso il 20.04.2016). 13. «Sight & Sound» (ultimo accesso il 20.04.2016). 14. «Transit» (ultimo accesso il 20.04.2016).
15. «Filmscalpel» (ultimo accesso il 20.04.2016). 16. «MUBI/Notebook» (ultimo accesso il 20.04.2016). 17. «Fandor/Keyframe» (ultimo accesso il 20.04.2016). 18. I video essays su “Criterion.com” (ultimo accesso il 20.04.2016). 19. Originario di Seul, è conosciuto solo con il suo nickname, kogonada appunto 20. «NECSUS. European Journal of Media Studies» (ultimo accesso il 20.04.2016). 21. «Frames Cinema Journal» (ultimo accesso il 20.04.2016). 22. «The Cine-Files» (ultimo accesso il 20.04.2016). 23. “[in]Transition. Journal of Videographic Film & Moving Image Studies” (ultimo accesso il 20.04.2016). 24. Sull’argomento rimandiamo a «Cinema Journal» Teaching Dossier, Vol. 1 (2) Spring-Summer 2013 e al dossier curato da Tracy Cox-Stanton su «The Cine-Files», n. 7, The Video Essay: Parameters, Practice, Pedagogy, Fall 2014 (ultimo accesso il 21.04.2016) 25. Per esempio non possiamo affrontare qui, per motivi di spazio, la complessa questione del copyright e delle leggi sul diritto d’autore, che variano di paese in paese. In ogni caso, i modelli legislativi cui gli autori di video essay provenienti da diverse realtà nazionali fanno più spesso riferimento sono la dottrina statunitense del fair use, che consente l’utilizzo di materiale protetto da copyright senza chiedere l’autorizzazione ai proprietari se ciò procura dei benefici a livello sociale e culturale, e il fair dealing per i paesi del Commonwealth. Rientrano nella categoria del fair use gli utilizzi a fini didattici, di critica e di ricerca. In Italia si avvicina lontanamente al fair use l’articolo 70 della legge sul diritto d’autore, anche se appare quantomeno restrittivo rispetto alla disciplina USA. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al saggio di Lucia Tralli, Living in a Den of (fair use) Thieves. Best Practices for Audiovisual Remix and its Online Diffusion, in Roberto Braga, Giovanni Caruso (a cura di), Piracy Effect. Norme, pratiche, casi di studio, Mimesis, Milano-Udine 2013 (ultimo accesso il 25.04.2016). 26. Christian Keathley, La caméra-stylo: Notes on Video Criticism and Cinephilia, in Alex Clayton e Andrew Klevan (eds.), The Language and Style of Film Criticism, Routledge, London-New York 2011, in particolare pp. 179-183. 27. David D’Arcy, Film Essayist Mark Rappaport on His Movie Archaeology: “If I get pretentious with this, slap me senseless”, “Thompson on Hollywood”, 18 novembre 2015 (ultima consultazione il 15.04.2016). 28. Lino Micciché, Fil(m)ologia, cit., p. 13. 29. Andrew McWhirter, Film criticism, film scholarship and the video essay, «Screen» n. 56.3, Autumn 2015, p. 372. 30. Va precisato innanzitutto che molto spesso i video essay pubblicati su siti di critica o su riviste accademiche sono accompagnati da un articolo o da un saggio scritto. Nella maggior parte dei casi fra il testo scritto e il video c’è una fruttuosa cooperazione: il testo aggiunge ulteriori riflessioni, fornisce alcune chiavi interpretative al video e ne chiarisce l’utilizzo come metodologia, cercando di evitare ripetizioni e ridondanze. Il video essay non serve a illustrare ciò che è già spiegato nel saggio, ma costituisce un altro percorso interpretativo, che può per esempio prediligere un approccio poetico-riflessivo laddove il testo scritto, invece, può mantenere un impianto analitico più convenzionale. 31. Tutti i video citati in questo saggio, laddove non diversamente indicato, sono inclusi nella webgrafia del volume, insieme agli indirizzi online a cui è possibile visionarli. 32. Jason Mittell, Curator’s Note, «[in]Transition», 3.1, March-April 2016 (ultimo accesso il 24.01.2016).
33. Catherine Grant, Christian Keathley, The Use of an Illusion. Childhood Cinephilia, Object Relations, and Videographic Film Studies, «Photogénie», n. 0, giugno 2014 (ultimo accesso il 24.01.2016). 34. Jacques Rancière, Scarti. Il cinema tra politica e letteratura [Les écarts du cinéma, La Fabrique, Paris 2011], Pellegrini, Cosenza 2013, p. 29. 35. Annette Kuhn, Cinematic Experience, Film Space, and the Child’s World, «Canadian Journal of Film Studies / Revue Canadienne d’Etudes Cinématographiques», 19.2, Fall 2010. 36. Si veda Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, Bloomington 2013, cap. 2 par. 2 [ebook]. 37. Il montaggio spaziale, secondo la definizione di Lev Manovich, «coinvolge un numero elevato di immagini, anche di dimensioni e proporzioni diverse, che appaiono contemporaneamente sullo schermo». Lev Manovich, Il linguaggio dei nuovi media [The Language of New Media, MIT Press, Cambridge 2002], Edizioni Olivares, Milano 2002, p. 395. 38. Dal glossario di «Filmscalpel» (ultimo accesso il 17.04.2016). 39. Riguardo la logica paradigmatica o “del database” si veda sempre Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., in particolare pp. 266-289. 40. Ken Provencher, Curator’s Note, «[in]Transition», 3.1, March-April 2016 (ultimo accesso il 25.04.2016). 41. Con la collaborazione di Chiara Grizzaffi. 42. Tony Zhou, Every Frame a Painting, post del 26 febbraio 2015 (ultimo accesso il 22.04.2016). 43. Christian Keathley, Cinephilia and History, or The Wind in The Trees, Indiana University Press, Bloomington 2015, pp. 14-15. 44. Andrew Lapin, Film Critics in Disguise: Pioneers of the Video Essay Discuss Their Art Form, «No Film School», 22.02.2016 (ultimo accesso il 25.04.2016). 45. Come spiega, tra gli altri, anche Vito Campanelli in Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, CLUEB, Bologna 2011, p. 45. 46. https://vimeo.com/161613650 (ultimo accesso il 26.04.2016). 47. https://vimeo.com/146438643 (ultimo accesso il 26.04.2016). 48. Si veda il sito di Pam Cook (ultimo accesso il 25.04.2016). 49. Per indicazioni su Cinemetrics rimandiamo al saggio di Adriano Aprà nel presente volume. 50. Jason Mittell, Videographic Deformations: Equalized Pulse, «Just Tv» (ultimo accesso il 25.04.2016). 51. Kevin B Lee, About the Premake, “alsolikelife” (ultimo accesso il 25.04.2015). 52. La serie si intitola, non a caso, Oscars Video Evidence, e l’utilizzo del termine evidence, “prova”, “indizio”, denota la fiducia posta nel potere dimostrativo del videosaggio, che ricorrendo direttamente alle immagini e non alla loro descrizione scritta è in grado di mettere davvero in evidenza le qualità di una perfomance attoriale, della regia, del montaggio ecc. 53. Pagina Facebook di «Audiovisualcy» (ultimo accesso il 26.04.2015). 54. Dan Casey, The Top 10 Best Recut Movie Trailers, «The Nerdist», 12.09.2013 (ultimo accesso il 25.04.2015). 55. Matteo Zanetti, Creative Exercise: “Fantozzi, alias Jep Gambardella” - Mash Up Trailer, YouTube (ultimo accesso il 25.04.2015). 56. Cristina Álvarez López, Adrian Martin, Béla Tarr’s “Repulsion”: Fragments of a Lost Remake, Mubi Notebook, 12.01.2015 (ultimo accesso il 25.04.2015).
57. Riportiamo la definizione di vidding fornita dalla Organization for Transformative Work: «Vids are fan-made music videos that involve the re-cutting and remixing of footage from television shows or films» (ultimo accesso il 25.04.2016). Rimandiamo anche, per ulteriori approfondimenti, al saggio di Lucia Tralli, Fan video goes to the movies: movie-vid, vidding community e cinefilia, «Cinergie», n. 3, marzo 2013 (ultimo accesso il 25.04.2015)
Appunti per una storia del critofilm italiano Simone Starace Se vogliamo ripercorrere il modo in cui il cinema italiano, attraverso le forme della nonfiction, ha raccontato se stesso, si dovrà partire almeno dai primi anni Trenta, individuando quindi un percorso che, nel bene come nel male, ha di fatto accompagnato parallelamente tutta l’evoluzione del nostro cinema. Già l’avvento del sonoro è segnato infatti da un ampio dibattito critico, avviato dalla rivista «Cinematografo» di Alessandro Blasetti e fatto proprio dal produttore Stefano Pittaluga con la tanto sospirata “rinascita” della sua Cines. Mentre realizza film di finzione che, più o meno esplicitamente, affrontano il tema del rinnovamento artistico del nostro cinema (Resurrectio, ma anche il metacinematografico Stella del cinema, 1931), la società di Pittaluga produce anche un proprio cinegiornale, la «Rivista Cines» (19301932), che svolge una funzione di rilancio promozionale della cinematografia italiana. Il primo numero è interamente dedicato proprio all’inaugurazione dei nuovi stabilimenti sonori della Cines, di cui attraverso una serie di quadri docu-finzionali viene illustrata l’efficienza tecnica. La «Rivista», modellata su prototipi statunitensi, è interessante soprattutto perché anticipa in prospettiva quelle strategie che saranno poi dominanti nella produzione cinegiornalistica dei decenni successivi: servizi di colore, brevi dietro le quinte, anticipazioni dei film in uscita e testimonianze politiche che legittimano, di fatto, il ruolo assunto dal cinema nella vita sociale italiana. La stagione della Cines, con la sua politica promozionale “illuminata”, resta però purtroppo una breve parentesi. Come lamenta pubblicamente Jacopo Comin sulla rivista «Cinema» [1], dopo il declino della Cines viene infatti presto a mancare nei produttori una qualsivoglia strategia promozionale, per cui di molti film non vengono realizzate nemmeno le fotografie di scena. La macchina promozionale si rimette in moto in grande stile soltanto per sforzi produttivi colossali come quello sotteso a Scipione l’Africano, documentato nello specifico da numerosi cinegiornali, che anche qui mettono bene in luce gli interventi politici legati alla realizzazione del film [2]. Nei primi anni Quaranta, in piena autarchia cinematografica, il bisogno di riempire la programmazione porta a un boom “pilotato” della produzione, e nel settore del cortometraggio si registra di conseguenza anche qualche caso di documentario a tema cinematografico: 5 minuti con Cinecittà (Pietro Francisci, 1939), Come nasce un cortometraggio (Vincenzo Solito, 1942), La scuola del cinema (Fernando Cerchio, 1942, dedicato al Centro Sperimentale di Cinematografia). Si tratta di cortometraggi intrisi di retorica,
ma preziosi oggi dal punto di vista storico, se non altro per il loro valore testimoniale. A questi si aggiunge un oggetto inclassificabile come il parodico Cinefollie di Mario Costa (e Steno), che i titoli di testa identificano come “cine-rivista”, ma che oggi definiremmo un mockumentary realizzato negli stabilimenti Titanus, prendendo in prestito sequenze, interpreti e accessori di scena dai film in lavorazione [3]. La situazione non sembra cambiare più di tanto negli anni del dopoguerra. I cinegiornali continuano infatti a offrire reportage da alcuni dei set più importanti (dedicando anche crescenti attenzioni ai film stranieri girati in Italia), a cui si aggiunge occasionalmente qualche “numero speciale” della «Settimana Incom» che, a mo’ di almanacco, cerca di fare il punto sulla produzione recente (Questo è il cinema nostro, 1948, Questo nostro cinema, 1953). In ogni caso, lo stile resta inevitabilmente quello abituale dei servizi dell’epoca, con una durata tipica di uno o due minuti, in cui a farla da padrone è soprattutto la voce dello speaker, che sopperisce all’abituale mancanza del suono in presa diretta. Si tratta in fondo di materiali che, al di là dell’odierno valore storico, nascono con finalità strettamente promozionali, ed è quindi di regola assente ogni finalità critica, a tutto vantaggio di una prospettiva banalmente mondana. Sempre restando sul versante promozionale, va inoltre notato come in Italia non sembra avere mai attecchito l’idea del trailer “d’autore”, praticata invece da diversi registi hollywoodiani (Hitchcock, DeMille, Preminger) che spesso trasformavano i propri “prossimamente” in piccole dichiarazioni di poetica a uso e consumo dello spettatore. Le uniche eccezioni che vengono in mente sono gli elaborati trailer per Miracolo a Milano di Vittorio De Sica e I cento cavalieri di Vittorio Cottafavi, a cui si può aggiungere al limite qualche stravaganza comica firmata da Mario Mattoli (Il pirata sono io!). I documentari sul cinema veri e propri restano intanto un numero relativamente ridotto, e di regola adottano un taglio squisitamente didattico, quasi presupponessero un pubblico ancora da alfabetizzare. In un mercato sostanzialmente “parassitario” come quello del documentario italiano, in cui i produttori cercano innanzitutto di spendere il meno possibile, la realizzazione di cortometraggi su argomenti cinematografici offre d’altra parte una garanzia economica non indifferente, visto che le riprese possono svolgersi rapidamente, spesso senza nemmeno doversi allontanare dagli stabilimenti. Ecco quindi che di tanto in tanto vengono realizzati documentari come 10 minuti con i doppiatori (1947), Nasce un cinema (Giampiero Pucci, 1948, sui metodi di costruzione delle sale), Il mercato delle facce (Valerio Zurlini, 1952, sulle comparse di Cinecittà), Bambini doppiatori (Damiano Damiani,
1957). Un sottogenere a sé, che riflette bene le preoccupazione sociologiche della nostra critica, è quello dedicato a un ipotetico censimento degli spettatori cinematografici, con documentari che immortalano le reazioni del pubblico davanti al grande schermo, spesso ricorrendo a soluzioni di messa in scena che sconfinano ampiamente nella fiction. Il titolo più emblematico è senz’altro Buio in sala di Dino Risi (1950), a cui vanno aggiunti almeno Guardatevi come siete (anonimo, 1952) e I bambini al cinema (Francesco Maselli, 1958). Pur con i dovuti distinguo, questi documentari sembrano nel complesso tradire un certo atteggiamento di superiorità rispetto alla materia trattata, affrontando il cinema innanzitutto come un fenomeno sociale, senza entrare in preoccupazioni di carattere propriamente teorico o estetico. Manca, per intenderci, un’opera a tutto tondo come quella che Michelangelo Antonioni dedica invece negli stessi anni al fotoromanzo, L’amorosa menzogna (1949), in cui l’ironia di fondo non impedisce all’autore di guardare alla cultura popolare con una certa partecipazione, analizzandone la portata sociale ma riconoscendone al contempo il fascino artigianale. In questo senso il film più memorabile, proprio per la passione palpabile con cui trascende i propri fini educativi, è Il museo dei sogni di Luigi Comencini (1949). Nato con l’intento di promuovere l’operato della Cineteca Italiana e realizzato attingendo anche alla sua preziosa collezione di film muti, il documentario diverrà negli anni un ideale manifesto per le cineteche italiane, e lo stesso Comencini ne svilupperà le premesse in forma di lungometraggio a soggetto, girando nel 1953 La valigia dei sogni.
La situazione inizia a cambiare negli anni Sessanta, quando sul modello francese assistiamo invece a diversi esperimenti di film saggistici a carattere monografico, talvolta dedicati a singole personalità registiche. Se i film prodotti nel decennio precedente partivano dal presupposto (casomai illusorio) di rivolgersi a un pubblico generalista, negli anni Sessanta gli autori postulano uno spettatore “colto”, magari cinefilo, che ha ormai assimilato l’ABC e si aspetta un diverso livello di approfondimento delle questioni estetiche. Del resto, questo cambiamento di prospettive va di pari passo con la diffusione della televisione, mass medium dalla vocazione trasversale che inizia presto a farsi carico delle esigenze più basilarmente informative e promozionali (vedi la rubrica Cinema d’oggi, curata da Pietro Pintus [4]), offrendo al contempo nuove opportunità e nuovi spazi per coltivare il documentario di lungometraggio. I primi tentativi di film-saggio “d’autore”, inevitabilmente, si ricollegano a un’impostazione critica che fa ancora capo alla vecchia scuola di «Cinema Nuovo», prediligendo quindi un canone autoriale molto ristretto, inquinato dai soliti equivoci contenutistici. Questo non esclude che alcuni film, influenzati dalle nuove forme documentaristiche introdotte dal cinema verità, propongano risultati ancora oggi stimolanti, come è il caso per esempio dei due documentari prodotti da Gian Vittorio Baldi in associazione con l’Office National du Film canadese. Lo stile da direct cinema conferisce infatti a Michelangelo Antonioni, storia di un autore di Gianfranco Mingozzi (1966) una certa libertà di sguardo, che supera le trappole del didascalismo per proporre invece una sorta di inchiesta personale, in cui prospettive diverse (di critici, collaboratori, amici) cercano di restituire un ritratto a tutto tondo del regista. Non soltanto Mingozzi cattura dal vivo queste testimonianze, restituendone la spontaneità, ma attraverso un abile gioco combinatorio le alterna ad altri materiali eterogenei (spezzoni di film, foto, scene tagliate, backstage amatoriali in 8mm), ripercorrendo attraverso questi documenti l’evoluzione del cinema di Antonioni. Lo stesso testo letto dal narratore, discreto ma convenzionale, finisce del resto per integrarsi con le voci catturate in presa diretta dalla macchina da presa, relativizzando la propria funzione di voice of God, per aprirsi a un ritratto polifonico. Virtù simili sono riscontrabili anche ne Il cinema della realtà (1966), in cui Gianni Amico con piglio cronachistico indaga a distanza di anni un momento della storia del cinema già allora ampiamente canonizzato come il neorealismo. Amico concede la parola sia ai “maestri” (Rossellini, De Sica, Zavattini) che alle nuove generazioni di cineasti (Bertolucci, Bellocchio, i Taviani), ma lascia parlare anche e soprattutto i luoghi in cui i film sono stati girati, e anche in questo caso la grande disinvoltura della cinepresa si traduce in uno sguardo originale, che rifiuta un approccio di tipo cattedratico,
proponendosi piuttosto come riflessione in fieri su un’idea di cinema ancora attuale. Molto interessanti, anche solo per il trattamento dei soggetti, sono poi i film che testimoniano il sotterraneo affermarsi di una nuova sensibilità che va al di là delle schematizzazioni ideologiche degli anni Cinquanta, con quel gusto cinefilo che caratterizzerà la cosiddetta “nuova critica”. Su questa linea d’onda, da notare in particolare una manciata di cortometraggi riconducibili al gruppo legato alla rivista «Cinema & Film»: Verso Rossellini (1967), Visconti (1967), Fellini in città ovvero frammenti di una conversazione su Federico Fellini (1968), tutti diretti da Maurizio Ponzi. Ma l’esperimento più avanzato, sempre firmato da Ponzi, resta senz’altro Il cinema di Pasolini (1966), che già dal sottotitolo (appunti per un critofilm) si presenta come un tentativo di analizzare lo stile pasoliniano sfruttando le potenzialità del mezzo audiovisivo.
Le parole di Pasolini entrano qui in dialettica con un montaggio di fotogrammi che rintracciano nelle opere alcune costanti tematiche e formali, accostate anche ai vari riferimenti culturali da cui queste immagini prendono le mosse. Attraverso la possibilità di citare direttamente brani del film, Ponzi analizza inoltre dettagliatamente la successione dei piani in una sequenza di Comizi d’amore, individuandone le specificità stilistiche con un’esattezza che sarebbe impensabile in un’analisi critica cartacea. Grazie alla partecipazione di Ninetto Davoli, il cortometraggio arriva persino a inscenare delle sequenze
pseudo-pasoliniane, in un’ipotesi di calco come momento critico in cui studiare cinema corrisponde a fare cinema. Sono tutte soluzioni che, pur nella loro eterogeneità, intuiscono sorprendentemente alcune delle direzioni in cui si muoverà quarant’anni più tardi la video-saggistica, anche se per la verità non risulta che all’epoca questo cortometraggio abbia funzionato da modello per altre operazioni simili. Ponzi proseguirà comunque occasionalmente questa attività documentaristica anche nei decenni successivi, in particolare con Mattolineide (1978, dedicato a Mario Mattoli) e la serie Cinecittà (1979), in cui spesso riuscirà nel non facile tentativo di coniugare documentazione storica e gusto per il racconto. Sul versante del documentario strettamente televisivo, segnato da una connotazione giornalistica più che propriamente critica, si muove nel frattempo il lavoro di autori come Giulio Macchi, che pur rivolgendosi a un pubblico più generalista cerca di far proprie alcune delle novità stilistiche introdotte nei primi anni Sessanta dal documentario d’inchiesta: Appunti biografici su Roberto Rossellini e Vittorio De Sica: autoritratto (entrambi del 1964) si propongono innanzitutto come vivaci ritratti che permettono allo spettatore di avvicinarsi agevolmente alla personalità dei due autori, senza guizzi interpretativi ma con un’ammirevole capacità divulgativa. Il modello è lo stesso adottato poi diffusamente anche da altri, come Sergio Zavoli (Un’ora (e ½) con il regista di “8 ½”, 1964) e Antonello Branca (Mastroianni, un Casanova dei nostri tempi, 1965), senza dimenticare i pregevoli reportage realizzati da Raffaele Andreassi per programmi come TG2 Odeon (in particolare i suoi ritratti di Monica Vitti e Dario Argento, entrambi del 1977). Ma l’opera imprescindibile, in questa direzione, resta l’inchiesta in cinque puntate La macchina cinema (1978), realizzata da un collettivo composto da Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Pretaglia e Stefano Rulli (già responsabili, nel 1975, di Matti da slegare). La trasmissione è un esperimento tutto sommato unico nel panorama italiano, visto che per una volta gli autori scelgono un’ottica a trecentosessanta gradi, senza circoscrivere la trattazione a un autore o una corrente, domandandosi piuttosto che cos’è il cinema e andandone poi a indagare tutte le varie manifestazioni, con particolare attenzione anche per quelle generalmente trascurate dal discorso critico ufficiale (cinema amatoriale, sperimentalismo, serie B). Da questa operazione nasce un grande affresco collettivo, in cui i problemi strettamente estetici sembrano dialogare con le esigenze industriali della “macchina”, e in cui d’altra parte viene concessa grande attenzione a quegli emarginati che vivono ai confini del set (maestranze, giovani debuttanti, attori in declino). La partecipazione attiva dei quattro autori, che interagiscono con i vari personaggi mettendo talvolta in discussione le proprie
idee, finisce inoltre per portare continuamente in evidenza i meccanismi stessi del fare documentario, ponendo in fondo sullo stesso piano intervistati e intervistatori. Senza preconcetti, ecco allora che il cinema diventa innanzitutto una scelta di vita, minimo comune denominatore capace di tenere insieme figure solo apparentemente antitetiche come Franco Piavoli e Gianfranco Parolini. La macchina cinema, con i suoi inserti tratti da Nel nome del Padre e Il gabbiano, è anche un esempio di come gli autori (in questo caso soprattutto Bellocchio) approfittino delle nuove forme saggistiche per riflettere sul proprio cinema, tornando magari sui propri film del passato, o stendendo al contrario degli appunti di regia per opere ancora da iniziare. Si tratta di una pratica che, per quanto raramente, si era già manifestata nei decenni precedenti, in forme singolari come Ambienti e personaggi (Vittorio De Sica, 1950, con la “ricostruzione” del set di Ladri di biciclette), ma che comincia a diventare sistematica proprio dagli anni Sessanta, con Sopraluoghi in Palestina per il film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini (1965), Block-notes di un regista di Federico Fellini (1969, dedicato principalmente al Satyricon, ma con anticipazioni anche sul progetto incompiuto de Il viaggio di G. Mastorna [5]) e Alla ricerca di Tadzio di Luchino Visconti (1970, sul casting di Morte a Venezia), fino ad arrivare ad autentici diari di lavorazione come Il diario del “Caimano” di Nanni Moretti (2005). Per quanto riguarda il ritorno a distanza di anni sui set del passato, il modello più o meno confessato sembra essere Return to the Edge of the World di Michael Powell (1978), a cui fanno eco Ritorno a Lisca Bianca di Michelangelo Antonioni (1983, sui luoghi de L’avventura) e I sentieri della gloria: in viaggio con Mario Monicelli sui luoghi della Grande Guerra (Gloria De Antoni, 2011). C’è poi il caso dei backstage che, pur girati per interposta persona, fungono in pratica da dichiarazione di poetica per il regista coinvolto, come è il caso di E il Casanova di Fellini? di Liliana Betti e Gianfranco Angelucci (1975), di Fare un film per me è vivere (1995) diretto da Enrica Fico Antonioni in occasione di Al di là delle nuvole, o di Stessa rabbia stessa primavera (2003) di Stefano Incerti, dedicato a Marco Bellocchio e al suo Buongiorno, notte. Particolarmente indicativo, in questo senso, è anche Bertolucci secondo il cinema (1975), making of di Novecento girato da un giovane Gianni Amelio, in cui le voci dei due registi finiscono progressivamente per intrecciarsi in un dialogo a due, tanto che nella scena finale è lo stesso Bertolucci a sollecitare le riflessioni di Amelio sul suo documentario. Con l’inasprirsi delle strategie di bombardamento promozionale, già dagli
anni Ottanta si intensifica la produzione generalizzata di making of, avvantaggiata anche dalla crescente disponibilità di nuovi spazi televisivi. Inevitabilmente, nella maggior parte dei casi si tratta di brevi special di scarsissimo interesse, spesso privi persino di quel valore basilarmente informativo che dovrebbe costituirne la principale ragion d’essere. Negli stessi anni assistiamo anche a una progressiva proliferazione di documentari dedicati al cinema del passato, con molteplici operazioni guidate da una malintesa idea di museificazione, che troppo spesso coincide con una sterile mummificazione di opere e autori. Se in alcuni contesti di stampo divulgativo è infatti accettabile qualche esemplificazione di tipo scolastico (vedi l’esempio per così dire “nobile” di Carlo Lizzani, responsabile di numerosi documentari, ma anche di video propriamente didattici), sul versante istituzionale, finanziato quasi invariabilmente con fondi pubblici, si potrebbe davvero stilare un interminabile elenco dei numerosi titoli da non ricordare, con un surplus di mediocri video d’occasione realizzati per eventi specifici e caduti poi giustamente nell’oblio. Si salvano principalmente quei casi, ascrivibili al found footage film, in cui il lavoro creativo valorizza materiali d’archivio rari e preziosi, a cui il montaggio si incarica di dare una nuova forma, come succede nei casi di Rossellini visto da Rossellini (Adriano Aprà, 1992, privo peraltro di qualsiasi intervento di voice over) e Le stagioni dell’aquila (Giuliano Montaldo, 1997, dedicato alla storia dell’Istituto Luce e penalizzato al contrario da un uso banale e talvolta irritante del commento parlato). Ma anche qui, per esempio, il titolo più interessante fra quelli realizzati in occasione del primo centenario del cinema è un’opera che nasce lontano dalle celebrazioni ufficiali, ovvero Nitrato d’argento di Marco Ferreri (1996). Ci troviamo per la verità davanti a un film sui generis, impossibile da etichettare come documentario od opera di finzione, visto che la sua struttura ibrida si diverte a combinare insieme materiali d’archivio e sequenze di fiction, in un’apocalittica contro-storia del cinema mondiale riletta “dal basso”, sul filo di una continua osmosi fra l’immaginario cinematografico e la vita quotidiana dei suoi spettatori [6].
Molti altri registi più o meno affermati, coinvolti in estemporanei omaggi a colleghi del passato, incappano invece spesso nelle trappole dell’aneddotica o peggio ancora dell’oleografia. Errori a cui sfuggono soltanto quegli autori dalla vocazione cinefila, in cui il cinema del passato diventa specchio in cui riconoscere il proprio percorso personale. È il caso per esempio di Giuseppe Tornatore, in particolare per il suo sentito ritratto del produttore Goffredo Lombardo, L’ultimo gattopardo (2010), notevole sia per il gusto del racconto cinefilo che per l’utilizzo citazionista del materiale di repertorio, integrato all’interno delle interviste tramite la tecnica del blue screen. Totalmente agli antipodi, ma altrettanto personale e autoriflessivo, è lo sgangherato documentario che la coppia Ciprì e Maresco dedica alle figure di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Come inguaiammo il cinema italiano (2004), opera peraltro speculare e complementare rispetto al loro precedente film di finzione, Il ritorno di Cagliostro [7]. Un caso a sé è poi quello de L’America a Roma (1998), diretto da Gianfranco Pannone e dedicato ai caratteristi dello spaghetti western: un’occasione per raccontare dal basso il nostro cinema di genere ma anche l’Italia del boom, verificando in particolare come una mitologia di derivazione hollywodiana si sia innestata nell’innata saggezza secolare delle classi più popolari. Ma se la produzione destinata alla sala cinematografica resta comunque molto limitata, la televisione italiana, con il moltiplicarsi delle emittenti private prima e dei canali tematici dopo, continua a produrre in questi ultimi decenni una quantità sterminata di materiali, che vanno dal semplice approfondimento giornalistico al documentario d’autore propriamente inteso. Nell’impossibilità di tentare una mappatura sia pure provvisoria di questo territorio, che andrebbe esplorato con la pazienza e la diligenza dell’archivista, si possono se
non altro identificare alcuni grandi contenitori che hanno funzionato da riferimento per il pubblico cinefilo. Il programma fondamentale, senza dubbio, resta ancora oggi Fuori orario, iniziato nel 1988 e figlio anche della precedente esperienza de La magnifica ossessione (1985). Curata da Enrico Ghezzi con un ricco team di collaboratori che si sono poi avvicendati negli anni (Marco Melani, Ciro Giorgini, Paolo Luciani, Roberto Turigliatto…), la trasmissione porta sul piccolo schermo quel gusto per la programmazione onnivora che aveva caratterizzato la cinefilia dei club cinema, sfruttando però al meglio le risorse del mezzo televisivo, che permette spesso di accompagnare i film con materiali eterogenei (introduzioni, montaggi creativi, filmati di repertorio, persino rushes nude e crude). Da non sottovalutare, infine, la realizzazione di veri e propri critovideo, come il rimontaggio comparativo delle varie edizioni di Confidential Report (1955) di Orson Welles, curato da Ciro Giorgini e trasmesso all’interno del programma, nonché la partecipazione alla produzione di film come Le ceneri di Pasolini (1994) di Pasquale Misuraca. Come progetti paralleli di storia orale del cinema italiano vanno inoltre ricordate alcune trasmissioni che, proseguendo idealmente il lavoro avviato dal programma radiofonico di Francesco Savio Il secondo cinema italiano (1977), hanno raccolto negli anni le testimonianze di alcuni degli artefici (maggiori e minori) del nostro cinema: Catene (Patrizia Pistagnesi, 1985, ottima rievocazione del mélo italiano), Per Luchino Visconti (Caterina d’Amico de Carvalho, Vieri Razzini e L’Officina filmclub, 1987), La regola del gioco (Sergio Grmek Germani, 1996, sul cinema di genere), Il Club (1997-2000, talk show condotto fra gli altri da Tullio Kezich, Tatti Sanguineti e Sergio Toffetti), Stracult (Marco Giusti e altri, iniziato nel 2000 e tutt’ora attivo, dedicato soprattutto al cinema exploitation) e Un luogo chiamato cinema (Francesco Maselli, 2002), a cui si aggiunge in anni più recenti la rubrica Movie Extra (Cristina Torelli, Roberto Torelli e Paolo Luciani, 20122016), interamente realizzata con materiali di repertorio RAI. C’è però purtroppo da annotare che, come spesso capita per le produzioni televisive, i materiali raccolti non sono facilmente consultabili per chi non segua (e casomai registri) in diretta le trasmissioni [8]. Il mercato home video italiano, nonostante il boom degli anni 2004-2007, non ha oggettivamente mai raggiunto la ricchezza editoriale che è possibile riscontrare ancora oggi negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei contenuti speciali appositamente creati per le edizioni in DVD. Questo non esclude che, nel corso di oltre quindici anni, siano stati realizzati prodotti di un certo interesse, anche grazie
all’occasionale partecipazione diretta di alcuni registi, che hanno curato in prima persona l’edizione dei propri film (è il caso per esempio di Gianni Amelio e Maurizio Nichetti). A livello di video-interviste, tutto sommato alcuni degli extra più curati sono quelli dedicati al cinema di genere italiano degli anni Settanta, che proprio in questo periodo del resto ha conosciuto una sua valorizzazione critica (talvolta casomai discutibile): vedi esempi come Nella giungla: the Making of “Cannibal Holocaust” (Michele De Angelis, 2003) e Il giro del mondo in 16 anni (Federico Caddeo, 2014, dedicato alla carriera di Jacopetti e Prosperi). Ci troviamo però ancora, in linea di massima, nel regno della featurette, che quasi sempre si risolve nell’intervista inframezzata da qualche brano di film, senza un vero tentativo di fare critica servendosi delle possibilità interattive del DVD. Per contro, gli esempi di video-saggio si contano davvero sulle dita di due mani, tanto più che quelli storico-analitici realizzati da Adriano Aprà (Circo Fellini, 2010, All’ombra del Conformista, 2011, La verità della finzione, 2012) sono prevalentemente pensati per il mercato americano.
Si tratta in ogni caso per ora degli unici lavori italiani che si allineano alle più recenti tendenze della video-critica internazionale, sfruttando la possibilità di “smontare” il tessuto del singolo film e studiarne in dettaglio il funzionamento, spesso aiutandosi anche con testimonianze dirette o indirette in cui gli stessi autori offrono una cornice interpretativa per la propria opera. Un discorso a parte merita infine l’edizione in DVD curata da Giuseppe Bertolucci per uno dei film del fratello Bernardo, Prima della rivoluzione, per cui Giuseppe realizza nel 2005 un lavoro di taglio quasi enciclopedico, recuperando addirittura la copia lavoro e andando a intervistare tredici collaboratori e testimoni. Si tratta, con tutta probabilità, dell’operazione
filologica più importante mai realizzata nell’ambito dello home video italiano, resa possibile dalla particolare prospettiva “famigliare” con cui l’autore si avvicina alla materia. Se ci spostiamo al di fuori di quello che è il mercato ufficiale, lontano dai canali di distribuzione classicamente intesi (sala, televisione, home video), c’è da render conto anche di una fittissima filmografia fiorita in particolare negli ultimi anni, grazie agli strumenti leggeri del video. Nate da produzioni marginali, sono opere che spesso non a caso finiscono per eleggere a proprio soggetto (e feticcio) figure di cineasti altrettanto marginali, come nel caso di Pa’ (Fiorella Infacelli, 1981, dedicato al padre produttore, Carlo), Augusto Tretti: un ritratto (Maurizio Zaccaro, 1985), Divine Waters (Vito Zagarrio, 1985, su John Waters), Il cinema digitale secondo Giulio Questi (Stefano Consiglio, 2007), Non c’era nessuna Signora a quel tavolo (Davide Barletti e Lorenzo Conte, 2013, su Cecilia Mangini) e Tecniche miste su schermo (Bruno Di Marino, 2013, sull’underground romano del periodo 1965-1975). Un’impostazione per cui l’impegno si identifica spesso come “resistenza” la ritroviamo anche in una serie di video recenti che, allargando il campo, si concentrano non soltanto su film e cineasti, ma prendono in esame personaggi e istituzioni che hanno segnato la storia della cinefilia italiana: ritratti di critici (vedi i due film, anche molto intimi, dedicati alla figura di Morando Morandini, Je m’appelle Morando di Daniele Segre, 2010, e Morando’s Music di Luigi Faccini, 2012, o Lino Miccichè, mio padre: una visione del mondo, diretto dal figlio Francesco Miccichè, 2013), ma anche rievocazioni di festival (Sassi nello stagno di Luca Gorrieri, 2016, sul Festival di Salsomaggiore) o di sale cinematografiche storiche (Filmstudio, mon amour di Toni D’Angelo, 2015). Senza dimenticare l’autentica esplosione di video, di fattura spesso anonima e amatoriale, che nel 2014 ha accompagnato su internet la fine delle proiezioni in pellicola e lo switch off verso il digitale, vissuto da un’intera generazione di nostalgici come la fine di un’epoca. A livello universitario, laddove in teoria ci sarebbe spazio per sperimentazioni all’avanguardia, non sembra per la verità muoversi granché. Molti docenti, forse anche per motivi generazionali, si contentano infatti ancora oggi delle possibilità didattiche offerte dalla classica lezione frontale, accompagnata nella migliore delle ipotesi da video-proiezioni o dai soliti soporiferi powerpoint. Del resto, un esperimento editoriale come quello di Lezioni di cinema, deludente collana di DVD didattici del 2015, non fa che confermare la scarsa dimestichezza di molti studiosi con i mezzi della critica audiovisiva. Meglio guardare dunque a esperienze isolate quali il laboratorio condotto da Amedeo Fago presso la Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma (con
un certosino lavoro di analisi su location e scenografie), o al limite al lavoro di documentazione coordinato dall’Università di Padova, che pur senza particolari valori formali si inscrive con merito nel già citato orizzonte della storiografia orale (con video dedicati a personaggi eccentrici come Giuseppe Taffarel e Mario Brenta). Ultimo arrivato e, almeno per ora, ultimo in termini di interesse, è infine l’ambito della video-critica sul web. Mentre non mancano certo, a livello internazionale, operazioni di video-analisi o anche di reinvenzione creativa dei singoli film, a livello italiano sembra infatti prevalere per adesso un modello riconducibile alla formula para-televisiva del videoblog, in cui commentatori più o meno autorevoli finiscono per recensire verbalmente i film in uscita, senza approfittare minimamente delle ampie possibilità creative del video digitale, ma anzi riproponendo spesso tutti i peggiori vizi della critica giornalistica (pigrizia, impressionismo, autoreferenzialità). Segno che, forse, una riflessione sulle radici della video-critica sarebbe necessaria oggi più che mai.
Note del capitolo: 1. Jacopo Comin, Cos’è un “si gira”?, «Cinema», n. 24, 25 giugno 1937. 2. Si vedano in particolare i due servizi presenti nel «Giornale Luce» in data 21 ottobre (Le riprese cinematografiche del film “Scipione l’Africano” alla presenza del ministro Alfieri) e 30 dicembre 1936 (Maria di Savoia assiste alla ripresa di alcune scene del film “Scipione l’Africano”). 3. Girato nel 1943, il film arriverà però brevemente sugli schermi solo nel 1948, per essere poi recuperato integralmente all’interno dello special televisivo Mario Costa. Il novantenario del cinema (1995), realizzato da Fulvio Toffoli e Sergio Grmek Germani per Fuori orario. Per una discussione approfondita rimando a Simone Starace, “Una canzonetta, così alla buona”. Spettacolo e metaspettacolo nel cinema di Mario Costa, «Immagine», n. 7, gennaio-giugno 2013. 4. Un discorso a parte meriterebbero gli spazi concessi al cinema dalla programmazione televisiva, anche al di là delle rubriche specificamente dedicate. Nonostante il lavoro anche meritorio sulle Teche Rai, manca infatti attualmente la possibilità di studiare agevolmente tutta la mole di materiali relativa per esempio agli innumerevoli servizi di attualità, ma anche alle numerose presentazioni che accompagnavano la messa in onda dei film, con la partecipazione di critici specializzati (per esempio Claudio G. Fava e Vieri Razzini) e l’intervento talvolta degli stessi registi (anche stranieri). 5. L’influenza di questa esperienza saggistica sul cinema di Fellini è un aspetto ancora da approfondire, visto che il Block-notes sembra aprire le porte al mockumentary di I clowns (1971) e a Intervista (1987), in cui appunto il regista sperimenta delle forme narrative fortemente indebitate con la nonfiction. 6. Vale la pena di notare che sia l’edizione in VHS che il DVD del film sono accompagnati da un interessante making of, intitolato Argento puro, che funge in pratica da postfazione, rafforzando la vocazione saggistica dell’operazione. Sempre su Ferreri, sono da ricordare anche due ritratti: Ferreri, I Love You (Fiorella Infascelli, 2000) e Marco Ferreri. Il regista che venne dal futuro (Mario Canale, 2007). 7. Alla vena “saggistica” di Ciprì e Maresco vanno ascritti anche i cortometraggi Il corridore della paura (su Samuel Fuller), Martin a Little… (su Scorsese) e Pasolini secondo Sergio Citti, nonché i materiali confluiti nelle edizione in DVD dei loro lungometraggi e in diverse puntate della trasmissione televisiva I migliori nani della nostra vita (2006). Da ricordare anche la loro partecipazione come intervistatori al film Directed by Anthony Dawson (2003) di Lillo Iacolino, dedicato ad Antonio Margheriti. 8. Una parte delle interviste realizzate per Il Club e La regola del gioco è stata comunque successivamente recuperata in DVD da Ripley’s Home Video, mentre Movie Extra è consultabile in streaming (con tutte le limitazioni del caso) sul sito ufficiale RAI.
Piccolo schermo e mitologia del cinema: i programmi sul cinema nella televisione francese Céline Gailleurd, Olivier Bohler Da quasi dieci anni abbiamo la fortuna di poterci immergere regolarmente all’interno di archivi audiovisivi e cinematografici, cosa che consente di documentare la storia del cinema. Che si tratti di ripercorrere la carriera di Jean-Pierre Melville (Sous le nom de Melville, 2007), rivisitare la mostra di Jean-Luc Godard Voyage(s) en Utopie rapportandola agli interventi del cineasta in televisione (Jean-Luc Godard, le désordre exposé, 2012) o recuperare il pensiero di Edgar Morin sul cinema (Edgar Morin. Chronique d’un regard, 2014), i programmi della televisione francese conservati all’Institut National de l’Audiovisuel [1] costituiscono una materia fondamentale per i nostri film. Di questo vasto patrimonio audiovisivo, che esamineremo qui in modo frammentario e parziale, tenteremo di mettere in risalto solo i punti più salienti nell’ottica di mostrare al meglio come la televisione francese ha guardato il cinema. Se, come asserisce Jean-Luc Godard nelle Histoire(s) du cinéma, il cinema è l’unica arte in grado di fare la propria storia, che cosa succede quando se ne impadronisce la televisione? Quali spostamenti essa opera nel momento in cui il cinema si ritrova assorbito in questo mezzo di comunicazione di massa? Diventa una cosa diversa da una “merce culturale”? È destinato ad accompagnare tutta un’ideologia della felicità che riflette quella promossa dai media coevi? Il modo in cui il cinema viene appreso dal grande pubblico la dice lunga «sulla società che lo applaude» [2] così come sulla maniera in cui si è costruita la consapevolezza che di arte si tratta e non soltanto di intrattenimento. Come un valzer a quattro tempi, vedremo così che lo sguardo della televisione francese sul cinema ha avuto un’evoluzione molto chiara, passando dalla feticizzazione dei divi del cinema a un approccio più sociologico, per poi approdare al feticismo degli “autori”, nel senso di nouvelle vague, e finire molto più in là per occuparsi di fare la sua storia. Feticizzazione dei divi: Les Reflets de Cannes, Cinépanorama, Cinéma André S. Labarthe ha deplorato a varie riprese l’assenza di programmi televisivi dedicati al cinema anteriormente a Cinéastes de notre temps, ovvero al 1964: «A dire il vero, la maggior parte dei programmi culturali trasmessi in televisione all’epoca era appassionante… tranne quelli dedicati al cinema, visto che erano inesistenti – fatta eccezione per rare trasmissioni mediocri, fra cui quella di François Chalais e quella di Roger Boussinot» [3]. Non bisogna
pensare che Labarthe si stesse vantando del proprio lavoro: non pretende di essere stato il primo ad aver parlato di cinema ma semplicemente constata che, prima del suo, praticamente non vi erano trasmissioni interamente dedicate all’argomento. Prima dell’avvento della televisione, era prassi corrente parlare di cinema appunto nei cinegiornali che accompagnavano le proiezioni in sala. All’epoca era percepito sì come un argomento culturale ma soprattutto mondano, in stretta connessione con esigenze promozionali. Grazie alle Actualités françaises, legate a doppio filo con Pathé e Gaumont, e quindi alle più grosse case di produzione stesse, agli spettatori venivano così regolarmente propinate immagini dei divi, scene dai set più promettenti o dai film in programmazione, o ancora relative alla loro diffusione all’estero. Con la televisione la prassi di parlare del cinema all’interno dei programmi di attualità continua, fino a che nel 1952 nasce il primo programma interamente dedicato al cinema, Les Reflets de Cannes, che avrà una longevità eccezionale, durando fino al 1967. Tutti gli anni François Chalais copre il Festival di Cannes approfittando del momento in cui tutti i grandi nomi del cinema sono riuniti per intervistarli: le interviste poi andavano in onda dalla fine di aprile fino alla fine di maggio. I Reflets si inseriscono nel filone delle attualità cinematografiche: il soggetto stesso, un grande festival internazionale, apriva la strada a considerazioni leggere su un mondo di feste, glamour e paillettes volutamente lontano dalla quotidianità del lavoro delle celebrità (e degli spettatori). I programmi erano costituiti soprattutto da interviste raccolte in interni o nei giardini cannensi, intervallati con brevi filmati girati senza sonoro e scanditi da una ritmica disinvolta data dal commento off screen, in linea con la retorica tipica dell’epoca, dal tono volta a volta piccante, divertito o leggermente disincantato. Quello andato in onda il 5 maggio 1955 inizia con una carrellata che scende sulla Croisette al mattino presto, con uno spleen tipicamente cannense, accompagnato da queste parole: «Tutti i giorni le stesse persone mettono lo stesso piede sulle solite tracce, raccontandosi storie che naturalmente sono le solite storie…». Facendo rivivere un’atmosfera effervescente, il commento di François Chalais ci vuole far sentire il polso del cinema, offrendoci un resoconto dei festeggiamenti e altre follie che hanno luogo dietro le quinte o più volentieri sulle spiagge, con le stelline che cercano di attirare lo sguardo dei giornalisti abbigliate nei costumi da bagno più osés… Mezzo secolo più tardi abbiamo la misura di come queste immagini stereotipate continuino a forgiare il mito del festival, con le cerimonie di rito, i ricevimenti e le serate di gala. Queste trasmissioni rivelano fino a che punto,
poco dopo la guerra, il cinema – oggetto che esercita attrazione – sia integrato negli svaghi di massa costituiti da ferie pagate, spiagge, mare, sole e un edonismo ingannevole, nel quale la parte erotica ha una posizione di primo piano. Di Reflet in Reflet, attori e attrici sfilano sul tappeto rosso, corrono lungo la Croisette, si lasciano voluttuosamente andare al sole, muovendosi con destrezza, sfavillanti, in ambienti di lusso e di sogno. Si succedono i primi piani dei volti delle star. È un po’ come se fossimo davanti a delle fotografie patinate, tanto sembrano volersi cristallizzare per mantenere la posa, evocando così ciò che scriveva Roland Barthes in Miti d’oggi, fra il 1954 il ’56, a proposito dello stile Harcourt: «Ridotte a un volto, a delle spalle, a dei capelli, le attrici testimoniano così della virtuosa irrealtà del loro sesso» [4]. È all’opera una vera religione delle star. E forse non è un caso se Edgar Morin, proprio in Les Stars (1956) – opera anch’essa coeva dei Reflets de Cannes –, dedica al sogno di Cannes brani molto ispirati: «Come quando durante le Antesterie i morti ritornano fra i vivi, tutti gli anni al Festival di Cannes impalpabili vedettes abbandonano la pellicola per offrirsi allo sguardo dei mortali, degnandosi di avere un corpo, un sorriso, un passo terreno […]. Cannes è il luogo mistico dell’identificazione fra l’immaginario e il reale. […] Sono l’apparenza, la bellezza, l’eternità truccata, il mito della vedetteche-vive-il-film-della-propria-vita, il cinema magico, che regnano a Cannes per quindici giorni» [5]. Questi programmi si perdono nella contemplazione dei divi che si prestano al gioco dell’obbiettivo, come per esempio nella trasmissione dell’11 maggio 1955 in cui l’attrice Dorothy Dandridge, ripresa in piano sequenza, non fa altro che camminare e mettersi in pose affettate per la macchina da presa, finendo per danzare da sola sul tramonto, come in estasi, mentre il commento sottolinea, con il maschilismo tipico dell’epoca: «Si rimane come inchiodati dallo stupore davanti a tanta audace incoscienza, a tanti ormoni lasciati in libertà, senza alcun controllo». Tuttavia, laddove le attualità cinematografiche si accontentavano di mettere le brevi vignette in sequenza, in Reflets queste diventano delle pause fra le interviste, con un ruolo di spalla, senza avere nei primi anni particolare profondità, né a livello di pensiero sul cinema né su quello della realizzazione tecnica. A partire dal 1960, però, il dispositivo si evolve e diventa più complesso. Brevi scene offrono un “ritratto” della star, che mantiene la posa in silenzio per qualche secondo prima di prendere la parola. La trasmissione del 19 maggio 1960 comincia quindi con una lunga carrellata che ci fa scoprire in successione Michel Subor, Laszlo Kovacs e Anna Karina, ciascuno dei quali in posa di profilo o con il pugno sinistro sollevato, prima che la macchina da presa si fermi su Jean-Luc Godard, seduto di fronte all’obbiettivo. Ha appena finito di girare Le petit soldat e spiega quanto
desideri che il suo nuovo film crei enorme disappunto, perché preferisce combattere piuttosto che avere a che fare con l’approvazione compiacente. La critica sociale e l’espressione della rivolta sembrano colpire al cuore sia la Croisette sia la televisione di Stato, la quale parla di un film poi censurato per due anni e mezzo dal potere gollista. In realtà, appropriandosi di questa rivolta e facendone il verso, il programma televisivo rende aneddotica la stessa critica sociale, l’ennesimo capriccio da divi, gentilmente provocatorio ma inoffensivo… L’abbiamo però scelto per utilizzarlo in Jean-Luc Godard, le désordre exposé, e per varie ragioni. Prima di tutto perché fin dall’inizio l’inquadratura iniziale aspira al cinema e non alla televisione: oltre alla grana della pellicola e il dolce contrasto del suo bianco e nero, la lunga carrellata che riunisce come in una messa in scena concertata gli attori e il regista del film crea una sorta di scarto (che cosa fanno queste persone in piedi e in tali posture?), lavorando di impertinenza (il pugno levato, molto poco conforme all’estetica della coeva televisione gollista), seduzione (i giovani attori di una bellezza selvaggia) e umorismo (la sequenza che termina su Godard, seduto, leggermente incurvato, con un pullover scuro, poco in sintonia con il glamour dei suoi attori). Altrettante qualità che parlano dell’universo del cineasta, e più in particolare della tematica aperta nel nostro film grazie a questa sequenza, ovvero la provocazione godardiana che consiste nel non dare al pubblico ciò che esso si aspetta, per gioco, per conservare una maggiore libertà, per sorprendere, scandalizzare. È esattamente ciò che spiega a François Chalais, e questa sequenza ne è una perfetta sintesi. Parallelamente a Reflets du cinéma, François Chalais lancia nel 1956 Cinépanorama, un magazine mensile che andrà in onda per dieci anni. Nel 1966 viene ribattezzato Cinéma e durerà fino al 1967. Cinépanorama riprende sì diversi principi già all’opera in Reflets, come la messa in scena delle star, le interviste con registi e attori, ma affronta anche una nuova dimensione, quella del film in lavorazione. Si incontrano gli attori e i cineasti e li si intervistano direttamente sul luogo delle riprese. Questa è una svolta importante, in primo luogo perché il cinema viene finalmente inteso come industria e non solo come sogno e incanto. Scopriamo le maestranze, gli operai al lavoro sulle scenografie con la sega in mano e il berretto in testa, gli elettricisti che trasportano cavi e riflettori… All’improvviso agli spettatori il mestiere del cinema sembra più vicino a quello dei piccoli artigiani, che conosce bene, rispetto ai soliti capricci dei divi che venivano loro sciorinati con dovizia. Oltretutto queste costituiscono testimonianze preziose che documentano le condizioni della produzione cinematografica, il lavoro dei cineasti sul set, a volte perfino mentre tagliano delle scene al montaggio.
Per quanto riguarda le interviste, esse assomigliano più a una conversazione amichevole che a riflessioni approfondite sull’arte cinematografica. François Chalais, molto presente, non esita a interrompere gli interlocutori per dire la sua. Spesso le domande vengono poste a tutta velocità, tanto che le risposte, molto brevi e poco articolate, fanno sembrare l’animatore il “vero” protagonista. François Chalais se lo può permettere ancora di più in quanto spesso conosce molto bene le persone che interroga, o perché ne segue la carriera da tempo o perché intrattiene con loro veri rapporti di amicizia. Infonde quindi un senso di intimità con i divi che da una parte sovverte l’abituale rapporto di adorazione ma dall’altra costituisce nuovo elemento di fascino. È il caso ad esempio della puntata di Cinéma del 30 luglio 1966, interamente dedicata a Jean-Pierre Melville impegnato nelle riprese di Tutte le ore feriscono… l’ultima uccide (Le deuxième souffle). L’intervista si svolge nell’immenso ufficio all’interno dei suoi studi. Il tono è cortese e le domande possono apparire leggere, perfino banali: a che età Melville ha cominciato a fare cinema (a 6 anni, con la sua macchina Pathé Baby!), quand’è che ha deciso veramente di dedicarsi al cinema… A poco a poco però si comprende che dietro tutte queste domande c’è uno scopo: far spiegare a Melville come abbia potuto realizzare Le silence de la mer nel 1947 senza aver mai lavorato prima nel cinema, cosa però obbligatoria secondo i termini legali in vigore all’epoca. E quando gli chiede di ritornare sui suoi gusti d’anteguerra, in particolare per il varietà o il teatro, aspetti che giustificano il suo amore per gli attori e specificamente per coloro che erano passati per il palcoscenico o il cabaret, come Jean-Paul Belmondo, Yves Montand o Bourvil. Tanto che, quando lo vediamo dirigere una scena di Le deuxième souffle, abbiamo la misura della precisione certosina delle sue indicazioni nel mentre spiega per ciascun personaggio, in un corridoio anche angusto, una concatenazione perfetta dei gesti da compiere. Ma più avanti, evocando le ragioni che lo hanno spinto a rifiutare di girare l’adattamento di Week-end à Zuydcoote, Melville ritorna sul periodo antecedente all’inizio della sua carriera: racconta il proprio percorso durante la guerra, la sconfitta, subita nonostante l’eroismo dei soldati, che rimprovera al libro di aver eluso. A distanza di tempo, ci si rende conto che Melville non ha mai raccontato questa versione dei fatti ad altri intervistatori, nonostante essa dia ragione della sua tenacia, del suo gusto per la lotta, della sua intransigenza – tutte qualità che lo hanno portato a diventare produttore di se stesso a 28 anni in un’era in cui sembrava impossibile. È che, di fatto, è amico dell’uomo che lo interroga, e sta parlando in confidenza. Questa amicizia, dapprima non dichiarata, Chalais non la dissimula a lungo, e lui stesso confessa che in realtà hanno l’abitudine di darsi
calorosamente del tu. È il motivo per cui in Sous le nom de Melville questa intervista ha una posizione prominente anche se frammentata attraverso il documentario. Il principio in effetti era di dare il più possibile la parola a Melville in modo che sembrasse raccontarsi da sé, in particolare relativamente all’esperienza della guerra e della Resistenza, il cui impatto si estende su tutto l’insieme della sua opera. I suoi film dispiegano un vero e proprio cosmo basato sui valori dell’onore, del pericolo, dell’amicizia virile, che traggono origine dal suo vissuto di Resistente e di soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa puntata di Cinéma nella voce di Melville si sente un calore, la voglia di confidarsi un po’, in definitiva un’umanità che non combaciano con l’immagine seriosa che conosciamo. Dietro il tono leggero e faceto di Chalais, con le sue domande aneddotiche a priori, si cela quindi un talento di giornalista senza pari che, pur non affrontando veramente l’estetica del cinema e le sue problematiche fondamentalmente artistiche, è come una formidabile “levatrice di parole”, parole essenziali per la comprensione dei personaggi che avvicina.
Feticizzazione degli autori: Cinéastes de notre temps, Cinéma cinémas Mentre i programmi di François Chalais attraversano il tempo rimanendo pressoché immutati, la Francia e la società francese invece mutano. Il numero di coloro che possiedono un televisore aumenta, e costituisce da un anno all’altro un pubblico meno borghese oltre che più giovane. Il dopoguerra vede anche nascere una nuova categoria di popolazione: i cinefili. Per la prima volta una generazione si educa al cinema, scrive sul cinema in riviste che s’impongono con forza nel paesaggio culturale del paese elevando al rango di autori i cineasti a cui si affeziona, attribuendo loro un’importanza maggiore che agli interpreti. Da questa generazione nasce la nouvelle vague, che
metterà a soqquadro il cinema, la sua economia e il sistema divistico. È in questo contesto che nel 1964 viene lanciata da André S. Labarthe e Janine Bazin la serie Cinéastes de notre temps [6]. Ex critico dei «Cahiers du Cinéma» e autore di Essai sur le jeune cinéma français, Labarthe è uno dei primi a constatare l’influenza della televisione (e in particolare del servizio di cronaca) sul rinnovamento estetico del cinema moderno [7]. Il suo interesse per questo mezzo di comunicazione, quindi, è grande. Unico nella storia della televisione francese, Cinéastes de notre temps ripensa la presenza del cinema alla televisione. L’intermediario non è più un presentatore o un giornalista, ma un regista o un critico, scelto per l’eventuale affinità con il cineasta che introduce: Alexandre Astruc prende in esame Murnau, Jean Douchet Alexandre Astruc, Jacques Baratier si dedica a René Clair, Rivette a Renoir, più avanti Claire Denis a Rivette, Jean-Pierre Limosin ai fratelli Dardenne, Paulo Rocha a de Oliveira, Assayas a Hou Hsiao-hsien, Pedro Costa agli Straub… Quello di Labarthe è un gesto innovativo e forte. Il lavoro di produttore del programma per lui è in qualche modo assimilabile a quello del caporedattore di una rivista – rivista che farà uscire più di 100 numeri, tanto che nel 2011 avranno l’onore di una retrospettiva al Centre Pompidou. Non sono più trasmissioni dallo schema ripetitivo, modellate all’infinito sullo stesso formato, ma opere a pieno titolo, che rimettono il proprio autore in primo piano, sono contraddistinte da uno stile proprio e appartengono in tutto e per tutto alla loro filmografia, contribuendo alla storia del cinema tanto quanto i soggetti di cui parla. Rompendo con il servizio di cronaca o la convenzione della diretta, i documentari prodotti da André S. Labarthe e soprattutto quelli diretti da lui prendono spesso in prestito tecniche dal cinema di finzione: «Quando si utilizza la finzione per un oggetto documentario, quest’ultimo guadagna in profondità» [8] dice Labarthe. Ciascun episodio ci fa così penetrare nell’universo di un cineasta, entrandovi in risonanza per mezzo della regia, del suono e del montaggio: nell’episodio di Claude Chabrol, girato a casa sua, la suoneria incessante di un telefono fa crescere una tensione angosciante; in quello dedicato a Cronenberg, Labarthe opera un détournement del dispositivo campo-controcampo, mettendo il regista in una stanza buia di fronte a uno schermo televisivo da cui sembra continuamente poter scaturire il peggio… È evidente che il gusto per la finzione all’interno del documentario ha profondamente segnato il nostro stesso lavoro, e che nel fare i nostri film abbiamo seguito le orme di André S. Labarthe. Sulla sua scorta abbiamo sempre sostenuto che la verità al cinema non esiste, o piuttosto che la si può
cercare esclusivamente attraverso i mezzi del cinema – principalmente la regia e il montaggio. Sintomaticamente, André S. Labarthe è presente anche in Sous le nom de Melville, Jean-Luc Godard, le désordre exposé, oltre a essere il soggetto di un ritratto che abbiamo fatto di lui, André S. Labarthe, du chat au chapeau (2011), in contemporanea con la sua mostra Le chat de Barcelone. In Jean-Luc Godard, le désordre exposé non abbiamo esitato a chiedergli di improvvisare delle scene, e lo studio in cui si svolge la maggior parte del film è un luogo che si rivela essere una sorta di riflesso della mostra Voyage(s) en Utopie, ma non la mostra stessa. Ma è soprattutto in Edgar Morin. Chronique d’un regard che la lezione di Labarthe ci è stata utile. Abbiamo fatto di Edgar Morin un personaggio non falso ma diverso da quello che i media fanno vedere di solito. Abbiamo immerso la sua luminosa personalità in ambientazioni notturne, solitarie, che rendono il suo discorso più cupo, avvicinandolo agli eventi tragici che lo hanno colpito, dalla morte della madre quando era bambino alla perdita dei compagni durante la guerra. Il rifugio che per lui ha costituito il cinema, e soprattutto la sua forza redentrice – un’idea importante in Morin – risaltano molto meglio che se avessimo privilegiato l’aspetto gioioso della sua personalità.
Nel 1982 Pierre Desgraupes, allora responsabile editoriale di Antenne 2, dà carta bianca a Michel Boujut affinché sviluppi un nuovo programma dedicato al cinema. Si tratta di Cinéma cinémas. Michel Boujut si avvale delle competenze del regista Claude Ventura e della giornalista Anne Andreu. Dal gennaio 1982 al novembre 1991 questa squadra sarà assistita anche, più o meno regolarmente, da personaggi esterni quali André S. Labarthe (molto spesso) e poi Serge Le Péron, Wim Wenders, Richard Leacock, Bernard Gesbert, Raoul Sangla, Pierre Oscar Lévy, Guy Girard… Fin dai titoli di testa viene fissato un appuntamento con l’emozione. Accompagnato dalla colonna musicale classica composta da Franz Waxman per Un posto al sole (A Place in the Sun di George Stevens, 1951), l’occhio della cinepresa scorre su un affresco dipinto da Guy Pellaert svelando progressivamente Marlon Brando in Fronte del porto (On the Waterfront), Fellini che dirige La dolce vita, Nicolas Ray, il Belmondo di Fino all’ultimo respiro (A bout de souffle) filmato da
Godard attraverso il parabrezza dell’automobile americana, infine Wim Wenders che gira L’amico americano (The American Friend) in una camera d’albergo in cui troneggia… un televisore sul quale l’obbiettivo fa uno zoom come se volesse entrarci dentro. Su ciascuno di questi momenti della storia del cinema risuonano brandelli di dialoghi dei film, buffi o laceranti, una babele di elementi che ci porta a ricordare tempi ormai lontani. Ciascun episodio è composto da una decina di filmati più o meno lunghi, separati da uno spezzone sempre identico: Lemmy Caution che apre una dopo l’altra le porte del corridoio di Alphaville. Un misto di impertinenza, malinconia e cordoglio aleggia sul programma, la cui estetica aspira manifestamente – come in Cinéastes de notre temps – ad avvicinarsi il più possibile al cinema piuttosto che alla televisione, offrendo una versione nostalgica dei miti ancora vivi ma sul punto di scomparire, con il sottofondo di musiche jazz “tristi” o lamentose che celebrano il grande cinema come fosse l’ultimo spettacolo e riattizzando a frammenti gli ultimi fuochi. Caratterizzato da un feticismo tutto cinefilo, Cinéma cinémas vuole anche essere un elogio dell’eterogeneità, il cui unico collante sarebbe la settima arte: interviste, omaggi, spezzoni di film o di pellicole originali, documenti d’archivio, libri… Non dimentichiamo che il programma è coevo di quella grande e magnifica orazione funebre che sono le Histoire(s) du cinéma di Jean-Luc Godard. La dimensione di funerale torna con forza in Adieu Rita, l’episodio del 27 maggio 1987 realizzato da Labarthe: la morte dell’attrice Rita Hayworth incarna quella del cinema. «Il cinema si è spento. Morte del cinema, ancora una volta…» dichiara con timbro cupo Jean-Claude Dauphin. Labarthe ricrea la morte dell’attrice attraverso la morte del personaggio da lei interpretato ne La signora di Shanghai (The Lady from Shanghai). Il grido straziante di Rita Hayworth, «I don’t want to die!», nel momento in cui il personaggio di Welles la abbandona agonizzante, diventa metafora del cinema che non vuole morire. Appoggiato su un tavolo, il televisore che trasmette il film di Welles assume una dimensione spettrale e finisce per riempirsi di quella “neve” che, come recita il commento, «cade sugli schermi quando è tutto finito». Un televisore che faceva parte della quotidianità dei cinefili nottambuli che arrivavano alla fine della programmazione con le ore piccole e che trasmetteva una dimensione ansiogena, come un’immagine della morte. Con la morte di Rita Hayworth, è tutto un universo cinematografico che scompare con lei. Ma al di là dell’atmosfera da veglia funebre la forza di questi episodi sta anche nel fare dei cineasti, attori, produttori, sceneggiatori, personaggi che sembrano usciti da un film di finzione, come assorbiti dall’universo che
creano, a tal punto che alcuni di essi sembrano veri e propri cortometraggi. La mimesi con la finzione appare anche nella scelta di ambientazioni naturali invece che in studio e nel modo di mettervi in scena la gente di cinema: Wim Wenders a Berlino o Isabelle Huppert in un caffè parigino, potrebbero essere personaggi di La maman et la putain; Catherine Deneuve in una suite del Crillon che legge un testo di Villiers de L’Isle-Adam o Welles che pranza da Fouquet sembrano uscire appunto da un film di Welles; Jacques Monory che nuota in una piscina in California evoca la Nuova Hollywood… In Jean-Luc Godard, le désordre exposé abbiamo deciso di utilizzare Godard Blues, un brano dell’episodio del 6 febbraio 1985 realizzato da André S. Labarthe.
Jean-Luc Godard, in un’auto guidata dallo stesso Labarthe, attraversa Parigi una notte d’inverno per andare alla proiezione del suo nuovo film, Je vous salue, Marie. I due discutono immersi nella luce azzurrognola della città, facendo un bilancio di ciò che è diventato il cinema dopo la nouvelle vague, dopo la morte di Truffaut, di Romy Schneider e di Langlois – secondo Godard ammazzati dai giornalisti e dalla televisione – e dell’importanza o meno di ingaggiare un dibattito con il pubblico al momento dell’uscita di un film. Lunghi silenzi. JLG aspira il suo sigaro. I riflessi dei lampioni scivolano sul parabrezza, evocando Il bandito delle 11 (Pierrot le fou). 27 anni dopo, nel 2012, abbiamo fatto guidare nuovamente nella notte di Parigi André Labarthe. In questa sequenza, che apre il nostro film, il tragitto è solitario, malinconico. Labarthe si mette a parlare da solo. E grazie al miracolo dell’archivio Godard, improvvisamente, gli risponde. Si stabilisce così l’atmosfera: l’amico Godard manca a Labarthe, gli manca proprio, e come in un sogno si inventa la sua
presenza. Il gioco del montaggio cancella il tempo e la distanza. I due compagni non evocano più il fatto di incontrare il pubblico, ma quello dell’andata al Beaubourg, il luogo dove è stata presentata nel 2006 la mostra di Godard Voyage(s) en Utopie. Constatano con amarezza che non ci vanno più tanto spesso, o ci vanno «per tristezza», per vedere «ciò che non è stato fatto». Quando, pochi istanti dopo, Labarthe arriva al Centre Pompidou, cerca la mostra di Godard ma gli viene detto che è stata ufficialmente chiusa e smantellata da sei anni. Poco importa: la reinventerà e ce la farà visitare. Qui l’archivio non interviene a titolo di prova o testimonianza: ne abbiamo alterato il senso, l’abbiamo estratto dal contesto e rimontato, aprendo una breccia verso la finzione. E la verità annunciata da questa finzione è più importante di quella delle immagini originali: in questo momento lo spettatore sa che il film guarderà al lavoro di Godard attraverso il prisma di una vecchia amicizia, in maniera soggettiva e sentimentale. A partire da lì gli andirivieni nel tempo continueranno a moltiplicarsi, dai primi anni del cineasta al momento dell’esposizione, per mostrare come l’incomprensione di quest’ultima da parte del pubblico e della critica fosse scritta fin dall’inizio, annunciata in tutta l’opera e il pensiero del regista. In questo viaggio attraverso il tempo Labarthe, che è sempre stato fra gli interlocutori privilegiati di Godard, ne resta anche l’indefettibile compagno. Sguardo sociologico: il cinema alla prova della verità Roger Boussinot produce due programmi televisivi con un approccio più sociologico, Démons et merveilles du cinéma, dapprima mensile e poi con cadenza bi-trimestrale (dal 02-05-1964 al 17-11-1969), et Visages du cinéma (dal 10-04-1970 al 14-01-1973), ovvero quasi dieci anni di programmazione dedicata al cinema. Il primo era focalizzato sul posto occupato dal cinema nella società francese e su coloro che contribuiscono a farlo, dai giovani produttori agli esercenti di sale cinematografiche, dai creatori di disegni animati fino ai caratteristi specializzati nel ruolo del traditore. Al primo impatto l’influenza del “cinema verità” salta agli occhi: i realizzatori di questi episodi prendono d’assalto la strada, filmano nei locali, fanno domande ai passanti… Lasciano tempo a dei perfetti sconosciuti per confidarsi, parlare delle loro speranze e disillusioni, come in L’apprentie vedette, ritratto di Yvonne Berger, una ragazza che sogna di diventare attrice: la seguono dal risveglio al mattino, con gli esercizi di ginnastica, fino alle terrasses sugli Champs Elysées dove si piazza per intercettare i produttori… Un episodio andato in onda il 25 luglio 1964, intitolato Premier film e diretto da Jean Claude Bergeret, prende di mira, con toni amabilmente beffardi, proprio la moda del “cinema verità”. Seguendo l’impostazione sociologica, viene data
una preferenza ai giovani: cineasti come Agnès Varda, sul set del suo terzo lungometraggio Il verde prato dell’amore (Le bonheur) o produttori come Pierre Kalfon (che più avanti, nel 1969, co-produrrà la Medea di Pasolini e, nel 1997, Blackout di Abel Ferrara), il quale parla delle difficoltà nel produrre il secondo film. Nell’altro programma prodotto da Roger Boussinot, Visages du cinéma, i protagonisti sono più gli attori e i registi, a volte in tandem. Bourvil e Mocky, Jean-Louis Trintignant, Nico Papatakis, Stéphane Audran e Claude Chabrol, Alain Cuny… Gli episodi, di 52 minuti, hanno ciascuno una forma diversa a seconda del contenuto. Le persone vengono filmate a diverse riprese nella loro intimità, come Trintignant seguito nella quotidianità di famiglia, o JeanPierre Mocky al lavoro con lo sceneggiatore sul prossimo film. Certi episodi offrono variazioni più complesse: in quello dedicato a Pierre Braunberger sono convocati vari registi, quali Jean Rouch o Marc Allégret, che raccontano dei loro rapporti con lui nelle varie tappe di lavorazione dei film. Ormai lontano dal divismo e scevro di glamourizzazione, Visages du cinéma rivendica un approccio innanzitutto umano, offrendo uno spettro sociologico della professione piuttosto ampio. Da apprezzare anche l’interesse nei confronti delle giovani generazioni. Un episodio, girato negli studi dell’Università di Vincennes, mostra gli studenti di cinema di Jean Douchet che analizzano l’adattamento di Madame Bovary fatto da Jean Renoir. Lunghe carrellate girano intorno al cerchio che hanno formato, mettendoli in risalto quando prendono la parola. In Réalisateurs de 20 ans giovani registi, studenti di cinema all’Università o all’IDHEC muovono i primi passi negli studi del Dipartimento Ricerca della ORTF. Gli scambi di battute si alternano con sequenze dei loro cortometraggi, lasciando uno spazio di primo piano alla sperimentazione. Feticizzazione della storia del cinema – Gli enciclopedici Il cinema francese è stato il tema di due grandi serie televisive realizzate a poca distanza di tempo l’una dall’altra. Il concetto alla base di questi programmi potrebbe sembrare, da lontano, una poco ambiziosa divulgazione dell’argomento. Ma non lo era affatto. L’histoire du cinéma par ceux qui l’ont fait era composta da 13 episodi prodotti e animati da Armand Panigel, musicologo, editore, cinefilo, collezionista, vero enciclopedico [9], che dal gennaio all’agosto del 1975 ha ripercorso la storia del cinema francese a partire dal muto fino alla nouvelle vague. Armand Panigel aveva già prodotto Thèmes et variations du cinéma (1966-1970) e Au cinéma ce soir (1969-1970), programmi che a modo loro
lavoravano sulla storia del cinema. Il primo affrontava temi o film o registi, da Les Docteurs Mabuse a Mysoginie ou matriarcat, passando per Les noirs dans le cinéma américain, Adapter Zola, L’enfance au cinéma, Orson Welles… Il secondo programma proponeva un film di repertorio incorniciato fra quindici minuti di attualità dell’epoca e quindici minuti di testimonianze sul film da parte del regista, dei compagni di avventura o degli amici. L’histoire du cinéma par ceux qui l’ont fait trattava delle condizioni della creazione di film nella loro epoca e della loro ricezione. Venivano convocati quanti più testimoni diretti fosse possibile, ripresi in studio su un fondale nero oppure a casa loro. Chiamati in gran numero, le loro parole erano sostenute da spezzoni di film, cinegiornali, fotografie o ritagli di giornale e a volte da interviste con i cineasti realizzate in altri tempi o mandate in onda in altri programmi. Panigel interviene con la voce fuori campo quando non trova nessuno che possa narrare un evento o per fare le transizioni. Un esempio è l’episodio 1895-1914: le premier âge du cinéma français, in cui gli attori principali della scoperta del cinema non sono purtroppo più in vita. In ogni caso, i pochi ospiti “d’epoca” testimoniano della volontà dell’autore di ritrascrivere il sentimento di un’era, distaccandosi dalla base concettuale comune a numerose storie del cinema. Scopriamo così che i pionieri della settima arte non erano originariamente convinti del risvolto artistico delle prime proiezioni. Marcel L’Herbier o Jean Painlevé concordano con Abel Gance quando spiega: «Ero rimasto molto impressionato al Dufayel [10] quando ho visto le prime immagini di L’arrivée d’un train à La Ciotat. Ma per la verità devo dire che il mio era più uno stupore, uno stupore che non avevo elaborato. Perché quel che vedevo era brutto. L’arroseur arrosé, cose di questo genere, erano brutte». Oltre a questi pregiudizi storici, sta nell’incredibile casting il valore del programma: Roger Leenhardt, Marcel Carné, Marc Allégret, Michel Simon, Henri-Georges Clouzot, Pierre Braunberger, Jean Delannoy, André Zwobada, Christian-Jaque, Pierre Billon, Raymond Bernard, Agnès Varda, Georges de Beauregard, Claude Chabrol, Henri Colpi, Eric Rohmer, Jacques Doniol-Valcroze, Jacques Demy, Costa Gavras, Roger Vadim, Louis Malle… Raramente un ventaglio della professione così ampio sarà raccolto davanti alla cinepresa, e il nostro sogno sarebbe di poter consultare i giornalieri integrali di quelle interviste, che sicuramente dureranno diverse decine di ore. Solo due anni dopo, la televisione francese produce L’encyclopédie audiovisuelle du cinéma: le cinéma français di Claude-Jean Philippe. Ci si potrebbe chiedere quale fosse l’interesse a tornare sull’argomento a così poca distanza di tempo. Tanto più che l’ambizione sembra molto modesta: il corpus
visivo è relativamente semplice poiché si limita a offrire spezzoni di film, foto e, a volte, qualche immagine d’archivio o di attualità. Il programma non aspira al nuovo né porta nuove testimonianze, ma rappresenta un complesso ben più vasto: si tratta di 41 film trasmessi fra il 1977 e il ’79. È articolato per epoche (Les années 10 ou le Temps de l’hécatombe; Les années 50 ou le Commencement d’une peur inconnue e così via) o per regista (Abel Gance, Renoir, Epstein, Grémillon, Duvivier…) o ancora per attore (Jean Gabin, Gérard Philippe, Michel Simon…). «L’interesse, per me, stava nel creare degli articoli di enciclopedia che fossero allo stesso tempo dei film» spiegava Claude-Jean Philippe, per poi aggiungere: «Ho potuto ascoltare il grande dialogo dei cineasti francesi nel corso del tempo» [11]. In realtà il suo lavoro si impone come modello di umiltà e di poesia. La voce, quasi un mormorio, di Jean Rochefort che accompagna fuori campo gli episodi, nei film cerca innanzitutto l’umanità, mettendone in risalto o la coerenza o il carattere innovativo e citando interviste, articoli o testi teorici. Ma è soprattutto il testo dello stesso Claude-Jean Philippe che si rivela carico di rara emozione. Contrariamente a Labarthe, non è tanto la morte del grande cinema (Cinéma cinémas) o un’enciclopedia “vivente” del cinema (Cinéastes de notre temps) che lo interessa, quanto piuttosto una forte nostalgia per dei fratelli che il tempo gli ha impedito di conoscere o ha allontanato troppo presto. «Si vuole intervistare dei fantasmi. Non ci sono più. La loro opera sopravvive, ma loro dove sono?» sentiamo dire da Michel Simon su inquadrature mute di lui, con lo sguardo perduto nel vuoto, lui che è già scomparso da quattro anni. «Non è forse l’opera di Michel Simon la sua stessa vita che sopravvive per noi sullo schermo di un cinema?» chiede Rochefort-Philippe. C’è indubbiamente un’arte del montaggio, perché alla fine dei conti è su questo che si fondano gli episodi. Spesso il commento riposiziona un estratto nella narrazione e, in poche parole, gli dà tutta la sua forza drammatica, per offrirlo poi alla contemplazione dello spettatore. Per il bellissimo film dedicato a Epstein vengono utilizzate prevalentemente le sue parole, estratte dai suoi libri. Messe in rapporto con sequenze scelte nell’insieme della sua opera, permettono di comprendere la portata del suo pensiero e del suo genio. Non stiamo parlando di analisi della sequenza ma di teoria confrontata con la pratica: il risultato è sconvolgente. Per quanto prezioso per il pubblico, il programma resta comunque difficile da citare nel contesto di altri documentari sul cinema: quando si tenta di estrarne un frammento il senso del tono e della coerenza si perdono. Sono oggetti meravigliosi che brillano per se stessi. Bisognerebbe citare molti altri programmi per rendere giustizia alla ricchezza delle teche della televisione francese. Avremmo potuto parlare di quelli realizzati alla fine degli anni ’50 da Marcel L’Herbier o dalla metà degli anni
’60 da Pierre-André Boutang, che ha condotto interviste appassionanti in Les écrans de la ville, Cinéma critique, Ciné regards, Champ contrechamp e ancora Etoiles et Toiles o Projection privée. Avremmo potuto menzionare Cinéma sans étoiles, dedicato ai cortometraggi, grazie al quale si possono scoprire delle vere chicche (perfino un film inedito di Pierre Étaix) e altri ancora. Questa memoria profondamente popolare del cinema – perché destinata al grande pubblico – permette di cogliere un’epoca e di diventare tutt’uno con le mentalità e i sogni che suscitava la settima arte. Consente di immergersi nell’immaginario collettivo, nelle sfide culturali. Ci dà oggi la possibilità di lavorare l’insieme delle rappresentazioni collettive di una società. Il modo in cui il cinema circola in televisione fa parte della storia culturale. Come afferma Pascal Ory in La culture comme aventure. Treize exercices d’histoire culturelle, «la cultura è determinata», «quindi mediatica», quindi «contestuale». Il cinema è stato senza dubbio sia un soggetto della società sia un soggetto culturale, raggiungendo fra gli anni ’50 e ’80 tutti gli strati di popolazione. A poco a poco, a partire dagli anni ’80 questo tipo di programma tende al declino, fino a limitarsi a operazioni promozionali per film di cui i canali televisivi sono spesso produttori. Solo la televisione via cavo, con canali come Ciné+ o Orange, finanzia e mette regolarmente in programmazione film dedicati al cinema, ma in una congiuntura estremamente fragile, resa ancor più difficoltosa dalla questione del costo dei diritti degli estratti – la cui utilizzazione in precedenza era totalmente libera – trasformandosi in un baratro finanziario per i produttori. Per il nostro ultimo film, Edgar Morin. Chronique d’un regard, abbiamo fatto la scelta di lasciare da parte gli archivi della televisione. Era diventato più importante, per noi, costituire un archivio a nostra volta. Che cosa poteva esserci di più prezioso che ascoltare Edgar Morin a 94 anni mentre ritorna sui suoi primi ricordi di spettatore e soprattutto sulle proprie opere dedicate al cinema, che risalgono ormai a 60 anni fa, e sulle quali nessuno gli faceva più domande tanto il suo pensiero è tuttora ancorato nell’attualità? I nostri film si sono nutriti degli altri film – speriamo che a loro volta possano essere di nutrimento per gli storici a venire. Traduzione dal francese di Carla Scura
Note del capitolo: 1. Il fondo dell’Institut National de l’Audiovisuel raggruppa tutti i documenti audiovisivi mandati in onda. Questi sono consultabili on line per i professionisti, mentre per il pubblico generale sono a disposizione all’Inathèque, presso la Biblioteca nazionale francese. Questi archivi sono stati integrati nel corso del tempo da diversi altri fondi audiovisivi, fra- cui quello delle Actualités Françaises – i cui documenti più antichi risalgono al 1924 – che comprende anche numerosi materiali sul cinema. 2. Pascal Ory in La culture comme aventure. Treize exercices d’histoire culturelle, p. 10. 3. André S. Labarthe, “Naissance d’une collection”, in André S. Labarthe, Thierry Lounas, La saga “Cinéastes, de notre temps” : une histoire du cinéma en 100 films, Nantes, Capricci 2011, p. 8. Tutte le citazioni sono a cura del traduttore là dove non diversamente specificato, N.d.T. 4. Roland Barthes, Mythologies, Paris, Éditions du Seuil (1957), 1970, p. 25 (Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1975). 5. Edgar Morin, Les stars, Paris, Éditions du Seuil (1957), 1962, pp. 59-61 (I divi, Milano, Mondadori 1963). V. anche Edgar Morin, “Notes pour une sociologie du Festival de Cannes”, Les Temps modernes, giugno-luglio 1955. 6. Da allora ribattezzato Cinéma, de notre temps, il programma continua grazie al sostegno del canale Ciné+ (Bruno Deloye). 7. Essai sur le jeune cinéma français, Éd. Le Terrain Vague, Paris 1960, p. 17: «Il cinema, nella sua accezione più tradizionale, ha sempre cercato l’angolo di ripresa ideale, assoluto, mentre il nuovo cinema, conformemente alla lezione del cinema di reportage, del film televisivo e di certe opere neorealiste, mira maggiormente alla ricerca della miglior angolazione possibile date determinate circostanze, proprio come noi, nella vita di tutti i giorni, cerchiamo il miglior punto di vista rispetto a un incidente stradale, sul quale è impensabile avere la vista ideale, il punto di vista assoluto». 8. “Interview d’André S. Labarthe”, in Gilles Menegaldo e Claude Murcia, Cinéma documentaire, cinéma de fiction: frontières et passages, Poitiers, La Licorne, n° 24, 1992, p. 186. 9. Alla sua morte, nel 1995, lascerà una collezione personale di oltre 200.000 dischi di musica classica, 40.000 film e 160.000 libri di musica e di cinema. 10. I Grands Magasins Dufayel, uno dei grandi magazzini più vasti del mondo ante-Prima Guerra Mondiale, contenevano anche una sala cinematografica. 11. France Régions 3 Lyon (FR3LY), giovedì 19-10-1978.
Film sul cinema. Il periodo muto Kevin Brownlow Ci vuole un certo talento per riuscire a guardare un film e allo stesso tempo dedicare attenzione alle modalità con cui è stato realizzato. Un ideale split screen dovrebbe essere guardato con una mente altrettanto split, divisa a metà. All’epoca del muto i tentativi di mostrare i processi cinematografici sono stati scarsi, perché agli occhi di molti spettatori sarebbero risultati altrettanto incomprensibili della fisica dei quanti. Il maggior deterrente per i professionisti del cinematografo era la paura di spezzare l’illusione, quasi di farsi scoprire. Ora sappiamo che si può spiegare anche l’effetto speciale più complicato e che, lungi dal mitigare il senso della meraviglia, la rivelazione lo incrementa. Eppure alle origini gli aficionados del cinema evitavano questo tipo di film, proprio perché non volevano sapere come i film venivano fatti. Quindi dovremmo valorizzare i rari film sopravvissuti, sia di finzione che documentari, in quanto anche nella finzione c’era molto di documentario. Nel 1967, durante il restauro del Napoléon, la BBC mi ha proposto di realizzare un documentario sul regista, Abel Gance. Per assicurarmi dell’approvazione da parte del maestro, andai a trovarlo nel suo splendido appartamento a Parigi. Era totalmente favorevole, e mi consigliò, nel momento in cui avessi cominciato a selezionare i materiali alla Cinémathèque Française, di richiedere il girato che lui stesso aveva realizzato durante le riprese. Dapprima pensai di non aver capito bene, il mio francese era pessimo e lui non parlava inglese. Quando ripeté, pensai che fosse un po’ rimbambito. Sicuramente nessuno documentava (visivamente) la realizzazione dei propri film, non lo fanno adesso (riflettei), perché avrebbero dovuto farlo allora? Ma andai coscienziosamente alla Cinémathèque e mi portarono alla moviola una pila di scatole di pellicola. La ruggine prometteva molto bene, anche se le unghie ne fecero le spese per aprirle. Contenevano una raccolta di piccoli rulli. Sbirciando tra i fotogrammi, vedevo ragazzini in livree del Settecento rotolarsi nella neve e diverse macchine da presa che li filmavano. Una di queste era fissata al torace dell’operatore. Questo materiale era il più illuminante che avessi mai visto nel suo genere. Rivelava che il reparto mdp del Napoléon comprendeva macchine da presa progettate per compiere delle panoramiche a 360° in autonomia, oppure, montate su una slitta come una ghigliottina mobile, per riprendere cadendo
giù mentre erano in movimento. Gance mi aveva detto di aver chiesto che chiunque non avesse niente da fare sul set prendesse un apparecchio portatile (di norma una cinepresa Debrie Sept) e filmasse ciò che succedeva. Esisteva un documentario di un rullo sul suo capolavoro del 1922, La rosa sulle rotaie (La roue), composto e girato a mo’ di home movie dallo scrittore (e aiuto regista) Blaise Cendrars e intitolato Autour de “La Roue”. A Jean Arroy venne affidato l’incarico delle riprese per Autour de “Napoléon”, presentato successivamente allo Studio 28 di Parigi. Negli anni Venti gli spettatori americani venivano tenuti al corrente delle future uscite in sala tramite serie intitolate Screen Snapshots o Screen Almanac che presentavano sequenze brevi, da cinegiornale. Potevano così vedere gli attori più amati al lavoro e cominciarono a conoscere i registi. Screen Snapshots è nata grazie all’infelicità del produttore Jack Cohn alla Universal. Gli venne l’idea di far vedere i film in produzione, un’idea così semplice e redditizia che portò alla creazione della CBC, successivamente Columbia Pictures, gestita dal fratello minore di Jack, Harry. Si dice che alcuni episodi della serie, che Jack Cohn ha continuato fino agli anni Cinquanta, possano essere stati diretti da Frank Capra. Almeno una di queste serie è nata come branca della rivista «Screen Supplement to Photoplay Magazine» che, nonostante il nome vagamente medicale, dagli esempi che ho visto io può vantare episodi di altissimo livello. Uno di questi documentava lo smantellamento dei set di Intolerance, un altro Cecil B. DeMille che dirigeva Maschio e femmina (Male and Female, 1919). Con A Trip to Paramountown (1922), la Paramount pubblicizzò Manslaughter [Omicidio colposo] di DeMille con scene di un’orgia anticoromana. Nell’unico rullo che è arrivato fino a noi (il film constava di due rulli) si possono vedere tutti coloro che frequentavano gli studi Lasky, da Rodolfo Valentino a Joe Martin, un orangutan che recitava nei film (giuro). In Europa il pubblico amava i western tanto quanto gli americani, e alle origini del cinema apparvero film di indiani e cowboy da uno o due rulli girati in luoghi improbabili come il Bois de Boulogne. Uno di questi faceva vedere un giovane che si era offerto per interpretare un pellerossa ma poi rimaneva distaccato dalla produzione. Lo si vede tornare a Parigi con i mezzi di trasporto pubblico, ancora ornato di piume e coperto da un misero perizoma. Nel 1912 la Vitagraph Corporation of America realizzò un simpatico cortometraggio intitolato A Vitagraph Romance con Edward M. Kimball, Clara Kimball Young e James Young, che lo aveva anche diretto ed era il marito di Clara nella vita. La casa di produzione, di impronta già industriale,
avrebbe annientato diverse delle fantasie romantiche che nutriva il pubblico, ma i beniamini della casa si comportavano diligentemente da beniamini e la cura con cui veniva realizzata ciascuna scena era affascinante. I fondatori della Vitagraph, “Pop” Rock, J. Stuart Blackton e Albert E. Smith interpretavano se stessi. Nel 1915, l’anno di apertura della Universal City, un film di due rulli intitolato Behind the Screen venne girato da Al Christie, che vi faceva anche un’apparizione. Originariamente la parte documentaria fu integrata con elementi di finzione ma questi ultimi vennero eliminati (probabilmente da un collezionista) e ora sopravvive soltanto il girato della produzione. Costituisce quindi l’esempio di attività di uno studio cinematografico più vivido a una data così lontana nel tempo; vediamo gli attori Eddie Lyons e Lee Moran che arrivano sul posto di lavoro insieme a Victoria Forde (che avrebbe sposato Tom Mix) e Al Christie che accoglie la piccola compagnia. È sorprendente che, nel calore della California, tutti gli uomini indossino completi, con solo un paio di tecnici in maniche di camicia. (Appunto di storia della moda: i colletti di celluloide, allora di rigore indipendentemente dalla temperatura, nel cinema avevano cominciato a venire sostituiti dai colletti non rigidi che adesso usiamo tutti). Il direttore della fotografia era Anton Nagy, originario dell’Ungheria, con una Debrie francese, l’ultima uscita dall’Europa prima che scoppiasse la guerra. Il suo aiuto era Gilbert Warrenton, che sarebbe diventato uno dei direttori della fotografia più immaginativi del cinema muto, girando nel 1927 Il castello degli spettri (The Cat and the Canary) di Paul Leni e nel 1928 Primo amore (Lonesome) di Paul Fejos. Vediamo Al Christie che prende una sceneggiatura nel reparto sceneggiature, ordina la scenografia e sceglie i costumi e il mobilio – tutti compiti che oggi sono svolti da persone diverse. La mdp fa una panoramica attraverso “il palcoscenico più grande del mondo” – una moltitudine di teatri di posa, con le compagnie che lavoravano fianco a fianco. Questo è uno dei pochi film sul cinema che mostra un personaggio raramente evocato, il fotografo di scena. Era essenziale, ma decisamente mal sopportato: immaginate il regista al lavoro con un’attrice recalcitrante e proprio quando ha ottenuto da lei la giusta posa e sta per gridare “Motore!” appare questo tizio che urla “Ferma così!”. Si intitolava Dietro lo schermo (Behind the Screen, 1916) anche una comica di Chaplin, una delle pellicole girate per la Mutual dopo che aveva raggiunto l’indipendenza. Come soggetto aveva scelto la realizzazione di un film, imitando Mack Sennett con un epico scontro di torte in faccia. (C’è un attore che si lamenta dicendo «Non mi piace questa roba da intellettuali»). Ci sono scene in stile tipicamente Keystone, con Charlot che inciampa fra cavalletti e
macchine da presa che cadono a terra, e quando le maestranze vanno in sciopero fanno saltare in aria lo studio. Sennett, che aveva originariamente assunto Chaplin, amava ambientare le sue comiche in teatri di posa o in sale cinematografiche. Lui stesso anni dopo avrebbe prodotto un film toccante e divertente con la fidanzata Mabel Normand come protagonista: The Extra Girl (La comparsa, 1923), in cui lascerà libero un leone nello studio della Keystone. Va detto a suo onore che quella scena è interpretata da Sennett in persona. In pochi sanno che nel 1919 Chaplin fece un film sul proprio studio, intitolato How to make movies (alias How Moving Pictures are Made). Lo aveva ideato come uno stratagemma per affrancarsi dall’oneroso contratto che aveva con la First National. Ma la First National non ci stette. Non fu mai completato fino al momento in cui io e David Gill, durante la realizzazione di Unknown Chaplin (1983), ci imbattemmo nei giornalieri del film non ancora montati. Scoprimmo una scaletta per il montaggio e le didascalie nell’archivio Chaplin a Vevey che ci permise di metterlo insieme. Era troppo divertente per definirlo un documentario, ma non era nemmeno una comica, il che può essere il motivo per cui non lo ha mai completato. Vi sono scene avvincenti delle prove della compagnia Chaplin con Jack Wilson, il secondo operatore alla macchina, mentre il primo, Rollie Totheroh, riprende effettivamente la scena, oltre alle riprese di due anni prima di Eric Campbell, il Golia di Charlot, su un campo da golf – le sue ultime prima di rimanere vittima di un incidente stradale. E ancora, scene del laboratorio dello studio, e di Chaplin al lavoro in sala di montaggio. Il suo cameriere, Tom Harrington, che entra in una camera blindata e ne emerge tenendo gli stivali di Chaplin come se fossero i gioielli della corona.
Il primissimo film di Chaplin nelle vesti del vagabondo, Charlot si distingue (Kid Auto Races at Venice, 1914), era già una sorta di film sul cinema, rappresentando il personaggio del vagabondo che si intromette fra l’operatore alla macchina e il regista (impegnati nelle riprese di una gara di macchinine a pedali per bambini a Venice, in California). Il film si basa su una singola gag, Charlot che si piazza davanti alla macchina da presa e il regista che lo manda via. L’operatore è Frank Williams, che in seguito avrebbe inventato un tipo di mascherino scorrevole (travelling matte) noto come Williams Process, e il regista è Henry “Pathé” Lehrman, che aveva diretto il primo film di Chaplin, Making a Living (Come sbarcare il lunario, 1913). Gli spettatori adulti non reagiscono in modo particolare, mentre i ragazzini sono chiaramente affascinati. Raramente un momento così storico come la nascita di una leggenda è stato colto in pellicola. Chaplin ha interpretato un cameo nel film più autentico e interessante sull’epoca del muto che sia mai stato realizzato a Hollywood. Diretto da King Vidor, Maschere di celluloide (Show People, 1928) costituiva al tempo stesso un omaggio a Mack Sennett. Vidor chiamò a raccolta quindici attori della compagnia originaria. I poliziotti erano i veri Keystone Cops, annata 1928. «Ormai questo tipo di gag non si possono più insegnare alla gente», ricordava Vidor. «Loro sapevano già saltellare qua e là e sapevano fare tutte le cose che avevamo in mente».
Vidor aveva rilevato lo studio della Keystone, che Sennett aveva appena lasciato, e mostrava al pubblico come venivano fatte quelle comiche attraverso la parodia. La star, Marion Davies, interpretava una versione appena dissimulata di Gloria Swanson, la quale pur lavorando con Sennett aveva sempre desiderato diventare una grande attrice drammatica. Riuscì nel suo intento, come sappiamo, e sposò un marchese così come quasi avviene nel film. Maschere di celluloide venne realizzato alla M-G-M, con molte particine interpretate da maestranze vere. Perfino i musicisti sul set erano veri. Il regista, Robert Z. Leonard, interpretava se stesso, e nessun film si sarebbe potuto permettere la scena della tavolata di star del cinema se non si fosse trattato di una produzione William Randolph Hearst Cosmopolitan; vi presero parte (in ordine) Louella Parsons, Ruth Taylor, Claire Windsor, Aileen Pringle, Karl Dane, Geo K. Arthur, Leatrice Joy, Renée Adorée, Rod la Rocque, Mae Murray, John Gilbert, Norma Talmadge, Douglas Fairbanks Sr., Marion Davies e William S. Hart. Lavorarono tutti gratuitamente, Marion non ebbe che da chiedere (senza coinvolgere Gloria Swanson, naturalmente!). Nell’ultima scena ci si parano davanti le Maschere di celluloide al gran completo, compresi l’operatore alla macchina John Arnold, il secondo operatore Gordon Avil, King Vidor stesso e aiuti quali Willard Sheldon. Le riprese le fece Clyde de Vinna, su un set allestito tre anni prima per La grande parata (The Big Parade). ***
Una rappresentazione più realistica della vita condotta dalla gente che lavorava nel cinema era stata offerta in A Girl’s Folly (1917), scritto da Frances Marion, la sceneggiatrice più raffinata dell’era del muto, per Maurice Tourneur. Regista ragguardevole, Tourneur era arrivato dalla Francia con il figlio Jacques (il futuro regista del Bacio della pantera / Cat People) nel maggio 1914 per diventare socio della World Film Corp a Fort Lee, NJ. Scultore, assistente di Rodin, e pittore – aveva collaborato con Puvis de Chavannes – avrebbe introdotto nel cinema americano un nuovo standard di fotografia cinematografica (con l’operatore John van den Broek) e di scenografia (il suo scenografo era Ben Carré). Trionfò durante la Prima Guerra Mondiale dirigendo una serie di film molto ammirati, diversi dei quali salutati come capolavori. La maggior parte di essi è andata perduta, mentre si è salvato A Girl’s Folly (1917), che ci offre una rappresentazione sagace e divertente della “colonia” cinematografica. Tourneur interpreta un cameo, e un bravo attore di nome Robert Warwick interpreta un divo che osserva la ragazza (Doris Kenyon) fare un provino – così che vediamo lo Studio
Paragon in azione. La ragazza viene scartata. Il divo le propone ciò che andava sotto il nome di “sistemazione” (un appartamentino ecc. ecc.) ma la ragazza, che viene da un’educazione rigida, lo respinge. La scena del commiato è commovente, con la ragazza che si ferma davanti alla limousine tutta lucida dell’attore e fissa, pensosa, il proprio riflesso. Poi tira un grosso sospiro, si volta e gli dice che, dopotutto, ha deciso di accettare la proposta. La censura non avrebbe tollerato un finale simile, quindi Tourneur aggiunge una scena in cui arriva sul set la madre, determinata a trarre la figlia in salvo riportandola nella “noiosa” campagna. Gli scandali della Hollywood degli anni Venti avevano intimorito i dirigenti delle case di produzione, che rischiavano di perdere il pubblico delle famiglie. Realizzarono così una quantità di film a soggetto incredibilmente realistici (in termini di rappresentazione della vita nel cinema, mi affretto ad aggiungere, non di scandali!). Alcuni erano concepiti proprio per distogliere le giovani donne dall’idea di avventurarsi a Hollywood. Fra di essi probabilmente si distinse Hollywood (id., 1923), diretto da James Cruze, che aveva appena realizzato I pionieri (The Covered Wagon), ma non lo sapremo mai con certezza dato che, ahimé, la Paramount non ne ha conservato copia (né degli altri loro 1.014 film muti, di cui ne rimangono appena 37). A giudicare dal trailer di tre minuti custodito alla Library of Congress, Hollywood era zeppo di sequenze sperimentali. Di fatto impostava il modello dello Hollywood Movie, presentando il grande regista Cecil B. DeMille e praticamente ciascun nome legato ai Famous Players-Lasky. La storia era quella di una ragazza (Hope Drown) che va a Hollywood per sfondare al cinema accompagnata dal nonno (Luke Cosgrove), il quale non fa che ricevere proposte di lavoro. Rupert Hughes, lo zio di Howard, fu un autentico auteur prima ancora che il concetto venisse inventato. Romanziere di successo ma anche regista, diresse Souls for Sale (1923), una produzione Goldwyn in cui Eleanor Boardman interpretava una giovane donna che, quando il treno su cui sono a bordo si ferma nel deserto, lascia il losco fidanzato (Lew Cody) e trova riparo presso una compagnia cinematografica. Approda così a Hollywood, dove fa il classico pellegrinaggio di studio in studio, incontrando così sul set vari registi famosi, da Chaplin (Charlot e la maschera di ferro / The Idle Class) a Fred Niblo (The Famous Mrs. Fair) fino a von Stroheim (Rapacità / Greed). La donna ha il sospetto che il fidanzato si sposasse per poi ammazzare le proprie mogli, e quando arriva a Hollywood i suoi dubbi trovano presto conferma. La pellicola era andata persa per decenni, fino a quando non è stata rinvenuta presso la Cineteca nazionale della Repubblica Ceca.
La sensazione diffusa era che la gente di cinema fosse troppo sensibile per scherzare su se stessa. Eppure quando nel 1922 il romanzo di Harry Leon Wilson Merton of the Movies ironizzava in modo spietato sul mondo del cinema, l’opera venne accolta, secondo «Photoplay», «con sorprendente amabilità»: «Lillian Gish ha chiesto a un giornalista che la intervistava: “Non ha letto Merton of the Movies lei, eh?” “Come no”, è stata la risposta. E spalancando gli occhioni azzurri, la Gish ha fatto: “E va ancora in giro facendo interviste?”» Al romanzo si ispirò una commedia di George S. Kaufman e Marc Connelly che ebbe repliche per oltre un anno a Broadway e venne votata lo spettacolo teatrale di maggior successo del 1922. Glenn Hunter interpretava il giovane impiegato volenteroso di un emporio di campagna per il quale il cinema rappresenta la più grande bellezza dell’universo. Crede a qualsiasi cosa legga sulle riviste. Poi si imbarca per il suo pellegrinaggio a Hollywood e… il povero Merton è distrutto, ma la fidanzata lo aiuta a non impazzire. Alla fine riesce a diventare un grande attore, ma finisce col fare la spalla a un attore strabico (Ben Turpin). Buster Keaton tentò di acquistarne i diritti senza riuscirci, e così fece La palla n° 13 (Sherlock Jr., 1924), una commedia brillante su un proiezionista di provincia. In una avvincente sequenza si addormenta sul lavoro e sogna di entrare nello schermo e interagire con il racconto, venendo maltrattato dal montaggio. (Nonostante fosse troppo anziano per il ruolo principale, nei tardi anni Cinquanta Buster Keaton riprese lo spettacolo teatrale interpretando comunque il protagonista, girando anche un cortometraggio di accompagnamento). Keaton era stato battuto dalla Paramount. I protagonisti degli scandali – Roscoe Arbuckle, William Desmond Taylor, Olive Thomas, Mary Miles Minter – avevano lavorato tutti per la Paramount, quindi non desta grande sorpresa che fossero così ansiosi di proteggere la propria reputazione. Assegnarono l’incarico al regista preferito della casa, James Cruze, che diresse il film nel 1924 con Glenn Hunter e Viola Dana. Quest’ultima mi ha raccontato che il Museum of Modern Art glielo ha fatto vedere, ma sembrerebbe che la pellicola faccia ormai parte della Legione dei Perduti. «Photoplay» lo classificò uno dei Six Best nello stesso mese del 1924 con Il cavallo d’acciaio (The Iron Horse) di John Ford e Monsieur Beaucaire di
Rodolfo Valentino. «Evitando la satira più mordace, la versione di James Cruze si concentra sul pathos del giovanotto sognante di provincia che nutriva grandi ambizioni per il cinema… In ciò, il Merton cinematografico è assolutamente soddisfacente». I critici annotarono che Will Hays, il grande capo della censura, era stato preso in giro sul palcoscenico ma la Paramount non aveva osato fare lo stesso sul grande schermo. ***
La fusione Metro-Goldwyn-Mayer ebbe luogo nel 1924. L’anno successivo, il triumvirato alla testa della società composto da Louis B. Mayer, Irving Thalberg e Harry Rapf decise di offrire alla conferenza annuale degli azionisti una breve veduta dello studio in azione. L’operatore William Daniels fu incaricato di girare il primo film su quella che stava rapidamente diventando la casa di produzione più ammirata d’America. Nel 1925 la M-G-M produceva due dei film più importanti dell’intera epoca del muto, La grande parata di King Vidor e Ben Hur di Fred Niblo. Ma da questo piccolo film non si sarebbe mai immaginato: si vedono l’ampia area dello studio (originariamente occupata da Thomas Ince) e i bei pratini ripiantati di fresco (“Non calpestare”, recitava un’insegna all’apice della febbre per Greta Garbo, “I want to be a lawn” [1]. Si vedono i vari uffici e le frotte di impiegati. L’unico accenno di maggiore ambizione è una scena con delle comparse in uniforme della Prima Guerra Mondiale che salgono su un pullman per andare sul set della Grande parata. Peccato che Daniels non abbia scelto di farci vedere quelle riprese! Avrebbe avuto bisogno di una guida. Qualsiasi fra i registi del brillante gruppo della Metro avrebbe potuto metterci un pizzico di mordente in più. Loro stavano in fila vicino a una lavagna che mostrava chi stava lavorando su quale set. Vediamo leggende del cinema come Victor Seastrom, Frank Borzage e Eric von Stroheim, e viene spontaneo pensare che alla M-G-M avessero una grande saggezza. Invece Josef von Sternberg e William Wellman, anch’essi visibili in fila, sarebbero stati licenziati l’anno successivo. ***
Tutti i paesi realizzavano film sull’industria cinematografica, a volte documentari, più spesso commedie romantiche. La First National ne fece uscire una nel 1926, Ella Cinders con Colleen Moore, ispirata a un fumetto di William Conselman e Charles Plumb. Conselman venne coinvolto nella lavorazione insieme a uno sceneggiatore specializzato in gag e commedie di nome Mervin LeRoy (il futuro regista).
LeRoy non si peritò di riciclare per Colleen Moore la gag del leone di Sennett e Mabel Normand. L’unica vera star a partecipare con un cameo era Harry Langdon, che lavorava già per la First National e quindi non venne pagato. Anche Alfred E. Green, il regista del film, vi interpretò un ruolo importante – quello del regista. Hans Koenekamp realizzò un effetto speciale grazie al quale gli occhi di Colleen Moore si giravano in direzioni opposte. Era così convincente che negli anni Sessanta, quando il film venne ritrasmesso in televisione, Colleen Moore si sentì ancora chiedere da degli optometristi come ci era riuscita. L’epoca del muto si concluse con due magnifici lungometraggi su questo soggetto, Maschere di celluloide di King Vidor e Crepuscolo di gloria (The Last Command) di von Sternberg, entrambi del 1928. Quest’ultimo era un’evocazione della rivoluzione russa più che un film sul cinema, ma la didascalia di apertura recita «Hollywood’s breadline» (tempi duri a Hollywood) e poi si vedono delle comparse che fanno di tutto per essere notate sotto le finestre del reparto costumi. Fra di loro c’è un anziano russo (Emil Jannings) che una volta era un generale. Si scopre che il suo regista (William Powell) era stato un leader della rivoluzione. Il film era zeppo di commenti amari su Hollywood, con la figura dell’assistente, che di dettagli militari sa molto più del Generale perché aveva già lavorato in numerosi film russi, chiaramente ispirato a Sternberg. Un giovane giornalista francese, Jean Dréville, ispirato da Abel Gance, si presentò a un altro maestro del cinema, Marcel L’Herbier, proponendogli di fare un documentario sulle riprese del suo film epico Il denaro (L’argent, 1928). Autour de “L’argent” è rimasto per anni l’esempio più esaustivo di cinema sul cinema. L’Herbier era uno dei rappresentanti più rispettati dell’avanguardia e aveva adottato molte delle tecniche innovative del Napoléon, lavorando anche con il direttore della fotografia Jules Kruger. Il film di Dréville non si limitava a documentare la produzione, ma era un vero e proprio documentario già impostato in questi termini. Riprendeva le stesse tecniche di L’argent, con movimenti di macchina stravaganti e piani sequenza. Il montaggio alterna scene delle macchine da presa in funzione con i corrispondenti paragrafi della sceneggiatura. L’Herbier dirige i suoi attori come fossero musicisti di un’orchestra. Il film nell’insieme adesso ci sembra troppo lungo, perché ciò che all’epoca poteva lasciare gli spettatori a bocca aperta ha perso un po’ della sua potenza a distanza di novant’anni. Il successo del “backstage” di Dréville fece sì che Gance si sentì obbligato a fare la stessa operazione per il suo primo film sonoro, La fine del mondo (La
fin du monde, 1931). Questo documentario venne girato da un esponente dell’avanguardia russa, Eugen Deslaw, che si concentrò sull’attrezzatura futuristica, facendo anche ricorso a una vecchia tecnica grazie alla quale lunghi brani di sequenze del lungometraggio si trasformavano da muti a sonori. Il cinema sonoro arrivò tardi in Europa, ed ebbe un impatto diverso sulla produzione di film muti. I paesi meno avanzati come Russia, Cina e Giappone continuarono a fare cinema muto fin negli anni Trenta avanzati. In America i sostenitori del sonoro erano convinti che la trasformazione sarebbe stata permanente. L’arma che usarono nella loro battaglia fu il ridicolo: prendevano vecchi film drammatici e li proiettavano a una velocità accelerata, aggiungendo commenti spiritosi e un accompagnamento musicale honky-tonky, assicurandosi così una reazione ilare da parte del pubblico. Gli spettatori più anziani, che avevano amato il cinema muto, erano in imbarazzo: «Era questo che ci era piaciuto così tanto?». I più giovani vennero scoraggiati per sempre. Ancora adesso si possono trovare persone della generazione della Seconda Guerra Mondiale che rifiutano categoricamente di vedere film muti. Cortometraggi a basso costo di questo tipo abbondavano, continuando a far parte della programmazione in sala fino a che nel 1963 non ne nacque una serie televisiva intitolata Fractured Flickers [Film a pezzi]. «Irriverente omaggio al cinema muto», come la descriveva «Classic Images», «in cui a brani di vecchi cinegiornali venivano sovrapposte battute un po’ pazzoidi, creando con ciascun episodio uno spassoso miscuglio di comiche e caos», per non parlare della presenza di star del calibro di Douglas Fairbanks Sr., Harry Houdini e Lon Chaney. Senza volere sono stato coinvolto in un’operazione del genere quando mi chiesero di raccogliere la maggior quantità di film muti di origine britannica che potessi trovare per un programma televisivo anonimo. Quando ho scoperto di che cosa si trattava mi arrabbiai moltissimo, e sono lieto di poter dire che il programma non è mai stato concretizzato. Purtroppo però nel frattempo le opere del cinema muto avevano assunto la reputazione di meri “flickers”, buoni soltanto per quattro risate anche quando si trattava di film drammatici. Quando verso la metà degli anni Sessanta sono andato a Hollywood per incontrare i veterani del mestiere ho scoperto che molti di loro erano stati contagiati da questi film deprecabili. Nutrivano un complesso d’inferiorità sul proprio lavoro e lo evitavano, avendo la sensazione che sarebbe loro sembrato assurdo. Per fortuna in qualche caso è stato possibile proiettare pellicole in ottimo stato e dimostrar loro, quindi, che cosa erano davvero i film che
avevano contribuito a fare. Risultato? Un rapido aumento dell’autostima. Mi resi conto che con tutto il denaro speso per mettere in ridicolo il cinema muto si sarebbe potuto produrre invece una serie per salvarne la reputazione. Decisi di farla io, ma ci vollero più di dieci anni. Nel frattempo veniva presentata Silents Please (1960-61) di Paul Killiam che, con la consulenza del collezionista William K. Everson, consisteva di edizioni sapientemente accorciate di film muti. Il programma era realizzato con cura e affetto; diede un grosso impulso a un mutamento nell’atteggiamento del pubblico, gettando le fondamenta per un revival del genere. Io pensavo che una serie che mostrasse come venivano realizzati i film muti, con interviste a coloro che vi avevano preso parte, sarebbe stata irresistibile. Fortunatamente anche Jeremy Isaacs, produttore del classico The World at War alla Thames TV, era giunto a questa conclusione. Cominciò così la saga della serie Hollywood. Isaacs era quel tipo di produttore che si incontra una volta sola in tutta una generazione, e io nel poter lavorare con lui ho avuto un’incredibile fortuna. Hollywood in realtà incontrò il primo ostacolo proprio a Hollywood. La M-GM aveva compilato un’antologia dei propri musical, C’era una volta Hollywood (That’s Entertainment), che aveva avuto un successo enorme. Nell’euforia, avevano deciso di tagliare tutti i rapporti con la televisione e mettere a frutto gli archivi per conto proprio. Per noi questo era un duro colpo, ma Jeremy teneva alto il morale: «Se non ci danno i diritti per i loro film, dovremo arrangiarci con i film di pubblico dominio». Ma quando That’s Entertainment II fece un flop la M-G-M tornò sui propri passi. Con il co-regista, David Gill, ci sistemammo con una moviola nel retro dello stabilimento, ordinando dagli archivi tutte quei film che finora avevamo potuto solo sognare. Qualche sporadico errore era benvenuto: una volta ordinammo La Bohème di King Vidor (1926) e ci venne consegnata la pellicola – ritenuta smarrita – di La vie de Bohème di Capellani (1915). Spettacolare! La realizzazione della serie Hollywood è stata estremamente complicata. Dovevamo scovare i film menzionati nelle interviste e illustrare le tecniche con immagini autentiche. Questa è la ragione per la quale i film che rappresentavano il cinema nel suo farsi erano una manna. Coprimmo così la nascita di Hollywood e la realizzazione dei classici di D.W. Griffith, la carriera della Garbo e gli effetti devastanti del sonoro sul cinema muto. Avevamo deciso di dedicare al western due episodi: il primo era sui pellerossa, ma dovemmo rinunciare per mancanza di materiale (e di interviste: trovammo solo Iron Eyes Cody, di cui si venne a sapere solo alla morte che
veniva dalla Sicilia!); il secondo episodio, però, risultò uno dei più forti della serie. Uno dei motivi è che i film western non si limitavano a riflettere la storia del West, bensì la perpetuavano. I cowboy, rimasti disoccupati con la chiusura dei ranch, trovarono lavoro nel cinema. E il rapinatore di banche Al Jennings, della famigerata Jennings Gang, uscito di prigione dopo la condanna all’ergastolo (beh, dopo cinque anni venne graziato!) ricreò i suoi exploit sperando di a) guadagnare soldi e b) poiché aveva trovato la fede, persuadere i giovani a non seguire il suo esempio. Ci imbattemmo in un film superbo datato 1918, Lady of the Dugout [La donna del rifugio], diretto da W.S. Van Dyke con Al Jennings e il fratello Frank. Girato in una vecchia cittadina del West e con i veri Jennings che reinterpretavano i loro crimini, è uno dei western più autentici che abbia mai visto. Abbiamo intervistato Tim McCoy, divo del western ed esperto di indiani, Yakima Canutt, campione di rodeo e divo del western, e la vedova di Harry Carey, l’attore che diede un grandissimo impulso alla carriera di John Ford. Abbiamo mostrato più immagini possibile della realizzazione de I pionieri (1923), riuscendo perfino a rintracciare l’operatore alla macchina, Karl Brown, che ci ha descritto come era stata filmata la sequenza dei carri che attraversano il fiume Platte, e come al primo tentativo fecero accidentalmente annegare i cavalli, riuscendoci invece al secondo grazie alla tecnica usata dai veri pionieri. La realizzazione del programma è durata quattro anni, vi abbiamo inserito 600 film. Abbiamo selezionato esclusivamente i positivi migliori e abbiamo avuto il privilegio di lavorare con il magistrale Carl Davis, che ha musicato tutti gli episodi. Abbiamo intervistato star del livello di Gloria Swanson e Lillian Gish, operatori come Lee Garmes e George Folsey, registi quali Allan Dwan e Henry King, stuntmen come Harvey Parry e Paul Malvern, perfino attrezzisti di nome Marion Morrison (il futuro John Wayne). Il costo è stato di un milione di sterline per tredici episodi di un’ora. Al giorno d’oggi, in un’epoca di canali multipli e “scelte” illimitate, imbattersi in cinque minuti di cinema muto alla televisione sarebbe una vera sorpresa. In Gran Bretagna Hollywood è stato mandato in onda in prima serata, alle 21.00 su ITV. E lì ha anche avuto un grande successo. Negli Stati Uniti il programma è stato mal gestito e, invece di farlo trasmettere dalla PBS in tutto il paese, l’agente ha tentato di guadagnarci di più attraverso la syndication (il sistema di diffusione televisiva su base locale
che coesiste negli USA con le reti nazionali, N.d.T.). Così era più difficile da trovare, e quando ci si riusciva si vedevano episodi a volte manomessi. Nell’area di Los Angeles Buster Keaton è stato tagliato dall’episodio sulle comiche a causa di una partita di baseball che si sovrapponeva alla programmazione. «Abbiamo trattato il vostro programma come uno spezzatino di fegato», dichiarò scusandosi il capo della RKO-TV. Ma Hollywood prese gradualmente piede e guadagnò grande popolarità. Oggi mi chiedono continuamente perché non si trova in DVD. La risposta è troppo deprimente. Così come stanno le cose, le uniche persone che traggono beneficio da ciò che io considero censura commerciale sono i pirati, quelli sì che hanno un business fiorente. Jeremy Isaacs nutriva una tale fiducia nella serie che quando è arrivato ai vertici di Channel Four ha rimesso in programmazione tutte e tredici le puntate, facendole seguire dal film principale di cui parlava l’episodio. La sua fiducia è stata nuovamente premiata da cifre Auditel incredibilmente elevate. Come tutti ormai sappiamo, i film muti non sono mai stati veramente tali. Negli anni Venti i cinema di prima visione avevano sempre un’orchestra in sala. Film e cinegiornali erano accompagnati dal pianoforte, e quando i musicisti prendevano posto c’era come un brivido di anticipazione, le luci si abbassavano e, accomodati in poltrona in mezzo a decorazioni reminiscenti forse di un palazzo d’Arabia, si veniva trasportati in un altro mondo. A Carl Davis e David Gill venne l’idea di riportare i film dell’epoca del muto in sala alla stessa maniera. Veniva considerata una forma di intrattenimento nuova, visto che per conoscerla già bisognava avere oltre 70 anni. Il primo dei “Thames Silents”, la copia restaurata da me del Napoléon di Abel Gance presentata allo Empire Leicester Square nel novembre 1980, fece il tutto esaurito in 40 minuti. Da lì nacque una successione di restauri di film muti presentati al London Film Festival con accompagnamento orchestrale dal vivo che è durata quasi vent’anni. Il primo festival del cinema muto dei tempi moderni ha avuto luogo a Pordenone nel 1982, diretto da Piera Patat e Livio Jacob. Era dedicato al grande comico francese Max Linder (di cui anche Charlie Chaplin si è detto allievo). C’erano nove ospiti, tutti italiani. Era stato pensato come un evento unico, ma uno degli ospiti, Davide Turconi, disse: «Bene. L’anno prossimo facciamo Mack Sennett». Da allora Le Giornate del Cinema Muto non si sono più fermate, guadagnando sempre più popolarità. Nel 2015 sono stati ospitati 800 delegati (300 provenienti dall’Italia e 500 dall’estero). ***
La Thames TV propose a me e David Gill di fare un’altra serie, Cinema Europe – the Other Hollywood, dedicata al cinema muto europeo, di sole sei puntate però (significava escludere la Russia, che da sola merita una serie intera). In ogni caso era una meravigliosa occasione, non solo per intervistare i pochi ancora vivi, ma anche per dedicare una lunga sezione al Napoléon, compresa l’intervista che avevo girato con Abel Gance. Forse l’intervista più rara è stata quella con il direttore tecnico del Napoléon, un esule russo, Simon Feldman. Quando lo ho filmato in Francia meridionale aveva 103 anni, e ci descrisse come era riuscito a fare delle riprese dalla groppa di un cavallo (ovvero utilizzando una piccola locomotiva a vapore alimentata però ad aria compressa). Io ancora non riesco a credergli. Però lo si può vedere nella sequenza in cui Napoleone viene inseguito in Corsica, contenuta nel quarto episodio, “The Music of Light”. (Chiedo scusa. Mi sono appena reso conto che nemmeno Cinema Europe è disponibile in DVD). Nel mentre scrivo, aprile 2016, al Cinema Museum di Londra c’è appena stata la proiezione di un film muto rarissimo. Trent’anni fa avrebbero avuto un pubblico di cinque o sei anziani con la nostalgia degli anni Venti. La sala invece adesso era piena. Lo spettacolo comprendeva la proiezione di tre film sul cinema: Behind the Screen (1915), A Trip to Paramountown (1922) e The MGM Studio Tour (1925). A giudicare dall’accoglienza entusiastica, esiste un pubblico per un documentario serio sul cinema muto. Molti degli spettatori non erano neanche nati all’epoca della programmazione della nostra serie Hollywood. Come sarebbe semplice riportarla in vita se soltanto gli Studios condividessero il nostro amore per il cinema! Traduzione dall’inglese di Carla Scura
Note del capitolo 1. L’autore fa qui riferimento a una battuta circolante all’epoca che ironizzava sulla pronuncia inglese della Garbo. La frase corretta era «I want to be alone» (Voglio stare da sola), enunciata dall’attrice in più di un film, deformata per omofonia nella trascrizione in “Voglio essere un prato”, N.d.T.
CRITICA
Critica col cinema Jonathan Rosenbaum Da «Sight and Sound» (inverno 1990-91): Non è un segreto che la critica cinematografica “seria” su carta stampata stia diventando una merce sempre più rara, mentre le “notizie di spettacolo”, le recensioni brevi e le altre forme di promozione sui media continuano a espandersi regolarmente. (Non includo nella lista la critica cinematografica accademica, un settore in crescita per quanto relativamente chiuso, che ha sviluppato una retorica e una tradizione autonome, come testimonia il nuovo, affascinante testo di David Bordwell, Making Meaning). Eppure la critica cinematografica più autorevole, ormai poco discussa e considerata come un’entità a sé stante, ha continuato a evolversi, arrivando a volte a soppiantare quel genere di produzione che un tempo appariva solo sulla carta stampata. Non sto parlando degli innumerevoli “approfondimenti” con tanto di giornalista parlante che trattano degli ultimi film in uscita – nient’altro che spot promozionali finanziati dagli studios o dalle produzioni – tra cui figura anche qualche esempio relativamente pregevole, come AK di Chris Marker (1985), sulla realizzazione di Ran di Akira Kurosawa. Il problema di questi cosiddetti documentari è che confondono ulteriormente la linea di demarcazione tra pubblicità e critica, col risultato che lo spettatore ha sempre più difficoltà a capire se sta ricevendo un’informazione o è semplicemente sollecitato ad acquistare un prodotto. Penso piuttosto a certi film sui film e sui registi, che analizzano o documentano seriamente l’argomento della loro indagine. Molti di questi film appaiono nei festival, passano rapidamente in tv e vengono utilizzati come supporto per i corsi accademici: ma pochissimi arrivano in sala, e quindi in genere vengono recensiti solo sulle riviste per addetti ai lavori. Non posso pretendere che la mia indagine sia esaustiva, quindi ciò che segue tenterà semplicemente di offrire una suggestione, e più che altro in merito a ciò che ho visto di recente. Qualche parola sulle convenzioni di questo sottogenere. I film sull’opera di un regista, di solito, hanno un itinerario standard: alternano narrazione e immagini, avvalendosi di interviste (sia al regista che ai suoi amici, colleghi, biografi, critici), filmati di repertorio e, se l’artista è ancora vivo, materiale sulla sua produzione recente. Tra i migliori esempi del passato citiamo Directed by John Ford di Peter Bogdanovich (1971), Whoever Tells the Truth Shall Die di Philo Bregstein (su Pasolini, 1980), Unknown Chaplin di Kevin Brownlow e David Gill (1983) e ‘I’m Almost Not Crazy’: John Cassavetes,
The Man and His Work (1984) di Michael Ventura. The Man You Loved to Hate (1979) di Patrick Montgomery, scritto da Richard Koszarski e concepito come un’integrazione della sua biografia di Stroheim, illustra chiaramente i vantaggi e i limiti di questo approccio. Le immagini di repertorio tratte da molti, rarissimi film in cui Stroheim ha recitato hanno un valore inestimabile, e le testimonianze delle persone che lo conoscevano bene ci restituiscono con efficacia la sua personalità; ma la quantità effettiva di informazioni è minuscola, se confrontata a quella del libro Koszarski. Le vicende produttive di ogni film sfrecciano così rapidamente sullo schermo che finiamo col saperne di più sul profilo pubblico di Stroheim che non sul suo stile registico. La voce fuori campo è molto sagace ma per capire come si sia evoluta l’arte di Stroheim dobbiamo cercare altrove. Discorso più o meno analogo per Preston Sturges: The Rise and Fall of an American Dreamer (1990), con la differenza che qui manca la sponda di una biografia soddisfacente – a meno che non si faccia affidamento sul recente Preston Sturges, curato e adattato egregiamente da Sandy Sturges a partire dalla biografia incompiuta, dalle lettere e dai diari di suo marito. Abbiamo poi il saggio di Manny Farber e W. S. Poster, “Preston Sturges: Success in the Movies” e il contributo su Sturges di Penelope Houston, contenuto in Cinema: A Critical Dictionary di Richard Roud: entrambi i testi presentano delle intuizioni critiche che il documentario non si sforza neppure di ricercare. Diretto da Kenneth Bowser e scritto da Todd McCarthy, già critico e inviato di Variety, il film illustra efficacemente i fatti più importanti e le contraddizioni della vita e della brevissima carriera di Sturges; ed è apprezzabile per la varietà di materiali di repertorio a cui attinge, dalle interviste radiofoniche al cameo di Sturges in Star Spangled Rhythm (Signorine non guardate i marinai, 1942), dalle fotografie alle testimonianze orali del maestro all’opera. Nel complesso il suo approccio è più biografico che critico, anche se riesce in modo accurato e insieme vivace a fornire moltissime informazioni senza risultare faticoso; la scelta dei materiali di repertorio e l’uso funzionale e sintetico della voce narrante si fondono con la massima efficacia. Due aspetti della carriera di Sturges, tuttavia, vengono affrontati frettolosamente: la straordinaria compagnia di attori caratteristi su cui il regista faceva affidamento e il suo ultimo film. Andrew Sarris descrive perspicacemente la funzione di questi attori in una tipica scena alla Sturges, e la voce narrante continua citando una mezza dozzina di nomi, mentre dei primi piani tratti da una foto di gruppo si susseguono rapidamente, in modo quasi subliminale: William Demarest, Jimmy Conlin, Robert Warwick, Jack
Norton, Robert Greig, Frank Moran. Ma data la ricchezza bruegeliana di quest’aspetto dell’arte di Sturges, la lista avrebbe dovuto essere molto più lunga – almeno una dozzina di nomi importanti restano fuori, da Edgar Kennedy e Raymond Walburn a Lionel Stander e Akim Tamiroff – e una sequenza illustrativa della funzione corale di questi caratteri non sarebbe apparsa fuori luogo. Realizzato in Francia nel 1956 in due versioni separate, una francese e l’altra inglese, Les Carnets du Major Thompson e The French They Are a Funny Race/The Diary of Major Thompson (Il carnet del maggiore Thompson), il rarissimo canto del cigno di Sturges è l’unico film del regista di cui non viene mostrato un estratto. A parte il breve e giudizioso commento di Pauline Kael, contenuto in 5001 Nights at the Movies, tutte le recensioni uscite sul suo conto sembrano stroncarlo, e il documentario non fa eccezione, liquidandolo in modo così frettoloso. Tuttavia, avendo visto la versione inglese, mi permetto di dissentire. Pur non essendo certo un capolavoro, il film possiede una dolcezza, un’eleganza, un’arguzia e un andamento stranamente pacato che lo rendono elegiaco, piuttosto che inerte. (Se davvero c’è un film orrendo tra quelli di Sturges – e temo che ci sia – è The Beautiful Blonde from Bashful Bend, it. L’indiavolata pistolera). A parte questi cavilli, il film è un buon esempio di quello che si può ottenere con la formula convenzionale del documentario con voce narrante. Altrettanto dicasi per Motion and Emotion: The Films of Wim Wenders (1989) di Paul Joyce, anche se il principale pregio di quest’opera è il suo taglio critico, virtù assai rara nei documentari americani di questo genere, che di solito cercano di astenersi dal formulare giudizi – al contrario di Joyce, che manifesta tutto il suo disprezzo per l’ultimo film del regista. Motion and Emotion, d’altro canto, mette efficacemente a fuoco questa duplicità dell’opera di Wenders – a volte opinabile, altre encomiabile. Senza essere né malizioso né polemico, ne offre anche la miglior critica ideologica che io abbia mai incontrato: essa si deve in buona parte a Kraft Wetzel, il quale osserva, nel corso di un’affascinante discussione in merito all’uso delle donne e dei bambini nei film di Wenders, che quest’ultimo sarà ricordato come il democristiano del Nuovo Cinema Tedesco. Indagine dettagliatissima su uno dei più importanti cineasti contemporanei, questo documentario per me fornisce una valutazione più efficace di qualsiasi libro o articolo che abbia mai letto in merito, fornendo perfino le basi per una critica ante litteram, per così dire, del Notebook on Cities and Clothes (Appunti di viaggio su moda e città) di Wenders. Signed: Lino Brocka di Christian Blackwood si concentra più sulla vita del
suo protagonista che sui suoi film: anche se, considerata la carriera di Brocka, quest’approccio sembra sensato. (Funzionava meno applicato a Raul Ruiz, nella serie Exiles di Jill Evans, per Channel 4; in quel caso, l’enfasi sul cameratismo del regista non lasciava grande spazio all’analisi degli aspetti sovversivi della sua opera). Il film si apre con delle immagini di Manila, mentre sentiamo Brocka parlare al telefono in inglese con qualcuno che lo chiama dalla Francia. Brocka dice a Blackwood che i francesi gli hanno chiesto di spiegargli perché fa cinema; lui allora legge la sua risposta, una lunga dichiarazione che si conclude così: «Il cinema mi serve a ricreare quella relazione spontanea, pura, non insensata, che avevo con il mondo da bambino. È per questo che in seguito, quando ho capito quello che stava succedendo ai miei compatrioti, ho deciso che volevo anche unirmi a quanti dicevano la verità – volevo piangere e creare disturbo… firmato, Lino Brocka». Stacco su un’inquadratura di Brocka sul set. Il film che sta girando, scopriamo, è stato realizzato per fare un favore a un produttore che gli ha pagato la cauzione quando è stato arrestato per aver agito come negoziatore nel 1985 durante uno sciopero dei trasportatori. Brocka poi parla della sua infanzia difficile, del suo complesso background (è stato anche monaco in una colonia di lebbrosi alle Hawaii), dell’evoluzione del suo rapporto con l’omosessualità, dell’industria cinematografica locale, del suo odio per Ferdinando e Imelda Marcos e del suo sempre più convinto attivismo. A colpire lo spettatore, in questa lunga conversazione illustrata con Blackwood, sono soprattutto il coraggio e l’intelligenza di Brocka, insieme al suo candore. Mentre vediamo dei brani dei suoi film – proiettati direttamente su una moviola – Brocka traduce i dialoghi, spiega le trame e integra le osservazioni di Blackwood con delle osservazioni autocritiche. Il documentario teorizza, e dimostra, l’esistenza di una continuità tra la passione per il cinema di Brocka e la sua passione come essere umano e, anche se le parole del regista non possono certo sostituirsi alla visione dei suoi film, costituiscono un’avvincente introduzione. L’attenzione dei francesi per lo stile e la forma diventa un’occasione per infondere nuova vita al genere del documentario classico, specie nella serie tv di André S. Labarthe e Janine Bazin, Cinéastes de notre temps, apparsa per la prima volta nel 1964, che tende a imitare lo stile di ripresa e di montaggio dei registi intervistati. Così Josef von Sternberg, illuminato in perfetto stile sternberghiano, ci parla di The Saga of Anatahan (L’isola della donna contesa); gli aneddoti di Samuel Fuller e i sui aforismi da bar sono scanditi da un montaggio frammentario; mentre John Cassavetes, intervistato (da Labarthe e Hubert Knapp) ai tempi di Faces (Volti), viene ripreso con la
macchina a mano a casa sua e nel suo ambiente più intimo. Peccato non vi sia alcuno sforzo di contestualizzare criticamente le dichiarazioni dei registi intervistati. Come la maggior parte degli studiosi di Sternberg, Labarthe sembra prendere per buona l’insistenza del regista quando afferma che in Anatahan, a parte il mare, tutto è artificiale e creato apposta per la macchina da presa. E allora come si spiega la sequenza chiave di repertorio, in cui i soldati giapponesi tornano dalla guerra? Senza il potere dialettico di quest’intrusione documentaristica – soprattutto in relazione all’astrattissima sequenza del ritorno a casa – la grandezza di Anatahan apparirebbe molto compromessa. Più di recente, in Cinéma, de notre temps, che è un’evoluzione di Cinéastes…, David Lynch viene ripreso da Guy Girard a casa sua, mentre detta una sceneggiatura a una segretaria. La macchina da presa galleggia come in sogno verso la stanza accanto, dove coglie un obliquo frammento di Eraserhead (Eraserhead - La mente che cancella) dallo schermo di un televisore, prima di scivolare di nuovo verso il regista. Anche grazie all’intelligenza delle domande poste, questo ritratto va ben oltre i consueti reportage promozionali sul conto di Lynch, anche se non può definirsi una vera e propria ricognizione critica. Di recente Labarthe ha impiegato una tattica analoga in un film a metà tra finzione e documentario, girato in inglese, sugli ultimi giorni di Orson Welles, intitolato The Big O o, in francese, L’Homme qui a vu I’homme qui a vu I’ours. Sotto molti aspetti, quest’opera imperfetta rappresenta una sorta di compendio di tutti i pregi e i difetti del “giornalismo mimetico” che impegna Labarthe da vari decenni. Definito come un “saggio di finzione”, The Big O resuscita il personaggio di Laszlo Kovacs – un alter ego di Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) in À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro), ripreso da Belmondo stesso, in forma un po’ diversa, in À Double Tour (A doppia mandata) di Chabrol – e qui interpretato dal giovane e misconosciuto attore nouvelle vague (nonché regista post-nouvelle vague) Laszlo Szabo, che fa da controfigura virtuale a Labarthe. Mentre cerca di promuovere un suo film a Los Angeles, Kovacs sviluppa una forma di ossessione per gli ultimi giorni di Welles. Con l’aiuto di alcuni amici organizza un’improbabile serie di interviste a colleghi e conoscenti del grande regista, realizzandole per lo più in prima persona e in inglese, col suo accento assurdo (anche se John Houseman, ripreso poco prima della sua morte, parla in francese). Alla fine Kovacs si trasferisce a New York e a Parigi in cerca di ulteriori rivelazioni e speculazioni metafisiche.
Pur migliorando in corso d’opera, il film incontra il suo limite in una sorta di perversa schizofrenia stilistica e citazionista: la pletora di angolazioni eccentriche, che domina nella prima metà del lavoro, restituisce un’idea solo superficiale dello stile mutevole di Welles (anche se più avanti il film acquista maggior sottigliezza, quando imita l’illuminazione della sequenza di Orly di F for Fake – F come falso); e il fatto che Welles venga trattato come una figura paterna avvolta nel mito, oggetto di una ricerca edipica, costringe il racconto a oscillare pericolosamente tra l’indagine sincera e il rifiuto ostinato di distinguere tra leggenda e verità. La convinzione di Houseman secondo cui Welles non avrebbe scritto una sola parola di Citizen Kane (Quarto potere) è stata definitivamente smentita: ma nessuno potrebbe mai saperlo a giudicare da questo film, in cui lo sceneggiatore ripete impunemente la sua balla – confutata dalla sua stessa corrispondenza con Welles, ai tempi in cui Kane era in produzione – senza che nessuno possa obiettare. D’altra parte, l’affermazione di Henry Jaglom, che sostiene di aver registrato apertamente molte delle sue conversazioni con Welles su richiesta di quest’ultimo, viene doviziosamente confutata dallo storico collaboratore del regista stesso, Alessandro Tasca di Cuto, che risulta essere l’ultima persona ad aver visto Welles da vivo. Secondo Tasca di Cuto le registrazioni, scoperte solo in seguito da Welles, furono effettuate a sua insaputa e senza la sua autorizzazione. Labarthe ha comunque l’eleganza di distinguere tra opinioni fondate e millanterie; e va anche detto che molti dei partecipanti furono
intervistati senza sapere che sarebbero apparsi in un lavoro a metà tra il documentario e la finzione, quindi un certo margine di ambiguità entra in gioco da entrambe le parti. L’effetto che ne deriva, alla fine, risulta in parte manchevole sia dal punto di vista storico che critico, anche se l’opera, intesa come una tormentata riflessione sul fascino e sulle insidie della cinefilia francese, è spesso pungente. Alcuni dei documentari più interessanti adottano molte delle caratteristiche del documentario tradizionale al solo scopo di sovvertirle, e in modo più proficuo del film di Labarthe. Filming Othello (1978) di Orson Welles, un saggio esemplare della furfanteria del grande regista, contiene degli estratti dell’Othello del 1952. Tali estratti, però, sono stati tutti rimontati da Welles, tranne il primo, e vengono mostrati senza sonoro, con il commento del regista. Anche se Welles non allude mai a questo escamotage – tranne forse in fugace riferimento alle citazioni “più o meno corrette” dei commenti critici di Jack Jorgens e André Bazin – l’effetto, provocatorio e disturbante è quello di trasformare continuamente l’oggetto dell’indagine, che in teoria dovrebbe rimanere lo stesso. Mentre sentiamo parlare di un film realizzato nel 1952, quello che vediamo, in realtà, non sono che le confuse schegge di un Othello sognato, che stranamente somiglia più al prologo quasi onirico di Citizen Kane che al film stesso. Tre studi accademici sul cinema degli esordi meritano attenzione. Anche se alcune delle affermazioni contenute in Correction, Please, or How We Got Into Pictures (1979) e What Do Those Old Films Mean? (1985) di Noël Burch sono discutibili dal punto di vista storico, i momenti di fiction introdotti nel primo dei due film per illustrare alcune teorie sull’evoluzione della forma cinematografica tra il 1900 e il 1906 sono ricchi di immaginazione e inventiva, ed entrambi i lavori presentano una gran quantità di documenti di repertorio rarissimi, in condizioni quasi perfette. Eadweard Muybridge, Zoopraxographer (1974) di Thom Andersen, invece, sembra inattaccabile sia dal punto di vista storico che cinematografico. Inizia con una citazione di Mao e si conclude con un’allusione a Zeno e a Da Vinci, e stupisce sia per la quantità di informazioni che riesce a fornire in un’ora sola, che per la sintesi con cui illustra le implicazioni filosofiche, sociologiche, scientifiche, estetiche, ottiche, tecniche e teoretiche degli studi sul cinema di Muybridge, senza dilungarsi troppo su nessuno di essi. Utilizzando l’effetto split-screen per affiancare simultaneamente due o più angolazioni e/o velocità di quegli studi, e arrivando perfino a simulare uno degli studi sul colore di Muybridge, il film sovrappone le sue griglie analitiche a quelle del fotografo americano, pervenendo a una complessa
riflessione storica.
Uno studio teorico più recente è la serie video di Godard Histoire(s) du cinéma (1988) – lavoro estremamente ermetico (seppur affascinante) che utilizza dozzine di filmati, immagini fisse, titoli in sovrimpressione e frammenti di colonne sonore, spesso simultaneamente o in rapida alternanza, accompagnati dal frammentario commento dell’autore, per sbrogliare l’articolata matassa delle relazioni che intercorrono tra cinema e storia. Godard escogita questo delirante esercizio di collage associativo proprio nel momento in cui la cinefilia che ha fatto la fortuna della sua generazione è sul punto di estinguersi, e dunque la maggior parte delle sue associazioni è destinata a risultare quasi incomprensibile, perfino agli addetti ai lavori.
La scritta “le cinema substitue” accompagna alcuni estratti alternati del Faust di Murnau (Faust e Mefistofele al bivio) e di The Band Wagon (Spettacolo di varietà) di Minnelli (Cyd Charisse e Fred Astaire che danzano in un bar), insieme a qualche frammento dei dialoghi di L’année dernière à Marienbad (il narratore che seduce l’eroina). Forse ad alcuni spettatori può apparire evidente che la sequenza di ballo fa parte di un musical basato sul Faust, ma è alquanto improbabile che molti tra loro riescano a riconoscere le immagini di Murnau o il dialogo di Marienbad, per non parlare delle relative implicazioni faustiane. E anche se fossero in grado di farlo, come dovrebbero (e noi con loro) interpretare gli estratti sconnessi, subliminali dei film di Renoir e Mizoguchi che appaiono subito dopo? Spesso alcune sequenze di montaggio sono argute, almeno finché non sopraggiungono altre associazioni a interromperle o a dissiparle: Howard Hawks viene identificato dal titolo di Only Angels Have Wings (Avventurieri dell’aria), seguito da alcune immagini di un aeroplano, di Charles Foster Kane, del logo della RKO, e poi, in una sorta di delirio associativo, dall’arrivo a Parigi dell’aviatore all’inizio de La Règle du jeu. La scena della vecchia messa al rogo con l’accusa di stregoneria in Vredens Dag (Dies Irae) di Dreyer è accompagnata dalla voce di Rita Hayworth che canta “Put the Blame on Mame” in Gilda. Ma quando, un istante dopo, vediamo il vecchio Borgen chiamare suo figlio Johannes in Ordet e il collegamento con Dreyer sembra liquidare la polemica femminista, si ha l’impressione di naufragare in una
reverie assolutamente privata. «Poniamo, ad esempio, che la storia del cinema sia la storia di tutti i film che non sono mai stati realizzati» suggerisce Godard, supportando subito la sua ipotesi con una serie di estratti di Welles – Don Quixote, Othello, Kane, Journey into Fear, It’s All True and F for Fake – di cui solo due possono definirsi incompiuti, e men che mai irrealizzati. Vista la sua perpetua deriva dentro e fuori dal significato, questa serie in continua evoluzione può essere considerata come il Finnegans Wake di Godard. Ma se mezzo secolo di studi ha ormai decodificato, o almeno illuminato, le concrezioni di senso di Joyce, resta difficile, ahimé, immaginare che analoghi sforzi vengano compiuti per Godard. C’è qualcosa di donchisciottesco in questo estremo, disperato tentativo di processare la storia del cinema in virtù delle sue stravaganti e criptiche esternazioni – una sorta di sintesi lampo (o un disparato aide mémoire) di qualcosa che abbiamo già dimenticato, o al massimo, come lo stesso Godard, ricordiamo solo a metà. Nella misura in cui tutti i film sui film di cui abbiamo parlato sono dei tentativi di recuperare o resuscitare una continuità nella storia del cinema che il mercato sta facendo a pezzi, il disperato assemblaggio da gazza ladra di Godard – dedicato a Mary Meerson della Cinémathèque Française – ha almeno il pregio di suggerire la portata di ciò che sta andando perso e sprecato per sempre. Critica col cinema: seguito (primavera 2016) Invitato da Adriano Aprà ad aggiornare quest’articolo dopo quindici anni, trovo di dovermi muovere subito in direzioni opposte – vale a dire sia indietro, per considerare alcuni dei primi esempi di “extra” di DVD nonché una mia successiva recensione di alcuni film sulle “storie” nazionali del cinema del BFI, e in avanti, per tratteggiare le dimensioni di un campo cresciuto così tanto negli ultimi anni che nessun individuo da solo può pretendere di fornirne un’indagine esaustiva. In verità, il massimo che posso fare in questo senso è citare alcuni lavori esemplari, singoli individui e approcci, ben sapendo che molto altro può e deve essere aggiunto a questo elenco. ***
I. L’approccio “a mosaico” [1] «Avendo realizzato più di 30 commenti audio per delle uscite in DVD», scriveva cinque anni fa il critico cinematografico australiano Adrian Martin nella sua rubrica per la rivista olandese «Filmkrant», «sento di essermi guadagnato il diritto di criticare questo genere di format. I commentari con la voce over di registi, critici e storici sono decisamente una benedizione
controversa. Talvolta mi chiedo se vi sia qualcuno, oltre ai più zelanti e/o masochisti ricercatori, che riesca ad ascoltarli fino alla fine. Non c’è dubbio che queste voci ci offrono a volte delle intuizioni illuminanti, che non potremmo ottenere in nessun modo sulla carta stampata. Ma davvero non possiamo fare di meglio, nel tentativo di coniugare la critica cinematografica con l’oggetto-film?» Martin non è affatto il solo ad assumere questa posizione. Molti dei miei amici che collezionano DVD, forse la maggior parte di loro, confessano di avere la tendenza a saltare completamente i commenti audio, ed è difficile non condividere il loro pregiudizio. Nella maggior parte di queste lunghe tiritere, le osservazioni coincidono di rado con quello che si vede (o si sente) sullo schermo, e si ha spesso la sensazione che il commentatore, che sia un critico o qualcuno coinvolto nelle riprese, se la stia cavando nel modo più facile – andando a braccio anziché seguire un testo scritto con attenzione. Da parte mia, con l’eccezione di un’unica registrazione realizzata per A Torinói ló (Il cavallo di Torino) di Béla Tarr, fino ad oggi ho accettato di fornire commenti audio solo se si trattava di un dialogo con qualcun altro – James Naremore (su Mr. Arkadin - Rapporto confidenziale and Touch of Evil L’infernale Quinlan di Orson Welles), Mehrnaz Saeed-Vafa (su Close-up e Bad ma ra khahad bord - Il vento ci porterà via di Abbas Kiarostami), o David Kalat (sulla versione più lunga, scoperta di recente, di Metropolis di Fritz Lang). L’idea di realizzare un commento con un’unica voce mi è sempre sembrata invadente, almeno se si condivide la mia premessa che il lavoro di un critico cinematografico è essenzialmente quello di facilitare (piuttosto che monopolizzare) la discussione che ha luogo intorno a un film. Forse un problema ancora maggiore è costituito dalla linearità compulsiva e dalla continuità artificiosa della forma stessa – la necessità di avere qualcosa di coeso da impartire per tutta la durata di un film. Ciò suggerisce, come avviene spesso nella cultura cinematografica contemporanea, che siamo ostacolati dal fatto di essere ancora legati ad abitudini discorsive ormai superate, che non possiedono più la validità di un tempo. Rispetto alla proiezione in sala, la fruizione in DVD tende ad essere un’esperienza più frammentaria, che richiederebbe una forma di commento altrettanto frammentaria, sia orale che scritta – e non per essere pigri in un altro modo, ma per organizzare il materiale in modo diverso. Anche se si potrebbe ribattere che la crisi dell’alfabetizzazione e la volatilità dell’attenzione hanno reso le analisi e i ragionamenti estesi meno appetibili, sarebbe anche sensato ammettere che ci sono alcuni vantaggi e perfino un certo margine di profitto nella ricerca di un approccio a mosaico.
Queste riflessioni mi sono state suggerite in parte dall’uscita in DVD di cinque classici russi – due di Lev Kulešov, Il progetto dell’ingegner Pright (1918) e Il grande consolatore (1933); due di Sergej Ejzenštejn, Sciopero (1925) e Ottobre (1927); e La felicità di Aleksandr Medvedkin (1934) – per un’etichetta chiamata Academia distribuita da Ruscico (abbreviazione di Russian Cinema Council). Ogni uscita è composta da due dischi PAL al prezzo di $40, e finora sono riuscito a vederne tre: Ottobre, Il progetto dell’ingegner Pright e Il grande consolatore. [Post Scriptum del 2016: altri titoli di questa serie, tra cui il sublime Vicino al mare più azzurro di Boris Barnet (1935) sono ora disponibili all’indirizzo http://www.ruscico.com/catalog/dvdsearch/). Nessuno di questi DVD, mi affretto ad aggiungere, si avvale di un commento audio. Ma tutti e tre, con una tecnica innovativa denominata “Hyperkino”, forniscono dei commenti in sovrimpressione con varie illustrazioni (fermi immagine, fotografie, estratti di montaggio e/o sequenze dei film), e tutti questi commenti vertono su vari argomenti – o «questioni sollevate», per dirla con l’ultimo Raymond Durgnat. Ciò significa, naturalmente, che lo spettatore può decidere in modo interattivo a quali argomenti accedere e in che ordine. A ciascuno dei film di Kulešov vengono dedicati 30 argomenti distinti, mentre a Ottobre niente meno che 44. Si potrebbe obiettare che una ragione per cui Kulešov ed Ejzenštejn sono stati i primi registi russi a ricevere questo genere di trattamento, è che la loro importanza come teorici del cinema rischia perfino di surclassare la loro opera – una distinzione che a mio giudizio è molto più sostenibile nel caso di Kulešov. (Anzi, si potrebbe perfino sostenere che Kulešov sia rimasto per tutta la sua carriera, nel bene e nel male, un ispirato dilettante). Che si accetti o meno questa premessa, il bisogno di un commento storico per comprendere appieno i loro film e le loro teorie è difficile da negare, e il fatto che la teoria e la pratica debbano essere trattate separatamente, oltre che in relazione l’una all’altra, suggerisce già in sé che sarebbe auspicabile più di un percorso per approcciare al meglio le loro biografie e carriere. Anche se non può essere esaustivo – ci sono delle peculiarità de Il grande consolatore che non vengono spiegate dalle teorizzazioni di Kulešov, come la sua decisione di mantenere il miglior amico dell’eroina perennemente fuori campo mentre ride in modo sarcastico – un approccio sfaccettato contribuisce moltissimo a fare chiarezza. Ogni cofanetto della Hyperkino contiene due dischi, proprio per dare allo spettatore l’opportunità di scegliere, seguendo un approccio interattivo. Ogni disco contiene lo stesso film, ma su quello commentato ci sono dei numeri
lampeggianti sull’angolo superiore destro dell’inquadratura, che corrispondono al commento accessibile con il telecomando. Sul secondo disco, in cui l’immagine è sgombra dai numeri lampeggianti, sono disponibili altri sottotitoli di vario genere – non solo in inglese e in russo, che sono già presenti sul primo disco, ma anche in francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Il fatto che Academia si stia impegnando a realizzare questi DVD in varie lingue è encomiabile: ma trovo buffo (e, ahimé, anche emblematico della mentalità un po’ chiusa dei russi) che lo spettatore possa apprezzarlo solo dopo aver avuto accesso al menù in cirillico. Le confezioni di tutte e tre le uscite in mio possesso, infatti, hanno le scritte esclusivamente in russo. (Questo vale anche per un’altra pregevole uscita della Ruscico, il folle e ispirato Motivi cechoviani di Kira Muratova, accompagnato da un suggestivo documentario sulla Muratova al prezzo di soli $26). E si potrebbe anche rimproverare sia il sito della Ruscico che le “chiosate” edizioni Academia di non venire abbastanza incontro allo spettatore; entrambi richiedono una certa dose di pazienza per capire come accedervi al meglio. Ciononostante, credo che l’iniziativa abbia qualcosa di potenzialmente fruttuoso e pionieristico, non solo per gli studi di cinema ma anche per il grande pubblico. Questa metodologia non lineare non è priva di precedenti. A mio giudizio, il primo, autorevole lavoro di questo genere è stato realizzato quasi un decennio fa, nel 2001, da Joan Neuberger e Yuri Tsivian, con i loro distinti saggi “multimediali” su Ivan il Terribile di Ejzenštejn contenuti nei DVD della Criterion dedicati alle due parti del film: “The History of Ivan” di Neuberger sul primo disco, nella Parte I, e “Eisenstein’s Visual Vocabulary” di Tsivian sul secondo, nella Parte II. È significativo che entrambi gli studiosi abbiano pubblicato dei brevi testi su Ivan il Terribile qualche tempo dopo – Tsivian per la BFI Film Classics nel 2002, Neuberger per le edizioni della KinoFile Film Companion nel 2003 – ma per quanto entrambi gli scritti siano eccellenti, e contengano molto più materiale degli extra dei DVD, trovo ben più impressionanti dal punto di vista critico i due saggi audiovisivi, se non altro perché attraverso il suono e l’immagine riescono a dimostrare le loro tesi in modo più immediato e succinto. Questi due lavori insieme hanno trasformato radicalmente la mia comprensione e ammirazione per il capolavoro di Ejzenštejn, assai più di qualsiasi altro testo che abbia letto prima o dopo. Tra le altre cose, essi dimostrano una volta per tutte che le due parti di Ivan il Terribile, lungi dal rappresentare una ritirata da parte di Ejzenštejn (come hanno sostenuto alcuni dei suoi primi critici), sono tra i film più coraggiosi mai realizzati nella storia del cinema, proprio dal punto di vista
politico. Quindi è importante sottolineare che anche i 44 commenti stampati contenuti nell’Ottobre della Hyperkino sono di Tsivian, e costituiscono un modello di critica non lineare ben più efficace di quelli presenti nelle due recenti uscite su Kulešov. Va anche detto che i commenti su Kulešov sono più di natura storica, mentre quelli di Tsivian su Ottobre tendono piuttosto a mescolare le informazioni storiche con delle intuizioni critiche. Giusto per citare alcuni dei primi argomenti trattati, ricordiamo “Smantellare il monumento”, “Destra e sinistra si scambiano di posto”, “Si alzano le falci”, “Denarrativizzazione dell’evento”, “Edouard Tissé come attore”, e “Rime visive e cinestetiche”. ***
Purtroppo, solo tre dei cinque rulli de Il progetto dell’ingegner Pright (chiamato semplicemente Ingegner Pright sul sito della Ruscico) sono sopravissuti, e anche tutte le didascalie originali sono andate perdute, quindi quel che ci resta, anche come semplice “ricostruzione” della durata di mezz’ora, è necessariamente un reperto molto più specialistico di Ottobre o de Il grande consolatore. Ma la sua importanza storica è enorme, e non solo perché è stato il primo film russo ad impiegare un montaggio concettuale. È stato realizzato quando Kulešov aveva solo 18 anni (e aveva per protagonista suo fratello Boris, di otto anni più gtande, che interpretava il personaggio del titolo) – proprio mentre il regista partecipava alla Rivoluzione russa, dopo aver trascorso buona parte dell’anno precedente a dirigere cinegiornali e a lavorare per il grande regista pre-rivoluzionario Jevgenij Bauer (principalmente come scenografo, ma anche come attore). In questo caso gli autori del commentario, Nikolai Izvolov e Natascha Drubek, hanno incluso anche i frammenti superstiti di Ingegner Pright – che durano solo 15 minuti, senza musica né didascalie – sul secondo disco, insieme a un eccellente documentario del 1969, The Kuleshov Effect di S. Raitburt, realizzato circa un anno prima della morte di Kulešov, che contiene una sua lunga intervista sia sulla attività di regista che sulla sua ben più lunga carriera di insegnante (in cui sono presenti alcune affascinanti osservazioni sul Galileo di Bertolt Brecht). Viene intervistato anche il padre del Formalismo russo, Viktor Šklovskij, che lavorò con Kulešov come sceneggiatore su un adattamento di Jack London, Secondo la legge, nel 1926. Tra gli studenti di Kulešov c’erano Barnet, Ejzenštejn e Pudovkin; spesso dovevano lavorare perfino senza la pellicola, il che può aiutare a capire perché il loro insegnante divenne il più istruttivo tra tutti i teorici di cinema russi, nonché il primo a elaborare una teoria del montaggio. Lo stesso Kulešov parlava di D.W. Griffith come dell’inventore della pratica del
montaggio, e uno degli aspetti più affascinanti dei suoi film è l’uso che egli fa degli Stati Uniti, paese che non visitò mai di persona e che scelse spessissimo come ambientazione – non solo ne Il progetto dell’ingegner Pright e Il grande consolatore, ma anche in Secondo la legge e Orizzonte (1932), il suo primo film sonoro; mentre la sua commedia più famosa, Le avventure di Mr. West nel paese dei Bolscevichi (1924), aveva nel titolo un eroe americano. Chiaramente, l’America era importante non solo per il dinamismo e la freschezza del suo cinema muto; ambientare i suoi film in quel contesto consentiva a Kulešov anche di parlare della Russia senza doversi preoccupare della censura. E quando fu il momento di realizzare Il grande consolatore – che lo storico del cinema Jay Leyda definì una volta «l’unico film sovietico degno di nota ambientato negli Stati Uniti» – Kulešov riuscì a creare una complessa riflessione sull’impatto sociale dell’arte usando il filtro della biografia e della narrazione di William Sydney Porter, meglio conosciuto con lo pseudonimo di O. Henry. L’utile commento è a cura di Jekaterina Chochlova – la nipote della grande attrice manierista bielorussa Aleksandra Chochlova, che Kulešov conobbe nel 1920 e poi sposò, e che divenne ben presto la sua principale collaboratrice, oltre che attrice principale, e musa. Per dare un’idea del commentario, mi si consenta di citarne brevemente la decima e l’undicesima parte: “Il debutto cinematografico di Weyland Rodd”, più che parlare dell’espatriato americano di colore che interpreta uno dei compagni di carcere di O. Henry, canta una canzone e parla un russo fluente (e avrebbe poi recitato in molti altri film sovietici, tra cui un adattamento di Tom Sawyer) sembra concentrarsi sul modo in cui venivano trattate le questioni razziali nel cinema sovietico degli anni ’30, argomento in sé molto affascinante. Ma la Chochlova, nella decima parte del suo commento, ha molto da dire anche sul “protagonista,” Konstantin Chochlov – un attore molto conosciuto che interpretava il ruolo di O. Henry, e che fu ampiamente criticato per la teatralità della sua interpretazione, che secondo Kulešov invece era voluta e fondamentale per la sua idea del film. E ne “Il confine tra realtà e invenzione” (N. 11) si parla di come Kulešov girò la storia di O. Henry, “The Metamorphosis of James Valentine”, secondo lo stile del cinema muto, con tanto di didascalie, musica e una breve sequenza animata, in contrasto con lo stile “parlato” del resto del film, che tratta sia della detenzione di O. Henry in carcere, dove scrisse la storia dello scassinatore Valentine, che del conseguente impatto di questa storia su una commessa (interpretata dalla Chochlova). Proprio la forma ibrida di questi commenti – sospesa a metà tra scrittura e video, come varie produzioni realizzate al computer – gli consente in qualche
modo di precorrere i tempi. Esempi in cui testi critici vengono presentati in modo frammentario, a mo’ di mosaico grafico, possono essere rintracciati anche altrove – per esempio nell’antologia di Chris Fujiwara, lunga ben 800 pagine, Defining Moments in Movies (Cassell, 2007), a cui io e Dennis Lim, il curatore di Moving Image Source, abbiamo contribuito entrambi – e appartengono forse a una categoria molto simile. Si potrebbe anche citare alcuni esperimenti nel campo dell’illustrazione e della grafica adottati dalla rivista di cinema online Rouge. Ciò che suggeriscono queste varie forme di critica non è soltanto un modo meno lineare di accostarsi all’esperienza filmica ma anche una metodologia più interattiva. Il fatto che i film vengono fruiti sempre più spesso fuori dalla sala non significa necessariamente che il modo in cui tutti ne facciamo esperienza, condividendola con altri, debba essere solipsistico. Forse è più pertinente notare che le anche le forme stesse delle nostre interazioni sociali legate al cinema stanno cambiando. ***
II. Saggi di critica audiovisiva A. Un esempio esemplarmente negativo: Room 237 [2] Come tanto (troppo) cinema contemporaneo, Room 237 di Rodney Ascher (2014) è insieme divertente e riprovevole. Alternando i commenti stravaganti di cinque analisti di The Shining di Kubrick (Bill Blakemore, Geoffrey Cocks, Julie Kearns, John Fell Ryan, Jay Weidner), il film rifiuta di distinguere tra interpretazioni semi-plausibili e psicotiche, concepibili o ridicole, sottintendendo che in fondo si tratta solo di “critica cinematografica”: e dato che oggi tutti sono critici cinematografici, meritano tutti di essere trattati con rispetto e/o presi per i fondelli allo stesso modo (sempre che si riesca a distinguere tra le due cose) – ovverosia in modo acritico e derisorio, con il perenne salvacondotto dell’ironia. Così ci sentiamo dire, in rapida successione, che The Shining parla essenzialmente del genocidio degli Indiani d’America, dell’Olocausto, che è il modo in cui Kubrick fa ammenda per aver realizzato – stando a quel che si dice – il falso repertorio relativo all’allunaggio dell’Apollo, che è un saggio sull’architettura “impossibile” dell’Overlook Hotel, e/o una contemplazione di Kubrick della propria noia e/o del proprio genio. Immagini tratte dal film e/o alterazioni digitali delle stesse vengono impiegate per dimostrare o ridicolizzare queste varie premesse, o forse per entrambi gli scopi, e superato un certo punto non importa neanche più quali tra queste possibilità siano più concrete. Al contrario dei suoi cinque esperti, Ascher non corre il rischio di esporsi esprimendo giudizi sulle tesi e le posizioni espresse, e finisce inevitabilmente col minare le fondamenta stesse della critica, facendola apparire come
un’attività disdicevole e assurda. Non riusciamo neanche a capire se presenti i suoi commentatori in maniera onesta; sembra così impegnato ad attribuire a tutti la medesima credibilità, che alla fine pare di trovarsi davanti a un gruppo di svitati.
Durante i 104 minuti del film di Ascher, ho continuato a pensare che il sistema scolastico americano e la sua diffidenza nei confronti dell’arte hanno molto di cui rispondere. Se la costruzione a mo’ di puzzle di L’anno scorso a Marienbad di Resnais e Copia conforme di Kiarostami è forse l’aspetto meno interessante di questi due film, il contrario vale per un prodotto cinico e tutt’altro che artistico come Memento di Christopher Nolan, in cui la frammentarietà è il motivo principale per cui, in certi circoli anglo-americani, esso è diventato un prezioso oggetto di culto e un feticcio. Un modo per liquidare la minaccia e la sfida dell’arte è quello di ridurla a una specie di prontuario fondato sulle soluzioni immediate, in stile “Eureka!” Se le opere d’arte vengono percepite come delle casseforti da scardinare o delle serrature che si aprono in virtù di qualche passepartout, le loro facoltà espressive vengono virtualmente ridotte a banali espressioni di un significato segreto o manifesto, come se l’arte dovesse “dire” anziché fare qualcosa. Posso solo immaginare la giustificazione di Ascher per questo approccio riduttivo – che non si preoccupa neanche di includere nel dibattito Diane Johnson, l’affascinante e talentuosa sceneggiatrice di Kubrick. Ma l’ipotesi più probabile è che egli stia fingendo di rendere omaggio a una presunta idea di giornalismo “imparziale”, lasciando che “i fatti” (che si pretendono fondati,
piuttosto che creati o selezionati ad hoc) “parlino da soli”. E tuttavia si potrebbe obiettare che una delle ragioni per cui non disponiamo più di un giornalismo degno di questo nome è proprio l’idea catastrofica che l’imparzialità sia possibile o auspicabile. Il che è un altro modo per dire che abbiamo bisogno della critica per poter avere il giornalismo, e la riduttiva equiparazione di tutte le opinioni critiche è il modo più sicuro per annullare ogni forma di critica e quindi anche di giornalismo. B. Qualche modello ed esempio di vario genere Raccolta internazionale [Film sui film] [3] Per celebrare il “centenario del cinema,” il British Film Institute ha commissionato una serie di documentari sulle cinematografie nazionali. Alcuni di questi sono ancora in via di realizzazione, ma i primi 13 sono visibili presso il Film Center di Chicago nell’ambito di una rassegna iniziata all’inizio di questo mese con il film in tre parti A Personal Journey With Martin Scorsese Through American Movies (eccellente) e continuata con il documentario di Sam Neill sul cinema neozelandese (arguto), di Nelson Pereira dos Santos sul cinema latino-americano (ambizioso ma fallimentare), di Edgar Reitz sul cinema tedesco (imbarazzante) e di Pawel Lozinski su quello polacco, che include anche l’ultimo Krzysztof Kieslowski (non l’ho visto). I lavori di Neill e Pereira dos Santos, che verranno replicati il 30 novembre, sono in 35 millimetri, mentre tutti gli altri sono proiettati in formato video; la maggior parte di essi dura meno di un’ora. (Aristotle’s Plot di Jean-Pierre Bekolo, un saggio di finzione dedicato al cinema africano, che era già stato proiettato in vari festival all’inizio di quest’anno, non rispettava la maggior parte dei parametri previsti dalla rassegna ed è stato escluso dalla selezione, anche se non capisco perché Latin America: Cinema of Tears di Pereira dos Santos, che era altrettanto eccentrico, è stato invece ammesso). Altri otto documentari de “Il Secolo del Cinema” devono ancora arrivare al Film Center, a cominciare con la coppia Stephen Frears (Cinema inglese) e Jean-Luc Godard (francese) questo venerdì, seguiti da Stig Björkman (scandinavo) e Donald Taylor Black (irlandese) il 29 novembre, Nagisa Oshima (giapponese) e Jang Sun-woo (coreano) il 6 dicembre, e Nikita Michalkov e altri (russo) e Stanley Kwan (cinema in lingua cinese) il 13 dicembre. A giudicare dai nove lavori che ho visto, la selezione è alquanto disomogenea. Tanto per cominciare, si fonda sulla discutibile premessa che il miglior modo per raccontare la storia del cinema sia quello di partire dalle cinematografie nazionali, un approccio che favorisce il provincialismo, penalizza molti autori
importanti che sono transnazionali o internazionali (tra cui Akerman, Antonioni, Chaplin, Davies, Dreyer, Godard, Hitchcock, Lang, Murnau, Ruiz, Snow e Stroheim), e spesso privilegia la sociologia rispetto all’estetica, e il convenzionale rispetto all’eccezionale. Ovviamente la maggior parte dei docenti di cinema apprezza quest’approccio, perché – per parafrasare quello che scriveva il critico Bill Krohn in un altro contesto – consente a un’istituzione (l’accademia) di rendere omaggio ad un’altra istituzione (la burocrazia nazionale) sul corpo degli artisti. Quindi non stupisce che il principale architetto di questo progetto sia stato proprio un accademico nonché burocrate del BFI, Colin McCabe. È significativo che il compianto Henri Langlois – il fondatore della Cinémathèque Française nato in Turchia, forse il principale guru della Nouvelle vague francese – abbia passato buona parte della sua vita a scagliarsi contro la burocrazia di stato, fomentando con la sua passione una cinefilia che ha travalicato con leggerezza i confini nazionali negli anni 60 e 70, proprio come era accaduto al cinema d’autore negli anni 20 e 30. Ma in epoche più reazionarie, come quella odierna, i cineasti stranieri devono essere esibiti nel loro habitat come gli animali nello zoo, per poter raggiungere un pubblico internazionale. Questo rientra nel pregiudizio sotteso all’attuale agenda del BFI, che spesso tende anche ad attribuire le responsabilità della storia del cinema ai registi piuttosto che agli studiosi, che hanno avuto ben più occasioni di istruirsi in merito all’argomento. Un pregiudizio analogo può essere ravvisato nella riorganizzazione della principale rivista del BFI, «Sight and Sound», avvenuta negli ultimi cinque anni, che si è allontanata dalla critica e dall’erudizione prediligendo l’intrattenimento commerciale che già pervade «Première» e «Movieline» – per non parlare del massiccio ridimensionamento dell’istituto, che tende a favorire i burocrati rispetto ai cinefili. (Avendo lavorato sia per il BFI che per «Sight and Sound» – anche se me ne sono andato per mia scelta vent’anni fa – immagino che mi si possa accusare di fare un po’ come la volpe con l’uva; ma il mio unico cruccio è che studiosi seri e riconosciuti siano stati rimpiazzati da imprenditori viscidi e misconosciuti – secondo una tendenza in atto presso gli istituti di cinematografia di molti altri paesi, tra cui il mio). Tra le vittime di questo approccio figura anche la produzione del BFI impegnata a indagare sull’orticello nazionale – che inizia con una povocatoria allusione a un protagonista della Nouvelle vague. Mentre scorrono i titoli di testa, la voce over di Stephen Frears proclama: «Il grande regista francese François Truffaut disse una volta, con una frase rimasta celebre, che c’era una certa incompatibilità tra il termine “cinema” e l’aggettivo “inglese”. [Pausa.]
Beh [pausa] Truffaut non ci capiva un cazzo». Va dato atto a Frears che egli ostenta con orgoglio tutto il suo background d’alto bordo in questa sorta di autobiografia e che il totale disprezzo suggerito dalle sue pause è eloquente quanto le sue parole. Gran parte del documentario, però, non è altro che una tediosa conferma del pregiudizio di Truffaut; Frears è così annoiato dal suo stesso argomento che, appena 50 minuti più tardi, conclude: «L’unica cosa vera che ho imparato è che la gente, quando va al cinema, vuol vedere i film americani». E non riesce neanche a immaginare perché non dovrebbe volerlo – né gli sorge il dubbio che questa tendenza sia dovuta più allo strapotere della promozione yankee, fatta a suon di dollari, che all’estetica hollywoodiana. Data la rozzezza di questa indagine sociologica sul cinema inglese, in cui sembra che la tendenza generale sia quella di giocare al ribasso, non stupisce certo che Frears liquidi come irrilevante l’intera stagione del cinema muto. E che tratti con condiscendenza Michael Powell e Humphrey Jennings (cui concede solo un misero estratto ciascuno); o non nomini Joseph Losey, Cy Endfield o Richard Lester (probabilmente perché li considera come tre intrusi americani); che scelga per Ken Russell e Mike Leigh le peggiori clip immaginabili (e non abbia nulla da dire sul lavoro fatto da entrambi in televisione); che circoscriva John Boorman, Bill Douglas, Terry Gilliam, Peter Greenaway, Isaac Julien e Sally Potter a una fuggevole locandina ciascuno; e infine ometta virtualmente l’intero movimento documentaristico inglese (anche se accenna con disprezzo a Night Mail), insieme al ciclo degli horror della Hammer – prostrandosi invece in modo abietto alla legge degli Oscar ed esaltando ogni singola briciola concessa dall’Academy al cinema britannico (in particolare a Momenti di gloria, Gandhi e Quattro matrimoni e un funerale). È frustrante immaginare cosa avrebbe potuto fare un vero critico del cinema come Raymond Durgnat con il materiale scelto da Frears – per non parlare di quello da lui omesso. Ciò che ci viene propinato, invece, è una sequela di stupidaggini su quello che secondo lui dovrebbe interessare il pubblico – in perfetto stile Janet Maslin. Sarebbe ingiusto attribuire a Frears tutte le inadeguatezze di questa precipitosa visita al museo – anche se il sottotitolo recita “Una personale storia del cinema inglese” e la narrazione si articola tra ricordi personali di film e bacchettate prese al collegio, chiacchierate con colleghi hollywoodiani (il critico e sceneggiatore Gavin Lambert, il defunto Alexander Mackendrick e i registi Michael Apted e Alan Parker), e brevi sequenze del regista sul set di Mary Reilly. Per quanto il pressbook cerchi di indurre il lettore a ignorarlo, la paternità dell’opera, oltre che di Frears, è di un co-regista, Mike Dibb, e un
co-sceneggiatore, il critico Charles Barr, che vengono accreditati entrambi prima di lui; quindi è possibile che Frears – che è un bravo direttore d’attori, ma non ha mai dimostrato molta abilità o interesse per l’estetica cinematografica – fosse troppo impegnato con Mary Reilly per fare molto più che spettegolare con quattro colleghi e aggiungere una stringatissima voice over. Ciononostante, mi sento comunque autorizzato a concludere che Frears non ci capisce un cazzo. Anche Jean-Luc Godard inizia con tono bellicoso in 2 fois 50 ans du cinéma français, e anche lui figura come secondo nome dopo la regista e scrittrice Anne-Marie Miéville, sua frequente collaboratrice. Ma qui finisce la somiglianza col Tipico Inglese. Lungi dall’essere un’altra indagine invasata, questa è piuttosto una sfaccettata polemica che mette in dubbio la maggior parte delle premesse della serie sul “Secolo del Cinema” – tranne quella, si badi, dell’orientamento nazionalistico (malgrado l’ultima immagine del video sia una fotografia di Henri Langlois). In modo alquanto paradossale, l’opera soddisfa anche le richieste del BFI (il contratto di Miéville e Godard figura bene in vista sotto al logo dell’istituto) offrendo uno sguardo approfondito sul cinema francese – per quanto suddiviso in frammenti spettrali, lirici e per lo più oscuri; filmati spesso privi di attribuzione, fermi immagine, fotografie e nomi sparsi; e brandelli di musica e dialoghi che alludono a un cinema e a una storia essenzialmente dimenticati.
L’esaustività di questo ritratto può non apparire evidente a un primo sguardo;
solo la terza volta che ho visto il documentario ho cominciato a capirne l’organizzazione logica e a sentirmi pienamente coinvolto dall’andamento della musica e dalla poesia delle immagini. Sulla rivista francese «Trafic», Jean-Claude Biette ha opportunamente impiegato le categorie critiche di Manny Farber definendo il recente film di Godard, JLG/JLG, “arte dell’ elefante bianco” (ovverosia magniloquente e presuntuosa) e 2 fois 50 ans “arte delle termiti” (umile e ben circoscritta entro i propri confini). Vale la pena aggiungere che in questo caso l’oscurità di molti riferimenti – che, insieme all’umiltà, tende a essere più evidente nei lavori di Godard co-firmati da Miéville – è cruciale per il significato stesso dell’opera. (Un tipico riferimento oscuro è quello a Lucien Coedel, un attore secondario degli anni 40, la cui figlia fa un’apparizione straordinaria in una scena). In un non meglio identificato albergo sulle rive di un lago europeo, l’attore Michel Piccoli – da poco eletto presidente della Associazione francese per il Primo Secolo del Cinema, con sede a Lione nel vecchio sito della fabbrica Lumière – raggiunge Godard per un rapido saluto dopo i festeggiamenti del 1995 per il centenario dello stesso Istituto Lumière. (Quest’evento ha dato origine a una sorta di spin-off sul centenario, Lumière & Co., che verrà proiettato al Film Center il 5 e il 6 dicembre – una raccolta affascinante, seppur discontinua, di brevi cortometraggi girati da registi famosi di tutto il mondo, da Peter Greenaway a Abbas Kiarostami a David Lynch a Jacques Rivette a Wim Wenders, che hanno avuto tutti a disposizione una cinepresa Lumière per girare i loro frammenti). Le scettiche esternazioni fatte da Godard a Piccoli in merito alle celebrazioni vertono essenzialmente su tre punti: 1. “Perché celebrare il cinema? Non è già abbastanza famoso?” 2. Ciò che viene celebrato è l’esibizione commerciale del cinema – il primo programma per spettatori paganti dei film dei Lumière si tenne nel 1895 – piuttosto che la sua invenzione o produzione, ed è per questo che nella pubblicità i proiettori vengono evidenziati più delle cineprese. 3. Come possiamo celebrare una storia che nessuno ricorda più? Godard osserva anche che «il cinema francese è stato l’unico ad avere dei critici. In altri paesi è diventato immediatamente un modo per far soldi». Questi sono i temi sviluppati dal resto del video. Su invito di Godard, Piccoli resta a dormire nell’albergo – interrogando di tanto in tanto lo staff sulla storia del cinema francese, facendo qualche telefonata a Lione e leggendo alcune pagine dei libri che gli ha dato Godard – per poi ripartire il mattino dopo. Durante tutto questo, riceviamo una panoplia non solo di nomi e titoli di film, ma anche di frammenti non identificati e privi di attribuzione, molti dei quali sono sicuramente sconosciuti o
difficilmente individuabili dallo spettatore. Lo stile e il metodo narrativo molto frammentari di 2 fois 50 ans differiscono chiaramente dall’impostazione dell’opus magnum in otto parti Histoire(s) du cinéma (di cui al Film Center è stata proiettata la prima metà; l’anteprima dell’opera completa avverrà a Cannes nel maggio prossimo), ma i presupposti filosofici sono in buona sostanza gli stessi. L’amnesia culturale è un tema centrale nel lavoro di Godard fin dagli anni 80 – evidente soprattutto in King Lear, ma presente anche in Passion, Nouvelle vague e Histoire(s) du cinéma – e anche qui appare centrale sia rispetto alla forma poetica che all’argomento trattato. È chiaro che Godard, regista che ha iniziato come critico, considera il video come uno strumento per la critica. 2 fois 50 ans si conclude con un toccante omaggio alla critica cinematografica francese – con un’accezione ampia del termine che include anche vari precursori nonché poeti, critici d’arte e registiteorici – fornendoci un parterre di 15 nomi illustri, da Denis Diderot a Serge Daney, e riservando a ciascuno un ritratto, una pagina di testo e una citazione di un breve passaggio letta in voice over da Miéville o Godard. Il sedicesimo membro della lista è Charles Baudelaire, che viene citato durante la tormentata veglia di Piccoli nella sua stanza d’albergo, e il diciassettesimo, Roger Leenhardt, viene nominato a un certo punto e intravisto in quello che forse è il filmato più lungo del video. Leenhardt era un critico e regista davvero straordinario, anche se ormai in Francia è dimenticato, e del tutto sconosciuto negli Stati Uniti; il filmato, privo di didascalie come gli altri, è tratto da un film di Godard del 1965,Une femme mariée. Leenhardt parla dell’intelligenza e di alcune sue funzioni sociali, facendo delle osservazioni che valgono per tutti gli scrittori citati nella sequenza conclusiva, tra cui figurano Elie Faure, Andre Malraux, Jean Cocteau, Robert Bresson, Jacques Rivette e Marguerite Duras. I Am Curious, Film di Stig Björkman, che parafrasa i titoli di Vilgot Sjöman, I Am Curious, Yellow e I Am Curious, Blue, mostra la protagonista di entrambi, Lena Nyman, in veste di presentatrice e interlocutrice, mentre viaggia tra Svezia e Danimarca, Norvegia, Islanda e Finlandia per parlare con alcuni registi, direttori della fotografia, e attori. (Gli svedesi, i norvegesi e i danesi si capiscono perfettamente tra di loro, quindi possono parlare ognuno nella propria lingua, ma il regista islandese Fridrik Tor Fridriksson e il finlandese Aki Kaurismäki parlano entrambi in inglese. Kaurismäki inserisce anche un suo cortometraggio, caustico come nel suo stile, Beer & Cigarettes, presumibilmente ispirato alla serie di cortometraggi di Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes).
Oltre al film di Godard, questo è l’unico documentario qui recensito che sia stato realizzato da un critico cinematografico, il che gli garantisce un’attenzione alla storia e alla forma del cinema che non si trova nella maggior parte degli altri lavori. Aprendosi (dopo una sequenza iniziale tratta da Persona di Ingmar Bergman) e concludendosi con una riflessione sul primo piano, quest’indagine spicca soprattutto per le sue rapinose immagini di repertorio, specie quelle tratte dai film in bianco e nero, e per la determinazione a trascendere i punti di riferimento scandinavi in favore di considerazioni critiche più generali (vengono citati Pier Paolo Pasolini, Robert Flaherty, Samuel Fuller, Sergio Leone e Andrej Tarkovskij). Dato che Carl Dreyer è il mio regista preferito, ero molto interessato a scoprire come Björkman se ne fosse occupato. Com’era prevedibile, egli delega buona parte del lavoro a Lars von Trier, il più celebre tra i sedicenti discepoli di Dreyer: e anche se i suoi commenti sono fastidiosamente brevi e tutt’altro che adeguati, la scelta di alcuni splendidi estratti di Vampyr e Gertrud risulta illuminante. Bergman viene trattato approfonditamente, anche se a quanto pare non ha voluto o potuto essere intervistato in prima persona; il suo direttore della fotogafia Sven Nykvist e due dei suoi attori, Liv Ullmann e Erland Josephson, compensano la mancanza. Tra gli altri partecipanti di spicco figurano i pionieri Astrid Henning-Jensen e Stefan Jarl. Oltre ad Akira Kurosawa, Nagisa Oshima è senza dubbio il più grande regista giapponese vivente, ma dato il suo disprezzo per il lavoro di quasi tutti gli altri suoi connazionali risulta piuttosto inadeguato a raccontare la storia del cinema del suo paese. In 100 Years of Japanese Cinema interpreta il ruolo dell’accademico, di cui non sembra neanche molto all’altezza, fornendoci una specie di Bignami della storia sociale del Giappone del XX secolo in relazione al cinema, in cui le questioni estetiche giocano un ruolo quasi irrilevante. (Alla fine, egli ipotizza che nei prossimi cento anni il cinema giapponese cesserà di essere giapponese e «sboccerà come cinema puro» – ed è evidente che la prospettiva lo galvanizza). Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu e Kurosawa vengono ricordati solo con una clip a testa; e cosa ancor più scandalosa, Oshima concede a se stesso niente meno che quattro estratti (da Racconto crudele della giovinezza, La cerimonia, Ecco l’impero dei sensi e Furyo) riuscendo anche a discutere o a citare la maggior parte gli altri suoi film. Il suo individualismo si evidenzia anche nel passaggio dalla terza alla prima persona, quando analizza il passaggio dagli anni 50 agli anni 80 – un approccio onesto, che però finisce col risultare confusionario rispetto a quasi tutti gli altri registi; e Oshima è poco convincente quando definisce “obiettivo” il suo commento in terza
persona. Il vero problema, in questo caso, è che la storia del cinema giapponese non può essere raccontata da una singola voce – anche se Oshima non sembra disposto a concederci nient’altro, con l’eccezione di un paio di citazioni; in quanto a sensibilità artistica, malgrado tutta la sua intelligenza, risulta secondo perfino a quello zoticone di Frears. È possibile che il modo in cui Oshima tratta la storia giapponese contemporanea sia audace e radicale in relazione alle regole giapponesi (si accanisce contro il militarismo di stato ed è attento verso i coreani residenti in Giappone), ma al resto di noi, quanto arriva di tutto ciò? Il pesante orientamento socio-politico e l’indifferenza estetica finiscono col lasciar fuori così tanti film di valore – da Una pagina di follia di Teinosuke Kinugasa (a cui viene concesso solo un breve fermo immagine) a La rivincita di un attore di Kon Ichikawa (ignorato) fino ai film di animazione e ai documentari (ammucchiati in poche e fugaci immagini), che sembrano annoiare Oshima quanto il cinema inglese annoia Frears – che quel che resta difficilmente può risultare interessante. Non sto dicendo che un approccio socio-politico alla storia del cinema sia sbagliato – purché sia fatto con sapienza critica e sensibilità estetica. A questo proposito, il più impegnato tra i documentari sul “Secolo del Cinema” è Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema di Stanley Kwan, 80 minuti di analisi sulla cinematografia di Hong Kong, Taiwan e Cina continentale, condotti rigorosamente dal punto di vista del genere, con l’esplicita parzialità autobiografica di un regista dichiaratamente gay. Vale la pena sottolineare che Kwan trascura molte aree importanti del suo argomento, anche nell’ambito ristretto scelto da lui stesso – e alludo in particolare alle registe donne, come la cinese Li Shaohong e la regista di Hong Kong Clara Law, anche se dedica molto spazio all’attrice di Hong Kong Brigitte Lin e alla critica taiwanese Peggy Chiao, ed esamina diffusamente la sua personale cinematografia, in quanto regista di donne), per non citare figure importanti come Tian Zhuangzhuang, Zhang Yimou, Yim Ho e Wayne Wang. (Il fatto che Kwan ometta di parlare del cinema muto cinese è certo più comprensibile, se non altro perché il suo capolavoro Center Stage, scritto insieme a Peggy Chiao, si è già occupato magnificamente dell’argomento). Ma il suo lavoro resta comunque l’indagine più entusiasmante ed esaustiva sul cinema cinese che io conosca. Dividendo il documentario in cinque o sei capitoli incentrati su temi come “Assenza del padre”, “Femminile e maschile, viso e corpo”, figure paterne, fratelli maggiori che diventano surrogati del padre, travestimenti e transessuali, Kwan trascura forse un poco le figure materne – con l’eccezione di sua madre, che conclude il film con un toccante
commento. Ma riesce comunque a tratteggiare i contorni di un’ampia storia del cinema e dei cambiamenti culturali che la pervadono (un compito cui Oshima adempie solo in parte, e con scarsa convinzione). Durante questo percorso, Kwan ci presenta un’affascinante elenco di figure relativamente sconosciute. (Sono rimasto particolarmente intrigato da Maxu Weibang, uno specialista dell’horror “unico nella sua perversione” attivo presso gli studi di Shanghai negli anni 30) inserendo anche dei commenti interessantissimi, tra cui quelli del regista di azione di Hong Kong Chang Cheh e del suo discepolo John Woo; dei registi di Hong Kong Wong Kar-wai e Allen Fong; dei registi taiwanesi Hou Hsiao-hsien, Edward Yang, Ang Lee, e Tsai Ming-liang (che parlano per lo più dei loro padri o dei loro figli, e di come queste relazioni si riflettono nei loro film); di registi cinesi più anziani come Xie Jin; e dell’attore Leslie Cheung (che critica alcuni dei suoi stessi film). Kwan intervista i registi eterosessuali Chen Kaige, Tsui Hark e Zhang Yuan (un indipendente cinese molto anticonformista) sulle loro abitudini sessuali – e accusa di omofobia Addio mia concubina di Chen, soprattutto in relazione al romanzo di Lilian Lee da cui è tratto – e nel mentre fornisce un’intelligentissima testimonianza non solo dei cambiamenti della sensibilità sessuale e dei valori familiari in atto nel mondo di lingua cinese, ma anche della portata e della vitalità della nuova cinematografia, che riflette questi cambiamenti. In breve, Yang ± Yin, lungi dal raccontare in modo esaustivo la storia del cinema cinese, costituisce comunque una testimonianza importante in attesa di altre nuove indagini. C. Tre modelli positivi: Mark Rappaport, Thom Andersen, Kevin B. Lee Anche se i pionieristici saggi audiovisivi di Mark Rappaport non possono e non dovrebbero essere visti solo dai cultori di certi attori del grande schermo, si potrebbe comunque affermare che queste indagini critiche sulle carriere delle star – un corpus che comprende Rock Hudson’s Home Movies (1992), From the Journals of Jean Seberg (1995), John Garfield (2002), Becoming Anita Ekberg (2014), I, Dalio, or The Rules of the Game (2015), e Debra Paget, For Example (2016) – rappresentano, nella maggior parte dei casi, il meglio del suo lavoro in quest’ambito. In ciascun caso, il lavoro critico consiste anche nel rivelare alcuni tratti che risulterebbero meno evidenti senza questo genere di analisi, e l’analisi comprende questioni sia ideologiche che estetiche ben più ampie di quelle che possono essere rintracciate nel lavoro creativo degli attori coinvolti. In Rock Hudson’s Home Movies, la questione principale è l’identità omosessuale nascosta o velata dello stesso Hudson al di fuori delle sue performance, che tuttavia produce ugualmente delle tracce distorte di tale identità all’interno dei film stessi; in From the Journals of Jean
Seberg, l’indagine trascende la biografia della Seberg per considerare le implicazioni delle sue ambigue espressioni “vuote” e le carriere di alcuni dei suoi contemporanei impegnati a sinistra, come Jane Fonda. Più recentemente, in I, Dalio, Rappaport ci offre un affascinante studio comparativo dei ruolitipo interpretati da Marcel Dalio nel cinema francese (sia prima che dopo la guerra) e nelle produzioni degli studios hollywoodiani, dimostrando come le origini ebree di Dalio portino a varie forme di stereotipi anti-semiti nei film francesi che vengono invece bypassati da Hollywood, in favore di altri stereotipi americani relativi al comportamento dei francesi. E in Debra Paget, For Example, egli usa la carriera cinematografica dell’attrice per riflettere su vari argomenti, come la mutevolezza (e, verrebbe da dire, l’intercambiabilità) degli stereotipi etnici, il CinemaScope e il Kitsch. In ognuno di questi lavori, Rappaport mescola finzione e documentario – usando attori per interpretare i ruoli di Hudson, Seberg, Dalio e Paget; in quest’ultimo caso, complica ulteriormente il metodo usando sia la propria voce che quella dell’attrice che interpreta la Paget per illustrare i vari argomenti. Ho già parlato di Eadward Muybridge, Zoopraxographer (1972) di Thom Andersen, un saggio della prima ora che anticipa di sedici anni Rock Hudson’s Home Movies; ma i successivi e non meno ambiziosi Los Angeles Plays Itself (2003, 170 minuti), Red Hollywood (realizzato in collaborazione col già citato Noël Burch, 1996, 118 minuti), e The Thoughts That Once We Had (2015, 108 minuti) meritano di essere citati in questa sede per il modo originale con cui sottopongono a scrutinio critico vaste aree della storia del cinema. Il primo di questi, uno studio su come Los Angeles è stata descritta nei film, analizza argomenti apparentemente secondari come l’architettura e la cultura dell’automobile (solo per citare due interessi particolari di Andersen che figurano anche in altri suoi lavori, dal testo mai pubblicato Cinema and its Discontents, una storia parallela del cinema e dell’automobile, fino al suo recente [2012] documentario portoghese, Reconversion), anche se ciò non rende completamente giustizia all’insieme delle finalità storiche, sociologiche e politiche della sua indagine analitica. Il secondo invece sviluppa un saggio di Andersen del 1985 dallo stesso titolo (successivamente aggiornato) che esamina il contenuto politico e sociale degli artisti finiti nella lista nera di Hollywood e il terzo offre un’indagine molto personale sulla storia del cinema secondo la tassonomia di due libri complementari di Gilles Deleuze, Cinéma 1: L’Image-Mouvement e Cinéma 2: L’Image-Temps (1983). Stando alle sue stesse stime, negli ultimi sei o sette anni Kevin B. Lee ha realizzato individualmente o come co-autore circa 300 lavori di critica audiovisiva, tutti relativamente brevi, la maggior parte dei quali è stata
caricata in rete – spesso sul sito di Fandor, dove egli commissiona anche dei lavori critici ad altri, ma anche presso Indiewire, «Sight and Sound», e sui suoi canali Vimeo (111 video) e YouTube (142 video). Per amor di trasparenza, devo aggiungere che anch’io ho collaborato con Lee su cinque dei suoi video: su Out 1, Satantango, su un analisi comparativa di The Sun Shines Bright e Gertrud (in due parti), e su Orson Welles; tra gli altri suoi numerosi collaboratori figurano Mike d’Angelo, David Bordwell, Nicole Brenez, Richard Brody, Chris Fujiwara, Molly Haskell, Adrian Martin, Dan Sallitt, Andrew Sarris, Matt Zoller Seitz, Kristin Thompson e Paolo Cherchi Usai.
Il lavoro di Lee, che rispecchia le ultime tendenze della produzione in questo campo molto più di quello di Rappaport o Andersen, è comunque troppo vario per essere ridotto a una rapida indagine comparativa, anche perché io ne ho visto solo una piccola parte. Anziché tentare un compendio di questo genere, consentitemi di concludere quest’indagine elencando una serie di lavori di Lee e di alcuni altri che lui e Alejandro Bachmann hanno selezionato per tre diverse rassegne del Filmmuseum austriaco nell’aprile del 2016, più o meno nello stesso periodo in cui veniva completato il presente saggio – lavori i cui titoli (e anche, in certi casi, gli autori) ben rappresentano alcune delle forme di indagine attualmente in corso: Ästhetik der Analyse / Estetica dell’analisi in presenza di Kevin B. Lee
Programma 1: Autoren & Analyse/Autori & analisi 18. Aprile, h 19:00 The Spielberg Face (Kevin B. Lee, 2011, 10’) Who Should Win the 2014 Oscar for Best Lead Actress (Kevin B. Lee, 2014, 7’) Double Insomnia (Kevin B. Lee, 2015, 6’ ) Deceptive Surfaces: The Films of Christian Petzold (Kevin B. Lee, 2015, 6’ ) Lynchian Ambience (Jacob Swinney, Fandor, 2015, 1’ ) The Career of Paul Thomas Anderson in Five Shots (Live Version) (Kevin B. Lee, 2012, 10’) Viewing Between the Lines: Hong Sang Soo’s The Day He Arrives (Kevin B. Lee, 2012, 12’) Jacques Rivette: Out 1 (Solitaire) (Kevin B. Lee & Jonathan Rosenbaum, 2014, 8’) Dissolves of Passion (Catherine Grant, 2015, 8’) Tarkovsky’s Candles (Kevin B. Lee, 2015, 10’) Programma 2: Technologie & Politik/Tecnologia & politica 18 Aprile, h 21 Why Framing Matters in Movies (Chloé Galibert-Lâiné, 2015, 7’) Interface 2.0 (Harun Farocki) (Kevin B. Lee, 2012, 8’) The CGI Menagerie of Rhythm & Hues (Kevin B. Lee, 2013, 8’) Is This Cinerama (Kevin B. Lee, 2013, 5’) What Makes a Video Essay Great? (Live Version) (Kevin B. Lee, 2014, 7’) Vancouver Never Plays Itself (Tony Zhou, 2015, 9’) Transformers: The Premake (Kevin B. Lee, 2014, 25’) Programma 3: Kino & Gesellschaft/Cinema & società 20 Aprile, h 21 The Hour of the Star (Kevin B. Lee, 2008, 8’) What * was * Documentary? (Kevin B. Lee, 2014, 8’)
The Essay Film: Some Thoughts on Discontent (Kevin B. Lee, 2013, 7’) The Tarantino Death Toll (Live Version) (Kevin B. Lee, 2015, 10’) When Soldiers Come Home in the Movies (Bill Kinder, 2015, 7’) Learning to Look: Eye Contact in Satyajit Ray’s The Big City (Joel Bocko, 2015, 7’) Fembot in a Red Dress (Allison de Fren, 2016, 13’) Talking with Siri About Spike Jonze’s Her (Kevin B. Lee, 2014, 10’) Traduzione dall’americano di Stefano Tummolini
Note del capitolo 1. Adattamento dell’articolo pubblicato su Moving Image Source del 18 agosto 2010 (http://www.movingimagesource.us/articles/the-mosaic-approach-20100818). 2. Tratto da un post su blog 3. Ristampato dal «Chicago Reader» (22 novembre 1996).
«Look at the way he rides with his legs stretched up!» / Lavorare con fotogrammi, lavorare con inquadrature, lavorare con sequenze Michael Baute, Volker Pantenburg [Nota di Michael Baute e Volker Pantenburg] Il testo seguente lo abbiamo scritto nel 2007 per la rivista austriaca «kolik.film». La sua stesura risale al periodo della preparazione del progetto di ricerca indipendente “Kunst der Vermittlung. Aus den Archiven des Filmvermittelnden Films” (Arte della mediazione. Dagli archivi dei film che mediano il cinema). In questo progetto ci siamo cimentati per quasi due anni, con la collaborazione di Stefan Pethke, Stefanie Schlueter ed Erik Stein, nell’esplorazione di un genere che abbiamo definito con un termine difficile da tradurre: “film che mediano il cinema”. Film che, con lo scopo di capire il cinema e di documentare il processo cognitivo, si indirizzano ad altri film criticandoli e analizzandoli. Sulla pagina web si possono trovare numerosi testi, interviste e un’ampia filmografia. Il genere del video essay di analisi, presto apparso in blog personali, su Youtube e Vimeo a opera dei protagonisti della cinefilia 2.0 e poi – grazie all’impegno di Catherine Grant e altri –recepito come “videographic film studies” dalla scienza del cinema accademica, all’epoca non esisteva. Solo durante il progetto – attraverso i lavori di Kevin B. Lee, Matt Zoller Seitz e altri – ci siamo resi conto che qualcosa stava nascendo grazie alle possibilità date da filesharing, weblogs e da software per ripping e montaggio digitale di facile uso. Per noi – in questo testo come nell’intero progetto – era importante porre l’accento sul fatto che proprio ai margini della storia del cinema, al di fuori degli ambienti canonizzati dell’arte come nelle redazioni televisive o nell’ambito di progetti didattici relativi al cinema, già da decenni si faceva opera di diffusione, elaborazione e articolazione in contesti che esistevano prima di internet e dei social media. I “videographic film studies” hanno una storia antecedente che si può raccontare non solo come storia dei mass media e delle istituzioni ma anche come storia delle pratiche della critica e delle tecniche di montaggio. A oggi ci pare che sottolineare il background artistico e sperimentale del genere “video essay”, come nel Found Footage Film, restringa inutilmente la prospettiva. C’era e c’è molto da scoprire. I I film di cui questo testo tratta perseguono un obiettivo specifico. Devono
“mediare”, spiegare, chiarire qualcosa. E cioè la questione su che cosa sia film, che cosa cinema. E su come nel caso specifico funzioni e agisca. Sono film che hanno imparato da altri film e che quello che hanno imparato lo vogliono mediare. Ad esempio Ernst Lubitsch: eine Lektion in Kino [1] (Una lezione di cinema) di Enno Patalas. Il film lavora con i film di Lubitsch come con una banca immagini. Raggruppa, ordina e intreccia, critica fuori campo. Il suo interesse è diretto alla costruzione di serialità, alla sostituibilità, al fatto che i personaggi e i conflitti in Lubitsch non sono concepiti psicologicamente ma in senso costellativo, relativamente al loro posizionamento in formazioni triangolari. Le costruzioni seriali di Lubitsch vengono ripetute in modo da rendere evidenti le loro differenti inquadrature e “valenze“. Mettere in evidenza – nel cinema di Lubitsch e nella sua concezione emersa dal film di Patalas – non significa premasticare, sintetizzare o definire ma è la comunicazione di una formula cinematografica che senza spettatori rimarrebbe incompleta. La collaborazione degli spettatori è infatti presupposto del suo funzionamento. Il documentario su Lubitsch è una dimostrazione di partecipazione attiva degli spettatori.
Di tali lavori ce ne sono molti e si possono riassumere come “film che mediano il cinema”. Trasmissioni televisive, film e istallazioni che lavorano
con immagini e suoni della storia del cinema entrando così a farne parte. Das Kino und der Tod (Il cinema e la morte, 1988) di Hartmut Bitomsky; Il documentario di Pedro Costa sul montaggio di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub del loro film Sicilia! [2]; Phoenix Tapes (1999), montaggio su Hitchcock di Christoph Girardet e Matthias Müller; le trasmissioni per la WDR (emittente radiotelevisiva pubblica locale, Ndt) che Enno Patalas e Frieda Grafe hanno fatto su Murnau o von Sternberg [3]. L’incontro con questi film è spesso frutto di coincidenze o di cinefilia randagia. Il videoregistratore è stato programmato con ampi margini e, dunque, dopo il film che si voleva registrare c’è anche un suggerimento di visione di altri film fatto da Norbert Grob o Helmut Merker [4]. Sulla cassetta VHS, noleggiata dal centro multimediale dell’Università, non ci sono solo i film Griffith ma anche il documentario che Helmut Färber ha fatto su A Corner in Wheat [5]. A una mostra museale sul cinema ci si imbatte in 12 monitor sul tema Arbeiten verlassen die Fabrik (I lavoratori lasciano la fabbrica) di Harun Farocki (2006). Nella biblioteca comunale si trova una videocassetta con 45 minuti di analisi di Jean Douchet su M di Fritz Lang, grazie alla quale si scoprono tutta una serie di film di analisi [6].
Questi lavori sono correlati. Comunicano reciprocamente. Si potrebbe dire che compongono un genere. Se il genere dei “film che mediano il cinema” esiste, allora come tale è rimasto sinora invisibile. Non emerge né dalla
storiografia cinematografica né dagli attuali progetti in ambito formativo o relativi alla promozione della cultura cinematografica.
Come ramo secondario della storia del cinema il “film che media cinema” c’è sempre stato. Se si concepisce in senso lato ne fanno parte – filmologicamente – film didattici e documentari [7], corti pubblicitari per il cinema (in ambito industriale) come i “making of” [8], così come gli innumerevoli formati tv che ruotano intorno a filmmaker, attori, star e generi per incrementare il loro valore di mercato [9]. Concorrono al genere anche i servizi “preformattati”, al cinema e in programmi culturali, i presskit-video redazionali per prime cinematografiche o i contributi critici dal mondo della cultura al film di denuncia sociale, i ritratti di registi per l’anniversario della morte e le biografie di attori contenenti testimonianze di collaboratori e di storici cinematografici. Tutti questi format hanno qualcosa a che fare con il cinema e con le sue declinazioni. A tutti loro è comune il fatto – almeno a livello potenziale – di avere un contatto diretto con il materiale dei film in quanto testo. Poiché l’oggetto da descrivere e la sua descrizione sono parte dello stesso medium.
II Tre forme del “film che media cinema“: Drei Minuten in einem Film von Ozu (Tre minuti in un film di Ozu) di Helmut Färber del 1988; Le cinéma. Une histoire de plans di Alain Bergala del 1998; diverse analisi di Tag Gallagher degli ultimi cinque anni. Il cinema in questi tre formati è contenuto in diverse concentrazioni. Helmut Färbers si limita a mettere insieme fotogrammi da Banshun di Ozu (Tarda primavera, 1949) e a commentarli con riservata determinazione. La serie Le cinéma. Une histoire de plans (Il cinema. Una storia di inquadrature) di Alain Bergala si occupa in ogni puntata di un’unica inquadratura. Diversamente da Färber e Bergala le analisi di Gallagher lavorano con il materiale completo, non di un solo film ma spesso anche con sequenze provenienti da altri film. E i tre elementi oggetto di analisi – fotogramma, inquadratura, sequenza montata – rappresentano nel contempo tre pietre miliari del lavoro cinematografico. III Drei Minuten in einem Film von Ozu è uno degli otto programmi che Helmut Färber ha realizzato tra il 1976 ed il 1995 per la redazione cinema della WDR [10]. È stato trasmesso il 23 ottobre 1988 e inizia con una neutrale lavagna grigia dove in lettere bianche è scritto il titolo. Il nome di Helmut Färber non è corredato dall’attributo “autore” o “regista” ma segue le parole “commentato da”. Questo richiama tutta una tradizione – religiosa e laica – del commentare e dice qualcosa sulla relazione in cui Färber si vuole porre nei confronti dei film di Ozu. Non vuole parlare “di” lui e mettersi così al disotto, ma parlare con le immagini di Ozu e accanto a loro generare un secondo testo. Qui si può richiamare una dichiarazione di Alexander Kluge, per la quale il commento è «la forma basilare del testo». Anche il cinema di Ozu in senso lato è riconoscibile come commento, in particolare come commento sulla società giapponese del 1949, nella quale si è sviluppato.
Il programma è suddiviso in tre parti. Nella prima Färber si trova seduto a una scrivania nello studio televisivo. Nel dispositivo “studio televisivo” è ammesso un secondo dispositivo “scrivania” o “posto di lavoro”. «Un film è un tutto che si compone di molte singole inquadrature. Adesso vorrei guardare più da vicino un brano tratto da un film così come si può anche guardare più da vicino la struttura di un’opera architettonica» [11].
Il brano, il giro in bicicletta di Noriko e dell’assistente, viene poi mostrato interamente. Segue un taglio e comincia la seconda parte dell’analisi di Färber, la più dettagliata, con netto distacco dalle altre. Vediamo una stanza vuota. Pareti azzurre, pavimento grigio. Sul pavimento c’è una striscia di cartoncino nero. Allineate al bordo di questa striscia ci sono dei fotogrammi attraverso i quali la sequenza è descritta e commentata. In tale analisi si ricorre a un procedimento molto semplice. A un espediente, in realtà, per trasportare nella costruzione spaziale del film quell’avvicendarsi di immagini che rappresenta la sequenza temporale del brano. Che Noriko si trovi a destra e l’assistente a sinistra, Färber lo evidenzia prelevando per un momento i fotogrammi dall’allineamento verticale e ponendole l’una accanto all’altra, così come, allo stesso modo, i due percorrono insieme la strada di campagna giapponese. In questa seconda parte c’è un approccio fisico alle immagini diverso dalla situazione della scrivania. Färber si muove accucciato scorrendo lungo i fotogrammi e indicando dettagli e strutture (abbiamo precisato su «kolik.film» che «dopo che la sequenza è stata mostrata una volta, Färber lavora esclusivamente con i fotogrammi. Per ogni inquadratura un fotogramma, ma se l’inquadratura cambia ci sono due fotogrammi: uno per l’inizio, l’altro per la fine dell’inquadratura»). Il dispositivo ha a che fare con la comprensione e la messa in relazione dell’osservatore con le immagini. Färber agisce egli stesso nell’immagine ed è così riconoscibile come colui che osserva e che indica.
La terza e ultima parte del documentario stabilisce ancora una volta un diverso rapporto tra il commentatore Färber e le immagini commentate di Ozu. I fotogrammi sono ora riportati in un sistema di coordinate sulla parete grigia dello studio. Ci sono due colonne nelle quali a una identica tipologia di inquadratura corrisponde pari altezza. Färber, ora, non è più seduto o accucciato ma in piedi davanti alle immagini come davanti a una tavola illustrata di Aby Warburg sulla quale con la matita indica ogni dettaglio. «Quando il pezzo viene osservato nel suo insieme, allora si evidenzia come sia costituito da solo due tipi di inquadrature, immagini e messe in quadro. Dai primi piani, che rimangono del tutto identici, a dei totali, tra i quali c’è da un lato una somiglianza di base e dall’altro esistono diversi tipi di analogie e corrispondenze. I totali sono per i primi piani una specie di cornice».
Il brano filmico (Färber dice “brano“ come si parlerebbe di un brano musicale) viene ripercorso in tutto nel documentario per tre volte. È un frammento, uno spezzone tratto dal film. Ma lo spezzone, d’altro canto, viene reso evidente come un tutto. In questi tre passaggi sono riconoscibili anche diversi livelli di astrazione e una letteralmente progressiva traduzione del film stesso (come sequenza) attraverso commenti su proporzionalità e tipologia di costruzione e sull’architettura filmica presenti in quel film. Nella versione successiva del commento Färber sintetizza così: «Queste così evidenti
formazioni, queste collocazioni nei film di Ozu, che si lasciano schematizzare così facilmente a livello illustrativo, e nelle quali si comunica sempre un qualcosa di liberatorio, in quei film non sono fine a se stesse e non sono predeterminate. Si costituiscono, sono fatte del nucleo interno dei film, di cui esse sono l’aspetto esterno» [12]. IV Nell’ultimo decennio i DVD sono diventati una nuova occasione di produzione di lavori di analisi cinematografica. Soprattutto in Francia ne sono stati realizzati in gran numero [13]. Tag Gallagher, i cui testi mostravano già in precedenza un approccio personale alle immagini cinematografiche, è uno dei più produttivi autori di “film di critica”. I suoi lavori si trovano in DVD francesi, inglesi e tedeschi [14]. Gallagher lavora con materiali diversi a seconda del film – foto di produzione, brani d’archivio, copertine di libri, ritagli di giornale, citazioni messe in evidenza in tavole illustrate, stralci da altri film del regista. Alle quali si aggiungono interventi sulle immagini stesse del film. È soprattutto nel tempo e nel ritmo che le analisi di Gallagher si differenziano da quelle provenienti dalla Francia e dalla Germania, dove più spesso vengono fatte delle pause artificiali, annunciate da fondi neri con titoli in stampatello o attraverso un cambiamento di tono della voce. Se è vero che il lavoro con interruzioni nette può essere riconducibile alla provenienza accademica di molti autori, Gallagher sceglie sovraimpressioni e ripetizioni per poter svincolare gli elementi del film dalla base lineare temporale e mettere in luce le loro relazioni. Questo conduce spesso alla formazione di motivi ricorrenti: i ballerini o gli sguardi nel vuoto di Ophüls, i cantanti e i picchiatori di Hawks.
Piano piano scaturisce così una qualità ritmica propria del commento. Film e commento sviluppano un rapporto reciproco che si allontana sempre di più da illustrazione e tesi. A prendere vita sono qui delle unità proprie, “colloqui” con le inquadrature e i motivi di un regista. E il film diventa un interlocutore attivo. In questo processo ha spesso luogo un’attribuzione di autorialità che identifica Gallagher come “auteurist”. L’aggiunta della storia della ricezione personale attribuisce all’analisi la sua energia motoria. Anche nelle diverse modulazioni del sonoro l’andamento produttivo dei lavori di Gallagher è percepibile. A volte è vicino, altre lontano dal microfono. Il livello non è omogeneo e normalizzato. Quella che si potrebbe considerare una disattenzione nei confronti della traccia audio del commento (partenze ritardate, diverse dinamiche) corrisponde invece a una peculiare sincronizzazione di fotogramma, inquadratura e sequenza, così come a una incorporazione di materiale aggiuntivo. Fa ricordare la “Termite Art“ di Manny Farber, la visione di un cinema indipendente che per mezzo della sua mobilità mina e mette in discussione le regole canoniche [15]. Spesso nei film di Gallagher è impossibile distinguere i suoi montaggi da quelli del film analizzato. Ma in nessun caso l’oggetto viene sacralizzato attraverso gesti di deferente umiltà. Al contrario. Gallagher si appropria aggressivamente delle inquadrature del film e dei loro movimenti semantici. Senza eccezioni Gallagher parte dal presupposto che i film analizzati portino a galla gli atteggiamenti e l’approccio degli uomini nei confronti della vita.
Così A Ribbon on the Land. (She Wore a Yellow Ribbondi John Ford) è un film sui motivi di Ford e sulla storia dei personaggi. Un film sul ruolo del Paese, della morte (i film di Ford come protesta contro la morte), su quello delle formalità (militari) e rituali che si oppongono al Paese e – «ecologicamente come formalmente» – lo conquistano. Questa una delle chiavi di Gallagher buttata là come per caso. Il film associa osservazioni, ripete, a volte fino all’eccesso, brevi sequenze (come, all’inizio, quattro volte di seguito l’alzabandiera o come, nella parte centrale, sei volte il saluto militare di Wayne). In questo procedere si accumulano piccole osservazioni che sembrano fuorvianti – «Look at the way he rides with his legs stretched up!» (Guarda come cavalca con le gambe allungate) – ma che in sintesi accentuano l‘attenzione di Ford per peculiarità e tipizzazioni. V Alain Bergala è una figura centrale nella promozione della cultura cinematografica francese. Con la traduzione del suo libro L’hypothèse cinéma pubblicato nel 2002 in francese il suo apparato concettuale a sostegno dell’educazione al cinema si è fatto conoscere anche in area germanofona. Meno conosciuti sono i suoi lavori come autore e produttore di diversi “film che mediano il cinema“, che da dieci anni a questa parte – parallelamente e in modo complementare al suo lavoro istituzionale – sono stati prodotti tra gli altri su Moonfleet di Fritz Lang, Mes petites amoureuses di Jean Eustache, Dov’è la casa del mio amico? di Kiarostami o Chronique d’un été di Jean Rouch [16]. Che certe analisi possano essere prodotte è ancora oggi una questione di capacità di negoziazione. Presente è la minaccia di paletti giuridici, divieti e reclami sui diritti d’autore relativi a immagine e suono. Per poter lavorare con il materiale dei film occorre pagare, anche quando il lavoro si svolge in un contesto di divulgazione a fini didattici [17]. Già nel 1998, prima della sua collaborazione con l’allora ministro della cultura Jack Lang nell’ambito delle politiche per l’istruzione, Alain Bergala ha ideato, scritto e messo in scena una serie di dodici puntate contenenti analisi di inquadrature di singoli film, dal titolo: Le cinéma. Une histoire de plans. La serie è stata prodotta nell’ambito di «Ecole et cinéma», un progetto di educazione al cinema promosso a livello statale [18]. Il presupposto di Le cinéma è che, come da un unico campione chimico, da una sola inquadratura si possa imparare e riconoscere qualcosa che va oltre l’inquadratura stessa. Che in essa cinema e storia contemporanea siano presenti e che possano emergere attraverso il dialogo. Per Bergala, come per altri teorici francesi del cinema, l’inquadratura è un’unità centrale. C’è tutto un arsenale di metafore organicistiche di Daney, Deleuze e altri, nelle quali
l’inquadratura è legata al passaggio dalla morte alla vita [19]. In questo senso Bergala la chiama una volta «la più piccola cellula vivente del film» e auspica che ci si possa «avvicinare al cinema a partire dall’inquadratura, dal momento che essa per me nella sua temporalità, nel suo divenire, nel suo ritmo […] è una componente relativamente autonoma del grande corpo cinema» [20]. Le prime tre puntate della serie hanno per oggetto i film dei fratelli Lumière. L’Attelage d’un camion (1896), La petite fille et son chat (1900) e Le faux Cul-de-jatte (1896). Per queste e per le rimanenti puntante relative a 80 anni di storia del cinema [21], la regola del gioco è sempre la stessa. Un’inquadratura del film (che per i film Lumière coincide con tutto il film) viene mostrata all’inizio una volta per intero e senza nessuna aggiunta. Dopo si inserisce la parte principale, il lavoro analitico o, meglio, descrittivo su quella singola inquadratura. Per altri otto, massimo dieci minuti si continua a vedere esclusivamente quell’unica inquadratura. Anche se tale inquadratura a tratti è fermata, rallentata, accelerata, mandata avanti o indietro. Questi cinque modi rappresentano le operazioni possibili in una moviola a 16 o 35 millimetri. Sono gli unici interventi. Concepiti come conversazioni e scritti sotto forma di dialoghi da Alain Bergala sono invece i testi fuori campo, letti di volta in volta da due attori, un uomo e una donna. Nell’analisi di L’attelage d’un camion sono Michel Piccoli e Fanny Ardant. Che si tratti di attori francesi, che vengono immediatamente associati alla Nouvelle Vague (Anna Karina, Michel Piccoli, Bulle Ogier ecc.) non richiama solo un certo canone cinematografico. Significa anche che qui la storia stessa del cinema parla di storia del cinema. La storia del cinema si anima e questa vitalità si estende all’approccio con le immagini, fino a che non è più chiaro chi animi cosa. Le immagini il parlato o il parlato le immagini. Il tutto dipende dall‘intonazione del testo di Bergala. Sembra di avere a che fare con una chiacchierata rilassata, lontana da ogni tipo di didattica. Pigramente, vagabondando attraverso l’immagine, si alternano osservazioni a sorprendenti deduzioni sul cinema. Nella puntata su Les vacances de monsieur Hulot di Jacques Tati, ad esempio, una costatazione sulle possibilità di “on” e “off” per immagini e sonoro conduce sorprendentemente a riflessioni sulla condizione sociologica della Francia degli anni ’50. Analogamente, diverse osservazioni vengono fatte anche nel brano su L’attelage d’un camion: Ardant: I cavalli arrivano uno dopo l’altro nell’immagine e poi la attraversano lungo tutta la diagonale. Quando ha iniziato a girare la manovella, quando il primo cavallo era nell’inquadratura, deve aver calcolato che in 50 secondi tutti i cavalli avrebbero finito di attraversare
l’immagine. Piccoli: A ciò si aggiunge anche l’altezza della macchina da presa. È l’altezza perfetta per vedere l’andatura del cavallo, dove sono i muscoli, cosa fanno le zampe posteriori. Si vedono apparire gli zoccoli sul lastricato. Ardant: Ti sei reso conto di quanto si possa scoprire in un solo secondo sulla Francia di un secolo fa? Questo è come un campionamento. E grazie a questa coincidenza si è ottenuto addirittura un perfetto spaccato che contiene tutti i gruppi della popolazione e anche i mezzi di trasporto. Viene da pensare quasi a una messa in scena tanto perfetta è l’inquadratura.
Questo tono intimo e personale accomuna, con diverse intensità, tutte le dodici puntate di Le cinéma. Une histoire de plans. Alcune puntate girano intorno a un’unica domanda. Su un’inquadratura di Vivre sa vie di Godard si discute se per poter fare a un’attrice un primo piano ben riuscito sia necessario essersene innamorati. Di fronte alla straziante inquadratura finale di La maman et la putain di Jean Eustache, Bergala si ritira completamente come autore per lasciare che Michael Lonsdale e Bulle Ogier, nella modalità del narratore che ricorda, richiamino il contesto del 1968 e degli anni successivi. Sulle possibilità di una educazione non autoritaria dopo il 1968 Roland Barthes ha scritto una volta: «Esistono forse due mezzi per evitare l’imposizione del sapere (non è forse questa, oggi, la posta in gioco in ogni
insegnamento, in ogni “ruolo” intellettuale?): o produrre un discorso lacunoso, ellittico, che derivi e sbandi; oppure, al contrario, caricare il sapere di un eccesso di chiarezza» [22]. Pubblicato (salvo il primo paragrafo) in «kolik.film», vol. 8/2007, pp. 7-15 col titolo «Look at the Way He Rides With his Legs Stretched Up!» Zum Filmvermittelnden Film. Traduzione dal tedesco di Isabella Rossi e (per le note) Francesco Bono
Note del capitolo: 1. Ernst Lubitsch: Eine Lektion in Kino, Enno Patalas, prima messa in onda sul Terzo programa del WDR il 2 giugno 1971, versione rivista sul Primo programma dell’ARD il 25 aprile 1982. Una trascrizione del film si trova in: Hans Helmut Prinzler e Enno Patalas (a cura di), Lubitsch, München e Luzern: C. J. Bucher 1984, pp. 60-80. La trasmissione su Lubitsch, come molte altre trasmissioni di analisi cinematografica del WDR, è stata curata redazionalmente da Werner Dütsch. 2. Due versioni: Cinéma, de notre temps: Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, cinéastes (Francia, 2001, 73’), Où gît votre sourire enfoui? (Francia, 2001, 104’). 3. Phantombilder. Zum 100. Geburtstag des Filmregisseurs Friedrich Wilhelm Murnau, Frieda Grafe e Enno Patalas (Germania Ovest, 1988), Meister der Szene. Zu vier Filmen von Josef von Sternberg, Enno Patalas (Germania Ovest, 1994). Sulle produzioni della redazione cinema del WDR vedi l’ampia intervista condotta da Michael Girke con Werner Dütsch, Mit dem Fernsehen das Kino umarmen (Abbracciare il cinema con la televisione), in «Funk Korrespondenz», 54 (2006), vol. 39. 4. «Filmtip»: programma del WDR curata redazionalmente da Helmut Merke. La prima trasmissione è andata in onda il 4 gennaio 1978. Era di Merker stesso e aveva per oggetto L’homme qui aimait les femmes (1977) di François Truffaut. L’ultimo Filmtip, circa 350 trasmissioni dopo, è di Cristina Nord sul film di Christian Petzold Yella, andato in onda il 30 agosto 2007. Vedi al riguardo anche Ekkehard Knörer, Dem Nachdenken eine Spielwiese, in «Die Tageszeitung», 16 luglio 2007. 5. Etwas über [Qualcosa su] “A Corner in Wheat” (Germania Ovest, 1983). Un messaggio dall’epoca in cui c’erano ancora le annunciatrici e negli istituti universitari di comunicazioni c’era gente che in una zona indeterminata sul piano della legge registrava più o meno sistematicamente i programmi televisivi. 6. «Image par Image», Francia, 1988 e seguenti, una serie coordinata da Jean Douchet con analisi fra l’altro di M, Citizen Kane di Orson Welles e La règle du jeu di Jean Renoir. 7. Per esempio Das Wunder des Films di Ekkehard Scheven (Germania Ovest, 1955) in cui diversi documentari didattici su singole fasi della produzione cinematografica sono inseriti in una storia che fa da cornice narrativa in cui è protagonista il regista Helmut Käutner. 8. Per esempio la produzione Warner A Trip thru a Hollywood Studio (USA, 1935, regia di Ralph Staub), che mette in scena una panoramica sul mondo degli studios per poi approdare sul set di un film Warner dove Busby Berkeley sta provando una coreografia. 9. Un esempio tratto dal contesto americano dei cinema d’essai è la serie “Anatomy of a Scene“ prodotta dall’emittente tv Sundance Channel per la televisione e il mercato DVD, in cui il making of della scena di un film viene ricostruito interervistando i realizzatori. 10. Nello specifico Baukunst und Film (Architettura e cinema, 45’, 1976), “Fantasia” (9’, 1978), Etwas über “A Corner in Wheat” (1983), Erich von Stroheim zum Gedächtnis (12’, 1985), Robert Bresson zum 80. Geburtstag (12’, 1987), Drei Minuten in einem Film von Ozu, kommentiert von Helmut Färber (15’, 1988), Dr. Cordelier und Professor Alexis. 2 x Jean Renoir (20’, 1989), Anmerkungen zu Eisensteins “Oktober” (10’, 1995). 11. Il testo della trasmissione di Färber, rivisto e ampliato nel marzo 2003, può essere letto nella rivista «shomingeki», 13-14, primavera-estate 2003, pp. 12. Ivi, p. 15. 13. Alcune editrici francesi di DVD che spesso realizzano per gli extra dei loro film “film che mediano il cinema“: Carlotta Films, Editions Montparnasse, mk2, Studio Canal. In Germania, in particolare Kinowelt offre film analitici negli extra; per esempio con lavori su Smultronstället (Il posto delle fragole) di Ingmar Bergmann e Pursued (Notte senza fine) di Raoul Walsh, realizzati da
Winfried Günther del Frankfurter Filmmuseum: Action, action, action: logische Dinge in logischer Abfolge. Aspekte der Inszenierungsweise von “Pursued“ (Germania, 2005); Ein Traumspiel. Ingmar Bergmans Film “Smultronstället” (Germania, 2006). 14. Film su John Ford (Stagecoach, She Wore A Yellow Ribbon, The Informer), Roberto Rossellini (Il Messia, Francesco giullare di Dio), Max Ophüls (Letters from an Unknown Woman, Madame de…), Otto Preminger (Angel Face), Howard Hawks (The Big Sky). 15. Manny Farber: White Elephant Art vs. Termite Art [1962], in Manny Farber, Negative Space. Manny Farber on the Movies, da Capo Press, New York, pp. 134-144. 16. Bergala è anche l’ideatore di una collana DVD concepita per uso scolastico, L’Eden cinéma. Erano previsti 100 DVD con i materiali più diversi per uso nell’insegnamento scolastico. Vedi il sito web della sezione cinema dell’Ufficio per l’Arte e la Cultura del Scéren CNDP http://www.artsculture.education.fr/cinema/ [26.8.2007]. 17. Le analisi presenti sui DVD della serie L’Eden cinéma non possono perciò essere acquistati attraverso i normali canali commerciali ma vanno richiesti attraverso canali di distribuzione pedagogici. La ragione è spesso un accordo di scambio: la licenza per poter utilizzare le immagini viene ottenuta in cambio del fatto che le società di produzione possono allegare “i film che mediano il cinema” come bonus ai loro DVD commerciali. 18. Il programma statale «Ecole et cinéma» esiste dal 1994 ed è promosso dalla associazione «Les enfants de cinéma». Informazioni al riguardo, anche per reperire Une histoire de plans di Bergala, su questo sito web. http://www.enfants-de-cinema.com [26.8.2007]. 19. Analisi di inquadrature sono al centro dei numerosi “film che mediano il cinema” di Jean Douchet e Bernard Eisenschitz. 20. Alain Bergala: Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schule und anderswo, a cura di Bettina Henzler e Winfried Pauleit, tradotto dal francese da Barbara Heber-Schärer, Marburg: Schüren, 2006, p. 88 (tr. it. L’ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo, Cineteca di Bologna, Bologna 2008). 21. Le altre analisi si riferiscono a una inquadratura dai seguenti film: Moonfleet (Il covo dei contrabbandieri, USA, 1955, Fritz Lang), Peau d’Âne (Francia, 1970, Jacques Demy), Mossafer (Il passeggero, Iran, 1974, Abbas Kiarostami), Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo (Sono nato ma…, Giappone, 1932, Yasujirō Ozu), Ladri di biciclette (Italia, 1948, Vittorio De Sica), La règle du jeu (Francia, 1939, Jean Renoir), Vivre sa vie (Francia, 1962, Jean-Luc Godard), Les vacances de Monsieur Hulot (Francia, 1953, Jacques Tati), La maman et la putain (Francia, 1973, Jean Eustache). 22. Roland Barthes, Lernen und Lehren (Imparare e insegnare, 1975), in Roland Barthes, Das Rauschen der Sprache, tradotto dal francese da Dieter Hornig, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006, pp. 202-205: 203. (Roland Barthes, Il brusio della lingua, Einaudi, Torino 1988, p. 188).
La visione sinottica nel critofilm Alain Bergala La mia personale esperienza del critofilm è nata dall’insoddisfazione di fronte allo schema dominante nella didattica del cinema, uno schema di trasmissione verticale del sapere: l’assunto è che l’insegnante detenga un capitale di sapere che è incaricato di trasmettere a degli uditori “ignoranti”. Quando viene applicato al cinema, questo schema è tutto sbagliato. I discenti non sono mai “ignoranti” come lo si può essere in scienze, storia o matematica, perché ciascuno ha già esperienza del cinema sin dall’infanzia, esperienza vissuta come completa e soddisfacente. Non c’è nessuno che provi la sensazione di una mancanza di sapere quando si tratta di vedere dei film, quindi è assurdo non partire da questa esperienza e da questa competenza di spettatori e non pensare un altro modo di trasmettere il cinema. La mia priorità di base, nella didattica del cinema, è stata di rovesciare il vecchio schema verticale che passava per prima cosa attraverso la parola del maître savant. E se il rapporto didattico maestro-allievi passasse per prima cosa, in una fase iniziale, attraverso l’esperienza e la parola dei discenti? È partendo da questa convinzione che ho elaborato un pensiero sulla messa in relazione fra scene corrispondenti di film e che ho cominciato a realizzare e produrre degli “strumenti” nuovi per poterla implementare. Il principio è semplice, ed eccone un esempio. Copio su un DVD o su una chiavetta USB delle sequenze da questi quattro film: Un posto al sole (A Place in the Sun, 1951) di George Stevens, Match Point (2005) di Woody Allen, Three Times (2005) di Hou Hsiao-hsien e Questa è la mia vita (Vivre sa vie, 1962) di Jean-Luc Godard. Le quattro scene hanno un soggetto in comune: l’incontro amoroso intorno a un tavolo da biliardo (o da ping-pong nel film di Woody Allen).
In una prima fase faccio vedere agli studenti, ragazzi o adulti (il principio rimane lo stesso), le quattro sequenze, senza alcun discorso di sapere preliminare. Dopo la proiezione do subito la parola (senza alcuna mediazione didattica) agli “spettatori”. Le idee circolano. Gli elementi in comune fra le quattro sequenze vengono individuati molto presto: l’incontro amoroso, uno spazio speciale (una grande sala occupata al centro da un oggetto ingombrante, il tavolo da biliardo o da ping-pong), l’intervento di una terza parte che si interpone fra l’uomo e la donna nel momento stesso del loro primo incontro ecc. Anche le differenze vengono colte piuttosto rapidamente: per esempio lo stile affettato di Un posto al sole, agli antipodi dei due piani sequenza di Three Times, lo stile dei dialoghi (o la loro assenza), le differenze nella recitazione e nel tono degli attori. Soltanto a partire da quel momento, quando molte cose essenziali sono state già dette, il docente può cominciare a porre domande più precise, che aiuteranno gli studenti a spingere un po’ più in là la loro analisi. Ad esempio: come filma il regista l’evoluzione dell’intervallo fra l’uomo e la donna? Qual è il ruolo del tavolo in mezzo allo spazio dell’incontro? Come se ne serve il regista per separare o avvicinare i due personaggi? Come mette in scena gli sguardi dei due personaggi? In quale momento dell’incontro amoroso appare il terzo personaggio? Come agisce sullo svolgimento dell’incontro? Ha una funzione di disturbatore o di acceleratore? Queste domande possono avviare una riflessione più generale sulla specificità
dell’incontro amoroso al cinema: quali sono le tappe? Come gestisce il regista l’accorciamento dell’intervallo che porterà al primo contatto fisico tra i due personaggi (più spesso le mani o le labbra)? Le idee dei discenti nascono dall’esperienza della visione comparata delle quattro scene dei film, e ovviamente hanno la forza delle idee trovate da soli, molto più formative di quelle enunciate a priori dal maestro. Una volta che le idee nate dall’esperienza diretta degli studenti sono state enunciate, discusse, affinate, il docente può riprendere in mano la situazione con il suo sapere specifico relativamente a questioni che non hanno più a che fare con l’esperienza diretta del visionamento dei film bensì, per esempio, con la conoscenza dell’evoluzione storica del linguaggio cinematografico. Adesso può trasmettere il proprio sapere, acquisito nel tempo, che costituisce il suo capitale e lo legittima nel ruolo di insegnante, adottando a questo punto uno schema didattico più classico. Può per esempio confrontare, proiettando nuovamente parti delle quattro scene iniziali, i codici del découpage classico degli anni ’50 e le riprese più fluide, con sequenze più lunghe, del cinema moderno di Godard e di Hou Hsiao-hsien, fornendo anche punti di riferimento storici relativi all’evoluzione del linguaggio cinematografico. Può inoltre lanciare una riflessione sulla natura della recitazione dell’attore in film realizzati in epoche diverse. A questo fine dovrebbe identificare brevi momenti dal contenuto identico nei quattro film, come la sorpresa del primo sguardo: la recitazione opta per indicare un colpo di fulmine oppure gioca sulla dissimulazione davanti all’altro rispetto all’emozione provata? Analizzare quindi le modalità secondo le quali gli attori interpretano l’attrazione che l’altro esercita su di loro: negli sguardi, nella postura, nel modo di camminare, nei toni e nel ritmo delle voci. A fine lezione, il docente può chiedere agli studenti che lo desiderano di portare al prossimo incontro (su una chiavetta USB) la sequenza di un incontro amoroso tratta da un film che hanno amato, la quale sarà proiettata davanti alla classe e commentata dai loro colleghi. Verrà fatta spontaneamente una comparazione con le sequenze analizzate la settimana precedente e gli studenti si renderanno conto che ai film appartenenti alla “loro cultura” si applicano gli stessi parametri che a quelli “del docente”. Va da sé che non c’è nulla di miracolosamente “spontaneo” in questa scoperta del cinema da parte degli studenti. La loro esperienza personale e le idee che da essa sono derivate nella loro mente nascono dal lavoro preliminare e dal sapere anteriore del docente, che ha “composto” la tabella comparativa [table
de comparaison] delle sequenze dei quattro film. Per comporre quest’ultima sono necessarie una preesistente cultura cinematografica (un sapere storico, estetico, tematico) e una grande esperienza di insegnamento a questo tipo di “pubblico”, una valutazione dei possibili effetti della proiezione di queste scene ai giovani a cui è rivolta. Nel caso specifico, l’incontro amoroso è uno dei temi più universali del cinema e la sua capacità di attrazione su spettatori di tutte le età e di tutte le culture non è mai stata smentita. Il processo descritto sopra dimostra che il cinema può aiutare a “pensare il cinema” senza che un discorso legato al sapere si appiccichi fin da subito alle immagini mostrate, orientandone se non riducendone la lettura. Nell’esperienza del film messo in relazione con altri film non c’è bisogno di voci fuori campo o commenti affinché nascano delle idee sull’essenza stessa del cinema: lo spazio, l’intervallo tra le figure, la misura e la durata delle inquadrature, la recitazione degli attori, le luci, il découpage. Le idee nate dalla mera esperienza delle sequenze messe a confronto devono in ogni caso passare in un secondo momento attraverso il linguaggio per poter essere condivise e così costituire una piattaforma di pensiero comune per i discenti e il loro insegnante, un ricordo di ciò che hanno capito di ciò che hanno visto. Ma l’esperienza personale, intima, ha preceduto la circolazione della parola, e la percezione dei film è rimasta indenne. Dopo Deleuze e Godard, la frase “il cinema pensa” è diventata uno slogan. Ma che cosa significa esattamente? Che un pensiero può farsi strada nella testa dello spettatore, attraversando certi film, a tutto un altro livello di coscienza rispetto a quello in cui ci limitiamo a consumare la storia che viene raccontata dal film, la psicologia dei personaggi e tutto ciò che ha a che fare con il suo contenuto manifesto. Tali idee sono meno “dirette” dallo svolgimento lineare del film, sono sia più personali sia più universali di quelle di cui parla la sceneggiatura, attingono più in generale a un pensiero sul mondo e sono definite dal mio posto nel mondo nel momento in cui vedo il film. La grande singolarità di queste idee è di nascere direttamente dalle sensazioni, in maniera intuitiva ed entusiasmante (pari al momento dell’atto di creazione per il cineasta), con un calore che deriva dal loro sorgere imprevisto nella coscienza. Un pensiero di questo tipo non ha certo la nettezza dei contorni di un pensiero fatto di parole e resta un po’ nebuloso. Affinché un pensiero allo stato nascente, più intuitivo che deduttivo, si possa fissare nella mente bisogna tornare alle parole, quelle che consentono lo scambio di una parte di tale esperienza, nonostante nel trasmutare quest’ultima in parole – le parole
degli altri – qualcosa della singolarità della mia esperienza, la sua unicità, venga necessariamente tradita o ridotta. Lacan ha fatto una limpida analisi di questo fenomeno. Ecco un altro esempio, apparentemente minimo, ma rappresentativo e irrefutabile, della differenza fra l’enunciare un’idea su un film e il farla provare (a uno spettatore). È una sequenza di Mes petites amoureuses (1974), quella della recita dei bambini. Io posso affermare davanti a un pubblico che nel momento in cui Jean Eustache la gira ha in mente la prima scena di Pickpoket (1959) di Robert Bresson. Vi è descritta la stessa emozione del mettersi alla prova, di eccitazione sessuale, di sfida alle regole sociali. Questa ipotesi, così come viene enunciata in un testo scritto o durante una lezione, resta un’affermazione, una speculazione, da prendere o lasciare. Oppure la posso “mostrare” – e non dimostrare – in modo sensibile e irrefutabile, in pochi secondi, sincronizzando due scene prese dall’uno e dall’altro film (nel mio film Le combat avec l’ange, 2004): le scene che seguono rispettivamente quella in cui il personaggio di Bresson ha avuto il coraggio di infilare la mano nella borsa della donna, a rischio di farsi arrestare dalla polizia, e quella in cui il personaggio di Eustache ha avuto il coraggio di toccare il virginale vestito della bambina che gli sta accanto, accompagnata dalla nonna, a rischio di provocare uno scandalo alla recita. La sequenza di Bresson comincia con il suo borsaiolo con gli occhi chiusi, tutto concentrato sul suo gesto: li riaprirà un istante dopo, come per verificare, dopo un’emozione così intensa, che il mondo non sia crollato. Il ritmo occhi chiusiocchi aperti è quello di un battito del cuore. Eustache costruisce esattamente la stessa scena con lo stesso ritmo nella transizione da occhi chiusi a occhi aperti.
In un critofilm dedicato a Mes petites amoureuses ho fatto vedere molto concretamente questa sovrimpressione “mentale” della scena di Bresson nella testa di Jean Eustache nel momento in cui gira la propria. Grazie alla tecnologia digitale ho agevolmente diviso lo schermo in due strisce orizzontali, mostrando così in tempo reale il perfetto sincronismo fra le scene di Bresson e di Eustache e in particolare il momento in cui i personaggi aprono gli occhi, identico quasi alla frazione di secondo. Questa riflessione, nella mia esperienza analitica e didattica, si è sviluppata parallelamente all’avvento e successiva diffusione del digitale, che nell’approccio del “cinema attraverso il cinema” ha permesso una rivoluzione senza precedenti, ovvero il passaggio dal lineare al sinottico [passage du linéaire au tabulaire]. L’importanza di questa mutazione non si limita a un cambiamento nella tecnica, ma nella storia del cinema costituisce forse la mutazione più grande nel modo stesso di pensare i film nel momento della loro creazione. La mutazione digitale ha accelerato il passaggio del pensiero sul cinema da lineare (la scrittura, il montaggio) a sinottico [d’une pensée linéaire … à une pensée tabulaire du cinéma]. Regista e montatore oggi, per esempio, possono visualizzare sul loro schermo nello stesso momento varie scene dei giornalieri fra le quali scegliere, ma anche l’immagine della colonna sonora e delle sue componenti. Anche l’analisi delle opere cinematografiche e la didattica sono state pesantemente condizionate dalla linearità: potevamo vedere un film (intero o
segmenti di esso) solamente nel suo sviluppo lineare, senza poter fermare le immagini, modificare la velocità di scorrimento, tornare indietro, né tantomeno confrontare diversi film in modo sinottico [mettre tabulairement plusieurs films en rapport]. Lo strumento digitale ha reso facile e quasi istantaneo l’accesso alle copie video (in DVD o su internet) e la selezione di inquadrature o scene tratte da un singolo film o da vari film dando anche la possibilità di mettere queste ultime in relazione fra loro, e infine di realizzare dei critofilm di un tipo nuovo, che accorda una maggiore fiducia alla convinzione che “il cinema pensa” a monte delle parole. Ma la conquista più importante dei critofilm non è tanto quella di rendere conto di un film come opera finita da analizzare, bensì del processo di creazione stesso. Perché la rappresentazione sinottica [le tabulaire], attraverso il pensiero e lo strumento digitale, è più adatta a rendere conto di ciò che succede nella mente del creatore nel momento in cui deve fare delle scelte fra le numerose possibili che gli si offrono. Sappiamo bene che, quando si scrive, le idee, le parole, le frasi arrivano nel nostro cervello contemporaneamente, e che è la costrizione lineare della scrittura che ci obbliga a far passare questi possibili multipli brulicanti attraverso l’imbuto da cui le frasi, le parole, non possono che uscire in fila indiana. Spesso le parole saggiamente allineate tradiscono il modo in cui sono state pensate simultaneamente, con quella gioia, eccitazione e ricchezza entusiasmante della simultaneità alla quale dobbiamo rinunciare a causa della linearità delle frasi e delle sequenze. Ricordiamo che già Mallarmé (Un colpo di dadi mai abolirà il caso) o Apollinaire (Calligrammi) hanno tentato di liberarsi dalla stretta della linearità utilizzando la superficie della pagina come uno spazio sinottico [espace tabulaire]. Nabokov ha scritto parole decisive sul modo in cui il romanzo nasce nella mente dello scrittore, ovvero alla stregua di un quadro e non in forma di concatenazione lineare: «Alla sequenza si arriva solo perché le parole devono essere scritte l’una dopo l’altra su pagine consecutive, come la mente del lettore deve avere il tempo di percorrere tutto il libro, almeno la prima volta che lo legge. Tempo e sequenza non possono esistere nella mente dell’autore perché nessun elemento temporale e nessun elemento spaziale hanno governato la visione iniziale. Se la mente fosse costruita su linee opzionali e se un libro potesse essere letto nel modo in cui un quadro viene percepito dall’occhio, cioè senza il fastidio di lavorare da sinistra a destra e senza l’assurdità degli inizi e delle fini, avremmo il modo ideale di apprezzare un romanzo, perché così l’autore lo ha visto nel momento in cui lo ha concepito» [1].
Quando Godard, un anno dopo Passion (1982), gira Scénario du film Passion (1982) non fa che costruire un dispositivo sinottico [dispositif tabulaire] in cui lui stesso fa parte del quadro, in mezzo alle sue macchine, davanti a uno schermo dove cerca di rendere visibile proprio il modo “non lineare” in cui gli sono venuti simultaneamente in mente idee, immagini, desideri di attori. Quest’ultimo costituisce un prezioso prototipo di critofilm sulla creazione stessa nel cinema.
In seguito, con le Histoire(s) du cinéma (1988-1998), Godard continuerà a percorrere la via maestra dell’esplorazione delle possibilità aperte dalla rappresentazione sinottica digitale [tabulaire numérique]. Continuerà a mettere in rapporto fra di loro, in tutti i modi possibili, materiali eterogenei come dipinti, parole scritte sullo schermo, fotografie, immagini di attualità, film di finzione e così via, mentre nel campo delle immagini cinematografiche continuerà a materializzare coesistenze folgoranti tra le epoche, le tecniche, gli stili. Anche quando brontolava contro il predominio della scrittura nel progetto e nella realizzazione di film, Godard ha sempre saputo che senza le parole non vi è pensiero. Le Histoire(s) du cinéma infatti sono tempestate di parole, frasi, citazioni. Ma a ben guardare i rapporti fra immagini, ralenti e sovrimpressioni in questa opera monumentale che ha impiegato più di dieci anni a comporre, è evidente che la colonna visiva “pensa” già da sé il cinema, il mondo, la storia, la pittura, indipendentemente dalla colonna sonora e dall’incorporazione di scritte nell’immagine. Il cinema non è mai stato così tanto in grado di pensare
con i propri mezzi. Traduzione dal francese di Carla Scura
Note del capitolo: 1. Vladimir Nabokov, “L’arte della letteratura e il senso comune”, Lezioni di letteratura, Garzanti, Milano 1992, p. 443.
I “videosaggi” di Tag Gallagher come paradigma di nuovi modelli di analisi cinematografica Elpidio del Campo Cañizares 1. Raccontare il film Ogni critico cinematografico si confronta quotidianamente con la sfida di criticare un film senza rivelarne la trama. Un lavoro praticamente impossibile e che, nel caso si rinunci a farlo, porta a omettere le questioni legate alla narrazione stessa o alla costruzione drammatica del film. Una delle soluzioni di convenienza a cui si è giunti è quella di identificare in qualche modo la parte che racconta la trama, così che chi non ha visto il film può saltare la parte chiamata comunemente “spoiler” [1]. In questo senso, in generale, il critico cinematografico (ma si potrebbe dire lo stesso per qualsiasi critico d’arte, specialmente letterario) desidererebbe fare il suo discorso dopo che lo spettatore ha visto il film, letto il romanzo, vista l’opera teatrale… Comunque la necessità di raccontare la trama o svelare il finale non è il maggiore inconveniente in cui incorre il critico cinematografico. Senza dubbio la sua maggiore frustrazione deriva dal fatto di dover impiegare un sacco di parole per descrivere, prima di criticare, le immagini, le inquadrature, le sequenze, i suoni… È allo stesso modo possibile dire che il critico vorrebbe non solo che, nel migliore dei casi, il lettore abbia visto recentemente il film ma anche che lo possa avere a sua disposizione in quello stesso momento per vederlo, prima di leggere le sue critiche. A questo si riferisce Tag Gallagher quando parla dei suoi videosaggi che accompagnano le edizioni in DVD dei film trattati: «Uno dei grandi vantaggi di questo tipo di “critica cinematografica” è che il pubblico ha nelle sue mani il film di cui sto parlando. Nei vecchi cattivi tempi, per chiunque scriveva di critica cinematografica era proibito ipotizzare che i lettori avessero visto il film di cui si scriveva (o addirittura che ne avessero sentito parlare), con il risultato che il 90 per cento di tutto ciò che uno scriveva era per spiegare, e spiegare, e spiegare…; per tacere che se uno citava un’inquadratura o una sequenza, doveva dedicare un altro 90 per cento per descrivere l’inquadratura o la sequenza perché i lettori non potevano vederle e queste descrizioni erano sempre una scocciatura, oltretutto fallivano nell’intento di far sì che i lettori potessero immaginare ciò che non potevano vedere» [2].
Anche se la descrizione della trama di un film può essere oggi, in gran parte, elusa: «La trama è già presente nei consigli sui quotidiani. Anche se conosco situazioni lamentevoli di colleghi che hanno scritto la loro critica e poi sono stati richiamati dal giornale perché la ritoccassero visto che non avevano spiegato a sufficienza la trama» osserva Carlos Losilla (García Calvo, 2006). Questa cosa continua a essere una vera maledizione: descrivere un’inquadratura, una scena o un movimento di macchina non è solo un esercizio arduo ma anche un qualcosa di insoddisfacente. La rivendicazione dell’uso del video che fa Gallagher nasce dall’eterna aspirazione del critico cinematografico a non dover spiegare o descrivere inutilmente ciò che il film mostra, per dirigere invece l’attenzione del pubblico su quello che considera importante. Questo è il vero problema con il quale il critico si scontra nel momento di stampare su carta un’analisi cinematografica; e questa difficoltà è sempre esistita. In questo senso Gallagher spiega lo scopo dei suoi interessi in modo molto esplicito e categorico: «Quando ho fatto una critica cinematografica con Final Cut sul mio Mac è stata la prima volta nella mia vita che ho sentito di stare realmente facendo una critica cinematografica» [3]. D’altra parte l’impegno costante di Gallagher è stato sempre quello di poter trattare direttamente l’essenza del linguaggio cinematografico: «Durante mezzo secolo o più, da quando ho iniziato a parlare di cinema, ho sempre voluto confrontarmi con la composizione e il movimento, e di come essi si relazionavano attraverso le inquadrature; quella musica del movimento che, come dice Sirk, è l’emozione dei film». Inoltre, il video non solo gli consente di realizzare quel tipo di analisi con una maggiore precisione ma gli permette anche di condividere con altri la propria esperienza della percezione filmica. 2. Gli inizi È importante sottolineare come i videosaggi realizzati da Tag Gallagher durante l’ultima decade non significhino né un cambiamento né una rottura rispetto al suo modo di intendere la critica cinematografica. Essi sono, semplicemente, la realizzazione della sua aspirazione costante ad avvicinarsi al cinema nel modo più efficace possibile. Anche se Gallagher non è stato il primo a utilizzare l’ingrandimento di fotogrammi nei testi sul cinema, certamente è stato uno dei primi a farne un uso estensivo e importante (a partire da copie in 16mm) [4]. Le riviste di cinema erano contrarie a utilizzare fotogrammi e Gallagher crede che questo fosse dovuto a vari motivi: in primo luogo la loro qualità tecnica non era sufficiente; poi per questioni di copyright (anche se ricorda che già negli anni ’70 i diritti di copyright venivano rispettati o meno a seconda dell’editore in questione); e infine (e questa è la
cosa più importante) perché quasi nessuno capiva la differenza fra l’ingrandimento di un fotogramma e una foto di scena della produzione. È significativo che anche oggi continua a essere praticamente irrilevante l’utilizzo dei fotogrammi nelle analisi delle riviste cartacee di critica cinematografica. Senza dubbio, con l’arrivo di internet le possibilità si sono moltiplicate. L’intuizione di un critico come Adrian Martin ha messo in evidenza questa incongruenza (Díaz y Cáceres, 2006): «Prendiamo per esempio un testo specifico che abbiamo tradotto in inglese e pubblicato in “Rouge”: The Film We Accompany di Raymond Bellour, un’analisi testuale dello splendido melodramma bengalese Meghe dhaka tara (La stella coperta da nuvole, 1960, di Ritwik Ghatak). Quando lo ha pubblicato per la prima volta su «Trafic», Raymond non ha usato immagini (perché questa è la politica editoriale della rivista). Nella versione su «Rouge», impostata in maniera diversa, abbiamo inserito di fianco al testo letteralmente centinaia di fotogrammi presi dal DVD. Abbiamo trasformato il testo in un’opera d’arte a sé stante, creando così nuove relazioni tra l’immagine e il mondo». Il numero 4, 2005, di «Rouge» [5] da una preminenza assoluta delle immagini sul testo, alla ricerca di una critica creativa. La combinazione, slegata totalmente dalla funzione analitica, delle immagini e del testo (quando è stato incluso) ha avuto come conseguenza un insieme di videosaggi che avevano come oggetto quello di sperimentare i limiti dell’interpretazione filmica. «La critica non è più un processo discorsivo, retorico, ma un processo di selezione: non si tratta più di un discorso elaborato ma di uno sguardo esercitato (dal critico in prima istanza e dopo dal lettore)» (López, 2011) [6]. 2.1 L’ambito accademico La necessità di Gallagher di esporre con precisione le analisi e le osservazioni cinematografiche è venuta fuori dalla sua esperienza di docente [7]. «Quando insegnava era sempre un problema mostrare brani di un film, perché si disponeva solamente di una copia in 16mm, cosa che richiedeva molto tempo durante la lezione per giungere alla parte desiderata, accendere il proiettore e mostrarlo una volta, cosa che poi non era sufficiente; ma se cercavi di tornare indietro per ripeterlo rischiavi di danneggiare seriamente la copia. Alcuni professori riunivano gli alunni intorno a una piccola moviola; ma in sostanza era quasi impossibile studiare anche solo un fotogramma durante una lezione, per non parlare dei rapporti fra le inquadrature o quelli dei movimenti, ecc. Quando è arrivato il videoregistratore le cose sono diventate molto più facili. Agli inizi del 1990, utilizzando due Betacam da mezzo pollice, ho fatto un
video di 70’ su Ford (che già trattava, tra gli altri, di Mogambo e Stagecoach); ma ovviamente la qualità visiva era abbastanza povera e allo stesso tempo risultava difficile fare un montaggio preciso». La diffusione dei nastri e dei riproduttori dei diversi formati di videocassette già a metà degli anni ’80 ha consentito un importante miglioramento nelle possibilità dei docenti di cinema. Bloccare un fotogramma o selezionare, in modo relativamente facile, un brano di film ha aperto l’impiego delle fonti audiovisive. Ovviamente l’elaborazione di questi materiali da parte dei professori richiedeva ancora persone e conoscenze tecniche scarsamente diffuse. Oltre alle possibilità tecniche e all’utilizzo che se ne è fatto nel mondo accademico bisogna fare attenzione al fatto che troppo spesso la critica cinematografica ha lasciato in secondo piano lo studio della grammatica filmica. Gallagher sottolinea la scarsità di questo tipo di studio su cui lui investiga: «In generale debbo dire che il lavoro accademico sul cinema durante gli ultimi trent’anni si è disinteressato degli aspetti del film che a me interessano, e io a mia volta mi sono disinteressato della semiologia, delle teorie culturali, della psicoanalisi, ecc. Mi sento più vicino alla scuola storicistica; anche se l’ultima volta (a proposito di Walsh) che ho buttato un occhio sugli scritti di persone che, per esempio, hanno parlato di quando le inquadrature da un punto di vista determinato (tra i personaggi) sono entrate a far parte della grammatica del cinema – inquadrature che, per esempio, sono praticamente inesistenti in Griffith fino alla metà degli anni ’20, anche se senza dubbio Walsh ne fa un uso importante già nel 1915 – non sono riuscito a trovare nulla da nessuna parte». Così possiamo affermare che la continuità che ha avuto il suo lavoro, specialmente nell’ambito accademico, è stata piuttosto scarsa. Un’eccezione può essere data dal lavoro della professoressa Janet Bergstrom che condivide punti di vista cinematografici con Tag Gallagher. Questa professoressa e storica del cinema dell’UCLA ha lavorato su registi come Jean Renoir, Fritz Lang e F.W. Murnau. Su quest’ultimo ha realizzato il documentario Murnau’s “4 Devils”: Traces of a Lost Film, incluso come extra nell’edizione in DVD di Sunrise (Twentieth Century Fox Films, 2003). Bergstrom non solo utilizza durante le lezioni i video di Gallagher ma ha diretto corsi per studenti sul modo di fare video utilizzando i suoi come esempio. 2.2 La critica Quando Gallagher ha iniziato a lavorare con questo tipo di materiale audiovisivo non ricorda se all’interno della critica cinematografica ci fosse qualcuno che stesse facendo qualcosa di simile. Riconosce Andrew Sarris e
Jean-Luc Godard come i critici che più lo hanno influenzato e crede che entrambi, se avessero potuto, avrebbero fatto video in linea con i suoi. In questo senso Gallagher sottolinea che, quando Godard ha realizzato il suo Histoire(s) du cinéma, era già del tempo che aveva smesso di fare il critico, ma riconosce il suo Letter to Jane: an Investigation About a Still (Godard, Gorin, 1972) come un esempio ammirevole. Le sue analisi visive però non sembrano aver incontrato un’eco nell’ambito della critica specializzata: «Qualche mese fa c’è stato un importante congresso sulla critica cinematografica a Chicago durato tre giorni [8] e, da quel che ne so, né io né il tipo di critica che faccio sono stati menzionati; e, per ciò che posso vedere in base al programma, tutto ciò che hanno discusso si basava sulla critica tradizionale esclusivamente attraverso la parola e i testi scritti». Ciononostante occorre chiedersi se sia possibile realizzare questo tipo di critica cinematografica “all’interno” delle riviste o delle pubblicazioni sul cinema. Secondo Gallagher questa è un’opzione molto remota: «No, non credo che questo tipo di critica si possa fare nelle riviste di cinema. Oltre ad aver bisogno di un DVD aggiuntivo, bisognerebbe ottenere le liberatorie, e le case di distribuzione proprietarie dei diritti sono poco comprensive in questo senso se non a costo di spese enormi che nessuna rivista di cinema si può permettere». Questo è senza dubbio il problema principale che nasce con questo tipo di analisi audiovisiva: l’utilizzo di fonti che hanno una proprietà intellettuale. Inutile dire che, specialmente negli Stati Uniti, esiste un forte dibattito sul modo e la legittimità della pubblicazione su internet di materiali protetti dal diritto d’autore. In questo momento si stanno dibattendo al Congresso degli Stati Uniti le leggi PIPA e SOPA la cui approvazione potrebbe alterare completamente il funzionamento del web come lo conosciamo oggi [9]. Il tema dei diritti d’autore non è di poca importanza. Un esempio recente lo possiamo vedere nelle indicazioni che Chris Marker fa a IntermedioDVD, la casa di distribuzione in Spagna delle sue opere, riguardo all’uso che può farne il regista Isaki Lacuesta [10]. Quindi il problema che deriva dalla gestione dei diritti d’autore incide direttamente sulla possibilità che questo tipo di videosaggi possa entrare a far parte di altre pubblicazioni, siano riviste o libri. Ciononostante sembrano essere il complemento ideale, per esempio, delle monografie, e Gallagher ammette che gli piacerebbe sviluppare questo lavoro sulla intera filmografia di un cineasta; ma allo stesso tempo considera che è impossibile farlo se non si può fare affidamento su un editore disposto a pagare i diritti: «Non ha senso fare video se non verranno distribuiti e l’unica maniera di trovare una distribuzione è se si includono come extra del DVD del film in questione». Serva di esempio il caso del video che ha realizzato su Francesco giullare di Dio: «Il primo video che ho
fatto su Roberto Rossellini è stato quello di Francesco giullare di Dio. L’ho realizzato per un editore che lo ha rifiutato perché non gli piaceva la qualità della registrazione della mia voce. Così ho perso l’opportunità di pubblicare questo saggio in quel paese e in alcuni altri. Un’altra possibilità era la Francia, però lì hanno il panico dei diritti d’autore e la casa francese ha detto che le sarebbe costato decine di migliaia di dollari comprare i diritti delle poche dozzine di inserti che avevo usato da altri film di Rossellini… Così alla fine ho mostrato il mio video su Francesco in vari musei di cinema e ho dato qualche copia agli amici, ma questo è stato tutto». La situazione derivata dalla negoziazione di questi diritti d’autore genera alcune situazioni assurde. Ogni paese deve contrattare i diritti di edizione in maniera separata e deve acquisire la propria copia o master del video. «Le case di produzione o di distribuzione tedesche, francesi o spagnole non mettono automaticamente i sottotitoli in inglese anche se questo potrebbe consentire l’aumento delle vendite perché detengono i diritti solo per il proprio mercato». Oltre ai problemi derivanti da questa gestione dei diritti d’autore, bisognerebbe in primo luogo considerare l’attitudine della critica a cercare connessioni con il linguaggio cinematografico. Come segnala Adrian Martin (Díaz y Cáceres, 2006), l’intermedialità può offrire possibilità che permettono la trasmissione di esperienze analoghe e di legami percettivi: «La maggioranza dei momenti più impressionanti e influenti nelle pubblicazioni di critica cinematografica – penso a riviste come “Movie” (Regno Unito), “Bright Ligths” (Stati Uniti), “Admiranda” (Francia), oltre ai “Cahiers du Cinéma” e a “Positif” nei loro periodi iniziali – hanno molto a che vedere, al di là del “contenuto” delle idee scritte, con l’impatto della composizione, del disegno grafico (o “mise en page”), delle relazioni giustapposte dei tipi di carattere, la collocazione delle immagini, gli spazi in bianco e i bordi… Questa grafica è già un tipo di cinema, un gesto verso di esso!». Tuttavia questo non vuol dire che attraverso l’uso della parola scritta soltanto non si possano ottenere esperienze analoghe. Jonathan Rosenbaum, quando è morto lo scrittore, pittore e critico cinematografico Manny Farber, ha scritto: «Il metodo più caratteristico di Farber è impilare queste osservazioni una sopra l’altra o giustapporle in modo disordinato nella superficie della pagina, senza allacciarle a linee narrative o ad argomenti. Dire che non vanno da nessuna parte sarebbe sbagliato, di fatto vanno da tutte le parti, creando un’estensione difficile da maneggiare che si espande oltre la cornice di ciò che tratta» (Rosembaum, 2008).
3. Lo sguardo critico di Gallagher Il termine “videosaggio” riferito ai video di Gallagher non è errato; riflette un punto di vista che lo distingue chiaramente dalla maggioranza dei documentari o reportage sul cinema. Bisogna ricordare che l’utilizzazione del mezzo non è per lui altro che la necessità di ottimizzare il suo discorso, approfittando dell’esperienza diretta che lo spettatore ha dell’immagine e del suono cinematografico. I suoi videosaggi non hanno come obiettivo principale quello di spiegare allo spettatore l’informazione che già è raccolta nei libri (come è abituale nella maggioranza dei documentari di cinema). Ma nemmeno hanno come obiettivo di spiegare la messa in scena o gli elementi della grammatica filmica se non per appoggiare la tesi che difende nella sua analisi. Quando Gallagher, per esempio, commenta uno scavalcamento di campo in una scena di dialogo tra Louise e Fabrizio in I gioielli di Madame de… (Madame de…, Max Ophüls, 1953) è unicamente perché è ciò a cui ricorre il regista per enfatizzare la passione e l’identificazione tra entrambi gli amanti: leitmotiv del suo saggio.
Pertanto, e anche utilizzando e apportando un’importante base documentaria, le sue analisi sono sempre interpretazioni personali con una chiara volontà di presentare il suo particolare punto di vista: «Credo che di fatto la cosa più difficile nel fare critica cinematografica è essere onesti con le proprie emozioni, le proprie esperienze». Potremmo aggiungere che nemmeno prova a nascondere il suo stile come autore. Le ripetizioni insistenti di inquadrature e sequenze o le dissolvenze in nero come elemento di punteggiatura sono modi per cercare la complicità dello spettatore e farlo partecipe della sua percezione personale. Uno stile che è lontano dalla normatività dei tradizionali documentari che espongono o documentano diversi aspetti del film. Tuttavia queste piccole trovate non si antepongono mai al film stesso o
al regista analizzato. Gallagher rimane sempre dietro, in secondo piano, al contrario di ciò che succede, come vedremo dopo, in video più creativi. Un espediente comune, praticamente immediato, quando si lavora con le immagini è aggiungere riferimenti visivi. Gallagher cerca corrispondenze visive nella pittura o in temi propri della storia dell’arte, che acuiscono la percezione dello spettatore. Per esempio, nel video che accompagna Il massacro di Fort Apache (Fort Apache, John Ford, 1948) include le opere di pittori che Ford ha studiato e che gli sono servite di riferimento per creare le sue immagini cinematografiche: Frederic Remington, Charles Russell, Charles Schreyvogel e Harold von Schmidt.
Un altro esempio può essere French Cancan (Jean Renoir, 1954) dove Gallagher stabilisce i parallelismi visivi e storici imprescindibili. In questo modo lo spettatore è cosciente della costruzione dell’artificio visivo e, attraverso questa percezione ampliata, può fruire maggiormente il film.
Tuttavia, come abbiamo già sottolineato, l’uso del mezzo audiovisivo non cambia il suo modo di intendere la critica cinematografica. Il suo metodo di lavoro focalizza lo sforzo nella ricerca documentale; ma anche, e in maniera fondamentale, nell’esperienza estetica della visione ripetuta dei film. «Quando stavo scrivendo il mio libro su Ford, ho visto ogni film molte volte e sono arrivato a elaborare un sistema di annotazioni per segnalare ogni inquadratura, ogni angolazione di ripresa, così che sono arrivato a conoscere i film di Ford sequenza per sequenza, a un livello molto tecnico. Mi mettevo a scrivere sul film – ma allora era molto difficile ottenere fotogrammi (bisognava possedere una copia della pellicola e una camera con una lastra traslucida e un cavalletto per la luce, sviluppare le fotografie, oltretutto carenti da un punto di vista qualitativo) – e dopo affrontavo un altro film, ma revisionando continuamente i capitoli precedenti mentre il lavoro proseguiva. Attualmente faccio lo stesso. Mi hanno chiesto di scrivere qualcosa su Ulmer e mi sono messo a leggere tutto quello che ho potuto, ma la cosa più importante è che ho visto solo film di Ulmer per tre mesi. Oggi, quando realizzo un video, seguo lo stesso processo. Vedo i film varie volte, prendo nota, a volte trovo cose da commentare o cose nei film che posso utilizzare. E dopo converto tutto questo in una specie di storia in video. La parte più difficile è l’inizio: spesso giuro che non tornerò a farlo, e allora il resto del lavoro si rivela a partire da questo momento iniziale, quando trovo per caso
un nuovo punto di partenza. E, perfino se ho visto il film 50 volte nel passato, ne scopro vari elementi splendidi e nuovi».
Gallagher, nel mettere in evidenza l’artificio dell’arte cinematografica, ottiene che il pubblico aumenti la sua esperienza emotiva e intellettuale e crede che ci si possa riuscire unicamente, nel miglior modo possibile, utilizzando il mezzo audiovisivo. «I film sono un’esperienza: quadri e sculture e la declamazione si sommano alla musica e si convertono in balletto». La sua prospettiva critica lo allontana dagli approcci semiotici o linguistici e lo identifica come un difensore della corrente francese della politica degli autori introdotta negli Stati Uniti da Andrew Sarris. In un certo modo questo approccio stabilisce come prioritaria l’esperienza della percezione artistica senza anteporvi la lettura e l’interpretazione dei segni. Gallagher ha scritto nel 2001 un piccolo manifesto dove riassume la sua posizione in difesa della politica degli autori mettendo in discussione le letture semiotiche: «Uno legge una partitura, ascolta musica. Uno può leggere una partitura mentre la ascolta, ma sono attività differenti. Non c’è modo di leggere un film, uno vede e ascolta. Leggere e vedere/ascoltare sono quasi opposti» (Gallagher, 2001). Osservando i video di Gallagher che in Spagna accompagnano le edizioni di Versus possiamo verificare la molteplicità di ricorsi e approcci che offrono: non applica lo stesso metodo di analisi a tutti i film e nemmeno a quelli dello stesso autore. Ogni film sembra che gli chieda un proprio trattamento.
«Il cinema non si può definire perché ci sono sempre nuovi film. Io non credo utile elaborare una teoria che si applichi a ognuno dei film che sono stati realizzati o perfino a tutti i film di finzione di Hollywood. Molti film sono semplicemente film di attori che recitano. In molti film la sceneggiatura è praticamente tutto, o anche, per alcuni, equivale ad ascoltare gli attori recitare. Perfino io, personalmente, oggi ho problemi ad applicare il termine stesso “recitare” tanto a quelli che fanno gli attori nei film di Ophüls quanto a quelli che lo fanno in film più recenti. Penso perciò che la “teoria” dovrebbe cominciare con un solo film». 4. La necessità dell’analisi audiovisiva Se i VHS già permettevano le edizioni duali dei film, l’arrivo del DVD ha reso possibile ancora di più l’inserimento di colonne audio. Questo ha permesso la collocazione di commenti audio sopra le immagini, certamente a fini commerciali. Questa colonna sonora contiene a volte la voce del regista che racconta aspetti delle riprese o del lavoro con gli attori e altre quella di un critico che offre dati sulla realizzazione, sullo stile particolare del regista, sul contesto sociale o artistico… Indipendentemente dai nomi che ci sono dietro questi commenti audio (Adrian Martin ne ha realizzati più di 30 dal 2006 per Madman Entertainment in Australia, alcuni dei quali sono stati utilizzati successivamente da Criterion), essi vengono percepiti come un’interruzione del discorso del film. In momenti precisi si sovrappongono all’audio originale permettendo allo spettatore di entrare e uscire dalla narrazione del film. Evidentemente non ci sono problemi con i diritti delle immagini dei film, i costi di produzione sono nulli e aggiungono un valore a quella edizione del DVD. Ma lo stesso Martin (Díaz y Cáceres, 2006) è cosciente delle sue carenze: «Molti dei grandi critici cinematografici del passato come Jairo Ferreira o Manny Farber sono stati sempre (magari senza saperlo!) i “profeti” di questo nuovo stile di critica: il tipo di scrittura che mettevano in pratica forzava i limiti della mera “letteratura” o giornalismo nel tentativo di evocare questa esperienza multicanale, multi-sensoriale. Analogamente il DVD, se i produttori e gli uomini d’affari permettono che accada, dovrebbe andare di più in questa direzione (il “commento audio” di un critico sopra un film è solo un piccolo, modesto, obbligato inizio)». Ma non è solo la funzione commerciale che spinge all’inclusione di videosaggi o di documentari come extra nei DVD. Le edizioni più curate da parte degli editori (in Spagna possiamo citare Versus Entertainment, Intermedio DVD, Cameo o Avalon) cercano, mediante l’inserimento di questi
contenuti speciali, di rendere più attraente il prodotto; ma se i costi di questi extra aumenteranno non li produrranno più. Tuttavia le possibilità che offrono internet e le nuove tecnologie informatiche risolvono in larga misura queste difficoltà. Le frontiere tra i diversi mezzi si dissolvono, l’esperienza è già audiovisiva: il critico dispone degli stessi mezzi del cineasta. I blog rendono possibile la pubblicazione di materiali che in altro modo non si sarebbero potuti diffondere. L’uso di software di montaggio video ha dato spazio a quello che è stato chiamato video essay. Kevin Lee ha iniziato nel suo blog a commentare i 1000 migliori film secondo la selezione di Shoot Pictures, Don ́ t They?, e subito dopo ha cominciato a montare i suoi stessi video con i commenti realizzandone già più di 50. In ogni video cerca di dirigere l’approccio su un aspetto diverso. Disponiamo del mezzo audiovisivo per trasmettere, criticare e analizzare l’essenza stessa del cinema. Il cammino aperto da Gallagher offre possibilità inesauribili per chi è disposto a percorrerlo. «Ho sempre cercato di sperimentare i film come film e il video mi permette di condividere queste esperienze che prima era quasi impossibile fare. “Perché ti piace Ford?”, mi chiedevano spesso. Come rispondere? Così ho scritto un libro. Però solo con il video si può rispondere davvero». «Revista Comunicación», n. 10, vol. 1, 2012, pp. 1334-1347. Traduzione dallo spagnolo di Pedro Armocida
Note del capitolo: 1. Utile specialmente in internet posto che il lettore possa nascondere/mostrare facilmente il testo inserito sotto la dicitura “spoiler”. Un esempio è il sito Filmaffinity che raccoglie i commenti e le critiche degli utenti registrati [consultato il 13-01-2012]. 2. Intervista realizzata dall’autore a Tag Gallagher il 2 e il 28 gennaio 2012. Tutte le citazioni riferite a Gallagher, se non indicato diversamente, provengono da questa intervista. 3. Intervista realizzata da Tag Gallagher a maggio 2009 per la rivista tedesca «Kunst der Vermittlung» [consultato il 13-01-2012]. 4. Tag Gallagher è un collezionista di copie in 16mm. Possiede una delle due copie esistenti della versione “lunga” di Il grande cielo (The Big Sky, Howard Hawks, 1952) da cui è stata realizzata l’edizione in DVD per Versus nel 2010. 5. Qui si può leggere il manifesto introduttivo di quel numero speciale. 6. La rivista nata da poco «Lumen» pubblica un articolo di Gallagher su Quei loro incontri (Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, 2006) che può essere inserito in questa linea di “pezzi” che aprono le frontiere della scrittura sul cinema http://lumenjournal.org/i-forests/letter-tag/ [consultato il 121-2011]. 7. Ha insegnato all’università di Boston fino al 1992. 8. Gallagher si riferisce al ciclo di conferenze presentato da Block Cinema nel Mary and Leigh Block Museum of Art della Northwestern University, Evanston, Illinois. Si può consultare qui il programma [consultato il 15-01-2012]. Si possono consultare qui le registrazioni audio delle tavole rotonde [consultato il 15-01-2012]. 9. Si possono trovare qui informazioni sulle norme e le ripercussioni che possono avere le leggi PIPA (Protect Intellectual Property Act) e SOPA (Stop Online Piracy Act). 10. «As for the idea for the composite video, you may guess I’m never against experiments. If Isaki Lacuesta wishes to pic bits and pieces from my films, let it be, I practice enough piracy myself to enjoy be pirated». Chris Marker, mail inviata a «Intermedio» il 16 dicembre 2006. Las variaciones Marker (Isaki Lacuesta, 2007) è stato commissionato da Intermedio DVD per inserirlo come extra nel cofanetto Chris Marker ma, una volta realizzato, è stato fatto uscire come film autonomo nelle sale cinematografiche. Anche se, in questo caso, bisogna sottolineare che è stata la stessa casa di produzione ad aver voluto portare avanti il progetto offrendo tutte le facilitazioni.
Bibliografia Díaz, A. y Cáceres, J.D. (2006): “Entrevista: Adrian Martin”, in «Miradas», 51, giugno 2006 [consultato l’11.01.2012]. Gallagher, Tag (2001) “Reading, culture, and auteurs”, in «Screening the Past», 12, 2001 [consultato l’11.01.2012]. Garcí Calvo, Alejandro (2006): “Entrevista: Carlos Losilla”, in «Miradas», 50, maggio 2006 [consultato l’11.01.2012]. López, José Manuel (2011) “Las posibilidades de la critica digital”, in «Transit. Cine y otros desvios», 10, 2011 [consultato l’11.01.2012]. Rosenbaum, Jonathan (2008) “They Drive by Night: The Criticism of Manny Farber”, in Featured Text-Jonathan Rosenbaum.com, 18-8-2008 [consultato l’11.01.2012].
Forme del riuso filmico nel cinema sperimentale. Un inventario personale Federico Rossin Il film di found footage ha una lunga storia: fin dalla metà degli anni ’20 alcuni filmmaker hanno iniziato a usare nei loro film materiale filmico “trovato” rielaborandolo nei più diversi modi. Due possibili forme di categorizzazione si possono tracciare per dare profondità teorica al film di found footage: la prima è quella semplicemente diacronica, un excursus storico come quello delineato da William Wees nel suo indispensabile Recycled Images, e la seconda è quella sincronica, come quella articolata da Nicole Brenez nel suo saggio Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental. Se Wees sottolinea il legame tra la storia e le forme filmiche, tracciando un percorso diretto che va dal modernismo al postmoderno, dal collage all’appropriazione e dall’avanguardia alla televisione, Brenez lavora invece sulla delineazione di una cartografia formale, fornendo un inventario accurato – benché idiosincratico e soggettivo – dei differenti tipi di riuso, ma senza alcuna gerarchia cronologica. Come e in che forme il cinema sperimentale ha riutilizzato materiali del cinema classico per analizzarne il linguaggio, svelandone le retoriche e smascherandone gli assunti ideologici, trasformandosi così da cinema puramente plastico in strumento critico e macchina di pensiero iconico? Abbiamo scelto alcune opere che ci sono care per attraversare, in maniera volutamente disordinata e libera, la storia del riuso dei materiali filmici nel cinema sperimentale, mescolando parti saggistiche a interviste, cercando insomma una forma che restituisca l’operare a collage di cui si scrive. I. Verifica incerta ovvero Eddie Spanier come educatore Per raccontare il valore seminale e unico di Verifica incerta percorreremo le due strade: la prima, quella storica, ci darà l’idea di un percorso lineare, accidentato ma diretto verso il nostro presente; l’approccio formalistico ci aiuterà invece a comprendere e a distinguere le diverse identità dei film che accosteremo all’opera di Alberto Grifi e Gianfranco Baruchello. Verifica incerta è il primo capolavoro del cinema underground italiano: è stato realizzato da due artisti tra il 1963 e il 1964, Grifi – un pittore e un fotografo, ma più tardi il più rivoluzionario e polimorfo dei filmmakers indipendenti italiani – e Baruchello – un pittore concettuale di valore internazionale: così il film dovrebbe essere considerato sia parte del cinema sperimentale italiano
sia parte dell’avanguardia artistica degli anni ’60. Nel 1963 Grifi e Baruchello acquistarono 150.000 metri di pellicola destinati al macero e al riciclaggio per estrarne sali d’argento (circa 40 film hollywoodiani degli anni ’50 girati in CinemaScope) e lavorarono sul materiale per otto mesi, prima selezionandolo e poi rimontandolo con l’ausilio di un vecchio tavolo di montaggio in legno. Il risultato del lungo lavoro – che si può davvero considerare una performance in sé – fu un film della durata di 30 minuti costituito da blocchi di fotogrammi incollati fra loro con del nastro adesivo, una sorta di miscuglio fra un objet trouvé in sé concluso – Duchamp, padre del ready made, era infatti un caro amico di Baruchello e appare più volte nel film – e una striscia di pellicola destinata a essere proiettata. L’idea originaria dei filmmakers era strutturata su una teoria del montaggio basata su numeri casuali e prevedeva la completa distruzione del film al termine della sua prima e unica proiezione: i pezzi di Verifica incerta sarebbero dovuti essere stati distribuiti al pubblico, trasformato dall’evento in testimone di un vero e proprio happening artistico chiamato “Disperse Exclamatory Phase”, una sorta di moderno σπαραγμός dionisiaco che sarebbe potuto piacere ad Ejzenštejn. Solo un altro film dell’underground italiano ha le sue radici più profonde nell’idea di resurrezione e distruzione del materiale, Trasferimento di modulazione di Piero Bargellini (1969), un’altra opera borderline tra arte e cinema condannata a morte dal suo creatore. La prima proiezione di Verifica incerta avvenne a Parigi di fronte a un pubblico di “grandi vecchi” dell’avanguardia, Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, John Cage, pronti a dare la loro benedizione e il loro assenso paterno e amicale al nuovo tipo di film: la distruzione del film non ebbe luogo – per fortuna! – e invece venne stampata una copia in 16mm dall’originale in 35mm e tale trascrizione su un diverso formato venne fatta senza l’uso di una lente Cinemascope, finendo così per aggiungere un’intensa distorsione e uno strano appiattimento alle immagini; per i medesimi problemi anche il suono risultò straniante rispetto alla colonna visiva, completamente fuori sincrono. Secondo la classificazione di Wees Verifica incerta apparterrebbe al film collage modernista marcato da un forte obiettivo polemico: Hollywood e i suoi cliché; il cinema classico americano è attaccato sia come prodotto di un determinato linguaggio sia come serbatoio di gesti e immagini stereotipate. Grifi e Baruchello usano un linguaggio stardardardizzato contro se stesso; in quest’ottica ogni strategia diventa utilizzabile: la duplicazione e l’analogia, lo spiazzamento e la somiglianza, la ripetizione e l’interruzione, la frammentazione e la contrazione. Questo uso complesso del found footage mostra all’opera un montaggio intellettuale completamente nuovo che non
dev’essere confuso e scambiato con quello presente in film di found footage realizzati in precedenza. Ad esempio Verifica Incerta ha poco a che spartire con il genere della parodia: un’opera seminale come Crossing the Great Sagrada di Adrian Brunel del 1924, vero e proprio détournement di un film di viaggio pieno di situazioni prevedibili, che pur adottando strategie interessanti (ad esempio un uso straniante e aggressivo delle didascalie e una conseguente e continua dislocazione cognitiva fra le immagini e le parole) si limita a un distacco sardonico che non mina mai le radici stesse del linguaggio cinematografico, svelando così la fragilità di una scelta unicamente parodistica. Né Verifica Incerta può essere caratterizzato solo come manifesto ideologico, cine-volantino, pamphlet d’intervento come ad esempio voleva essere il film di Henri Storck Histoire du soldat inconnu del 1932, film di montaggio di cinegiornali bellici intriso di umori violentemente antimilitaristi e di sarcasmo anticapitalistico, pieno di idee ma ancora troppo inconsapevolmente tutto dentro alla macchina dell’immaginario bellico. Verifica Incerta è invece più vicino al meraviglioso atto d’amore segreto e sublime per Hollywood quale è Rose Hobart di Joseph Cornell del 1936, rimontaggio di un solo film del 1931 da cui l’artista-cineasta americano ha scelto quasi unicamente le immagini di un’attrice isolandole dal contesto narrativo, abolendo i campi-controcampi (intensificando così il fuori campo), sostituendo la colonna sonora con una musica brasiliana e infine virando in violetto la pellicola: vero e proprio oggetto labirintico ed enigmatico proprio come i collages e le scatole del suo autore, Rose Hobart ipostatizza un’icona attoriale attraverso una demolizione controllata dell’edificio-film, e in ciò sta la differenza con l’opera di Grifi e Baruchello, molto più anarchici e ontologicamente iconoclasti.
Infine un ulteriore confronto può essere fatto con A Movie di Bruce Conner del 1958, sinfonia astratta e spietata che con sarcastici campi-controcampi racconta di un’umanità in preda a violenza e orrori, amplificando con magniloquenza scultorea un montaggio a blocchi potente e senza uscita: là dove Grifi e Baruchello aprono e slabbrano la struttura filmica mostrandone indirettamente anche i nessi storico-economici, Conner reinventa il linguaggio mischiando di tutto (cinegiornali, disegni animati, western, film di guerra, film scientifici, code nere, titoli di testa e di coda) e adottando però un simbolismo arcaico e una visione della vita nihilistica e intemporale.
In Verifica incerta ogni immagine in movimento è stata trasformata nelle sue connessioni spazio-temporali, tolta dal suo contesto e inserita in un’altra serie significante completamente diversa: un nuovo significato, che non ha nulla a che vedere con quello delle “vecchie immagini” – sia come icone provviste di un contenuto simbolico sia come cellule di un organismo filmico più grande – esplode sullo schermo. Il significato preesistente è abolito, le nuove connessioni riempiono con idee spiazzanti lo spazio/tempo vuoto dei cliché di Hollywood: anche lo spettatore è chiamato in causa dalla nuova opera, anzi ne è parte fondamentale nella sua vana ricerca di apprendere un nuovo linguaggio, un nuovo codice, sebbene nulla possa trovare di definitivo per imparare una nuova sintassi che in realtà non esiste più! Perché il vero significato è l’opera in sé, un film ready made! Il film come materiale esisteva già prima, con la sua struttura narrativa, i suoi personaggi, gli attori, la colonna sonora e i colori e Grifi e Baruchello non hanno creato nulla ex novo: ma è l’atto di appropriazione in sé – una vera e propria “azione” artistica – che costruisce Verifica Incerta, che infonde nuovi significati alle vecchie immagini attraverso un processo di distruzione-resurrezione del significato che, con la selezione e il montaggio, giunge ad articolare un nuovo ritmo del tutto artificiale, orchestrando uno spazio-tempo completamente ricostruito. Il montaggio viene investito dell’intero carattere creativo del film: è il puro linguaggio che si dispiega, il puro significante resosi autonomo che proprio negli anni ’60 decostruzione, semiotica e psicoanalisi stavano mettendo al centro dei loro interessi.
All’inizio dell’opera non c’era un piano di lavorazione e nemmeno una sceneggiatura a guidare il processo di montaggio: ironicamente lo script fu l’ultima azione dell’intero processo artistico e venne quindi scritta a film finito; ancora una volta la rottura radicale fra significato e significante emerge e impedisce ogni comparazione profonda con altri film di found footage: il significato del film non è più nel suo contenuto visivo (sebbene vi siano molte connessioni simboliche, molti legami iconografici, ecc.) ma nell’atto stesso di decostruzione e di ricostruzione artificiale in cui anche il caso ha molta parte in causa (e i due filmmaker italiani si dimostrano compagni di strada di Lettristi, Neo-Dadaisti, Fluxus e concettuali che nel medesimo periodo e con paragonabile violenza stavano spazzando via ogni illusione vanamente realistica e sterilmente mimetica dal paesaggio artistico attraverso nuove forme e nuove “azioni”). In questo senso Verifica incerta tocca molti problemi di ontologia artistica che sono ancora oggi al centro della teoria: qual è il ruolo del caso nella produzione artistica? Qual’è la vera identità dell’autore di un’opera? Qual’è la connessione concettuale tra il film come immagine in movimento proiettata e il film come mero oggetto materiale? Il titolo stesso del film di Grifi e Baruchello era e resta un concetto: indica a noi spettatori la necessità di una ricerca, di una verifica da compiersi sugli assunti teorici e materiali della modernità ma senza darci la linearità, la gerarchia, il senso delle opere della tradizione – da qui l’incertezza fondante. Dagli anni ’60 agli anni ’80 il film di found footage ha guadagnato una posizione centrale nel panorama del cinema sperimentale fino a diventare un genere in sé: per uscire dalle sabbie mobili del vuoto intellettualismo di molto cinema strutturale, il found footage è sembrato la via più economica e meno “fredda”, un mezzo che ha permesso ai filmmaker di mantenere vivi i loro legami sia con la tradizione dell’avanguardia sia con il loro amore per il cinema classico e per il film in quanto materiale deperibile e in quanto catalogo infinito di forme cui attingere liberamente. In molti film di found footage di oggi che si dicono eredi di Verifica incerta il cinema viene considerato come un pianeta autosufficiente e in via di sparizione: il rimontaggio segue molto spesso logiche morfologiche che non rispettano né gerarchie cronologiche né strutture simboliche e questo non per replicare il détournement situazionista né per intenti polemico-ideologici (a parte il caso di Craig Baldwin e di alcuni suoi sodali) ma per sviluppare in film-saggi sperimentali un interesse idiosincratico ma vivo per la storia e per l’archivio, malinconici depositi del Moderno e delle sue rovine.
Se compariamo ad esempio Home Stories del 1990 di Matthias Müller [password: shortmovie] al film di Grifi e Baruchello potremo vedere che nel film del regista tedesco la ripetizione ossessiva degli stessi sentimenti divenuti cliché, delle stesse posture dei corpi, degli stessi movimenti di macchina, indica come in Verifica incerta un codice convenzionale e un linguaggio hollywoodiano divenuto “naturale”, ma allo stesso tempo l’intera struttura del film è costruita su di un processo di saturazione che rende omogeneo l’eterogeneo, che unifica il molteplice e che impasta tutti i personaggi in un solo personaggio usando come dispositivi strategici proprio gli stretti codici di rappresentazione, la rigorosa censura e i rigidi dettami produttivi che regolavano Hollywood negli anni ’50 e ’60. Se Grifi e Baruchello distruggevano la trasparenza del cosiddetto linguaggio del cinema svelandone rimossi e volgarità, Müller ci rende consapevoli della trasparenza del montaggio del cinema classico attraverso la sua paradossale intensificazione: un sistema di “super” campo-controcampo ma senza che ci venga mai mostrato davvero il controcampo (allo sguardo non corrisponde mai il suo oggetto). Questa nuova forma di rimontaggio non ha nulla a che vedere con il ready made duchampiamo di Verifica incerta, né con il collage modernista invocato da Theodor Adorno e Peter Bürger come la soluzione rivoluzionaria per l’avanguardia degli anni ’60 e ’70 contro l’emergere del postmodernismo e dei suoi giochetti d’assemblaggio: l’ibridazione, l’impurità, la soggettività e l’ambiguità sembrano aver sostituito l’ironia feroce, la polemica sul linguaggio e la radicalità politica. È il nostro presente e, seppur a contrario, Verifica Incerta ci aiuta ancora a comprenderlo, a combatterlo. II - Phil Solomon ovvero Film per elaborare il lutto Che cosa resta impigliato nelle antenne sensibili degli artisti quando a un secolo ne succede un altro? Come l’angelo della storia di Walter Benjamin ci ha insegnato, non si può definire il presente o il futuro se non volando in avanti ma con le spalle rivolte al passato, senza retorica reazionaria né sterili illusioni progressive. L’ipertecnologico cinema del XXI secolo ci sembra sempre più cieco e senza efficace memoria: quella meravigliosa macchina per creare sogni e decostruirne la sostanza profonda attraverso la forma che è stato il cinema del XX secolo si trasforma sempre più – anche tecnologicamente – in un indistinto mare di effetti mirabolanti che non registra più la realtà né sembra volerne conservare alcuna traccia. Se il grande cinema muore consumato dalle richieste di un’industria imbarbarita, allora dobbiamo trovare altrove il suo presente e il suo avvenire: la sua commovente
resistenza e la sua inattuale bellezza stanno in forme che sfidano l’oblio, in progetti che migrano lontano dai grandi schermi dei cinema multisala dei centri commerciali, in scelte stilistiche che si realizzano con tecniche solo in apparenza desuete. Non si esce dal XX secolo senza aver fatto i conti con la sua storia, senza aver attraversato i suoi orrori e le sue miserie: molto cinema di oggi non ci piace perché è un cinema della rimozione e dell’infantilismo, un cinema che non affronta, né con la forma né con il contenuto, il lutto per un secolo di sconfitte e distruzioni, e pertanto ne resta profondamente e inconsciamente prigioniero. Freud chiamava questo compito ineludibile – per l’arte in primis – Trauerarbeit, lavoro del lutto: è un lavoro lungo e doloroso che ha per scopo il recupero dell’energia psichica – la libido – intrappolata nel rapporto con ciò che si è perduto; finché la libido resta prigioniera del passato non può essere utilizzata nel rapporto con la realtà ed è questo che determina la perdita di interesse per il mondo esterno. Vorremmo un cinema che non rifugga dal Trauerarbeit ma anzi ne faccia la sua forte primaria, un cinema che elabori la propria scomparsa interiorizzando e riflettendo su se stesso, un cinema che si immerga senza paura nelle acque scure di un secolo terribile per riemergerne liberato e liberante, pronto a toccarci di nuovo e nel profondo, pronto a riorganizzare in un nuovo immaginario la realtà. Tra i non numerosi esempi di cineasti che sentiamo appartenere davvero al XXI secolo vorremmo citare Phil Solomon, raro esponente radicale di un cinema del Trauerarbeit che rende possibile una memoria viva del passato e quindi una tensione liberatoria verso il futuro: Solomon non fa cinema industriale, lavora ancora con la pellicola utilizzando il processo del passo-uno, ha innovato alle radici la tecnica per farne uno strumento formale intimamente personale, ha affrontato la storia del XX secolo per aprire un varco di comprensione profonda verso nel nostro presente. Nel suo film Twilight Psalm III: Night of the Meek (2002) Solomon unisce la tecnica del found footage con un uso straordinario dell’optical printer e di trattamenti chimico-fisici della pellicola: quello cui assistiamo è un gorgo ottico e sonoro in cui le immagini completamente rielaborate, stravolte e fiammeggianti di tre bambini minacciati da tre mostri (M di Fritz Lang, Frankenstein di James Whale, Der Golem di Paul Wegener) diventano uno struggente kaddish per il popolo ebraico sterminato nella Shoah. Twilight Psalm III è una vertiginosa e sublime visione che coinvolge autore e spettatore, allo stesso modo presi in un divorante vortice di segni e rovine dell’immaginario e della storia, allo stesso tempo malinconici collezionisti di tracce e di senso dopo la Caduta e il Diluvio. Se l’allegoria e l’analogia poetica sono i principi che per Solomon strutturano costruzione e montaggio, le sostanze più profonde del suo lavoro sono invece
il confine e l’ambiguità: i suoi film attraversano diverse condizioni dell’essere (psiche e corpo, conscio e inconscio, oblio e memoria), opposti mondi (la notte e il giorno, la veglia e il sogno, la realtà e l’utopia), antitetici stati della materia (l’astratto e il concreto, la bidimensionalità e il 3D, il liquido e il solido) raggiungendo un’intensa meditazione sulla forma, una scabra poesia dell’oscuro e del rimosso, unica per intelligenza compositiva e tensione emozionale. Solomon non rifiuta il coinvolgimento emotivo ma lo riarticola all’interno di strutture formali che agitino il pensiero, scuotano la coscienza, muovano alla passione politica: esplora le difficoltà morali, formali e politiche insite nella rappresentazione artistica di un trauma storico epocale, adotta un’ardua complessità formale e una rete infinita di riferimenti iconografici, musicali e poetici. Ma non è un autore postmoderno che gioca con la tradizione mescolandone arbitariamente l’eredità fino a ritornare e a farci ritornare bambini: è un artista che allarga la nostra responsabilità e contemporaneamente la nostra visione, un cineasta per cui il Trauerarbeit è una necessaria operazione metalinguistica e morale. Anche grazie al suo lavoro possiamo conservare una parte del secolo passato per aprirci al nuovo, rispettandone l’alterità senza illusioni di pacificante introiezione, ma sapendo mantenere con il passato un interminabile e determinante lavoro del lutto. Come contravveleno al riuso puramente giocoso del postmoderno, pensiamo dunque che le parole di Phil Solomon siano semplicemente le più giuste. Da dove vieni? Qual’è il percorso che ti ha portato a diventare uno dei filmmaker più interessanti della tua generazione? Sono nato il 3 gennaio 1954 da Sam e Ruth Solomon. Abbiamo vissuto ad Astoria, nel quartiere di Queens a New York fino al 1959, poi ci siamo spostati a Monsey, che è a mezz’ora dal nord di New York, in quella che era la zona residenziale del nascente “baby boom”. C’erano laghi e boschi e strade sterrate – era proprio l’inizio dell’esodo della classe media dalle città. Gli inquilini del mio palazzo appartenevano tutti alla borghesia ebraica, al punto che ci si chiede quanto queste cose fossero pianificate. Ma il punto è che credo che il mio background e la mia identità culturale ebraico-americana abbiano in qualche modo un ruolo negli aspetti ermetici, mistici e alchemici dei miei lavori. Mi sentivo al sicuro, protetto, e nella nuova casa c’era finalmente una stanza tutta per me. Guardando le diapositive e i filmini casalinghi di mio padre mi rendo conto di essere stato un bambino pensieroso e introverso, e ho un ricordo di me spesso ritirato in camera a creare i miei mondi di fantasia con modellini e fumetti, e a guardare la TV. Poi è arrivato il rock e il mio stereo con le cuffie. Rimanevo in camera a lungo in quel periodo…
Al liceo andavo molto bene, ma non potevamo permetterci una scuola privata, così sono andato all’Harpur College (SUNY Binghamton) esattamente al momento giusto della sua storia, alla fine degli anni delle donazioni Rockefeller quando c’era molto denaro investito per assumere nuovi professori e portare artisti in visita. Così ho studiato, una volta o l’altra, con Ken Jacobs, Ernie Gehr, Larry Gottheim, Dan Barnett, Saul Levine, Tony Conrad e Peter Kubelka. Non sapevo nulla del cinema d’avanguardia prima del primo giorno di università (pensavo che i “film d’arte” fossero quelli delle Nouvelles Vagues europee e quelli dei giovani registi americani formati nelle prime scuole di cinema nei tardi anni ’60 e primi ’70). Sapevo poco di arte e musica classica. Ero cresciuto avvolto nella cultura pop americana. Ebbene, il primo giorno Ken (Jacobs, NdA) ci proiettò The Flicker (1965) di Tony Conrad e il mio mondo venne capovolto. Mi occorse molto tempo per capire la mappa di dove e come guardare questo tipo di cinema, ma furono lo studio e la scansione inquadratura per inquadratura di Anticipation of the Night (1958) di Stan Brakhage (dove ho iniziato a comprendere i concetti di metafora visiva e le analogie grafiche nel fotogramma e del taglio di montaggio) e la visione del capolavoro pedagogico di Ken Jacobs Tom, Tom, the Piper’s Son (1969) ad aprirmi occhi e mente e a offrirmi davvero “il percorso”, come lo hai chiamato. La scoperta della stampatrice ottica (giunta dopo che lasciai Binghamton) fu il passo successivo… I tuoi lavori sembrano all’incrocio tra i film di Ken Jacobs e quelli di Stan Brakhage: ma riesci a oltrepassare sia il freddo intellettualismo del cinema strutturale che l’autoindulgente estetica degli home movies. Come potresti definire il tuo tipo di cinema? Questa è un’osservazione che condivido. Ciò che amavo del lavoro di Ken era il suo rigore: la sua ricerca andava oltre la vampata iniziale di eccitazione e raggiungeva qualcosa di molto profondo; amavo il suo senso del meraviglioso, dell’arcano (lo sento sempre dire «guarda questo – fantastico!»). Mi ha insegnato a considerare tutta la storia del cinema con un atteggiamento mentale diverso. Il gesto di usare materiali filmici trovati era frutto di un profondo rispetto per la materia originale e il suo contesto storico, non certo delle disinvolte ironie di ciò che potrei chiamare lo “sciovinismo storico” di molti film di found footage. Ken lavorava con quello che considerava rivelatore, bello o con qualcosa che in qualche modo lo portasse a una verità più profonda, sommersa, proprio grazie all’uso di materiali storici e alle loro trasformazioni. Tom, Tom ha ispirato l’atto di ri-guardare e riconsiderare quello che appare, “l’evidente”… Le performance del Nervous
System create da Ken hanno a che fare con l’estasi e il sublime, qualcosa che ho sempre desiderato nel mio cinema: poter vedere, come farebbe Ken, l’impossibile. Essere disperatamente coinvolti nelle sensazioni prelinguistiche del meraviglioso… Sapevo che avrei dovuto trovare una via attorno a Stan (Brakhage, di cui Phil Solomon è stato collaboratore e amico per oltre un decennio fino alla sua scomparsa nel 2003, NdA). Ero molto attratto da un cinema personale e intimo, ma spesso provo un senso di autocoscienza e imbarazzo quando filmo la realtà nel mondo. I miei film sono profondamente radicati in una biografia e in un’iconografia personali, ma mirano a un approccio al referente più allegorico (e simbolico). Gli anelli più interni dei miei film hanno riferimenti e significati che sono, in un certo modo, segreti e irraggiungibili; ma credo di riuscire a creare visioni oniriche che intercettano le riserve inconsce del pensiero simbolico. Cerco il misterioso e l’inevitabile. Il singolare e l’universale. Immagini che sono cariche di meraviglia e che sembrano sfiorare una certa forma di verità – almeno per me. Così, per rispondere alla tua domanda, il cinema “visionario” (Visionary Film è il titolo di un libro classico sull’underground americano di P. Adams Sitney, NdA) funziona bene per quello che cerco di realizzare. Questo è più o meno il motivo per cui non ci sono titoli di testa o di coda nei miei film. Voglio che le visioni arrivino e se ne vadano, oceaniche, vaporose, organiche… I miei film raccontano storie di uno strano genere, con una logica di montaggio onirica e riverberi poetici in ogni immagine e trattamento della materia. Il materiale filmico “trovato” diventa nelle tue mani il propulsore più forte del lavoro? Oppure lo usi solo come un elemento tra gli altri? Dipende dal film. Con Nocturne, il materiale che avevo girato era la base, e il materiale trovato e rielaborato è arrivato molto più tardi durante il processo di montaggio, quando mi sono accorto di affinità tra le immagini che avevo girato di notte e le sequenze dei bombardamenti notturni della seconda guerra mondiale – cosa che ha reso più ampia di quanto avevo previsto all’inizio la portata di senso del film. E ancora, con What’s Out Tonight is Lost, il materiale trovato è servito da immagine emblematica dell’infanzia che si riverberava sul mio girato nebbioso ed elegiaco delle zone circostanti la casa dei miei genitori. Con The Secret Garden si ha invece un cambiamento radicale nel modo in cui il found footage (The Wizard of Oz e una versione sottotitolata di The Secret Garden) ispira completamente il lavoro, e il materiale girato da me (quasi solo immagini di acqua) agiva da una sorta di
intermediario di immagini edeniche. Remains to Be Seen e The Exquisite Hour sono i film più bilanciati e integrati nella composizione e nell’uso di materiali girati e materiali trovati, ma entrambi i film sono dipesi dal fatto di aver trovato i materiali giusti al momento giusto (le immagini chirurgiche in Remains, gli home movies in 16mm in Exquisite). I Twilight Psalms hanno un approccio completamente differente – invece di aspettare che i materiali trovati trovassero me, ho cercato io immagini specifiche avendo idee a priori. Come avviene tecnicamente il lavoro sul materiale con la stampatrice ottica e i trattamenti chimici? Lavoro sul positivo, rielaboro le immagini fotogramma per fotogramma con trattamenti chimici e organici e poi le rifotografo con la stampatrice. A volte creo delle dissolvenze tra strisce di film che ho rielaborato, altre volte faccio un montaggio con dissolvenze già incorporate nel materiale (che ho già rifotografato). Di solito ci sono molte fasi nel processo e accade che la rifotografia possa avvenire due o tre volte… Quanto spesso scopri nuove cose durante la manipolazione ottica e chimica della pellicola? Questo è il motivo per cui lo chiamano cinema sperimentale – sperimento davvero moltissimo, ma uso solamente i risultati che esprimono al meglio il momento che ho immaginato. Spesso scopro moltissime cose all’inizio di un film o durante un particolare processo che non ho mai provato (come in Twilight Psalm II: Walking Distance), ma poi inizio a padroneggiare la tecnica fino al punto in cui riesco a produrre o a prevedere certi risultati; allora inizio a spingere la cosa più in là, usando variazioni o provando semplicemente le cose. La tremolante fine piena di lacrime di Twilight Psalm III: Night of the Meek mi è arrivata proprio alla fine della fase di riprese – ho provato qualcosa con la stampatrice ottica e ho visto il risultato “in tempo reale”, poi ho immaginato come potesse essere a 24 fotogrammi al secondo. Una volta che ho visto i risultati, li ho incrementati e migliorati. Quanto vuoi controllare questo processo? Suppongo che dovrei rispondere che mi piacerebbe poter controllare completamente il processo, ma ho l’alternativa di scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre ne sto cercando un’altra: insomma la serendipità! Mi piace essere sorpreso da quelli che Stan [Brakhage] chiamava gli «angeli del film», quando mi visitano, ma sono, purtroppo, ossessionato dal controllo e mi piacerebbe essere capace di lavorare con l’emulsione filmica con la
precisione di Vermeer… Di solito quanto penetri nel fotogramma? Come consideri questo passo del lavoro: un’investigazione o uno scavo nella materia? Ancora una volta, dipende dal film. Con The Passage of the Bride, zoomavo spesso con la stampatrice all’interno del fotogramma avvicinandomi quanto più mi era possibile. La stessa cosa è avvenuta con alcune parti di Seasons… (che ho codiretto con Stan Brakhage) e con le sezioni sottotitolate di The Secret Garden. Con Remains to Be Seen e The Exquisite Hour sono sostanzialmente entrato solo per certe inquadrature per isolarne parti ed enfatizzarle. In Remains ho focalizzato il ciclista durante la sequenza in cui appare e ho anche stretto sui riflessi delle persone che camminano attorno al Walden Pond e li ho capovolti per quella che chiamo la sequenza degli “angeli che camminano”. In Exquisite, ho isolato la silhouette dell’uomo nella casa di cura dall’originale Super-8, così diventa molto granulosa. Invece in Night of the Meek l’integralità dei fotogrammi di partenza è stata rispettata quasi completamente. All’inizio è un’investigazione (faccio attenzione a ciò che il materiale mi suggerisce), poi diventa uno scavo (ho bisogno di scavare più a fondo del materiale originale rielaborandolo in qualche modo, aggiungendo strati di ambiguità per arrivare alla verità – così è una sorta di scavo al contrario) e alla fine è un’espressione formale di sentimento. Scrivi un abbozzo di sceneggiatura prima di filmare o scopri sempre nuove cose durante il lavoro? Non una sceneggiatura vera e propria ma tengo un quaderno di appunti e scrivo idee e suggestioni mentre fantastico e vagheggio sul film. Ora sto facendo ricerche per American Falls, l’installazione a 6 schermi che farò a Washington, D.C. nel 2009. Ma la ragione per cui amo questo tipo di filmmaking è perché non è studiato a tavolino e quindi eseguito, ma ha un che di archeologico: lo scoprire antiche e nascoste verità sul “mondo come l’ho scoperto” (“The world as I found it”, cit. dalla versione inglese del Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein, NdA). Mi piace l’avventura di mettere insieme cose che prima non sono mai state sistemate insieme con il fine di svelare quello che chiamo “l’inevitabile ineffabile”. I primi elementi che colpiscono lo spettatore dei tuoi film sono il ritmo, la tessitura delle immagini e una particolare risonanza poetica: la musica, la pittura e la poesia sono gli elementi portanti dell’ispirazione per i tuoi lavori,
il cinema sembra essere meno importante per te… Sì e no. In termini di ritmo e tessitura e metafora, sì, considero la musica, la pittura e la poesia come le fonti per lo svilupparsi dell’ispirazione. Tengo costantemente questi libri aperti nella mia biblioteca, affinché mi tengano compagnia e riaffermino la mia visione – e la mia vocazione. Ma c’è un elemento narrativo in tutto il mio lavoro che proviene direttamente dal mio iniziale amore per il sogno condiviso, collettivo e inconscio dei film della mia infanzia – il meraviglioso! Il magico! Il miracoloso! E soprattutto un senso di favola illusoria, di desiderio, di eterno volere ma non avere… e molti dei miei riferimenti provengono direttamente dai film, in modo particolare nel mio ultimo lavoro (Last Days in a Lonely Place). Ho sempre voluto trovare nel cinema poetico le profondità emozionali che sgorgano, attraverso un intimo riconoscimento, dalle profondità della mia anima nel migliore cinema prosastico-narrativo, ma senza la vergogna di essere manipolato e ipnotizzato in malafede. Uno dei modi con cui definisco l’arte è che tu rimani tu, ed essa rimane essa… una meditazione sulla forma. Con la maggior parte del cinema narrativo non sei più tu… e questo è il grande piacere degli spunti e delle fantasie d’identificazione, ma non è estetica come la intendo io. Tutti i tuoi film hanno una forte struttura poetica con eco metaforiche e allegoriche, temi e variazioni: una poesia dell’oscuro, del nascosto, del rimosso… e, allo stesso tempo, sono aperti all’interpretazione dello spettatore: come lavori sui confini? Ottima esposizione critica. La verità è che non so davvero cosa gli altri vedano nella mia opera. Pochissime persone si sono prese il tempo di andare davvero fino in fondo ai miei film. Vengono visti una o due volte, ma non più di così, mentre io, che insegno cinema all’università da 30 anni, ho visto la maggior parte dei film d’avanguardia almeno 20 o 30 volte. Così cerco davvero di non pensare agli “altri”, dal momento che semplicemente non posso parlare per loro. Il punto è che la proiezione e la ricezione dell’opera sono aspetti vitali, ma secondari del mio processo creativo. È per lo più un fatto sociale per me, che contempla da una parte vari gradi di entusiasmo per “l’essere visto” e “l’ottenere la parola”, e dall’altra un senso di distacco da chi è interessato solo agli aspetti più superficiali di quello che faccio e mi chiede cose come “che prodotti chimici usa?” o “come è riuscito a ottenere questo effetto?”. III - Gianikian e Ricci Lucchi, esploratori del moderno, archeologi del presente Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian sono certamente la coppia di
filmmaker più importante nel vasto e semisommerso mondo del cinema di nonfiction europeo: fin dai primi film degli anni ’70 il loro percorso è caratterizzato da un ripensamento radicale e una serrata critica sia del cinema tradizionale sia di quello cosiddetto sperimentale (un’etichetta troppo facile, quasi a volerli chiudere in un ghetto normalizzante): con il loro lavoro ormai più che trentennale hanno indirettamente mostrato come la finzione similhollywoodiana sia ormai del tutto mummificata in un inutile riproporsi di teatro filmato ed esibizione tecnologica, e viceversa come le neoavanguardie postmoderne siano rimaste impastoiate in un feticistico e impolitico culto per il valore atemporale dell’immagine. A questa stanca e inadeguata alternativa Gianikian-Ricci Lucchi contrappongono un’idea arditamente “anacronistica” di cinema, che fa propria e affina un’artigianale tecnica del cinema sperimentale (il found footage) per reinventarla, rendendola un flessibile e implacabile strumento di conoscenza e una pratica percettiva acuminata e dolorosa per lo spettatore, chiamato continuamente in causa in quanto voyeur da smascherare e soggetto storico responsabile da coinvolgere mai solo emotivamente. Il già citato William C. Wees, che per primo ha dato una definizione teorica del found footage, ha distinto acutamente tre possibilità che si aprono di fronte al filmmaker che adotti tale pratica: una prima è quella del semplice film di compilazione in cui il regista-montatore si limita a cercare una narrazione realistica unendo tra loro spezzoni eterogenei di pellicola senza intervenirvi con scopi estetici evidenti; una seconda è quella del collage modernista che rivoluziona esteticamente e ideologicamente i materiali di base scovandovi una memoria nascosta e latenze storiche e figurali seppellite, mantenendo altresì un amoroso rispetto per i frammenti; la terza è invece quella dell’appropriazione postmodernista e televisiva dell’archivio, visto solo come inerte magazzino di rovine cui attingere senza alcuna reale scelta etica [1]. Che affrontino la violenza imperialista e coloniale (Dal Polo all’Equatore, 1986), la tragedia della Prima Guerra Mondiale (Prigionieri della guerra, 1995; Su tutte le vette è pace, 1998; Oh! Uomo, 2004), il turismo predatorio occidentale (Images d’Orient - Tourisme vandale, 2001; Frammenti elettrici N. 4-5, 2005), la macchina mitologica fascista (Archivi italiani n° 1-2, 1991; Animali criminali, 1994; Lo specchio di Diana, 1996), il genocidio del popolo armeno (Uomini anni vita, 1990), la distruzione della Mitteleuropea (Inventario balcanico, 2000), i film di Gianikian-Ricci Lucchi adottano una struttura temporale “anacronistica” e un periodare modernista centrato sul montaggio di ritmi temporali e figurativi eterogenei: le immagini d’archivio
s’incastrano entro costellazioni-film in cui rime e ripetizioni, stasi e rallentamenti contribuiscono al disvelamento-sovvertimento dei frammenti “trovati”, tornati finalmente a parlarci.
Cedendo a una tentazione storicizzante che poco si concilia con l’operare di Gianikian-Ricci Lucchi, sembra che – guardando in ordine cronologico i loro film – siano passati lentamente da una struttura compositiva a catalogo/collezione con un ordinamento delle immagini essenzialmente analogico (Catalogo 9,5 - Karagöez, 1981) a una struttura dell’opera tendente all’archivio, fondato invece sulla morfologia: quasi che la storicità drammatica delle immagini abbia preso il sopravvento sulla loro pura bellezza e abbia determinato un cambiamento formale – e quindi di ricerca – decisivo per il loro percorso. «L’atlante è una sorta di stazione di depolarizzazione e ripolarizzazione […] in cui le immagini del passato, che hanno perduto il loro significato e sopravvivono come incubi e spettri, sono tenute in sospeso nella penombra in cui il soggetto storico, fra il sonno e la veglia, si confronta con esse per restituire loro la vita – ma anche, per destarsi eventualmente da esse» [2]. Montaggio, memoria, archeologia; Benjamin, Warburg, Foucault: è questo il triangolo “magico” in cui ci pare idealmente muoversi la ricerca di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, al convergere di storia, cinema, genealogia, nel continuo sforzo di circoscrivere nelle immagini ciò che alle immagini continuamente si sottrae, il punto cieco del visibile e il buco nero della storia.
Lavorando anni e anni negli archivi visuali di tutto il mondo, i due filmmaker hanno maturato un amoroso rispetto per la pluralità delle immagini, ognuna marcata da una sua irriducibile singolarità formale, che tuttavia, una volta indagata con gli strumenti dell’analisi [3], consente un’apertura verso orizzonti storico-politici impensati, che ne dischiudono nuovamente la dimensione storica e antropologica. L’intero loro corpus filmico si può anche intendere insomma come una dolorosa meditazione sul complesso rapporto che lega l’umanità al proprio passato e alle figure in cui si è rappresentata: ogni loro film è una pedagogia visuale libertaria che ci permette di tornare a fare esperienza dell’immagine, a trovare l’attenzione per poterla riconoscere, oggi per il domani. «Per noi, come sempre, con i temi delle immagini del passato si sottintende il nuovo» [4]. I dogmi postmoderni di ineffabile e invisibile sono demoliti con assoluto rigore: i film di Gianikian-Ricci Lucchi ci mostrano come le immagini siano rese sempre inguardabili dal potere – di censura –, una pratica negazionista che trova il suo apice nella società dei mass media. Allora il lavoro interminabile sui singoli fotogrammi – la schedatura, la rifotografia, il rallentamento, la penetrazione in profondità, il viraggio (ripristinato o del tutto nuovo) – diviene una costante ricerca del rimosso del nostro passato e una messa in crisi del dispositivo voyeuristico dello spettatore e delle sue certezze psicostoriche: l’Altrove e l’Altro ora ci guardano dallo schermo, rovesciando la prospettiva – coloniale, imperialistica, polemologica, turistica – verso di noi. Attraverso il meticoloso processo analitico e di montaggio «l’immagine è marcata dal presente – la luce della stampatrice ottica letteralmente brilla sulla striscia di pellicola nel presente dal passato – per produrre un’immagine sia del passato che del presente» [5]. Seguendo un sentiero aperto da Adriano Aprà, si può affermare l’appartenenza dei lavori di Gianikian-Ricci Lucchi al continente vasto e inesplorato del cinema saggistico, un cinema che prosegue il dettame ejzenstejniano di visualizzazione di un concetto astratto attraverso il montaggio di immagini appartenenti a serie e sfere semantiche differenti. Insomma molti dei loro film sono pensiero e visione coesistenti in un unico corpo, radicali tentativi di capire l’altrove di immagini, storie, uomini facendone di nuovo vibrare le fibre più intime (la pellicola) perché ci possano parlare del qui e ora. Film-saggio come strumento di comprensione storica e come riflessione lirico-teorica, insomma tra Jean Vigo e Dziga Vertov.
Opporsi al flusso indistinto e irresponsabile della società dello spettacolo, che infinitamente ripete l’immagine fino al punto di non poter essere più guardata davvero e quindi compresa nella sua complessità temporale e segnica, porta verso un cinema di resistenza mai consolatorio o mistificatorio, perché mai apocalittico o autoindulgente – in una parola, postmoderno. La scelta e l’indugio di fronte a una immagine e alle sue stratificazioni comporta nello spettatore la percezione di un tempo altro rispetto a quello della quotidianità, un tempo di attesa e di riconoscimento che si fa tempo perturbante (unheimlich, ciò che spiazza il familiare). La latenza storica (gli eventi nascosti nelle pieghe del film) e l’inconscio figurale (una sorta di psicologia delle forme) si abbracciano e ci rivelano un altro film sotto la pelle-pellicola dopo il lungo e laborioso processo di rielaborazione: l’ambivalenza del reale, la sua irriducibile complessità, può essere accolta solo con questo lavoro duplice – di Gianikian-Ricci Lucchi e dello spettatore. E proprio dal sovvertimento delle caratteristiche del ruolo spettatoriale inizia il processo di ripensamento/sovvertimento dei materiali: se lo spettatore è davvero la figura centrale per comprendere le dinamiche storiche della contemporaneità [6], mostrarne nell’oggi del film le responsabilità di osservatore-testimone significa riportare drammaticamente alla luce la sua connivenza con la visione/versione dei fatti che il potere ha proposto e continua a proporre. La condizione contemporanea del rapporto tra il prodotto del potere e il suo fruitore prevede che lo spettatore sia parte attiva dell’offerta che gli si porge: i film di Gianikian-Ricci Lucchi non riguardano tanto in prima istanza un catalogo di contenuti (la guerra, la morte, la violenza, la religione) quanto piuttosto di relazioni che si costruiscono tra un’immagine e il suo fruitore in un contesto. Sono quelle relazioni e lo scoprire il sistema generale che le salda a spiegare la macchina generativa del vincolo di convinzione, del consenso culturale, dell’ideologia: per procedere a questa ricostruzione è necessaria un’inchiesta stratigrafica delle immagini che colga la storia della loro formazione culturale. Lo spettatore è costantemente chiamato in causa, sia come figura sociale in qualche modo implicata storicamente nella storia degli eventi delle immagini mostrate nei film (stare a guardare lo sterminio…) sia come figura etica cui s’impone di reagire: il campo di tensioni che si sviluppa durante la visione del film (tra le immagini che scorrono e l’immaginario dello spettatore, tra la memoria di celluloide e il rimosso dei traumi) produce allo stesso tempo un completamento dell’opera e una nuova domanda su di essa. Questa dinamica produce sì pensiero e concetti, ma anche immagini da leggere e montare nella mente per trarne estasi formali e nuove associazioni dialettiche: un cinema di
passaggi e non di essenze, un lavoro politico sulla forma di straordinario valore. Nella ricerca di Gianikian-Ricci Lucchi – in modo molto simile al laboratorio loro contemporaneo di Furio Jesi (e anche, per certi aspetti di George L. Mosse) – non è saliente solo l’apparenza del cosa quelle immagini ci raccontano ma chi attraverso quelle immagini parlava a chi: ovvero partire dalla consapevolezza che la tessitura dell’immagine è sempre spia indiziaria del suo uso politico e che il catalogo mostra infine la sua natura di archivio («l’archivio definisce un livello particolare; quello di una pratica che fa sorgere una molteplicità di enunciati come tanti eventi regolari, come tante cose che si offrono al trattamento e alla manipolazione» [7]). Prendere sul serio quelle immagini in funzione della loro proposta di organizzazione simbolica in grado di produrre progetti e vissuti significa seguirne sul tempo lungo le invarianze, le permanenze specifiche, la morfologia, la struttura del loro montaggio, ovvero le condizioni che permettono loro di accreditarsi come verità. Il processo di disvelamento nell’immagine si sviluppa in una temporalità sincronica che manda all’aria tutti i determinismi e gli storicismi (opporre a una morfologia omogeneizzante una morfologia della distinzione): ogni immagine è immessa in una costellazione nuova, in una serie archivistica aperta frutto di un intreccio di ritmi e di tempi eterogenei prima solo virtuali e immaginabili. Gesti e corpi distanti vengono fatti balenare l’uno accanto all’altro, filtrati da una morfologia che non perde per strada la storia: la singolarità irriducibile di ogni fotogramma, di ogni corpo, non è annullata ma coltivata in una acribia di osservazione delle differenze formali e temporali, nelle quali la materialità del fotogramma sopravvive cambiando costantemente di senso. Il lavoro estenuante su di esso non è tanto un semplice «prelievo chimico effettuato sulla sostanza del film» quanto piuttosto «frammento di un secondo testo, il cui essere non eccede mai il frammento; film e fotogramma si ritrovano in un rapporto di palinsesto, senza che si possa dire che l’uno è il disopra dell’altro o che uno è estratto dall’altro» [8]. La sensibilità analogica nell’accostamento dei materiali-documenti non definisce semplicemente una scelta estetica, ma nasce allora come contromossa, come costruzione di «serie differenti, che si giustappongono, si succedono, si accavallano, s’incrociano senza che si possano ridurre a uno schema lineare. Sono comparse così, al posto di quella cronologia continua della ragione che si faceva invariabilmente risalire all’inaccessibile origine, al
suo fondamento iniziale, delle scale talvolta brevi, distinte le une dalle altre, ribelli a una legge unitaria, portatrici spesso di un tipo di storia propria soltanto a ciascuna di esse, e irriducibili al modello generale di una coscienza che acquisisce, progredisce e ricorda» [9]. L’uso del montaggio non cerca la retorica cinematografica della linearità sequenziale e narrativa e della trasparente continuità dei piani; è semmai l’opposto, una modalità di dar vita ad alterità, fratture ritmiche, alla ricerca insomma di differenze non omologabili (a sintomi-sincopi ravvisabili solo ora nel nuovo film) e mai con lo scopo di collezionare variazioni seriali dell’identico precostituito/precotto dalla macchina-cinema. I film di Gianikian-Ricci Lucchi smascherano le mitologie del moderno rivelandone l’aspetto violento e fascinatorio, scoperchiando insomma la macchina mitologica dell’Occidente, quel corpus di forme e figure che ha legittimato (e continua a farlo) imperialismi e guerre: questo vero e proprio processo all’immaginario riesce solo attraverso un meticoloso lavoro sulle immagini d’archivio, in cui operano archeologia, filologia e genealogia ma senza alcun cascame accademico. E questa elaborazione di un’idea visiva avviene senza il bisogno di alcun commento testuale: uno scarto conoscitivo che nasce davanti alla “camera analitica” nel farsi del film, e prosegue nella mente dello spettatore. L’extra-temporalità apocalittica degli esteti è avversata con la massima radicalità: nessuna eternità è postulabile di fronte al massacro degli uomini e a ciò che ne resta in brandelli di immagini, solo un amore doloroso per la metamorfosi della storia è possibile. La morfologia di Gianikian-Ricci Lucchi crea uno shock cognitivo e percettivo che nella mente dello spettatore smantella una pre-visione ingessata e contemporaneamente crea una nuova comprensione (di fatti formali che si danno così mediatamente come fatti storici), un nuovo montaggio di attrazioni per differenza (direbbero sia Ejzenštejn che Warburg, entrambi morfologi mai destoricizzanti). La ripetizione dei gesti, dei corpi, delle morti viste e riviste cela a ogni passaggio una diversità, un portato storico che è carico di irrevocabile terribilità: dimenticarsi di questo scarto significherebbe falciare con una dialettica del sempre medesimo la storia minore e minima, che è invece il rovescio potenzialmente rivoluzionario di quella maxima e totalitaria del potere. «La memoria restituisce al passato la sua possibilità» [10]. Il rapporto fra memoria, storia e immagine è uno dei cardini di questo cinema:
da un lato, con il lavoro sui materiali, si cerca la storia e la memoria nelle immagini, rinsaldando giunte spezzate e raccordando sguardi impossibili; dall’altro le nuove immagini prodotte trovano una loro inedita dimensione memoriale e storica negli spettatori, che così debbono a loro volta lavorare sulla durata e il ricordo: un cinema così sottilmente costruito eppure così aperto all’altro. La scelta – che è anzitutto cura amorosa per la materia – per la singolarità dei fotogrammi, il saperne l’unicità irriproducibile, sta certamente in una storia del cinema sperimentale che ha rifiutato l’idea del cinema come immagine in movimento per poterne disvelare la falsificante potenza ipnotico-seduttiva [11] (da Kurt Kren a Peter Kubelka, da Ken Jacobs a Phil Solomon) ma anche per lavorarne materialmente la carne/la pellicola in ogni suo anfratto e sfatta porzione: singolarità formale e complessità storica si intrecciano vertiginosamente in un lavoro filologico estremamente concreto e del tutto alieno alle pratiche e teoresi di una estetica negativa predominante nel mercato, proprio perché impolitica e mai davvero pericolosa negli immaginari e negli inconsci spettatoriali (si veda ad esempio l’irresponsabile sopravvalutazione dei lavori decadenti e grossolanamente estetizzanti di Bill Morrison, Decasia su tutti). Il punto cieco delle immagini non è mai vuoto, ci ripetono Gianikian-Ricci Lucchi: chi paluda la storia e il suo racconto in retoriche dell’oscurità, dell’irrappresentabilità, dell’indicibilità sta dalla parte di chi quel vuoto l’ha creato e ha tentato e tenta di riempirlo di immagini inutili e –queste sì – vuote. «Alcuni film sono fastidiosi non tanto per la loro intrinseca nullità quanto perché abbiamo la tenace sensazione che nel momento in cui ci opprimono con il loro nirvana di vignette qualcosa di ignobile continui a perpetrarsi. Ci sono immagini […] che esistono solo per renderne altre inimmaginabili. Immagini per distrarre lo sguardo» [12]. Il vero cinema di resistenza ci obbliga a una revisione costante del mondo e di noi stessi, e ancor prima delle modalità di vedere e di vederci, in quel mondo e oggi: fra le poche e vere immagini necessarie, i film di Angela e Yervant sono simultaneamente azione pedagogica e riflessione metalinguistica, per levarci le bende dagli occhi e scegliere, una volta e per sempre. IV - Addenda experimentalia Proponiamo, sotto forma di idiosincratico e personale catalogo di immagini e titoli, una ulteriore genealogia esplorativa del cinema sperimentale come forma di critica cinematografica e politica:
Charles Gagnon, Le Huitième jour (1967) Sára Sándor, Pro Patria (1969) Tadeusz Junak, Epizod (1973) Alan Berliner, Natural History (1983) Basma Alsharif, O, Persecuted (2014) Kelly Sears, The Rancher (2012) Malcolm Le Grice, Berlin Horse (1970) J.J. Murphy, Print Generation (1974) Ernie Gehr, Eureka (1974) Morgan Fisher, Standard Gauge (1984) Peter Tscherkassky, Happy-End (1996) Stan Brakhage, Murder Psalm (1980) Deimantas Narkevičius, Į nežinomybę [Into the Unknown] (2009) Paul Sharits, Epileptic Seizure Comparison (1976) Daniel Eisenberg, Displaced Person (1981) Fabio Scacchioli, Vincenzo Core, Miss Candace Hilligoss’ Flickering Halo (2011) Péter Forgács, Free Fall (Private Hungary 10) (1996) Matthew Buckingham, Situation Leading to a Story (1999) [password: buckinghampreview] Anna Baumgart, Prawdziwe (Lecą żurawie) [Real? (The Cranes Are Flying)] (2001) Christina Battle, Cooper/Bridges Fight (2002) Iván Zulueta, Frank Stein (1972) Les LeVeque, Backwards Birth of a Nation (2000) Kirk Tougas, The Politics of Perception (1973) Marcelo Expósito, Tierra prometida (1992) Joyce Wieland, Betty Ferguson, Barbara’s Blindness (1965) Standish Lawder, Dangling Participle (1970)
Note del capitolo: 1. William C. Wees, Recycled Images: the Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archives, New York 1993. 2. Giorgio Agamben, Ninfe, Torino, Bollati Boringhieri 2007, p. 36. 3. Cfr. il fondamentale scritto autobiografico di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, La nostra camera analitica, in Paolo Mereghetti ed Enrico Nosei (a cura di),






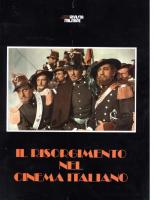


![Per il cinema [Vol. 1]
9788804489412, 8804489413](https://dokumen.pub/img/200x200/per-il-cinema-vol-1-9788804489412-8804489413.jpg)
