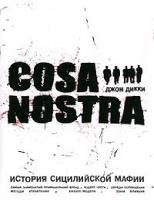Cosa Nostra, Cosa di Stato. Storia delle collusioni tra mafia e istituzioni dalle origini ai giorni nostri 8866522988, 9788866522980
È stato storicamente provato che nel sud, nell'800, l'esercito italiano venne, vinse, decimò e ammazzò più con
121 94 12MB
Italian Pages 320 [289] Year 2015
Polecaj historie
Citation preview
DENTRO LE STORIE
Benito Li Vigni
Cosa Nostra Cosa di Stato Storia delle collusioni tra mafia e istituzioni dalle origini ai giorni nostri
© 2015 SOVERA MULTIMEDIA s.r.l. Via Leon Pancaldo, 26 - 00147 Roma Tel. (06) 5585265 - 5562429 www.soveraedizioni.it e-mail: [email protected] I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.
«Il giudizio morale non cancella né ignora le responsabilità individuali e collettive delle storie raccontate».
«Se non riesci a scoprire la perla con uno o due tuffi, non gettare la colpa sull’oceano; dà la colpa a te stesso, “disse il Maestro”. Non ti sei ancora tuffato abbastanza profondamente». (da “Il Maestro disse”, di Paramahansa Yogananda).
«Ma solo con lo scambio dei doni della Terra otterrete abbondanza e sarete soddisfatti. Perché, fino a quando i bisogni dell’ultimo di voi non saranno stati soddisfatti, il supremo spirito della Terra non dormirà in pace, nel vento». (da “Il Profeta”, di Gilbran Kahlil Gilbran).
«… e le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono pietre». (Carlo Levi Le parole sono pietre).
«A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini». (Giovanni Falcone).
Introduzione
Con l’unità d’Italia, il re ed il suo primo ministro Cavour, annessa all’isola il territorio Nazionale per plebiscito, attraverso una politica fortemente accentratrice, imposero la preminenza piemontese facendo della questione siciliana solo un problema di polizia ed attribuendo ogni turbamento dell’ordine pubblico a rigurgiti borbonici, mene papali e tresche garibaldine. A ragione Filippo Cordova, in un suo discorso del 1863, a questo proposito aveva affermato: “Io credo che un governo, allorquando riceve un paese non dalla conquista ma dalle mani della rivoluzione, debba domandare a se stesso per quali bisogni questa rivoluzione si è fatta. Che cosa voleva il popolo che si è sollevato e pensare in tutti i modi a soddisfare questi bisogni.” L’unità d’Italia con l’affermazione della media e alta borghesia nel ruolo di una nuova classe dirigente, volta all’accumulo di capitali attraverso il protezionismo industriale, agricolo e fondiario, vide l’accentuarsi del dualismo fra regioni in via di espansione economica al Nord, che monopolizzavano le attività imprenditoriali, e un Sud ancora emarginato, colpito da un sistema fiscale inadeguato alla sua realtà e rapinato delle sue risorse. Si pose la “questione meridionale” preferendo considerare il Sud una “palla al piede”. È stato storicamente provato che nel Sud l’esercito italiano venne, vinse, decimò, ammazzò più contadini di quanti soldati perirono in tutte le tre guerre di indipendenza nazionale. Da tutto ciò, nacque l’endemica emarginazione delle masse popolari e l’affermazione di un sistema di sfruttamento di mafia e potere. Benito LiVigni
11
La matita disse al fucile “Io sono più forte di te”
13
1 Le radici del malessere
Le rivoluzioni siciliane della prima metà del 1800 non avevano avuto capi storici. Oscuro protagonista del dramma collettivo le cui svolte, il cui epilogo riconducevano a forme di secolare sottomissione, fu il popolo tutto. La classe dirigente borghese ed i nobili terrieri dalle idee più o meno liberali temevano che il proletariato delle barricate, i disperati del 1820 e del 1848 avrebbero trovato prima o poi l’uomo capace di dare un senso politico alla loro protesta e di assumerne la guida. Per cambiare la società nella forma lasciandone immutata la sostanza le leve del potere, gelose dei loro privilegi, pensavano che l’unica via era di gestire direttamente la rivoluzione antiborbonica lasciando alle masse popolari, che lo volessero o no, il ruolo di comparsa. Nell’uomo che aveva guidato i leggendari Mille, quel Garibaldi che dai balconi municipali di Piazza Pretoria infiammava le folle palermitane: «… il nemico mi ha fatto proposte ignominiose per te, le ho rifiutate…» dialogando con i derelitti da sempre ignorati dal potere, che i governi stranieri chiamavano filibustiere, che passava la notte della vittoria dormendo nell’androne di palazzo Villafranca a piazza Bologna con la testa su una sella, ognuno avrebbe potuto riconoscersi e affidargli le sue speranze di riscatto. Questo «avventuriero» che coltivava un rozzo ma genuino, ed in fondo profetico, socialismo, che dovunque andasse sembrava recare un impalpabile messaggio capace di segnare il corso dei tempi, dove-
15
va essere fermato prima che il suo carisma contagiasse i ceti destinati a servire tacendo. Il Gattopardo avrebbe condensato queste sollecitudini con la lapidaria dichiarazione: «Ma se il Galantuomo lo ha fatto venire quaggiù vuol dire che è sicuro di lui. Lo imbriglieranno». E Vittorio Emanuele II, divenuto re d’Italia «per grazia di Dio e volontà della nazione», secondo la formula adottata dopo un lungo dibattito parlamentare, lo imbrigliò bloccandone l’unica iniziativa valida, la legge sulla distribuzione delle terre ai contadini che, se attuata, avrebbe consentito la formazione di un ceto di piccoli proprietari mai esistito in Sicilia e l’apporto di linfa vitale agli esasperati bisogni del popolo che nel 1860 aveva dato il suo contributo di sangue e mezzi spremendoli dalle esigue risorse per debellare l’odiata tirannide borbonica. Le scariche di fucileria di Bronte ordinate da Bixio, l’eccidio dei contadini che avevano preso possesso simbolico delle terre demaniali e l’esecuzione dell’avvocato Lombardo che li aveva sostenuti, furono il primo avviso del fallimento di tanta attesa. Il re ed il suo primo ministro Cavour, annessa l’isola al territorio nazionale per plebiscito, attraverso una politica fortemente accentratrice, imposero la preminenza piemontese facendo della questione siciliana solo un problema di polizia ed attribuendo ogni turbamento dell’ordine pubblico a rigurgiti borbonici, mene papali e tresche garibaldine. A ragione Filippo Cordova, in un suo discorso del 1863, a questo proposito aveva affermato: «Io credo che un governo, allorquando riceve un paese non dalla conquista ma dalle mani della rivoluzione debba domandare a se stesso per quali bisogni questa rivoluzione si è fatta, che cosa voleva il popolo che si è sollevato e pensare in tutti i modi a soddisfare questi bisogni». L’unità lasciò invece l’isola spoglia perfino delle sue riserve: si diede infatti la paradossale circostanza che nella costituzione del Gran Libro del Debito Pubblico effettuata dal Ricasoli nel 1861, la sola Sicilia contribuisse in attivo con le ricchezze ammucchiate dai Borboni e non impiegate in opere pubbliche le quali trovarono così la via del definitivo «espatrio» a favore di iniziative produttive ed investimenti al nord, fuori dall’area che le aveva generate sulle privazioni dei suoi
16
lavoratori. Più tardi, nel 1881, anche la prima Società di Navigazione Generale Italiana verrà costituita con la flotta Florio e Rubattino nata in Sicilia. Fu introdotto il principio della proprietà illimitata, con la perdita dell’uso civico dei terreni comunali, senza contromisure sociali che ne bilanciassero gli effetti: l’immiserimento progredì ed i grandi agrari, così come i nobili terrieri, ebbero mano libera nelle amministrazioni per trarne vantaggi personali. La mafia, per l’investitura ottenuta con l’aiuto prestato alla classe politica nella lotta antiborbonica, cominciava intanto ad emergere in vasti e solidi centri di potere tanto più che il nuovo sistema rappresentativo le offriva ferrei agganci per motivi elettorali. In questo modo la parte dominante del paese stringeva alleanza con gli esponenti mafiosi firmando una triste cambiale che il popolo siciliano doveva pagare con il ritardo della sua crescita materiale e morale. La monarchia sabauda ed il governo cavouriano inviando a Palermo il La Farina, per porre fine alla dittatura di Garibaldi, bloccarono il processo di sviluppo economico avviato con la promulgazione di importanti leggi quali l’abolizione della tassa sul macinato, la censuazione delle terre, la costruzione della ferrovia Palermo–Messina passante per Caltanissetta, 1’enfiteusi di tutti i beni ecclesiastici. La delusione e la sfiducia nelle nuove istituzioni facevano affermare: «È chiacchiri la leggi italiana». Veniva di contro, nel 1861, ripristinata la coscrizione obbligatoria, che privava la campagna del sostegno delle migliori braccia e faceva scattare per reazione la leva del brigantaggio dei renitenti. I versi di un canto popolare dicevano malinconicamente: «Vittorio Manueli chi facisti la megghiu gioventù ti la pígghiasti!». Così come nel 1720, durante la carestia scoppiata nel periodo della breve dominazione di Vittorio Amedeo II, lo squallore dei tempi aveva coniato il detto: «Pari ca ci passò Casa Savoia». Per il trasferimento dei beni al Nord e per i pesanti provvedimenti fiscali privi di contropartita si cantava «Loro e l’argentu squagghiaru ppi l’aria, di carta la vístèru la Sicilia». Il mancato appello alla leva provocò nel governo reazioni durissime attraverso la legge Pica che prevedeva misure draconiane.
17
Incaricato di combattere il banditismo dei coscritti rifugiatisi nelle montagne fu il generale Govone che intervenne con venti battaglioni per «battere quel che si può di paese in paese arrestando tutti quelli che s’incontrano per la campagna con l’età apparente del renitente e col viso dell’assassino, circondando i paesi e facendo perquisizioni in massa». Il generale Govone ottemperò alla lettera al mandato, effettuò vere spedizioni punitive, mise in stato d’assedio diversi comuni, operò esecuzioni capitali. Durante sei mesi di operazioni militari e di aperte violazioni delle leggi catturò quattromila disertori e fece inviare al confino più di mille persone. La rivista «La Storia Illustrata» del 1863 scriveva: «Si disse che c’erano stati episodi di gente bruciata viva dentro i casolari incendiati dalla truppa e che certi paesi dell’interno dell’isola erano stati privati dell’acqua in piena estate allo scopo di indurre le famiglie a consegnare i renitenti nascosti». Enorme impressione in tutto il paese fece la denuncia del deputato Vito D’Ondes Reggio che accusò il generale Govone di aver fatto torturare con ferri roventi applicati alle mani un povero sordomuto solo per provare che era veramente minorato. Lo stesso D’Ondes Reggio affermava: «Il militarismo in Sicilia aveva fatto strazio dello statuto, delle leggi, della libertà e della vita dei cittadini». Contemporaneamente il deputato siciliano presentava alla Camera una proposta d’inchiesta sull’operato del governo in Sicilia e sugli eccessi già denunciati. La richiesta fu respinta e l’azione militare e poliziesca giudicata perfettamente legale. Così l’incomprensione e la lontananza del nuovo Stato italiano nei confronti della realtà siciliana crearono un profondo malcontento popolare ed alimentarono il fenomeno del brigantaggio corroborato dal sostegno morale di una parte della popolazione che riconosceva al fuorilegge il diritto di esercitare la giustizia così male applicata ed interpretata dal potere. Nelle montagne che circondavano Palermo apparve il brigante calabrese Angelo Pugliesi soprannominato Don Peppino il Lombardo col quale il banditismo cominciò ad organizzarsi e visse la sua era d’oro fra gli anni 1865–1875. Tutto il fenomeno nei suoi aspetti più cospicui si svolse nell’arco di un trentennio circa. Alla scuola del Pu-
18
gliesi si formeranno i briganti Valvo, Di Pasquale, Salpietra e Leone che riempiranno le pagine dell’epoca. La delusione faceva rifiorire nostalgie borboniche contro lo Stato a cui il paese si era consegnato. Una parte del clero colpita dai provvedimenti e dalla soppressione delle corporazioni religiose faceva causa comune coi ribelli, in un primo momento interpreti del malessere popolare ma presto strumenti della mafia rurale impegnata a difendere i privilegi dei grandi agrari contro le masse contadine. Mafia che, secondo gli ideali di giustizia predicati dal nuovo governo, sarebbe dovuta scomparire, e andava invece rinforzandosi per l’ambiguo rapporto di dare e avere intrecciato col potere politico. Il proletariato, tenuto estraneo al decorso degli eventi, gestiti con distacco dall’oligarchia dominante, rispose con la «legge del silenzio» di cui fu matrice più la sfiducia che la paura. Il rifugio nella tanto vituperata omertà ha le radici nel sovvertimento dei valori, del senso di equità che le masse subivano. Diceva un motto popolare: «l’omu ch’è omu nun rrivela mancu se avi corpa di cortella». Questi altri detti siciliani: «quannu c’è lu mortu bisogna pinsari a lu vivu» – oppure – «la tistimonianza è bona sinu a quannu nun fa mali a lu prossimu» – rivelerebbero uno strano pervertimento morale se non vi fossero alla base motivazioni di diffidenza verso un potere sostanzialmente fiscale e repressivo. La collaborazione con una giustizia sommaria, la delazione di un simile accomunato da uguale sconfitta esistenziale, apparivano eticamente assurde secondo la deontologia dell’oppresso. Giovanni Lorenzoni, nell’inchiesta sulla Sicilia affermava: «La Sicilia fu sempre terra di conquista: ma non venne effettivamente vinta mai perché í conquistatori non seppero guadagnare a sé l’anima del popolo che si chiuse in se stessa, nel suo orgoglio e nella sua solitudine, negando fin dove le era possibile le istituzioni impostele e che, per il cattivo modo con cui funzionavano, non potevano nemmeno raccomandarsi al suo rispetto. Per questo l’anima siciliana fu in fondo ribelle sempre, e lo è tuttora. Non per vuota e superba negazione ma per difetto d’amore in chi dalla storia era chiamato a dirigerla e non seppe e non volle comprenderla, pago di domarla esteriormente».
19
L’età delle rivoluzioni aveva ancora dei sussulti: nel 1861 a Caltanissetta si erano avute dimostrazioni ad opera del partito estremista, nel 1862 vi fu la sommossa popolare di Castellammare del Golfo contro i borghesi chiamati «cutrara». A Castellammare il popolo il 1° gennaio 1862 scese in piazza al grido «abbasso la leva, morte ai liberali, viva la repubblica»; si vide inalberata una bandiera rossa. Avvennero scontri sanguinosi con la forza pubblica e vi furono diverse vittime da una parte e dall’altra. La sommossa fu spenta tre giorni dopo con la solita azione di forza. Il 5 gennaio 1862 il supplemento del Giornale Officiale di Sicilia scriveva: «… Il sottoprefetto marciava con l’avanguardia di quel battaglione. Giunto a Castellammare trovò già l’ordine ristabilito, ordinato il disarmo: seppe inoltre che sei dei colpevoli, presi colle armi alle mani e in atto di far fuoco contro le truppe, furono fucilati: di costoro tre non vollero palesare il loro nome, uno fu un triste prete imbracatosi fra quella sanguinosa ribaldaglia». La stessa cronaca precisava inoltre che: «… ridottisi su per la sovrastante montagna i tumultuanti ne furono sloggiati con alcuni colpi di cannone…». A Palermo, specie negli strati più poveri tiranneggiati dalle nuove cosche settarie alimentate in parte dal clero, dalla aristocrazia nera, dai repubblicani e dagli internazionalisti, per la pressione fiscale che privilegiava la classe ricca, per la mancata attuazione di iniziative sociali in alternativa al vecchio sistema caritativo borbonico, con 1’espoliazione dei beni ecclesiastici interpretata come offesa al sentimento religioso, si erano create forti tensioni. Era il settembre del 1866 e la voce popolare diceva: sentu friscura d’aria lu celu è picurinu. Nun c’è spiranza populi la bufera è vicinu. Nonostante gli inquietanti segnali che arrivavano dalla città e dalla provincia (la delinquenza imperversava, gli attentati alla proprietà ed alle persone si moltiplicavano, le autorità venivano aggredite a viso aperto) il prefetto Torelli e il questore Pinna, incerti quanto ambigui, continuavano ad assicurare il governo centrale che la situazione dell’ordine pubblico era sotto controllo. Ma la minaccia che concludeva una poesia su un cartello trovato appeso al collo di una statua di
20
una delle fontane dei quattro canti di Palermo non era certo rassicurante: “Aspittannu stu jornu e nun sa quannu vinnitta si farà, sangu pi sangu”. Anche quando le bande furono alle porte di Palermo si disse, come a voler nascondere la realtà, che trattavasi di un semplice attacco di contrabbandieri. La mattina del 16 settembre del 1866 nell’interno della città iniziarono atti di rivolta con un tentativo di assalto alle carceri dell’Ucciardone per la liberazione dei detenuti. Protagonista fu l’anonima plebe com’era accaduto nel 1820; comparvero bandiere rosse com’era già avvenuto a Castellammare nel 1862. Gli insorti delle campagne, riaffermando l’antica fede separatista, fecero irruzione al grido di guerra: «Ripubbrica e Santa Rusalia!» che somigliava a quello di «muoia il malgoverno» lanciato dai napoletani in rivolta contro aragonesi e spagnoli. E il popolo, ancora una volta, faceva la «sua guerra» spinto non dalle utopie del tempo ma dalla fame e dalla miseria; il saccheggio e il delitto ne erano la logica conseguenza. In poco tempo tutto fu in mano ai ribelli che si abbandonarono alla vendetta, bloccarono le strade principali ed alzarono barricate per ostacolare l’intervento della forza dell’ordine. Da parte dei fomentatori si era contato sul fatto che il governo centrale, impegnato nella terza guerra d’indipendenza da poco scoppiata, non sarebbe potuto intervenire tempestivamente ed infatti per sette giorni e mezzo la rivolta potè sconvolgere la città e per la sua durata venne chiamata laconicamente del «sette e mezzo». Il 22 settembre il generale Cadorna, nominato comandante delle forze militari dell’isola e commissario straordinario del re nella città, entrò a Palermo proclamando lo stato d’assedio ed iniziando una dura repressione. A tal proposito Paolo Alatri affermava: «ben più gravi furono non tanto gli arresti quanto le brutalità che le truppe commisero e peggio ancora le fucilazioni incontrollate dei primi giorni e quelle ancora più raccapriccianti eseguite a sangue freddo perfino dopo la soppressione del Commissariato straordinario e dello stato d’assedio».
21
Una scena della rivolta antiborbonica a Palermo nel 1848
A spegnere i moti collaborò l’ammiraglio Acton, ex ufficiale della marina borbonica, nominato comandante dei reparti da sbarco, che venne insignito della medaglia d’oro al valor militare, più che per i suoi precedenti meriti, a seguito di questa azione diretta non contro un esercito nemico ma contro un popolo affamato, oppresso e martoriato oltre ogni misura. Dopo la rivolta, nell’ottobre dello stesso anno, scoppiò il colera che provocò altri dolori e lutti alla già provata popolazione: la città
22
subì una ulteriore paralisi dei commerci e della vita sociale con l’aggravamento dello stato di miseria degli strati popolari. Ritornarono antichi pregiudizi e la cronaca segnalò che a Bagheria e Monreale «… alcuni popolani hanno di notte tirato fucilate non tanto con lo scopo di aggredire la forza pubblica. ma piuttosto di intimorire i supposti untori… L’autorità ha provveduto opportunamente: l’ordine fu immantinente ristabilito dal presidio…». Nel 1867 venne costituita una commissione parlamentare, per una inchiesta sulle condizioni di Palermo e provincia, la quale svolse i lavori nella capitale dell’isola fra il 16 maggio ed il 1° giugno, in un breve lasso di quindici giorni insufficienti a mettere in luce i fatti ed enuclearne le ragioni, con la palese determinazione di chiudere il caso in fretta riconducendolo a consueti episodi di volgare banditismo. Altre inchieste verranno effettuate negli anni 1875, 1877, 1907, 1963 e 1976 per indagare principalmente sui problemi della mafia, sempre vanificate dalla volontà politica sostenuta da forze economiche reazionarie contrarie alla moralizzazione della vita siciliana. Napoleone Colajanni, denunciando la scandalosa mafiosa ingerenza nelle amministrazioni comunali, esercitata particolarmente durante í periodi elettorali, diceva che: «per combattere e distruggere il regno della mafia è necessario ed indispensabile che il governo italiano cessi di essere il re della mafia». Questa, che attivamente aveva partecipato ai moti del 1848 e 1860, in occasione del «sette e mezzo» si era mantenuta neutrale per rendere un servizio al governo e molti altri ne renderà in seguito al fine di ottenere le contropartite necessarie ad incunearsi nei gangli vitali della vita economica e politica dell’isola. Un notevole sviluppo le organizzazioni settarie avranno con l’avvento della Sinistra nel 1876 la quale, negli anni dell’opposizione, assetata di potere, aveva contratto molti debiti con gli esponenti mafiosi ai quali, arrivata alla guida del paese, dovette elargire adeguati favori. A sua volta la Destra storica, perseguendo accanitamente l’obiettivo del pareggio del bilancio statale, che venne raggiunto verso la fine del suo mandato, aveva adottato la tattica del ministro delle finanze Quintino Sella la cui formula: «economia fino all’osso» portò nuove imposizioni fra cui l’impopolare tassa sul macinato ripristinata nel
23
1868. Il malessere provocò tensioni specie tra le classi meno abbienti alimentando rigurgiti separatisti. Il 9 novembre 1868 si diede notizia del sequestro di un grosso numero di proclami che inneggiavano all’autonomia terminando con queste parole: «Coi teschi de’ nostri nemici edificheremo la solida base sulla quale dovrà sventolare da Capo Faro a Capo Passaro la bandiera dell’Autonomia Siciliana». Vennero arrestati i componenti di un «comitato autonomista» e si disse che uno degli arrestati aveva tentato di recarsi a bordo di alcune navi inglesi alla fonda nel porto di Palermo con l’intento di chiedere protezione (era ancora vivo il ricordo del ruolo degli inglesi nelle rivoluzioni siciliane) a favore del movimento autonomista. La stretta fiscale provocava tensioni per le quali, nel 1874, il ministro Minghetti chiese alla Camera provvedimenti straordinari atti a riportare l’ordine nella provincia «turbata dalla frequenza di omicidi, grassazioni, ricatti, per la presenza di associazioni di briganti, accoltellatori, malandrini, camorristi, mafiosi». In effetti, tra il 1873 ed il 1874, gli omicidi commessi in Sicilia in occasione di furti e rapine erano passati da 42 a 199, gli assassini ed i ferimenti volontari da 339 a 658. Dal 1871 al 1874, 6255 persone erano state ammonite. Tra il 1875 ed il 1876 il parlamento affrontò il dibattito sulle eccezionali misure di pubblica sicurezza da introdurre in Sicilia e venne effettuata un’altra analisi politica sulla mafia ormai divenuta una vera «questione nazionale». Per fronteggiare la gravissima situazione venne mandato a Palermo il prefetto Malusardi. Ma nella classe intellettuale siciliana e lentamente nella coscienza collettiva le idee innovatrici mettevano radici. Nasceva il foglio «Il Povero» organo dell’Internazionale e si costituiva il circolo di propaganda socialista che apriva il colloquio con le altre forze d’avanguardia europea ed inviava un indirizzo ai vinti della Comune di Parigi. Il Sud scrollava il secolare isolamento, stabiliva un’osmosi con le più avanzate teorie del momento. Nel 1876, con i seggi conquistati attraverso i voti del meridione, la Sinistra subentrava al potere accendendo ventate di speranze. Il presidente del nuovo ministero, Depretis, si era impegnato ad una serie di riforme come l’abolizione della tassa sul macinato, che però fu realizzata solo nel 1880, e l’e-
24
stensione a tutti dell’istruzione obbligatoria e gratuita che divenne operante nel 1877 con la legge Coppino. Tuttavia anche le Sinistre poco concedettero alle aspettative popolari. Con il definitivo rafforzarsi dell’onorata società inserita nel tessuto connettivo della pubblica amministrazione e della giustizia il brigantaggio tramontava. La mafia medesima non più interessata ad utilizzare i fuorusciti come strumento di oppressione nelle campagne, li abbandonava al proprio destino e, quando poteva, ne permetteva la cattura da parte delle forze dell’ordine. Con questo aiuto «fratricida» il prefetto Malusardi, al quale il ministro dell’Interno Nicotera aveva dato ampi poteri e funzioni di coordinamento per le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, maggiormente interessate dal fenomeno delle bande armate, poteva sconfiggere il brigantaggio che aveva raggiunto una elevata recrudescenza. Il Malusardi non di rado dimenticò la legalità e permise abusi alle forze di pubblica sicurezza tra le inutili proteste della stampa e dei politici dell’opposizione. Tra il 1876 ed il 1877 le principali organizzazioni di banditi che imperversavano nelle zone occidentali furono debellate. Cadevano uccisi i noti Leone e Rinaldi ed altri principali gregari mentre gli altri componenti delle bande si disperdevano o si costituivano. Giuseppe Alongi nel suo libro «La mafia e le sue manifestazioni» pubblicato a Torino nel 1866, scriveva: «Scorrendo la storia di Sicilia si è notato mai un brigante che non sia finito sulla forca o sotto le palle? Tutti, incominciando da Giangiorgio Lancia impiccato nel 1582 e terminando a Leone ucciso nel 1877, hanno avuto una triste fine. Non uno solo ha potuto morire impunito. L’alta mafia è stata risparmiata da tutti i governi incominciando da quello di Don Rodrigo de Guzman conte di Olivarez e terminando a quello dell’on. Nícotera». Lo stesso Crispi che aveva appoggiato dapprima le istanze dei lavoratori abolendo le limitazioni al diritto di sciopero e sostenendo le casse popolari e le società di mutuo soccorso, scontratosi poi con l’estrema sinistra e con i radicali, temendo l’anarchismo libertario infiltrandosi con Bakunin che, più della direzione di Marx, aveva fatto presa sui proletari esasperati dalle persecuzioni governative, durante il suo secondo ministero divenne un intransigente repressore dei mo-
25
vimenti progressisti. Non per nulla aveva assunto a modello, in politica estera ed interna, il cancelliere di ferro Bismarck. Impegnatosi conflittualmente contro i movimenti operai, prendendo spunto dai disordini scoppiati a Partinico ed a Caltavuturo, dove i contadini avevano invaso per coltivarle le terre abbandonate, ordinò la soppressione dei Fasci dei Lavoratori che si erano organizzati nel 1892 e che nel suo precedente incarico di governo aveva incoraggiato. Il diritto di associazione venne revocato, istituiti tribunali di guerra, inviate le persone sospette a domicilio coatto, fino al proclama di stato d’assedio e l’arresto di De Felice Giuffrida promotore delle leghe bracciantili. La mafia ebbe parte determinante in quest’opera di dissolvimento dei Fasci che, come afferma Massimo Ganci («I Fasci dei Lavoratori in Sicilia», Giornale di Sicilia, 12 febbraio 1975) «erano una sintesi tra la vecchia società di mutuo soccorso e la lega di resistenza e rappresentavano il primo tentativo di dare un’espressione centralizzata ai bisogni delle masse». Debellato il brigantaggio, contenuto nel sorgere il moto sindacale, la mafia diventava dunque una grossa componente della reazione contro le rivendicazioni dei lavoratori. Il clamoroso delitto Notarbartolo, nel 1893, confermava che la mafia si era ormai annidata negli alti livelli del mondo politico e finanziario ed era pronta a colpire chiunque facesse da deterrente alle sue pretese di egemonia, per la moralizzazione della società contro il sistema dei favori. Da parte sua, nell’insensata opposizione al fluire dei tempi, la forza pubblica continuerà nei suoi interventi massacratori: nei soli primi quattro anni del 1900 ucciderà ben 250 lavoratori. Al popolo che si cercava di ricacciare nella secolare acquiescenza, schiacciato da mafia e governo, si apriva la triste via dell’emigrazione, l’esodo doloroso da una realtà senza sbocco per una prospettiva incerta ma piena di speranze. La gente del profondo Sud, siciliani sradicati dalla loro terra assieme a napoletani e calabresi, scaricata come bestiame nei porti d’America e d’Australia, faceva pensare, come scriveva Edmondo De Amicis «che fosse contata per essere venduta e che non passassero davanti cittadini d’uno Stato d’Europa ma vittime di una razzia di ladri di carne umana fatta sopra una spiaggia dell’Africa o
26
dell’Asia, uno spettacolo che rappresentava la fuga di un popolo». Quel popolo che aveva combattuto con Garibaldi al grido di «Viva Vittorio cu la Talia una» avrebbe dovuto sostenere, nel corso del passato secolo, molte altre dure battaglie per aprirsi la strada verso la conquista di un ruolo civile nella società nazionale.
27
2 Latifondo e mafia
La Sicilia, per la sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo, che fu l’unico mare della civiltà occidentale fino alla scoperta delle Americhe, punto di passaggio e di incontro dei popoli che vi gravitavano attorno, oggetto di cupidigia per la fertilità del suo suolo, fu terra di dominazioni, devastazioni, espoliazioni, saccheggi d’ogni genere. Dai Fenici, ai quali essenzialmente servivano i grandi porti naturali dell’isola per i loro commerci, ai greci che, pur realizzando una forte integrazione culturale la ritennero soprattutto terra da colonizzare, ai Cartaginesi che effettuarono una vasta distruzione del territorio e di intere città, ai Romani che, conquistatala, la sfruttarono sia come «granaio» che attraverso pesanti imposizioni fiscali caratterizzate dalle «decime» gravanti su tutta la produzione agricola e da usure e soprusi che provocarono spesso ribellioni popolari, la Sicilia subì attraverso i tempi il gravame delle rapaci dominazioni straniere. Greci, Cartaginesi e Romani divisero la terra in vasti latifondi che assegnarono ai maggiori notabili ed a fidi collaboratori, che si impegnavano a corrispondere contributi in natura ed a coltivare le terre ricevute avvalendosi dell’opera di turbe di schiavi. Goti e Bizantini, barbari gli uni, distanti e toccati da ben altri interessi gli altri, succedutisi nel dominio dell’Isola ai «predoni» romani, mutarono la struttura del latifondo ma attraverso un sistema di governo basato sullo sfruttamento e la corruzione che è stato così sintetizzato da Giorgio Arcoleo (Palermo e la cultura in Sicilia): «Nessun
28
altro popolo discese con tanto precipizio per l’altra parte dell’arco; sotto la dominazione romana e bizantina parve l’ultima e la più reietta delle province: disparvero sino i nomi delle vetuste città. Sciolti i vincoli sociali l’individuo tornò alla campagna quasi selvaggio, vittima della terra, che l’opprimeva più che schiavo con la tirannide del latifondo creato dal dominio lontano: Roma, la Chiesa, Bisanzio, cumulo di favori a chi meglio tiranneggiava persone e coscienze. Il feudo, espressione economica, si spiritualizzò, si filtrò per lungo abito di servaggio nelle menti, sul costume, nella vita intima, separò le classi, le fortune, gli animi». La Sicilia sotto i bizantini divenne caserma e covo di ladroni d’ogni specie in quanto servì solo ai generali dell’imperatore d’Oriente come punto di partenza nella lotta gotica ma non le venne attribuita altra importanza che non fosse strategica per cui gli abitanti dell’isola presero ad odiare come nemici lo Stato, i1 governo, la legge, la società; i germi della ribellione incubarono nel sangue della plebe creando una profonda avversione, nei confronti del potere che li voleva servì o banditi, che avrebbe esteso i suoi rami nel futuro. Gli arabi che tolsero l’isola ai bizantini, violentarono la cultura isolana perché furono convinti ed agguerriti diffusori della loro, notevole ed importante ma di altra matrice. Cambiando tutto, usi, costumi, religione e leggi, contaminando anche la lingua, dopo un periodo iniziale di sanguinose repressioni, allorché su tutte le chiese e tutti i palazzi svettò la mezzaluna come segno dell’avvenuta unificazione, riuscirono ad imporsi in modo così schiacciante da poter poi concedere un sistema di governo più equilibrato e tollerante che lasciò in Sicilia alte vestigia di civiltà. Ma anche i saraceni, come vennero definiti gli arabi in Europa, vessarono gravemente il popolo soggiogato, affidando la custodia del territorio ad un corpo di facinorosi a cui diedero il nome di «falange sacra», il cui mantenimento era esclusivamente sostenuto dai cristiani. E «la falange sacra», apparentemente addetta alla custodia del territorio, in realtà rubava saccheggiando anche le città vicine e ripartendo il bottino con le corti degli Emiri acquiescenti. I Normanni, che conquistarono l’isola attorno al mille, attuarono
29
un sistema feudale di tipo francese che poté consolidarsi grazie alla naturale predisposizione dell’ambiente caratterizzato dal latifondo, sul quale il diritto di proprietà veniva espletato con la più assoluta sovranità. Per consolidare il loro predominio, attuarono un processo di rifeudazione dell’isola cedendo i territori interni che avevano occupato alla nobiltà, ai notabili locali, a coloro che li avevano sostenuti ed aiutati nell’opera di conquista, non disdegnando di vendere i feudi al miglior «offerente». I baroni, nati per investitura o per acquisto della proprietà, provvidero a popolare il feudo utilizzando una popolazione rurale la cui condizione era quella dei servi della gleba: essi avevano la responsabilità dei furti di campagna nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per cui la protezione del feudo veniva affidata a campieri e guardiani armati, vecchi e nuovi delinquenti, che interpretavano in modo estensivo la consegna dei loro padroni. Questa organizzazione privata, nata nel feudo e delegata dal padrone a difendere con la sopraffazione e con la violenza i propri privilegi feudali nelle campagne a danno delle popolazioni rurali, aveva in sé il germe della mafia. Caduta la casa di Svezia, gli Angioini, conquistatori di turno, attuarono in Sicilia un sistema di governo fondato sulle vessazioni e prepotenze in una struttura feudale ormai consolidata nella sua forma di oppressione dei ceti rurali. Con la rivolta dei Vespri siciliani il popolo intese liberarsi dalla tirannia ed ottenere nuove e più giuste forme di governo. Ma la speranza rimase tale in quanto gli Aragonesi perpetuarono il sistema ingiusto ed oppressivo come scrisse Antonio Cutrera ne La mafia e i mafiosi: «alle prepotenze del governo si aggiunsero quelle dei signori, il concetto della giustizia fu questo: ai grandi tutti i diritti, ai miseri tutti i doveri. Del resto questa fu l’epoca vergognosa in cui i signori godettero tutti i diritti, sino a quello dello jus primae noctis». Sotto gli Aragonesi il sistema feudale divenne esca di sanguinosi conflitti fra le nobili famiglie locali e quelle catalane entrate in possesso di una parte dei latifondi; il parlamento, per regolare le gravi dispute sorte, venne ampliato con un braccio demaniale, oltre quello ecclesiastico e militare.
30
Fu Alfonso il Magnanimo a risanare, in parte, la situazione, pacificando i baroni e concedendo franchigie per l’acquisto di terre ad enfiteusi con un miglioramento della produttività e della condizione contadina. Fregiandosi contemporaneamente del titolo di re delle Due Sicilie, che verrà ripreso dai Borboni, ed unificando il meridione, iniziava l’avvicinamento dell’isola al regno di Napoli, creando i presupposti di quella dipendenza dalla quale i siciliani si sarebbero liberati con gravi stenti e dure lotte, alcuni secoli dopo. Divenuta, nel secolo XV vicereame della corona di Spagna, la Sicilia resterà più di due secoli sotto la dominazione iberica e vedrà rafforzato il suo ruolo di semplice baluardo strategico contro il pericolo ottomano che incombeva sulla monarchia regnante, mentre l’ordinamento sociale, incentrato su un ferreo feudalesimo e sul principio del maggiorascato che salvaguardava la concentrazione dei possedimenti, induceva le popolazioni all’abbandono delle terre alla cui coltura i proprietari si dimostravano assai poco interessati. Ottusa religiosità, pomposa magnificenza, lusso sfrenato della nobiltà caratterizzarono il periodo, mentre nelle torture, impiccagioni e roghi, gli organi governativi espressero spietate forme di repressione ed il parlamento, svuotato di autorità, si riunì, sempre più raramente, più che altro per elargire donativi al monarca che pretese elargizioni, anche di 400.000 scudi, da popolazioni segnate da profonda indigenza. Con la dominazione borbonica la Sicilia visse un periodo importante in cui le storture ed i mali della sua società troveranno una radicalizzazione che segnerà l’avvenire dell’isola perché foriera dei futuri rivolgimenti. L’abolizione del feudalesimo, sancita dalla costituzione del 1812, era rimasta semplice enunciazione teorica in quanto l’operazione, da tempo preparata dal baronaggio siciliano, si tradusse in un ulteriore grave danno per il contadino, che rimase spoglio di un diritto da lungo acquisito, ed in un grosso affare per i baroni. Affermava a ragione Ernesto Pontieri (Il tramonto del Baronaggio Siciliano ed. G.C. Sansoni–Firenze, 1943): «Bisogna pur dirlo: l’eversione della feudalità nel Regno di Sicilia fu più teorica che effettiva: coloro stessi che l’avevano sancita furono i primi a frustrarne
31
l’applicazione ed a renderla sterile dei benefici effetti che si potevano sperare». In dispregio alle leggi i baroni continuarono ad esigere i diritti feudali, ad esercitare il monopolio delle derrate, servendosi della loro condizione sociale privilegiata per procacciarsi gli affari col maggior profitto possibile. Convergendo, in tal modo, nella stessa persona del grande terriero, il sistema feudale di produzione e quello capitalistico di scambio, si venne a determinare una contraddizione del sistema stesso, che ebbe come diretta conseguenza prezzi di mercato molto esosi. Ancora sulla abolizione del feudalesimo il Pontieri affermava: «Gli abusi secolari, consacrati dal tempo, ed appoggiati dall’ambizione o dall’interesse non si sradicano con dei semplici atti legislativi. Vi bisogna ancora il concorso efficace del potere esecutivo e la volontà ferma e determinante del governo. Con successive leggi la monarchia borbonica ritornò sull’argomento al fine di ottenere finalmente l’applicazione di tutti i provvedimenti eversivi. Formalmente l’eversione era eseguita ma sostanzialmente non mutarono le condizioni dell’economia e del mondo contadino siciliano. La terra mutava padrone ma non si frazionava, il latifondo di fatto sopravviveva. Le terre vendute da qualche barone disonesto andavano ad aggiungersi ai latifondi di altri ex feudatari o alle proprietà dei gabbellotti arricchiti con l’industria delle grandi affittanze. Restarono immutati gli arcaici sistemi di coltura basati sulla fatica dei bracciantato rurale, restarono immutate le contrattazioni fra proprietari e contadini, restarono in vigore servizi, prelazioni e monopoli giuridicamente abrogati. Restò immutata l’arroganza dei grandi agrari che continuarono ad imporre ai contadini le condizioni che a loro piacevano in cambio della terra che davano a coltivare. I contadini costretti a vendere il loro grano all’indomani del raccolto per far fronte ai loro impegni, erano costretti a cedere il prodotto a mediatori e commercianti che divennero i signori del mercato coalizzandosi con i baroni per fronteggiare la classe rurale. Inoltre i contratti agrari, fortemente vessatori, costringevano il contadino ad indebitarsi col suo padrone a cui dovevano fortissimi interessi».
32
Afferma Michele Pantaleone in Mafia e Politica (Einaudi 1962): «Queste condizioni di miseria e di inospitalità hanno pesato nel lungo corso dei secoli sullo sviluppo economico e sociale ed in breve sul grado di civiltà della zona del feudo, rimasta sempre preclusa ad ogni duraturo contatto con le civiltà che, col succedersi delle diverse occupazioni, si son venute stabilendo nell’Isola, dai Fenici fino ai Borboni, fino al 1860». In questo quadro desolante, caratterizzato dalla cronica carenza di pubblici poteri e dove il padrone esercitava un dominio illimitato sul feudo, anche attribuendo deleghe ad individui estratti dalla classe dei peggiori malfattori, in una società costruita sullo sfruttamento e sulla sopraffazione del più debole, nacque e si sviluppò la mafia che si pose al servizio del potere per difendere i privilegi secolari dei padroni e mantenerne inalterate o accrescerne le rendite stroncando sul nascere e prevenendo, con l’intimidazione e la repressione, i fermenti di rivendicazione del mondo contadino. Le stesse Compagnie d’Armi, istituite dai Borboni con 1’intento di reprimere i delitti nelle campagne, erano in effetti esse stesse strumenti di vessazione nei confronti del mondo rurale, quindi antitesi di quella giustizia che virtualmente rappresentavano. Scrisse a proposito Antonino Cutrera ne La Mafia ed i Mafiosi «… il siciliano nella polizia non trovò mai l’autorità che avrebbe dovuto difenderlo, l’istituzione che avrebbe garantito la sua libertà ed i suoi averi… Continuamente vessato da soprusi e camorre, il suo odio per la polizia, per la legge, per l’autorità pubblica divenne feroce. Per reagire egli si credette in dovere di vivere fuori dalla legge, di servirsi della sua forza, della sua astuzia, se voleva che la giustizia fosse a lui resa». Con l’unità d’Italia, che aveva acceso tante speranze ed aveva avuto l’appoggio perfino degli indipendentisti, le condizioni economiche e sociali dell’isola divennero anche più drammatiche. Le leggi eversive del 1866-67, che spossessavano l’asse ecclesiastico e demaniale generarono un accentramento della proprietà nelle mani di una schiera di nuovi proprietari ai quali venne venduto un notevole numero di lotti di terreno, così che abili accaparratori riuscirono a sostituirsi ai contadini ed a nuovamente deluderli e danneggiarli.
33
A tale proposito Sidney Sonnino affermò: «È triste pensare di quale enorme ricchezza è stato defraudato lo Stato, senza che per questo si giovasse né all’agricoltura né alle classi bisognose, ma contribuendo soltanto a diminuire nelle menti di quelle popolazioni ogni rispetto per le leggi, ogni concetto di equità. È più triste ancora considerare gli effetti di quella censuazione quando si abbiano in mente tutti i benefici che si potevano ritrarre da quella proprietà per la salute economica e morale di quelle province». Anche quei contadini che avevano goduto della cessione di beni ecclesiastici, per mancanza di adeguati mezzi finanziari, per l’assenza di strade, acqua, di una benché minima struttura rurale, per atavica estromissione da ogni accenno di tecniche più avanzate di coltura, non potevano sottoporre le campagne ad uno sfruttamento intensivo e dovevano limitarsi a piantagioni estensive o all’utilizzo dei terreni per pascolo. Finivano quindi per venderli, a poco prezzo, ai latifondisti che accrescevano proprietà e potere. L’incomprensione, la mancanza di programmi organici nel governo centrale, l’attuazione di un sistema legislativo e di una conduzione delle problematiche del Sud fondata sulla presunzione che esistesse in Sicilia una classe media numerosissima, determinarono quello che fu definito «un colossale malinteso». La mafia, nata nel latifondo per la difesa dei privilegi degli agrari, si era coperta di «eroismo» in occasione dei moti rivoluzionari del 1820, 1848 e 1860: le squadre armate dei mafiosi, non ancora definiti tali nell’espressione corrente, dette «bonache», puntualmente ad ogni occasione di rivolta si riversavano dalle campagne nelle città. Si disse che in Sicilia, senza l’aiuto della mafia, non si facevano le rivoluzioni. I governi se ne servirono, quando fu di loro occorrenza. Nel 1848 le «bonache», costituitesi in squadre armate, furono tutte amnistiate dal principe di Satriano, generale borbonico, per non avere ostili gli esponenti di quelle cosche nel rientro delle truppe reali a Palermo. Il comitato rivoluzionario che spianava la strada all’arrivo garibaldino, il 4 aprile 1860, in occasione della tentata sollevazione popolare, aveva chiesto la massiccia partecipazione delle squadre armate della provincia. Scrisse A. Cutrera «ma per la formazione
34
di queste squadre fu necessario che si rivolgessero a nuovi e vecchi capi mafia». Né avrebbe avuto successo l’impresa dei Mille senza il consenso e l’ausilio dell’onorata società che in assenza di un potere legale lo esercitava a mezzo dei suoi «padrini» e di quanti si erano fatto carico abusivamente della gestione della vita pubblica. La mafia ordì le sue trame sul tessuto feudale e latifondistico, ereditato dal nuovo stato italiano, ed al posto delle disciolte Compagnie d’Armi pose le schiere dei suoi adepti. Emersero i gabellotti, personaggi di rispetto, che trasformatisi in proprietari imposero le loro leggi private alle numerose famiglie sottoposte, emersero i campieri, vere e proprie sentinelle del malandrinaggio, strumenti attivi delle prepotenze, delle intimidazioni, delle speculazioni agrarie e commerciali della mafia. Sui campieri, che nelle campagne del palermitano prendevano il nome di curatoli o guardiani, così si esprimeva un rapporto intorno alle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia nel 1874: «Là un curatolo che non abbia omertà, ossia riguardi mafiosi, che sia infame, cioè non isvii sempre le ricerche della forza pubblica, che non avverta i latitanti dell’avvicinarsi di questa, che non occulti i delinquenti, che non mentisca in giudizio, è un curatolo impossibile, o si ritira o muore…». Con l’unificazione nazionale la mafia, trovando condizioni fisiche ideali di ambiente e cultura, emerse e si organizzò anche come strumento di politica elettorale aiutando la classe agiata ad ottenere cariche pubbliche che gestiva all’insegna dell’arricchimento illecito, degli abusi, della corruzione. Con tale evoluzione, trasferendosi dalla campagna alle città, la mafia allargò il suo raggio d’azione, entrò in una dimensione «nazionale» e pretese sempre maggiori contropartite alle sue prestazioni fino a divenire una vera e propria questione di Stato. Nel suo libro Pirandello e la Sicilia Leonardo Sciascia afferma: «E anche la mafia, che sta al brigantaggio come una specie di potere legislativo rispetto all’esecutivo, ha queste origini di protesta e vendetta di classe: origini divenute remote e vaghe nell’attuale carattere e organizzazione».
35
Organizzata in cosche e famiglie si era divisa il territorio in zone di competenza, il rispetto delle quali era intangibile e poteva dar luogo a sanguinose rivalse fra cosche rivali e a vere faide che avevano un loro codice per mantenere il raggiunto equilibrio tra i vari gruppi di potere mafioso. Famosa la contesa nata per mancata osservanza dei limiti di confine ed ingerenza abusiva negli interessi concorrenziali fra gli «stoppaglieri» di Monreale ed i «fratuzzi» di Bagheria. La pretesa di attuare un ordine interno nella illegalità non permetteva di lasciare impunita alcuna violazione delle norme sancite da taciti accordi e codificate verbalmente fra gli appartenenti alla consorteria per i quali era grave violazione di prestigio il commettere omicidi o altre azioni criminali senza la preventiva autorizzazione dei capi o non sottostare alla regola dell’omertà. Le punizioni venivano eseguite secondo una precisa simbologia che Michele Pantaleone ne Il Sasso in bocca così descrive: «… gli occhi cavati e chiusi in un pugno indicano che l’ucciso era un bravo tiratore e si è servito della sua abilità per far fuori persona “amica” o “protetta”; la pala di fico d’India al posto del portafoglio indica la punizione della mafia contro un affiliato che s’era appropriato del denaro comune o comunque di cosa a lui affidata; gli organi genitali appesi al collo costituiscono l’inequivocabile indicazione che l’ucciso aveva tentato, con successo o no, di abusare della donna di un mafioso, in quel momento in carcere». Riferendosi ancora ai simboli della mafia Michele Pantaleone dice che: «la mano tagliata posata sul petto, ad esempio, sta ad indicare che l’ucciso era uno “scassapagghiaru”, che ha rubato mentre sapeva di “non dover rubare perché la zona era protetta”». Il nocciolo del codice morale dei mafiosi era l’omertà, il più importante di una serie di comandamenti che sancivano l’ubbidienza, il silenzio, il rispetto verso la consorteria di appartenenza, la sfida alla giustizia ed all’autorità. E la mafia colpisce chi viola questo codice: il sasso in bocca – come dice Michele Pantaleone – «… è lo sfregio che la mafia compie, sul cadavere di un suo affiliato che si è coperto “d’infamità”, cioè ha rivelato i segreti della mafia». Giuseppe Alongi nel suo libro La mafia e le sue manifesta zioni, pubblicato a Torino nel 1886, ci offre un campionario di detti divenuti
36
proverbiali nel gergo della malavita e costituenti il suo codice d’onore: A cu ti leva lu pani levacci la vita: (a chi ti fa perdere il mezzo per vivere - qualsiasi - levagli la vita); Cappeddu e malu passu dinni beni e stanni arrassu: (Cap pello - per «galantuomo e funzionario» - e mali passi, dinne bene ma stanne lontano); Scupetta e muggheri nun si ‘mprestanu: (fucile e moglie non si prestano, si noti il «fucile» messo prima della mo glie); Si moru mi drivocu, si campu t’allampu: (se muoio sarò sepolto, se sopravvivo ti ucciderò); Vali cchiù n’amicu ‘nchiazza ca cent’unzi’nsacca: (val più un amico influente che cento onte - 1275 lire di quel tempo - in tasca); La furca è pri lu poviru, la giustizia pri li fissa: (la forca è per il povero, la giustizia per i fessi); Cu avi dinari e amicizia teni ‘nculu la giustizia: (chi ha denari ed amicizia tiene in scacco la giustizia); Zoccu nun ti apparteni né mali, né beni: (di ciò che non ti appartiene non dire male né bene); Quannu c’è lu mortu bisogna pinsari a lu vivu: (quando c’è un morto bisogna pensare ad aiutare il vivo); La tistimuníanza è bona sino a quannu nun fa mali a lu prossimu: (la testimonianza è buona finché non fa male al prossimo); Cu mori si drivoca, cu campa si marita: (chi muore va sepolto, chi vive prende moglie); Carzeri, malatíi e nicissità provanu lu cori di 1’amici: (carce re, malattie e disgrazie, provano il cuore degli amici). Nel complesso quadro della criminalità del mondo rurale, un delitto caratteristico, che affonda le sue radici nelle condizioni sociali ed ambientali, era il furto di bestiame o abigeato, oggi quasi estinto ma che in Sicilia costituì a lungo una delle forme tradizionali di attività della vecchia mafia agricola ed al riguardo si può affermare che gli studi su questa e sul brigantaggio sono sempre stati fondati su ricerche socio economiche riguardanti tale reato. I provvedimenti di legge volti a stroncare il traffico di bestiame asportato ai proprietari, non trovarono in tutto il secolo scorso pratica
37
attuazione per la difficoltà di applicarli e farli rispettare in un ambiente permeato di omertà in cui si offriva protezione agli esecutori materiali del ratto e si falsificavano le marchiature che, fino a non molti anni addietro, si potevano ancora osservare sugli animali, praticate allo scopo di vanificarne la sottrazione ai legittimi proprietari. Le Compagnie d’Armi, istituite dai Borboni agli inizi del 1800, ufficialmente per reprimere i reati nelle campagne, ma in realtà per difendere i privilegi feudali, facevano combutta con i malfattori e ne agevolavano i furti e gli abigeati alimentando quello spirito di mafiosità che alcuni studiosi fanno risalire a quegli anni. I militi a cavallo, creazione del nuovo stato unitario italiano, subentrati alle Compagnie d’Armi, recitarono a loro volta un ruolo ambiguo tanto da far dire a Filippo Cordova, nella sua presentazione alla Camera dei Deputati dell’ordine del giorno per l’abolizione del corpo, durante la seduta dell’11 giugno 1865: «Ora i militi a cavallo, trasformateli quanto volete rappresenteranno sempre, in faccia alle popolazioni siciliane, l’alto malandrinaggio». Disciolte le Compagnie d’Armi, la mafia si sostituì di fatto ad esse per difendere í privilegi dei grandi proprietari terrieri e lasciarne immutate le rendite secondo il principio che a produrre economicamente doveva essere sempre il capitale e mai il lavoro affinché la condizione contadina non si affrancasse dalla sua tradizionale indigenza. La mafia mise nei posti chiave i suoi gabellotti, i campieri, i guardiani, suoi membri preposti alla sorveglianza della situazione e del facile arricchimento di chi riusciva a mettere le mani sulla terra rendendosene padrone. L’abigeato, nella sua dimensione primigenia, rimase per molto tempo nell’ambito del brigantaggio ma con la nascita e lo sviluppo della mafia divenne una delle più cospicue fonti di reddito di essa. Afferma Enzo D’Alessandro nel suo libro: Brigantaggio e Mafia in Sicilia; «L’analisi volta a seguire l’azione del brigantaggio isolano dai Normanni all’età di Federico, dagli Angioini agli Spagnoli, dal regno di Vittorio Amedeo II sino ai Borboni, ne rileva, come manifestazione tipica e protratta nel tempo, l’abigeato». In una società di stampo prevalentemente agricolo l’abigeato, assieme alla protezione forzata del raccolto, furono l’espressione della
38
prepotenza criminale nei confronti delle categorie meno difese o più esposte a rappresaglie nei casi di resistenza o rifiuto delle ingerenze brigantesche e mafiose. Nella relazione dell’on. Romualdo Bonfadini, sulla conclusione dell’inchiesta parlamentare in Sicilia del 1875-76, si leggeva: «Dal 1836 al 1847 l’abigeato costituì veramente una setta che spediva ai mercati d’Algeri intere mandrie di cavalli, di buoi e d’altri animali da macello, ricattati nelle vaste e desolate lande dei pascoli interni… Le Compagnie d’Armi per il loro ordinamento erano responsabili dei furti e dovevano indennizzare il danno. In fatto si accordavano coi ladri pei ricatti e coi derubati per le restituzioni. Guadagnavano cogli uni e cogli altri, garantendo quei soli che acconsentivano a regolari tributi». La mafia ricalcò il medesimo stile con l’aggravante di pesanti ritorsioni nei casi di rifiuto della sua offerta di protezione. Un primo avvertimento consisteva nella distruzione del raccolto e della coltura; nei casi in cui non fosse riuscito a scuotere la resistenza del soggetto preso di mira si passava a vie di fatto più deleterie mediante la sottrazione di interi armenti, spesso unitamente all’uccisione di alcuni capi di bestiame allo scopo di una maggiore intimidazione psicologica, per colorire il ricatto con il drammatico effetto della vista del sangue. Per l’impossibilità di ottenere duratura giustizia e copertura dalla legge, il proprietario del fondo era costretto a cedere ed accettare di entrare a far parte degli «amici degli amici» cioè di coloro che, avendo pagato i protettori, divenivano intoccabili e contro cui non era possibile perpetrare altri danni. Colui infatti che si fosse introdotto nel territorio posto sotto la sorveglianza di una cosca mafiosa, allo scopo di recar nocumento al proprietario, veniva rinvenuto cadavere e con una mano mozzata, in funzione di quella simbologia di cui si è detto che «marcava» le salme di quanti avessero arrecato torti alla potente organizzazione. Naturalmente anche briganti isolati o contadini ridotti in miseria potevano commettere abigeato; era usuale l’immagine di un pastore costretto sotto la minaccia delle armi a consegnare buoi, mucche, vitelli, cavalli, muli, pecore, capre e tutto quanto era fonte di ricchezza in seno ad un tipo di società che cavava dalla natura il suo solo reddito.
39
Ma l’abigeato eseguito dalla mafia era più complesso e devastatore e rientrava in quell’azione a largo raggio che essa andava espletando per imporsi con la forza e la paura sul latifondo, come afferma a ragione E. D’Alessandro: «Impaurire con azioni brigantesche proprietari e benestanti in genere, era uno dei mezzi – perdurato nel tempo – di cui la mafia di volta in volta si serviva per tenere legate a sé quelle persone: era una dimostrazione, spesso ripetuta, della necessità della sua presenza e interferenza». Durante il periodo di profondo malessere popolare, che si ripropose già dai primi anni dell’unità nazionale, il fermento rivoluzionario dei contadini nei centri rurali si attuò attraverso l’azione delle squadre popolari, azione che venne repressa assai duramente con la forza anche dalle truppe dell’esercito garibaldino inviato, specialmente nelle province orientali dell’Isola, per stroncare ogni movimento di protesta con fucilazioni e dure condanne. I proprietari terrieri fornirono il loro appoggio alla repressione attraverso la Guardia nazionale e con loro squadre armate. A Bronte, dove la popolazione, nell’agosto del 1860, s’era ribellata chiedendo l’esproprio e la divisione dei terreni di proprietà degli eredi dell’ammiraglio Nelson (la famosa ducea di Bronte), un reggimento dell’esercito garibaldino, sotto il comando di Nino Bixio, effettuò la repressione che culminò con le fucilazioni e le condanne dei capi e di alcuni partecipanti. Anche in altri centri agricoli dell’Isola i moti popolari, motivati dalla mancata ripartizione delle terre demaniali, in compenso degli usi feudali aboliti e degli usi civici, vennero spenti nel sangue. La repressione dei moti nelle campagne, tanto duramente condotta dal governo di Garibaldi, rappresentò una drammatica sorpresa che lasciò sbigottite non solo le masse rurali, le quali avevano sperato, nel 1860, nell’avvento di una società più giusta, ma soprattutto i capi democratici locali (molti furono vittime della repressione) che nutrirono da quel momento una profonda avversione nei riguardi della nuova classe dominante costituita dai moderati e dai liberali conservatori. La repressione, oltre ad alimentare lo spirito democratico e ribellistico dell’Isola, radicò nelle masse popolari la convinzione che solo
40
ricorrendo alla forza sarebbe stato possibile cambiare il contesto socio-economico in senso democratico. Tali vicende, che caratterizzarono quel particolare momento storico, sfociarono specie nelle campagne, in un continuo stato di guerra fra contadini e borghesi, questi ultimi protetti dalla forza pubblica e da squadre private in difesa di vecchi privilegi ormai consolidati a danno di quelle masse popolari che, come scrive Francesco S. Romano in Storia della mafia, «non cessarono dal pensare a come armarsi o conservare le armi in attesa del gran giorno; e che i borghesi non pensassero ad altro che a difendersi, con le guardie pubbliche e private nelle campagne, dalla latente rivolta, anche individuale, dei contadini». Le squadre popolari dei dintorni di Palermo furono le sole che riuscirono a sopravvivere alla repressione mantenendo organizzazione e combattività grazie anche agli appoggi di cui godevano presso quelle forze politiche molto quotate in Sicilia ma che, a livello nazionale e locale, si ponevano su un piano di opposizione al governo. Si disse che le squadre popolari partecipanti alla rivolta del 16 settembre 1866, e che misero per sette giorni e mezzo a ferro e fuoco la città di Palermo, erano le stesse del 1860 e molte anche del 1848, e si disse, tra il popolo, che quella del 1860 era stata uno «schifo» di rivoluzione. Questa continuità delle squadre popolari dal 1848 al’1866, fece pensare a molti studiosi che si potesse identificare le squadre con la mafia ipotizzando appunto la nascita di quest’ultima nel 1860 in quanto in tale occasione s’erano formati gruppi armati che, con mezzi violenti, intendevano ottenere benefici personali profittando del naturale disordine politico e sociale. Si trattò di un grosso errore di valutazione storica poiché non venne considerato che la partecipazione delle squadre popolari, contadine e cittadine, era l’espressione organica del movimento rivoluzionario, profondamente radicato nella società siciliana, che scaturiva da una sentita aspirazione, degli strati popolari, al miglioramento delle condizioni di vita nei suoi aspetti socio–economici e politici. Le squadre, quindi, non erano «il prodotto patologico, individuale, o di gruppi
41
ristretti della società siciliana», come osserva lo storico Francesco S. Romano, con ciò escludendo una identificazione, almeno generalizzata, della mafia con le squadre medesime. La mafia, certamente, si poteva invece identificare con le squadre private utilizzate dai borghesi per la difesa dei propri privilegi ed a prova di ciò basterà citare la partecipazione attiva dei «campieri» che avverrà al momento delle stragi dei «Fasci». Con l’alibi di stroncare l’indisciplina e il disordine, che in effetti scaturivano dal profondo malessere degli strati popolari, motivato dall’irrisolta questione della ripartizione delle terre e più in generale dalla drammatica situazione sociale, vennero perseguitate le squadre protagoniste dei moti del 1860 e diffamati i capi e gli esponenti democratici che impersonavano le aspirazioni democratiche e popolari per una società più giusta. Alcuni esempi di aperta diffamazione e di demolizione del prestigio di alcuni capi democratici e politici che erano stati vicini al movimento rivoluzionario, varranno a dimostrare che dopo l’annessione il nuovo governo regio attuò una subdola azione «controrivoluzionaria» che fu alla base del «grave e prolungato malinteso fra il paese e l’autorità» in quanto le masse popolari, che avevano partecipato ai moti rivoluzionari per l’unità d’Italia, si aspettavano che venissero comprese quelle aspettative che le avevano spinte a partecipare ai moti e non che si agisse, da parte del nuovo potere, come se si fosse trattato di una annessione. Di fatto ci si convinse ben presto, e l’insurrezione del 1866 ne fu la conseguente reazione, che di annessione si era trattato in dispregio di tutti i sacrifici e di tutte le speranze. La diffamazione e la sistematica denigrazione colpì anche La Masa che Garibaldi aveva voluto a capo delle squadre dei «picciotti» e successivamente distintosi quale esponente democratico, nonché Giovanni Corrao che aveva partecipato ai moti del 1848 e che si era battuto nel 1860 nelle file garibaldine guadagnandosi il grado di generale. Arrestato e rilasciato nell’aprile del 1863, nell’agosto dello stesso anno il Corrao venne ucciso a colpi di fucile alle porte di Palermo; si sospettò che fosse stata l’Autorità di Polizia il mandante del delitto. Anche Pasquale Calvi, ministro del 1848 e capo democratico so-
42
stenitore delle squadre popolari, subì l’onta della persecuzione dopo l’ordine di Cavour di destituirlo dalla sua carica di presidente della corte di giustizia. Giovanni Raffaele, esponente del comitato insurrezionale e segretario di Stato nel governo garibaldino fu arrestato e deportato a Genova come un comune malfattore. Saverio Friscia, che si era distinto per le sue idee sociali avanzate e godeva di molto prestigio quale esponente democratico, venne destituito dalla carica di supremo magistrato di salute per la Sicilia a causa della sua azione volta ad ottenere l’emanazione dei decreti sui beni ecclesiastici. Dalla valutazione di tali fatti si può meglio comprendere il significato e le motivazioni che stavano alla base del rapporto sulla mafia, redatto dal prefetto di Palermo Gualtiero nel 1865 e che provocò molti errori di interpretazioni sulla mafia allocandone la presenza nel movimento popolare e negli schieramenti democratici e ciò per un preciso disegno politico volto a disperdere ogni possibile resistenza al nuovo regime. La rivolta del settembre 1866 non fu una rivolta della mafia né vide la partecipazione di mafiosi come fecero intendere le autorità di polizia. Fu un conflitto sociale e politico nato da un profondo dissenso espresso dagli strati popolari e dagli stessi gruppi patriottici per il modo con cui il potere intendeva governare l’isola. Le autorità si adoperarono per far credere ch’era stata una feroce e inconsulta reazione borbonica con la partecipazione di gruppi mafiosi e malandrineschi. Francesco Crispi deplorò aspramente quella insurrezione popolare e la sua presa di posizione influì molto, durante il processo, sulla condanna degli uomini della rivolta. Dopo la rivolta del 1866 la delusione pesò molto sul movimento popolare per cui i componenti di alcuni gruppi, non rassegnati a sottomettersi al nuovo regime, tenteranno di perseguire, individualmente, obiettivi economici e sociali sfruttando i rapporti con esponenti di gruppi politici democratici di opposizione contro il governo di destra contrari però ad aggravare le spinte ribellistiche popolari. Fu in quel periodo che le autorità governative cominciarono a non avere scrupoli legali alimentando connivenze con gruppi malandrineschi, con reciproci sostegni e scandalose protezioni, pur di perse-
43
guitare gli esponenti democratici ed i rappresentanti dei movimenti popolari, effettuando arresti anche contro le norme di legge. In Sicilia innumerevoli furono gli arbitrii nell’applicare una legge speciale voluta dal generale Medici in base alla quale si potevano infliggere ammonizioni ed assegnare il domicilio coatto per semplici sospetti e, non sempre disinteressate, informazioni. Si delineò chiaramente come la Pubblica Sicurezza si servisse della mafia per raggiungere e colpire i malfattori. La mafia si poneva quindi a metà strada tra l’autorità e la delinquenza confermando con ciò un’emergente peculiarità di notevole rilevanza ai fini della collocazione del fenomeno mafioso nel rapporto tra potere e contesto sociale, fenomeno non necessariamente da ricondurre agli ambienti malandrineschi della delinquenza. Dopo la rivolta del 1866 ed a seguito della dura applicazione delle leggi speciali si verificò, con la mediazione dei gruppi politici che avevano moderato la loro opposizione al governo onde evitare il rischio di una rottura, 1’inglobamento di varie forme di attività criminose, utilizzando organicamente quelle che si prestavano, per la difesa di gruppi di potere, di interessi socio economici e politici. Con tale nuova strategia, che superava la fase rivoluzionaria e insurrezionale, vennero a costituirsi ed a consolidarsi oscuri legami di complicità ed influenza fra attività criminosa ed economica, fra giustizia pubblica e privata, fra malandrinaggio e politica e, più in generale, fra potere legale e illegale, venendosi a delineare il ruolo nella società siciliana ed il contributo storico della mafia per l’affermazione della nuova classe dominante e la sua funzione, che si rafforzerà ulteriormente negli anni successivi, come potere intermedio «tra la legge dello Stato e la società reale dell’Isola». Il passaggio di alcuni gruppi democratici, perseguitati ed assimilati ad associazioni mafiose, dallo spirito rivoluzionario a quello della ribellione e della violenza individuale, venne interpretato come un effetto della politica del governo della destra nell’Isola e come logica conseguenza di una rivoluzione che non fu sedata negli animi. Francesco Crispi, a quel tempo esponente del partito democratico siciliano di opposizione, osservò che la mancanza di provvedimenti sociali ed economici, dopo le repressioni del 1860 e del 1866, aveva-
44
no deteriorato la sicurezza e la libertà economica e morale dell’Isola, calpestate dal governo della Destra. Crispi così disse: «Ora o signori, un paese che per quindici anni fu governato con lo stato d’assedio, con la ammonizione e con il domicilio coatto, volete che si trovi in uno stato normale, che la morale di questo paese, che il cuore, l’anima dei suoi abitanti siano in uno stato di calma e di tranquillità mentre li avete eccitati, li avete indispettiti, li avete irritati, sino a far credere che voi siete i loro nemici anziché il governo della riparazione e della libertà?». Nel periodo della caduta della destra la mafia assunse una più articolata connotazione sia come evoluzione di metodi e d’influenza sia come diffusione sociale. Nel descrivere le motivazioni e le adesioni al fenomeno mafioso così osserva lo storico Francesco S. Romano: «… si inserisce (nella mafia) l’individuo violento e senza scrupoli, che vuol farsi strada, come il ricco potente proprietario che vuole difese le proprie ricchezze, o il professionista o il borghese desiderosi di affermarsi nella vita pubblica. In tal modo ogni uomo coraggioso ed audace, avido di farsi strada senza scrupoli nei riguardi dei mezzi da usare, poteva contare sulle possibilità che gli erano aperte con il rendersi solidale o partecipe con l’attività e i mezzi e l’organizzazione della mafia…». Si consolidava in tal modo un potere illegale che più o meno segretamente condizionerà, con la sua rete di potenti legami, le vicende politiche e sociali dell’Isola. Scriveva Pasquale Villari nella sua lettera meridionale: «Il contadino agiato ed il “borghese,” come dicono colà, di Monreale, di Partinico, ecc., i gabellotti o affittuari e le guardie rurali di quei medesimi luoghi sono quelli che costituiscono il nucleo principale della mafia». Le radici della mafia, come abbiamo già detto, erano in campagna, dove essa era nata e s’era consolidata inserendosi nel rapporto tra i contadini ed il signore feudale, quale forza oppressiva al servizio di quest’ultimo. Nella fase di evoluzione avvenuta con l’unità d’Italia la mafia estese i suoi legami nella città. Pasquale Villari, osservando che in città esistevano tre classi distinte, precisava che «in Palermo stanno i grandi possessori di vasti latifondi o ex feudi, nei dintorni abitano i contadini agiati, dai quali sorge o accanto ai quali si forma una classe
45
di gabellotti, di guardiani e di negozianti di grano. I primi sono spesso vittime della mafia, se con essa non s’intendono; fra i secondi essa recluta i suoi soldati, i terzi ne sono i capitani… Fra i tiranni dei contadini sono le guardie campestri, gente pronta alle armi e ai delitti e sono ancora quei contadini più audaci che hanno qualche vendetta da fare o sperano a trovare coi delitti maggiore agiatezza: così la potenza della mafia è costituita. Essa forma come un muro tra il contadino e il proprietario…» Da ciò chiaramente risalta la funzione di inquietante intermediazione parassitaria che aveva la mafia nei riguardi dei contadini e dei proprietari, questi ultimi avevano preso il posto degli antichi signori feudali per quella sostituzione dei ceti da cui nulla sarebbe cambiato in base all’intuizione gattopardiana. In questa evoluzione della funzione della mafia nel senso di più ampia presenza nella vita sociale e politica dell’Isola, emergevano le figure dei guardiani e dei gabellotti che mantenevano il loro predominio con il terrore. Essi estendevano la loro influenza nella città dove la mafia aveva nuovi interessi specie a Palermo dove c’era una maggiore concentrazione di capitali, dove più importanti erano le attività connesse alla vendita dei prodotti agricoli e dove la plebe era, per miseria e per conseguente aberrazione, pronta alla violenza e quindi disponibile a fornire in ogni momento «manovalanza» alla mafia. Inserite nel contesto produttivo della campagna e della città, le associazioni mafiose avevano spesso maggiore influenza di quella che poteva esprimere il potere legale e di conseguenza «il mafioso» traeva da ciò forza mentre gli stessi proprietari venivano attirati dalla mafia ormai convinti che dal potere legale non avrebbero mai ricevuto né protezione né prestigio. Con l’unità d’Italia i «Sedara», sostituitisi agli antichi «Gattopardi», esercitarono la loro violenza di avidi borghesi con tutta una serie di «rapacità» che andavano dalla usurpazione delle terre demaniali all’appropriazione delle terre degli enti ecclesiastici, mettendo in atto, specialmente intorno alla capitale dell’Isola, un efficacissimo sistema di coercizione e di mediazione tra i rapporti di classe, di produzione e di lavoro. A Palermo tale avanzata organizzazione venne messa in atto dai borghesi rurali del posto che accumularono notevoli
46
fortune investendo nella coltivazione degli agrumi. In particolare il commercio degli aranci e dei limoni, fu spesso alla base dello sviluppo di quelle redditizie attività. La ricchezza che ne derivò per tanti proprietari fece altresì sviluppare «il sentimento della mafia» vale a dire l’uso aperto, convinto ed organizzato della violenza extralegale ed extraeconomica. Le manifestazioni che riguardavano la difesa degli interessi mafiosi e l’acquisizione o la difesa di qualche privilegio di natura economica, facevano immancabilmente applicare tutta una serie di soprusi e di violenze tipiche della «minaccia mafiosa». Scrive a riguardo Michele Pantaleone in Mafia e Politica: «La borghesia terriera, che specialmente nell’ultimo scorcio dell’ottocento e nella prima metà di questo secolo è venuta soppiantando la nobiltà nel possesso della terra, ha in gran parte le origini che abbiamo detto. Questa graduale trasformazione della classe padronale, e il conseguente frazionamento dei confini del feudo, non incidevano in alcun modo sulle strutture della proprietà terriera, né valevano a scuotere il sistema che stava a base dell’organizzazione mafiosa che anzi finiva per potenziarlo ulteriormente: poiché il mafioso, fattosi proprietario, era ancora più direttamente interessato alla rigida applicazione del sistema». Come dicevamo, l’abigeato e la tutela forzata del raccolto furono le forme tradizionali della violenza mafiosa nelle campagne siciliane. Nessun proprietario poteva rifiutare un’offerta di «guardiania» fatta dal capo della mafia della zona senza che i suoi vigneti o i suoi alberi di ulivi venissero tagliati per «avvertimento» proprio nel momento che si caricavano del frutto. Nel caso in cui il malcapitato proprietario resisteva o, peggio, si rivolgeva alla polizia, si passava all’uccisione di cavalli e vitelli. Questo secondo avvertimento non lasciava dubbi sulle intenzioni della mafia e su quello che poteva capitare a chi si ostinasse a non accettare i suoi voleri. Chi s’era rivolto alla polizia finiva per convincersi che nessuna possibilità c’era di rintracciare i colpevoli né, tantomeno, poteva ricevere la ben che minima protezione. Quindi il proprietario, verificato il proprio totale isolamento, finiva
47
per accettare la «protezione della mafia», pagando tale vera e propria «sottomissione» con l’accettare i «collaboratori» che gli venivano imposti, col subordinare al consenso del capo mafia la stipulazione di un contratto di mezzadria, con tributi in natura versati in proporzione ai propri redditi. La protezione mafiosa risultava essere molto più efficiente di quella della polizia e con questa constatazione, certamente amara ma concretamente vera, il proprietario finiva per accettare, gioco forza, di entrare a far parte dei cosiddetti «amici degli amici», anticamera, il più delle volte, dell’«onorata società». Nella rete mafiosa esisteva una specie di gerarchia nella quale si collocavano i diversi gruppi sociali, ch’era inoltre caratterizzata dalla preminente funzione di guida costituita dalla classe media dei gabellotti e dai proprietari borghesi. Già, nell’organizzazione mafiosa del feudo si trovava tale tendenza considerato che la mafia contava i suoi adepti fra i guardiani e i campieri soprastanti ma che i capi mafia erano sempre gabellotti e proprietari, persone queste ultime, in migliori condizioni economiche relativamente agli altri. Il contadino, vera vittima del latifondo e afflitto da condizioni economiche generalmente disastrate, raramente era un mafioso ed il suo sentimento di omertà era da motivare con la necessità di sopravvívere in un sistema dove, all’autorità dello Stato ormai completamente assente, era subentrato il potere mafioso che dominava la vita sociale ed economica. Ben presto la mafia, imponendo la sua volontà alle numerose famiglie del feudo, fu in grado di procacciare i voti al deputato di maggioranza nei vari collegi con ciò controllando le amministrazioni comunali e spesso assumendone in proprio la gestione. Si verificò quindi una stretta connessione fra le attività della mafia e quelle politiche e le influenze delle organizzazioni mafiose furono tali che, vigendo il sistema elettorale del collegio uninominale, le zone di un determinato capo mafia coincidevano solitamente con quelle elettorali. Sugli «amici» mafiosi dei politici così scriveva Giuseppe Bruccoleri nel 1913 in La Sicilia oggi: «Questi amici sono quei tali alti papaveri della delinquenza dei quali appunto il Governo si giova nelle elezioni amministrative o politiche, per far trionfare il partito che a lui fa co-
48
modo. Sono, costoro, i sollecitatori di tanti favori presso la Prefettura, delle concessioni dei porti d’arma ai pregiudicati, talvolta direttamente, tal altra, invece, per tramite di Sindaci o altre Autorità. Non raro è il caso che costoro siano insigniti di croci di cavaliere o di commendatore, per i servizi che rendono alla prefettura, specie in tempo di elezioni; con quali metodi abbiamo detto: mentre, d’altra parte, sono in rapporto continuo, diretto o indiretto, con quei malviventi dati alla campagna. Questi alti papaveri, dunque, sono i veri manutengoli ed il Governo ben lo sa; ma non osa molestarli, anzi li gratifica ed accarezza perché se ne giova al momento del bisogno». La mafia, molto sensibile all’influenza delle trasformazioni politiche, ricevette notevole impulso con l’avvento al potere della sinistra ed anche con l’allargamento del sistema elettorale. Si può ben dire che da quel momento, e cioè dal 1882 in poi, si verificò una vera e propria legalizzazione politica della mafia nel senso che «il potere reale» dei gruppi mafiosi tese sempre più a tramutarsi e ad identificarsi con il potere legale del potere e con i relativi rappresentanti. Ma i gruppi mafiosi, attraverso il sistema di interdipendenza tra potere locale e potere nazionale, riuscirono a diventare un elemento di sostegno anche dei gruppi politici a livello nazionale, riuscendo a condizionare, a loro vantaggio, perfino alcune scelte politiche. Si realizzava, così, attraverso un sistema di pressioni illecite, di intimidazioni, di ricatti e di violenze, il potere di gruppi politici dominanti ed aventi più stretti legami con la borghesia degli affari e delle speculazioni. La vita politica italiana in tale periodo fu dominata da metodi preminentemente «affaristici» non del tutto leciti tanto da far osservare a Francesco De Sanctis, che fu deputato e ministro, come nei consigli comunali, provinciali e parlamentari si fossero formate «associazioni di cointeressati i quali, pur nascondendosi sotto una qualsiasi maschera, sono vere associazioni a delinquere o, se preferite, dei mangia con tutti». Nel primo semestre del 1875, in base ad una indagine, duecento sindaci risultavano accusati davanti ai Tribunali, alcuni di frode, altri di concussione, altri ancora per falso in atto pubblico e per arresti arbitrari ed ingiurie. Altra interessante testimonianza di quel periodo
49
della vita politica italiana fu quella di Napoleone Colajanni nel libro La Sicilia dai Borboni ai Sabaudi. Egli scrisse: «La sinistra affrettò la degenerazione del regime parlamentare; quella degenerazione che si era preparata nel suo seno per la lunga assenza dal potere, che l’aveva condannata ad una specie di ostracismo politico e l’aveva privata di quella pratica che dà le migliori e le più salde attitudini per ben governare. Quando acchiappò le redini del governo (la sinistra) era già affamata di potere, assetata di vendetta, esaurita in una posizione infeconda, aveva molti risentimenti da sfoggiare ed aveva contratto molti debiti politici e morali in sedici anni di lotta contro la “Destra”. Non poteva pagarli che a spese della cosa pubblica, a spese soprattutto della giustizia e della legalità. I favori e le ricompense perciò, piovvero sugli amici, sui clienti, sui creditori, sotto forma di impieghi, di concessioni d’ogni genere, d’onorificenze cavalleresche; agli amici che chiedevano, nulla si seppe e si volle negare e quando non bastarono i favori per contentarli, non si risparmiarono le prepotenze e le iniquità a danno del pubblico o a danno dei privati». Nell’analizzare l’evoluzione dell’organizzazione mafiosa in quel periodo e l’influenza dello stesso potere politico nell’azione della mafia in Sicilia, Napoleone Colajanni così continuava: «Lo spirito della mafia non scaturì più esclusivamente dalle sorgenti dell’ufficio di polizia, del principe, del latifondista, del gabellotto, del campiere, del compagno d’arme, ma su queste sorgenti s’innestò e spesso prevalse l’influenza del deputato e talora del semplice candidato governativo». Le conseguenze di tale situazione furono disastrose sotto il punto di vista politico, morale e amministrativo ed in questo contesto si consumò la vicenda dei «Fasci dei Lavoratori» che trovarono sulla loro strada la compatta reazione del potere politico e di quello mafioso, uniti nel difendere un sistema sociale ed economico che garantiva loro il mantenimento e la difesa di vecchi e nuovi privilegi. Intanto la mafia, ormai inserita nei centri del potere finanziario, si rese protagonista di un altro fatto eclatante, cioè la eliminazione, il 3 febbraio 1893, del marchese Notarbartolo che si accingeva ad avviare un’inchiesta al Banco di Sicilia a seguito di gravi scandali. Il timore
50
di un ritorno a sani criteri amministrativi nel massimo istituto bancario siciliano spinse la mafia ad eliminare dalla scena il Notarbartolo. Venne accusato come mandante del delitto il deputato parlamentare Raffaele Palizzolo. Il Palizzolo fu processato due volte e sfuggì in appello alla giusta condanna grazie alle pressioni degli «amici» che si batterono ottenendo una clamorosa sentenza di assoluzione. Ancora una volta la connivenza fra mafia e politica usciva «vittoriosa» e non sarebbe stata l’ultima. Molti anni dopo nemmeno il Fascismo, che si vantava di avere ripristinato l’ordine in Italia, riuscì a mettere il bavaglio alla mafia. che, annidatasi negli alti livelli del regime, aveva continuato una stretta collaborazione con il potere politico. Cesare Mori, detto il Prefetto di Ferro, al quale Mussolini aveva dato (in apparenza) pieni poteri nella lotta alla mafia, era riuscito a mettere le mani solo sui mafiosi di piccolo calibro. Quando egli intuì che le vere fila della criminalità in Sicilia venivano tirate da personaggi molto influenti del mondo politico ed economico, venne esautorato (nel 1929) dallo stesso Mussolini. Il Mori, in una riflessione raccolta da Arrigo Petacco nel libro Il Prefetto di Ferro, così affermava: «La mafia è una vecchia puttana che ama strofinarsi cerimoniosamente alle Autorità per adularle, circuirle e incastrarle… Ma l’Autorità dello Stato è il rotolo della carta igienica. Quando manca tutti imprecano, quando c’è ciascuno ne strappa un pezzo e…» Dopo il secondo conflitto mondiale la mafia «che aveva assunto meriti nello sbarco americano nell’Isola», tornò nuovamente ad operare alla luce del sole inserendosi nella nuova organizzazione democratica soprattutto come elemento d’«ordine» nei confronti delle azioni di rivendicazione sociale avviate dalle masse popolari. Si ricompose la connivenza mafia e politica in forza del ripristinato sistema elettorale e si ebbero gravi ed inquietanti effetti nell’azione repressiva attuata, anche con le armi, nei confronti di sindacalisti e di chi si poneva in posizione di resistenza ai soprusi ed alle intimidazioni.
51
La vicenda del bandito Giuliano, strumento nelle. mani della mafia nella strage di Portella della Ginestra, fece rivivere la vecchia storia dei Fasci. Ma il modello mafioso ha avuto nei nostri giorni una ulteriore evoluzione inserendosi, come forza imprenditrice, nei grandi nuovi «business» degli affari pubblici e della droga, compiendo gravissimi delitti ed eccidi onde mantenere inalterato il proprio potere ormai lungo più di un secolo e assumendo un ruolo preminente nella grande criminalità interagendo con i centri della corruzione politica ed amministrativa, con quelli della corruzione economica e con le lobbies.
Contadini siciliani sui campi del latifondo
52
1860. Una carica della cavalleria borbonica contro i rivoltosi di Palermo. Garibaldi e i suoi mille era già sbarcato a Marsala il 5 maggio di quell’anno
53
La rivolta popolare a Palermo nel 1866 con una componente di brigantaggio e mafia
54
3 Bronte cronaca di un massacro
«Sono innocente come Cristo!» Queste parole furono le ultime pronunciate da Nicolò Lombardo prima di cadere sotto il fuoco del plotone d’esecuzione, a Bronte, nel piano di San Vito, il 10 Agosto del 1860. Assieme a lui furono giustiziati i «civili» Nunzio Samperi Spiridione, Nunzio Spitaleri Nunno, Nunzio Longhitano Longi ed il contadino Nunzio Civaldo Frajungo detto «il pazzo». Una immensa folla di popolo seguiva con sgomento, muta ed impaurita, il corteo dei condannati e gli occhi di tutti erano rivolti all’alta figura dell’avvocato Lombardo che procedeva lentamente fumando l’abituale sigaro; lo sguardo dell’uomo, noto a Bronte per le sue lotte civili, era triste e rassegnato, il volto era inquadrato da una lunga barba nera sotto un cappello a larghe falde cadenti. Il silenzio era rotto dai singhiozzi e dal pianto di molti popolani che ben sapevano che quel «civile» aveva sempre combattuto per difendere i loro diritti per una migliore giustizia sociale e che stava per essere ucciso perché ingiustamente accusato di essere uno dei capi della reazione borbonica e per questo responsabile, per naturale quanto facile conseguenza, della rivolta e dei massacri che dal 2 al 4 agosto 1860 avevano insanguinato Bronte. La calunniosa denuncia era stata inoltrata a Bixio dagli esponenti della fazione «ducale», cioè proprio da quegli elementi retrivi che, nella disputa con la fazione «comunista» avversaria, difendevano i loro privilegi di classe borghese dominante e quelli dei duchi di Bronte. Con l’eliminazione dei capi della corrente progressista i reazio-
55
nari, oppositori delle rivendicazioni popolari, si volevano eliminare i pericolosi concorrenti nell’amministrazione del comune e bloccare l’attuazione del decreto dittatoriale del 2 giugno 1860 riguardante la censuazione delle terre e dei demani comunali. Tale proposito apparve chiaro dal momento che l’obbiettivo della fazione ducale non fu rivolto a dare punizione ai veri protagonisti della rivolta ed agli autori dei massacri, plebe che non avrebbe potuto esprimere, oltre gli eccessi dell’eccidio immediato, una vera contrapposizione politica nei confronti delle forze reazionarie per la gestione del Municipio di Bronte. Secondo tale logica, lucida quanto aberrante e comunque tipica delle dispute politiche, a Nino Bixio dovevano essere consegnati i dirigenti della fazione «comunista», pericolosi antagonisti degli esponenti della sfera ducale i quali si vedevano già sfuggire dalle mani potere e ricchezza per la reale concreta attuazione della rivoluzione di Garibaldi attraverso una politica agraria. di carattere democratico e popolare e l’attuazione di un più giusto assetto sociale. Nino Bixio, personaggio di indubbio talento militare ma povero di sensibilità storica, ed irruento, per natura, non esitò ad accogliere la denuncia a carico di Lombardo e compagni ed a ritenerla fondata sì da sollecitare alla Commissione di Guerra, repentinamente formata, un processo celere ed una sentenza severa. Con un giudizio superficiale e sbrigativo, per Bixio la rivolta non era diretta contro quel feudalesimo che il «liberatore» era venuto a smantellare definitivamente e quindi di appoggio alla stessa azione garibaldina, ma bensì un attentato borbonico alla riuscita dell’impresa dei mille da debellare con un esemplare sentenza di morte. Che la pena capitale fosse nei suoi intendimenti ed avesse la sicurezza di verderla applicata fu convalidato dal biglietto scritto di suo pugno, 1’8 agosto al comandante Dezza, un giorno prima che venisse emessa: «Io sarò a Bronte per la fucilazione e poi ci vedremo a Randazzo».
*** Il processo che condannò Niccolò o Lombardo fu puramente formale, un processo «burla» che in quattr’ore raccolse le prove, le va-
56
gliò e pronunciò la condanna; all’imputato fu concessa solo un’ora per preparare la propria difesa e respingere le accuse; le discolpe furono presentate in ritardo e volutamente rigettate per questo vizio di forma affinché la sentenza di morte venisse stabilita senza l’esame delle testimonianze a discarica che contenevano importanti elementi per attestare l’innocenza del capo della fazione «comunista». Una delle accuse che maggiormente incisero nel giudizio fu quella di detenzione abusiva di armi che non aveva luogo a sussistere in quanto il decreto che intimava il disarmo della popolazione era stato emanato nella stessa mattinata in cui fu eseguito l’arresto. Si compiva così un’enorme ingiustizia come non molto tempo dopo, fece intendere la stessa magistratura impegnata nell’istruttoria sollecitata dalla parte conservatrice che ormai sedeva, unica ed indisturbata dominatrice, nel consiglio civico di Bronte nel quale non esisteva opposizione. Le conclusioni dell’Istruttore furono che «i fatti di Bronte non avvennero per effetto di una reazione, ma per essersi negata al popolo la divisione delle terre di demanio comunale». La «controrivoluzione» che i rappresentanti del movimento di rinnovamento sociale intesero attuare a Bronte, e che aveva lontane radici, fu solo l’episodio di un più vasto disegno politico. Bronte rappresentò il simbolo della protesta popolare esplosa nel vento di libertà portato in Sicilia dall’arrivo delle squadre garibaldine, nel momento in cui si incominciò ad intravedere la possibilità concreta di scrollare il vecchio sistema feudale che violava i più elementari diritti umani e di ottenere, sia pure con la forza, la giustizia a lungo negata. I contadini, per l’impossibilità di far fronte alle tassazioni, avevano gradualmente perso anche le poche terre da loro coltivate che erano andate ad accrescere il patrimonio dei baroni e dei grandi agrari i quali, a Bronte, gestivano il feudo con criteri strettamente medioevali non esclusi lo “ius primae noctis e la ruota dei bastardi” che colpivano come un marchio d’infamia il cosiddetto ceto inferiore. Le terre demaniali erano ridotte a ben poca cosa dopo le varie donazioni (le prime risalivano al papa Innocenzo VIII nel 1491) che perduravano in epoche recenti come la Ducea di Maniace ceduta in possedimento privato all’ammiraglio inglese Orazio Nelson nel 1799
57
da Ferdinando I (allora terzo) per ricompensarlo dell’aiuto datogli nel fronteggiare le truppe napoleoniche. Ciò,significava miseria per il contadino avulso sempre più dalla terra, unica sua fonte di sussistenza,mentre il condottiero britannico poteva fregiarsi del titolo di Duca di Bronte aggiungendosi in tal modo agli.altri signorotti che già si erano spartiti gli averi comunali. Fin dall’11 maggio 1860, giunta notizia dello sbarco dei Mille a Marsala, il fermento era cominciato ad affiorare nel popolo che inveiva contro i. galantuomini al grido: «Viva Garibaldi! » e «A morti li cappeddi! », ed era lievitato il 16 maggio dopo la vittoria di Garibaldi a Calatafimi. I primi incidenti avvennero quando nella piazza del paese apparve il tricolore salutato dall’entusiasmo della folla e vilipeso dal notaio della Ducea Cannata che lo definì «pezza lorda» accrescendo l’odio dei contadini verso di lui che ritenevano persona infida e servo della causa degli «usurpatori». Ma in Bronte la compattezza del ceto contadino, fondata sulla comune situazione di miseria e sull’atavico odio contro la classe dei «cappeddi», non trovava riscontro fra i «civili», in maggioranza liberali, divisi per motivi di politica e di parte, in due opposte fazioni. Più numerosa e forte era quella «ducale», conservatrice in quanto rivolta a difendere i propri interessi e privilegi e quelli più ampi, per ovvi condizionamenti politici, dei duchi di Bronte; meno agguerrita perchè di più recente costituzione quella «comunista» recitante un ruolo progressista, ma non meno decisa a riequilibrare la situazione riaffermando i diritti del Comune nei confronti degli «usurpatori» delle terre.
*** Il popolo dava il suo appoggio a quest’ultima fazione, da cui si sentiva protetto e verso la quale aveva superato l’antica diffidenza per la classe borghese, tradizionalmente alleata dei regimi reazionari, della quale erano esponenti i fratelli Nicolò e Placido Lombardo il primo dei quali era più in vista per l’energia con cui lottava per l’affermazione dei principi di giustizia e solidarietà umana ai quali era improntata la sua attività.
58
La disputa fra i due movimenti era divenuta ormai storica per antiche motivazioni e viveva in uno scenario drammatico per le tensioni popolari che, ridestatosi dal torpore a seguito degli eventi siciliani del maggio 1860, tendevano a diventare fiamma distruttiva, molto vicina alla deflagrazione. In passato la fazione ducale aveva sempre esercitato la sua influenza avendo alleate, com’è nella logica del potere, la polizia e la magistratura per domare gli avversari con l’arresto, la tortura, il carcere, l’esilio. Anche i fratelli Lombardo, assieme a molti altri, erano stati vittime delle persecuzioni, per l’impegno civile speso nella lotta contro l’ingiustizia, ed avevano patito l’onta del carcere. L’avvicinarsi dell’esercito garibaldino aveva rinfocolato le speranze di una Libertà ormai prossima e quindi di una rivalsa sui secolari padroni, dell’arrivo di quella liberazione così a lungo agognata, dell’eliminazione di tasse inique specie quella sul macinato, della divisione delle terre del demanio comunale che, promossa dal borbone e decretata da Garibaldi il 2 giugno 1860, doveva essere concretamente attuata. Il decreto dittatoriale che ordinava la censuazione delle terre era stato accolto con un’ansia prorompente che spingeva il popolo ad affrettarne i tempi di attuazione nel fondato timore che le forze conservatrici potessero vanificare gli obiettivi di progresso, primo fra tutti la ripartizione delle campagne della Ducea di Bronte, simbolo della vergognosa violazione dei propri diritti in atto da tre secoli mediante progressive «usurpazioni». Il 17 giugno 1860 la speranza popolare trovava motivo di credere ad un vicino componimento della rivoluzione quando l’avvocato Nicolò Lombardo, capo della fazione progressista, prendendo forza dall’esclusione dai Consigli Civili degli elementi sostenitori del regime borbonico, tentò di prendere la guida del municipio allo scopo di poter dar corpo ai principi dello stesso Garibaldi, con una motivazione che lasciava spazio agli avversari per un’equivoca incriminazione che gli fu esiziale. L’accusa della fazione conservatrice fu infatti diffamatoria e stranamente in
59
linea con quell’apertura al rinnovamento di cui era tenace negatrice ed addossò all’avvocato Lombardo la responsabilità di voler favorire la restaurazione borbonica. La tensione popolare ricevette impulso da tale fatto e si aggravò ulteriormente allorquando la fazione ducale prevalse su quella progressista nelle elezioni tenutesi a Bronte nella seconda metà del mese di giugno 1860. Alle turbolenti manifestazioni di piazza, sottovalutate dai tutori dell’ordine pubblico, erano seguiti gli scontri, in verità non nuovi, tra le guardie della compagnia ducale e quella degli «Spataioli» ch’era una delle quattro Compagnie della Guardia Nazionale comandata da Nicolò Lombardo il quale, proprio quei giorni, sfuggiva, per avvertimento di amici, ad un attentato che mirava alla sua eliminazione fisica. Sull’onda delle notizie e dei tumulti che erano esplosi violentemente in molti paesi della Sicilia il popolo di Bronte mostrava, con i segnali inquietanti della protesta sempre più accesa, di non voler contenere l’ira da troppo tempo repressa contro i «galantuomini». L’arresto di alcuni popolani, ritenuti i protagonisti dei disordini, effettuato da una compagnia della Guardia Nazionale appartenente all’Amministrazione della Ducea con in testa l’odiato notaro Cannata, venne considerato dal popolo una aperta provocazione. A nulla erano valse la protesta dell’avvocato Nicolò Lombardo presso il marchese Casalotto comandante distrettuale della Guardia Nazionale che si era apertamente pronunciato a favore delle forze reazionarie. Nel precipitare della situazione il Lombardo, che aveva rivolto raccomandazioni di moderazione al muratore Rosario Aidala che fu il vero comandante della rivolta, sperava probabilmente che i tumulti, contenuti nei limiti di una protesta né grave né sanguinosa, sarebbero serviti per intimorire la fazione avversaria e ad indurla a lasciare l’amministrazione municipale. Ma la rabbia popolare, ormai esplosa non era più controllabile. Le squadre popolari il 2 agosto accerchiarono il paese ed instituirono dei picchetti allo scopo di bloccare all’interno i «galantuomini»; il notaro Cannata, uscito in piazza armato di fucile, fece esplodere l’i-
60
ra dei rivoltosi ed a Bronte fu massacro nonostante i nuovi tentativi dell’avvocato Nicolò Lombardo per cercare in extremis di quietare gli animi; la folla era ormai un mostro di odio che nessuno, in quel momento poteva ammansire. Masse di plebe inferocita assaltarono le case dei ricchi bruciando, saccheggiando uccidendo; si attuò una feroce caccia al ricco e la vita umana si svuotò di ogni significato; Bronte per tre giorni visse nel terrore immersa nel sangue delle molte vittime. Il 4 agosto, davanti a tale massacro, fu lo stesso Nicolò Lombardo a tentare una imposizione dell’ordine mediante la richiesta a Catania dell’invio dei militi della Guardia Nazionale. Così il giorno dopo una compagnia di soldati, comandata dal colonnello Poulet, riusciva ad entrare in Bronte anche per la mediazione dello stesso Lombardo e dell’arciprete del paese che scongiurarono in tale maniera lo scontro fra la truppa e le squadre popolari che, senza tali interventi, avevano deciso di attaccare il Poulet alle spalle. Lo stesso giorno giungeva a Bronte Nino Bixio in carrozza da Randazzo. Egli dimostrò subito l’intenzione di fare giustizia sommaria e sedare i tumulti con la forza, senza perdere tempo a stabilire le cause ed indagare i motivi della sollevazione, smanioso com’era di procedere in fretta oltre lo stretto per raccogliere la sua fetta di gloria sui monti di Calabria. Bixio raccolse senza indugio le denunce fatte dagli esponenti della fazione «ducale» contro l’avvocato Nicolò Lombardo ed i suoi compagni, preoccupato che i giudici da lui ammoniti emettessero subito la condanna di morte che aveva anticipato in quel suo biglietto scritto l’8 agosto, e ripartì per Randazzo dopo la fucilazione eseguita nel piano di San Vito e che doveva servire, com’era scritto nella sentenza, da «pubblico esempio». A Bronte, in quel giorno d’estate, la fazione conservatrice tentò di seppellire per sempre, con l’aiuto dei nuovi dominatori, assieme all’avvocato Lombardo le rivendicazioni contadine che tendevano al raggiungimento di un tono di vita più umano, all’affrancamento dalla grande secolare miseria, al diritto al lavoro della terra usurpata a lungo dai rapaci interessi dei ricchi.
61
A Bronte la plebe aveva agito in chiave di grave violenza contro le sopraffazioni ed il malessere, essi stessi scuola di violenza, da cui il popolo traeva profondi motivi di risentimento verso coloro dai quali era considerato massa informe da asservire. E quel giorno, nel piano di San Vito, si compiva una storia infame le cui motivazioni politiche andavano ricercate nel tentativo della classe conservatrice di scongiurare l’avanzata del mondo contadino fermando i capi che lo rappresentavano. Così cadeva sotto il fuoco del plotone d’esecuzione Nicolò Lombardo gridando: «Sono innocente come Cristo!».
62
4 Il Sud tradito
L’unità d’Italia, con l’affermazione della media e alta borghesia nel ruolo di nuova classe dirigente, volta all’accumulo di capitali attraverso il protezionismo industriale ed agricolo–fondiario, vide l’accentuarsi del dualismo fra regioni in via di espansione economica al Nord, che monopolizzava le attività imprenditoriali, ed un Sud ancora emarginato, colpito da un sistema fiscale inadeguato alla sua realtà e rapinato delle sue risorse. Nei latifondi improduttivi dove milioni di contadini, tra malattie e denutrizione, sfruttati e deformati dalla fatica, trascinavano una vita di stenti e miseria, il brigantaggio divenne nel Sud la prima forma di lotta contro lo stato insensibile ai veri problemi del mezzogiorno. Il cancelliere dello scacchiere Gladstone, leader del liberalismo britannico, dopo un viaggio nelle terre sottoposte ai Borboni, ne aveva denunciato il malgoverno all’opinione europea in alcune lettere in cui li definiva «negazione di Dio» ed il loro predominio «oltraggio permanente alla pubblica decenza». Con l’unità non si ebbe lo sperato cambiamento di rotta. Il risanamento, anziché attraverso una pianificazione economica ed azioni legislativo–finanziarie fu regolato da leggi repressive che riconducevano le espressioni di insubordinazione al nuovo stato unitario nella sfera della pura criminalità sulla quale la Destra storica pretese di agire con la pseudo pedagogia dell’educazione delle masse delle quali però ignorò i motivi della lotta. Si pose la «questione meridionale» preferendo considerare il
63
Sud una «palla al piede». È fatto storicamente provato che nel Sud «1’esercito italiano, vinse, decimò, ammazzò più contadini di quanti soldati perirono in tutte e tre le guerre d’indipendenza nazionale» (F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità). Quindi il mezzogiorno, con l’unità d’Italia, divenne il «corpo criminale» dello Stato e bisogna ben dire che già tale definizione dovette certamente guidare l’azione dei Piemontesi quando, nell’ottobre del 1860, venne invaso il territorio napoletano, infatti «una delle prime azioni del generale Cialdini fu di far fucilare sul posto ogni contadino che fosse trovato in possesso di armi; era una dichiarazione di guerra contro la gente che non aveva nessun altro mezzo di difesa, e ottenne i risultati che erano da aspettarsi» (Mack Smith, Storia d’Italia dal 1861 al 1958). Il capitalismo della nuova classe borghese era soprattutto incentrato sul diritto alla proprietà «intangibile ed incondizionata» per cui il latifondo poteva restare improduttivo mentre per le plebi rurali del Sud che si dibattevano nella miseria, la repressione puntualmente scattava al primo segno di rivendicazione alla terra. Un quadro della condizione sociale del Sud continentale venne disegnato con una certa efficacia dal contemporaneo Cesare Lombroso nel libro In Calabria 1862–1897. Sulla base di esperienze dirette egli dice: «La popolazione povera della città e del contado abita in piani terreni privi di luce e di ventilazione. In un solo ambiente vivono molti individui: grandi e piccoli, uomini e donne insieme coll’asino e le galline. In alcuni tuguri si agglomerano sino a venti mendicanti e nel mezzo dell’abituro vi è la latrina aperta e puzzolente. Le latrine sogliono mancare in molte abitazioni a pianterreno e i rifiuti si trasportano sotto le mura della città. Non vi sono lavatoi pubblici. Domina la sifilide ma non vi sono dispensari. Vi sono nove case di tolleranza». È probabile che i piemontesi si aspettassero di riscuotere al Sud lo stesso rispetto ed ammirazione che avevano suscitato in Lombardia e nel Veneto, ma la realtà fu diversa per precisi motivi. Fu chiaro che dell’annessione al Regno erano stati fautori la classe borghese ed i grandi agrari, storici antagonisti dei Borboni, per i quali ogni rafforzamento del loro potere era limitativo dell’assolutismo nel
64
governo. All’insegna del «divide et impera» il regime borbonico aveva aiutato i contadini con diversi provvedimenti che ne privilegiavano il rapporto con le terre demaniali. Però tali diritti vennero aboliti dai Piemontesi come primo atto della loro occupazione, con l’aggravio della introduzione di pesanti imposizioni tributarie. Sempre il Lombroso puntualizzava così lo stato di malessere delle popolazioni calabre: «Infatti la miseria è estrema nei contadini, in primo luogo, e poi negli operai. La retribuzione che ritraggono dal loro lavoro non è rispondente a ciò che è strettamente necessario al giornaliero sostentamento: quindi la loro vita di stenti e il malessere fisico e morale che li domina». Circa la politica antimeridionalistica dei governi dell’epoca, in realtà l’azione dello stato unitario nei confronti del Mezzogiorno si era rivelata carente sin dall’inizio, soprattutto per ciò che concerneva l’approntamento delle necessarie infrastrutture. A riguardo appare significativo che nel 1886, lo Stato spendeva nel Mezzogiorno per opere pubbliche e interventi in tutti i settori di competenza molto meno di quanto percepiva per tasse e imposte pagate dalle regioni meridionali. Per ogni dieci lire di tasse percepite nelle quattro regioni settentrionali, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, lo stato nel 1886 spendeva lire 40,40 pari ad una media per regione di lire 10,10 mentre nelle regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, spendeva lire 23,14 corrispondenti ad una media per regione di lire 5,70. Il delitto, nelle sue multiformi sfaccettature, rappresentava per gli strati più poveri delle campagne un modo per sopravvivere; il Lombroso così analizzava le conseguenze del malessere: «si spiega la frequenza del furto campestre diventato quasi un mestiere. I campi e i boschi sono saccheggiati perché il contadino, non ricavando dal lavoro la parte adeguata di prodotto per campar la vita, o deve delinquere, o emigrare, o coalizzarsi ed insorgere. La risultante di questi tre fattori è sempre la stessa: la demoralizzazione pubblica, di cui è inseparabile compagna la pubblica miseria. Di qui la lotta latente che a volta a volta minaccia di apertamente manifestarsi». L’approfondimento dell’analisi storica rivolta ad assegnare o meno una funzione rivoluzionaria e quindi politica al brigantaggío meridio-
65
nale conduce a definire una netta differenziazione fra brigantaggio sud continentale e brigantaggio siciliano. Il fenomeno, generato dal malessere del mondo contadino le cui rivendicazioni alla terra si erano infrante contro il muro della reazione eretto dai grandi agrari, assumeva nel territorio continentale motivazioni di classe. La ragione privata che aveva spinto il brigante a divenire tale si tramutava in posizione ideologica e, a volte, in una pretesa di lotta contro tutte le ingiustizie. In Sicilia, la borghesia agraria affermatasi con l’unità, aveva stretto rapporti con la mafia che, con la partecipazione ai moti rivoluzionari del ’48 e del ’60, aveva acquisito crediti nei confronti della classe dominante. In Sicilia la mafia, originariamente legata al latifondo, con l’unità si avvicinò all’area del potere scoprendo più vasti campi di azione e rivendicando, per le «prestazioni elettorali», contropartite sempre più consistenti. Approfittando del clima di delusione popolare determinatosi dopo il 1860, essa strinse legami coi briganti, li inserì nella consorteria mafiosa e li adoperò quali strumenti di repressione contro i suoi nemici rappresentati dalle forze progressiste del tempo. Di conseguenza i briganti siciliani, fagocitati dalla mafia e spesso protetti dalla borghesia agraria favorevole all’intervento piemontese ed antagonista dei borboni, non ebbero alcuna motivazione politica. Generati dal mondo contadino tradito ed oppresso si schierarono il più delle volte dalla parte dell’oppressore tradendo la iniziale matrice di protesta spesso catalogata, da chi ne voleva mitizzare l’immagine, come «nobile impresa di rivendicazione sociale». Tale apparve spesso la loro azione anche agli ingenui occhi popolari ai quali l’attesa messianica di una vicina situazione nuova non sempre serviva a sostenere la durezza del presente. Lorenzo Lorenzoni, nella sua inchiesta del 1910, puntualizza tale concetto: «Orbene questi briganti si sa che agiscono di pieno accordo colla mafia che li ricetta, li occulta, li protegge e divide con essi il provento delle taglie prelevate, come regolari imposte, sui proprietari e da questi considerate come un premio di assicurazione per avere salva la vita e protetti gli averi…».
66
Come già detto i briganti siciliani, che con Angelo Pugliesi avevano creato l’industria del sequestro di persona, che con Rocca e Rinaldi uccidevano a San Mauro di Castelverde il sindaco progressista inimicandosi la parte sana del paese, che con Sajeva agivano in aperta alleanza con la mafia di Agrigento, che con Leone seminavano terrore fra i contadini, s’erano posti al di fuori della tradizione brigantesca ch’era stata, in ogni tempo, ribellione aperta contro il potere e la proprietà, si erano dimostrati incapaci di tradurre la loro protesta emotiva in lotta, si erano sottomessi alla mafia ed alla borghesia agraria nemici dello stesso mondo contadino da cui provenivano. Nelle regioni del Sud continentale il fenomeno del brigantaggio ebbe invece un accentuato riflesso politico in quanto, spesso, si affiancò al bracciantato contadino nella opposizione ai Piemontesi e nella resistenza all’abbattimento del regime borbonico. In ciò i briganti calabresi, lucani, pugliesi e campani, furono coerenti con una scelta che, sebbene reazionaria, si rifaceva al «gioco delle parti» nel momento in cui le masse contadine, contrapposte alla borghesia agraria fautrice dell’avvento unitario, si trovarono a contrastare le posizioni assunte dai «galantuomini» schierandosi dalla parte dei borboni. Dice infatti Antonio Altomonte (in Mafia, briganti, camorra e letteratura) «Non per nulla, paradossalmente, la difesa del Regno delle Due Sicilie, nel Sud continentale, è stata assunta da quel bracciantato che tutto aveva da guadagnare da un cambiamento». Successe che i «galantuomini più abili nel prevedere la direzione del vento, si erano messi subito dalla parte dei piemontesi, per cui i contadini ai quali, per ragione di classe, spettava di trovarsi sulla sponda opposta, non restò che occupare la posizione lasciata libera dai galantuomini. Quando questi ultimi partirono per unirsi alla Guardia nazionale ed alle Camicie Rosse per cacciare i Borboni, molti contadini staccarono i fucili dal muro e presero le difese dei vecchi “oppressori”. Il brigantaggio che interessò le regioni Sud continentali, rappresentò, insieme alla resistenza antipiemontese del bracciantato contadino, un vasto fenomeno di carattere politico e sociale e possiamo ben dire che costituì un esempio di lotta contadina
67
che trova riscontro solo nelle rivoluzioni sud americane». Su ciò le interpretazioni degli storici non sono concordi. Infatti riferendosi alla lotta dei briganti e del bracciantato contadino del Sud contro i nuovi dominatori piemontesi, Denis Mack Smith (Storia d’Italia dal 1861 al 1958) è più propenso ad escludere una vera e propria motivazione politica affermando che «più di una rivoluzione politica, si trattava di un prodotto della disoccupazione, dell’antica tradizione di rapina stimolata da uno stato di rivolta endemica delle plebi. Molti briganti avevano originariamente abbracciato la loro professione allo scopo di regolare i conti con qualche avversario locale ed erano quindi riparati sulle montagne per sfuggire alla giustizia». Anche ammettendo che il brigante non era mosso da una vera motivazione politica dobbiamo riconoscere che il sentimento di solidarietà e lasimpatia che molti cittadini dimostravano ai briganti, trovava certamente fondamento nella loro avversione ad un sistema di governo subìto ma non accettato e questo fatto aveva un suo riflesso politico espresso con una chiara presa di posizione contro il nuovo regime. Dice lo stesso Denis Mack Smith, parlando di questo vasto fenomeno che interessava le regioni meridionali, «Molti cittadini, pur non partecipando essi stessi al brigantaggio, consideravano i briganti come combattenti legittimi nell’eterna guerra contro i proprietari terrieri ed un governo eccessivamente remoto, quasi straniero». Inoltre ricordando il capo brigante Carmine Crocco, Ludovico Greco, nel suo libro Piemontesi, briganti e maccaroni, affermava: «Nella sua migliore stagione, tra i boschi di Lagopesole e sui greti del Sauro, Crocco era Pancho Villa. E i suoi peones scorrevano al galoppo flagellando e vincendo…» Lo stesso Crocco esaltava, da vero «generale» la lotta contro il nemico piemontese riconoscendo la mancanza di un vero ideale nelle file dei briganti e delle masse contadine, affermando: «Il valore di noi basilicatesi e pugliesi non era secondo a quello dei piemontesi, per quanto mancasse in noi l’entusiasmo di un ideale e si combattesse con la tempesta degli odi nell’anima». Ma a sostegno della componente politica e sulla dimensione del brigantaggio in Calabria, Temistocle Mariotti, volontario garibaldino, ne Una pagina del brigantaggio in Capitanata negli anni 1862-65
68
così scriveva: «L’esercito nazionale, reduce pur allora dalla campagna di guerra del 1860-61, dovette affrettarsi a riprendere la via delle province meridionali dove non più si sarebbe trovato di fronte alla guerra regolare ma ad un immane fenomeno di carattere politico sociale, di conflagrazione selvaggia, sconosciuta, inaspettata per le truppe, difficilissimo quindi ad essere da esse padroneggiato e domato. Ad ogni modo, cominciò allora quella lotta terribile che, nonostante leggi eccezionali, energiche, severissime, nonostante il governo fosse messo in mano dei militari, si prolungò per quasi un quinquennio con incredibile audacia dei briganti, con abnegazione e sacrifici inauditi dell’esercito il quale largamente bagnò del suo sangue quelle terre e vi lasciò a brandelli le sue membra mutilate e seviziate: per le misere popolazioni fu un quinquennio di uragani spaventosamente devastatori». La classe dirigente liberale non riconobbe tuttavia al vasto fenomeno del brigantaggio Sud continentale alcun movente politico ma ebbe interesse ad interpretarlo come semplice manifestazione di criminalità. Un fatto significativo: il comune di San Marco in Lamis, in Puglia, nel corso della prima festa dello statuto, il 2 giugno del 1861, venne occupato per tre giorni da una numerosa banda di briganti guidati da Del Sambro e Nardella che il giorno seguente, affiancati da molti popolani, uomini e donne, affrontarono in una vera e propria battaglia un reparto dell’esercito regolare al grido di «Viva Francesco, viva Pio Nono, viva la religione!». Il fine politico venne scartato dalla classe dirigente liberale per il solo fatto che popolo e briganti non avevano pensato, per mera ignoranza dei metodi politici, civili ed amministrativi, a rovesciare, come in ogni sommossa che si rispetti, il governo della città. Si disse che «… i briganti, sotto le misteriose apparenze di un fine politico, trovano il pretesto di velare le loro iniquità e i loro trascorsi». Ma non era la solidarietà tra briganti e popolari a confermare la componente politica del fenomeno? In varie località della Puglia avvennero veri e propri assedi in cui interi paesi furono messi a ferro e fuoco dai bersaglieri mentre i briganti rispondevano colpo su colpo riuscendo spesso ad avere la meglio sulle truppe regolari. Il popolo, che era apertamente contro i «nazionali», considerava i briganti i veri soldati del Borbone.
69
Il delegato di pubblica sicurezza di Molfetta, Carlo De Donato, con evidente insensibilità storica, così motivava la sua rabbia per la solidarietà tra briganti e popolani: «Non vi era modo a far persuasi questi popolani che i briganti tutti erano nemici da odiarsi, gli usurpatori delle loro sostanze, gli insidiatori della loro stessa vita, i disturbatori continui della pubblica pace, quelli, infine, che oggi o domani alla bocca dei fucili avrebbero pagato con la più infelice morte il fio delle perverse azioni». Ma al di là del tentativo, effettuato dalla classe dirigente liberale, di dare a tali fatti una interpretazione circoscritta alla sfera criminale, non poté essere sottaciuto che, alla base delle azioni armate popolari e brigantesche, stava la spinta sociale sempre presente come fatto fortemente istigatore che, sebbene caratterizzato dalla forte passionalità delle masse, non perdeva il suo significato politico. A riguardo dice bene Pasquale Soccio nel suo libro Unità e brigantaggio, Napoli 1979: «A parte il movente sociale, sempre presente, già cronico durante il passato regime e che qui spunta, anzi esplode clamorosamente ed emerge come fortemente istigatore, a parte l’endemica ignoranza del tempo borbonico e 1’istigazione clericale e i fatti personali e la brama di sangue e di rapina dei briganti, lo scopo “precipuo” e non “secondario” parrebbe essere proprio quello politico». A tale stato di cose si rispose solo con la repressione come afferma Denis Mack Smith: «la severità a breve scadenza era ovviamente qualcosa di più urgente e più facilmente comprensibile nella lontana Torino. Il risultato di ciò fu l’approvazione della legge Pica… e 120.000 soldati, quasi la metà dell’intero esercito furono concentrati in Sicilia e nel Mezzogiorno continentale». Una lettera scritta nell’agosto del 1861, dall’ex Presidente del consiglio, il piemontese Massimo d’Azeglio, contribuì ad aggravare la frattura fra Nord e Sud: «A Napoli noi abbiamo altresì cacciato il sovrano per stabilire un governo fondato sul consenso universale. Ma ci vogliono, e sembra che ciò non basti per contenere il regno, sessanta battaglioni: ed è notorio che, briganti e non briganti, niuno vuole saperne. Ma si dirà: e il suffragio universale? Io non so nulla di suffragio: ma so che al di qua del Tronto non sono necessari battaglioni, e che al di là sono necessari. Dunque vi fu qualche errore e bisogna
70
cangiare atti e principii. Bisogna sapere dai napoletani un’altra volta per tutte se ci vogliono, sì o no». In merito a tale affermazione fatta da un esponente ufficiale della politica governativa, che era altresì espressione del pensiero dei più influenti conservatori liberali del Nord, Denis Mack Smith afferma che il «Sud stava così diventando il teatro di una guerra civile di tipo irlandese e per un certo numero di anni dovette sostenere il peso di quello che praticamente era un esercito di occupazione». In tale contesto le popolazioni meridionali più povere trovavano profondo motivo di avversione al nuovo stato anche per la cessazione di un sistema caritativo che in passato aveva sostenuto la sopravvivenza. Mentre in Calabria la reazione che attraeva i briganti era rappresentata dal regime borbonico; in Sicilia dove l’opposizione era amministrata dalla mafia, i briganti, anziché schierarsi contro i nuovi «oppressori», come avevano fatto i briganti calabresi, si misero dalla loro parte, agli ordini delle cosche mafiose e della borghesia agraria, in una posizione meno confacente alla loro originaria vocazione di ribelli. Il brigantaggio siciliano dell’ottocento, che rappresentava un ulteriore aggravamento della emarginazione del mondo contadino che doveva lottare contro un nemico in più, non combatté una guerra armata e organizzata, ma come si affermò nel corso dell’inchiesta parlamentare del 1874, «tranne alcune purtroppo gravi e forse non infrequenti eccezioni è formato da malfattori d’occasione». In Sicilia il brigante sociale che toglieva al ricco per dare al povero, apparteneva solo ai miti popolari e non rispondeva che in minima parte alla verità storica. È in questo processo storico che si inserì il cosiddetto «processo alla malavita meridionale», confermando l’orientamento antimeridionalistico del governo dell’epoca ed il suo disegno autoritario, concretizzatosi in una azione intimidatrice e persecutoria ai danni di popolazioni così tanto provate. Con le leggi speciali contro il brigantaggio, con gli stati d’assedio, con le azioni repressive contro le rivendicazioni popolari, si volle imbastire un grosso processo che doveva costituire una requisitoria alla morale collettiva e si strumentalizzarono i briganti e i gruppi di crimi-
71
nali comuni, che non erano certo una caratteristica peculiare di quelle popolazioni, mentre si lasciarono fuori i «mafiosi» e gli intoccabili amici del potere.
1886. Venditori di ostriche e pesce sul lungomare del rione Santa Lucia a Napoli
72
5 I fasci dei lavoratori
I fasci dei lavoratori, organizzazione sindacale che raggruppò, tra il 1892 ed il 1893, almeno trecentomila contadini, rappresentarono una sorta di risorgimento siciliano in cui la parola libertà significò liberazione dalla miseria, dal bisogno, dallo sfruttamento del padrone, dalle soverchierie perpetrate dalla mafia e dal potere in tutte le sue espressioni. Sembrò un sogno a portata di mano, che più concretamente voleva dire nuovi contratti agrari basati su condizioni di lavoro più umane e su rapporti di mezzadria che superassero quelli vecchi di tipo «angarico» in base ai quali una parte (il padrone) poteva sfruttare impunemente l’altra (il contadino). La celebrazione del primo maggio 1893 costituì un momento di grande importanza per l’affermazione del ruolo dei fasci sia nei confronti dell’opinione pubblica che della stessa classe lavoratrice, soprattutto per l’allargamento della base organizzativa del movimento. La celebrazione assunse in alcuni comuni proporzioni inaspettate, come avvenne nei centri di Termini Imerese, di Piana dei Greci, di Prizzi e di Corleone. Fu un giorno di grandi promesse e grandi speranze. Le sedi dei Fasci vennero addobbate con fiori e festoni dai quali pendevano cartelli con le scritte «Viva il I maggio», «Viva il socialismo». Il giornale «Giustizia sociale» del 6–7 maggio 1893 descrisse la festa di quel primo maggio a Corleone, il paese di Bernardino Verro. Ne riportiamo alcuni passi significativi: «La sera del 30 aprile la città
73
presentava un bel colpo d’occhio, il popolo era in movimento, era lieto, gioiva, esultava… Dal più umile dei tuguri, alla casetta linda dell’operaio, si notavano le finestre illuminate a lampioncini rossi, e poi le massaie e le rubiconde giovanette farsi bel tempo a preparare l’animo al grande avvenimento. Dentro il fascio, l’orchestra composta dai soci sin dalle prime ore pomeridiane intrecciava ballabili, continuando così la veglia sino alla mezzanotte, ora in cui fu cantato l’inno dei lavoratori per dare il buon riposo alla miriade dei soci. Che bella giornata è il I maggio del 1893 a Corleone!… Il fascio e le vie adiacenti erano impenetrabili, massime perché i contadini correvano a centinaia a iscriversi, la società cooperativa tra muratori, tutta in corpo fece adesione… La giornata passò tra suoni, balli e canti nonché con l’intercalare di non pochi contadini che spiegavano l’importanza della ricorrenza e che cosa sia e sarà il socialismo… Si aprì la veglia che si protrasse fino a tardi e tra baci e sorrisi si diede fine alla festa del I° maggio, augurandoci che un non lontano giorno metterà fine alle feste di esperimento e si chiamerà con la fiaccola in mano o con la scure ad abbattere il disincomodo borghese, per installarvi l’umanità stretta in un amplesso d’amore». Scrive Massimo Ganci ne I fasci dei lavoratori: «Oltre alle dure condizioni spesso angariche dei contratti d’affitto, oltre al predominio degli usurai e delle consorterie, oltre la svendita e la truffaldina minorazione dei possedimenti demaniali, oltre le imposte, con la loro ingiusta ripartizione ed il crudele sistema di riscossione, quando la crisi non fornì più il sistema per pagarle, avvennero espropri per morosità, sia pure per somme irrisorie, che privarono molti contadini della terra e quindi dell’unico mezzo di sopravvivenza per intere famiglie che vennero gettate nella più grande disperazione». Per l’agricoltura, che rappresentava per la Sicilia l’attività economica preminente, non era stato fatto quasi nulla dopo l’unità d’Italia. S’era drammaticamente avverata l’intuizione gattopardiana secondo cui «noi fummi i gattopardi, i leoni: chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra». Era avvenuto che ai nobili gattopardi, sperperatori dei loro patri-
74
moni nell’ozio e nel lusso delle loro ville palermitane, incapaci di integrarsi nel nuovo sistema politico ed economico erano succeduti i rappresentanti di una borghesia traffichina, ed avevano preso potere i gabellotti, esponenti questi della mafia imprenditrice. Si erano essi arricchiti alle spalle dei loro antichi padroni ed avevano usurpato i terreni demaniali, in beffa ai decreti di Garibaldi che erano rimasti, per volere della nuova classe dominante, lettera morta. Proprio i gabellotti rappresentavano la componente più rapace di tale nuova classe che intendeva, a tutti i costi, mantenere l’assetto feudale della proprietà e l’arcaico sistema di coltura. Il principio si basava sulla accumulazione del capitale e sulla minimizzazione del reinvestimento produttivo, il solo che avrebbe potuto assicurare un reale cambiamento dell’agricoltura nell’isola. In verità, neanche il governo aveva operato per una moderna trasformazione dell’agricoltura siciliana, poiché ci sarebbero voluti, da un lato adeguati investimenti e dall’altro lo smantellamento dei vecchi rapporti di sfruttamento che vigevano a danno del mondo agricolo; in effetti, con tale atteggiamento, i governi, che s’erano succeduti dopo l’unità d’Italia, avevano finito, più o meno per scelta politica, per difendere l’alto livello della rendita agraria e più in generale il mantenimento dei vecchi privilegi, creandone di nuovi. Era cresciuto a dismisura il malgoverno per cui, il quadro caratterizzante la società siciliana era, alla fine dell’800, fortemente deteriorato. Alcuni esempi: ruoli di contribuenti fatti arbitrariamente, proprietari che sottraevano impunemente i loro animali al censimento e all’imposta, sindaci, assessori e consiglieri comunali aiutati dall’autorità tutoria nel commettere arbitri e soprusi purché al momento elettorale servissero ai voleri dei sottoprefetti, dei prefetti, del governo insomma. In questo contesto la mafia trovò terreno fertile per il suo sviluppo secondo quel patto del dare e dell’avere che significò: «io ti faccio dare i voti per farti eleggere, tu mi fai i favori di cui abbiamo bisogno sia io che gli amici degli amici». Il sistema non era nuovo. Già, nel 1872, Leopoldo Franchetti ave-
75
va compreso la portata di tale «equazione» ed aveva scritto che: «La legislazione italiana, in generale, ed il modo con cui viene applicata, sono tali che, da un lato la classe proletaria viene per un verso data in assoluta balia della classe abbiente e, dall’altro, una porzione di quest’ultima ed anche la minore, può impadronirsi dell’autorità in modo da spadroneggiare senza controllo alcuno». Per quasi tutto l’ottocento, il popolo siciliano aveva vissuto tutta una serie di dissoluzioni per il fatto di non avere né coscienza dei propri diritti né capi in grado di guidare una riscossa. Era stato, in poche parole, nelle mani della classe dominante che riusciva ogni volta ad utilizzarne, per i propri fini, la capacità di ribellione per la rabbia sempre latente e l’incapacità a comprendere le mistificazioni del potere. Spesso, agli occhi del popolo, i padroni da cattivi diventavano buoni; accadeva tutte le volte che il baronaggio siciliano si schierava contro il potere regio divenuto, al momento, il nemico comune. In Sicilia, tali mistificazioni furono ricorrenti generando varie rivoluzioni nel quadro dell’eterna contrapposizione di Palermo nei confronti di Napoli ovvero dei baroni nei confronti del potere regio; il baronaggio siciliano mai si rassegnò a recitare un ruolo secondario, per cui tramò ad ogni occasione contro la capitale borbonica. Il popolo venne sistematicamente strumentalizzato finendo per recitare il ruolo di comparsa nel teatro della storia agendo, spesso, contro i propri interessi. Significativa, al riguardo, fu l’avversione popolare contro il Viceré Caracciolo che, continuando l’azione riformatrice di Carlo III, iniziata nel 1735, con la costituzione del Regno delle Sicilie, intendeva ridimensionare il potere dei baroni. Questi riuscirono a fomentare la contrapposizione popolare indicando, appunto, nel potere regio il nemico comune. A Palermo le masse popolari erano tenute d’occhio dalle maestranze alle quali era affidata la difesa dei baluardi della città e per tale incarico abilitate a portare armi. Con tale sistema si intendeva imbrigliare il ribellismo delle masse senza dover intervenire attraverso l’autorità costituita. Anche nelle campagne, il ribellismo popolare, che si esprimeva at-
76
traverso il fenomeno del brigantaggio, divenne strumento nelle mani della mafia che lo usò spesso contro lo stesso mondo contadino per la difesa di antichi e di nuovi privilegi. Fu la stessa mafia a distruggere il brigantaggio nel momento in cui (avvenne subito dopo l’unità d’Italia) potè agire all’interno del potere con mezzi legali. Tutto ciò ci aiuta a capire l’ansia, in molti casi passionale, che colse le masse popolari siciliane alla fine dell’800, nel momento in cui venne loro prospettata la possibilità di essere protagoniste della propria storia; a prospettare un progetto di riscossa c’erano finalmente i capi, con le loro ideologie, con la loro forte volontà di operare. Come abbiamo già detto, per la marginalità della sua situazione economica e sociale, la Sicilia che rappresentava il punto debole dell’intero sistema nazionale, aveva subito negli anni ’90 del secolo 1800, in misura più drammatica, la crisi economica che attanagliava il Paese. Il crollo dei prezzi delle derrate e la guerra doganale scoppiata fra Italia e Francia, provocarono il crollo della piccola e media proprietà con gravi contraccolpi anche per l’industria, con la conseguenza che il fragile capitalismo siciliano si trovò in grosse difficoltà anche per l’attacco sferrato dal nascente capitalismo monopolistico del Nord, indubbiamente più progredito e certamente favorito dal potere pubblico. La crisi, che colpì in modo particolarmente drammatico i settori agricolo e minerario, si riversò sul mondo agricolo e dei minatori che videro aggravarsi l’allucinante situazione di sfruttamento perpetrata, da sempre, nei loro confronti, da parte di proprietari e imprenditori che, neppure con tale sfruttamento del lavoro, riuscivano a produrre alcuna accumulazione capace di far nascere rapporti capitalistici più funzionali dai quali ottenere maggiori profitti. Quindi la crisi agrario-zolfifera e quella industriale (il crollo della Banca Romana aggravò ancor più la crisi nazionale) fece precipitare ulteriormente la condizione della classe operaia e contadina dell’Isola. Dal diffuso malcontento e dagli scioperi spontanei, scarsamente efficaci per assenza di una adeguata organizzazione, si passò al reclutamento sindacale che diede vita al movimento dei Fasci dei lavora-
77
tori, ovvero ad una organizzazione più moderna ispirata da Garibaldi Bosco che aveva visitato le organizzazioni operaie milanesi ed aveva studiato a Parigi la «Bourse du Travail». Nell’intento di Bosco, c’era quello di associare i Fasci siciliani al Partito dei lavoratori di Milano allo scopo di aggiungere alla funzione mutualistica anche quella politica. Al Congresso dei Fasci dei lavoratori tenutosi a Palermo nel maggio 1893, l’intento di Bosco, definito «tendenza milanista» in quanto aveva un carattere politico con conseguenti obiettivi elettorali, venne respinto da De Felice Giuffrida il quale sosteneva invece un discorso «autonomista» ovvero l’idea di una organizzazione politica «autonoma», con programma proprio, coerente con l’autonomismo che aveva caratterizzato il programma del suo movimento popolare. Ma De Felice Giuffrida, che aveva orientato il Fascio catanese verso una prassi riformistica, fece propria, al Congresso di Palermo, con sorprendente incoerenza, una tattica insurrezionalistica ed anarchica nettamente in contrasto con quella del Congresso di Genova del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani alla cui linea Garibaldi Bosco aveva aderito. Con tutta probabilità De Felice Giuffrida, contestando la posizione assunta dal Bosco, intendeva contrapporsi alla linea politica dei Fasci della Sicilia occidentale che era coincidente con quella del socialismo nazionale. Tale intento del Giuffrida era da ritenersi alquanto attendibile se si considera la successiva sua espulsione dal partito socialista con l’accusa di «tendenze» borghesi. Il Congresso accettò la linea di Genova e, con grande maturità, vennero accolte le proposte avanzate da De Felice e da altri, volte ad improntare l’organizzazione regionale del Partito a criteri di autonomia, costituendo come venne deciso, per il necessario coordinamento, un Comitato Centrale. Secondo quanto stabiliva lo statuto, ciascuna sezione dei Fasci avrebbe aderito al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. Lo Statuto dei Fasci inoltre stabiliva che «I Fasci dei lavoratori di Sicilia dichiarano costituirsi in sette federazioni, una per ogni provincia» e
78
che «Tutti i Fasci di ciascuna Federazione si dichiarano sezioni del Fascio». Quali furono le motivazioni dell’adesione ai Fasci? – C’era un contesto socio-economico che aveva creato una esigenza di lotta resa inderogabile da una crisi che gravava drammaticamente sulle classi meno abbienti; – c’era un riferimento ideologico nel partito socialista improntato alla lotta di classe; – c’era una nuova organizzazione sindacale (I Fasci) che aveva aderito al Partito Socialista accogliendone le direttive politiche ed i programmi sociali; – c’erano i Capi, in grado di orientare le masse secondo nuovi metodi di lotta; – c’era un programma volto a superare la vecchia impostazione anarco-operaista attraverso una strategia articolata, basata sulla organizzazione sindacale del movimento contadino ed operaio, abbandonando definitivamente le caratteristiche delle vecchie società di mutuo soccorso e lo spontaneismo insurrezionalistico. Antonio Gramsci, nel trattare della questione meridionale avrebbe scritto: «Il mezzogiorno può essere definito una grande disgregazione sociale; i contadini costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione, non hanno nessuna connessione tra loro (…); sono in continuo fermento, ma come massa essi sono incapaci di dare una espressione centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni». Ma il programma dei Fasci, che aveva inteso superare tale concetto, non conteneva nessuno degli elementi caratterizzanti la vecchia impostazione anarco-operaista, tipicamente di mutuo soccorso. Il movimento rappresentò invece un primo segno importante di quella espressione «centralizzata» delle masse meridionali mentre, forse, era da dimostrare, e lo si poteva fare solo coi fatti, che quelle masse fossero mature, specie rispetto alla natura dei vasti processi economici allora in atto, e quindi pronte a recepire il carattere sociale e conseguentemente politico che gli stessi promotori avevano dato al nuovo movimento. Già agli inizi del 1893 le organizzazioni dei Fasci erano diffuse
79
in quasi tutte le grandi città siciliane ed in moltissimi borghi rurali dell’Isola; rappresentavano concretamente la prima presa di coscienza antipadronale, attraverso una opposizione solidale alle prepotenze dei grandi agrari e dei gabellotti. Ha scritto lo storico Massimo Ganci: «Era vivo nell’animo popolare il senso religioso delle vicende umane, il bisogno, cioè, di ricercare ovunque il senso del divino, per cui le masse erano convinte che fossero arrivate le scadenze fatali del millenarismo dallo scoccare delle quali sarebbe giunta la redenzione, “perché era scritto che doveva giungere”, rafforzando paradossalmente queste istanze, rendevano più intensa la preparazione attiva del mondo migliore e la sostituivano all’attesa escatologica del passato». Sulla organizzazione dei Fasci il giornalista Adolfo Rossi, nell’ottobre del 1893, così scriveva ne La Tribuna dimostrando che non tutto nei Fasci era coerente con i principi della moralità: «Trovai che nelle province di Palermo, Girgenti e Caltanissetta il movimento era realmente serio specialmente, anzi quasi esclusivamente, fra i contadini. In certe regioni si era diffuso come una specie di contagio; le turbe erano invasate dalla credenza che fosse imminente un nuovo regno di giustizia, si riunivano nelle rustiche sedi dei fasci col fervore con cui si dovevano raccogliere una volta i seguaci di Spartaco, ne’ grandi boschi, e i primi cristiani nelle catacombe; quando si inaugurava in un paesello un nuovo fascio, ciò si faceva con lunghe processioni in cui invece delle croci si portavano in giro delle bandiere rosse e certe tabelle infisse sulla punta di pali, con iscrizioni socialistiche. Non dappertutto però i fasci avevano un vero carattere socialista moderno. In taluni luoghi non erano altro che un’accozzaglia di poveri ignoranti organizzata da qualche ambizioso contro il partito dominante del Municipio. In altri paesi i fasci s’erano formati, per istinto di imitazione; in altri ancora invece dell’idea socialista si trovava una specie di mania religiosa, alla Lazzaretti, tanto è vero che nelle sedi di alcuni fasci vidi il crocifisso col lumino acceso davanti; in altre il fascio non era che la riunione di birbaccioni i quali col nuovo nome di fascio battezzavano le stesse associazioni di delinquenti che una volta si chiamavano della mafia o della camorra». «Quello della presenza di elementi mafiosi fra gli iscritti dei fasci
80
dei lavoratori fu un argomento su cui puntò molto Giolitti nell’intento di poter trarre pretesto per soddisfare le richieste di scioglimento di quella associazione di lavoratori, che gli venivano da tante parti, dai sindaci di molti comuni, dai proprietari terrieri, dai funzionari di polizia e di prefettura ed anche dai circoli vicini alla corte e dallo stesso Sovrano». I Prefetti siciliani, nell’agosto del 1893, furono invitati allo «studio diligente e sollecito sulle condizioni dei Fasci operai in codesta provincia e provvedimenti circa quelli i quali, per essere composti di persone pregiudicate, ovvero per atti che abbiano compiuto». Questo invito faceva seguito ad una circolare nella quale, sin dal 27 giugno dello stesso anno, il Ministro dell’Interno aveva chiesto, a mezzo dei questori, gli elenchi e le fedine penali degli iscritti al Fascio, da cui risultasse chi fossero, tra gli affiliati i pregiudicati, cioè le persone che avevano subito condanne e, comunque, erano state sottoposte a giudizi in generale. In base ad una prima sommaria indagine effettuata, i questori di Girgenti e Caltanissetta segnalavano che, nelle rispettive province, i pregiudicati iscritti ai Fasci erano in numero elevato; per la provincia di Caltanissetta veniva affermato che il numero di tali pregiudicati superava il migliaio. Ma la segnalazione si rivelava non attendibile, oltre che per le lacune della documentazione, per la incertezza del metodo con cui furono raccolti i dati. Infatti vennero, con tale superficiale indagine, considerati pregiudicati molti contadini che avevano subito multe per evasione del dazio di consumo e anche tutti coloro che avevano partecipato alle manifestazioni dei primi di maggio e che, per tale motivo, erano stati oggetto di denuncia in massa. Questo criterio, certamente assurdo, venne definito dal deputato Napoleone Colajanni un «capolavoro di infamia». Scrive a riguardo Salvatore F. Romano nel suo libro Storia della mafia: «Trovar pregiudicati in Sicilia non era certo difficile, se si considera che tra leggi eccezionali di polizia, governi militari, stati d’assedio, in una regione dove anche le lotte per la conquista delle amministrazioni comunali e la litigiosità giuridica avevano grande parte,
81
non erano pochi negli strati popolari coloro che per un verso o per un altro avevano modo di incorrere in denunzie, querele, lievi condanne o nella ammonizione». Ma la realtà, pur con la incertezza dei criteri utilizzati per la indagine, che pareva dovesse approdare ad un risultato di netta condanna dei Fasci, risultò molto diversa. Nella provincia di Palermo, ad esempio, dove il fenomeno della mafia era storicamente molto diffuso anche negli strati popolari dei quartieri e della campagna, in numerosi Fasci non risultò affiliato nessun pregiudicato e, per il resto di tali organizzazioni, i pregiudicati (di piccolo calibro) risultarono in numero alquanto ristretto. L’inchiesta voluta da Giolitti non evidenziò quindi un fenomeno apprezzabile di partecipazione di elementi mafiosi, tale da permettere lo scioglimento dei Fasci, che da più parti si auspicava. Il clamoroso fallimento dell’inchiesta risultò eloquente dal rapporto inviato dal Prefetto di Palermo al quale erano state allegate le fedine penali degli iscritti ai Fasci che si potevano ritenere pregiudicati. «Dopo un attento esame, portato sui singoli Fasci, ho rilevato che i condannati messi in confronto col numero piuttosto considerevole dei consoci, sono una insignificante minoranza. Ed è perciò che non si possa, sotto questo riguardo, adottare un provvedimento di rigore a carico dei Fasci. Tanto più che mancherebbe la relativa prova specifica, non essendo in potere dell’autorità registri, atti e documenti, per accertare la vera posizione giuridica degli affiliati ai singoli Fasci e potendosi d’altro canto ad arte accampare dai componenti dei rispettivi consigli di amministrazione 1’ignoranza che il socio iscritto fosse pregiudicato». L’affermazione del giornalista Adolfo Rossi, pur se in qualche caso poteva risultare non del tutto infondata, poiché alcuni elementi mafiosi erano entrati nei Fasci o ne avevano costituito qualcuno per la conquista dell’amministrazione comunale in varie province, si riferiva a casi eccezionali in quanto il «movimento» si poteva di certo considerare, nella sua vera essenza, lontano dagli strati criminali dell’Isola. La prova del carattere sostanzialmente antimafioso dei Fasci, malgrado la presenza di alcuni gruppi minori, si ritrovò nella parte vera-
82
mente decisiva che ebbero i gruppi mafiosi nell’azione provocatoria e nella repressione del movimento. Scrive a riguardo Salvatore F. Romano: «Quei Fasci che derivano dalle trasformazioni di precedenti associazioni di mafiosi non erano riconosciuti in linea di principio dal Comitato centrale del movimento che, per principio, escludeva l’ammissione anche soltanto di semplici pregiudicati… Le deroghe si ispiravano al criterio che l’assorbimento di piccoli mafiosi nelle associazioni di lavoratori significherebbe un passo decisivo per la emancipazione di questi pregiudicati e di minori mafiosi dall’influenza dell’alta mafia, e probabilmente anche un indebolimento, e perfino la scomparsa, dell’attività mafiosa stessa». I gruppi mafiosi delle campagne, espressione di quella mafia ch’era ascesa a posizioni di prestigio economico attraverso l’acquisizione di proprietà terriere e la gestione della produzione agricola, attuarono l’offensiva meno nota ma assai sanguinosa nei confronti dei fasci. Per questi gruppi mafiosi più direttamente interessati alla rendita agraria, il movimento contadino rappresentava un serio pericolo per il mantenimento di tale rendita oltre a costituire la sola opposizione alla usurpazione dei territori demaniali già in buona parte acquisiti illegalmente con la complicità della stessa pubblica amministrazione. Altri gruppi mafiosi svolgevano una azione di intermediazione parassitaria tra il capitale e le forze del lavoro assicurando, con le loro iniziative intimidatorie, contratti convenienti per i padroni che, avvalendosi di ingiustificate accumulazioni derivate dalle mercedi di fame corrisposte ai poveri braccianti, rafforzavano di continuo il loro potere contrattuale. Due campi di azioni, quindi, in cui la mafia imponeva spudoratamente la propria volontà con l’intento di stroncare ogni tentativo di avanzamento delle masse contadine. Ma c’erano altri settori di attività in cui la mafia faceva sentire il suo peso. Basti citare i settori «amministrativo» e «politico» dove l’azione repressiva, nei confronti del popolo, risultava puntuale ogni qualvolta era in pericolo la posizione di qualche «amico degli amici» attaccato, giustamente, da esponenti progressisti che si riconoscevano spesso negli ideali del partito socialista. Tale azione repressiva si avvaleva essenzialmente dei legami fra
83
attività criminosa ed attività economica e politica, come pure fra giustizia privata e giustizia pubblica, utilizzando mezzi e sistemi differenziati, a seconda delle diverse situazioni, per conquistare posizioni di potere sempre più forti. Punte avanzate, in tale azione, erano i gabellotti e i campieri i quali rappresentavano il reale gruppo dirigente di quel fenomeno di criminalità politico-sociale che, sul piano storico, viene indicato col termine di «mafia». Circa la definizione di mafiosi minori è da considerare che, nella evoluzione del fenomeno della mafia dopo l’unità d’Italia, nel passaggio quindi da mafia storica a mafia imprenditrice, inserita nel potere legale dello Stato, vennero tagliati fuori gli strati inferiori della mafia cosiddetta popolare, che finirono per non avere alcuna forza economica, né riuscirono ad esercitare una influenza politica e sociale di un qualche rilievo. I grossi papaveri della mafia divennero in sostanza «governativi» e si schierarono apertamente (avverrà chiaramente nel corso della provocazione e della repressione) contro il movimento socialista. Chi erano i capi del movimento? Elemento di spicco dunque fu Rosario Garibaldi Bosco, palermitano, classe 1866. Nell’elenco nominativo dei soci più influenti del Fascio dei lavoratori, redatto dalla Questura di Palermo in data 22 ottobre 1892, così di lui era scritto: «Non ha alcun procedimento penale. È di bella cultura, di un ingegno molto svegliato. Cominciò a manifestare idee socialiste nel 1885. In qualunque occasione fu sempre il primo ad agitare le classi operaie. Essendo riuscito, sul finire del 1892, a costituire in Palermo il Fascio dei lavoratori, ha acquistato grande influenza in Palermo e in tutta l’Isola, da ritenersi superiore a qualsiasi altro socialista». Giovanissimo Garibaldi Bosco era stato segretario di tutte le associazioni popolari di Palermo. Sulla base dell’esperienza della «Bourse de Travail» di Parigi, dove si recò per studiare quella organizzazione sindacale, costituì il Fascio di Palermo dividendolo per sezioni d’arti e mestieri.
84
*** Bosco rappresentò la corrente più avanzata del movimento che venne esaltata dal successo fulmineo avutosi nelle zone agricole nei primi mesi del 1893: quella corrente si era spinta al di là delle posizioni radicali di partenza aderendo al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e s’era legata al movimento contadino siciliano, favorevole ad un più stretto collegamento con il socialismo nazionale e con le linee espresse al Congresso di Genova. Ha scritto lo storico Massimo Ganci: «La Direzione Centrale del partito socialista, attraverso Bosco e la maggioranza del comitato centrale del partito, condizionava però ai suoi principi, e alla sua linea politica intransigente, il movimento operaio e contadino siciliano». Giuseppe De Felice Giuffrida, catanese, nato nel 1860, era l’ispiratore della corrente «autonomista» che chiedeva uno statuto e una organizzazione indipendente dal partito socialista che s’era costituito a Genova nel 1892. Aveva organizzato il Fascio di Catania ed era l’animatore del giornale democratico «Unione» che portava avanti un’aperta lotta contro la mafia ed il malcostume che spadroneggiavano in quella parte dell’Isola. Venne eletto deputato nel 1893 ed ebbe molto ascendente sulle masse; fu uno dei maggiori combattenti dei fasci dei lavoratori. De Felice Giuffrida fu l’anima del movimento dei Fasci catanesi che erano in parte opera sua. A differenza della Sicilia Occidentale, dove il movimento politico-sindacale era caratterizzato dalla prevalenza della struttura orizzontale, soprattutto in chiave sindacale (i grandi scioperi agrari e minerari della primavera-estate 1893 lo attestarono), nella Sicilia Orientale era l’organizzazione verticale, culminante nel vertice defeliciano, ad egemonizzare il movimento operaio, con una curiosa sintesi di riformismo e di anarchismo ribellista. La struttura dei Fasci catanesi ricalcava, infatti, ancora più marcatamente di quelli palermitani, lo schema delle società di mutuo soccorso. Il Fascio di Catania in questo senso fu esemplare; il primo ad essere costituito in Sicilia il I maggio 1891, fu quello che più fortemente risentì l’influsso del Fascio democratico bolognese.
85
Bernardino Verro, corleonese, classe 1867, fu l’ardente animatore del grande sciopero agrario dell’estate del 1893 e fu tra i più attivi promotori del Congresso di Corleone e ispiratore dei «patti agrari», che intendevano conquistare un minimo di giustizia nella divisione del raccolto e dei salari. Nei primi del 1900 venne ucciso per mano della mafia. Nicola Barbato, medico di Piana degli Albanesi, nato nel 1859, abbracciò le idee socialiste operando nel suo paese a favore dei poveri e dei perseguitati. Considerato sobillatore dalle autorità, patì arresti, processi e condanne. Egli, fervente rivoluzionario, riuscì ad organizzare a Piana degli Albanesi, un «Fascio» che contava oltre 4000 iscritti, compreso un migliaio di donne. Scrive Massimo Ganci: «Nicola Barbato non era un medico qualsiasi; la sua era una personalità spiccata, nella quale era insita la componente apostolica cioè quella del medico dei poveri che non cura solo il corpo ma anche la coscienza dei propri pazienti ai quali infondeva speranza e fiducia… La preparazione alla lotta dei suoi contadini divenne lo scopo della sua vita e di quella dei suoi amici più fedeli: egli era fautore di un ruolo da “collettivo intellettuale” che agisse con la massa, in un continuo rapporto con essa e che non si limitasse a guidarla staccato da essa, ma ne sapesse recepire le istanze ancora vaghe per formularle in modo politicamente esatto». Il fascio di Palermo assunse un ruolo guida per l’esperienza del locale movimento operaio ma, soprattutto, per l’antica tradizione democratica e risorgimentale che aveva visto Palermo alla guida delle insurrezioni del 1812, del 1820, del 1848 e del 1860. Il mito di Palermo rivoluzionaria esercitò un notevole fascino su tutto il movimento. Si disse che Palermo «s’era svegliata dal sonno come il leone» ed in quei giorni, il fatto più significativo fu che operai ed artigiani non costituirono più gli elementi trainanti del movimento. Tale ruolo venne assunto dai contadini che ne divennero la forza più cospicua. Il centro di gravità dei fasci si spostò, di conseguenza, dalla città alla campagna, gli iscritti alla fine del 1893 erano 300 mila, i contadini raggiungevano le 200 mila unità mentre gli operai e gli artigiani insieme raggiungevano i 100 mila iscritti. Tale aggregazione aveva un
86
grande significato ove si pensi a quello che Antonio Gramsci avrebbe scritto: «Ogni formazione di volontà collettiva nazionale e popolare è impossibile se le grandi masse popolari non irrompono simultaneamente nella vita politica». L’eccidio di Caltavuturo, avvenuto nel gennaio del 1893, aveva convinto le masse rurali che, contro ogni forma di repressione, si doveva porre la resistenza di tutti i lavoratori e che solo i fasci, in quel preciso momento storico, potevano rappresentare una concreta occasione di unità sindacale per avviare le vertenze volte ad ottenere migliori mercedi e più moderni contratti di lavoro. Il subitaneo diffondersi dei fasci aveva proposto, con urgenza, il problema della resistenza nelle campagne e, sebbene non mancassero del tutto i precedenti, questo era, tutto sommato, un problema nuovo, almeno di quelle proporzioni. Il fatto delineò, nel programma volto all’ottenimento di nuovi contratti agrari e, più in generale, di migliori condizioni economiche per il lavoro bracciantile, l’obiettivo vero della lotta. Al riguardo, il congresso dei fasci dei lavoratori che si tenne a Corleone nel maggio del 1893, servì a stabilire una piattaforma rivendicativa, appunto tesa a definire gli aspetti normativi ed economici nel rapporto tra proprietari e mezzadri nonché a fissare nuove e più giuste mercedi per i lavoratori della terra. Quale fu l’atteggiamento del potere nei confronti di questo movimento contadino? All’inizio della vita dei fasci, Giolitti, in quel periodo Presidente del Consiglio, lasciò correre, pensando forse che le nuove associazioni contadine potessero perseguire l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della terra in ciò riuscendo a condizionare o neutralizzare la resistenza dei proprietari terrieri siciliani. Probabilmente Giolitti aveva ben chiara in mente l’affermazione di Sidney Sonnino che, nella famosa inchiesta del 1877, notava come cominciasse «a nascere nei contadini siciliani la coscienza della loro forza quando operino in comune e la persuasione di dover aiutarsi da sé e coi mezzi legali. Del resto non vi sarebbe nulla che dovesse spaventarci in un movimento contadino che tendesse per mezzo delle
87
associazioni ad ottenere un miglioramento della loro sorte. Se lo Stato e i proprietari non vorranno adoperarsi efficacemente per mutare le condizioni attuali, non resta altra speranza per l’avvenire che in un simile movimento di contadini stessi».
1896. Due automobilisti che partecipano alla “Coppa della Velocità di Brescia”
Ma Giolitti ben presto, su pressione dei grandi agrari, iniziò a mutare atteggiamento prospettando lo scioglimento dei Fasci, tentando di dimostrare, (non riuscendovi) che si trattava di organizzazioni formate preminentemente da elementi mafiosi. Caduto Giolitti, nel di-
88
cembre 1893, Crispi non avrebbe perduto tempo mirando diritto al cuore del movimento. Bisogna considerare che i grandi agrari siciliani rappresentavano una grossa forza politica in grado di farsi rappresentare nel governo ai massimi livelli (avvento di Crispi al potere) e quindi di influire anche sulle scelte politiche. Erano pertanto in grado, se ce ne fosse stato il bisogno, di chiedere perentorie azioni a tutela dei propri interessi che erano, innanzi tutto, strenua protezione delle rendite parassitarie attraverso il mantenimento di quello statu-quo economico e sociale nel quale le masse contadine rappresentavano la controparte da opprimere. In effetti, i nuovi patti agrari di Corleone, pur progettando un concreto avanzamento delle condizioni delle masse rurali dell’Isola, rivelavano il distacco culturale dei Capi dei Fasci dal dibattito nazionale che, nella mezzadria, aveva il punto di maggiore frizione fra conservatori e progressisti i quali si muovevano verso l’abolizione di tale forma di rapporto contrattuale. Ma anche in Sicilia, l’azione svolta dai contadini del latifondo, tipica realtà delle province occidentali, che si battevano per modificare il sistema della mezzadria, non rappresentava l’avanguardia più moderna dell’intero schieramento contadino siciliano. Infatti, nelle zone interessate da una agricoltura più progredita, come quelle di Siracusa, Catania, Messina e come quella di Marsala che, pur essendo ubicata nell’estremo lembo occidentale, si avvaleva di diffuse colture specializzate, i lavoratori agricoli propugnavano un più moderno inserimento dell’agricoltura in una nuova società rurale nel più vasto contesto di una società capitalistica fondata su un nuovo equilibrio sociale ed economico. Si può affermare che la condizione di massima arretratezza in cui versava il mondo rurale, sottoposto alla dura legge di sfruttamento del latifondo nelle province occidentali dell’Isola fu causa di una dura conflittualità che forse anticipava un più maturo ed avanzato processo di rinnovamento. Ma l’urgenza della miseria non fece attendere giorni migliori e pose il problema delle riforme dei contratti agrari in termini assai perentori.
89
Da considerare, però, che il problema della riforma dei contratti agrari era di rilevanza nazionale ed il governo, ammesso che avesse avuto l’intenzione di affrontarlo in termini positivi, doveva fare i conti (e Giolitti lo aveva intuito) con i grandi agrari del Sud ed in particolare con quelli siciliani che costituivano una notevole forza reazionaria e conservatrice. I successi ottenuti con le lotte salariali di primavera, con il congresso socialista di Palermo ed in modo più marcato con il congresso di Corleone dei Fasci dei Lavoratori, che portò molti proprietari ad accettare i nuovi «Patti», spinsero i grandi agrari ad intervenire sul governo affinché fermasse con la forza l’avanzata del movimento contadino. Il Congresso di Corleone, tenutosi nel luglio del 1893, coglieva le istanze contadine, che consistevano essenzialmente nella concessione di patti agrari più equi e nell’aumento della mercede giornaliera dei braccianti. Queste richieste furono approvate dal Congresso che elaborò una vera e propria piattaforma politica concernente nuovi patti agrari con cui venivano abolite tutte le inique forme che regolavano i vecchi rapporti tra proprietari e contadini; veniva proposta una forma di mezzadria che salvaguardasse il più possibile i diritti di chi coltivava i fondi agricoli investendo in lavoro ed in risorse economiche. I patti di Corleone prevedevano che i contadini riuniti in congresso fissassero autonomamente le condizioni dei nuovi contratti agrari sottoponendoli poi all’accettazione della parte padronale e, in caso di rifiuto, si ricorresse allo sciopero scegliendo tempi e modalità opportune affinché l’astensione dal lavoro risultasse la più dannosa possibile per i proprietari. In pratica si voleva utilizzare, anche per le lotte contadine siciliane, l’esperienza degli scioperi salariali tipica dei movimenti operai europei. Nella formulazione elaborata nel corso del congresso del 31 luglio del 1893, i «Patti» si basavano essenzialmente sull’abolizione del «terraggio» ch’era un tipico rapporto tra contadino e proprietario con una quota di prodotto garantita, a favore di quest’ultimo, qualunque fosse l’esito del raccolto. Al posto di tale iniquo rapporto si proponeva il più moderno contratto di mezzadria, meno garantistico per il concedente e quindi meno penalizzante per il contadino.
90
Il terraggio rappresentava, a sua volta, una variante peggiorativa del vecchio contratto di colonia parziaria che garantiva al proprietario una predeterminata quantità di prodotto qualunque fosse la produzione annuale del fondo concesso. Era questo un tipo di rapporto che riservava al concedente, per ogni unità di misura di terreno, una quota che prendeva a riferimento il cosiddetto «terraggio» corrispondente ad un ettolitro di grano per ogni ettaro di terra coltivata. Nel caso in cui il «patto» prevedeva due, tre, quattro «terraggi» la quota garantita al concedente, per ogni ettaro di estensione, doveva risultare di due, tre, quattro ettolitri di frumento. Questa quantità di prodotto veniva prelevata dalla intera produzione e, da quanto rimaneva, venivano detratte le sementi e il corrispondente degli eventuali prestiti ricevuti dal contadino nel corso dell’annata agricola, con l’esoso interesse che non era mai inferiore al 25 per cento. Anche la vecchia mezzadria risultava iniqua al pari del «terraggio», specie quando venivano effettuati i cosiddetti «prelevamenti» consistenti in detrazioni di prodotto effettuate a raccolto avvenuto. Il mezzadro doveva pagare il «tumulo per il campiere», il «tumulo per la lampada», il «tumulo per la madonna», «per San Francesco» o per qualche altro santo del luogo. L’inchiesta parlamentare di Lorenzo Lorenzoni, accertò in Sicilia, per quanto riguardava la condizione del mondo rurale, una situazione anomala rispetto alle altre regioni italiane, in termini di un più accentuato sfruttamento delle masse contadine. Gli stessi organi governativi, consci della grave situazione siciliana, avevano posto all’ordine del giorno la modifica dei patti agrari (1889 Consiglio di agricoltura presso il ministero di agricoltura, industria e commercio), ma successivamente, dimostrando scarsa sensibilità nei confronti della diversa realtà socio economica meridionale, pervennero alla conclusione che fosse da escludere una legislazione speciale sui contratti agrari. Tale decisione non venne resa pubblica e si scelse «un colpevole» silenzio, tipico delle omissioni che caratterizzarono l’atteggiamento del governo nei confronti delle esigenze sociali delle regioni meridionali. Di ciò dovevano certamente essere a conoscenza i capi dei fasci in
91
particolare il Verro e Barbato e fu chiaro, dal loro impegno, il convincimento che il problema dei patti agrari fosse ormai giunto a maturazione. I «patti» agrari di Corleone rappresentavano, metodologicamente, una formula di base elaborata su uno schema contrattuale da adottare per la definizione delle varie piattaforme locali. Questa possibilità di adattamento alle singole realtà territoriali rappresentò la vera forza dei nuovi contratti che potevano essere articolati e quindi adattati alle diverse richieste dei contadini. L’obiettivo era anche quello di applicare solamente i contratti di mezzadria con divisione del prodotto in parti uguali. Le scelte scaturite dal Congresso di Corleone, e la stessa scelta dei Fasci volta a perseguire l’obiettivo di miglioramento delle condizioni di vita del mondo rurale nell’ambito di un diverso rapporto con il sistema produttivo, pur con tutte le incertezze che caratterizzavano questa prima fase dell’ingresso nella vita politica delle masse contadine, ch’erano ormai supportate da una guida politica, potevano rappresentare il primo passo di una futura strategia rivoluzionaria. Gramsci, lo ripetiamo, avrebbe scritto nei Quaderni: «Ogni formazione di volontà collettiva nazionale e popolare è impossibile se le grandi masse dei contadini coltivatori non irrompono simultaneamente nella vita politica…» Ma al rifiuto dei grandi proprietari di prendere in considerazione le proposte del Congresso di Corleone i lavoratori avevano risposto con il primo grande sciopero contadino dell’Italia capitalista che, iniziando nella primavera del ’93, era proseguito anche nel mese di settembre. La reazione non si fece attendere. Venne arrestato Bernardino Verro ma il tentativo di bloccare l’agitazione ebbe l’effetto contrario. La notizia che uno dei capi dei Fasci era stato incatenato come volgare delinquente si sparse per paesi e villaggi ed animò alla lotta i più restii. Quello che doveva rappresentare il primo grande sciopero contadino, il primo grande sogno delle masse lavoratrici, finalmente protagoniste del proprio destino, divampò come un incendio incontenibile con grande spontaneità di partecipazione, con disciplina, con ordine, con straordinaria consapevolezza che mai s’era vista in Sicilia.
92
Corleone fu il centro direttivo della lotta ma fu anche roccaforte della resistenza padronale; lo sciopero agrario si estese in una vasta area a cavallo di quattro province della Sicilia occidentale: da Piana dei Greci a Canicattì, da Valledolmo a Caltabellotta. Mentre per tutta la primavera del 1893 l’agitazione registrava una serie ininterrotta di assemblee contadine nelle sedi dei fasci, nei mesi di settembre ed ottobre la lotta si trasformò in una serie di vertenze con relative trattative per le cui composizioni s’era avuto anche l’intervento delle autorità. Non c’era nulla di sovversivo in tutto ciò. Era una semplice agitazione sindacale che, nell’ottobre, dopo mesi di sciopero non turbati da alcun incidente, costringeva i datori di lavoro ad accettare i Patti e le mercedi del Congresso di Corleone. Grazie a questa lotta composta, il 18 settembre del 1893, si cominciarono a registrare alcuni successi: dodici feudi per circa 1200 salme venivano concessi ai contadini. A Corleone avevano ceduto alcuni proprietari e gabellottí; in undici feudí erano stati introdotti i nuovi «patti agrari». Analoghi accordi vennero conclusi a Roccamena, a Villafrati ed in altri centri delle province di Caltanissetta e Girgenti. Mentre sulla linea delle rivendicazioni sociali l’iniziativa dei fasci raggiunse alcuni successi, in campo politico non ebbe invece risultati corrispondenti all’ampiezza del movimento ed alla peculiarità della situazione; mancò infatti la partecipazione allo sciopero agricolo delle altre province orientali dell’Isola. Non c’era stata in verità una «compattezza siciliana». Alla chiamata avevano risposto le masse contadine assoggettate al latifondo ovvero le masse più povere, quelle storicamente più emarginate. Pur se il governo Giolitti aveva dato l’impressione di voler prendere tempo sperando, forse, in una naturale e incruenta sistemazione della vertenza, i grandi agrari iniziavano, nell’autunno del 1893, una sistematica «provocazione», spingendo le autorità locali alla «repressione». Infatti alle prime azioni dure parteciparono insieme le guardie municipali ed i campieri e già, nel settembre del 1893, quando ancora non erano iniziati i disordini, si parlò dello scioglimento dei Fasci e
93
questo significa che si volevano, senza indugio alcuno, bloccare le rivendicazioni sociali ed evitare che si allargassero. Nel mese di novembre del 1893, nell’infuocato clima di iniziative e di lotte nate attorno alle vertenze contrattuali, avvennero in molti centri grandi manifestazioni popolari. A dicembre Francesco Crispi, asceso al potere con un vasto consenso, ricercò anche coperture a sinistra, tra i radicali ed i repubblicani, chiedendo appoggio perfino a Napoleone Colajanni, in precedenza suo accanito oppositore politico. Su questo contraddittorio fatto lo storico Francesco Renda ha scritto: «… più che in altre regioni, gli spostamenti politici e sociali, verificatisi sull’onda della sconfitta giolittiana, ebbero uno spiccato carattere di riscossa antisocialista che isolò e strinse i fasci in una morsa soffocatrice».
*** La rottura fra Colajanni ed i socialisti, avvenuta in quei giorni, ebbe una enorme rilevanza per lo sviluppo dell’azione repressiva che, di lì a poco, sarebbe stata attuata da Crispi e, tutto sommato, come aggiunse Francesco Renda «… nel momento in cui (Colajanni) ruppe coi socialisti, passò nel campo avverso ai fasci dando una copertura ed una legittimazione di inconsueta proporzione». Ma Napoleone Colajanni, superato il primo sbaglio di valutazione sulle reali intenzioni del governo Crispi, non avrebbe perseverato nell’errore. Infatti, mentre era in corso la repressione ed i dirigenti dei fasci si trovavano rinchiusi nelle patrie galere, trovò il coraggio di denunciare la provocazione reazionaria del governo Críspi, nel quale individuò il principale responsabile delle stragi avvenute; egli nello stesso tempo motivò le cause dei disordini popolari nella grave situazione oppressiva in cui erano costretti a vivere i contadini siciliani. Crispi aveva preso una dura posizione nei confronti del movimento dei Fasci e fu significativo, per trovare la motivazione di tale fatto, che i gruppi politici che si raggrupparono intorno allo statista siciliano, esercitavano grande influenza sugli esponenti della mafia. Uno dei motivi di dissenso e di contrasto fra Crispi ed i Fasci fu il netto rifiuto
94
espresso dagli esponenti del movimento di accettare la funzione mediatrice dei gruppi mafiosi legati direttamente con il Crispi. Lo stesso Crispi, poiché lo sviluppo del movimento dei Fasci s’era avuto sotto il governo Giolitti (tra il 1892 ed il 1893) e rappresentava quindi un movimento di opposizione a quel governo, aveva incoraggiato in quel periodo l’adesione ai Fasci di alcune società operaie ch’erano però, organismi elettorali guidati da noti mafiosi. Ciò avvenne soprattutto nella provincia di Girgenti, dove grande era l’influenza di Crispi e poiché le associazioni operaie erano intitolate a Francesco Crispi o alla «Madonna Addolorata» nessuno le aveva perseguitate e tanto meno aveva chiesto le fedine penali degli associati. I primi gravi disordini scoppiarono a Partinico il 9 dicembre del 1893, quando la folla assaltò il municipio saccheggiando gli uffici e bruciando carte e registri. A Monreale, quasi contemporaneamente, la folla incendiò i casotti daziari. Disordini e tumulti avvennero in altri centri delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. La repressione scattò puntuale. A Giardinello la tragedia si tinse del sangue del popolo: mentre la folla dimostrava chiedendo la riduzione delle tasse, la truppa da una parte e le guardie campestri dall’altra, aprirono un fuoco incrociato uccidendo dieci persone e ferendone gravemente almeno venti. Si accertò che le guardie campestri avevano sparato appostandosi, addirittura, nella casa del sindaco. A Lercara venne versato altro sangue durante una manifestazione di piazza alla quale partecipavano, oltre ai contadini, anche gli zolfatari delle locali miniere di zolfo. Gli stessi proprietari fecero sparare sulla folla inerme servendosi tanto delle guardie municipali quanto dei propri campieri. I morti a Lercara furono undici e moltissimi i feriti. A Gibellina fu il sindaco a dare alle guardie campestri l’ordine di sparare sui contadini; le guardie lo fecero dal campanile di una chiesa provocando morti e feriti. A Marineo ed a Santa Caterina di Villarmosa, gli stessi proprietari spinsero le guardie municipali a massacrare la gente a colpi di fucile sparando sulla folla che dimostrava contro il governo.
95
Fu ampiamente provato che la mafia partecipò attivamente alle stragi, spesso con i campieri i quali, insieme agli agenti locali ed alle guardie municipali, aprirono il fuoco sulla folla inerme. La scena delle stragi fu di solito la piazza, tipica dei poveri paesi dell’interno dell’Isola. Al centro, c’erano il municipio, la chiesa con il suo campanile e poco distante la caserma dei carabinieri. Gli attori erano il sindaco con i familiari e gli amici, che, quasi di norma, avevano monopolizzato tutti gli incarichi pubblici, da quello di maestro a quello di medico condotto e di capo guardia, quest’ultimo quasi sempre il peggior individuo della zona messosi al servizio del sindaco; i sindaci siciliani erano in quel tempo più potenti e più temuti degli stessi agenti dell’ordine. Il capo delle guardie e le guardie campestri (i cosiddetti campieri), che per la loro specifica funzione dovevano assicurare la sorveglianza delle campagne, finivano spesso per diventare le guardie del corpo del sindaco e venivano utilizzate, il più delle volte, nei terreni di proprietà dello stesso. La prova della partecipazione dei campieri ai citati eccidi, si ebbe a Lercara e a Giardinello ed in altri centri. Nel primo di questi due paesi, entrambi in provincia di Palermo, la dimostrazione del 25 dicembre del 1893, che aveva avuto luogo davanti alla casa municipale e nella piazza del Duomo, si concludeva, come abbiamo detto, con undici morti e numerosi feriti, per i colpi di fucile sparati sulla folla dalle guardie municipali e dai campieri appostati sul campanile della chiesa. A Giardinello la prova della partecipazione di elementi mafiosi (i campieri) all’eccidio si trovò nel rapporto redatto dall’Ispettore di Polizia Gervasi il quale esaminò attentamente la posizione dei cadaveri di sette contadini uccisi e i tipi di proiettili che ne avevano provocato la morte. Si poté così accertare con assoluta precisione che le vittime erano state prese fra due fuochi: quello dei colpi sparati dalla truppa, con proiettili a mitraglia in dotazione all’esercito, e quello dei proiettili sparati dalle guardie campestri, di ben diversa fattura e calibro. Si accertò, inoltre, che alcuni colpi sparati dalle guardie campestri erano partiti sia dalla casa del sindaco che da quella dell’attigua abitazione del capo delle guardie campestri. Lo stesso fatto, con qualche variante, era avvenuto negli altri casi. La partecipazione agli eccidi della truppa, delle guardie munici-
96
pali e di quelle campestri, avvenuta in piena sintonia, dimostrò che il potere costituito, sia a livello centrale che locale, aveva agito avvalendosi dell’appoggio della mafia, confermandosi, con tale scellerata collaborazione, le connivenze e le complicità che caratterizzavano la gestione politica ed amministrativa del Paese. La repressione, oltre alle stragi, provocò migliaia di arresti. I capi dei Fasci vennero arrestati ed insieme a loro vennero incarcerati contadini ed operai ai quali fu riservato un trattamento molto duro, come a Valguarnera dove uomini, donne e vecchi, furono trascinati a piedi fino a Caltanissetta per oltre cinquanta chilometri ed al loro arrivo una popolazione muta e piangente li accolse mentre le donne arrestate, costrette ad abbandonare i loro bambini, gridavano disperate. La Sicilia era rimasta completamente in balia della sua classe dominante (promotrice e protagonista della dura repressione) che s’era collocata al di fuori di ogni ordinamento giuridico e sociale che non fosse il potere mafioso. Nella strategia repressiva, agrari, uomini politici ed anche uomini di cultura, si trovarono uniti in una omertà che altro non era se non l’intento di difendere con l’ordine costituito posizioni di sfruttamento e di difesa delle rendite parassitarie. Francesco Crispi tuonò contro i socialisti ed i grandi agrari fecero appello al governo perché andasse alla radice dei disordini abolendo l’istruzione obbligatoria. Si arrivò così alla proclamazione dello stato d’assedio dell’Isola. Era il 3 gennaio 1894. Il Generale Morra di Lavriano venne nominato Commissario Straordinario con pieni poteri. Ma di fronte ai gravi tumulti popolari i socialisti vollero prendere le distanze dai «fatti di Sicilia». Il giornale socialista Lotta di classe, il 31 dicembre 1893 così infatti scriveva: «Giacché, per quanto il partito socialista abbia il diritto di non rimanere insensibile al grido di dolore di un intero proletariato, esso si rende ben conto che la sua azione sarà nulla o quasi di fronte ad un movimento che non procede da un pensiero determinato e che non è l’espressione di una coscienza chiara e precisa del suo fine. La rivolta della fame non è una rivolta di partito». In un manifesto diretto al Paese alcuni deputati socialisti scriveva-
97
no: «… I moti dolorosi di Sicilia non sono fenomeni coscienti della nostra propaganda, non sono manifestazioni ed applicazioni del nostro programma, ma sono gli spasimi sintomatici di profonde ed antiche ingiustizie, che noi vogliamo soppresse con la completa rigenerazione sociale… Riaffermiamo il nostro programma che non nei moti tumultuosi e sanguinosi, ma solo nella cosciente organizzazione dei lavoratori in partito di classe segna la via della vittoria». Anche i socialisti siciliani avevano preso le distanze e, sui disordini popolari, il 31 dicembre 1893, da Catania inviavano questo messaggio ai lavoratori della provincia: «… sono moti dovuti alla fame ed alla influenza dei partiti locali, non agli ideali ed il fascio dei lavoratori di Catania non può che sconsigliare moti scomposti. Siate calmi! È questo il momento di dimostrare all’Italia che noi siamo tutt’altro che sobillatori». Nei confronti del movimento dei fasci siciliani non era nuova una certa riserva che, forse, nasceva, per quanto riguardava i socialisti, nella difficoltà di riconoscere al mondo contadino un ruolo nella lotta di classe, invece interamente riconosciuto al proletariato del settentrione d’Italia. Infatti, nel gennaio del 1893 Antonio Labriola incredibilmente, in una sua lettera inviata ad Engels, aveva affermato: «Tutti questi fasci e leghe dei lavoratori sono delle barbette… Tutta questa roba siciliana è del romagnolismo peggiorato. Nemmeno qui a Roma si sa tutto, si arriva a capire che cosa ci sia nella pretesa agitazione siciliana, di socialismo, di anarchico, di affaristico e di mafioso». *** L’errore politico dei socialisti fu evidente. Il distacco da un movimento popolare di rivendicazione costretto alla dimostrazione di piazza, a causa delle gravi provocazioni attuate dalla classe dominante, rivelava una scarsa sensibilità storica e, quanto meno, una esemplificazione delle cause e degli effetti, al punto da confondere i secondi con le prime. Ma una iniziativa tesa a riparare all’errore venne presa dallo stesso
98
Labriola con una lettera indirizzata a Garibaldi Bosco e pubblicata in «Critica Sociale» il 16 gennaio 1894. L’iniziativa rivelava una aperta adesione politica ed una intensa partecipazione intellettuale a «difesa dei socialisti siciliani e delle masse esasperate che avevano avuto fiducia in loro». Come ha scritto L. Valiani in Questioni di storia del socialismo: «L’iniziativa segnò la maturazione marxista di Antonio Labriola il quale, dalla esperienza delle vicende del movimento siciliano, fece un punto di riferimento, politicamente e storicamente definito, per la elaborazione del suo pensiero». Nella sua lettera Labriola affrontò il problema della collocazione del partito socialista rispetto al movimento dei fasci, ai cui capi scrisse: «… le vostre decisioni non impegneranno soltanto voi, né varranno solo a delineare la situazione vostra di fronte ai proletari di Sicilia e di fronte al governo. Le vostre decisioni torneranno, o di grande aiuto, o di molto nocumento a tutto il partito socialista italiano che solo da poco tempo si è liberato dalle incertezze, incoerenze ed inconcludenze che lo assediano, e d’ora innanzi non potrà vivere, crescere di forza e prosperare, se non a patto: “di non ricadere nella fatuità dell’anarchismo; di non cristallizzarsi nella goffa idea del legalitarismo parlamentare, che poi in avvenire può ben risolversi in una nuova requisizione del bestiame votante; di essere, di voler essere e di saper essere ispirato sempre al principio della rivoluzione pratica e progressiva, usando modi non preconcetti ma sperimentati di organizzazione, e forme tali di propaganda quali le richiedono la condizione del paese e il temperamento degli uomini”». Labriola indicava quindi la scelta per la «rivoluzione proletaria» e per la «rivoluzione progressista» contro l’anarchismo e contro il legalitarismo, nei confronti del quale egli sarà sempre scettico, concludendo la lettera con vibranti accenti che mettevano a fuoco il suo pensiero conclusivo, esprimendo con ciò la sua maniera di concepire il rapporto partito–movimento basato su una adesione non necessariamente acritica, evitando il trarsi in disparte che era una strada per costituire «un alibi alla vigliaccheria» ed evitando, inoltre, di «confondersi» semplicemente con la rivolta. Antonio Labriola così continuava: «Fuori di ciò è, o il dubbio o la viltà: di qua da tale linea nasce,
99
e vegeta poi, la setta, la consorteria, la combriccola, ma non sorge e vive il partito.
1898. Alcuni operai al lavoro sulla costruzione di una strada statale. Quindi “Cosa di Stato”
100
Né c’è chi possa dispensare un partito vero e proprio dal dovere di studiare le reali condizioni del momento, per rifarsi sempre di nuova esperienza: salvo che, negata ogni ragione di processo, di adattamento e di progresso, non si voglia ridurre il socialismo al quissimile della dottrinella». Il movimento dei Fasci, per Labriola, non era soltanto la protesta popolare contro antiche ingiustizie, ma si poneva come il prodotto di un determinato ordine sociale mentre gli eccessi del proletariato ne erano la conseguenza; la lettera così concludeva: «Ho letto in non so quanti giornali: “Laggiù non si tratta del socialismo ma della fame”. E poi: “Quegli incoscienti danno in eccessi”. La gran sapienza da discussione d’angolo di farmacia di paesello di provincia! Ma quelli che in qualunque modo si assumono il carico di condottieri e maestri del movimento proletario sanno bene, come voi sapete benissimo per vostra esperienza, che appunto i passionali eccessi del proletariato rivelano la malvagia natura di quest’ordine sociale del quale il proletariato è vittima ed onta ad un tempo». Sul nuovo giudizio di Labriola sui fasci avevano influito certamente, in ampia misura, i fatti di Aigues–Mortes, tragico eccidio di lavoratori avvenuto il 17 agosto 1893 nella cittadina provenzale, che avevano fatto esclamare allo stesso Labriola: «Al di sopra e d’intorno ai barbaramente trucidati e ai barbari trucidatori di Aigues–Mortes, non sta soltanto di qua l’Italia, di là la Francia, con due sistemi di politica, secondo il misero ed ovvio senso di tale parola. Al di sopra dei trucidati e dei trucidatori, come al di sopra di Francia e Italia, sta il sistema capitalistico tutto intero, contro del quale sono rivolti gli atti e i pensieri, i sentimenti e le parole di noi socialisti». I Fasci ed i fatti insurrezionali posero problemi fondamentali al socialismo organizzato italiano ed al marxismo teorico; il Labriola coglieva il segno del socialismo nel movimento dei Fasci parlando di «proletariato» e di «movimento proletario» con ciò centrando il significato di scontro politico e di classe in una interpretazione valida nel tempo sebbene si trattasse di proletariato anomalo. La proclamazione dello stato d’assedio nelle province siciliane, avvenuta il 3 gennaio del 1894, anche se rappresentò un inqualifi-
101
cabile atto repressivo di estrema gravità, volto a stroncare un intero movimento di avanzata rivendicazione sociale, ebbe numerosi consensi, spesso anche entusiastici, da parte degli strati borghesi. La stampa, esclusa quella socialista e clericale, con sfumature diverse a seconda delle differenziate posizioni politiche di ciascun giornale, approvò l’operato di Francesco Crispi, riconoscendo la «necessità» di quel provvedimento e della conseguente repressione armata che venne considerata come una dura ed ineluttabile necessità. Alcuni di questi giornali, nel plaudire alla repressione armata, la considerarono come una nuova guerra d’indipendenza e i più reazionari speravano che la repressione fosse solo l’inizio di un duro regime illiberale, assolutista e antiparlamentare, tutto ciò in nome di un malinteso ordine per una conservazione sociale di ben precisa connotazione autoritaria. Lo «stato d’assedio» non essendo contemplato dallo statuto e dalle leggi dello Stato, a nessuna legge poté fare riferimento un decreto reale, che, controfirmato da tutti i ministri per superare tale difficoltà d’ordine giuridico, decise di far riferimento all’art. 246 del codice penale militare che prevedeva la proclamazione dello stato di guerra, da parte dell’autorità militare solo nel caso di territori «invasi da truppe nemiche» oppure quando eserciti stranieri si trovassero «a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia». Tale fatto spiega, fra l’altro, perché si insistette, oltre misura, non solo sul carattere insurrezionale dei moti siciliani, ma anche su pretesí accordi con potenze straniere (Crispi sosteneva che i Fasci erano ispirati dalla Francia) e sulla minaccia di guerra che ne derivava. Ne conseguì che lo «stato d’assedio», non essendo previsto da alcuna legge, non poteva essere sostenuto da alcuna garanzia di legalità per cui quei poteri, che furono ampiamente dati all’autorità militare, risultarono trasformati in puro «arbitrio» e si era giunti all’assurdità di un governo, che in assenza di un istituto regolato da norme esplicite e sostenuto da precise garanzie legali, nel contenuto e nella forma, finì per delegare al Generale Morra di Lavriano, poteri legislativi e giudiziari che esso non aveva. Con la istituzione dei tribunali militari di guerra, entrati in fun-
102
zione in conseguenza dello stato d’assedio, venne clamorosamente violata la norma statutaria secondo la quale «nessuno può essere sottratto ai propri giudici naturali» violando inoltre il principio della irretroattività della legge penale. Venne anche calpestata l’immunità parlamentare e limitato il diritto alla difesa; pene esagerate vennero comminate per delitti compiuti prima della proclamazione dello stato d’assedio e dell’inizio della nuova giurisdizione. Con l’assenso del parlamento e della magistratura erano state cancellate, con inqualificabile modo di procedere, le conquiste della rivoluzione liberale ed i principi stessi della legalità dello stato. La riunione del Comitato centrale dei «Fasci», tenutasi a Palermo in pieno stato d’assedio, costituì l’ultimo atto politico certamente il più importante, assunto dal movimento. Le deliberazioni che vennero emesse in quella riunione consentirono di rimediare agli errori di giudizio espresso dal partito socialista e che ne avevano indebolito i rapporti col movimento dei Fasci. Tali errori di giudizio erano stati evidenziati nella «scissione di responsabilità»; analoga posizione era stata assunta da alcuni deputati socialisti nel manifesto al «Paese» che abbiamo già menzionato. Antonio Labriola fu il solo fra i dirigenti socialisti nazionali a credere necessaria una iniziativa tesa a dimostrare l’interesse del partito alle vicende siciliane attraverso una esplicita adesione politica ed una chiara partecipazione intellettuale a difesa dei socialisti siciliani e delle masse lavoratrici dell’isola. Tale adesione e partecipazione vennero esplicitate nei contenuti di lettera indirizzata a Garibaldi Bosco e pubblicata in «Critica Sociale» il 16 gennaio 1894 della quale abbiamo già riportato alcune parti più significative. La lettera mirava a fornire ai Dirigenti dei Fasci indicazioni fondamentali, da un punto di vista ideologico e politico che valessero a risolvere i contrasti interni dei socialisti siciliani sulla linea da seguire, in vista della discussione e delle deliberazioni che sarebbero state prese dal Comitato centrale nella riunione del 3 gennaio. Le indicazioni del Labriola, di così viva perspicacia politica, servirono ad ispirare il comportamento conclusivo dei dirigenti siciliani
103
che fu di ampia assunzione di responsabilità politica proprio nel momento in cui, nella sera del 3 gennaio 1894, iniziava la dura repressione militare. In quell’incontro, i dirigenti dei fasci ricercarono una linea unitaria (De Felice Giuffrida aveva sostenuto che in mancanza di una preparazione politica ed organizzativa, parlare di rivoluzione sarebbe stato insensato) attraverso l’approvazione di due documenti datati 3 gennaio 1893: il primo indirizzato telegraficamente al Presidente del Consiglio, il secondo redatto in forma di manifesto. I due documenti, in sostanza, contenevano le seguenti proposte: «Il Comitato Centrale del Partito socialista siciliano riunitosi oggi, in vista del gravissimo momento politico ed economico attraversato dalla Sicilia, deliberò di comunicare al governo le seguenti proposte: – Abolizione del dazio–farine. – Inchiesta sulle pubbliche amministrazioni siciliane, fatta col concorso dei fasci dei lavoratori. – Sanzione legale patti colonici del Congresso di Corleone. – Sanzione legale deliberazioni Congresso minerario Grotte e costituzione sindacato zolfo. – Costituzione collettività agricole e industriali, mediante beni incolti privati, beni comunali, Stato e Asse ecclesiastico non ancora venduti, nonché espropriazione forzata latifondi accordando temporaneamente agli espropriati rendita annua che non superi tre per cento valore terreni. – Concessione tutti i lavori della pubblica amministrazione e quelle dipendenti o sussidiate dallo Stato ai Fasci lavoratori, senza obbligo cauzione. – Leggi sociali che basandosi su di un minimo salario e massimo ore lavoro valgano migliorare economicamente e moralmente condizioni lavoratori. – Per provvedere spesa onde mettere esecuzione suddetti progetti per acquistare strumenti lavoro tanto collettività agricole quanto quelle industriali e in genere per anticipare alimenti socii e porre collettività in grado funzionare utilmente, stanziare bilancio stato, una volta tanto somma 20 milioni. Non usi rivolgerci Governo, da cui nulla
104
abbiamo mai sperato, vogliamo tentare prova indicandovi solo via richiesta, oltre che dalla civiltà, dalle gravi esigenze del momento. Seguitela, se no assumerete gravi responsabilità». Nella versione Manifesto, prima della declaratoria degli otto punti già descritti, era stata riportata questa premessa: «Lavoratori della Sicilia! La nostra Isola rosseggia del sangue di compagni che, sfruttati e immiseriti, hanno manifestato il loro malcontento contro un sistema dal quale indarno avete sperato giustizia, benessere, libertà. L’agitazione presente è il portato doloroso ma necessario di un ordine di cose inesorabilmente condannato e mette la borghesia nella necessità o di seguire le esigenze dei tempi o di abbandonarsi a repressioni brutali. In questo momento solenne mettiamo alla prova le declamazioni umanitarie della borghesia ed in nome vostro chiediamo al governo: … (seguivano le proposte di cui agli otto punti già descritti). Il manifesto così concludeva: Lavoratori! seguitate intanto ad organizzarvi, ma ritornate alla calma poiché con moti isolati e convulsionari non si raggiungono benefici duraturi. Dalla decisione del governo trarremo norma per la condotta che dovremo tenere». La risposta del governo fu quindi l’occupazione militare dell’Isola, l’arresto dei capi dei fasci e di molti altri appartenenti al movimento, i processi per direttissima davanti al tribunale militare, le durissime condanne. Le requisitorie a carico di Bosco, Verro, De Felice e Barbato rivelarono il preciso intento del governo di criminalizzare il movimento accusando i capi d’aver tramato contro lo stato. Le condanne furono «esemplari»; 18 anni di carcere per De Felice, 12 anni a Bosco, Verro e Barbato. L’accusa fu di «eccitamento all’odio tra le classi» e di «rivolta armata contro le istituzioni dello Stato». Il processo, che si impose all’attenzione europea, registrò un comportamento estremamente dignitoso da parte degli imputati che volle-
105
ro dare un esempio ai loro compagni di lotta affinché perseverassero e sperassero nel futuro. Nessuno degli imputati difese la propria persona. Garibaldi Bosco disse ai giudici: «Se poi voi vorrete punire non i cospiratori, non gli eccitatori, ma i socialisti, allora io e i miei compagni, orgogliosi e convinti delle idee che professiamo, a fronte alta abbiamo il coraggio di gridarvi: “avanti, colpite”». L’autodifesa di Nicola Barbato dimostrava che il nascente socialismo siciliano aveva compreso la dialettica classista della società e della storia: «Davanti a voi abbiamo fornito documenti e le prove della nostra innocenza: i miei compagni hanno creduto di dover sostenere la loro difesa giuridica; questo io non lo credo di fare. Non perché non abbia fiducia in voi: ma è il codice che non mi riguarda. Perciò non mi difende. Voi dovete condannare: noi siamo gli elementi distruttori di istituzioni per voi sacre. Voi dovete condannare: è logico, umano. E io renderò sempre omaggio alla vostra lealtà. Ma diremo agli amici che sono fuori: Non domandate grazia, non domandate amnistia. La civiltà socialista non deve cominciare con un atto di viltà. Noi chiediamo le condanne, non chiediamo pietà. Le vittime sono più utili alla nostra causa di qualunque propaganda. Condannate». Ma le condanne non bastarono poiché Francesco Crispi, nell’attuare il suo disegno repressivo, sopprimeva anche i diritti politici, scioglieva i fasci e metteva al bando il partito socialista contrassegnando, in tal modo, la riscossa della borghesia italiana che, negli anni seguenti, avrebbe dimostrato una forza di espansione e di penetrazione travolgenti. Quel che contava, in quella classe politica dirigente, era l’urgente bisogno di uscire subito, e a qualunque costo, dalla lunga crisi che travagliava la società italiana. L’ipotesi di un regime forte, energico ed efficiente aveva conquistato molti uomini di fede liberale. «La paura del socialismo, vissuta come timore di una imminente catastrofica rivoluzione politica e sociale, contrapposta al millenarismo delle masse oltre che alle speranzose previsioni degli stessi capi socialisti, trovò il suo coagulo negli avvenimenti di Sicilia che, se era come si è detto il punto debole del sistema capitalistico italiano,
106
non era per ciò il punto più forte del movimento socialista italiano». (Francesco Renda, I Fasci Siciliani 1892–94). Indubbiamente le masse popolari siciliane, avvilite dalla grave condizione sociale ed economica, fattasi oltremodo drammatica per i catastrofici eventi di fine secolo, sfociando nel ribellismo, avevano resa veritiera l’affermazione di Napoleone Colajanni: «Il popolo, per altro, quale che esso sia, poco suole accogliere e fecondare delle teorie d’un partito: afferra tutt’al più un’idea rispondente al suo stato, un sentimento che consuona col suo, e quando si sente alla stretta, si getta nell’azione senza chiedere consiglio a nessuno. La miseria e la mala signoria furono e saranno sempre i motivi principali delle rivolte». Ma se era vero tutto ciò, e la cosa non fa che suonare condanna nei confronti di un potere responsabile delle miserande condizioni in cui versavano in quel tempo le masse popolari, viene spontaneo chiedersi se, in assenza di fenomeni ribellistici, la classe dominante avrebbe avviato in tempi ragionevoli e anche in parte le riforme richieste dai fasci. Forse è più giusto credere che la classe dominante siciliana non era disponibile a cedimenti per difendere l’elevato livello della propria rendita e che i tumulti e gli scioperi rappresentarono l’alibi per l’azione repressiva attuata proprio nel momento in cui il mondo contadino siciliano stava acquistando coscienza dei propri diritti. Questa presa di coscienza popolare, che per la prima volta aveva trovato in Sicilia un preciso riferimento ideologico e quindi politico, fu certamente la motivazione principale che spinse il governo a spegnere con la forza il movimento dei Fasci che rappresentava, per le forze più conservatrici, un serio ostacolo all’attuazione di una politica antipopolare attraverso una gestione autoritaria della crisi economica che attanagliava il Paese e con la ripresa di una politica coloniale voluta dai gruppi industriali del Nord e presentata con la mistificante possibilità di creare sbocchi occupazionali alla manodopera meridionale. Il riferimento ideologico nel partito socialista, improntato alla lotta di classe, ed in particolare la presenza di una organizzazione sinda-
107
cale che ne aveva accettato le direttive politiche, con capi che impersonavano una nuova classe dirigente in grado di orientare le masse secondo nuovi metodi di lotta, provocò la dura reazione della classe dominante che trovò nel governo un fedele alleato nel reprimere sia il movimento dei Fasci sia il partito socialista, attuando in tal modo una svolta nazionale autoritaria di stampo borghese. Avveniva così la «diaspora» dei fasci, la dispersione di un patrimonio di forze comuni, di idee, di ipotesi di un progetto di una società più giusta. Attuata la repressione e sciolto il movimento dei Fasci, Francesco Crispi tentò di introdurre in Sicilia la piccola e media proprietà borghese in funzione antisocialista ed antifeudale. La proposta di legge prevedeva la quotizzazione forzata dei latifondi demaniali e privati, l’introduzione, ope-legis, dell’enfiteusi dei fondi rustici di enti pubblici con divisione ai contadini e imponeva ai proprietari la bonifica dei relativi fondi. Crispi che rappresentava gli interessi della borghesia industriale, soprattutto settentrionale, la quale era interessata alla nascita di una agricoltura moderna, provocò le reazioni della destra agraria siciliana, guidata dal Marchese Antonio Starrabba di Rudinì. Venne accusato di aver proposto una riforma «socialista», che trovò l’opposizione anche della destra «illuminata» del Nord, impegnata, in quel periodo, allo sviluppo industriale di quelle regioni e quindi poco sensibile ai problemi dell’agricoltura, specie del lontano meridione e della Sicilia. La riforma, tentata da Crispi, di una certa modernità, ma che sostanzialmente recepiva le istanze borghesi, oltre a risultare debole per la mancata previsione di finanziamenti dello Stato, venne concretamente avversata dagli agrari siciliani che costituirono un fronte unico, proclamando intenti separatisti e minacciando azioni di forza. Essi sostennero che la garanzia dell’istituto della proprietà aveva condizionato la propria adesione plebiscitaria all’unità d’Italia. La legge agraria, in tal modo osteggiata, non venne neanche discussa in parlamento.
108
28 Dicembre 1908. Terremoto di Messina. Superstiti accampati al porto
109
6 Fasci e ruolo delle donne
«Reclamo i diritti delle donne, perché sono convinta che tutti i mali del mondo sono prodotti dall’oblio e dal disprezzo in cui sono stati tenuti finora i diritti naturali e imperscrittibili dell’essere femminile…» così scriveva Flora Tristan esponente di rilievo del movimento femminista del XIX secolo e non aveva tutti i torti, almeno per quanto riguardava l’emarginazione delle donne nella storia dell’umanità. La storia delle rivoluzioni ha per troppo tempo attribuito alle donne un ruolo secondario limitandosi a ricordare qualche episodio, pochi miti e pochissimi nomi per rimarcare la eccezionalità della loro partecipazione. Ma al di là di quei pochi miti e di quei pochissimi nomi femminili, le rivoluzioni sono state per le donne l’occasione per portare avanti le loro rivendicazioni specifiche e per partecipare, in modo più autentico, alla vita politica, attraverso le associazioni, i movimenti, i partiti in cui potevano in qualche modo riconoscersi. Se la storia si è solo interessata della partecipazione di una minoranza di donne alla lotta armata rivoluzionaria, intendendo con ciò riferirsi soltanto alle barricate e ai combattimenti considerati universalmente «cose da uomini», molte donne in effetti hanno svolto, nel corso delle rivoluzioni, un ruolo che non ha nulla a che vedere con tutto questo. Molte, infatti, si sono battute per affermare le proprie rivendicazioni, per essere riconosciute «partner» dell’uomo su un piano di assoluta parità; in pratica per la «conquista» dei propri diritti. Non soltanto il sistema borghese ha sbarrato la strada alle donne nel
110
loro cammino verso l’emancipazione ma anche gli stessi movimenti popolari le hanno relegate a svolgere un ruolo meramente simbolico e pochi autentici rivoluzionari hanno saputo capire la convergenza delle lotte femminili per l’emancipazione. Un esempio significativo: nel 1848 in Francia, Proudhon chiese ai socialisti di sganciarsi da qualsiasi forma di solidarietà con le femministe e pretese, da buon «rivoluzionario maschilista», di relegare la donna ai suoi tradizionali campiti domestici e familiari. Le donne, quindi, hanno dovuto lottare sia contro le forze borghesi conservatrici, sia contro quelle progressiste molto spesso incapaci di cogliere, negli aspetti più diversi, i fermenti di rigenerazione sociale, per cui impossibilitate ad inserirsi nei più ampi processi di rivendicazione, per le condizioni sociali e per l’opinione pubblica avverse, le donne hanno finito per approfittare delle ribellioni onde porre le basi della loro partecipazione alla storia. In Francia, ad esempio, nel corso delle lotte che culminarono nella grande rivoluzione ed in quelle successive dell’800, la partecipazione delle donne risultò emblematica di tale precisa volontà. Ma anche quella volta per loro non fu facile. Infatti, nonostante che donne come Theroigne de Mericourt, Olympe de Gouges, Claire Lacombe, Pauline Leon fossero in prima fila nelle barricate, combattendo con coraggio inaudito insieme ad altre 300 donne, ci fu nei loro confronti l’avversione delle stesse forze rivoluzionarie che, nel 1792, respinsero la richiesta di arruolamento di 73 donne della sezione parigina dell’Hotel de Ville. Si disse che i grandi rivoluzionari del 1798 non potevano permettere una partecipazione «contraria alla natura». Più fortunate furono le 300 volontarie della «legione femminile», della «Comune di Parigi», che tuttavia, per poter partecipare ai combattimenti dovettero prima superare le perplessità di molti ufficiali contrari alla loro presenza nell’esercito. Analoghe perplessità si verificarono nei confronti della partecipazione femminile alla vita politica rivoluzionaria e fu per tale ragione che nessuna donna fu inserita tra i 90 membri del consiglio della «Comune di Parigi». Avvenne che gli stessi rivoluzionari, che s’erano
111
fermamente opposti ad un ruolo marziale delle donne nel corso dei combattimenti, assunsero analoga avversione alla loro partecipazione alla vita politica.
Il ‘900 inizia qui
112
Ma le donne parigine contestarono tali atteggiamenti e per risposta, nel 1848, fondarono alcuni giornali, come “la voix des femmes”, “l’opinion des femmes” e diversi club come la “société della voix des femmes” e il “club de l’emancipation des femmes”, che costituirono altrettante tribune di una espressione politica femminista. Tale volontà associativa si rafforzò nel 1871, durante la «Comune di Parigi», con la costituzione dell’«Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés», che si occupò sia della protezione civile e dell’assistenza ai feriti sia dell’insegnamento dell’organizzazione nel lavoro femminile. Questi esempi valgono a dimostrare quanto difficile sia stata, anche nelle società più evolute, la strada della emancipazione della donna. Passando alla realtà storica siciliana così come si presentava nel corso dell’800, è interessante approfondire il ruolo della donna nella vecchia società agricola in rapporto all’ambiente sociale di quei tempi. La donna, nelle zone dell’entroterra isolano, caratterizzato dall’arretratezza del latifondo, veniva educata fin da piccola al silenzio e cresceva in un clima di paura e di risentimento. Ma in quella società, per taluni aspetti «matriarcale», la donna, contraddittoriamente, rappresentava un elemento di rilevante influenza all’interno della famiglia; essa, educata al silenzio, educava a sua volta all’omertà i propri figli e, segnata dalla sofferenza della miseria, li preparava anche alla sopportazione dell’umana sofferenza. La donna, nella vecchia società agricola siciliana esprimeva quindi i suoi comportamenti in stretto rapporto all’ambiente umano e sociale in cui viveva per cui, là dove regnava la tradizione “mafiosa”, essa assumeva spesso anche il ruolo di “sacerdotessa della mafia”. Accadeva che nei processi la donna non parlava nemmeno se le avevano ucciso il marito, il figlio o il padre sotto i propri occhi. Ella agiva spesso secondo i canoni mafiosi, organizzando poi, come meglio poteva, la vendetta.
113
*** Là dove il mondo agricolo era invece scosso dalla protesta sociale, la donna siciliana assumeva un ruolo con la lotta, spingendo con consapevolezza, gli uomini a lottare a loro volta. Lo storico Francesco Paternò Castello, scrivendo sulla rivoluzione che nel corso del 1820 aveva sconvolto la Sicilia dei Borboni, evidenziò il ruolo di protagonista assunto in quella vicenda dal sottoproletariato palermitano ed in particolare dalle donne del popolo, le quali, ad esempio, nel turbolento quartiere della Conceria, spingevano coraggiosamente gli uomini alla ribellione e alla lotta armata, così affermava: «… le donne, il marito, l’amico, le madri, i figli alla tenzone invitavano e di viltà i timidi erano tacciati; più il sole estivo i suoi pungenti raggi diffondeva, più le teste di fuoco marziale scaldavansi». Lo stesso Francesco Paternò Castello, descrivendo l’assalto popolare al palazzo reale, avvenuto in quell’afoso luglio del 1820, affermava che: «… sino le donne della plebe a spingere i loro mariti e figli erano accorse e cariche di polvere e di palle nei loro grembiuli li somministravano a coloro che ne mancavano, e se ai loro insinuanti detti vedean taluni ancor dubbiosi, colle ingiurie e di viltà tacciandoli a salir le scale li spingevano…». In quei giorni a Messina, mentre a Palermo divampava la rivolta, Antonina Cascio, umile popolana, guidò una squadra armata composta da sole donne, che riuscì a soverchiare, dopo duri combattimenti, le truppe borboniche poste a difesa della città. A Palermo, nel 1848, certa Santa Astorina, moglie di Pasquale Miloro, popolana coraggiosa e spregiudicata, organizzò e capeggiò varie bande armate. Fin dai primi momenti della rivoluzione ella incitò la gente ad unirsi agli insorti e lei stessa, in prima linea, aprì il fuoco contro la gendarmeria borbonica che tentava di spegnere sul nascere la sedizione. Proprio in quei giorni, un’altra popolana, sempre a Palermo, guidò una squadra armata. Si chiamava Teresa ed era soprannominata «Testa di lana». Gli sbirri borbonici le avevano torturato e massacrato
114
due figli e questa tragica circostanza era di certo all’origine della sua disperata follia.
1894. Donne corrono contro i soldati durante la rivolta dei Fasci siciliani dei lavoratori
115
Feroce e sanguinaria Teresa attirò sulla sua persona i giudizi attivi degli stessi capi della rivoluzione allorquando, stabilito dagli esponenti borghesi lo scioglimento delle squadre armate rivoluzionarie, essa rifiutò fermamente di deporre le armi e non esitò un solo attimo ad aprire il fuoco contro la Guardia Nazionale incaricata di disarmare il popolo. A Messina, sempre nei giorni ruggenti del ’48, la temeraria Rosa Donato, mentre la città dello stretto subiva il fuoco del bombardamento borbonico, combatté come irriducibile artigliere per difesa della città. Tale partecipazione della donna siciliana, rappresentò, nel corso della rivoluzione del 1848, un primo passo avanti sulla strada di una presa di coscienza che, più avanti, avrebbe portato a un diverso rapporto tra vicenda storica e mondo femminile. Infatti nel corso degli avvenimenti che segnarono la difficile strada verso l’unità d’Italia , la donna siciliana, molto spesso, fu presente nella lotta attiva e lo fece con coraggio, e quello che più conta, con piena consapevolezza delle proprie scelte. Anche nel 1860, molte giovani donne siciliane parteciparono alla lotta armata in appoggio alle truppe garibaldine e, come scriveva in quei giorni Cesare Abba: «… indossavano disinvolte la camicia rossa…». Lo stesso Garibaldi, conquistata Palermo restò favorevolmente sorpreso dalla partecipazione delle donne e rivolse loro un caldo saluto dicendo: «Colla coscienza di far bene, io propongo cosa gradita certamente ad anime generose come voi siete o donne di Palermo…». Mentre s’accendeva in ogni angolo della Sicilia la lotta garibaldina, una giovane donna di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, certa Giuseppa Calcagno, detta «Beppa la Cannoniera», vestita di abiti maschili, compì vari atti d’eroismo combattendo nelle barricate della città. Il soprannome le fu dato perché durante tutto il tempo della rivolta essa manovrò con particolare destrezza un cannone sottratto al nemico sparando contro le truppe borboniche; per questo motivo divenne in quei giorni il simbolo stesso della insurrezione popolare.
116
Ma «Beppa», popolana intrepida, dopo i giorni della speranza che precedettero l’unità d’Italia, visse quelli amari della delusione e del dolore. A Biancavilla, altro centro del messinese, su di lei e sulla folla dei contadini che tentavano di occupare le terre comunali, mai divise in dispregio ai decreti di Garibaldi, si riversò la scarica della fucileria dei soldati «italiani», assunti al ruolo di nuovi conquistatori. Tra i rivoltosi di Biancavilla che rivendicavano, al pari di quelli di Bronte, il diritto al lavoro, si distinse un’altra popolana coraggiosa. Si chiamava Vincenza Viccerri e venne arrestata e condannata come tanti altri che, aspirando ad una vita più umana, scesero in lotta contro un regime rivelatosi anzitempo distante dalle aspirazioni popolari. A Palermo, nel settembre del 1866, durante la rivolta del «sette e mezzo», che segnò la prima crisi del nuovo stato unitario e denunciò l’immutato malessere di quelle masse popolari incomprese dalla nuova classe dominante oltremodo distante dai bisogni dei meno abbienti, non mancò la partecipazione delle donne alla lotta.
*** Episodi di coraggio ma anche di feroce crudeltà segnarono quella drammatica vicenda. Tra gli episodi di coraggio si ricorda che durante la rivolta le monache dei monasteri delle «Stimmate» e di «Santa Maria Nuova» ospitarono i rivoltosi che dalle finestre di quei conventi tiravano sulle truppe regolari. Il generale Cadorna, sedata la rivolta, si dolse dell’accaduto in una storica lettera inviata all’Arcivescovo di Palermo al quale chiedeva spiegazioni. Per i fatti di crudeltà si distinsero tristemente le donne di Misilmeri (in provincia di Palermo) che furono protagoniste di atti di efferata violenza. Un giornale di quei giorni raccontò che esse inveivano contro la forza pubblica gridando minacciose: «A sei grana la carni d’un surdati! A otto chidda d’un carrubbineri». Anche a Palermo, le donne dei quartieri poveri furono tra i protagonisti più agguerriti; al pari dei mariti, dei figli, dei padri commisero atti di crudeltà, perché in quei giorni, la ferocia fu prerogativa di tutte le forze in campo e le donne, che forse in maggiore misura erano
117
vittime di una condizione miseranda, espressero con proporzionale reazione la propria rabbia veicolandola negli atti di dura violenza. In quei giorni la mafia scese in campo ma dalla parte del potere e quindi delle forze dell’ordine facendo chiaramente intendere di volersi inserire all’interno del sistema legale. Essa infatti non indugiò ad uccidere il mafioso Miceli che s’era messo alla testa dei rivoltosi. Giuseppe Maggiore, nel romanzo storico Il sette e mezzo raccontando quella rivolta così mirabilmente descriveva la partecipazione delle donne: «… pattuglie di rivoltosi in armi, torme di forsennati, frammiste di ragazzaglia urlante e di donnacole inserpentíte, sciamavano per le vie, dando la caccia ai “galantuomini”, disseminando il disordine ed il terrore…». Egli scriveva inoltre che, sotto le abitazioni signorili della città, turbe di rivoltosi sfogavano la rabbia che antiche sofferenze e l’avvilente atavica miseria avevano trasformato in odio rabbioso e dirompente. Quelle donne come la cronaca raccontava in quei giorni, più «inselvaggite» e «insatanate» degli stessi uomini gridavano a mo’ di cantilena: «Scinniti signuruzzi, livati i cappidduzzi, picca n’avití; venite giù sanguisughe dei poveri, che faremo polpette». Mentre a Palermo divampava la rivolta, gli abitanti dei paesi vicini, delle borgate e dei villaggi più poveri facevano così scrivere al cronista; «… sui carri, sui muli bardati, a piedi, armati di vecchi schioppi e di strumenti contadineschi, seguiti dalle donne più ardimentose, calavano verso il centro…». Ancora Giuseppe Maggiore, descrivendo la partecipazione delle donne all’assalto delle carceri palermitane scrisse: «Le donne in prima linea, le più invelenite e inacerbite, strillavano come ossesse, lasciandosi andare a gesticolazioni sguaiate e sconce. Dalle grate, fitte di grappoli umani, i detenuti facevano eco con urli ferini». Ed ancora le donne protagoniste nell’atmosfera di tragedia che in quei giorni incombeva sulla città: «… un’orda di uomini e donne, ebbri come scimmie, tra risa squarciate e gesticolazioni oscene, facevano il girotondo sotto un fanale, da cui pendeva impiccato un celebre sbirro». Nella città, tra le macerie «torme di femmine scarmigliate… con i bimbi attaccati alle sottane, si aggiravano e strisciavano tra i cadaveri
118
disseminati per ogni dove, studiandosi di raffigurare nei visi sformati e contraffatti, chi il padre, chi il figlio o il marito». Il popolo disperato era stato ancora una volta sconfitto e la condanna delle crudeltà popolari lasciava posto, nelle parole del cronista, alla umana pietà. Ma le donne ribelli, che alla rivolta avevano attivamente partecipato dimostrando combattività e ferocia, erano in realtà espressione di una società che le aveva costrette a vivere nella dimensione aberrante della paura e della miseria; esse in altri termini, avevano appreso dallo stesso potere oppressivo e dagli stessi abusi subiti la rabbia e l’odio. In assenza di una coscienza civile, esse istintivamente tentavano di affrancarsi da tutte le ingiustizie e lo facevano nel solo modo che conoscevano e cioè con la reazione violenta e irragionevole.
*** Il quadro che fornisce Cesare Lombroso sulla condizione della donna nella campagna calabrese, nel suo libro In Calabria, pubblicato nel 1863, non fa che rispecchiare in generale la condizione della donna nel profondo sud, all’interno della comunità rurale e della famiglia che ne era la cellula fondamentale. La donna siciliana in particolare godeva di quel potere che le derivava dal dovere amministrare le risorse economiche, pur misere ed incerte, del nucleo domestico. In pratica sussisteva una vera e propria forma di matriarcato da cui la donna traeva un certo rispetto che essa aveva finito per pretendere usando tale arma per molti versi efficace. Significativo di tale prestigio e potere era il fatto che perfino i briganti ed i mafiosi rispettavano, quasi con timore, la donna e quando l’organizzazione mafiosa in Sicilia conquisterà spazi più vasti nel mondo del crimine e del sopruso, lo sfruttamento della prostituzione non sarà mai di interesse della mafia che, a suo modo ed anche per non alienarsi certe simpatie popolari, finirà per rispettare la donna. A1 di là delle rinunce che il contesto socio-economico imponeva alla donna, peraltro condizionata da un ambiente decisamente arretrato per i molti tabù morali, questo fattore di diffuso rispetto fu alla
119
base del coraggio spesso dimostrato dalle donne anche in circostanze riguardanti vicende di brigantaggio e di mafia. Anche nei casi in cui furono costrette a subire la violenza e la sopraffazione, le donne, che dovettero stabilire, più o meno volontariamente rapporti con gli appartenenti a tali organizzazioni criminose, lo fecero senza rinunciare alla loro personalità e dando spesso prova di grande forza d’animo. L’ammirazione che, per paura o convenienza gli strati rurali esprimevano nei confronti del brigantaggio e della mafia, non condizionò la capacità delle donne di formulare, con senso critico e spesso con spregiudicatezza, il proprio personale giudizio, anche a rischio della propria vita. Alle donne che, coraggiosamente denunciarono i briganti, si affiancarono quelle che li amarono per propria volontà; ciò conferma, se ce ne fosse bisogno, la loro capacità di assumere la responsabilità di una scelta in quei casi densa di pericoli per opposti motivi. Non deve del tutto sorprendere l’ostilità delle donne di San Mauro di Castelverde, piccolo centro in provincia di Palermo, dimostrata in modo netto e senza tentennamenti, attorno al 1870, nei confronti dei famigerati briganti della banda Maurina, nonostante essi fossero elementi notoriamente feroci e temuti. L’atteggiamento femminile, di ripulsa e riprovazione, che si ritrova nei fatti di cronaca avvenuti in quei giorni nel piccolo paese, fu di chiara e coraggiosa condanna per quanto di ingiusto e aberrante c’era stato nell’azione criminale di quei loschi malfattori. In effetti le donne di San Mauro di Castelverde si posero in primo piano nella lotta che aveva coinvolto la parte sana del paese, a seguito della uccisione del sindaco Pace Turrisi, assassinato dai briganti, avendo egli intrapreso un impegno progressista per la crescita civile e sociale di quella popolazione immiserita, anche a rischio del suo contributo di sangue puntualmente pagato. Tutto ciò contraddiceva quel sentimento di solidarietà e la disponibilità al sostegno e alla collaborazione che, solitamente, il popolo esprimeva nei confronti dei briganti, chiamati con ammirazione: «omini, risoluti, arditi e forti». Era pur vero che questo sentimento popolare presupponeva, da parte dei briganti il rispetto di quei principi di etica elementare che, nel caso della banda Maurina, erano stati profondamente offesi.
120
Se una morale va tratta da questi atti si deve affermare che le donne, in quanto parte di una umanità in «tensione», pur tra profonde contraddizioni, hanno assunto nella storia delle rivendicazioni popolari in Sicilia, una posizione attiva, nel bene e nel male, anche se un giudizio definitivo non risulta di facile formulazione a meno che non si approfondiscano gli aspetti sociologici che discendono dalle varie vicende storiche. Ai fini dell’analisi che stiamo affrontando in queste pagine è opportuno accennare ad altre vicende che hanno visto le donne protagoniste delle contestazioni sociali e politiche. Non è facile visto che ci riferiamo a fatti avvenuti nella seconda metà del secolo scorso quando la definizione «emancipazione», aveva ancora poco significato. Ma la cronaca di quel tempo ci viene in aiuto: «Lucia Scialabba, 21 anni, contadina di San Mauro di Castelverde, respinse le profferte amorose del famigerato brigante Nicolò Zito il quale, per vendicarsi del rifiuto di lei, ne ferì gravemente il fratello in una vile imboscata. Ma il brigante venne dalla donna coraggiosamente denunciato alle autorità». «Anna Piscitello non ebbe timore a denunciare il brigante siciliano Domenico Botindari che le aveva ucciso il fidanzato mentre questi bussava alla porta della sua casa; dopo averlo denunciato, subito dopo il delitto, lo accusò nuovamente e duramente davanti alla Corte d’Assise nel corso del processo celebrato nel 1872». «A Sciara (provincia di Palermo) la giovane Marianna Panzarella, che era stata rapita il 23 ottobre del 1876 dai noti briganti Lo Bue e Gullo, amici del proprio fidanzato Pietro Di Pasquale, un onesto contadino del vicino centro di Montemaggiore, liberata dopo alcuni giorni non esitò a denunciare i rapitori permettendone l’arresto. Ella nonostante le minacce ricevute ripeté le accuse nel corso del processo, quando, come scrisse il Giornale di Sicilia del 3 ottobre del 1878, alla affermazione di uno dei briganti: “Io nemmeno vi conosco”, rispondeva con fermezza “Non mi conoscete? Guardatemi bene adunque! Io sono Marianna, la fidanzata del vostro amico Pietro! E il fazzoletto rosso degli sponsali lo possedete tutt’ora o l’avete smarrito nelle vostre scorrerie?”».
121
1915. Soldati italiani in una trincea sul Carso
122
«Grande coraggio e determinazione dimostrò anche Giovannina Rinaldi di Polizzi centro agricolo dell’entroterra palermitano, costretta a diventare l’amante del brigante Angelo Rinaldi. Quando la donna si ribellò e si adoperò per denunciarlo venne da questi assassinata quando era sul punto di farlo. Era il gennaio del 1875 e la povera donna doveva certamente conoscere i rischi che correva, ma non aveva avuto paura». Durante i tumulti di Corleone avvenuti nel luglio del 1884, contro la imposizione del dazio di consumo, le donne di quel paese parteciparono in massa alla protesta e fecero scrivere al Giornale di Sicilia che ne dava notizia: «… ebbe luogo una prima dimostrazione la quale, dapprincipio tranquilla, divenne poi tumultuosa. Erano tutte donne che riunite in piazza Municipio cominciarono a gridare: Viva il re, abbasso il dazio di consumo. Poi andarono per via Cappuccini ove a loro si unì una donna armata di scure, la quale propose di recarsi in via Bentivegna per atterrare un casotto eretto dal municipio per la riscossione delle imposte. Le dimostranti infilarono subito la via Bentivegna come amazzoni furibonde…». Gli uomini di Corleone, superato ogni timore, grazie al coraggio delle proprie donne, il giorno dopo appesero alcuni cartelli in cui era scritto: «Ieri l’hanno fatto le donne, domenica la faremo noi (la rivolta) con gli schioppi alle mani». Anche durante uno sciopero nel 1890, attuato alle miniere di Favara in provincia di Agrigento «le donne, i ragazzi e i vecchi appartenenti a famiglie di zolfatari… tutti gridarono minacciosamente e a squarciagola…» come riportava una cronaca coeva di quel fatto. Il movimento dei fasci dei lavoratori segnò un momento fondamentale del processo di avanzamento dei ceti popolari anche proiettando la donna nel ruolo di consapevole partecipazione alla lotta intrapresa dalle masse contadine. In questa vicenda storica, le donne siciliane appartenenti a quel ceto contadino per molto tempo mortificato, divisero con gli uomini speranze e delusioni mostrandosi pronte, dove c’era da protestare, gridando senza timori, la propria protesta, lottando coraggiosamente anche a rischio della vita.
123
In una cronaca di quei giorni si leggeva: «A Villafrati, durante una manifestazione di contadini accompagnati dalle loro donne in un feudo, i gabellotti avevano fatto ricorso alle armi». Le donne, diceva la cronaca, erano state le più coraggiose e non avevano dimostrato paura. Tutto ciò poiché «I fasci» avevano rappresentato una speranza di libertà ch’era, in gran misura, liberazione dalla miseria e dalle umiliazioni per un avvenire più giusto. I «fasci» erano finiti di diventare una nuova fede, come scriveva il giornalista de la «tribuna» Adolfo Rossi in quei giorni. «… le donne che erano religiosissime, non credono più che ai fasci… Dove sono i tentennanti o i timorosi dell’autorità, le mogli riescono a convertirli e li spingono a iscriversi nel grande esercito dei lavoratori». Il socialista Filippo Turati, preoccupato che l’azione repressiva del governo potesse provocare una ribellione popolare dalla quale i socialisti temevano di aver tutto da perdere e nulla da guadagnare, in un suo discorso contro il governo, richiamava il ruolo primario assunto dalle donne nella lotta dei fasci e la loro azione volta a promuovere la partecipazione di tutti i componenti delle famiglie. Sottolineava altresì la resistenza ad ogni provocazione tesa a creare disordini e quindi a giustificare provvedimenti autoritari nei confronti dei fasci: «Malgrado tutto ciò, e con l’indole sulfurea di quelle popolazioni, e con la partecipazione delle donne al movimento delle donne, la cui accensibilità insurrezionale è ben nota, e che abbandonano la chiesa per i fasci e vi spingono i mariti e i figlioli – il governo, coi provvedimenti del “teppismo” più svergognato, non è riuscito a suscitare neppure una parziale sommossa». In molti comuni dell’Isola, all’interno dell’organizzazione dei fasci, c’erano le sezioni femminili ed in alcuni paesi perfino «Fasci» composti da sole donne. Nell’estate del 1893, a Piana dei Greci, in provincia di Palermo la sezione femminile del fascio contava già mille contadine iscritte a fronte di duemilacinquecento uomini. Fasci femminili vennero costituiti a Campofiorito, con due centoquattordici donne iscritte, a S. Giuseppe lato con ottanta iscritte, a
124
Belmonte Mezzagno con settanta iscritte a Villafrati con centocinquanta iscritte. Numerose sezioni femminili erano aggregate ai fasci di Altofonte, Sommatino, Chiusa Sclafani, Corleone; molte donne facevano parte dei fasci di Casteltermini, Mazara del Vallo, Trappeto. A Campofelice di Fitalia il fascio contava più donne che uomini tra i propri iscritti. Una contadina di Piana dei Greci, alla domanda fattale dal giornalista Adolfo Rossi: «Cosa sperate dai fasci?», così rispondeva: «Vogliamo che, come lavoriamo noi, lavorino tutti. Che non vi siano più né ricchi né poveri. Che tutti abbiano del pane per sé e per i propri figli. Dobbiamo essere uguali. Io ho cinque bambini ed una sola cameretta, dove siamo costretti a mangiare, a dormire e a far tutto, mentre tanti signori hanno dieci o dodici camere, dei palazzi interi». La stessa contadina così spiegava il rapporto tra la fede religiosa e la propria adesione ai fasci: «Gesù era un vero socialista e voleva appunto quello che vogliono i fasci, ma i preti non lo rappresentano bene, specialmente quando fanno gli usurai. Alla fondazione del fascio i nostri preti erano contrari e al confessionale ci dicevano che i socialisti sono scomunicati. Ma noi abbiamo risposto che sbagliavano, e in giugno, per protestare contro la guerra ch’essí facevano al fascio, nessuno di noi andò alla processione del Corpus Domini. Era la prima volta che avveniva un fatto simile». C’era, nell’adesione ai fasci dei lavoratori, una componente religiosa e mistica nello stesso tempo. L’immagine del Cristo e del Santo protettore del paese non mancavano quasi mai nelle sedi dei fasci come pure non mancavano i ritratti del re e della regina a dimostrazione della componente paternalistica, storicamente ricorrente, nei movimenti di protesta popolare specie contadina. Le classi più deboli erano convinte che il re fosse ignaro delle malefatte dei suoi ministri e luogotenenti e durante le manifestazioni dei fasci in alcuni cartelli si inneggiava al re e alla regina considerati nella loro astratta idealità e non come espressione di quel potere iniquo oggetto delle dure contestazioni. Sulla componente religiosa influiva certamente l’insegnamento evangelico sulla condanna della ricchezza e secondo cui Cristo è, e
125
vuol essere, il vero povero, il povero assoluto; in base a tale insegnamento ogni uomo che si arricchisce rinnega Cristo e ne diviene nemico. Le donne dei fasci, nella loro disperata ansia di giustizia, non vedevano alcuna contraddizione tra la fede religiosa e 1’idea del movimento e quindi tra il socialismo e il cristianesimo; con tale contraddittoria valutazione semplicistica, erano fortemente convinte che, l’essenza stessa della religione cristiana e quindi gli insegnamenti del vangelo, non potessero essere in contrasto con i principi fondamentali del socialismo. Questa esemplificazione fa parte della visione tipicamente popolare della storia talché si è spinti a valutare più i lati formali dei fatti che l’essenza stessa dei fenomeni, più gli obbiettivi che si vogliano raggiungere, che le filosofie e gli strumenti che si vogliono utilizzare. Il 1893 era iniziato con la strage di Caltavuturo, che aveva spinto il mondo contadino ad unirsi e a riconoscersi nei fasci dei lavoratori. Il deputato Napoleone Colajanni aveva così gridato in parlamento: «Il sangue versato forse, feconderà la terra meglio che non l’abbia fecondato sinora il sudore dei suoi lavoratori!». Sembrava che non potesse avvenire maggiore provocazione di quella strage e pur tuttavia Caltavuturo non fu che il principio di una serie di attacchi ancor più gravi. Anche in quella tragica giornata di Caltavuturo le donne furono presenti. Il Giornale di Sicilia infatti così scriveva: «Questa mattina, cinquecento persone, fra uomini e donne, muniti di zappa ed altri arnesi campestri, si recarono sui terreni di proprietà del comune volendo così fare atto di proprietà collettiva di quelle terre». In un successivo articolo di cronaca si leggeva: «Le donne si diedero a tirar sassi contro la forza pubblica, una pietra colpì alla faccia il brigadiere dei carabinieri che ordinò di far fuoco». Nei tumulti di Monreale (dicembre 1893) avvenne che «al grido abbasso il municipio, viva il fascio, i capannelli ingrossarono, si fusero, ma erano tutti ragazzi e donne e pochissimi uomini». Nel descrivere l’assalto ai casotti daziari lo stesso giornale riportava: «Le donne, nel tumulto si distinguevano per la loro irrequietezza.
126
Molte di esse parteciparono al saccheggio e alla distruzione… Verso le undici ebbe luogo un’altra dimostrazione di donne che gridavano: – Abbiamo fame! E insistevano perché al balcone municipale fosse inalberato l’emblema cioè il “fascio d’erba”». Il primo maggio del 1893 a Corleone, paese di Bernardino Vervo, uno dei Capi dei fasci, si fece grandissima festa. Su «Giustizia Sociale» si leggeva: «Che bella giornata, il fascio e le vie adiacenti erano impenetrabili, perché i contadini correvano a centinaia a iscriversi; la società corporativa tra muratori tutta in corpo fece adesione… Alle sette pomeridiane la vasta sala del fascio si popolò delle socie del fascio della sezione massaie, più che mille donne, le quali sentono abbastanza il perché dobbiamo muoverci». E ancora: «Bernardino Verro, fattosi al banco della presidenza, tra gli evviva di quelle donne contadine, spiegò il 1° maggio, come festa di affermazione dei lavoratori del mondo, dicendo poi della donna nella questione sociale». Nell’ottobre di quell’anno, a Villafrati durante lo sciopero contadino, s’era avuta una straordinaria partecipazione di donne. Certa Caterina Costanza, che aveva avuto parte attiva nella organizzazione di quello sciopero, venne arrestata e subito dopo liberata grazie ad una manifestazione di solidarietà di contadini e contadine. Scrisse Giuseppe Casarrubea: «Due giorni prima, dieci donne armate di bastone s’erano recate nel campo di Salvatore Forte per invitare i braccianti ad astenersi dal lavoro». A Giardinello, il 10 dicembre del 1893 fu giorno di massacro: dieci popolani cadevano uccisi sotto il piombo della truppa. Scriveva così Alfredo Angiolini ne Socialismo e socialisti in Italia: «La folla cominciò a tumultuare chiedendo le chiavi del municipio per distruggere i ruoli delle imposte. Si chiese un rinforzo di soldati e giunse sulla sera un plotone di bersaglieri: le donne gli andarono incontro gridando: “Viva il re, viva il fascio”; i soldati, non si seppe come mai, fecero fuoco». Sulla partecipazione delle donne ai disordini di Balestrate del 13 dicembre, il Giornale di Sicilia, scriveva: «Ieri verso le 16, una gran folla di donne riunivasi nella piazza matrice armata di grossi bastoni e randelli, protestando contro la guardia daziaria Giorgio Sirchia che
127
aveva dichiarato in contravvenzione una povera donna, per aver venduto un litro di vino senza il regolare permesso. Le donne del vicinato indignate cominciarono ad assembrarsi ed a tumultuare; quindi recatesi innanzi la porta del Sirchia cominciò una sassaiola fittissima… Accorsero i bersaglieri ed i carabinieri guidati da un tenente, il quale messosi da paciere calmò quelle energumene inducendole a sciogliersi… Le donne sono in fermento, preveggonsi altre dimostrazioni». «L’agitazione che aveva provocato i tumulti di Lercara del 24 dicembre», scriveva il Giornale di Sicilia, «era cominciata verso le ore 13 con un corteo di donne che, sventolando una bandiera bianca, fatta con uno straccio, invitavano gli uomini a manifestare». Il 28 dicembre venivano tratte in arresto diverse danne di Balestrate, sospette d’aver tirato delle pietre contro la caserma dei carabinieri. Nella stessa notte parecchie donne venivano arrestate anche a Camporeale. «A Pietrapersia, in provincia di Caltanissetta, il 2 gennaio del 1894, una manifestazione di protesta si tenne all’interno della matrice. Erano uomini e donne, parecchie di queste portavano bambini alle braccia. Infilarono il corso Vittorio Emanuele alle grida di viva il socialismo! Abbasso le tasse! Siamo affamati! ». Avvenne lo scontro con la truppa e restarono uccise alcune dimostranti fra le quali una bambina. A Gibellina, in provincia di Trapani, il 3 gennaio del 1894, «…una enorme folla di donne incominciò a percorrere il paese aizzando gli uomini a gridare “abbasso le tasse”, “abbasso il consiglio”». Il Giornale di Sicilia che pubblicò la cronaca dei gravi tumulti che culminarono in un massacro, scriveva così delle donne che avevano fronteggiato con coraggio i soldati: «Fu innalzata la bandiera del fascio al balcone del Municipio e si ebbero delle grida assordanti, specialmente dalle donne». E ancora: «Le donne, forse, che si trovavano davanti, si diedero ad insultare qualche soldato e quando ebbero a sentire che il consiglio non volle dimettersi, si diedero a gridare fortemente». Dopo il massacro compiuto dai militari che avevano aperto il fuo-
128
co sulla folla inerme scoppiò la rabbia popolare; ancora il Giornale di Sicilia riportò in cronaca l’ira delle donne: «Il delegato fuggì per un’altra via e, rimasto solo il Pretore, anche questi pensò di fuggire, gli andarono dietro e a colpi di pietra lo resero cadavere». La sera del 3 gennaio del 1894 fu proclamato in Sicilia lo Stato d’assedio. Sgomento e rabbia si impossessarono della gente. L’indomani a Marineo, piccolo centro in provincia di Palermo, vi furono gravi disordini che culminarono in un altro feroce massacro. Nella cronaca si legge: «Il paese è nella disperazione. Ovunque lamenti e grida di dolore. Le donne, massimamente furenti, corrono le vie del paese soccorrendo i moribondi». Queste immagini drammatiche di rabbia e di disperazione, che abbiamo voluto trarre dalla scarna cronaca di quei giorni, senza aggiungere nulla per evitare di togliere verità ai contorni del dramma, sembrano sottolineare, da un lato la sconfitta di una speranza e dall’altro la determinata partecipazione delle donne alla lotta. Adolfo Rossi, giornalista de la Tribuna, nel suo libretto L’agitazione in Sicilia pubblicato nel 1894, descrisse con grande sensibilità il suo incontro con alcune donne del fascio di Piana dei Greci. Egli arrivò in paese alla vigilia della inaugurazione della bandiera della sezione femminile del fascio. Intervistò uomini e donne e di queste ultime vogliamo trascrivere quanto risposero alle domande poste dal Rossi in una intervista emblematica della visione popolare dei fatti: D – E così vorreste dividere le terre e le case? R – Una contadina maritata (bella donna con denti candidissimi e grandi occhi pieni di intelligenza): «No, basta metterle in comune e distribuire con giustizia, quelle che rendono». D – E non temete che, anche se si arrivasse a questo collettivismo, non venga fuori qualche imbroglione, qualche capo ingannatore? R – «No, perché ci deve essere fratellanza, e se qualcheduno mancasse, ci sarebbe il castigo». R – Una zitella (alzandosi e venendo a parlare in mezzo al circolo perché la sentissi bene): «I signori prima non erano religiosi e ora che
129
c’è il fascio hanno fatto lega con i preti e insultano noi donne socialiste come se fossimo disonorate. Il meno che ci dicono è che siamo tutte le sgualdrine del presidente». R – Una vecchia: «Io ho avuto il marito malato per sette anni e andai al Municipio a dire che non potevo pagare il fuocatico. Mi hanno risposto che dovevo andare a servizio, ma che era necessario pagare». D – Ah! C’è anche qui la tassa del fuocatico? R – Un vecchio contadino (presente all’incontro) rispose affermativamente e parlò anche della tassa sugli animali per cui si doveva pagare ogni anno 10 lire per ogni mulo e 5 per ogni asino. Un consigliere comunale operaio aggiunge d’avere constatato «che certi signori i quali hanno, per esempio, venti muli, non ne mettono in nota che quattro, e nessuno si cura di verificare». R – La contadina maritata (quella bella): «E i nostri muli servono a noi per farci campare, mentre i signori che non pagano ne hanno d’avanzo». R – Un’altra contadina: «Non trovando qui lavoro, mio marito è andato in America, e per campare le mie due figlie hanno dovuto mettersi al servizio a Palermo. Sentendo che c’era il colera, la settimana scorsa io volli andare a trovarle. Non avevo da pagare il carretto e fui costretta ad impegnare qualche straccio presso uno strozzino, perché qui non abbiamo monte di pietà, ma solo certi usurai che una volta erano poveri come noi». R – Una terza contadina: «Quando poi si sono arricchiti molto, vanno a stare a Palermo o a Napoli, come i grandi proprietari, e lasciano qui noi alle prese con altri strozzini prepotenti, i quali ci dicono che per chi fa la legge non c’è legge». R – Una zitella (quella che quando parlava si alzava e andava in mezzo alle compagne): «Infatti, quando un reato è commesso da un ricco, nessuno se ne cura, mentre il povero che ruba un pugno di grano per sfamarsi va subito in prigione». R – Una sposa: «Vedete che per i poveri non c’è giustizia in Piana dei Greci I signori dicono apertamente che ci vogliono ammazzare ad uno ad uno».
130
R – La bella sposa (ai contadini): «E non gli dite nulla dei baffi?». R – Un contadino: «Ah, già! – Prima del fascio, come in quasi tutta la Sicilia, anche qui noi contadini usavamo raderci completamente la barba. Ma visto il modo con cui i signori seguitavano a trattarci, per protestare ci siamo tutti lasciati crescere i baffi, come vede. Ora i padroni ce l’hanno con noi anche per questo e ci minacciano dicendo: “conteremo questo inverno, quando avrete più fame di adesso. Vedremo se mangerete i baffi, allora”». D – Ma quando pure i vostri uomini fossero padroni del consiglio, non potranno per questo levare le tasse! R – «Lo sappiamo – saltò su a dire la contadina più intelligente – che per ora i nostri consiglieri non potranno far altro che impedire gli abusi e le prepotenze dei signori, i quali, finora hanno comandato anche nel Comune. Ma i fasci nomineranno anche i consiglieri provinciali e i deputati e quando alla camera avremo una maggioranza socialista…». Quelle donne intervistate da Adolfo Rossi ripeterono con fermezza ed entusiasmo di essere pronte a «Morire gridando: Viva il socialismo». «Il nostro fascio esisterà finché uno dei suoi sarà vivo» dissero quelle contadine intervistate alzando le braccia in atto di sfida e aggiunsero: «Vedete questa nostra compagna? – mostrando una bella giovane diciottenne, formosa, dai grand’occhi neri, che col viso incorniciato dalla mantellina albanese di lana bianca aveva tutto l’aspetto di una vestale – durante l’ultimo tumulto ella si avanzò verso i soldati che avevano spianato le armi contro il popolo e disse loro: “Avreste il coraggio di tirare contro di noi?”. Un soldato le rispose piano, per non farsi sentire dagli ufficiali: “Io per me ti do anche il fucile, se vuoi” Il Capitano poi le disse: “Invitate le vostre compagne e i vostri uomini a gridare: Viva il re! Viva l’esercito! E tutto sarà finito”. Così infatti avvenne. Da quel momento noi abbiamo scelto questa compagna per portabandiera della sezione femminile del fascio». Questi sono alcuni esempi della partecipazione delle donne alla protesta dei fasci dei lavoratori in Sicilia; esse si posero in prima linea con coraggio e determinazione con la consapevolezza del proprio diritto alla vita,
131
fianco a fianco degli uomini. La loro partecipazione fu spesso passionale e forse irrazionale ma fu quasi sempre espressione di una protesta che loro sentivano come l’unica possibilità di rivalsa dalla miseria. Il loro rapporto con la storia era espresso nei termini elementari ed eterni della sopravvivenza al di là di ogni possibile ideologia.
132
7 Dal «Discorso dell’ascensione» di Mussolini del 26 maggio 1927
“Vengo alla mafia. Signori Deputati! Anche qui parlerò, chiaro: non m’importa nulla se domani la stampa di tutta il mondo si impadronirà delle mie cifre. La stampa di tutto il mondo, però, dovrà ammettere che la chirurgia fascista è veramente coraggiosa, è veramente tempestiva. Di quando in quando giungono fino, al mio orecchio delle voci dubitose, le quali vorrebbero dare ad intendere che in Sicilia attualmente si esageri, che si mortifica un’intera regione, che si getta un’ombra sopra una Isola dalle tradizioni nobilissime. Io respingo sdegnosamente queste voci, che non possono partire che da centri malfamati. Signori, è tempo che io vi riveli la mafia. Ma prima di tutto, io voglio spogliare questa associazione brigantesca da tutta quella specie di fascino, di poesia, che non merita menomamente. Non si parli di nobiltà e di cavalleria della mafia, se non si vuole veramente insultare tutta la Sicilia!”. “Vediamo. Poiché molti di voi non conoscono ancora l’ampiezza del fenomeno, ve lo porto io come sopra un tavolo clinico: ed il carpo è già inciso dal mio bisturi. Nei Comuni di Bolognetta, Marineo e Misilmeri (Palermo) sin dal 1920 si era costituita una associazione a delinquere composta di circa 160 malfattori, che si erano resi responsabili di 34 omicidi, 21 mancati omicidi, 25 rapine, furti. ecc. A Piana dei Greci e molti di voi ricordano quell’ineffabile sindaco che trovava modo di farsi fotografare in tutte le occasioni solenni: è dentro, e ci resterà per un pezzo! – a, Piana dei Greci, Santa Cristina, Gela e Parco venne arrestata una comitiva di 43 malviventi, 43 che avevano consu-
133
mato 12 omicidi, 6 rapine, ecc. Nel circondario di Termini Imerese, fra l’1 e il 31 marzo, sono stati arrestati 278 delinquenti associati, che dovevano rispondere di 50 omicidi, 9 mancati omicidi, 26 rapine: trascuro la minutaglia minore.” “Un’altra vasta associazione a delinquere venne scoperta nei circondari di Nistretta e di Patti. Degli associati 40 vennero arrestati, e vennero sequestrati grandi quantità di animali e derrate per un valore di 2 milioni. Un’altra comitiva di malviventi, a Belmonte e a Mezzaiuso, aveva commesso 5 omicidi, 7 rapine, ecc. A Piana dei Colli un’altra comitiva di gentiluomini, 38 omicidi. A Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone; Campofiorito, 72 delinquenti, 14 omicidi. A Casteldaccia, Baucina e Ventimiglia (Palermo) si poté stabilire che 179 malfattori, in epoche varie, si erano resi responsabili di 75 omicidi, 14 mancati omicidi, ecc. Nei Comuni di Bagheria, Ficarazzi, Villabate, Santa Flavia (Palermo) si era composta un’associazione di 33 individui che, in epoche varie, si sono resi responsabili di 111 omicidi, 19 rapine, ecc. A Santo Stefano, Quisquina, provincia di Girgenti, 42 individui, 7 omicidi, ecc. A Roccamena (Palermo), altra comitiva di 42 delinquenti con omicidi, ecc. A quest’opera, che è stata fatta in gran parte dai Carabinieri, si è associata anche la Milizia. In tutte le grandi battute contro la delinquenza della mafia, la Milizia è stata al suo posto”. “Ma non crediate che tutto ciò non abbia costato qualche cosa. Ecco qui l’ordine del giorno, che torna a onore dell’Arma fedele dei Reali Carabinieri. Dopo un anno di lavoro, l’Arma può fare questo rendiconto morale: 10 militari uccisi in conflitto con malviventi, 1 morto nel compimento del proprio dovere, 330 feriti con lesioni guaribili oltre i 10 giorni, 14 premiati con una medaglia d’argento al valor militare, 6 con medaglia al valor civile, 10 attestati di pubblica benemerenza, 50 encomi solenni. Bisogna che tutti i fascisti sappiano che l’Arma dei Reali Carabinieri è una delle colonne del Regime fascista”. “Quali sono i risultati di quest’opera contro la delinquenza? Notevoli. Ecco un bollettino del prefetto Mori, al quale mando il mio saluto cordiale. Ecco il suo bollettino complessivo per tutta la Sicilia: nel
134
1923, 696 abigeati, nel 1926 126; le rapine, da 1216, sono discese a 298; le estorsioni da 238 a 121; i ricatti, da 16 a 2; gli omicidi, da 675 a 299; i danneggiamenti, da 1327 a 815; gli incendi dolosi da 739 a 469. Questo è il migliore elogio che si può fare a quel Prefetto e ad un altro funzionario che collabora con lui molto egregiamente. Parlo del magistrato Giampietro, il quale, in Sicilia ha il coraggio di condannare i malviventi”. “Qualcuno mi domanderà: quando finirà la lotta contro la mafia? Finirà. non solo quando non ci saranno più mafiosi ma soltanto quando il ricordo della mafia sarà scomparso definitivamente dalla memoria dei siciliani”.
25 maggio 1927. Mussolini parla a Palermo il giorno dell’ascensione
135
Roma, 28 ottobre 1931. Un esempio del tipo di fotografie non ufficiali che Adolfo Porry Pastorel poteva scattare al capo del governo. Qui vediamo Mussolini tra la folla acclamante in via Depretis dopo aver inaugurato l’istituto centrale di statistica
136
1921 – 1945
137
20 Aprile 1945. Partigiani entrano a Milano liberata e quindi “Cosa di Stato”
138
Milano, Piazzale Loreto, 27 Aprile 1945. Mussolini e Claretta Petacci appesi al distributore di benzina. E fu Cosa di Stato
139
8 Le collusioni del potere
Con l’omicidio, nel 1915, di Bernardino Verro, esponente socialista, già animatore dei fasci dei lavoratori, instancabile capo del movimento contadino siciliano e nel primo decennio del nuovo secolo fautore, nel corleonese, delle cooperative agricole con lo scopo di contendere ai mafiosi la gestione di ampie estensioni di latifondo, la mafia intese opporsi con la violenza alla simultanea irruzione nella vita politica siciliana delle masse lavoratrici organizzate e guidate da un ceto politico che si identificava nel nuovo partito socialista. Non si trattava, infatti, della solita plebe esaltata, protagonista di sommosse destinate a dissolversi nel nulla, bensí di una organizzazione di lavoratori coscienti dei propri diritti e degli obiettivi di progresso sociale. Si trattava, per la borghesia-mafiosa, di un pericolo ben piú serio a cui bisognava reagire con tutti i mezzi. L’uccisione di sindacalisti rappresenta un esempio emblematicio di come la mafia, con l’unità d’Italia, divenuta forza elettorale e di supporto ad esperienze politiche, a partiti, a uomini politici, abbia occupato spazi vitali della società civile siciliana opponendosi alla sua crescita sociale ed economica. Alcuni anni dopo nemmeno il Fascismo, che si vantava di aver ripristinato «l’ordine» in Italia, riuscí a mettere il bavaglio alla mafia che, annidatasi negli alti livelli del regime in Sicilia, aveva continuato una stretta collaborazione con il potere politico. Cesare Mori, detto il «Prefetto di Ferro», al quale Mussolini aveva dato (in apparenza) pieni poteri nella lotta alla mafia, era riuscito a mettere le mani solo sui briganti e sui mafiosi di piccolo calibro.
140
Quando egli intuí che le vere fila della mafia venivano tirate da personaggi del regime molto influenti a livello locale, venne esautorato (nel 1929) dallo stesso Mussolini. La riforma agraria, attuata con i metodi che abbiamo raccontato, permise ai grandi proprietari di farsi espropriare a prezzi molto elevati la parte peggiore dei vecchi feudi. Su quelle estensioni di terra, per lo più aride e lontane dai centri abitati, nacquero con il sostegno di lauti prestiti fondiari “villaggi fantasma”, con tanto di monumento in piazza, che nessuno ha mai abitato. Nell’insieme, la riforma agraria fu condotta senza tenere in debito conto le reali esigenze sociali, economiche e produttive, sicché centinaia di migliaia di contadini siciliani ne decretarono implicitamente il fallimento abbandonando le campagne e andando a cercare lavoro altrove. Quelle terre che si estendevano a perdita d’occhio, irte di aride montagne, solcate da pochissime strade carrozzabili e rari corsi d’acqua, con sparsi abituri e borghi isolati, formavano lo scenario del latifondo, una forma di gestione del territorio, che ancora si identificava nella feudalità d’antica memoria dove alla miseria dei lavoratori della terra si sommava l’inospitalità ambientale e il flagello dell’avvicendarsi delle piogge torrenziali e delle grandi siccità. “Il problema centrale per la Sicilia – aveva detto Girolamo Li Causi nel 1944 – è il problema del latifondo: è da questo che scaturisce la miseria, l’oppressione, l’arretratezza del popolo siciliano”. Il decreto Gullo (ottobre 1944), per l’assegnazione delle terre incolte ai contadini, non riuscì a superare gli errori e le lacune dei provvedimenti precedenti, con la conseguenza che, con le successive leggi sulla proprietà contadina (1948) e con quella di più ampia portata di riforma agraria (1950), si incorse negli stessi difetti di impostazione che s’erano lamentati nel 1893, al tempo dei fasci. Sembrava essere destino di ogni successiva generazione trovarsi di fronte a problemi insoluti, spesso mutati soltanto in apparenza, per ricadere quasi altrettanto spesso, non per fatalità bensì per umana volontà, nei vecchi errori.
141
1932. Roma. Insegnanti con un gruppo di studenti in gita scolastica
Quelle leggi, sebbene assai moderate, divennero causa scatenante di conflitto tra il movimento contadino e la mafia, schieratasi una volta di più a difesa della rendita agraria: i contadini si trovarono esposti alle continue violenze mafiose e agli ostruzionismi burocratici dei pubblici poteri. Come abbiamo già scritto nelle precedenti
142
pagine, molti grossi proprietari terrieri delle province occidentali dell’isola, per contrapporsi alla minaccia dei contadini, protesi nell’assalto al latifondo, e per scoraggiare le richieste d’esproprio, fecero gestire le loro terre a noti mafiosi, consentendo loro di ritornare ai posti da cui erano stati costretti a fuggire durante la repressione del prefetto Mori. In quel momento denso di tensioni sociali la mafia si pose perentoriamente nel ruolo di arbitro delle sorti della riforma agraria nel segno inquietante della più generale trasgressione della legalità ch’era nella sua naturale cultura.
Cosa Nostra non era sola
143
Milano 1943. In mezzo alla città distrutta dalle bombe pausa pranzo improvvisata
144
Pochi spazi restarono alle organizzazioni contadine poiché la ricomparsa dei capimafia finì per vanificare la legittima loro aspirazione alla terra; molte richieste di esproprio di vaste estensioni di territorio furono archiviate dall’Alto commissario per la Sicilia, come quella avanzata dai contadini di Villalba – associati nella cooperativa “Libertà” – per il feudo Micciché, che la principessa di Trabia e Butera aveva affidato a don Calogero Vizzini a motivo di una scelta reazionaria. Del resto, le poche terre rimaste fuori il tiro della mafia furono ugualmente sottratte al movimento contadino con mille inganni: molte proprietà erano state ad arte divise e date in affitto per sottrarle alla sfera della legge; molte divisioni furono fatte – a questo scopo – tra parenti; piccole proprietà erano scarsamente fertili, senza acqua, lontane dalle strade di comunicazione, sicché i nuovi assegnatari, inesperti e senza capitali, finirono per non poterle più coltivare. I gabellotti mafiosi, tornati sulla scena del feudo, non indugiarono ad imporre un gravosissimo sistema di usura nelle subaffittanze e nella concessione di anticipi agli affittuari con l’intento, chiaramente speculativo, di supplire, con tale pratica, alla carenza di capitali; tra grandi agrari e gabellotti si creò una specie di racket solidale e complice sia nei confronti dello sfruttamento del contadino sia nell’azione politica volta al mantenimento della condizione di disagio sociale ed economico, necessaria al sopravvivere della sottocultura, del fatalismo e della sottomissione, da secoli humus ideale per il perdurare dei sistemi di sfruttamento. Attori del sopruso sistematico, i campieri tornarono ad affermare il dominio della mafia nei latifondi e il loro forte desiderio di denaro e di autorità. E proprio su siffatti “personaggi”, coi quali si scontrerà con esiti tragici Salvatore Carnevale, si era concentrata l’attenzione e la preoccupazione di Cesare Mori, nel corso del periodo fascista. A riguardo –, il famoso prefetto di ferro scriveva in quegli anni: “Era necessario anzitutto epurare il personale, eliminandone i pregiudicati, i mafiosi militanti e gli elementi imposti dalla mafia; ma conservare la figura del campiere quale essa era nella sua tradizione, ed acquisirli a noi nella forma di regolari, di sentinelle avanzate, di arditi della difesa sociale…”. Poi, con l’ambiguità della retorica fascista, prettamente demagogica, aggiungeva: “Il campiere deve restare quello
145
che era: un uomo cioè di capacità specifica, di forza fisica di coraggio personale e di lealtà professionale: capace di tenere testa da solo alla malvivenza e di affrontare, solo, le più pericolose situazioni, ma senza vincoli di formalismo regolamentare e con la piena libertà dei suoi mezzi”. Detto questo, li convocò a convegno, li passò a rassegna e raccontò dopo che “la massa dei campieri, in gran parte armati ed a cavallo, era magnifica di prestanza e di forza”. Poi, volle inquadrarli nelle forze fasciste e perfino farli giurare fedeltà al re per adempiere alle funzioni “di uomini di onore e di coscienza”; infine descrisse la cerimonia del giuramento, che si svolse in Palermo “in cospetto delle masse lavoratrici e della popolazione”. “Dopo alcune parole di circostanza – scrisse testualmente – lessi la formula del giuramento già prestato dai campieri, concludendo: “Lo giurate voi?”. A questo punto, tra il più alto entusiasmo della immensa folla assiepata nella piazza, i “guardiani ebbero un unanime, poderoso grido: giuro! La folla – Palermo intera – proruppe in un interminabile entusiastico grido di consenso, di gioia e di liberazione. Altri trecento uomini, forti e coraggiosi, passavano apertamente, volontariamente in linea, di fianco a noi, contro la malvivenza. La mafia, la sanguinaria mafia della Conca d’oro, perdeva d’un tratto il suo più valido mezzo di azione. La cintura di insidie che stringeva Palermo, celata nel bianco profumo della zagara, era definitivamente infranta”. Quel tentativo di legittimazione dei campieri rifletteva un certo senso la precisa volontà del regime di tenere sotto controllo vasti strati della mafia che non fossero quelli più elevati ormai inseriti nel partito fascista in una sorta di “normalizzazione”. Ma in realtà la mafia era stata soltanto ricacciata nell’ombra, e non distrutta; si rivelerà qualcosa di più duraturo del fascismo: un costume profondamente radicato in tutte le classi di provvedere da sé alla giustizia cosiddetta privata e alla protezione dei propri interessi; quasi sempre con mezzi violenti.
146
Una intensa espressione di Giovanni Falcone. (1990)
E reagirà sistematicamente ad ogni minaccia dell’ordinamento economico esistente, specie alle tendenze rivoluzionarie che partivano dai contadini. A tale riguardo Henner Hess nel suo libro Mafia ha scritto: “Queste sono molto più pericolose per proprietari e grandi locatari, per-
147
ché hanno per meta un cambiamento fondamentale di tutto il sistema”. A quelli che erano i fondamenti del potere mafioso si uniformarono, nei primi anni dell’ultimo dopoguerra, i capimafia i quali, attraverso il controllo violento di vaste aree di latifondo, riuscirono a trovare alleanze tra i partiti conservatori e ad organizzare un fronte di reazione con i grandi agrari che avevano trovato un’ala protettrice nel clero e in settori della Democrazia Cristiana. Ciò fu possibile in quanto mancava in Sicilia una nuova classe dirigente democratica e antifascista che nel nord Italia s’era formata con la Resistenza; venne così a mancare, proprio alla vigilia delle leggi di riforma agraria, l’unità politico–sindacale delle forze progressiste, sicché i dirigenti del movimento contadino si trovarono politicamente isolati, confusi nello schieramento politico della sinistra e, soprattutto, senza l’appoggio del mondo cattolico che annoverava la partecipazione di larghe masse contadine. La clamorosa vittoria dei partiti di sinistra (Blocco del Popolo), nelle elezioni del 20 aprile, 1947 per la prima legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, sembrò avesse finalmente e definitivamente rotto l’assedio reazionario e segnato l’inizio di un tentativo di rinnovamento. Ma contro questo tentativo e più in generale contro il movimento politico e sindacale che operò prevalentemente nel settore agrario, con l’apporto di elementi di tutte le tendenze, la mafia ingaggiò una lotta sanguinosa, colpendo senza pietà e privando il movimento sindacale, ed anche politico, dei suoi elementi migliori di ispirazione cattolica e socialista. Lo scopo non era solo di ostacolare la riforma agraria nella sua attuazione, ma anche quello di evitare che partiti e sindacati, rinnovati nelle strutture, potessero essere gli istituti, nei quali il singolo avrebbe finito per trovare la protezione necessaria, per uscire infine dall’angusta sfera di una visione individualistica e affrancarsi dalla sudditanza al potere illegale dei mafiosi. L’elenco degli esponenti politici e dei sindacalisti assassinati in Sicilia negli anni immediatamente successivi al 1945 è particolarmente lungo e – come si legge nella relazione della Commissione antimafia del 1976 – “con ogni verosimiglianza non è nemmeno completo, non bastando talora la sola personalità della vittima a qualificare il delitto”. Comunque l’elenco più attendibile dei sindacalisti e dei politici, caduti per mano mafiosa tra il 1946 e il 1952,
148
comprende ben quarantaquattro omicidi. Ma questi fatti così drammatici che insanguinarono per tanti anni la campagna ed i paesi della Sicilia occidentale ebbero un comune denominatore: l’incapacità che per quel periodo caratterizzò l’amministrazione giudiziaria in Sicilia, di assicurare alla giustizia gli autori di tanti efferati delitti.
La strage di Capaci del 1992 in cui morì il Giudice Giovanni Falcone assieme alla sua scorta
149
I deputati Giovanni Elkan (Dc) e Mario Assennato (Pci), a conclusione della loro indagine basata sull’analisi di campioni di processi penali per delitti e reati dal 1945 a tutto il 1964, e sul raffronto di processi di stampo mafioso con altri non di stampo mafioso, delinearono un quadro impressionante del modo in cui era stata amministrata la giustizia e condotta la lotta contro la mafia in Sicilia per moltissimi anni. Essi scrissero, tra l’altro: “Si deve anche ricordare che la maggior parte delle volte, non appena le indagini per un delitto si indirizzavano verso un individuo determinato e costui veniva posto a disposizione della Autorità giudiziaria, ogni altra pista veniva immediatamente abbandonata, sia dalla polizia che dalla magistratura, e ogni altra ipotesi di responsabilità diversa veniva quindi implicitamente accantonata.
1945. Auschwitz: l’orrore nazista
150
La polizia in simili casi sospendeva ogni attività, per non interferire nell’istruzione giudiziaria in corso, mentre dal canto loro i magistrati di null’altro si preoccupavano che di raccogliere elementi di prova nei confronti degli inquisiti: sì che il problema in definitiva non era più di accertare chi fosse stato a commettere il delitto, ma solo di verificare se a commetterlo fosse stata la persona denunciata. Avvenne così che per lungo tempo si condussero istruttorie volte soltanto a controllare se l’imputato fosse colpevole, mentre si tralasciarono tutte le altre possibili ipotesi, con la conseguenza perciò che, nel caso di errori della polizia o di accuse calunniose o di calcolo studiato negli ambienti mafiosi di prospettare un falso colpevole, proprio per stornare le indagini dalla pista giusta, la sospensione dell’attività istruttoria in direzioni diverse da quella per prima imboccata finì col favorire, una volta assolto il presunto autore del reato, il vero colpevole, in quanto impedì a distanza di tempo di riprendere una ricerca interrotta e quindi di sollevare il manto dell’oblio, che aveva finito col coprire i responsabili con una vera e propria immunità”. Un caso “classico” per il tempo, per l’ambiente, le circostanze e i personaggi implicati, era stato l’omicidio di Placido Rizzotto di Corleone il quale, come già il sindacalista Bernardino Verro, l’ispiratore dei Fasci siciliani, ucciso nel 1915, si prodigava nel movimento contadino e bracciantile, per la revisione della politica agraria e per la ripartizione dei grossi feudi incolti e improduttivi, contro la resistenza dei proprietari terrieri e ancor più contro quella dei gabellotti del prepotere mafioso. Rizzotto scomparve la sera del 10 marzo 1948. A distanza di oltre venti mesi furono ritrovati in una foiba della zona miseri resti umani che si ritenne gli appartenessero. Un ragazzo dodicenne, Letizia Giuseppe, che si trovava in quel feudo per sorvegliare il gregge e aveva visto gli assassini, sconvolto e agitato per la scena terribile che si era svolta sotto i suoi occhi, venne portato nell’ospedale di Corleone, dove il medico Michele Navarra – capomafia locale – gli praticò una iniezione dopo la quale morì. Su Luciano Liggio si concentrarono i sospetti dei carabinieri di Corleone i quali, il 3 aprile 1948, lo denunciarono in istato di irreperibilità, in quanto latitante per precedenti crimini, quale autore del se-
151
questro di persona del Rizzotto ma, in esito alle risultanze istruttorie, il giudice istruttore, con sentenza del 30 novembre 1949 lo prosciolse. Successivamente, due persone sospettate di aver partecipato al sequestro lo accusarono di essere l’autore del delitto. Uno dei due, certo Vincenzo Collura, raccontò che Liggio gli aveva ingiunto di avvicinare il Rizzotto e di condurlo verso la contrada di Sant’Ippolito dove lo avrebbe aspettato. “Liggio e Rizzotto – precisò il Collura – avevano proseguito verso le pendici della montagna. Pochi minuti dopo ho inteso tre colpi di pistola; dal Liggio, ritornato indietro, mi è stato riferito che aveva ucciso Rizzotto perché questi era un ‘tragediatore’ e che ne aveva buttato il cadavere in un fosso dove nessuno avrebbe potuto trovarlo”. In base a queste indicazioni, venne identificata una foiba profonda oltre cinquanta metri, da dove furono estratti i resti scheletrici di tre cadaveri, lembi di indumenti e oggetti utili per l’identificazione. I resti e gli oggetti repertati furono mostrati ai familiari del Rizzotto e tutti dichiararono di riconoscere come appartenenti al congiunto alcuni oggetti e lembi di stoffa. Rinviati a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, Luciano Liggio e i due complici – che nel frattempo avevano ritrattato le accuse – furono assolti per insufficienza di prove con sentenza 30 dicembre 1952. Sette anni dopo l’ll luglio 1959, la Corte d’Appello li assolverà con formula dubitativa confermando la sentenza di primo grado. In entrambi i giudizi, i giudici avevano dubitato delle confessioni “stragiudiziali” rese ai carabinieri dai due complici, dubitando anche del riconoscimento dei miseri resti effettuato dai congiunti del Rizzotto e dubitando infine dell’effettiva causale del raccapricciante assassinio. L’ambiguo percorso dell’impunità si concluse il 26 maggio 1961, con il rigetto del ricorso che il pubblico ministero proponeva in Cassazione. Si legge nella relazione della Commissione antimafia del 1976: «È degno di meditazione il fatto che il difensore del Liggio nel processo Rizzotto, avvocato Dino Canzoneri, deputato regionale, nella seduta del 23 agosto 1963 dell’Assemblea regionale siciliana, nel corso di un acceso dibattito circa l’accusa che gli si lanciava di aver avuto a Corleone numerosissimi voti di preferenza per una presunta attività elettorale spiegata dal Liggio a suo favore, pubblicamente dichiarava che “il Liggio in passato era
152
stato accusato e perseguitato giudiziariamente dai comunisti, i quali evidentemente per consolarsi della assoluzione subita, perché era stata dimostrata calunniosa la loro accusa per la scomparsa di un sindacalista di sinistra, hanno bisogno di fare del Liggio Luciano un democristiano, anzi addirittura un propagandista democristiano”».
Sono ripartite in sordina le indagini sulla strage che costò la vita al giudice Falcone e alla sua scorta. Parla il procuratore antimafia Gianfranco Donadio e rivela: “C’erano un fascista e ordigni militari…”
153
Dopo l’omicidio Rizzotto, il potere e il prestigio di Luciano Liggio si accrebbe enormemente. Egli non era più il piccolo delinquente audace e sanguinario, possibile sicario di autorevoli mandanti, né il modesto esecutore di ordini altrui; era pronto per lavorare in proprio sullo stesso piano dei più autorevoli mafiosi della zona. Nel novembre 1948 si sottrasse all’arresto e si dette alla latitanza che doveva protrarsi per ben sedici anni, ad eccezione di un breve intervallo tra il 1957 e il 1958, in cui ritornò libero a Corleone, finché il 14 maggio 1954 non venne arrestato in circostanze poco chiare. Per lungo tempo s’era tenuto nascosto nell’Ospizio Marino di Palermo, sotto il falso nome di Gaetano Centineo, alloggiato in una confortevole camera appartata e assistito da un medico suo buon amico. La lunga latitanza dimostra quali enormi profitti il Liggio abbia ricavato dalle sue imprese criminali e quali ingenti somme abbia speso per spostarsi continuamente da una località all’altra, per ricoverarsi o soggiornare in costosi luoghi di cura, per pagare informatori e favoreggiatori.
10 Luglio 1943. Le truppe americane sbarcano a Gela (Sicilia). A sostenere lo sbarco fu “Cosa Nostra”
154
lo sbarco in Sicilia
155
10 Luglio 1943. Entusiasmo in Sicilia per l’arrivo delle truppe americane sbarcate a Gela, con la partecipazione della mafia siculo-americana
Era stato il dottor Michele Navarra a dare impulso alla carriera criminale di Luciano Liggio, quando, tra il 1946 e il 1948 – morto il direttore dell’ospedale di Corleone, dottor Carmelo Nicolosi, trovato ucciso i126 aprile 1946 ad opera di ignoti – aveva rafforzato il suo potere mafioso in tutto il corleonese. Medico condotto, medico fiduciario dell’Inam, direttore dell’ospedale civico, Navarra aveva potenziato il gruppo mafioso dei suoi accoliti di cui Liggio divenne in breve uno dei principali esponenti. Attraverso la cosca del Navarra passavano ormai i controlli nell’assunzione della manodopera bracciantile ed operaia, i versamenti in denaro del “pizzo” per protezioni ai campi, ai raccolti, ai lavori, alle abitazioni, alle persone. Ovviamente era lo stesso gruppo mafioso che
156
organizzava sequestri di persona a scopo di estorsione, delitti contro la persona nei confronti di avversari personali o politici o di cosca e nei confronti di chi osasse recare disturbo alla zona protetta o di influenza, e i delitti di ogni genere suscettibili di recar danno o intimidazione (pascoli abusivi, danneggiamenti, abigeati, incendi, eccetera). La “famiglia” mafiosa di Corleone, vera e propria associazione a delinquere di cui il Navarra era il capo e il Liggio il luogotenente, agiva prevalentemente a tutela degli interessi del feudo per tornaconto economico e per motivi politici, contrapponendosi la classe agraria o feudale alle masse in fermento che reclamavano le assegnazioni di terra e migliori redditi di lavoro. Protetto dal Navarra, che, reduce nel 1949 dal confino di polizia e abbandonati i legami politici di un tempo (prima separatista, poi liberale) aveva sposato la causa democristiana dopo le elezioni del 18 aprile 1948, Liggio per alcuni anni, sebbene latitante, operò e agì in silenzio, fidando sul timore che incuteva e sul proprio prestigio, e proprio agli inizi degli anni ’50 la mafia corleonese si mostrò nell’intera sua potenza, quando cioè nessuno osò contrastarle il passo e nessuna voce si levò contro quella “autorevolissima” dei suoi accoliti. Più avanti, Luciano Liggio non sopporterà di dividere con altri la supremazia mafiosa nel territorio di Corleone; Michele Navarra, ormai avversato dal suo luogotenente, verrà crivellato di colpi in automobile insieme ad un ignaro compagno di viaggio, il dottor Giovanni Russo, il 2 agosto 1958. Nello stesso periodo di tempo, oltre agli omicidi sindacali e politici, furono molte altre e altrettanto gravi le manifestazioni delittuose dell’attività mafiosa nelle campagne siciliane, in quel mondo in cui andava morendo la vecchia società pastorale ed agricola e si sperava che si sviluppasse una società moderna ed evoluta. Basta pensare che soltanto nel piccolo paese di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, furono ben venticinque gli omicidi di marca mafiosa nell’arco di tempo, dal 1946 al 1962, e che nel 1958 a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, la mafia locale costrinse con minacce di morte i frati di un convento ad improvvisarsi esattori delle estorsioni imposte a benestanti del posto. In questo contesto contrassegnato da violenze mafiose, tutte ispirate da causali spesso inverosimili in pieno secolo ventesimo, come la volontà
157
perversa di contrapporsi al desiderio di giustizia sociale espresso dai più poveri, all’aspirazione di un misero guadagno, alla necessità di sfruttare estensioni di terra incolta e improduttiva, mosse l’azione di Salvatore Carnevale, in quel lontano 1952, segnata da quel primo successo per il raccolto delle olive nel feudo della principessa Notarbartolo.
I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi assassinati nel 1992
158
9 La mafia legittimata
Cosa Nostra ricomparve in Sicilia nel 1943, alla vigilia dell’occupazione alleata. È stato accertato che gli Usa si avvalsero dei rapporti tra mafiosi italiani o italo–americani, che erano nel loro territorio e mantenevano frequenti contatti con i servizi segreti americani e mafiosi che erano in Sicilia per preparare il terreno per lo sbarco. Un ruolo particolare lo ebbe Lucky Luciano, uno dei capi della mafia americana, di origine siciliana, che essendo detenuto negli Stati Uniti fu contattato dalle autorità locali per saggiare la sua disponibilità a favorire lo sbarco alleato. Luciano si adoperò positivamente. Quindi fu “espulso” dagli Usa e iniziò il suo soggiorno a Napoli. Altri mafiosi detenuti negli Usa vennero anch’essi “espulsi” e fatti arrivare in Italia per collaborare con i boss siciliani. Si rilevò che l’elevato numero degli “espulsi” dagli Usa, immediatamente dopo la fine della guerra, non poteva che corrispondere ad una ricompensa per il contributo fornito nella preparazione e nell’esecuzione dello sbarco. Alla prima Commissione antimafia risultò che complessivamente i boss mafiosi “espulsi” dagli Usa nel primissimo dopoguerra furono sessantacinque. Dal ruolo ad essi conferito e dai compiti assegnati dagli alleati ai boss siciliani derivò alla mafia la prima forma di legittimazione alla quale altre ne seguiranno per fatti e comportamenti successivi connessi ad un preciso disegno volto ad esercitare sul territorio, sulla politica e sui cittadini un potere reale e un’influenza spesso decisiva.
159
La verità sostanziale sul coinvolgimento di Lucky Luciano venne così spiegata dal senatore Estes Kefauver nel suo rapporto conclusivo dell’inchiesta della Senate Crime Investigatory Committee: “Durante la seconda guerra mondiale si fece molto rumore intorno a certi preziosi servigi che Luciano, a quel tempo in carcere, avrebbe reso alle autorità militari in relazione a piani per l’invasione della sua nativa Sicilia. Secondo Moses Polakoff, avvocato difensore di Meyer Lanskv, la Naval Intelligence aveva richiesto l’aiuto di Luciano, chiedendo a Polakoff di fare l’intermediario. Polakoff, il quale aveva difeso Luciano quando questi venne condannato, disse di essersi allora rivolto a Meyer Lansky, antico compagno di Luciano: vennero combinati quindici o venti incontri, durante i quali Luciano fornì certe informazioni”. Il gangster americano, una volta accettata l’idea di collaborare con le autorità governative, prese contatto con i grandi capimafia statunitensi di origine siciliana. Questi a loro volta misero a punto i piani operativi per agevolare il compito agli elementi dell’esercito americano infiltratisi clandestinamente in Sicilia e per favorire concretamente i movimenti delle truppe d’occupazione. Fornirono informazioni sugli schieramenti delle truppe italo-tedesche e delle loro fortificazioni e convinsero un gran numero di militari italiani a disertare; di conseguenza il dispositivo difensivo di monte Cammarata a cui era affidato lo sbarramento delle strade Agrigento-Palermo e Catania-Palermo non poté fare alcuna resistenza.
160
1943. Lo storico capo mafia Carlo Vizzini
161
Dal suo quartier generale di Villalba, don Calogero Vizzini mandò agli “amici” un messaggio cifrato in dialetto in cui si parlava dei vitelli di Curatolo Turi, di vacche, di tori, di pecore e si fornivano istruzioni sui movimenti del bestiame, sui compiti da svolgere alle date stabilite. Aveva scritto di suo pugno: “Io partirò lu stessu iornu cu li vacchi. Li voi di carrozzu e lu tavaru”. Voleva dire: Io partirò lo stesso giorno (il 20 luglio 1943) con il grosso delle truppe, i carri armati (li voi di carrozu) e il comandante in capo (lu tavaru). In quello che era un vero e proprio piano operativo, descritto da Michele Pantaleone nel suo libro Mafia e politica, i vitelli, le vacche, i tori e le pecore erano denominazioni convenzionali per indicare le colonne americane e le truppe italo-tedesche: le istruzioni sui movimenti si riferivano all’operazione a tenaglia con cui la colonna americana proveniente da sud (i vitelli di Curatolo Turi) e il grosso delle truppe dirette verso nord (le vacche) avrebbero chiuso in una sacca, come avvenne, le forze italo-tedesche che stavano ammassate nel versante occidentale dell’isola togliendo loro ogni possibilità di ritirata. Quel 20 luglio del ’43, data indicata da don Calogero Vizzini per la sua partenza “con il grosso delle truppe”, tre carri armati americani erano giunti alle porte di Villalba; su uno dei carri era stato issato un vessillo giallo oro con la elle nera che stava ad indicare il nome di Lucky Luciano, una sorta di biglietto da visita affidato come credenziale all’ufficiale siculo-americano che comandava i carri. Il capo mafia era là ad aspettarlo, con un fazzoletto giallo oro nel taschino come segno di riconoscimento. Il colloquio tra i due riguardò il piano operativo per la conquista di Palermo e, soprattutto, il ruolo che avrebbe svolto don Calò a cui gli “amici” americani mandavano devoti messaggi di stima e di fiducia, confidando sul buon esito dell’operazione. Le truppe americane occuparono Palermo il 22 luglio, grazie a quella manovra a tenaglia che permise loro di ricongiungersi lungo la costa occidentale per avanzare poi verso la capitale dell’isola. L’operazione si era conclusa senza scontri tra gli schieramenti contrapposti, quasi senza perdite umane. La fiducia degli “amici” americani nei confronti di don Calò e degli “amici” siciliani era stata ben riposta.
162
10 luglio 1943. Le truppe alleate lanciano l’operazione “Husky” e sbarcano in Sicilia con l’apporto della mafia (Lucky Luciano ecc.)
163
Secondo la Commissione antimafia, «una seconda forma di legittimazione, certamente meno necessitata dalla prima, venne dalla protezione che il governo alleato conferì, soprattutto nei primi tempi dopo lo sbarco, al movimento separatista, che era l’unica organizzazione antifascista organizzata in Sicilia, ma con stretti rapporti con la mafia. Nella prima Commissione antimafia vennero depositati i frontespizi di due documenti del consolato americano a Palermo, in data 21 novembre 1944 e 27 novembre 1944, che avevano come oggetto il primo: Riunione di capi della mafia con il generale Castellano e la formazione di gruppi per favorire l’autonomia e il secondo: Formazione di gruppi per favorire l’autonomia sotto la direzione della mafia. L’ufficio dei servizi strategici americani nel Confidential Appendix Report on conditions in liberated Italy n. 11, con data 11 gennaio 1944, segnalava che: I leaders principali del partito separatista, si potrebbe dire addirittura la quasi totalità dei suoi aderenti, provengono dalle seguenti categorie: 1) l’aristocrazia… 2) i grandi proprietari fondiari latifondisti, anche se di origine plebea 3) i capi massimi e intermedi della mafia 4) professionisti mediocri o politici che sarebbero altrimenti condannati all’oscurità in un Paese avanzato… La confluenza di settori della mafia nel movimento indipendentista rafforzò tanto i separatisti quanto i mafiosi…». Pochi giorni dopo la conquista di Palermo e a poche ore dalla caduta del fascismo, il gruppo promotore del separatismo lanciava un proclama chiedendo formalmente “ai governi alleati di consentire la costituzione di un governo provvisorio siciliano, al fine di predisporre ed attuare un plebiscito perché si dichiarasse decaduta in Sicilia la monarchia sabauda nella persona di Vittorio Emanuele III – e suoi successori, e la Sicilia fosse eretta a Stato sovrano indipendente con regime repubblicano”. Nasceva così formalmente il Movimento Indipendentista siciliano (Mis) guidato da Andrea Finocchiaro Aprile. Antonio Varvaro, Lucio Tasca, Antonio Canepa. Concetto Gallo, i duchi di Carcaci, il barone Stefano La Motta. E proprio in quei giorni, i capi separatisti e alcune cosche mafiose concludevano una vera e propria intesa, nell’intento di difendere comuni interessi e di conquistare cospicue posizioni di potere all’ombra della protezione alleata. Del resto la partecipazione di don Calogero Vizzini al primo
164
convegno regionale clandestino dei separatisti a Catania (6 dicembre 1943) l’ostentata fede indipendentista di altri capimafia, come Gaetano Filippone, Paolino Bontate detto Bontà e Genco Russo, spingeva il generale dei carabinieri Amedeo Branca a scrivere testualmente in un suo rapporto segreto del 18 febbraio 1946: “Il movimento agrario separatista siciliano e la mafia da diverso tempo hanno fatto causa comune; anzi, i capi di tale movimento, tra i quali don Lucio Tasca, si debbono identificare per lo più con i capi della mafia nell’isola”.
1943. Lo storico capo mafia Genco Russo
165
Man mano che le forze alleate estendevano l’occupazione in Sicilia, prefetti e podestà furono destituiti dalla carica e sostituiti con nuovi amministratori di “fiducia”; tra questi uomini politici separatisti, e tra loro anche autentici mafiosi insediati come sindaci in molti dei 357 comuni siciliani. “Nacque così la terza legittimazione per la mafia. Quella che derivò dalla collocazione, al vertice delle amministrazioni comunali, di politici separatisti sostenuti dalla mafia e, in alcuni casi, di autentici mafiosi, come Calogero Vizzini nominato sindaco di Villalba e Genco Russo nominato sindaco di Mussomeli. Ai mafiosi, inoltre, vennero conferiti altri incarichi pubblici, Vincenzo Di Carlo, capo della mafia di Raffadali, fu nominato responsabile dell’Ufficio per la requisizione del grano ed altri cereali. Michele Navarra venne autorizzato a raccogliere gli automezzi militari abbandonati dall’esercito. Il boss della mafia italo-americana Vito Genovese prestava servizio presso il quartier generale alleato di Noia”. Lord Rennel, capo del governo militare alleato nei territori occupati, nell’agosto 1943 così scriveva, con toni preoccupati, in un rapporto riservato inviato a Londra: “Io temo che nel loro entusiasmo nel destituire i podestà fascisti e i funzionari municipali delle località rurali, i miei ufficiali, in alcuni casi per ignoranza della società locale, abbiano scelto un certo numero di capimafia o autorizzato tali personaggi a proporre docili sostituti pronti a obbedirli. La mia difficoltà risiede a questo punto nel codice siciliano dell’onore e dell’omertà. Quasi non riesco ad ottenere informazioni da parte degli stessi carabinieri del posto, i quali ritengono che sia preferibile tacere e salvare la vita quando il locale rappresentante dell’Amgot (il governo alleato provvisorio, n.d.a.) decide di nominare un mafioso…”. “La quarta legittimazione venne dai grandi latifondisti siciliani che, preoccupati per le rivendicazioni contadine, ritornarono ad affidare ai gabellotti mafiosi il controllo dei campi”. Questa decisione permise al mafioso della gabella di svolgere di nuovo il suo ruolo, imponendo con la presenza violenta e con l’antica intermediazione parassitaria il perverso sistema di ruberie e di sopraffazioni. Così, a Villalba, Calogero Vizzini assunse la gestione del feudo Micciché; a Mussomeli, Giuseppe Genco Russo quella del feudo Polizzello, Salvatore Malta
166
prese in affitto il feudo Vicarietto, Vanni Sacco il feudo Parrino, Barbaccia le terre di Ficuzza. In moltissimi altri feudi vennero stabiliti rapporti del genere di quelli citati, scegliendo sistematicamente personaggi di nota condotta criminale come il giovane mafioso corleonese Luciano Leggio, detto Liggio, divenuto in quei giorni gabellotto del feudo Strasatto, quando già era colpito da mandato di cattura per essere stato accusato di gravissimi reati. Nella difesa del latifondo, accanto ai mafiosi, c’erano i capi del separatismo, come quel Lucio Tasca che, con sfrontata mistificazione storica e toni demagogici, non esitò a proclamare: “Sia gloria al latifondo siciliano, grande riserva di ricchezza che i siciliani sapranno valorizzare il giorno in cui le risorse economiche della loro terra saranno impiegate nell’isola”.
Luglio 1943. Un soldato americano ferito durante la conquista della Sicilia voluta da “Cosa Nostra”
167
1945. Significativa la pagina “Il Popolo” che inneggia all’Italia libera. Un esempio di “Cosa di Stato”
168
USA. Il boss Luky Luciano prima di essere scarcerato e mandato in Italia nel 1943
169
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e il successivo ritorno all’Italia della giurisdizione della Sicilia, scelta con cui gli alleati dimostravano di ritenere impossibile una riconquista dell’isola da parte fascista, il separatismo entrò in crisi, sebbene Finocchiaro Aprile (capo riconosciuto del movimento) continuasse nell’azione secessionista e avversasse la soluzione autonomistica sostenuta dai partiti nazionali come l’unica risposta valida alle ispirazioni secolari di autogoverno del popolo siciliano. Messo alle corde sul piano politico, abbandonato dai potenti alleati di una volta, al separatismo non restò che la via dell’insurrezione armata. Così, nel marzo del 1945, alcuni capi separatisti decisero di istituire un’organizzazione militare, l’Evis (Esercito volontario per l’indipendenza della Sicilia) e ne affidarono il comando supremo al duca Guglielmo di Carcaci. Il compito dell’effettiva preparazione militare e della guida delle truppe venne affidato ad Antonio Canepa, docente dell’Università di Catania che, già al momento della costituzione dell’Evis, comandava nella Sicilia orientale alcuni raggruppamenti militarizzati. La morte di Canepa, ucciso il 17 giugno 1945 dai carabinieri in circostanze rimaste avvolte nel mistero, non impedì ai separatisti di perseverare nel loro disegno insurrezionale e di allearsi con due bande di fuorilegge che allora imperversavano nell’isola: quella di Rosario Avila, che terrorizzava le province orientali, e quella del più temibile Salvatore Giuliano attestato col suo quartier generale nelle montagne attorno a Montelepre. “L’idea di aggregare ad elementi di fede separatista malfattori comuni – scrisse il generale Amedeo Branca – è una trovata di Lucio Tasca il quale, dimenticando che viviamo in pieno secolo ventesimo, ha sempre affermato in politica che tutti i movimenti politici in Sicilia hanno trovato saldo appoggio nel brigantaggio comune”. In un rapporto del 7 marzo 1946 dell’ispettorato di pubblica sicurezza si leggeva testualmente: “Trattandosi di realizzare il fine politico agognato (separazione della Sicilia dall’Italia e lotta al comunismo) una delle figure più eminenti era il cavaliere Calogero Vizzini, che aveva avuto il compito di reclutare gli elementi torbidi della delinquenza dell’isola”. È stato storicamente accertato che furono i capi mafiosi a favorire gli incontri e gli accordi tra i separatisti e i banditi.
170
E d’altra parte, nessuno meglio della mafia doveva aver capito in quel tempo che la speranza dei separatisti di ottenere una vittoria sul piano politico era ormai diventata impossibile, ed era quindi naturale che essa abbia cercato di giocare la carta del banditismo dilagante anche ai fini politici, per la difesa degli interessi legati al mantenimento della struttura latifondistica dell’agricoltura siciliana. La decisone presa il 3 ottobre 1945 dal governo Parri di inviare al confino di polizia, all’isola di Ponza, Antonio Varvaro, Finocchiaro Aprile e l’avvocato Francesco Restuccia, un leader separatista di Messina, spinse gli altri capi del movimento, che temevano un intervento governativo ancor più energico, ad accelerare la manovra di aggancio di Giuliano per convertirlo alla causa separatista.
171
Lo storico capo mafia Vito Genovese
172
10 Il bandito Giuliano
Si stentava a credere che quel povero corpo senza vita di giovane in canottiera, pantaloni di tela grezza, sandali di para e calze scozzesi, quasi rannicchiato sul suolo di un cortile inondato di sole, appartenesse al famigerato “re di Montelepre”. Intorno al cadavere un mitra, una pistola e un tascapane e, ad osservare la macabra scena carabinieri, fotografi e perfino una folla di curiosi. Era la foto di Salvatore Giuliano morto pubblicata su tutti i principali giornali italiani; la cronaca non lasciava alcun dubbio e spiegava che il bandito era stato ucciso nella notte tra il 4 e il 5 luglio 1950. II colonnello Luca fornì i nomi dei brillanti protagonisti dell’operazione: il capitano Antonio Perenze, i brigadieri Filippo Catalano e Pietro Giuffrida e il carabiniere Roberto Renzi. Perenze raccontò: “Gli sparai contro rabbiosamente ed egli cadde in avanti bocconi. Dall’angolo in cui ero nascosto guardai sul cortile e vidi che il brigadiere Giuffrida aveva subito raggiunto il bandito che rantolava. Allora bussai a una porta di una casa vicina per chiedere dell’acqua e non mi fu risposto, l’abbattei a colpi di spalla. Presi l’acqua per il morente, tornai nel cortile e la passai a Giuffrida perché gliela desse. Giuliano, però, era già morto”. Lo stesso Perenze, il 9 luglio 1950, fece la relazione ufficiale, riassumendo le fasi della operazione. Scrisse che due macchine civili erano partite da Montelepre il 4 luglio verso le 22 dirette a Castelvetrano dove il capobanda era nascosto. E parlò di un “confidente”, senza rivelare che il confidente era Gaspare Pisciotta che viaggiava in una
173
delle vetture per fungere da guida e accompagnarli fino al rifugio del bandito. L’ingresso a Castelvetrano delle due vetture (nella seconda c’era Perenze con due carabinieri) avvenne a fari spenti alle ore 0,30 del 5 luglio. Il piano era questo: il confidente, accertata la presenza di Giuliano in una certa casa, sarebbe uscito con lui per accompagnarlo in altra abitazione ove avrebbe dovuto incontrarsi con altri fuorilegge e favoreggiatori per prendere accordi sul come reperire denaro per l’espatrio. Avrebbe dovuto fargli da battistrada per assicurargli che la via fosse libera e, al primo cenno dei carabinieri, doveva raggiungere la 1100 lasciata sulla piazza di Castelvetrano e, guidandola personalmente, allontanarsi dal paese e dalla zona accerchiata grazie ad uno speciale permesso di cui era stato munito. L’azione vera e propria scattò invece alle ore 3,15 – dopo tre ore di appostamento – allorquando il confidente uscì sulla strada (stranamente a piedi nudi e con le scarpe in mano) seguito a cinquanta metri da due individui, entrambi in canottiera, che procedevano senza far rumore. A questo punto i due banditi, scorto il carabiniere Renzi che insieme agli altri presidiava la zona, sparavano una breve raffica. “I due fuorilegge – scrisse il Perenze nella relazione – si disorientavano correndo sconsideratamente alla ricerca di un qualsiasi riparo, e mentre uno di essi essendo a capo scoperto, alla luce delle lampade stradali fu facilmente riconosciuto per il bandito Salvatore Giuliano; non si riuscì a identificare l’altro che portava un berretto floscio”. E mentre lo sconosciuto, sparando furiosamente, scomparve oltre i caratteristici cortili moreschi di Castelvetrano, Giuliano, braccato dalle forze dell’ordine si rifugiava in un cortile di via Fra Mannone, attiguo alla casa dell’avvocato De Maria. Qui i carabinieri “con concentrato fuoco lo immobilizzavano al suolo dove decedeva dopo pochi minuti”. Questa versione, come vedremo, sarà giudicata del tutto inattendibile, un vero falso ideologico commesso in nome della ragion di Stato, una sorta di mistero che si percepiva dentro una “realtà” narrata, sacrificata alla metafisica e all’inconoscibilità del potere. Ma c’erano, nella relazione ufficiale, due punti che si riveleranno di grande importanza: l’esistenza di un “confidente”, ruolo svolto da Gaspare Pisciotta, che
174
in breve sarebbe venuto alla luce, e la presenza di un “terzo uomo”, l’enigmatico uomo dal berretto floscio, una presenza “spettrale” senza volto né contorni precisi che farà sorgere sospetti e formulare ipotesi quasi romanzesche. Forse il capitano Perenze, spinto dalla volontà di mentire il meno possibile, volle fare a suo modo una relazione onesta – pur nel falso ideologico – ammettendo l’esistenza di un “confidente” e di un “terzo uomo”. E proprio su quest’ultimo si concentrerà il sospetto che fosse lì a interferire nel piano di cattura predisposto dai carabinieri. O forse ancora il Perenze volle anticipare l’esistenza del confidente nella persuasione – dimostratasi poi esatta – che il ruolo di Pisciotta, presto o tardi, si sarebbe rivelato; e forse analogamente – in questo caso sbagliando – ragionò per l’uomo dal berretto floscio, quello che uscì da casa De Maria insieme a Giuliano e poi si diede alla fuga durante il conflitto. *** La versione ufficiale della morte del bandito resistette appena tre giorni. Per fornire ai lettori una cronaca veritiera della morte del “re di Montelepre”, l’inviato dell’Europeo, Tommaso Besozzi, decise di ricostruire le fasi della sparatoria attraverso le testimonianze della gente. E per prima cosa, parlando con gli abitanti di via Fra Mannone, pervenne a un primo clamoroso risultato: nessuno aveva sentito colpi d’arma da fuoco; eppure nella versione ufficiale si sosteneva che erano stati sparati almeno duecento colpi, una ventina dal bandito e il resto dai carabinieri. Qualcosa non funzionava e Besozzi decise di andare più in fondo. “Ho sentito solo due colpi e molto attutiti” disse il mugnaio Giovanni Carta, che abitava proprio in via Fra Mannone. Ancora più inquietanti furono le altre testimonianze, come quella di Pino Corso e Nunzio Di Menti, due garzoni del panettiere Pietro Lo Bello, che aveva il forno proprio in quella strada, al confine con il cortile dov’era stato trovato il corpo di Giuliano. “Verso mezzanotte – raccontarono – aspettavamo che il pane lievitasse seduti a prendere il fresco sul marciapiedi davanti al forno quando due individui, sopraggiunti all’improvviso, ci
175
hanno invitati ad andar via “se non volevamo finire in galera”’. Aggiunsero che quei due si erano comportati da poliziotti e che loro, sebbene rientrati nel locale dove c’era il forno, avevano continuato a sbirciare verso quella zona. “Più tardi abbiamo notato un uomo attraversare di corsa il cortile, salire su un’auto che partiva a grande velocità” dissero, concludendo il loro racconto. Una conferma più circostanziata la fornì il venditore ambulante Luciano Maniscalco con un racconto abbastanza preciso da dare alla sua testimonianza il valore di una verità. “Dal mio balcone dove stavo quella notte per sfuggire al gran caldo ho visto quell’uomo uscire da una abitazione che dava sul cortile” disse con chiaro riferimento alla precedente testimonianza. “L’uomo – aggiunse fornendo vari dettagli – aveva un piede scalzo e prima di dirigersi verso l’automobile, una 1100 scura che l’aspettava in via Fra Mannone, incrociando due ombre aveva detto chiaramente: tutto fatto”. Un altro raccontò di aver visto tre uomini trasportare un corpo esanime fuori dalla casa dell’avvocato De Maria e sistemarlo al centro del cortile. “Poi uno dei tre – precisò il testimone – imbracciò un mitra e sparò due raffiche, una breve contro quel corpo, l’altra più lunga in aria”. Ce n’era abbastanza per dimostrare l’esistenza di un’altra verità nettamente diversa dalla versione ufficiale dei carabinieri che il servizio pubblicato nel numero 29 dell’Europeo del 16 luglio 1950 col titolo Di sicuro c’è solo il morto, aveva smontato con le testimonianze raccolte sul posto e con altri particolari inequivocabili. Infatti il Besozzi accertò che due colpi contro Giuliano erano stati sparati a bruciapelo e altri quando era già morto; i primi avevano lasciato nel fianco del cadavere due fori dai contorni irregolari e bruciati, i secondi invece erano perfettamente regolari. Ancor più strano risultò il fatto che la canottiera era intrisa di sangue in una zona della schiena priva di ferite, per cui ragionevolmente si poteva supporre che il corpo fosse rimasto in posizione supina giusto il tempo per permettere al sangue sgorgato dalle ferite sotto l’ascella, di colare copioso dietro la spalla e di impregnare la canottiera. La posizione bocconi in cui era stato trovato il cadavere di Giuliano rappresentava all’esame dei fatti una strana incongruenza ch’era
176
sfuggita a coloro che avevano trasportato il corpo nel cortile. C’erano infine alcuni interrogativi da porsi che sottolineavano altrettante stranezze. Perché il bandito non portava al polso il cronometro d’oro dal quale non si separava mai? Perché la cintura dei pantaloni era infilata solo in due passanti? Perché il corpo di Giuliano era privo di mutande? Da tutto questo risultò chiaro che il bandito era stato ucciso in un posto diverso da quello indicato dai resoconti ministeriali (forse nel sonno ed era stato rivestito in fretta) e che la ricostruzione meno attendibile era proprio quella ufficiale. La settimana dopo le prime clamorose rivelazioni sulla morte di Giuliano seguì un altro colpo giornalistico. L’Europeo denunciò Gaspare Pisciotta di essere l’assassino del suo capobanda, l’accusò, in pratica, di essere lui il confidente indicato dal capitano Perenze nella sua relazione ufficiale. Ma Pisciotta, ancora latitante, s’affrettò a scrivere al Giornale di Sicilia smentendo l’accusa. Nove mesi più tardi sarà lui stesso a fare delle clamorose rivelazioni. Dopo la morte di Giuliano, Gaspare Pisciotta viveva tranquillo a Palermo sotto la protezione dei carabinieri, accolto come ospite di riguardo nell’appartamento occupato dal capitano Perenze. Ma, imprevedibilmente, nel dicembre 1950, il questore Marzano, un uomo abituato a non guardare in faccia nessuno, ne ordinò l’arresto. Il 16 aprile del 1951, al processo di Viterbo, Pisciotta si autoaccusò dell’uccisione di Giuliano. E accusò come mandanti della strage di Portella della Ginestra, Bernardo Mattarella. Gianfranco Alliata, Leone Marchesano e Giacomo Cusumano Geloso, pezzi grossi della politica nazionale. Parlò dei loro incontri con Giuliano il quale, a suo dire, “aveva ordinato anche il sequestro della famiglia dell’onorevole Mattarella perché questi non aveva tenuto fede alle sue promesse”. Nel corso di una udienza, rivolgendosi ai giudici, disse: “Ho letto nei giornali le smentite dei politici da me accusati, i quali dicono che sono pazzo. Ma i pazzi sono loro. Indico ora altri nomi di persone che conoscono tutta la verità”. Denunciò poi che l’onorevole Cusumano aveva tentato di comprare il suo silenzio per cinquanta milioni e che analoga cifra gli era stata offerta, nel carcere di Viterbo, da un avvocato per conto del ministro Scelba. E nei
177
confronti di Scelba, l’ex luogotenente di Giuliano lanciò un’accusa ben più grave e mai provata: di essere tra i mandanti della strage. Gli interrogatori degli ispettori Messana e Verdiani e degli ufficiali dei carabinieri Luca e Perenze rivelarono i loro frequenti e normali rapporti con pericolosi banditi e noti mafiosi, i quali, grazie alle protezioni, poterono continuare indisturbati la loro attività delittuosa e mantenere ancora in vita per un lungo tempo la banda Giuliano, se così si può dire, col consenso degli organi statali. Furono d’altra parte proprio questi metodi a permettere a Gaspare Pisciotta di gridare nell’aula di Viterbo: “Siamo un corpo solo, banditi, polizia e mafia, come il padre, il figlio e lo spirito santo”. Il processo si concluderà con dodici condanne all’ergastolo e due condanne a vent’anni. Mattarella, Alliata e Marchesano saranno in seguito prosciolti da ogni accusa con sentenza istruttoria pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo. Alla fine del processo però, Gaspare Pisciotta, scornato e avvilito per la condanna a vita, griderà con rabbia: “Ma si dovrà rifare un giorno il processo per la morte di Giuliano e per la strage di Portella della Ginestra. E allora dirò tutta la verità che non ho saputo dire qui!”. Ma la verità sulla grave vicenda sembrò avere, per i suoi protagonisti, conseguenze di segno opposto: per Luca, Perenze, Vicari, Restivo e Scelba rappresentò il passaporto verso grandi carriere; ad altri il tremendo segreto non apportò che lutti e sfortune. Fu il caso dell’onorevole Cusumano Geloso, che secondo Pisciotta era stato intermediario tra i mandanti politici e la banda Giuliano. Nel luglio 1953 venne trovato morto immerso in una pozza di sangue. Responso del medico legale: emofilia. Ma si sospettò subito trattarsi di delitto. Fu anche il caso dell’ex ispettore generale di pubblica sicurezza Ciro Verdiani, morto ufficialmente d’infarto nello stesso anno. Si parlò invece di avvelenamento con stricnina. Fu la morte di Pisciotta, il 9 febbraio 1954, nelle carceri dell’Ucciardone, a dimostrare quanto fosse determinante la volontà criminale di chi voleva ottenere il definitivo silenzio. Il processo d’appello era vicino e Pisciotta aveva chiesto di parlare con il magistrato. Da lui si recò l’allora sostituto procuratore Pietro Scaglione. In quella
178
occasione Scaglione non avrebbe verbalizzato quello che gli riferì l’ex luogotenente di Giuliano in quanto era andato senza segretario. Il magistrato promise di tornare. Ma nell’intervallo tra queste due visite Pisciotta morì avvelenato. II 20 settembre 1960, a San Giuseppe Jato, il mafioso di Monreale Nitto Minasola, l’uomo che aveva convinto Pisciotta a collaborare con i carabinieri, venne ucciso da tre killer a colpi di pistola. Il 12 luglio 1961 toccò ad un suo compare, Filippo Riolo, ucciso a Palermo, forse per seppellire con lui un tremendo segreto. Riolo si trovava all’Ucciardone nei giorni dell’avvelenamento di Pisciotta ed era stato accusato da un inserviente del carcere di esserne l’autore. Il sostituto procuratore Scaglione, definì “infondata” la denuncia dell’inserviente. Dieci anni dopo, l’assassinio di Scaglione concluderà la terribile sequela di morte legata ai segreti della strage di Portella della Ginestra. Per Giuliano, poco più che ventenne, la svolta, tragica e inaspettata, avvenne la mattina del 2 settembre 1943. Quel giorno, mentre trasportava con il suo cavallo due sacchi di grano, giunto al Quarto Mulino di San Giuseppe Jato, a sedici chilometri da Montelepre, s’imbatté in una pattuglia di carabinieri e di guardie campestri le cui frequenti irruzioni erano rivolte a stroncare il contrabbando e individuare i contadini che sottraevano il grano all’ammasso. Fu invitato a consegnare la sua carta d’identità e obbligato a scaricare i due sacchi che trasportava: circa centoventi chili di frumento. Altre volte era incappato nella pattuglia dei carabinieri mentre faceva la borsa nera; in una occasione gli avevano sequestrato due erossi carichi di grano; non c’erano state altre conseguenze e Turiddu aveva finito per accettare il sequestro. Ma quella mattina le cose andarono diversamente per via del prolungato interrogatorio a cui fu sottoposto, un fuoco incrociato di domande per strappargli il nome di chi gli aveva venduto il grano. “Non so, non conosco il nome di quel contadino” ripeteva Giuliano che, piuttosto indispettito, finì per proporre: “Piuttosto tenetevi il grano ma lasciatemi andare”. La pattuglia non volle indulgere, anzi minacciò di arrestarlo. Turiddu, a questo punto, non seppe più frenare la sua rabbia. “Quel grano – gridò ormai fuori di sé – serve a sfamare la mia famiglia, non certo per farla arricchire”.
179
Intanto un altro gruppo di “intrallazzisti” era apparso dal fondo della strada e quasi tutta la pattuglia era andata incontro ai nuovi arrivati lasciando Giuliano sorvegliato da un solo carabiniere, Antonio Mancino. Turiddu si guardò intorno. Da un lato della strada, c’era la pietraia del fiume Iato in secca, dall’altro una fitta macchia d’arbusti. Pensò che bisognava agire subito, ma c’era il problema della carta di identità da recuperare. L’azione fu tutt’uno con il pensiero: impugnò la calibro 9, che teneva nascosta nella calza destra, la puntò contro il Mancino intimandogli di restituire il documento di riconoscimento. “Non posso, l’ho dato all’altro mio collega” rispose alzando d’istinto la canna del fucile. Ma non fece in tempo a tentare una difesa. Giuliano sparò freddandolo con un solo colpo mortale in pieno petto. Compiuto il delitto fuggì attraverso la macchia d’arbusti. Non s’arrestò ai colpi delle guardie, nemmeno quando sentì al fianco una ferita bruciare come ferro rovente. Corse disperatamente, stremato dalla copiosa perdita di sangue, fino a Partinico dove un amico gli prestò le prime cure. Solo negli ultimi giorni del 1943 i carabinieri iniziarono la caccia per catturarlo. La sera del 22 dicembre un reparto dell’Arma entrò a Montelepre e rastrellò il paese casa per casa. Turiddu, che si trovava in famiglia, riuscì a scappare in tempo facendo perdere le sue tracce, ma il padre incappò nella retata mentre rincasava dalla campagna. Nel corso della notte, perquisizioni e arresti diffusero un collettivo sgomento in tutta la zona; tra gli arrestati c’erano, oltre al padre, i parenti e gli amici di Giuliano; un’azione, questa, che il bandito, informato da qualcuno, considerò un affronto personale da risolvere a modo suo. Ritornò quindi a Montelepre armato di un fucile mitragliatore e, alla vista del padre incatenato insieme a un folto gruppo di arrestati, ammassati davanti alla caserma dei carabinieri, fu preso da tale furore sanguinario che usò l’arma uccidendo il tenente Aristide Gualtiero e ferendo un carabiniere. Era il secondo delitto di Giuliano, ma l’audacia e la crudeltà dimostrate (pochi giorni prima aveva scagliato un tascapane pieno di bombe contro una pattuglia, fortunatamente senza provocare vittime) furono motivo di grande preoccupazione specie per l’incapacità delle forze dell’ordine di contenerne la crudeltà.
180
Nel mese di gennaio 1944, Giuliano tornava agli “onori” della cronaca con due notizie: la prima riguardava l’uccisione a Montelepre del giovane Salvatore Palizzolo, ritenuto dal bandito una spia dei carabinieri, la seconda, ancor più clamorosa, si riferiva all’azione con cui era riuscito a fare evadere otto uomini dal carcere di Monreale. Si trattava di alcune delle persone fermate nel corso del rastrellamento del 22 dicembre. Sei degli uomini evasi erano suoi parenti. Era nato in quei giorni il primo nucleo della banda Giuliano; il primo arsenale fu sottratto da una vecchia polveriera abbandonata; il vettovagliamento venne fornito da molte famiglie di braccianti e di contadini del circondario di Montelepre. Il taglieggiamento dei proprietari terrieri ed i sequestri di persona costituirono le principali fonti di finanziamento della banda, che si andava via via ingrossando con l’affluire di giovani disperati con la vocazione al ribellismo. Nella prima fase della sua attività e fino agli inizi del 1945, Salvatore Giuliano impersonò il classico bandito populista ribelle meridionale che estorce ai proprietari terrieri denaro e prodotti agricoli che distribuisce ai contadini e ai pastori di Montelepre. Lo testimoniò, in quei giorni, il commissario di pubblica sicurezza Carlo Drago che testualmente scrisse: “Giuliano incontrando i contadini non mancava di domandare come se la passavano. Alle lamentele per la miseria patita, per colpa dei padroni, regalava loro cinque, diecimila lire”. E i contadini lo proteggevano e lo assecondavano perché ai loro occhi egli simboleggiava la ribellione contro le ingiustizie sociali di cui si sentivano vittime. Faceva pensare a Rinaldo, corrispettivo idealizzato delle figure più realistiche dei banditi ‘dell’opra dei pupi’, idealizzazione popolare del ribelle positivo e generoso, al cui mito il popolo fece ricorso tutte le volte che ebbe bisogno di trovare una illusione di forza o di rivalsa. E proprio in quei giorni, Corrado Alvaro si domandava: “Come mai un bandito, macchiato di decine di delitti, abbia potuto rappresentare un personaggio di fronte a cui ogni terribilità sanguinosa passava in seconda linea, per cedere il posto a una certa attrattiva, se non a pietà, come verso il figlio di una terra generosa che ha piegato al male, una forza non comune, un ingegno strategico, un’audacia. un senso primordiale della giustizia, divenuto delinquenza”.
181
1948. Il bandito Salvatore Giuliano, con alle spalle Gaspare Pisciotta e due giornalisti
182
Nel corso del 1944, Giuliano diede fondo alla sua “terribilità sanguinosa” guadagnandosi il titolo di “re di Montelepre”, scellerata “nobiltà” di cui poté fregiarsi dopo l’attacco a fuoco contro la caserma dei carabinieri di Piano dell’Occhio, nei pressi di Montelepre, e l’assalto alla fattoria della duchessa di Pratameno in località Colabutto, tra Alcamo e Partinico. Operazione, quest’ultima, di alto brigantaggio che fruttò i gioielli che la terrorizzata duchessa s’era convinta a consegnare per evitare una triste fine ai suoi piccoli nipoti. Ma sull’onda della contraddizione l’azione di Giuliano si paludò subito dopo di contenuti sociali. Avvenne sul monte Sagana, una mattina, quando impose, con la minaccia delle armi, agli esterrefatti amministratori di quel feudo, l’assegnazione ai contadini di Montelepre di vaste estensioni di terra. L’ascesa di Giuliano cominciò nel periodo dell’occupazione alleata della Sicilia per il fatto che allora la polizia italiana aveva limitate capacità operative. Giacinto Paolantonio, generale dei carabinieri, denunciò in quei giorni che il contingente di stanza nell’isola non aveva né mezzi né armi. “I primi mitra che ho dato ai miei militi di Montelepre – disse con evidente amarezza – li ho tolti proprio alla banda di Giuliano”. A Giuliano non sembrò vero di poter nobilitare con l’alone politico i suoi crimini passati e quelli che si accingeva a compiere. Chiese ed ottenne la promessa che la prima legge della “nuova nazione” sarebbe stata un’amnistia, un colpo di spugna per i suoi delitti. Nel corso di sei mesi – dall’ottobre del ’45 al marzo del ’46 – il patto scellerato produsse una notevole recrudescenza di gravissimi delitti e frequentissimi divennero gli attentati e gli attacchi contro le forze dell’ordine, condotti in nome e per conto dell’Evis, da separatisti e banditi insieme sotto il vessillo giallo–rosso della “nazione” siciliana. L’impresa di debellare l’Evis, il braccio armato del movimento separatista, non si rivelò facile. A poco valse la reazione dell’ispettorato generale di pubblica sicurezza, guidato da Ettore Messana, che affiancò, nel corso del 1945, gli organi locali di polizia. Finché, alla fine di quell’anno – era il 29 dicembre – nella località di San Mauro, lo scontro armato fra Italia e Sicilia segnò la disfatta dell’Evis e la cattura del suo capo, Concetto Gallo. Da quel
183
momento restarono in campo Rosario Avila e Salvatore Giuliano che, refrattari agli inviti di prudenza dei capi dell’Evis – preoccupati dell’arresto di Finocchiaro Aprile, Varvaro e Restuccia, a cui erano seguiti quelli di Stefano La Motta, Giuseppe Cammarata e Pietro Franzoni – continuarono nei loro attacchi con il chiaro intento di dare all’azione banditesca un confuso significato politico. Una sorta di legittimazione venne alla mafia dalla vicenda del bandito Giuliano. Cosa Nostra risultò il burattinaio di tutta la vicenda nel corso della quale si verificarono avvenimenti idonei ad incrinare fortemente la credibilità dello Stato. D’altra parte non mancava alle autorità del tempo la lucidità nella valutazione dello stato delle cose. A riguardo la Commissione antimafia ha scritto: “Le autorità Usa di stanza in Sicilia avevano chiesto ai loro superiori direttive sulle iniziative da intraprendere contro la mafia a causa della delicata natura politica del problema”. Il capitano dei servizi segreti americani W.E. Seotten fu incaricato di redigere un rapporto sulla situazione. Il rapporto è di straordinario interesse per la storia di quegli anni e rivela la piena consapevolezza dell’amministrazione alleata della gravità dei processi che si erano oggettivamente avviati. “Secondo alcuni fatti – scrive Scotten –1’Amg non è solo svantaggiata nel trattare con la mafia (evidentemente trattative c’erano) ma ha finito per farne il gioco. Scotten poi passava ad indicare tre possibili soluzioni. Arresto e deportazione per tutta la durata della guerra di 500 o 600 capimafia senza badare alle personalità e alle connessioni politiche. Per qualche anno la mafia sarebbe stata frenata e la popolazione avrebbe acquisito il senso della legalità; nel frattempo la polizia si sarebbe riorganizzata ed avrebbe potuto contrastare con pienezza di mezzi l’eventuale ripresa di attività mafiose. La seconda ipotesi prevedeva un accordo con la mafia, che avrebbe dovuto rinunciare all’ingresso sul mercato degli alimenti e dei generi di prima necessità, nonché ad azioni contro obiettivi di carattere militare. In cambio gli alleati non avrebbero interferito nelle vicende della mafia, salvo a chiedere la punizione per i reati comuni. Non ci sarebbe stata cioè un’azione repressiva contro la
184
mafia in quanto tale. La terza soluzione prevedeva la via della resistenza e del contenimento, ma senza azioni dirette a distruggere l’organizzazione mafiosa. Non si è mai trovata la risposta dell’autorità superiore, che aveva sede in Algeri, forse perduta o forse mai inviata. Ma le vicende successive fanno ritenere che si sia optato, di fatto, per la terza soluzione”. L’esito del referendum del 2 giugno 1946 e la ricostituzione di un preciso quadro istituzionale, per di più democratico e di tipo partitico, spinse la mafia a staccarsi dal separatismo e ad avvicinarsi ai partiti di potere. Ma se don Calogero Vizzini e altri capimafia avevano fatto questa scelta, non allo stesso modo s’erano comportati tutti gli esponenti dell’onorata società, tra i quali Santo Flores di Partinico, grande elettore del partito liberale che aveva deciso di continuare ad appoggiare Giuliano per contrastare l’avanzata delle forze progressiste e il loro attacco al feudo. In realtà don Calò e Santo Flores, perseguivano entrambi lo scopo di introdursi attivamente nei contrasti tra i grandi agrari e il movimento contadino. E l’occasione politica si presentò con il primo governo regionale siciliano – eletto il 20 aprile 1947 – quando si verificò la confluenza delle forze mafiose nei partiti conservatori (monarchico e liberale), finiti nella sfera di influenza della Democrazia Cristiana, protagonista di una astuta operazione politica. “L’effetto della operazione di assorbimento che le forze politiche di destra e la Democrazia Cristiana compirono in questo periodo – ha scritto Salvatore F. Romano – non fu infatti soltanto che il grosso dei gruppi mafiosi che si divise tra i partiti nazionali, entrò nella Democrazia Cristiana e nei partiti di destra. Fu principalmente che essa rianimò e diede forza e prestigio, oltreché potere economico e politico, ai gruppi mafiosi, inserendoli per così dire in un sistema e mettendoli in condizione di servirsi non solo della burocrazia regionale ma anche di quella nazionale e perfino di diventare i collaboratori diretti dei funzionari di polizia, delle forze dello Stato, che avevano il compito di reprimere le manifestazioni criminose e il banditismo in Sicilia”. Il provvedimento di amnistia firmato il 22 giugno del ’46 dall’allora ministro della Giustizia Palmiro Togliatti aveva cancellato de-
185
litti e reati politici commessi da chiunque avesse militato nell’Evis. L’amnistia non riguardava il banditismo a cui nessuna motivazione politica era stata riconosciuta. Si racconta che Giuliano gridò al tradimento; riunì i suoi uomini e disse: “Chi vuole lasci la banda e torni a casa sua”. Molti della banda lo abbandonarono, ma lui non smobilitò, restò con un pugno di fedeli gregari, e al suo fianco restò quel Gaspare Pisciotta, che tanto farà parlare di sé. Qualche mese dopo, attraverso le pagine del quotidiano L’Ora, Giuliano si rivolse ad Alcide De Gasperi con una lettera aperta, una sorta di j’accuse nei confronti dei separatisti rei, a suo dire, di non aver rispettato i patti. Poi, sperando che la mafia continuasse a proteggerlo, concluse un patto con Santo Flores non tralasciando di mantenere i contatti con esponenti locali dei partiti anticomunisti sulla base di un accordo in nome dell’anticomunismo: l’impunità in cambio di aiuto elettorale. La vittoria del “Blocco del Popolo”, composto da comunisti e socialisti, alle elezioni regionali del 20 aprile 1947, ottenuta nonostante le gravi intimidazioni messe in atto dalla mafia con delitti e violenze d’ogni genere, costituì un grosso smacco per lo stesso Giuliano, garante di quell’accordo. La reazione non si fece attendere, e il 1° maggio, su ordine di mandanti rimasti nell’ombra, secondo un costume che caratterizzerà tutta una serie di trame e di stragi che dal dopoguerra ad oggi hanno insanguinato l’Italia, la banda Giuliano compì uno spaventoso eccidio. Nel corso della celebrazione della festa dei lavoratori, a Portella della Ginestra, sparò sulla folla di contadini: a terra, tra la folla terrorizzata, rimasero undici morti e cinquantasei feriti. Risultò evidente che ad armare la mano di Giuliano furono forze collegate al blocco agrario siciliano (e anche a centrali straniere) che intendevano sviluppare un aperto ricatto verso la Dc per indurla a rompere con i partiti di sinistra in Sicilia; contribuendo così ad accelerare anche la rottura sul piano nazionale. D’altro canto la banda Giuliano diede un seguito alla sua azione terroristica e, dopo la strage di Portella, nelle settimane successive, si ebbero attacchi alle sedi del Pci e del Psi e delle Camere del lavoro in numerosi comuni del palermitano (San Giuseppe
186
Jato. Partinico. Monreale, San Cipirrello, eccetera) nel corso dei quali furono assassinati o feriti numerosi lavoratori. Tale clima del terrore venne alimentato sino alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 che segnarono una profonda modifica dei rapporti di forza tra i partiti in tutti i comuni di influenza della banda Giuliano. A trarre benefici dall’ intervento elettorale della banda Giuliano, furono il Partito Monarchico da un lato e la Democrazia Cristiana dall’altro. In merito, poi, alle centrali straniere di cui si faceva cenno nella relazione Antimafia di maggioranza del 1976 e che avrebbero armato Giuliano, significativi indirizzi risultano in un rapporto dell’ottobre 1947 del Dipartimento di Stato americano in cui si parla dell’agente “Frank Gigliotti, esponente della massoneria americana ed ex agente dell’Oss (poi sostituita dalla Cia), che stava cercando di riattivare la vecchia banda dei servizi strategici in Italia come strumento per la lotta al comunismo”. Lo stesso Gigliotti informava il Dipartimento di Stato che cinquanta generali stavano preparando un colpo di Stato in Italia. Facevano parte di un gruppo organizzato dal colonnello Ettore Musco (futuro capo del Sifar) che proprio in quell’anno aveva fondato 1’Ail, Armata italiana per la libertà, un’organizzazione sostenuta economicamente e militarmente dai servizi segreti degli USA, con lo scopo di far fronte ad una eventuale insurrezione comunista. Del resto, molti documenti declassificati negli ultimi anni dimostrano come nel 1948 i piani di intervento militare fossero stati predisposti non solo per contrastare un’ipotetica invasione da parte dell’esercito sovietico, ma anche in caso di vittoria elettorale del fronte Popolare. In un rapporto del Nsc, National Security Council, dell’8 marzo 1948 sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’Italia nella ipotesi di una partecipazione dei comunisti al governo con mezzi legali, si diceva espressamente che una vittoria del Fronte Popolare avrebbe minacciato gravemente gli interessi USA nel mediterraneo. Per opporsi ad un simile evento gli Stati Uniti avrebbero fornito “assistenza militare e economica al movimento clandestino anticomunista”. Tutto questo spiega la fornitura, alla banda Giuliano, di armi della Divisione Anders, formata da polacchi e sbarcata in Sicilia al
187
seguito delle forze di occupazione statunitensi. E spiega la fornitura segreta, nel marzo 1948, di una grossa partita di armi al fronte antibolscevico. composto da fascisti, monarchici e ufficiali di polizia che avrebbero dovuto operare all’interno del cosiddetto “piano x” contro il pericolo rosso. Alla vigilia delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, mentre Giuliano, con un suo manifesto, invitava a votare Dc, le navi da guerra americane attraccavano nei principali porti italiani. In questo clima di tensione e di intimidazione, si verificava la grande vittoria della Dc (47,3%1o dei voti e maggioranza assoluta alla Camera) e l’arretramento del Fronte Democratico Popolare che ebbe solo il 31,1% dei suffragi. Cospicua l’avanzata in Sicilia della Dc che, nelle zone controllate da Giuliano, triplicò i voti. Il clima di tensione si era accentuato con il discorso del 22 dicembre 1946 con cui Pio XII aveva iniziato la “crociata anticomunista”: “O con Cristo o contro Cristo, o con la Chiesa o contro la sua Chiesa”. Un mese prima, a Palermo, i capimafia riuniti avevano dichiarato: “La mafia è pronta a combattere il comunismo anche con le armi”. Un mese dopo le elezioni esplodeva l’odio politico: lo studente di estrema destra Antonio Pallante feriva gravemente Togliatti; sciopero generale e scontri con la polizia in tutta Italia; frattura all’interno della Cgil, con la componente cattolica che si dissociava dallo sciopero e dava vita alla Cisl. Il ministro dell’Interno Scelba sperimentava in quei giorni i “piani insurrezionali”. Nel 1947, il Grande Oriente d’Italia otteneva il riconoscimento ufficiale da parte della circoscrizione massonica del nord degli Usa grazie a Frank Gigliotti, il quale – come ha scritto Alfredo Galasso nel suo libro La mafia politica – “patrocinò l’unificazione della massoneria italiana utilizzando i suoi rapporti con il siciliano principe Alliata di Montereale, che poi risulterà anche membro della P2. Costui era uno degli organizzatori del golpe Borghese, e fu l’anello di congiunzione tra massoneria e mafia, all’epoca della strage di Portella della Ginestra”. Il 10 febbraio di quell’anno entravano in vigore le clausole politiche inserite ex novo nel trattato di pace con l’Italia, il cui articolo 16, formulato su proposta e condizioni del rappresentante Usa, recitava: “L’Italia non perseguirà né di-
188
sturberà i cittadini italiani, particolarmente i componenti le forze armate, per il solo fatto di avere, nel corso del periodo tra il 10 giugno 1943 e la data di entrata in vigore del presente trattato espresso la loro simpatia per la causa delle Potenze Alleate e Associate o di avere condotto azioni a favore di detta causa”. La mancanza di indicazioni e precisazioni per le generiche parole “cittadini italiani”, ha fatto desumere che nella genericità si volessero tutelare in termini politici e, addirittura, in termini amministrativi, gli individui che, proprio in quel periodo, gli americani espellevano dal proprio territorio consegnandoli alle autorità italiane, e quei personaggi della vita siciliana già colpiti da provvedimenti della polizia contro la mafia. In merito alla validità temporale delle predette clausole politiche bisogna considerare che nei primi anni del dopoguerra nella lotta politica entrarono in gioco scelte di vita, schieramenti di campo, sistemi di civiltà, in un mondo dominato dal bipolarismo in cui la vicenda italiana vedeva da un lato il più forte partito comunista e dall’altro uno schieramento più ampio e compatto di indirizzo nettamente filoccidentale. Le esigenze del bipolarismo riconducevano ai rapporti tra settori dello Stato e la mafia e alla conseguente impunità di Cosa Nostra.
189
Enrico Mattei, fondatore dell’ENI. Una vita per l’Italia. (1953)
190
11 La commedia degli inganni
Nella vicenda del bandito Giuliano esplosero pubblicamente gravi rivalità tra carabinieri e polizia. Più volte nei suoi periodici rapporti al ministero dell’Interno, il generale dei carabinieri Amedeo Branca non esitò a denunciare le mene dei dirigenti di pubblica sicurezza e più di una volta i piani elaborati dai carabinieri vennero sventati all’ultimo momento da contrordini o da interventi intempestivi degli uomini alle dipendenze dell’ispettore Messana. Nel frattempo, la banda di Montelepre uccideva mafiosi, poliziotti, carabinieri e cittadini innocenti: tra i mafiosi cadeva Santo Flores il cui posto nella cosca di Partinico sarà preso nel gennaio 1950 dall’americano Frank Coppola, mafioso abilissimo, anch’egli “espulso” dagli Usa. Cadde anche qualche politico considerato “traditore”, come Leonardo Renda, segretario della Dc di Alcamo. ma non s’interruppero gli incontri segreti di Giuliano con alti funzionari di polizia, altissimi magistrati e giornalisti ai quali il bandito concedeva lunghe interviste. In questo quadro contorto e confuso, agì da vero maestro dell’intrigo e del doppiogioco l’ispettore di pubblica sicurezza Ciro Verdiani il quale, dopo essere stato esonerato dall’incarico della lotta al banditismo, s’incontrò più volte con Giuliano alla presenza di Gaspare Pisciotta e del mafioso Miceli. Lo scopo era chiaro: trovare un accordo che salvaguardasse, con il silenzio di Turiddu, i politici compromessi con la banda. L’ultimo incontro avvenne pochi giorni prima del Natale 1949, a Giacalone, in casa del mafioso Giuseppe Marotta; Verdiani promise una
191
larga amnistia che avrebbe consentito ai componenti della banda di tornare a casa. “Comunque vadano le cose – aveva detto a Giuliano – un aereo ti preleverà dall’aeroporto militare di Castelvetrano e ti porterà fuori dall’Italia, in un paese mediterraneo’”. In quella occasione il mafioso Miceli, nel ruolo di garante degli accordi, ripeté a Giuliano quanto gli aveva detto in un precedente incontro, nell’agosto di quell’anno: “Se accetti di espatriare subito, ti saranno concesse tutte le garanzie possibili”. Fu Verdiani a ricevere un memoriale che Giuliano scrisse intorno alla strage di Portella della Ginestra, quando il procedimento penale per tale crimine aveva avuto il suo primo inizio a Viterbo nel giugno 1950, trasmettendolo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Emanuele Pili, non già all’ufficio, ma al suo indirizzo privato. Di questo memoriale e di altri presunti di cui si è tanto parlato non si saprà mai nulla. Stretto dai suoi gregari che gli rinfacciavano di non aver saputo ottenere il rispetto degli impegni presi dai mandanti, Giuliano compì una serie di azioni clamorose. Il 7 agosto 1949 tentò di catturare vivo il ministro Mattarella nel tratto di strada Alcamo-Calatafimi senza riuscirvi perché un “amico” aveva avvisato l’onorevole; anche don Calogero Vizzini sfuggì ad un tentativo di sequestro, anche lui messo in guardia dai soliti “amici”. Il 19 agosto la rabbia di Giuliano culminò nella strage di Bellolampo, nei pressi di Monreale, dove persero la vita sette carabinieri: una mina anticarro aveva fatto saltare in aria un camion con trentacinque carabinieri. In quella “torbida” estate 1949 il ministro Scelba decise di togliere la faccenda dalle mani della polizia – ormai troppo compromessa – e di affidare l’eliminazione di Giuliano al nuovo Corpo forza repressione del banditismo (Cfrb) composto esclusivamente da carabinieri. Vennero concessi pieni poteri al colonnello comandante del Corpo, Ugo Luca che veniva dal Sim, il servizio segreto delle forze armate, il quale decise di sfogliare la banda Giuliano come un carciofo. I luogotenenti ed i gregari vennero uccisi o catturati ad uno ad uno per una serie di tranelli tesi loro dalla mafia di Monreale. Può dirsi ormai storicamente accertato – sosterrà la Commissio-
192
ne antimafia – che fu la mafia di Monreale capitanata da Miceli e da Nitto Minasola, a frantumare le ulteriori resistenze della banda Giuliano e permettere la cattura di alcuni degli uomini che gli erano più vicini, Castrense Madonia, Nunzio Badalamenti, Frank Mannino. Tra i personaggi di quella che qualcuno definì la “commedia degli inganni” entrò perentoriamente Gaspare Pisciotta, desideroso di tentare una sua solitaria linea di salvezza. Nitto Minasola, a cui s’era rivolto gli aveva consigliato di affidarsi personalmente al comandante del Cfrb ma questi, ricevuta la richiesta di un incontro e temendo un trucco delegò due suoi stretti collaboratori: il tenente colonnello Giacinto Paolantonio e il maresciallo Lo Bianco, i quali insieme al Minasola che fungeva da garante, condussero la delicatissima trattativa e convinsero Pisciotta a tradire Giuliano. Era il 19 giugno 1950. Solo a quel punto Luca volle concludere personalmente l’operazione: sette giorni dopo, nei pressi di Monreale, s’incontrò con Pisciotta, al cui fianco c’era sempre il fidato Minasola. Il giorno dopo il bandito ebbe il suo tesserino, sotto il falso nome di Giuseppe Faraci, che gli permetterà di frequentare la caserma di corso Calatafimi, a Palermo, e di incontrare quando voleva il capitano Perenze. L’operazione dei carabinieri, il cui scopo era quello di prender Giuliano vivo, anche per sapere la verità sugli attentati in cui avevano perso la vita un’ottantina di commilitoni, subì tutta una serie di interferenze della polizia che finirono per arrecare non pochi danni al lavoro del Cfrb. Infatti, alcuni avevano previsto un finale assai diverso da quello voluto dai carabinieri ai cui piedi verrà gettato soltanto un cadavere; fu la mafia che, puntando sul tradimento di Gaspare Pisciotta, arrivò alla liquidazione fisica di Giuliano, per l’interesse che aveva al suo definitivo silenzio sulle troppe cose che sapeva. “Il compito di Pisciotta – ha detto alla Commissione antimafia il capitano Antonio Perenze – non era quello di uccidere il bandito, ma solo di stanarlo”. La sera del 4 luglio 1950, il colonnello Luca riunì, nella caserma di piazza Indipendenza, a Palermo, i suoi principali collaboratori. Il piano per la cattura di Giuliano doveva scattare la sera seguente.
193
Cattura, non uccisione. La riunione si concluse alle ore 21, con un appuntamento per la sera seguente e Gaspare Pisciotta fu avvertito di attendere ordini. “Ma pochi minuti più tardi – ha scritto Pietro Zullino nel suo libro Guida ai misteri e piaceri di Palermo – Paolantonio e Lo Bianco videro uscire il colonnello Luca dal comando, infilarsi in una 1100 civile e partire. Incuriositi, lo seguirono lungo la via di Monreale e scoprirono che andava a Partinico, zona controllata dal mafioso Frank Coppola. Che cosa andava a fare Luca tutto solo a Partinico?”. La risposta la fornì il maresciallo Lo Bianco all’Antimafia: “Alle 5 di mattina (del giorno dopo) mi svegliò il telefono. Era il colonnello Paolantonio. ‘Lo Bianco, vuoi una notizia? È stato ucciso Giuliano. A Castelvetrano. Ho avuto una telefonata di Luca il quale mi dice che per un contrattempo è successo un conflitto. Giuliano è rimasto morto…’ La notizia amareggiò molto il Lo Bianco che all’invito di Paolantonio di recarsi sul posto rispose indispettito: non vengo, perché potrei perdere le staffe”. Il capitano Perenze credeva in buona fede di dover prendere vivo Giuliano, come risulta dalla sua testimonianza resa alla Commissione antimafia nella seduta del 22 maggio 1969: «On. Tuccari. Ma era indispensabile farlo uccidere (Giuliano) da Pisciotta? Perenze. Ma no, assolutamente no. On. Tuccari. Quindi, sarebbe stato possibile prenderlo vivo? Perenze. Noi speravamo di poterlo prendere vivo: anzi, eravamo protesi proprio verso quello scopo lì. On. Tuccari. Io mi permetto di essere sorpreso di fronte a questo dato che Pisciotta, in fondo, agiva di concerto con voi. Perenze. Ma Pisciotta non doveva ucciderlo, doveva stanarlo: accertare, prima di ogni altra cosa, dove si trovasse e poi tirarlo fuori. On. Tuccari. Ma che ragione avrebbe avuto di ucciderlo, se l’uccise nel sonno? Non ci fu neanche un motivo di legittima difesa. Perenze. C’è stato un motivo: Giuliano, cioè, era stato avvertito, qualche minuto prima, o la sera prima, o nella stessa giornata, che Pisciotta era con noi, che Pisciotta lo tradiva.
194
On. Tuccari. E come mai, allora, quella notte si addormentò tranquillamente? Perenze. Non credo che si fosse addormentato tanto tranquillamente. Credo che siano rimasti in piedi per molte ore a chiacchierare: e Pisciotta, che aveva una dialettica non indifferente, riuscì a convincere Giuliano che si sbagliava e quello che gli avevano detto era inesatto e così via… On. Tuccari. Ma io torno alla mia domanda: come mai Pisciotta che era il vostro braccio (e quindi come lei dice, conosceva la vostra volontà di prenderlo vivo) invece l’ha fatto fuori? Perenze. Quando Pisciotta arrivò in casa di questo avvocato De Maria, mi sembra che Giuliano stesse cenando. Pisciotta – entrò, si mise a sedere, e quell’altro lo aggredì letteralmente: gli disse: ‘Traditore! Bastardo!’. Gliene disse di tutti i colori. On. Tuccari. Ma se Giuliano dormiva e fu ucciso nel sonno, come è possibile dire che Pisciotta non sarebbe uscito vivo dalla casa? Ormai Giuliano dormiva! Perenze. Pisciotta ha detto che ha dovuto far finta di dormire per parecchio tempo; di russare per parecchio tempo: ‘Soltanto quando mi sono accorto che lui dormiva sicuramente ho sparato’. Questo ha dichiarato Pisciotta che precipitandosi fuori gridò a De Maria: ‘Avvocato, stanno sparando!’». Dal racconto di Pisciotta, riferito con imbarazzata convinzione dal Perenze, oltre al curioso verbo al plurale, “stanno sparando”, emerse un’altra stranezza: Giuliano si sarebbe addormentato, dando prova, perlomeno, di un’ingenuità e di una tranquillità addirittura inconcepibili in un bandito che sapeva essere braccato come un cane rabbioso, e Pisciotta, allora, pur sapendo che i carabinieri lo volevano vivo, avrebbe approfittato del sonno del capobanda, e gli avrebbe sparato. Una storia, che vista alla luce della testimonianza resa dal Perenze, non stava in piedi. Del resto, gli stessi superstiti della banda esclusero che fosse stato Pisciotta a uccidere Salvatore Giuliano. Interrogato dalla Commissione antimafia nelle carceri di Civitavecchia, il 2 luglio 1970, Frank Mannino (che durante la detenzione aveva abbracciato la fede dei Testimoni di Geova e quindi
195
ripudiata la menzogna), ad un certo punto dichiarò, riferendosi ad un momento del processo di Viterbo: «Prima che Pisciotta dicesse “Io ho ucciso Giuliano”, l’avvocato ci parla e ci dice: “Badate che Piseiotta dirà di avere ucciso Giuliano: ma state tranquilli perché non è lui. Io oggi, sono convinto che Pisciotta non ha ucciso Giuliano. È un traditore, Pisciotta, ma non è l’uccisore di Giuliano». E ancora: «È questo che si dovrebbe chiarire. Chi diede il colpo di grazia? Perché, per conto mio, è stata la bustina che ha bloccato Giuliano». Il Mannino chiamò “bustina” una dose di sonnifero e intendeva dire che Salvatore Giuliano era stato drogato e ucciso nel sonno da un killer diverso da Pisciotta. E riuscì a dire all’Antimafia che il maresciallo dei carabinieri Calandra, nei giorni precedenti la morte di Giuliano, aveva mostrato a lui, in carcere, una bustina, dicendogli che si trattava di un potente sonnifero.
196
12 Omertà di Stato
L’Antimafia, purtroppo, non reputò opportuno soffermarsi su questo punto, certamente un particolare rilevante, una vera e propria “chiave di lettura” da cui si poteva evincere che Gaspare Pisciotta, per incomprensibili motivi, si era accollato un omicidio che non gli apparteneva. Lo testimoniò anche Antonio Terranova, altro esponente principale della banda Giuliano, interrogato il 2 luglio nelle carceri di Civitavecchia: «Pisciotta aveva promesso a me che avrebbe detto la verità, a Viterbo, ma nel senso come la intendevo io, e cioè la verità vera. Mi disse che la sapeva e che l’avrebbe detta. Lui, in un primo tempo, disse che aveva ucciso Giuliano. In un secondo tempo disse di no. Successivamente cambiò ancora opinione affermando che avrebbe detto chi era il responsabile…». Ma Gaspare Pisciotta non riuscirà a dire più niente e sarà avvelenato nel carcere di Palermo la mattina del 9 febbraio 1954. Da chi fu assassinato Giuliano? Come lo stesso Perenze scrisse nella sua relazione del 9 luglio 1950, oltre alla figura di un confidente che guidò i carabinieri (ruolo svolto da Gaspare Pisciotta), c’era anche un “terzo uomo”: quello che fu visto uscire da casa De Maria insieme a Giuliano e poi datosi alla fuga durante il conflitto. Chi era? Chi l’aveva mandato a interferire nel piano dei carabinieri? La Commissione antimafia ha avanzato l’ipotesi che sia stato Luciano Liggio a uccidere il bandito di Montelepre, “garantendo così alla organizzazione mafiosa, di cui era diventato uno degli
197
uomini di punta, la protezione e l’appoggio di quelle forze politiche che avevano l’assoluta necessità di eliminare il famoso capobanda. Troppi, in Sicilia sono coloro che non hanno alcun interesse a far cadere Giuliano vivo nelle mani dei carabinieri: il bandito sa troppe cose, e può compromettere troppe posizioni di potere”. È stato ipotizzato che Giuliano, sotto l’effetto del sonnifero, sia stato trasportato con una macchina nottetempo a Castelvetrano. Per agevolare in questa operazione Gaspare Pisciotta, la cosca di Partinico gli avrebbe affiancato uno sconosciuto, il “terzo uomo”: in apparenza per vigilare su Giuliano mentre Pisciotta guidava, e per aiutarlo a trasportare il corpo su per la scala, fino alla camera da letto, dove sarebbe avvenuta la consegna ai carabinieri, in realtà soltanto per ucciderlo. Secondo questa ipotesi fu a Partinico, forse in casa di Frank Coppola, o di un amico di Coppola, che Pisciotta, durante la cena, avrebbe propinato a Giuliano il sonnifero. E proprio quella sera – il 4 luglio alle 21 – il colonnello Luca lasciò Palermo pedinato a distanza da Paolantonio e Lo Bianco, imboccò la via di Monreale e si spinse fino a Partinico, forse per concordare con Frank Coppola i dettagli dell’operazione. Un corteo di tre automobili, tra le 22 e le 23, si sarebbe mosso da Partinico, in direzione di Castelvetrano. Nella prima viaggiavano Pisciotta, il “terzo uomo” e Giuliano addormentato, nella seconda il capitano Perenze e tre carabinieri e nella terza il colonnello Luca che si fermerà alla periferia di Castelvetrano in attesa. Verso l’una Pisciotta e il “terzo uomo”, giunti a casa De Maria, trasportarono Giuliano sul letto e aspettarono l’irruzione dei carabinieri. Improvvisamente, il “terzo uomo”, sotto lo sguardo terrorizzato di Pisciotta, estrasse una pistola e sparò su Giuliano alcuni colpi. Pisciotta si precipitò fuori e gridò al De Maria: “Avvocato, stanno sparando!”, mentre il killer si dileguava nella notte. Subito dopo, Perenze e i tre carabinieri sopraggiunsero e furono colti da sorpresa alla vista di Giuliano morto. Poi, venne fatto allontanare Pisciotta e si mandò ad avvertire Luca che, giunto a casa De Maria, decise di simulare un conflitto a fuoco che rendesse accettabile questa morte di Giuliano davanti all’opinione pubblica. Quindi si montò nel cortile la scena del conflitto: il cada-
198
vere venne steso bocconi a terra, si collocarono intorno un mitra, una pistola e un tascapane, si controllò che tutto fosse a posto. Finalmente verso le 3 di notte, si spararono le raffiche sul cadavere. Dai fori delle nuove ferite non uscì sangue ma la canottiera ne fu abbondantemente intrisa in una zona della schiena priva di ferite. Furono le cose strane che il giornalista Besozzi, tre giorni dopo, avrebbe notato. Luciano Liggio secondo l’ipotesi avanzata dall’Antimafia, sarebbe il “terzo uomo” di cui parlò Perenze nella sua relazione. La stessa Antimafia ha scritto per avvalorare questa ipotesi: “In quei primi mesi del 1950, nella Sicilia occidentale, la mafia si identifica soprattutto nel binomio Navarra–Liggio, essendosi conquistato, quest’ultimo, i gradi di killer più spietato della organizzazione. Nel periodo in cui Giuliano viene eliminato, Liggio è già latitante. Ma la sua è una strana latitanza. Anzi, proprio a Corleone, gode dell’aperta protezione di alcuni notabili del luogo”. Il pentito Leonardo Messina, ex collaboratore del Sisde, quarant’anni dopo, soffermandosi a parlare sui rapporti tra mafia e politica, nonché del patto tra la mafia ed una parte dello Stato, confermerà l’ipotesi avanzata dall’Antimafia sul ruolo del “terzo uomo”. Ai giudici dirà: “Quando Giuliano faceva il separatista Liggio lo ammazzò e lo portò ai carabinieri; era un regalo, evidentemente non solo a titolo personale, ma frutto di un accordo a monte”. Nei colloqui raccolti da Pino Arlacchi nel libro Addio Cosa Nostra, Tommaso Buscetta non accenna minimamente alla storia del “terzo uomo” e sostiene che non fu Cosa Nostra a tradire e uccidere Giuliano, definito uomo d’onore della famiglia di Montelepre, ma alcuni uomini di Cosa Nostra, singoli personaggi mafiosi, neppure famiglie. Essi avrebbero agito per conto di quei politici, gli stessi che avevano deciso di eliminare Giuliano dopo averlo illuso con i discorsi e con gli accordi sull’indipendenza della Sicilia. Secondo Buscetta, fu Cosa Nostra “nel suo insieme” a decidere di vendicare Giuliano uccidendo Pisciotta (avvelenato in carcere), Minasola e altri, per vendetta mafiosa e non per impedir loro di rivelare ciò che sapevano. Tutti avevano agito contro la volontà e all’insaputa delle rispettive famiglie. Si avverte nelle inedite dichiarazioni di Buscetta una volontà di
199
coerenza con la sua interpretazione mitica della vecchia mafia, di allontanare da essa ogni sospetto di tradimento nei confronti dell’uomo d’onore Giuliano, da lui definito “una sorta di eroe che emanava una luce speciale”. La stessa interpretazione mitica con cui rispondeva ad Enzo Biagi (II boss è solo) che gli chiedeva com’era il mafioso di una volta: “Non doveva essere prepotente. Non doveva far vedere che era un mafioso: ma far sentire nell’aria che poteva esserlo. Non doveva approfittare delle disgrazie altrui”. E se è vero – come afferma Buscetta – che a quel tempo (1947, ’48 o ’50) Cosa Nostra non aveva ancora una organizzazione unitaria e verticistica, tale da potere esprimere la volontà concorde di tutte le famiglie (ogni famiglia stava, per così dire, per conto suo), è altrettanto vero che “importanti” scelte politiche vennero assunte da esponenti storici di Cosa Nostra, su richiesta e sollecitazione di quegli uomini politici che avevano interesse ad ottenere il silenzio di Pisciotta e di quanti altri conoscevano i retroscena della “commedia degli inganni” e, soprattutto, della strage di Portella della Ginestra. A proposito di Portella, Buscetta sostiene che fu un “incidente”. “Giuliano – dice – non era presente e non aveva dato l’ordine di sparare contro donne e bambini inermi per uccidere, ma solo per intimidire, spaventare gli organizzatori comunisti”. Che Portella rientrasse in una strategia terroristica in vista delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, lo dimostrano i successivi attacchi sferrati da Giuliano alle sedi del Pci e del Psi e delle Camere del Lavoro in numerosi comuni del palermitano nel corso dei quali furono assassinati o feriti numerosi lavoratori. Tommaso Buscetta, che fu un boss pentito, ha fatto interessanti dichiarazioni su Cosa Nostra e convinto di essere nel giusto dice: “io non ho più niente da spartire con la mafia, è cambiato il modo di pensare, non esistono più quei concetti che hanno fatto di me un mafioso: la difesa dei più deboli, la fedeltà, la stima. Vedo solo una corsa per il denaro e tanti tradimenti, e le uccisioni assurde.” Buscetta poi dice ancora: “E non sono nemmeno un pentito: le mie rivelazioni non nascono da un calcolo di interesse. Voglio raccontare quanto è a mia conoscenza su quel cancro che è la mafia, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e più umano…”
200
Immagine1
Tommaso Buscetta, il boss pentito
201
Immagine 2
Tommaso Buscetta, scortato da un carabiniere
202
13 Portella della Ginestra
A Portella della Ginestra, nel luogo consacrato al tempo dei Fasci da Nicola Barbato alla celebrazione del Primo Maggio e ai convegni dei contadini di San Giuseppe Jato, Sancipirello e Piana dei Greci, cinquantaquattro anni dopo, nel 1947, una strage, freddamente premeditata ed organizzata dalla reazione feudale ed agraria, si abbatté sulla folla di popolo riunitasi il 1° maggio per manifestare pacificamente nel segno della giustizia e del riscatto del lavoro. Sul podio di pietra, quel giorno, nella gola tra i due monti, il calzolaio Giacomo Schirò cominciò a parlare; a fatica gli si fece silenzio intorno, poi si cominciarono ad udire le parole: «Compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il primo maggio, la festa del lavoro» ed all’improvviso il costone di Monte Pizzuto avvampò di raffiche, i proiettili fischiarono più rabbiosi; qualche secondo di silenzio, poi l’urlo di tremila persone prese in gabbia, che corrono da pazze, da tutte le parti e cercano riparo fra i sassi; seguono minuti incessanti, i primi feriti si abbattono al suolo invocando soccorso, i primi morti giacciono nella pietraia. Alla fine dell’orrendo eccidio i morti saranno 11 e 50 i feriti: uomini, donne e bambini. Quel primo maggio del 1947 doveva essere un giorno di festa per il lavoro, per la vittoria della sinistra alle elezioni regionali, per la crescita del movimento contadino, per tutto quello che era avvenuto e che ci si attendeva che potesse ancona avvenire sul piano dell’avanzamento delle forze progressiste. Ma in quel pianoro
203
all’ombra della Pizzuta e della Kumeta le forze della reazione usarono il banditismo per uccidere e lo useranno ancora come politica delle armi tutte le volte che con le armi della politica non riusciranno ad ottenere i risultati sperati. Si può dire che Portella è stato il prologo della stagione delle stragi che dalla fine degli anni sessanta insanguineranno l’Italia. È stata la drammatica messa in scena di quella che sarà definita la “democrazia bloccata”. È stato il luogo dove si svolsero le prove generali del “doppio Stato”. A Portella della Ginestra, mafia e istituzioni colluse usarono la banda Giuliano per coprire le loro responsabilità. Secondo 1o storico Giuseppe Casarubbea, che ha fatto accurate ricerche tra le carte dei processi dell’epoca, Salvatore Giuliano non avrebbe potuto compiere quell’atroce azione criminale senza la complicità di parti dello Stato. Per Casarubbea il primo maggio del 1947 gli uomini di Giuliano erano convinti di dover rapire, dietro ordine della mafia locale allora capeggiata dalla famiglia Miceli di Monreale, Girolamo Li Causi, uno dei dirigenti più prestigiosi del Pci siciliano. In una intervista rilasciata al giornalista Rino Cascio, Casarubbea spiega che la cosa era in realtà infondata perché la storia del rapimento del dirigente comunista era solo una invenzione personale dell’ispettore di pubblica sicurezza Ettore Messana. *** Il depistaggio doveva strumentalmente servire a costringere Giuliano a trovarsi a Portella come paravento di un’operazione che in realtà aveva ben altri moventi, altri protagonisti, altri personaggi. Sulla sparatoria che uccise undici contadini, Casarubbea spiega che sul terreno furono trovati ottocento bossoli, ma quei bossoli non furono mortali. Che ad uccidere i contadini furono invece tredici colpi che vennero sparati ad altezza d’uomo. D’altra parte i giudici sostennero che i colpi vennero sparati anche dal basso. Di fronte a loro, diversi testimoni, dichiararono che dalle postazioni basse avevano visto uscire i capimafia della zona. Ma coloro che avevano la responsabilità di rilevare tutte le po-
204
stazioni e fornire agli inquirenti tutte le prove di ciò che era accaduto, si comportarono invece rimuovendo i documenti, i fatti, le circostanze, le memorie, riconsegnando agli atti giudiziari un ritaglio che inchiodava soltanto il bandito Giuliano, il quale era senz’altro corresponsabile, ma non il solo artefice della strage. Per questo motivo mafia e istituzione colluse eliminarono Salvatore Giuliano per coprire con i1 silenzio le loro responsabilità quelle di aver tentato di arrestare con la strage di Portella della Ginestra il movimento contadino siciliano. Lo provano il ricorso a pratiche illegali da parte dei rappresentanti dello Stato: contatti con i banditi, con i mafiosi, che andavano ben oltre le normali pratiche poliziesche volte ad acquisire informatori e confidenti all’interno dei mondi criminali. Gli incontri del bandito Giuliano e di altri banditi con i vertici delle forze dell’ordine, servirono a stringere patti con gli agrari e con i mafiosi che vollero la strage per non essere sconfitti dal movimento contadino. La strage di Portella della Ginestra e l’azione repressiva attuata, anche con le armi, nei confronti di sindacalisti e di quanti si ponevano in posizione di resistenza ai soprusi ed alle intimidazioni, fecero rivivere la vecchia storia dei Fasci. Ma la mafia che aveva assunto meriti nello sbarco americano nell’isola, tornò nuovamente ad operare alla luce del sole dopo il secondo conflitto. Ricomposta la connivenza mafia e politica, il modello mafioso avrà nel tempo, ulteriori evoluzioni inserendosi, come forza imprenditrice, negli affari pubblici, nel traffico della droga, compiendo gravissimi delitti ed eccidi, assumendo un ruolo preminente nella grande criminalità organizzata e interagendo con i centri della corruzione politica ed amministrativa, con quelli della corruzione economica e con le lobbies. Alle madri di Portella e a quelle delle stragi che segnarono le vicende dei Fasci e le repressioni del movimento contadino siciliano, il poeta Salvatore Quasimodo, dedicò il suo Lamento della Sicilia, un brano struggente, una lamentazione antica: «Voi vedete ora le immagini della Sicilia che piange e pensate che uno scenario pesante, luttuoso, si sia aperto su un mondo sconosciuto, lontano di mil-
205
lenni nel tempo. È la Sicilia più viva quella che vedete, il suo sentimento che si esprime con forza e pietà dinanzi alla morte. Le madri dei caduti di Portella della Ginestra piangono come tutte le donne di Sicilia: a Messina, a Siracusa, a Catania, a Palermo il lamento per i morti ha la stessa tremenda potenza, ed è un coro che afferma la continuità della vita… A Portella della Ginestra ricade ancora il silenzio, ma i suoi morti continuano ad abitare coi vivi…».
206
14 Mafia e politica
«Per quali ragioni Cosa Nostra ha potuto svolgere cosí a lungo la sua attività senza essere permanentemente contrastata? Per quali ragioni è riuscita a sviluppare veri e propri rapporti di integrazione con i pubblici poteri? La spiegazione non può essere costituita soltanto dalle viltà o dai calcoli dei singoli. Troppo duraturi nel tempo, vasti e diffusi sono stati quei rapporti, per poter essere fondati su debolezze individuali. Le compromissioni soggettive non sarebbero state di per sé sufficienti e non si sarebbero certamente manifestate con quell’ampiezza, quella continuità e quell’efficacia se non fossero state sostenute da piú generali condizioni di carattere storico–politico. Precise ragioni di carattere storico–politico hanno infatti favorito da piú di un secolo, i rapporti di Cosa Nostra con i poteri, le hanno attribuito una specifica e riconosciuta funzione politica, le hanno consentito di svolgere un ruolo di sostegno ad esperienze politiche, a partiti, a uomini politici. Tutto ciò ha sinora impedito la liberazione del Paese da quei condizionamenti. Ed è evidente che la sconfitta definitiva di Cosa Nostra passa non solo attraverso la punizione delle responsabilità individuali, ma anche attraverso il superamento definitivo delle condizioni oggettive che hanno favorito le compromissioni». La relazione su «Rapporti tra mafia e politica» approvata il 6 aprile 1993 dal Parlamento ha cosí spiegato le ragioni per cui la mafia è nella società contemporanea, un particolare gruppo di potere di cui si servono le forze politiche, economiche e sociali che vogliono conquistare o mantenere una egemonia, anche con mezzi extralegali; gruppo di
207
potere che tende a confondersi e talora a identificarsi sempre piú con una parte o con certi gruppi di quelle forze. Sicché la questione mafia è rimasta insoluta, dall’Unità d’Italia ai nostri giorni, nonostante il susseguirsi di governi, di provvedimenti e le innumerevoli inchieste, nonostante il sangue delle vittime e l’interminabile calvario di dolore dei sopravvissuti. La mafia ha continuato ad esistere e a riprodursi come un cancro maligno nel tessuto stesso della società italiana, non solo siciliana, mentre lo Stato alternava fiammate di repressioni brevi ed effimere alla complicità mafiosa. Già con l’Unità d’Italia si agitava, sorretta dal vecchio «sicilianismo», come ha scritto Leonardo Sciascia, «la formazione di una categoria sociale, se non di una classe, che approssimativamente si può dire borghese, borghese-mafiosa piú esattamente di cui è campione il “Sedara” del Gattopardo: la quale categoria vedeva nel parlamentarismo, o almeno nella macchina elettorale, quelle chances che lo Stato dei Borboni non offriva e non prometteva… Quella classe borghese– mafiosa, la quale aveva capito che tutto stava per cambiare appunto perché niente cambiasse e che l’entrare nel Regno d’Italia, abdicando a certi privilegi autonomistici, avrebbe accelerato il passaggio di consegne dai Gattopardi agli sciacalli su una realtà destinata per molti anni ancora alla immobilità». Il capitalismo della nuova classe borghese–mafiosa era soprattutto incentrato sul diritto di proprietà «intangibile e incondizionato» per cui il latifondo poteva restare improduttivo mentre per le plebi rurali della Sicilia e dell’intero meridione, che si dibattevano nella miseria, la repressione puntualmente scattava al primo segno di rivendicazione della terra. Nel 1860 Garibaldi ottenne contro i Borboni l’aiuto dei contadini promettendo loro la terra. Ma quando, con i due decreti del maggio e del giugno, egli mantenne la promessa, abolendo la tassa sul macinato e concedendo la terra ai contadini, si scatenò la dura reazione. In molti paesi dove le masse rurali entusiaste avevano iniziato ad occupare le terre comunali incolte, campieri e sovrastanti spararono seminando morte e terrore. La classe dirigente rinunziò immediatamente alle opportune garanzie di unione all’Italia con il mantenimento di una certa forma di autonomia, accettando la tesi cavouriana
208
della «annessione incondizionata». Cosí, in cambio, i decreti furono revocati e Bixio si incaricò di ristabilire 1’“ordine” con una dura repressione. Iniziò con Bronte, in provincia di Catania, dove nell’agosto 1860, la plebe rurale delusa e avvilita agì con violenza contro la provocazione della fazione conservatrice borghese e mafiosa. Bixio, entrato in paese, con un contingente dell’esercito, spense nel sangue i disordini, processò e fucilò il capo della fazione progressista Nicolò Lombardo, tre civili di questa fazione e un povero contadino. Fu cosí che il sogno di giustizia che Garibaldi voleva realizzare, per il ricatto della classe dirigente borghese e mafiosa, fu spento sul nascere.
Il boss Totò Riina
209
Rocco Chinnici, Consigliere del Tribunale di Palermo, ucciso dalla mafia nel 1990 mentre indagava sugli omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre
210
Questa analisi storica inizia con la vicenda del movimento contadino dei «Fasci siciliani» le cui rivendicazioni per piú equi contratti agrari e per mercedi piú giuste provocarono, alla fine dell’800, la compatta reazione del potere politico e di quello mafioso, uniti nel difendere un iniquo sistema sociale ed economico che garantiva loro il mantenimento e la difesa di vecchi e nuovi privilegi. La drammatica vicenda della dura e sanguinosa repressione del movimento dei «Fasci siciliani», attuata dal governo Crispi, tra il 1893 e il 1894, sulla spinta della borghesia agraria e mafiosa, rappresenta uno dei nodi cruciali della storia dell’Italia postunitaria in cui si possono scorgere quei caratteri nuovi e problematici che andava assumendo in quegli anni la questione agraria, nella teoria e nella pratica delle forze progressiste e del movimento socialista. Intanto la mafia, come già detto – ormai inserita nei centri del potere finanziario – si rese protagonista di un altro fatto eclatante, cioè la eliminazione il 3 febbraio 1893, del marchese Emanuele Notarbartolo che si accingeva ad avviare un’inchiesta al Banco di Sicilia a seguito di gravi scandali. II timore di un ritorno a sani criteri amministrativi nel massimo istituto bancario siciliano spinse la mafia ad eliminare dalla scena il Notarbartolo. Venne accusato come mandante del delitto il deputato parlamentare Raffaele Palizzolo che, processato due volte, sfuggí alla giusta condanna grazie alle pressioni degli «amici» che si batterono in suo favore ottenendo una clamorosa sentenza di assoluzione. Il Palizzolo occupa un posto eminente nella storiografia mafiologica della Sicilia e rappresenta un palese esempio del rapporto mafia politica instauratosi con l’unità d’Italia. Con l’uccisione, nel 1909, del celebre poliziotto di origine italiana Joe Petrosino, venuto dagli Stati Uniti per indagare sul passato di alcuni mafiosi espatriati illegalmente dalla Sicilia, la mafia siciliana dimostrò di avere già saldi collegamenti con quella americana e di avere posto le basi al futuro internazionale dell’organizzazione criminale e dei suoi affari. La vicenda dell’uccisione di Petrosino s’inquadrò sulla scena criminale siculo–americana di fine Ottocento inizi Novecento che aveva come protagonista la «Mano Nera» e la «Mafia». La «Mano Nera» aveva stretti collegamenti con la mafia siciliana attraverso individui,
211
come don Vito Cascio Ferro (tra i piú famigerati capimafia), che operavano, a seconda dei momenti e del tipo d’affare, ora con l’una, ora con l’altra etichetta. Sicché le due «sigle», in molti casi finirono per rappresentare la stessa cosa all’interno di una stessa «cosca»; da qui il viaggio di Petrosino a Palermo, per cercare nella mafia la matrice della «Mano Nera». Negli anni successivi, l’unione di piú «cosche» darà origine alla definizione di «Cosa Nostra», sinonimo di «affari nostri», qualcosa cioè da difendere da ogni insidia interna ed esterna. La «cosca», cellula dell’organizzazione mafiosa, stava allegoricamente per «carciofo» le cui foglie erano gli associati, stretti intorno al torso che rappresentava il capo. Le finalità criminali erano diverse e articolate: nel ricatto, nella estorsione, nella intermediazione parassitaria, nella politica e nei grandi affari illeciti. Con l’omicidio, nel 1915, di Bernardino Verro, esponente socialista, già animatore dei fasci dei lavoratori, instancabile capo del movimento contadino siciliano e nel primo decennio del nuovo secolo fautore, nel corleonese, delle cooperative agricole con lo scopo di contendere ai mafiosi la gestione di ampie estensioni di latifondo, la mafia intese opporsi con la violenza alla simultanea irruzione nella vita politica siciliana delle masse lavoratrici organizzate e guidate da un ceto politico che si identificava nel nuovo partito socialista. Non si trattava, infatti, della solita plebe esaltata, protagonista di sommosse destinate a dissolversi nel nulla, bensí di una organizzazione di lavoratori coscienti dei propri diritti e degli obiettivi di progresso sociale. Si trattava, per la borghesia–mafiosa, di un pericolo ben piú serio a cui bisognava reagire con tutti i mezzi. I casi Notarbartolo, Petrosino e Verro rappresentano esempi emblematici di come la mafia, con l’unità d’Italia, divenuta forza elettorale e di supporto ad esperienze politiche, a partiti, a uomini politici, abbia occupato spazi vitali della società civile siciliana opponendosi alla sua crescita sociale ed economica. Alcuni anni dopo nemmeno il Fascismo, che si vantava di aver ripristinato «l’ordine» in Italia, riuscí a mettere il bavaglio alla mafia che, annidatasi negli alti livelli del regime in Sicilia, aveva continuato una stretta collaborazione con il potere politico. Cesare Mori, detto il «Prefetto di Ferro», al quale
212
Mussolini aveva dato (in apparenza) pieni poteri nella lotta alla mafia, era riuscito a mettere le mani solo sui briganti e sui mafiosi di piccolo calibro. Quando egli intuí che le vere fila della mafia venivano tirate da personaggi del regime molto influenti a livello locale, venne esautorato (nel 1929) dallo stesso Mussolini.
213
15 Cosa Nostra e nuovo assetto politico
Subito dopo la seconda guerra mondiale la vicenda del bandito Salvatore Giuliano e la strage di Portella della Ginestra del 1947 coincisero con la ricomparsa di Cosa Nostra dopo la caduta del fascismo e l’occupazione alleata dell’isola. Un momento storico, che segnò il processo evolutivo della mafia nella società siciliana e nazionale in forza, soprattutto, di varie forme di legittimazione che impressero al fenomeno un rilevante carattere sociale politico ed economico. Ripetiamo che la prima legittimazione venne alla mafia dall’occupazione alleata, quando gli USA, per preparare lo sbarco si avvalsero dei rapporti tra mafiosi residenti negli Stati Uniti e mafiosi residenti in Sicilia. Una seconda forma di legittimazione derivò dalla protezione che il governo alleato conferí, soprattutto, nei primi tempi dello sbarco, al movimento separatista, l’unico movimento antifascista in Sicilia, ma con stretti rapporti con la mafia. La terza legittimazione per la mafia venne dalla collocazione ai vertici delle amministrazioni comunali di politici separatisti sostenuti dalla mafia e di molti capimafia. Nacque cosí la quarta legittimazione: quella che venne dai latifondisti siciliani che, per opporsi alle rivendicazioni contadine, ritornarono ad affidare alla mafia il controllo dei campi. La quinta legittimazione, infine, derivò dal ruolo che nella vicenda del bandito Giuliano svolse la mafia, la quale dopo averlo utilizzato per i propri fini, provvide ad eliminarlo per l’interesse che aveva Cosa Nostra (e che avevano le istituzioni colluse e certi amici politici) al definitivo silenzio del bandito che sapeva troppe cose sulla strage di Portella della Ginestra.
214
Catania. Ottobre 1962, Enrico Mattei sale sull’aereo che precipiterà a Bascapè (Pavia), alle porte di Milano
215
Nei primi anni del dopoguerra, quelli che vanno dal 1943 al 1950, la mafia riuscí ad insediarsi stabilmente nella società siciliana sfruttando abilmente ogni occasione che le si presentava per stringere relazioni con i pubblici poteri, rafforzare la propria organizzazione e incrementarne le risorse. L’assassinio di esponenti politici di sinistra, di capilega e sindacalisti, la devastazione delle Camere del Lavoro e l’attacco alle sedi dei partiti comunista e socialista, collegò Cosa Nostra alle forze piú reazionarie e agli interessi piú retrivi. L’impunità per tutti questi crimini finí per convincere la gente della «legalità sostanziale» della mafia e del suo operato. Collusioni e impunità cementarono Cosa Nostra dentro il nuovo assetto politico economico e segnarono profondamente la vicenda degli anni successivi, anni in cui la mafia ebbe un ruolo determinante nella politica generale, internazionale ed interna, tutta condizionata dal bipolarismo. La lotta politica in Italia non ebbe soluzioni di alternanza dentro un quadro politico bloccato. C’era un forte Partito Comunista, il piú forte Partito Comunista fuori dal blocco sovietico, e, ad esso aspramente contrapposto, uno schieramento maggioritario di indirizzo nettamente filoccidentale. E c’era la preoccupazione delle forze di governo di rinsaldare la propria alleanza e di sconfiggere quegli avversari che avrebbero potuto portare il Paese fuori dall’alleanza occidentale. Cosa Nostra fino alla caduta del comunismo, diventò una «necessità strategica» nazionale e dunque una componente non secondaria nella lotta anticomunista con mezzi criminali e si guadagnò una sostanziale impunità, assicurata di fatto da quelle istituzioni che avrebbero dovuto attuare nei suoi confronti un’azione repressiva legale, permanente e decisiva.
216
Bascapè (Pavia), i rottami dell’aereo di Mattei, precipitato il 27 ottobre 1962
217
Il giornalista Mauro De Mauro, rapito e ucciso il 16 settembre 1970. Stava indagando sul traffico di droga e sull’attentato a Mattei
In un rapporto del National Security Council, dell’8 marzo 1948, sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’Italia nella ipotesi di una partecipazione dei comunisti al governo con mezzi legali, si
218
diceva espressamente che una vittoria del Fronte popolare avrebbe minacciato gravemente gli interessi americani nel Mediterraneo. Per opporsi a un simile evento gli Stati Uniti avrebbero fornito «assistenza militare» ed economica al movimento clandestino anticomunista (comprendente Cosa Nostra). Tutto questo spiega la fornitura, alla banda Giuliano, di armi della Divisione Anders, formata da polacchi, sbarcata in Sicilia al seguito delle forze di occupazione statunitensi. E spiega la fornitura segreta, nel marzo 1948, di una grossa partita di armi al fronte antibolscevico, composto da fascisti, monarchici, mafiosi e ufficiali della polizia che avrebbero dovuto operare all’interno del cosiddetto «piano X» contro il pericolo rosso. Alla vigilia delle elezioni politiche del 1948, le navi da guerra americane attraccavano nei principali porti italiani. In questo clima di tensione e di intimidazione, si verificava la grande vittoria della DC (47,3 % dei voti e maggioranza assoluta alla Camera) e l’arretramento del Fronte Democratico Popolare che ebbe solo il 31,1% dei suffragi. Cospicua l’avanzata in Sicilia della DC che, nelle zone controllate da Giuliano, triplicò i voti. Il clima di tensione si era accentuato con il discorso del 22 dicembre 1946 con cui Pio XII aveva iniziato la «crociata anticomunista»: «O con Cristo o contro Cristo, o con la Chiesa o contro la Chiesa». Un mese prima, a Palermo, i capimafia riuniti avevano dichiarato: «La mafia è pronta a combattere i comunisti anche con le armi». Nel tempo i rapporti mafia-politica diventeranno ancor piú essenziali perché la mafia-imprenditrice avrà necessità di favori del mondo politico e della pubblica amministrazione per bloccare, intralciare, stravolgere leggi che potessero danneggiare il suo potere economico e i suoi affari. Avrà bisogno di nuove leggi che riguardassero le imposizioni fiscali, i condoni, le franchigie, le agevolazioni di ogni genere. Dovrà richiedere favori per gli appalti, le licenze edilizie, i piani regolatori, le compravendite dei suoli, le grandi opere. Avrà costante bisogno di amici influenti per il riciclaggio del denaro sporco attraverso i depositi bancari e persino attraverso la gestione diretta o indiretta delle banche. Per sanare
219
situazioni di emergenza avrà bisogno di decreti di pronto intervento mentre per assicurarsi l’impunità dovrà controllare il più possibile i palazzi di giustizia, influire per le nomine e i trasferimenti nelle questure, nelle prefetture, nei commissariati. Cercherà autorevoli protezioni per condizionare l’operato di ispettori e superispettori della finanza, per scegliere i periti comodi, per far trasferire gli ufficiali corretti e far promuovere quelli corrotti.
1953. Un pozzo di petrolio del giacimento scoperto a Ragusa
220
1953. Contadini transitano nei pressi di una sonda petrolifera a Gela
221
Nelle prime ore di venerdì 4 novembre 1966 l’Arno rompe gli argini e sommerge la città di Firenze. È una drammatica “Cosa di Stato”
222
Roma, 1967. Una vignetta di Mauro Biani
223
La P38 a Milano. Corteo a Piazzale Accursio nel 1971. Il 12 dicembre 1969 una bomba scoppia nella Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana. Sono gli “anni di piombo”, tra terrorismo rosso e nero
Per far tutto questo la mafia avrà bisogno anche della massoneria occulta che l’aiuterà a stringere rapporti con pezzi deviati dello Stato stabilendo cordate e trasversalità che peseranno sul sistema politico italiano. Avrà bisogno di una stampa amica che gestirà disinformazione, di giornali che dicono e non dicono. «La leggenda vuole», ha scritto il giudice Giuseppe Di Lello del pool antimafia «che alcuni strati della classe di governo, per mantenere il loro potere, si siano serviti di una organizzazione criminale, usualmente chiamata mafia, ad essa rimasta sempre esterna, e che quindi si sia prodotto un dualismo tra il potere “legale” dei primi e l’illegalità della seconda. Alla tesi di questo dualismo la magistratura ha aderi-
224
to per lunghi anni contribuendo ad occultare la realtà di due anime che man mano hanno raggiunto una perfetta simbiosi». *** Da una dichiarazione di Tommaso Buscetta nel 1970: «Cosa Nostra viene prima del sangue, della famiglia, delle relazioni del paese. Mi affascinava in quella confraternita il mistero dello spirito d’avventura. Una volta era bello sentirsi amici di persone mai conosciute. Uno andava in una città, in qualunque posto, e veniva accolto, con una lettera di presentazione, come un fratello. Ti accompagnavano, sentivi cos’è l’affetto, un senso profondo di rispetto; e oggi questo grande ideale, fa di due uomini d’onore due dello stesso sangue. Pronti a soccorrersi, a proteggersi l’uno con l’altro in ogni momento di bisogno, con la corsa solo al potere finanziario». Alla domanda «chi è un uomo d’onore», Buscetta così rispondeva: «Uno che non si può offendere, o schiaffeggiare. Uno col quale si può discutere, o al massimo sparargli. E poi è una persona che non mente: non ha interesse a farlo. Le bugie si ritorcerebbero contro di lui». «C’è una nuova procedura per l’arruolamento a cosa nostra?» «Una volta si faceva così: si informavano tutte le cosche, anche per sapere se avevano qualche obiezione da fare. Potevano dire di no: questo è parente di un ufficiale, quest’altro nipote di un magistrato; non c’era posto per chi, in qualche modo, serviva la legge. Poi c’era il banco di prova: e gli davano l’incarico di eliminare qualcuno».
225
Michele Greco, uno dei principali alleati dei boss corleonesi (qui al maxiprocesso del novembre 1985)
226
16 Il denaro delle mafie
Scrive il procuratore generale antimafia Pietro Grasso nel suo libro Soldi Sporchi scritto con il giornalista Enrico Bellavia: INTRODUZIONE Le cifre e l’allarme Non ha odore e non riposa mai. È il denaro delle mafie, corre veloce, cambia posto di continuo e quando si materializza è irriconoscibile. Profuma di fresco e di pulito, candeggiato dopo decine di transazioni, ricompare in circolo come linfa buona per nuovi affari. Rintracciarlo nei forzieri dove sta in ammollo prima di finire nella centrifuga degli scambi e degli acquisti, delle cessioni e delle vendite, è la sfida del nuovo millennio. Governi, non tutti, e analisti si ingegnano a trovare soluzioni, ma dall’altra parte un sistema vive di quei soldi e sa di non poterne fare a meno. È il sistema dell’economia parallela, che si muove nell’ombra per difendere quella fetta di fortuna alla quale deve la propria esistenza e sopravvivenza. Ma il denaro delle mafie non alimenta un circuito chiuso, non genera soltanto nuovi e redditizi traffici criminali. Il riciclaggio non è un accessorio dei reati, non è la parte terminale di un traffico, è il pilastro sul quale sempre di più le organizzazioni criminali edificano le loro opere. I grandi gruppi avviano un’attività solo nella consapevolezza di potere ripulire i proventi. Con i soldi della droga, senza altre mediazioni,
227
si può comprare soltanto altra droga. Gli utili, però, sono alti, i rischi di impresa calcolati e per ogni organizzazione c’è la necessità di immettere quei liquidi nell’economia sana. Per dissimulare ma anche per coronare di sicuro successo i traffici sommersi. Così quel denaro entra nel circuito legale. Si annida dietro formidabili scalate, ascese di tycoon rampanti, sta a difesa dei patrimoni di manager in grisaglia, fa sempre più spesso capolino in Borsa. Rappresenta una holding con migliaia di partecipate e collegate, ha diramazioni in tutto il mondo e schiere di professionisti e consulenti che lavorano per cancellare le tracce della provenienza di quei soldi e per individuare nuove opportunità di investimento. Un’azienda che è rappresentata al tavolo delle decisioni, fa sentire il proprio peso, negozia spesso da posizioni di forza. Con il denaro delle mafie si costruiscono dal nulla fortune e si demoliscono assetti consolidati. L’economia criminale, lo ha ricordato l’ex magistrato Giuliano Turone, è protesa verso la conquista illegale di spazi di potere economico e inquina il tessuto produttivo e gli assetti istituzionali dei Paesi in cui opera. In un sistema corrotto non c’è più spazio per la libera concorrenza, saltano le regole, i valori sono falsati, si creano posizioni dominanti, le istituzioni subiscono effetti che non governano e, in definitiva, non c’è vera ricchezza perché non c’è innovazione. Il denaro delle mafie, semmai, si apposta comodo nei settori più moderni del mercato, dall’energia al riciclo dei rifiuti, e sconvolge anche lì le regole. Impone opere inutili, massimizza il profitto a dispetto della qualità, taglia fuori dal gioco chi avrebbe le carte in regola per parteciparvi. L’avvento dell’euro, la crisi del dollaro, la recessione mondiale, fanno dell’Europa un mercato al quale la holding del riciclaggio guarda con attenzione crescente. In parallelo, mentre l’allerta è massima sui rischi che legano la finanza sporca al terrorismo internazionale, soprattutto dopo l’attentato alle Torri Gemelle, è del tutto inadeguato rispetto al pericolo che la finanza mafiosa finisca per impossessarsi di pezzi pregiati dell’economia dei Paesi occidentali. Dalle grandi aziende, alle banche, governando il destino di milioni di cittadini inconsapevoli di maneggiare denaro sporco.
228
Stefano Bontade un gran mafioso democristiano ed un distinto massone, forse l’ultimo autentico Padrino. Ucciso dai “Corleonesi”, nell’aprile 1981
229
Senza il riciclaggio, il denaro delle mafie sarebbe un ricavato inerte. Perché il crimine si rafforzi è necessario che quel denaro torni in circolo, diventi lo strumento attraverso il quale tessere una rete di relazioni che coinvolge broker e professionisti, intermediari ed esperti che prestano la loro opera per la costruzione di architetture complesse e per la selezione della schiera di prestanome. Dal riciclaggio spicciolo, dal reinvestimento nel mattone, fino alla creazione di fiduciarie estere, la movimentazione delle fortune dei boss è una parte rilevante dell’economia planetaria. Secondo il Fondo monetario internazionale il denaro sporco muove tra i1 3 e il 15% del Pil del pianeta, pari a una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli Usa, come dire: l’intera economia italiana. Lo studioso americano Dale Scott, ex diplomatico ed ex insegnante a Berkeley, nel suo American War Machine, citando fonti del Senato americano, sostiene che il riciclaggio bancario muoverebbe tra 500 miliardi e 1000 miliardi di dollari, con la metà incanalatí verso il circuito bancario americano. La gran parte proverrebbe proprio dal traffico di droga che è appena dopo il petrolio e prima del commercio di armi per volume di traffici. In Italia, ogni giorno, l’industria del riciclaggio produce 410 milioni di euro, 17 milioni l’ora, 28,3 mila euro al minuto, 4,7 euro al secondo. Bankitalia stima che rappresenti da sola il 10% del Pil, attestatosi di poco sopra a 1500 miliardi di euro. Con un fatturato di 150 miliardi di euro, dunque, la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come Eni, che con i suoi 120 miliardi è in cima alle classifiche della produzione italiana e tra le venti maggiori imprese internazionali. La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit, fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di un’azienda di credito come Intesa San Paolo. La gravità della situazione è tale che da Palazzo Koch si è levato un vero e proprio grido al quale è seguito un assordante silenzio della politica. «Il riciclaggio – ha detto il vice direttore generale Anna Maria Tarantola – è una sfida per il Paese». In gioco è «la tutela dell’integrità del sistema finanziario». In 17 cartelle, al master sull’etica della pub-
230
blica amministrazione e sul contrasto alla corruzione, tenutosi a Roma alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, il 10 maggio 2011, ha condensato un’analisi dei guasti del sistema, indicando possibili correttivi, in un quadro che pure vede triplicare il numero di segnalazioni sospette da parte di istituti bancari, intermediari e professionisti. Dagli allarmi scaturiscono accertamenti e indagini. Si tratta in massima parte di violazioni fiscali, non di ipotesi di riciclaggio, e molte vengono trattate in sede amministrativo-finanziaria. In media solo il 20%, come documentato dalla Guardia di Finanza, confluiscono poi in procedimenti penali.
1970 – 1975. Operava a New York, la mafia americana dei Gambino, che teneva i rapporti con l’Italia
231
17 Mafie e terrorismo
Scrive Pietro Grasso: Sul denaro delle mafie ruota una fetta importante dell’economia mondiale. Sui traffici che determinano quelle fortune si gioca la partita degli assetti geopolitici del pianeta. La droga, il business illegale per eccellenza, muove interessi da capogiro e intorno alle rotte dell’oppio e della cocaina, mentre governi ed eserciti si fanno la guerra, nuovi e vecchi gruppi di potere mettono a frutto gli sconvolgimenti trovando il modo di trarre profitto anche dai conflitti. In definitiva, buona parte delle guerre a cavallo tra i due secoli hanno mosso interessi criminali paralleli agli obiettivi ufficiali, hanno costretto le organizzazioni a riposizionarsi e a variare le partnership con l’unico obiettivo di trarre il massimo dell’utile dalle mutate situazioni contingenti. Si prenda il caso dell’Afghanistan, per esempio. Nel 2009 il cambio della guardia alla guida delle forze Usa ha impresso una decisa sterzata agli obiettivi militari e strategici dell’impegno Nato. Sulla base di un documento del Pentagono dopo l’era di Donald Rumsfeld anche i signori della droga sono entrati al fianco dei membri di Al Qaeda nella lista dei 367 ricercati da catturare «vivi o morti», dal momento che secondo Cia e intelligence militare i talebani ottenevano in media 70 milioni di dollari all’anno proprio dalla droga. Sempre lei, la lingua di tutti gli scambi, capace di abbattere ogni barriera e di far intendere terroristi fanatici e mafiosi rapaci, di tradurre ogni interesse a dispetto delle differenze e diffidenze di etnia, religione e lingua.
232
Lo ha dimostrato ancora un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli del maggio del 2011 riassumibile nel paradigma: droga per armi, armi per droga. La droga partiva dal confine tra Pakistan e Afghanistan, in quelle aride montagne e polverose valli che da dieci anni vediamo percorse da soldati occidentali e talebani in pick–up e kalashnikov. Arrivava in Italia con i corrieri pakistani lungo la rotta terrestre, nascosta dentro i carichi di merce. Qui finiva nelle mani di un clan ghanese dell’etnia Dagomba, con basi anche a Bologna e Varese, che la piazzava lungo il litorale domizio. I pakistani, originari della provincia di Peshawar, incassavano i soldi della droga e li mandavano in patria con rimesse continue servendosi degli ormai imprescindibili money transfer. Quel denaro serviva ad alimentare due traffici di un clan Pashtun: le armi per la fazione jihadista del gruppo armato legato al movimento ‘Tehreek e Nafaz e Shariat e Muhammad agli ordini del leader filotalebano, il mullah Maulana Fazlullah nella valle dello Swat, in Pakistan, e l’arrivo in Italia di altri immigrati pakistani che a loro volta, dopo essersi stabiliti a Napoli, Frosinone, Roma, Macerata, Milano, Oristano, Cagliari e L’Aquila, con il sistema dei visti per motivi di lavoro, si mettevano in affari con l’organizzazione che aveva basi anche in Spagna e Gran Bretagna. Un circuito che si scoprì la prima volta nel 2007 con un’indagine sulla colonna bolognese e che fino a metà del 2011 ha prodotto arresti e sequestri con un aggiornamento periodico delle attività del clan. Il gruppo fa capo a Shariq ur Rehman Syed, arrestato in Pakistan nel 2008 e condannato a 18 anni. Ma in Patria, l’attività di Shariq ur Rehman Syed è stata tenuta in vita dagli altri componenti del clan, compresi il padre e il fratello del trafficante che avevano continuato a organizzare il traffico lungo la rotta che dalla provincia afghana di Nangarhar, dove la droga veniva prodotta, arrivava fino alle famiglie pakistane trasferitesi a Napoli, Macerata oltre che a Bologna e a Roma. Dall’analisi della documentazione ottenuta con le perquisizioni è iniziato un lavoro di scavo per ricostruire il meccanismo inverso che porta i soldi nelle tasche dei terroristi attraverso i circuiti finanziari occulti e il travaso del denaro liquido sui conti internazionali che alimentano le centrali del terrore. Altre città, altre nazionalità, ma sempre la droga come veicolo
233
per finanziare il terrorismo. A Milano, la magistratura si è interessata all’attività di due tunisini, Adel Ben Mabrouk e Ben Mohamed Riadh Nasri portati in Italia dalla prigione di Guantanamo nel 2009. Avrebbero svolto attività di reclutamento in Italia per almeno 4 anni occupandosi della rete necessaria a spedire i mujaheddin provenienti dall’Italia nei campi militari per essere utilizzati in azioni suicide. Nasri, da Jalalabad, avrebbe tenuto i contatti con l’Italia, dove aveva vissuto stabilendosi a Bologna e dove era stato anche condannato per spaccio di monete false. Quando era in Italia, del resto, Nasri si era lungamente occupato dei finanziamenti alla rete ed era stato poi arrestato dagli Usa in Afghanistan. Adel Ben Mabrouk, invece, aveva come base Milano e la moschea di viale Jenner dove lavorava come barbiere ed era coinvolto direttamente in un traffico di stupefacenti. L’anno precedente, sempre a Milano, era emerso un giro di altri tre tunisini arrestati in precedenza per sospetti di attività terroristica, poi entrati nel traffico della droga con l’obiettivo di reperire fondi per la Jihad. Si tratta di Hammadi Ben Abdelaziz Bouyahia, del fratello Maher, e di Kamel Ben Mouldi Hamraoui, residente a Brescia, tutti condannati a pene tra i sei e i tre anni nell’ambito di precedenti inchieste sul terrorismo. Una volta liberi avrebbero stabilito un asse con Adel Jelassi – trafficante tunisino con base a Milano considerato il capo di un’organizzazione criminale che aveva contatti con gli estremisti – per mettersi in affari con la droga. Non sono che alcune delle indagini che hanno messo a nudo, con epicentro ancora l’Italia, quello che gli esperti conoscono bene da molti anni e che ha convinto la polizia europea a lanciare un vero e proprio allarme sui rischi dell’asse droga-terrore. Ad aprile del 2011, la polizia Europol, nel rapporto annuale alla commissione libertà civili di Bruxelles, ha ipotizzato che nel flusso di migranti che arrivano in Europa dalle coste africane si possano nascondere terroristi, anche in considerazione delle rivolte scoppiate in tutti i Paesi della fascia Nord del continente africano. Se da un lato l’organizzazione terroristica di Osama Bin Laden sembra essere in difficoltà, dall’altro, secondo Europol, non è escluso che frange possano rafforzare la loro presenza in Europa attraverso i canali della criminalità. Elementi singoli entrano in contatto con le mafie
234
dei loro Paesi d’origine inserendosi nel traffico di droga e di armi, nel commercio di esseri umani e naturalmente nel riciclaggio dei proventi. Europol indica due gruppi su tutti, i guerriglieri curdi del Pkk e l’organizzazione terroristica delle tigri Tamil in Sri Lanka e traccia un bilancio delle indagini svolte nei Paesi europei lungo i12010: 179 persone legate al terrorismo islamico arrestate, con un aumento del 50%. La maggior parte degli arresti, 94, è avvenuta in Francia, 19 in Olanda, 14 in Romania, 11 in Spagna e Belgio, 9 in Germania, 6 in Danimarca, 5 in Irlanda e 4 in Italia, il resto disseminati negli altri Stati membri. Ma nel nostro Paese, considerando anche i gruppi non islamici, per reati legati alla rete di finanziamento al terrorismo, nel 2010 sono state arrestate altre 25 persone, la gran parte delle quali legate a organizzazioni separatiste non strettamente religiose, 8 legati a gruppi di estrema sinistra e uno di estrema destra.
“La Repubblica” 14 gennaio 2015
235
“La Repubblica” 14 gennaio 2015
“La Repubblica” 14 gennaio 2015
236
“La Repubblica” 14 gennaio 2015
237
7 gennaio 2015. Due uomini entrano nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo nel centro di Parigi e fanno una strage invocando Allah. E questa è una drammatica “Cosa di Stato”
238
11 Febbraio 2015. È “Cosa di Stato”
239
18 Stragi non solo di mafia
L’uccisione a Palermo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, il 3 settembre del 1982, confermerà l’esistenza di rapporti della mafia con settori dei servizi deviati e con strutture occulte ed eversive alle quali era solita offrire la più ampia collaborazione nell’esercizio del suo potere. Dalla Chiesa era stato “mandato” a Palermo, dal governo di allora, con l’incarico di prefetto con funzioni antimafia, ma senza i necessari poteri ripetutamente da lui richiesti e ripetutamente negati. Al tradimento del governo, al tradimento delle istituzioni, all’indifferenza dello Stato, al rifiuto di ogni sostegno in una Palermo nelle mani della mafia, seguì il suo atroce assassinio e quelli della moglie e dell’agente di scorta. Sapeva Dalla Chiesa i segreti del memoriale di Aldo Moro da lui scoperto nel covo delle Br di Via Montenevoso. “Segreti di Stato” che non doveva rivelare, nei quali poteva intravedersi un collegamento operativo tra ambienti delle lobby internazionali, della criminalità organizzata, della massoneria (P2), dei settori dei servizi “deviati” e di una struttura segreta paramilitare nata con funzioni antinvasione, ma che aveva debordato in azioni illegali per destabilizzare il quadro interno del Paese. E fu così che la gente sospettò che un fedele servitore dello Stato era stato mandato allo sbaraglio solo per essere ammazzato. E si parlò dei suoi contatti con il giornalista Mino Pecorelli, direttore della rivista O.P., a conoscenza pure di quei segreti, ucciso da Cosa Nostra il 20 marzo del 1979. Dalla Chiesa e Pecorelli dunque, due delitti
240
che ruotano intorno allo stesso mistero coperto e depistato: i segreti ancora intatti del sequestro e del delitto di Aldo Moro. Ne Il golpe di Via Fani, lo studioso Giuseppe De Lutis, nel delineare motivazioni internazionali nell’assassinio del presidente della Dc, ha scritto: «L’ipotesi di una confluenza di interessi a livello planetario per l’eliminazione di Aldo Moro e del progetto di compromesso storico è ritenuta verosimile da persone che hanno avuto accesso a un livello molto alto di informazioni, dunque da esaminare con molta attenzione. Se gli Stati Uniti avevano la necessità, soprattutto sul piano militare, che fosse scongiurata l’ipotesi di un governo a partecipazione comunista (che Moro stava per varare; n.d.a. ) sia pure limitata… l’Unione Sovietica non poteva tollerare l’eventualità che si rafforzasse quello che allora si chiamava eurocomunismo, cioè quello dei partiti comunisti italiano e spagnolo, che accettavano totalmente le regole democratiche. Nel 1956 e nel 1968 erano state represse nel sangue le aspirazioni degli ungheresi e dei cecoslovacchi a realizzare propri esperimenti di questo tipo. Un governo a partecipazione comunista in Italia avrebbe fatto risorgere aspirazioni simili in molti paesi dell’Europa Orientale, e questo rischio non poteva essere corso». E ancora: «settori del Vaticano si mossero per la salvezza di Moro, i servizi segreti italiani brillarono per la loro passività, il mondo politico si divise nel partito della fermezza e in quello della trattativa. In quello della fermezza si riunirono coloro che avevano come obiettivo la salvezza del quadro costituzionale che rischiava di essere travolto, ma ci fu probabilmente chi per fermezza intese stare fermi e lasciare che vi fosse un epilogo tragico. Fu la scelta strategica della P2, che dominava i servizi segreti di allora. Il partito della trattativa era stato composto certamente da persone, soprattutto di estrazione cattolica, che tentarono disperatamente di salvare la vita di Moro. Ma vi erano anche uomini politici che giocarono questa carta per perseguire un loro obiettivo: quello di impedire che si saldasse un’alleanza politica tra Dc e Pci, e per raggiungere questo scopo usarono spregiudicatamente i contatti e i legami che avevano da tempo stabilito con alcuni settori della galassia eversiva, e quindi anche con Cosa Nostra
241
che gestì, con la dovuta “spietatezza”, l’eliminazione, prima di Mino Pecorelli e dopo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un fedele servitore dello Stato». Nel corso degli anni ’80, con il superamento del bipolarismo e l’accresciuta reattività dell’opinione pubblica verso i fatti di corruzione e di malversazione si sono notevolmente innalzati i rischi per la mediazione e per la protezione degli interessi mafiosi in sede politica. Ed ecco che nel 1992 l’allora ministro degli interni Scotti è costretto ad ammettere: «Caratteristica fondamentale di Cosa Nostra è la sua tendenza al confronto da pari a pari con lo Stato ed i suoi rappresentanti, nonché l’infiltrazione in esso, tramite relazioni occulte con esponenti dei suoi apparati e degli organismi elettivi, fino alla neutralizzazione, tramite corruzione e violenza, di chiunque si opponga al suo strapotere… Cosa Nostra costituisce solo il segmento, il livello piú nascosto, profondo e pericoloso di ciò che viene chiamato mafia: a causa della sua capacità di confronto-scontro diretto con l’autorità legale che deriva dalla sua collaudata attitudine verso la manipolazione, l’assoggettamento di uomini ed istituzioni…». Esponenti del governo non si erano mai espressi con questa nettezza né la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia aveva mai votato, quasi unanimemente, una relazione come quella approvata i1 6 aprile 1993, sui ‘Rapporti tra mafia e politica’. Un documento di grande spessore e di valore storico che non si proponeva la pura e semplice dimostrazione di questi rapporti, bensí di cogliere i caratteri che essi avevano, le condizioni che li hanno favoriti, il modo in cui si sono diversificati nel corso delle fasi politiche, i fattori che li hanno resi così determinanti in alcuni momenti della vita politica siciliana e nazionale. Anche sul versante della strategia della tensione e dei rapporti tra l’eversione, i poteri occulti e pezzi deviati dello Stato, la magistratura ha tentato invano di ricomporre le tessere di un mosaico che avrebbe consentito di leggere i fatti che hanno intessuto la storia del nostro Paese, per individuare i responsabili delle stragi. Fino a non molti anni fa le conoscenze delle strutture organizzativo-funzionali di Cosa Nostra sono state frammentarie e inadeguate e, correlativamente, episodica e discontinua è stata l’azione repressi-
242
va dello Stato, diretta prevalentemente a colpire, con risultati assolutamente deludenti, le singole manifestazioni criminose viste in un’ottica parziale, disancorata da una piú ampia visione unitaria del fenomeno mafioso. Sono gli anni delle ripetute sconfitte della giustizia e dei conseguenti ‘successi’ che Cosa Nostra ha colto con le scandalose assoluzioni dei boss, nei processi di Bari e di Catanzaro, a metà degli anni ’70. È stato, per primo, il giudice Rocco Chinnici ad intuire la sostanziale unicità dell’organizzazione mafiosa e ad impostare istruttorie che tenevano conto di questa realtà. A continuare il lavoro di Chinnici dal punto in cui fu costretto a interromperlo, in quanto assassinato dalla mafia, sono stati Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e gli altri giudici del pool antimafia la cui sentenza-ordinanza del 16 agosto 1986 parlava di «un rinnovato impegno investigativo, assistito da una professionalità più qualificata e da tecniche di indagine più sofisticate, che ha prodotto un corretto approccio al fenomeno mafioso, ispirato dalla riconosciuta necessità di inquadrare gli specifici episodi criminosi nella logica e nelle dinamiche della organizzazione criminale di cui sono espressione». Anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno pagato con la vita questo corretto approccio al fenomeno mafioso nell’ambito della nuova strategia, che partiva dal presupposto che la mafia è reato in sé, indipendentemente dalle singole manifestazioni criminali. *** Lo spartiacque costituito dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992, non ha garantito di per sé il definitivo avvio della rottura dei rapporti tra mafia e mondo politico ed economico. Le vecchie condizioni oggettive, infatti, non hanno determinato quei rapporti in modo automatico, inevitabile; le convenienze, mascherate dietro l’alibi delle condizioni oggettive, non sono state certamente sradicate e restano in agguato. Una considerazione, questa, molto realistica, che ha trovato una concreta conferma anche nella serie di attentati a Roma, Milano e Firenze, messi in atto nel luglio del ’93, probabilmente suggeriti a Cosa Nostra da certi gruppi di potere con l’avallo di settori deviati dei
243
servizi segreti, per intimidire lo Stato e condizionare il rinnovamento politico e istituzionale del nostro Paese; per avvertire anche la Chiesa (attentati a Roma), con un segnale rivolto a Giovanni Paolo II che, nel suo viaggio in Sicilia nel maggio del ’93, aveva lanciato il suo anatema contro la mafia. Il Pontefice aveva tenuto diciotto vibranti discorsi in cui aveva definito martiri i morti di mafia e paragonata questa al diavolo. Per la mafia, la Chiesa e i sacerdoti sono i concorrenti diretti per il controllo del territorio. Non per niente “Cosa Nostra”, come scriveva Giovanni Falcone, «ha la forza di una Chiesa e le sue azioni sono frutto di una ideologia e di una subcultura». Essa sa quanto i sacerdoti possono muovere le coscienze in una terra dove la Chiesa rappresenta l’unica autorità che riscuote maggior credito. Per questi motivi la mafia non ha accettato l’altissima denuncia del Papa ed ha ammazzato sacerdoti come don Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio, il quartiere palermitano dove il coraggioso prete si opponeva alla violenza mafiosa.
Il giudice Giovanni Falcone
244
La situazione di sofferenza in cui si è venuta a trovare negli anni ’80 Cosa Nostra scaturí innanzitutto dal vasto fenomeno del pentitismo promosso dalle leggi premiali. La tesi della indispensabilità dei pentiti è ineccepibile. Le polizie di tutto il mondo hanno sempre usato, per combattere la criminalità, i ‘confidenti’ o informatori che erano e sono, in buona sostanza, dei ‘pentiti’ (collaboratori di giustizia) che non invocano alibi morali o problemi di coscienza, ma che ammettono di servire la polizia per qualche interesse economico o d’altro genere. È un fatto incontestabile che il ‘pentitismo’ in Italia ha consentito di sconfiggere il terrorismo. I buoni risultati ottenuti hanno suggerito di trasferire l’esperienza ai fenomeni di criminalità organizzata, a cominciare dalla mafia. Anche su un terreno cosí diverso il ‘pentitismo’ ha permesso di raggiungere obiettivi molto importanti quali ad esempio la conoscenza dell’organizzazione di Cosa Nostra e la cattura di vari boss mafiosi. Tommaso Buscetta aveva previsto in tempi non sospetti una campagna di disinformazione gestita da Cosa Nostra, da settori del mondo politico e della stampa, finalizzata a screditare il ruolo dei ‘pentiti’. Aveva avvertito che, fino a quando detta campagna fosse stata in corso, gli attentati sarebbero stati sospesi per ricominciare successivamente. La ripresa della strategia stragista – secondo Buscetta – sarebbe stata improntata alle metodologie proprie dei narcotrafficanti colombiani con l’utilizzo di bombe contro innocenti e con l’attivazione di attentati contro alte cariche dello Stato. Dopo le stragi del 1992, seguirono di certo patti e ricatti tra la mafia e lo Stato italiano. Preoccupate per quello che stava succedendo a certi personaggi delle Istituzioni, le stesse trattarono col vertice di Cosa Nostra per porre fine alla strategia stragista portata avanti dal sanguinario Totò Riina in risposta alla norma sul carcere duro (art. 41 bis), agli espropri sempre piú consistenti dei patrimoni dei boss e al fallimento della campagna di delegittimazione dei pentiti. È del tutto comprensibile che dietro la cattura di Riina, (avvenuta il 15 gennaio 1993) ci sia stata una messa fuori giuoco dei corleonesi stragisti a favore del più ‘moderato’ Provenzano. Ipotesi questa che spiega il motivo per cui il covo di Riina non fu perquisito dai carabinieri del ROS che lasciarono il campo a coloro che avevano tutto l’interesse a
245
ripulirlo di ogni documento compromettente. Piú che il mistero fu la “ragion di stato” a suggerire la cosa. Per rispondere alla polemica sul “terzo livello” Giovanni Falcone aveva scritto: «Questi crimini eccellenti, su cui finora non si è riusciti a fare interamente luce, hanno alimentato l’idea del terzo livello, intendendosi con ciò che al di sopra di Cosa Nostra esisterebbe una rete, ove si anniderebbero i veri responsabili degli omicidi, una sorta di supercomitato, costituito da uomini politici, da massoni, da banchieri, da alti burocrati dello Stato, da capitani di industria, che impartirebbero ordini alla Cupola. Questa suggestiva ipotesi, che vede una struttura come Cosa Nostra agli ordini di un centro direzionale sottratto al suo controllo è del tutto irreale e rileva una profonda ignoranza dei rapporti tra mafia e politica». Nel 1992, in piena Tangentopoli, mentre stava crollando sotto i colpi della magistratura il vecchio sistema dei partiti, ed era da poco crollato anche il muro di Berlino e con esso la pregiudiziale che escludeva le forze di sinistra da qualsiasi ipotesi di governo, si dava ormai per scontata la loro scalata alla guida del Paese. Una ipotesi questa assolutamente non gradita da quella zona grigia fatta da massoneria, servizi deviati, mafia e stampa compiacente che spesso ritroviamo nella nostra storia più recente. Cosí con l’avallo di settori deviati dei Servizi segreti, Cosa Nostra sferrò un attacco mortale ai principali rappresentanti dell’antimafia Falcone e Borsellino. Le nuove elezioni che dovevano esser vinte dalla sinistra approderanno a soluzioni diverse ed inattese. Dopo il 1992, la magistratura stava per conseguire importanti successi contro la mafia, la politica collusa, e contro la corruzione. La pista seguita dagli investigatori portò ad alcuni leader politici accusati di proteggere i mafiosi e ad altri di essersi appropriati di denaro pubblico. Due azioni “storiche”, sui “capisaldi” di Palermo e di Milano, che hanno creato grandi speranze di risanamento della società italiana. Ma questa vigorosa reazione contro la mafia e contro la corruzione venne bloccata da “certi poteri” che hanno rappresentato una sorta di continuità di quel sistema che ha condizionato l’intensità della lotta contro le “mafie” e le “eversioni”, lotta che si è rivelata incostante
246
nel corso degli anni piú recenti fino a limitarsi alla repressione di fatti emergenti. D’altra parte la strategia messa in atto da Cosa Nostra punta da qualche tempo, nella sostanza, al dialogo con la politica e con le istituzioni allo scopo di poter gestire con tutta tranquillità i suoi notevoli affari illeciti che alimentano grosse attività legali che fanno della mafia la piú grossa impresa italiana. Questo spiega la mancata cattura del boss dei boss Bernardo Provenzano latitante da 43 anni, braccato finalmente dalle forze dell’ordine nell’aprile del 2006 in uno sperduto casolare di Corleone, vicino Palermo. La lunga latitanza del boss dei boss, colpevole di una incredibile sequela di omicidi e di stragi, fa pensare all’esistenza di un “Patto” tra mafia e pezzi dello Stato e con un certo sistema politico e imprenditoriale; un patto di “non aggressione” che ha impegnato i mafiosi a mettere fine alla strategia stragista e lo Stato a non interferire nei loro affari. È stato agli inizi degli anni ’90 che le organizzazioni criminali come Cosa Nostra hanno cominciato ad ampliare a dismisura il loro raggio d’azione acquisendo una dimensione transnazionale. La trasformazione si è consumata con l’affermazione del dogma liberista nella politica del Fondo Monetarlo Internazionale e della Banca Mondiale, già alla fine degli anni ’80. La globalizzazione dell’economia e della finanza ha di fatto determinato la deregolamentazione dei mercati finanziari e commerciali, la privatizzazione dei servizi ed il rafforzamento dei paradisi fiscali, fenomeno questo cha ha dato origine ad una sorta di compromesso tra la cosiddetta economia legale e l’economia criminale. In pratica s’è consumata la vocazione criminogena della globalizzazione liberista che ha favorito la riorganizzazione dei poteri criminali, a tutto vantaggio dei loro affari nel traffico internazionale di armi, di droga e nel riciclaggio di denaro sporco. La ripresa delle attività belliche in varie parti del mondo (Balcani, Afghanistan, Colombia ecc.) ha portato a un perverso intreccio tra guerre e globalizzazione liberista conseguentemente a un incremento “planetario” degli introiti delle mafie internazionali, specialmente degli utili derivanti dalla droga, il cui valore complessivo, secondo il competente Osservatorio europeo, sarebbe compreso fra i1 2 e i1 5 per cento del Pil mondiale. A ciò va aggiunto il traffico di armi, di
247
rifiuti, di esseri umani e la contraffazione di prodotti, i cui guadagni, immediatamente riciclati, vengono immessi nel mercato legale. Oggi Cosa Nostra ed altre mafie in Italia, incidono per il 30 per cento nel sistema finanziario. La mafia investe in borsa riuscendo ad incrementare le proprie ricchezze in relazione alla notevole capacità di immettere denaro sporco nei canali leciti. Oggi Cosa Nostra, prima impresa italiana, è una potente multinazionale in grado di investire in ogni parte del mondo ingenti capitali su svariate attività legali. Oggi, quelle lobby della politica, della finanza e della imprenditoria, che da sempre ne hanno condiviso affari e potere economico–politico, al cospetto della sua forza “planetaria” hanno piú forti motivazioni per farne parte e condividere ancora affari e potere con grave danno per la nostra democrazia. In realtà, a partire dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, sono cambiati i rapporti tra Cosa Nostra e la politica, essendo ormai decadute le vecchie alleanze essenzialmente fondate sull’anticomunismo criminale. Per la mafia è venuto il momento di aprire un nuovo capitolo con nuove alleanze e nuovi rapporti di forza. Di conseguenza 1’organizzazione mafiosa ha deciso una strategia che, da un lato limita l’utilizzazione di mediatori nei suoi rapporti con la politica, dall’altro punta sull’entrata diretta in alcuni partiti e nelle istituzioni con uomini di sua fiducia, con l’obiettivo primario di utilizzare la politica per indirizzarne l’azione, conquistare potere economico e guadagnare l’impunità. Abilmente Cosa Nostra è riuscita a scaricare sulla “mafia militare” ogni responsabilità politica sui delitti e sulle stragi, per costruirsi un alibi perfetto. Sulla scena del nuovo millennio, la mafia borghese, ovvero i “sistemi criminali” di Cosa Nostra, ha stabilito nuovi rapporti con la politica, consolidato nuove alleanze, abbandonato le stragi, ridotto gli omicidi. Si è resa invisibile nella illecita gestione del potere, trasmettendo con la cattura di Bernardo Provenzano, l’immagine della propria fine allo scopo di restare protagonista senza mai apparire e di infiltrarsi nella grande zona grigia della politica che fonde e confonde tutto. D’altra parte, la nuova legge elettorale del 2005, che ha precluso agli elettori la possibilità di scegliere, attraverso il voto di preferen-
248
za, i candidati da mandare al Parlamento, lasciando questa scelta al sistema dei partiti, ha di fatto sottratto al popolo sovrano ogni valutazione selettiva e qualitativa dei propri rappresentanti. Una legge elettorale che è una prova inconfutabile di come nella politica italiana certa classe dirigente, al di là dei distinguo, oltre ad essere diventata una “casta” di intoccabili ingorda di potere e privilegi, ha preteso con estrema arroganza il diritto esclusivo di portare in Parlamento “amici” e “amici degli amici”, anche se con precedenti giudiziari di mafia e corruzione. Un vero “colpo di mano” che ha tolto valore alla nostra democrazia e favorito le zone grigie della politica. Da Corleone al Parlamento dunque; un percorso che Cosa Nostra conosce bene e che vuole coprire senza clamore per non destare l’attenzione della cosiddetta società civile, con un crescente numero di parlamentari “portati” a Roma dopo aver “concesso”, previa contrattazione, il suo appoggio. Una lenta e inarrestabile conquista del potere resa possibile dal silenzio delle istituzioni, dei media e, soprattutto, grazie alla debolezza della democrazia in Italia. Tutto ciò dimostra che la lotta alla mafia, divenuta più problematica, non può essere delegata solo alla magistratura, alle forze dell’ordine e alla politica. Deve essere una lotta di tutti rivolta ad affermare la cultura della legalità, il valore delle regole della convivenza civile e del rispetto della vita; una battaglia di civiltà che può essere vinta. Una battaglia civile per rivendicare con forza un nuovo rapporto tra partiti, elettori, realtà sociale, per dare un senso compiuto alla parola democrazia. La mafia non è una emergenza ma una piaga profonda ed è assolutamente necessario, per dare un senso alla morte di Falcone, Borsellino e di tanti altri martiri uccisi per mano mafiosa, isolare la mafia dalla rete di protezione che ne ha permesso l’impunità e le lunghe latitanze di Riina e Provenzano. A oltre venti anni dalla strage di Capaci e a quasi dieci anni dalla cattura di Provenzano ancora non si conosce la verità sui mandanti occulti (esterni a Cosa Nostra) delle stragi del ’92 e del ’93. Quel pool di magistrati valorosi che, superato il momento di emergenza stava per alzare il tiro delle indagini, investendo pezzi di quella classe dirigente che ha fatto affari con Cosa Nostra, è stata oggetto, da parte
249
di “certi poteri”, di una poderosa campagna di stampa di denigrazione dei collaboratori di giustizia e, contestualmente, di una diffusa “sterilizzazione” legislativa, che hanno finito per vanificare ogni lodevole sforzo per arrivare a quella verità negata. C’è una parte del paese che non vuole la verità e vuol continuare a fare affari con quella mafia che ha le leve del potere ed è una componente organica del sistema di potere del nostro Paese. Il bilancio della lotta a Cosa Nostra – se si eccettua il lavoro di Falcone e Borsellino e del pool antimafia – è stato fino ad oggi drammaticamente carente e pieno di chiaroscuri e troppi silenzi. Segno tangibile delle responsabilità politiche che hanno messo in discussione la credibilità dello Stato è l’inadeguatezza della vigente legislazione antimafia non sufficientemente organica e talvolta contraddittoria. È dunque urgente che il Parlamento approvi un testo unico antimafia che dia, attraverso una legislazione armonica ed efficiente, un segnale forte e inequivocabile. Una legislazione che riservi particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale nonché ai temi della espropriazione rapida e concreta dei beni della mafia e dell’antiriciclaggio, in modo da creare contro la “mafia finanziaria” un’“antimafia finanziaria”. Amara e significativa è stata l’accusa che gli studenti di un liceo di Palermo, provocatoriamente, hanno lanciato alla politica, gridando che la mafia è più forte dello Stato. E va pure detto con profonda amarezza che Palermo della rivolta morale contro il potere mafioso, Palermo della gente onesta è convinta che le idee di Falcone e di Borsellino e le loro tensioni morali non hanno camminato fino d oggi sulle gambe dei politici e dei nostri governanti. La mafia del nuovo millennio ha cambiato pelle in silenzio. È la “mafia invisibile” che consolida il controllo territorio, annoda nuove alleanze, abbandona le stragi. È scomparsa per vincere, per restare protagonista senza mai apparire, per entrare nella zona grigia della politica e degli affari che fonde e confonde tutto. Molte stragi, da Portella della Ginestra in poi; sono rimaste impunite con grave danno per la credibilità delle nostre istituzioni e della nostra democrazia. Ha giocato il “segreto di Stato”, il segreto apposto in maniera subdola, strisciante, senza assunzione di una responsabili-
250
tà politica, come invece dovrebbe avvenire secondo le regole della democrazia, La legittimità del “segreto di Stato” avrebbe dovuto trovare le sue ragioni nella sicurezza dei cittadini e della Stato e non, come spesso è accaduto, nella protezione di certi equilibri politici; nell’occultamento di scomode verità; nell’attività di copertura nei confronti degli autori delle stragi e di depistaggio delle inchieste della magistratura; nella gestione di ampie “zone d’ombra” in cui sono allignate piante maligne di diverso ceppo come la P2 e altre consorterie politiche, affaristiche, criminali. Nella realtà dei molti «misteri italiani», con cifre da guerra che non hanno uguali in nessun altro paese europeo, i mandanti occulti di stragi e di delitti sono stati troppo spesso protetti e coperti appunto dalla logica aberrante del «segreto di Stato». L’Italia è stata ed è un Paese diviso, segnato da contrapposizioni ideologiche che nel secondo dopoguerra hanno finito per esasperare l’opposizione fra le diverse appartenenze. A proteggerlo hanno pensato la Nato e la Cia, mentre a spaventarlo hanno provveduto i «Servizi segreti» creando situazioni di allarme, attraverso pericoli di svolte autoritarie, che avessero l’effetto di costruire «consenso» secondo le temperie della stagione politica. Una macchia intollerabile per la nostra democrazia, da cancellare in nome di una legalità ritrovata e nel rispetto delle nuove e delle future generazioni. Tutto ciò premesso chiediamo che venga tolto il segreto di Stato» sui misteri che hanno drammaticamente attraversato la storia del nostro Paese. Per la strage di Portella della Ginestra, che dopo quasi 70 anni non ha ancora avuto né giustizia né verità, chiediamo vengano «desecretati» gli archivi dei Carabinieri, dei Ministeri degli Interni e della Difesa. Chiediamo infine la riapertura di quelle inchieste giudiziarie e di quei processi che non sono arrivati ai veri mandanti occulti i quali hanno goduto della più ampia scandalosa impunità, come nel caso delle stragi del ‘92, di Capaci e Via D’Amelio, per le quali chiediamo l’Istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta .
251
19 La mafia invisibile (dal libro di Saverio Lodato e Pietro Grasso)
C’era una volta la lotta alla mafia? Dalla trattativa con i detenuti alla legge sui pentiti Ci avviamo alla conclusione. Le ipoteche di un lontano passato gravano sugli scenari contemporanei. Lei ha individuato tanti fili neri che dagli anni Cinquanta si dipanano sino alle vicende odierne di mafia, rendendole per tanti aspetti ancora incomprensibili. E ha espresso una previsione: la cosiddetta mafia legale sarà la mafia del futuro. È una conclusione ineluttabile? Abbiamo già visto come in America la mafia sia diventata “legale” già da tanti anni. E come le nuove generazioni hanno abbandonato le strade dell’arricchimento violento e illecito inserendosi completamente nel tessuto sociale, gestendo le attività imprenditoriali più disparate. In Sicilia il percorso sarà più lungo e più lento. Altrettanto inesorabile? I presupposti ci sono tutti: la new economy, le occasioni di investimento, le società quotate in Borsa, la maggiore possibilità di inserirsi nei flussi di danaro pubblico. E ancora: il reinvestimento di profitti illeciti in attività legali, la sinergia tra la mafia, l’imprenditoria e gli amministratori, i rapporti con la politica. Queste sono tutte componenti destinate a proiettare gli interessi criminali su un piano di apparente legalità. È un processo irreversibile.
252
Aumenteranno i guadagni e diminuiranno i rischi? Sarà sempre più difficile scoprire l’origine dei capitali. Sarà sempre più difficile identificare i nuovi mafiosi perché si mimetizzeranno nelle pieghe di una società pulita. Si rafforzerà ancora di più la cosiddetta borghesia mafiosa. L’allarme sociale, rispetto al fenomeno, diminuirà progressivamente. E credo di non esagerare prevedendo un tempo in cui saranno smantellate tutte le strutture antimafia. Saranno considerati superati i corpi speciali, le superprocure, le superpolizie. Troveranno spazio le istanze ipergarantiste, si brinderà alla fine dell’emergenza criminale, trionferanno normalità e normalizzazione. A una totale pax mafiosa corrisponderà finalmente, da parte delle istituzioni, la chiusura definitiva di un’epoca. Calerà il sipario sui protagonisti della mafia e dell’antimafia. Non ci sarà più bisogno di scorte armate, eserciti per le strade, bunker e metaldetector, auto blindate. Saranno definitivamente sepolti tutti i misteri ancora irrisolti. E nessuno si accorgerà che la mafia esiste ancora. Che è riuscita a inabissarsi, a mutare pelle, senza per questo avere smesso di perseguire le proprie finalità. Sarà difficile, come quando Bernardo Provenzano fu arrestato, conoscere il nome del suo successore. Anzi, all’indomani della cattura di Provenzano, ci fu qualcuno pronto a dire che quello era il segnale della resa. All’indomani della cattura di Provenzano, non mancarono i perplessi che denunciarono l’esistenza di una trattativa. Non mancheranno anche quelli che proclameranno la sconfitta della mafia e la fine dell’emergenza. Avverte una grande stanchezza su questo argomento. È così? Sì. Non avrebbe senso nasconderlo. È la stanchezza di chi non può essere eternamente costretto a ricordare. La stanchezza di chi non riesce più a immaginare un proprio impegno contro un nemico diventato così invisibile. La stanchezza di chi – forse sbagliando – riponeva un’eccessiva fiducia nella stagione dei grandi processi. Ma avverto anche il calcolo politico, i silenzi interessati, il desiderio di rivincita contro una magistratura che “pretendeva di riscrivere la storia d’Italia”. Temo che questa stagione non sia troppo lontana.
253
Sono parole senza speranza. In questa fase non riesco ad avere ragioni di ottimismo. Mi lasci dire… Le sembra normale che dopo tutto quello che è accaduto, la mafia torni a dialogare con le istituzioni? È accettabile che si sia data a una belva ferita la possibilità di riacquistare tutta la sua pericolosità? Non è stato forse un errore madornale rinunciare allo scontro finale? Stiamo ancora qui a discutere di Cosa Nostra. Stiamo ancora a parlare di come diventerà la mafia. Quella stessa mafia che, appena qualche anno fa, era in ginocchio per effetto di una repressione costante e mirata. Si è perduta una grande occasione, a metà degli anni Novanta. Oggi siamo a un bivio: o assistiamo indifferenti alla mafia che si nasconde dietro il paravento della legalità o apriamo ancora una volta gli occhi di fronte a un fenomeno secolare che ha spesso dimostrato di avere mille vite. Com’è accaduto che un prezioso patrimonio di conoscenze sia stato dilapidato? Sono guasti che vengono da lontano. Non mi sono mai meravigliato che i mafiosi facessero il loro mestiere. E per mestiere intendo anche le ricorrenti campagne astiose e velenose contro i magistrati, i poliziotti, i carabinieri. Dal nemico ci si aspetta tutto. Ne sapeva qualcosa Falcone che, come abbiamo visto, prima fu delegittimato e isolato, poi fu ucciso. Quello che non ci saremmo mai aspettati sono state le campagne durissime, amplificate dai media in maniera spettacolare, che sono riuscite a far prevalere l’immagine di investigatori prevaricatori e persecutori. Magistrati, in particolare, mossi esclusivamente dal desiderio di condizionare la politica e votati a uno sfrenato protagonismo, piuttosto che al rispetto delle leggi. Perché dovremmo dimenticarlo? Negli ultimi anni, abbiamo assistito a trasmissioni televisive dove, fra il boss mafioso, il pentito che lo accusava e il magistrato che lo aveva processato, a uscirne meglio era senz’altro il mafioso. Gli assassini erano diventati i magistrati. I conduttori dei talk show, in alcuni casi, erano talmente presi dalla campagna denigratoria su pentiti e magistrati da “dimenticarsi” di ricordare al pubblico quali erano i reati che i mafiosi avevano commesso.
254
Poiché la storia centenaria della lotta alla mafia è caratterizzata da scontri e polemiche colossali, non sarebbe ora di cominciare a trarne una lezione? Trascorrono i decenni, ma la lezione, purtroppo, è sempre la stessa. Quale? Le radici di Cosa Nostra non vengono mai estirpate. Alla singolare frase di Pino Arlacchi sulla mafia che avrebbe imboccato il viale del tramonto, lei rispose con durezza che forse «la prospettiva internazionale aveva finito con l’annebbiare la visione nazionale del fenomeno». Analoghe dichiarazioni da parte di Rita Borsellino, Anna e Maria Falcone, Guido Lo Forte e Antonio Ingroia, Gian Carlo Caselli e Giovanni Tinebra. Come mai una simile lettura ha potuto trovare credito in ambienti che dovrebbero essere tanto qualificati? L’assenza di manifestazioni esteriori ed eclatanti ha finito col far perdere la percezione della pericolosità di Cosa Nostra. Siamo abituati a combattere una mafia che spara, che commette stragi, che regola i conti interni lasciando decine di cadaveri sulle strade. Non siamo abituati a fronteggiare la mafia quando s’inabissa, quando tesse una ragnatela di interessi, compromessi e relazioni, quando riscopre la vocazione al dialogo con le istituzioni. È un limite culturale di tutti gli addetti ai lavori. Ma è anche il risultato del consenso attorno a un modello che riesce a garantire vantaggi a tutti coloro che ne rimangono coinvolti. Lei oggi rileva un limite culturale degli addetti ai lavori. Ma non è forse vero che lo Stato ha sempre dimostrato di saper reagire solo di fronte a dichiarazioni di guerra di Cosa Nostra che non potevano essere ignorate? Capisco la sua domanda. Ed è il cuore del problema. Lei ricorda cosa diceva Falcone? Adoperava un paradosso per la verità alquanto macabro. Diceva: «Ci vorrebbe almeno un omicidio eccellente all’anno per potere contare sul massimo impegno di tutte le forze istituzionali».
255
Allora, il rischio che lei vede in questa fase è un rischio di vecchia data? Sì. Ne già abbiamo parlato. Ci vollero le stragi del 1992 per arrestare Riina, Santapaola, i Graviano, Bagarella, Brusca, Aglieri, per ricordare solo i nomi più rappresentativi. Ed erano tutti boss che vantavano lunghe latitanze. Ormai, dopo tutto quello che conosciamo su Cosa Nostra e sulla sua capacità di rigenerarsi, dovremmo aver capito che la logica dell’emergenza ci porta a risultati temporanei che non risolvono il problema. C’è qualcosa di più grave. Sono diventate ricorrenti le voci sulla trattativa che sarebbe in corso, da oltre un anno, fra lo Stato e i boss detenuti. È la prova del nove che con la cosiddetta mafia legale il dialogo delle istituzioni è possibile? C’è un punto di partenza autentico. Alcuni anni fa alcuni boss mafiosi, dal carcere, chiesero di incontrare Pier Luigi Vigna. La richiesta venne accolta. La legge, infatti, prevede che il procuratore nazionale antimafia possa avere colloqui investigativi con i detenuti. Ma erano tutti boss sottoposti al 41 bis, cioè al regime carcerario che prevede il massimo isolamento per i mafiosi. È ovvio che quella richiesta era gravida di conseguenze. Sì. Ma non c’era altra scelta. Si trattava di andare ad ascoltare e valutare le loro richieste. Alcuni di loro, nel manifestare genericamente di non avere condiviso la strategia stragista del ‘92–93, si dichiararono disponibili a dissociarsi pubblicamente. Fra di loro molti sono detenuti proprio per avere partecipato alle stragi. Infatti. Nei colloqui non ammettevano né negavano le loro responsabilità. Non entravano nel merito delle posizioni processuali individuali. Si limitavano a sottolineare che non si sentivano più parte dell’organizzazione. Giustificavano questo nuovo atteggiamento con lo sdegno provato quando ormai le stragi erano avvenute. Ma c’era un problema da risolvere…
256
Alla luce di tutte le sue considerazioni, possiamo concludere che la lotta alla mafia è diventata la grande Cenerentola delle priorità della politica? In tempi non lontani, i periodi di campagna elettorale erano un’occasione unica per presentare importanti proposte sulla giustizia, sulla legalità e sulla lotta alla mafia. Né i programmi elettorali della maggioranza né quelli dell’opposizione contengono oggi specifici riferimenti. Non sentiamo i leader di primo piano confrontarsi sul dramma reale di intere regioni del Sud ancora oggi sotto il controllo delle organizzazioni criminali. In queste regioni si torna a respirare l’aria dell’arroganza e dell’impunità, della prevaricazione e dell’intimidazione. Apparentemente il fenomeno viene stigmatizzato in una miriade di convegni, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni di libri. Ma non si entra mai nel merito della questione. Qual è la questione? La questione è sempre la stessa: non si può guardare alla mafia pretendendo di non indagare nelle zone d’ombra del potere. Nell’Italia dal 2001 tutti sappiamo che continuano a esistere le collusioni, le contiguità, le complicità. E nessun politico può più nascondersi dietro l’alibi di un fenomeno scarsamente conosciuto. Ma allora Tommaso Buscetta non aveva tutti i torti quando affermava che la mafia ha vinto? Oggi, molto di più che in passato, la sopravvivenza di Cosa Nostra dipende dagli orientamenti dell’amministrazione pubblica, della politica, delle istituzioni. La situazione è difficilissima. Ne prese atto, in diverse occasioni, l'allora capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. Ma le sue parole coraggiose e controcorrente finora non hanno trovato da parte dei politici tutto l’ascolto che meritavano. Quando si tratta di lotta alla mafia, maggioranza e opposizione dovrebbero agire di comune accordo. Purtroppo devo constatare che le intese fra i due schieramenti, quando ci sono state, hanno prodotto effetti controproducenti e deleteri. E ciò è accaduto indipendentemente dalle buone intenzioni che possono avere animato i singoli
257
contendenti. Ormai non è rimasto moltissimo tempo a disposizione. Invertire la rotta dovrebbe essere nell’interesse di tutti. In caso contrario, la previsione di Tommaso Buscetta, che vedeva una mafia vittoriosa, è destinata ad avverarsi.
258
20 Cosa nostra ha occupato il nord (L’allarme dei magistrati “La mafia ha occupato il Nord”).
Roma. Le toghe non si smentiscono. Aprono l’anno giudiziario nelle grandi città, denunciano l’incombere di mafia e corruzione, attaccano il governo per le contromisure insufficienti, continuano a sentirsi delegittimate, ma tra loro si dividono. Il guardasigilli Andrea Orlando le rimbrotta perché “la giustizia inefficiente rallenta la crescita”. È di Giovanni Canzio, il presidente della corte d’appello di Milano, la frase più forte della giornata. Decide che la ‘ndrangheta sta occupando il Nord e che non si tratta di una “mera infiltrazione, ma di un’interazione-occupazione nel tessuto dell’economia, della società e delle istituzioni”. Parla di “un’opera distruttiva come le metastasi di un cancro”. Poi l’allarme terrorismo per Expo. Canzio non dimentica “il clima di dileggio verso i giudici”, Ma non spende neppure una parola sul caso Bruti-Robledo. Il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati entra nell’aula magna con i suoi aggiunti, spicca la chioma di Ilda Boccassini, ma Alfredo Robledo non c’è. In compenso, nella relazione scritta, c’è un messaggio su Napolitano che non viene letto in pubblico. Contro la decisione di Palermo di interrogarlo nel processo sulla trattativa stato-mafia Canzio dice: “È mia ferma e personale opinione che questa dura prova si poteva risparmiare alla magistratura, alla Repubblica italiana”. A che gli chiede perché lui minimizza, sono “cose che ho già detto”. Da Palermo, il pm Nino di Matteo non replica.
259
Magistrati contro il governo, e viceversa. Sempre a Milano si misurano l’uno dopo l’altro l’avvocato generale Laura Bertole Viale, protagonista dei processi contro Berlusconi, e il presidente dell’Anm Rodolfo Sabelli. “Non poche norme peccano di distonia, sono irragionevoli”. Bocciate la delega fiscale (quella del 3% per Berlusconi) e delle misure contro la corruzione. Commento amaro: “i protagonisti iniziali si sono ridotti in un misero condensato”. Sabelli boccia “l’aumento delle pene contro la corruzione, la soluzione più facile ma nulla più efficace”. Ma è da Bologna che parte l’affondo più deciso. Il presidente della corte d’appello dice che “le cose sono sostanzialmente rimaste quelle di prima (dei tempi di Berlusconi, ndr) ed è cambiato il metodo, diventato Medicalmente più sottile. Non siamo più additati come disturbati mentali, metti che sono mafiosi, criminali, irresponsabili quelli impegnati in noti processi”. Si arrabbia David Ermini, il re anziano responsabile giustizia del PD: “un’occasione sprecata, solite italiane in difesa dei privilegi” La Repubblica domenica 25 gennaio 2015
260
21 Cosa di Stato al Quirinale
Di certo Sergio Mattarella assunto alla prestigiosa carica di presidente della Repubblica, ha dato una risposta a Cosa Nostra e a quei poteri occulti che il giorno dell’Epifania del 1980 hanno ucciso il fratello Piersanti il quale, da presidente della regione Sicilia stava per passare alla enunciazione di linee programmatiche dirette e ad estromettere mafia e sistemi mafiosi dai gangli vitali della regione. È significativa la frase pronunciata dal presidente uscente Giorgio Napolitano che in merito alla nomina del Sergio Mattarella a Capo dello Stato ha detto: “è una nomina al di sopra delle aspettative!” Così il Giornale di Sicilia descrisse, attraverso la drammatica testimonianza della moglie, l’esecuzione di Piersanti Mattarella in quel lontano 1980: PIERSANTI MATTARELLA “L’omicidio del Presidente della Regione Piersanti Mattarella caduto nel tentativo generoso di dare un volto nuovo alle pubbliche istituzioni e nel momento in cui predisponendo le necessarie riforme stava per passare alla enunciazione di linee programmatiche dirette ad estromettere mafia e sistemi mafiosi dai gangli vitali della Regione costituisce la drammatica riprova della validità della tesi che qui si sostiene”. In un articolo di quel tempo si legge: “Non ditemi che non è cristiano: io quell’uomo e il suo complice
261
non potrò perdonarli mai”. Con un filo di voce Irma Chiazzese, la vedova del presidente della Regione, non lancia un grido di odio ma spiega che non potrà mai dimenticare gli occhi dell’assassino ed un suo attimo di esitazione proprio quando pur avendolo già colpito al cuore, cercava un varco fra i corpi della madre, della moglie e della figlia di Mattarella per mettere a segno quello che doveva essere il colpo di grazia… Quando l’assassino si è trovato faccia a faccia con Irma Chiazzese che stringeva a sé il corpo del marito proteggendone il capo con le sue mani, ha avuto un attimo di esitazione. Stava per premere ancora il grilletto ma gli occhi di questa giovane signora che chiedeva pietà debbono aver aperto un varco nell’omicida. “Non so come sia successo ma lui se ne è andato. L’ho seguito con gli occhi, mi è sembrato che fosse quasi entrato nella macchina che l’aspettava. Stringevo Piersanti e guardavo quell’auto sperando che il Signore li facesse andare via. E invece no: il complice, quello alla guida ha fatto dei gestacci, proprio come se gridasse all’assassino di tornare a sparare. E lui è venuto di nuovo verso di noi. I suoi occhi fissi sui miei, ha esploso l’ultimo colpo. Non potrò mai perdonarlo, né lui né il suo complice”. Così il Giornale di Sicilia descriveva, attraverso la drammatica testimonianza della moglie, l’esecuzione di Piersanti Mattarella avvenuta a mezzogiorno del giorno dell’Epifania del 1980. Per Irma Mattarella, quei terribili attimi erano rimasti impressi nella sua mente come graffiti nella roccia; il dolore s’era annidato negli anfratti del cuore dove è più difficile poterlo assopire. Il volto dell’assassino, il suo sguardo gelido e spietato, gli istanti di inaudita ferocia, tornavano nella sua memoria con mille fotogrammi di angoscia. Dopo il delitto aveva spiegato che non intendeva lanciare un grido di odio, voleva dare al ricordo la forza della rabbia silenziosa, per non dimenticare mai. Piersanti Mattarella divenne presidente della Regione nel febbraio del ’78, un mese prima del rapimento di Aldo Moro e del massacro della sua scorta. Per la Sicilia fu un esito davvero imprevedibile e financo clamoroso se si pensa che si trattava di un uomo “nuovo”, con una visione moderna della funzione pubblica,
262
sostenitore della politica delle carte in regola, che emergeva, con effetto dirompente sul versante dell’amministrazione degli affari, e si poneva all’interno della Dc siciliana come elemento di rottura degli equilibri in larga parte gestiti da gruppi egemoni, quello dei Lima, dei Ciancimino e dei Gioia solidamente attestati nel governo della città di Palermo. L’incarico di consulente giuridico del governo regionale, formato da Mattarella, nei giorni del sequestro Moro, venne affidato a Leoluca Orlando che, a metà degli anni ’80 verrà eletto sindaco di Palermo. “Divenni democristiano – ha scritto Leoluca Orlando – solo perché c’era Piersanti. Forse, però, scelsi la Dc anche per quella mia abitudine a rompere dall’interno il mondo dal quale in un modo o in un altro provengo”. E ancora: “Per me, amico di Piersanti, impegnato nella ‘Lega democratica’ di Pietro Scoppola, di Achille Ardigò, di Paola Gaiotti e di Paolo Giuntella; per me, cattolico, democratico fino al midollo, a Palermo non esisteva la Dc: c’erano, da un lato un elettorato che votava per dovere ideologico, dall’altro un partito interamente condizionato da un comitato d’affari. Il comitato dei Lima, dei Gioia, dei Ciancimino, tutt’uno con i grandi appaltatori di Palermo: i Cassina, i Vassallo”. Dalla lettura degli atti del processo emergono, come ipotesi di causali specifiche, quelle iniziative politiche messe in atto dal presidente Mattarella che più rappresentavano elementi di rottura di certi equilibri ed interessi. La prima indicazione, da un punto di vista cronologico, è data dalla approvazione della legge urbanistica regionale del 1978 che, attraverso nuove regole, incideva notevolmente sul potenziale edificatorio e quindi sul valore economico sia dei territori urbani sia di quelli con destinazione a verde agricolo. A seguito dei nuovi vincoli, il valore commerciale delle aree edificabili diminuiva anche a un terzo o addirittura a un settimo del valore nel caso di terreni agricoli; per questi ultimi era noto l’interesse di Cosa Nostra la cui presenza era ben radicata nelle borgate di Palermo. Nel periodo successivo, proseguendo nell’azione rivolta a perseguire l’obiettivo del rinnovamento e della correttezza, Mattarella promosse una politica molto dura di decentramento di funzioni: 120 miliardi della capacità di spesa dei singoli assessori regionali
263
furono trasferiti ai comuni. Sotto questo profilo istituzionale si collocò l’approvazione della legge regionale numero uno che mirava a ridurre l’ampissima discrezionalità dei singoli centri di spesa e soprattutto dei singoli assessorati, e ad assicurare una maggiore trasparenza e correttezza degli appalti di opere pubbliche.
Piersanti Mattarella nominato Presidente della regione Sicilia nel 1978 e ucciso dalla mafia nel gennaio 1980
264
6 gennaio 1980. Piersanti Mattarella viene estratto moribondo dall’auto dov’era stato colpito a morte anche con l’apporto della mafia
265
Primo atto da Presidente di Sergio Mattarella è stato il doveroso omaggio ai martiri delle “Fosse Ardeatine” Per affermare ancora l’unità europea contro il terrore; a quel tempo il terribile potere nazista; oggi l’Europa libera è esposta a nuovi pericoli e terrorismi. Un atto doveroso del nuovo capo dello Stato nel rispetto della nazione italiana in ogni aspetto delle istituzioni e della storia; una lezione per tutti; una lezione di dignità; una lezione per gli italiani che hanno perduto la fiducia nei governanti e nella politica in generale. Che con Sergio Mattarella al Quirinale hanno un motivo in più per credersi “Fratelli d’Italia” in ogni aspetto della vita d’ogni giorno. La larga maggioranza che lo ha eletto rappresenta una garanzia della centralità del parlamento che ha riconosciuto l’impegno iniziato drammaticamente dal fratello Piersanti Mattarella che, oltre un politico di specchiata onestà, ha rappresentato un “martire” della buona politica e della democrazia. Sergio Mattarella, 12º presidente della Repubblica, ha voluto sottolineare con queste parole la sua idea di socialità e giustizia: “il mio pensiero va alle speranze e alle difficoltà delle famiglie italiane che attualmente vivono non pochi problemi economici e occupazionali”. E questo ha detto in parlamento tra l’entusiasmo e gli applausi dell’assemblea. Da Palermo al Quirinale la lunga quaresima dell’ex democristiano sopravvissuta a una doppia tragedia. Sergio Mattarella viene eletto nelle liste della DC per la prima volta alla camera nel 1983. Vi rimane fino al 2008. Nel 1989 diventa ministro dell’istruzione di Giulio Andreotti. Lascerà nel 1990 per protesta contro la legge Mammì. Nel 1998 Mattarella torna al governo: è vice premier di D’Alema. Resterà nell’esecutivo con Amato. Il 5 ottobre 2011 viene eletto dal parlamento in seduta comune alla Corte Costituzionale. Da buon siciliano ama i silenzi, e Mattarella, riscatta la politica sofferta. Chiunque lo conosca lo descrive come un uomo che non calpesta i luoghi ma li sfiora con grazia e rispetto; che non solo vede le persone, sempre tutte, ma che umilmente si inchina di fronte a chiunque, qualunque sia la condizione sociale. Il giorno di Mattarella al Quirinale, il presidente del consiglio Matteo Renzi, rivolgendosi a tutte le forze politiche ha detto: “eleggiamo un galantuomo, autorevole servitore
266
dello Stato”. Con la sua elezione Mattarella sfonda il “quorum”. E subito dice: “il mio primo pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini”. Poi nella visita alle “Fosse Ardeatine” dice: “ il popolo seppe battere l’odio nazista. La stessa unità abbatterà chi vuole trascinarci di nuovo a stagioni di terrore”.
La “Repubblica” 14 gennaio 2015
267
Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella nominato il 2 febbraio 2015
268
Una immagine di Sergio Mattarella (2015)
269
Sergio Mattarella durante la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della Repubblica
270
Un presidente che piace anche in tv
271
Premio agli studenti. Il presidente Mattarella, premia alla Camera gli studenti per il concorso “La Grande Guerra”
272
L’Italia di Mattarella che Roma ha abbracciato come “nostro presidente gentiluomo” al vertice dello Stato, contiene molte speranze: “No alle mafie”; “no alle criminalità”; “no alla politica dei clan e dei gruppi di affari illegali”; “no alle collusioni del potere”; “no alla violazione della costituzione”, “no agli interessi personali dei politici e degli amici degli amici”; “no alla prevaricazione di quanti vogliono rispettare la legge”. A questi “no”, seguono i “sì”, e tutti insieme alimentano le speranze degli italiani: “sì all’interesse del popolo”; “ad una politica sociale ed economica che prepari un valido sviluppo futuro”; “sì ad una politica di occupazione per i giovani”; “sì allo sviluppo industriale”; “sì al controllo della spesa pubblica”; “sì alla diminuzione del costo della vita”; “sì ad una informazione onesta e corretta”. Da Mattarella ci aspettiamo che faccia quello che sa fare, e questo essendo anche un professore, un giudice: dare quel rigore che l’Italia ha perso. Il nostro paese con tanta dignità, che negli ultimi anni si è offuscata. Anzi ha dovuto mettere da parte. Invece dovremmo ritrovare l’orgoglio di essere italiani: e lui è la persona giusta per aiutare i giovani a riaccendere la speranza. Nel discorso di insediamento, e giuramento al parlamento del 3 febbraio 2015, il nuovo capo dello Stato Sergio Mattarella ha detto in modo esplicito e convincente: – Avanti con le riforme istituzionali più credibili per fermare l’antipolitica; – Ogni scelta va presa nel rispetto dell’unione europea; – Rendere la politica più adeguata e imparziale; – La politica deve mirare al bene comune; – Avviare le riforme per dare risposte ai problemi della gente; – Assicurare con coerenza la piena partecipazione alla vita pubblica; – La costituzione va applicata giorno per giorno; – Nessuna discriminazione per le donne alla loro più ampia partecipazione al parlamento; – Stessi diritti per le persone disabili; – Garantire il diritto al futuro, abiurare ogni guerra e perseguire la pace;
273
Con parole commosse ha ricordato la “resistenza” che liberò l’Italia dalla dittatura fascista; la “lotta alla mafia”, il sacrificio di Falcone e Borsellino e di tanti uomini onesti; l’impegno della magistratura. Infine: – Alle minacce globali servono risposte globali; – È necessaria un’Europa più attenta all’impegno dei lavoratori; – Lotta a tutti i terrorismi; – Lotta alla criminalità; – Sostegno alle famiglie e agli anziani in difficoltà. Con Sergio Mattarella assunto alla carica di presidente della Repubblica, tutto questo diventa “Cosa di Stato” che approda al Quirinale.
274
Giornale “La Repubblica” di mercoledì 11 febbraio 2015. Camorra è Cosa Nostra
275
BIBLIOGRAFIA
Saverio Lodato – Pietro Grasso “La mafia invisibile”, Editore Mondadori, Milano 2001. Giuseppe De Lutis – “I servizi segreti in Italia”, Sperling & Kupfer editore, Milano, 2010. John Dickie – “Cosa Nostra”, Storia della mafia siciliana, Editori Laterza, Roma–Bari, 2007. Pino Arlacchi – Giorgio Bocca – “Morte di un generale”, Mondadori Editore, Milano, 1982. Maurizio Torrealta – “II quarto livello” BUR – Rizzoli, Milano, 2011. Michele Pantaleone – “Omertà di Stato”, Tullio Pironti Editore, Napoli, 1993. Benito Li Vigni – “I predatori della Finanza globale”, Baldini, Castoldi, Dalai Editore, Milano, 2009. Benito Li Vigni – “Il Vicerè”. Tullio Pironti Editore, Napoli, 1992. Benito Li Vigni – “Omicidi Eccellenti”, Tullio Pironti Editore, Napoli, 1995. Benito Li Vigni – “Poema Civile”, Editore Riuniti, University press, Roma, 2008. Giampaolo Pansa – “Il Regime”, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1991. “Indagate su Andreotti”, L’atto di accusa dei giudici di Palermo su mafia, politica e delitti, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 1993. “La Repubblica Probabile”, Garzanti Editore, Milano, 1972. Segreto di Stato, Gianni Flamini, Claudio Nunziata, Editori Riuniti, 2002, Roma. Dove lo Stato non c’è, Tahar Ben Jelloun, Editore Einaudi, 1991, Torino.
276
La mafia politica, Alfredo Galasso, Baldini &Castoldi, 1993, Milano. I Savoia e il massacro del Sud, Antonio Ciano, Editore Grandmelo, 1996 Gaeta. La Sicilia contemporanea, Massimo Ganci, Storia di Napoli e della Sicilia, Società editrice, 1980. I Briganti, Benito Li Vigni, Editrice Pubblisicilia, 1980, Palermo. Storia della mafia, Salvatore F. Romano, Editore Arnoldo Mondadori, 1963, Milano. Antologia della mafia, Nando Russo (a cura). Il ponte edizioni, 1964 Palermo. Salvatore Giuliano, Enzo Magri, Editore Arnoldo Mondadori, 1987, Milano. Delitto al potere, R. De Santis, Editore Samone e Lavelli, 1972, Napoli. Cose di Cosa Nostra, Giovanni Falcone, Editore Rizzoli, 1988, Milano. Guida ai misteri e piaceri di Palermo, Pietro Zullino, Editore Sugar & c., 1973, Milano. Mio fratello Salvatore Giuliano, Editore La Rivalsa, 1987, Montelepre. Dizionario storico della mafia, Gino Pallotta, Editore Newton Compton, 1977, Roma. Il boss è solo, Enzo Biagi, Editore Arnoldo Mondadori, 1986, Milano. Mafia: Pentiti?, Michele Pantaleone, Editore Cappelli, 1985, Bologna. Mafia – Le origini e la struttura, Henner Hess, Editori La Terza, 1970, Roma, Bari. Sicilia contro Italia (Il separatismo siciliano), Salvatore Nicolosi, Editore Tringali, 1985. Michele Pantaleone Personaggio scomodo, Mario Grasso, Editore “Prova d’autore”, 1994, Catania. Diario Siciliano, Ercole Patti, Editrice Bompiani, 1975, Milano. Segreti di Stato, Paola Baroni, Paolo Benvenuti, Editore Fandango, 2003, Roma. Gianni Viola – “Polizia” 1860 – 1977, Bertani Editore, Verona, 1965. Pietro Zullino – “Guida ai misteri e piaceri di Palermo”, Sugar Edito-
277
re, Milano, 1973. Giovanni Falcone – “Cose di Cosa Nostra”, Rizzoli Editore, .Milano. 1991. Enzo Biagi – “II boss è solo”, Mondadori Editore, Milano, 1986. Maurizio Calvi – “Figure di una battaglia”, Edizioni Dedalo, Palermo, 1992. Aurelio Depre – “Mussolini”, Editori Laterza, Roma – Bari, 1998. Antonino Caponetto – “I miei giorni a Palermo”, Garzanti Editore. Milano, 1992. Giuseppe Ayala (con Felice Cavallaro) – “La guerra dei giusti”, Mondadori Editore, Milano, 1993. Alfredo Galasso – “La mafia politica”, Baldini e Castoldi Editore, Milano, 1993. Benito Li Vigni – “ Le verità negate”, Roma Live Editore, Roma, 2009. Giuseppe Carlo Marino – “I Padrini”, Newton Compton Editori, Biblioteca de “Il Messaggero”, Roma, 2006. Giuseppe Carlo Marino – “Storia della Mafia”, Newton Compton Editori, Biblioteca de “Il Messaggero”, Roma, 2006. Benito Li Vigni – “ Falcone e Borsellino e i segreti di Stato–Mafia” – Sovera Edizioni, Roma, 2013. Giuseppe Ayala – “Troppe coincidenze”, Mondadori Editore, Milano, 2012. Pietro Grasso, con Enrico Bellavia – “Soldi Sporchi”, Dalai Editore, Milano 2011. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati, Editore Mondadori, Milano 1945. I pugnalatori, di Leonardo Sciascia, Editore Einaudi, Milano, 1976. Briganti, di Bibi Bianca. Segreteria Letteraria, Roma, 1980. Benito Li Vigni – “Sicilia 1943”, Sovera Edizioni, Roma, 2014. Giuseppe Ayala – “Chi ha paura muore ogni giorno”– Mondadori Editore, Milano, 1998.
278
Cinema Salvatore Giuliano, film di Francesco Rosi, produzione “Cristaldi Film”, 1949. Le mani sulla città, film di Francesco Rosi, produzione “Cinecittà”, 1956. E li chiamavano briganti, film di Mario Martone, produzione “Minerva Film”, 1969. Il Cammino della speranza, film di Pietro Germi, produzione “Lux Film”, 1954. Il brigante di Tacca del Lupo, film di Amedeo Nazzari, produzione “Lux Film”, 1982.
279
INDICE DELLE IMMAGINI
La matita disse al fucile “Io sono più forte di te” Una scena della rivolta antiborbonica a Palermo nel 1848 Contadini siciliani sui campi del latifondo 1860. una carica della cavalleria borbonica contro i rivoltosi di Palermo. Garibaldi e i suoi mille era già sbarcato a Marsala il 5 maggio di quell’anno La rivolta popolare a Palermo nel 1866 con una componente di brigantaggio e mafia. 1886. venditori di ostriche e pesce sul lungomare del rione Santa Lucia a Napoli 1896. Due automobilisti che partecipano alla “Coppa della Velocità di Brescia” 1898. Alcuni operai al lavoro sulla costruzione di una strada statale. Quindi “Cosa di Stato” 28 Dicembre 1908. Terremoto di Messina. Superstiti accampati al porto. Il ’900 inizia qui 1894. Donne corrono contro i soldati durante la rivolta dei Fasci siciliani dei lavoratori. 1915. Soldati italiani in una trincea sul Carso. 25 maggio 1927. Mussolini parla a Palermo il giorno dell’ascensione
280
13 22 52
53 54 72 88 100 109 112 115 122 135
Roma, 28 ottobre 1931. Un esempio del tipo di fotografie non ufficiali che Adolfo Porry Pastorel poteva scattare al capo del governo. Qui vediamo Mussolini tra la folla acclamante in via Depretis dopo aver inaugurato l’istituto centrale di statistica. 1921 – 1945 20 Aprile 1945. Partigiani entrano a Milano liberata e quindi “Cosa di Stato” Milano, Piazzale Loreto, 27 Aprile 1945. Mussolini e Claretta Petacci appesi al distributore di benzina. E fu Cosa di Stato. 1932. Roma. Insegnanti con un gruppo di studenti in gita scolastica. Cosa Nostra non era sola Milano 1943. In mezzo alla città distrutta dalle bombe pausa pranzo improvvisata. Una intensa espressione di Giovanni Falcone. (1990). La strage di Capaci del 1992 in cui morì il Giudice Giovanni Falcone assieme alla sua scorta. 1945. Auschwitz: l’orrore nazista. Sono ripartite in sordina le indagini sulla strage che costò la vita al giudice Falcone e alla sua scorta. Parla il procuratore antimafia Gianfranco Donadio e rivela: “ C’erano un fascista e ordigni militari…” 10 Luglio 1943. Le truppe americane sbarcano a Gela (Sicilia). A sostenere lo sbarco fu “Cosa Nostra”. Lo sbarco in Sicilia
136 137 138
139 142 143 144 147 149 150
153 154 155
281
10 Luglio 1943. Entusiasmo in Sicilia per l’arrivo delle truppe americane sbarcate a Gela, con la partecipazione della mafia siculo-americana. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi assassinati nel 1992. 1943. Lo storico capo mafia Carlo Vizzini 10 luglio 1943. Le truppe alleate lanciano l’operazione “Husky” e sbarcano in Sicilia con l’apporto della mafia (Lucky Luciano ecc.) 1943. Lo storico capo mafia Genco Russo Luglio 1943. Un soldato americano ferito durante la conquista della Sicilia voluta da “Cosa Nostra”. 1945. Significativa la pagina “Il Popolo” che inneggia all’Italia libera. Un esempio di “Cosa di Stato”. USA. Il boss Luky Luciano prima di essere scarcerato e mandato in Italia nel 1943 Lo storico capo mafia Vito Genovese 1948. Il bandito Salvatore Giuliano, con alle spalle Gaspare Pisciotta e due giornalisti Enrico Mattei, fondatore dell’ENI. Una vita per l’Italia. (1953). Tommaso Buscetta, il boss pentito Tommaso buscetta, scortato da un carabiniere Il boss Totò Riina Rocco Chinnici, Consigliere del Tribunale di Palermo, ucciso dalla mafia nel 1990 mentre indagava sugli omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre. Catania. Ottobre 1962, Enrico Mattei sale sull’aereo
282
156 158 161
163 165 167 168 169 172 182 190 201 202 209
210
che precipiterà a Bascapè (Pavia), alle porte di Milano. Bascapè (Pavia), i rottami dell’aereo di Mattei, precipitato il 27 ottobre 1962. Il giornalista Mauro De Mauro, rapito e ucciso il 16 settembre 1970. Stava indagando sul traffico di droga e sull’attentato a Mattei. 1953. Un pozzo di petrolio del giacimento scoperto a Ragusa. 1953. Contadini transitano nei pressi di una sonda petrolifera a Gela. Nelle prime ore di venerdì 4 novembre 1966 l’Arno rompe gli argini e sommerge la città di Firenze. È una drammatica “Cosa di Stato”. Roma, 1967. Una vignetta di Mauro Biani. La P38 a Milano. Corteo a Piazzale Accursio nel 1971. Il 12 dicembre 1969 una bomba scoppia nella Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana. Sono gli “anni di piombo”, tra terrorismo rosso e nero. Michele Greco, uno dei principali alleati dei boss corleonesi (qui al maxiprocesso del novembre 1985). Stefano Bontade un gran mafioso democristiano ed un distinto massone, forse l’ultimo autentico Padrino. Ucciso dai “Corleonesi”, nell’aprile 1981. 1970 – 1975. Operava a New York, la mafia americana dei Gambino, che teneva i rapporti con l’Italia. “La Repubblica” 14 gennaio 2015 “La Repubblica” 14 gennaio 2015 “La Repubblica” 14 gennaio 2015
215 217
218 220 221
222 223
224 226
229
231 235 236 236
283
“La Repubblica” 14 gennaio 2015 7 gennaio 2015. Due uomini entrano nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo nel centro di Parigi e fanno una strage invocando Allah. E questa è una drammatica “Cosa di Stato”. 11 Febbraio 2015. È “Cosa di Stato” I pm di Caltanissetta a caccia di file nel pc del giudice, manomesso dopo Capaci Piersanti Mattarella nominato Presidente della regione Sicilia nel 1978 e ucciso dalla mafia nel gennaio 1980. 6 gennaio 1980. Piersanti Mattarella viene estratto moribondo dall’auto dov’era stato colpito a morte anche con l’apporto della mafia. La “Repubblica” 14 gennaio 2015 Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella nominato il 2 febbraio 2015 Una immagine di Sergio Mattarella (2015) Sergio Mattarella durante la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della Repubblica. Un presidente che piace anche in tv Premio agli studenti. Il presidente Mattarella, premia alla Camera gli studenti per il concorso “La Grande Guerra”. Giornale “La Repubblica” di mercoledì 11 febbraio 2015. Camorra è Cosa Nostra
284
237
238 239 244
264
265 267 268 269 270 271
272 275
INDICE
Introduzione
11
Capitolo 1 Le radici del malessere
15
Capitolo 2 Latifondo e mafia
28
Capitolo 3 Bronte cronaca di un massacro
55
Capitolo 4 Il Sud tradito
63
Capitolo 5 I fasci dei lavoratori
73
Capitolo 6 Fasci e ruolo delle donne
110
Capitolo 7 Dal «Discorso dell’ascensione» di Mussolini del 26 maggio 1927
133
Capitolo 8 Le collusioni del potere
140
285
Capitolo 9 La mafia legittimata
159
Capitolo 10 Il bandito Giuliano
173
Capitolo 11 La commedia degli inganni
191
Capitolo 12 Omertà di Stato
197
Capitolo13 Portella della Ginestra
203
Capitolo 14 Mafia e politica
207
Capitolo 15 Cosa Nostra e nuovo assetto politico
214
Capitolo 16 Il denaro delle mafie
227
Capitolo 17 Mafie e terrorismo
232
Capitolo 18 Stragi non solo di mafia
240
Capitolo 19 La mafia invisibile
252
Capitolo 20 Cosa nostra ha occupato il nord
259
286
Capitolo 21 Cosa di Stato al Quirinale
261
Bibliografia
276
Indice delle immagini
280
287
Finito di stampare